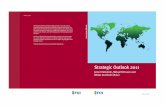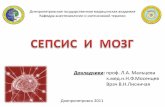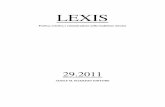Omero, da Bibliothéke (2011)
Transcript of Omero, da Bibliothéke (2011)
Letteratura greca [1]
1
Omero Aedi e rapsodi Il cantore che accompagnandosi con la cetra celebrava le gesta di degravei ed eroi si chiamava ἀοιδός (laquoaedoraquo) si trattava di esecutori e compositori al tempo stesso personaggi socialmente rilevanti come mostrano le figure di Demodoco e Femio nellrsquoOdissea Lrsquoaltro termine che denotava lrsquoattivitagrave del cantore epico era ῥαψῳδός (laquorapsodoraquo) attestato per la prima volta nel V secolo aC1 e spesso usato in riferimento a esecutori di poesia preesistente che si esibivano in occasione di festivitagrave pubbliche Il composto doveva essere giagrave noto a Pindaro che attraverso una perifrasi (Nemea II 1-3 ῥαπτῶν ἐπέων ἀοιδοί laquocantori di versi cucitiraquo) ne propone unrsquointerpretazione etimologica connessa al verbo ῥάπτειν laquocucireraquo e una perifrasi analoga (ἐν νεαροῖς ὕμνοις ῥάψαντες ἀοιδήν laquoavendo cucito il canto in nuovi inniraquo) egrave contenuta in un brano attribuito a Esiodo2 Poicheacute in queste due testimonianze il riferimento egrave agli ldquoaedirdquo egrave possibile che il termine laquorapsodoraquo non fosse sorto per indicare dei semplici ripetitori ma che originariamente designasse in unrsquoaccezione piugrave specifica di quella di ἀοιδός il poeta epico compositore-esecutore di canti secondo la tecnica formulare Lo stesso Pindaro sembra riferirsi altrove (Istmica IV 37-39) a Omero come ldquorapsodordquo allorcheacute dice che il valore di Aiace fu da lui proclamato κατὰ ῥάβδον laquocol bastoneraquo alludendo a una diversa etimologia del termine che collegava ῥαψῳδός e ῥαψῳδία a ῥάβδος laquobastoneraquo (il bastone su cui i cantori si appoggiavano nel corso delle loro esecuzioni)3 Ancora nel VI secolo aC Lrsquoattivitagrave dei rapsodi non doveva essere ridotta a pura esecuzione di canti di un repertorio giagrave esistente sappiamo infatti che il rapsodo Cineto che avrebbe per primo eseguito Omero a Siracusa nel 504501 aC inseriva nella recitazione dei poemi omerici versi di sua composizione Per altro in etagrave arcaica i rapsodi non recitavano solo Omero ma anche Esiodo Senofane Empedocle e al di fuori della tradizione esametrica poesia giambica ed elegiaca (Archiloco Solone Semonide di Amorgo4) Quando lrsquoaedo iniziava la sua recitazione sceglieva (o gli era assegnato dallrsquouditorio come accade a Odisseo in Odissea VIII 487 ss) un argomento tratto da uno dei grandi cicli della leggenda eroica ad esempio lrsquoira di Achille le avventure di Odisseo il ritorno dei Greci la contesa tra Odisseo e Achille (Odissea VIII 73-81) il Cavallo di legno Il cantore epico doveva avere giagrave un posto fisso nei palazzi micenei come suggerisce la figura venuta alla luce a Pilo di un uomo nel tipico atteggiamento del musico che seduto su una roccia suona una grande lira a cinque corde (lrsquolaquoaffresco del cantoreraquo di Pilo) Un leggendario cantore
1 Cfr Erodoto V 67 (Clistene τοὺς ῥαψῳδοὺς ἔπαυσε ἐν Σικυῶνι ἀγωνίζεσθαι τῶν Ὁμηρείων ἐπέων εἵνεκεν laquovietograve ai rapsodi di gareggiare con i carmi di Omeroraquo Sofocle Edipo Re 391 (la Sfinge come ῥαψῳδός hellip κύων laquocagna cantatriceraquo) 2 Fr 357 Merkelbach-West 3 Cfr Callimaco fr 265 Pfeiffer καὶ τὸν ἐπὶ ῥάβδῳ μῦθον ὑφαινόμενον (laquoe il racconto intessuto sul bastoneraquo) e lo scolio a Platone Ione 530a Greene laquoi rapsodi erano cosigrave chiamati poicheacute nel recitare i poemi omerici tenevano bastoni di alloro (ῥάβδους δαφνίνας)raquo 4 Per Archiloco cfr Eraclito 22 B 42 D-K (laquoOmero merita di essere cacciato dagli agoni e frustato e lo stesso vale per Archilocoraquo) Platone Ione 531a-532a Clearco fr 92 Wehrli (laquoSimonide di Zacinto usava recitare [ἐρραψῴδει] i canti di Archiloco nei teatri seduto sopra un seggioraquo) Per Solone cfr Platone Timeo 21 b-c (laquomolti di noi ragazzi cantammo [ᾔσαμεν] i componimenti di Soloneraquo) Per Semonide di Amorgo cfr Ateneo XIV 620c (laquoLisania nel I libro del suo scritto Sui poeti giambici dice che il rapsodo Mnasione nelle sue esibizioni era solito interpretare [ὑποκρίνεσθαι] alcuni dei giambi di Semonideraquo) Per Senofane cfr la testimonianza 21 A 1 D-K (laquorecitava [ἐρραψῴδει] le proprie opereraquo) per Empedocle cfr Dicearco fr 87 Wehrli
Letteratura greca [1]
2
dellrsquoetagrave micenea ritenuto uno degli inventori della musica e della poesia fu Lino forse rappresentograve originariamente la personificazione di un canto di lamento fondato sullrsquoiterazione dellrsquoespressione di dolore αἴλινος Altro leggendario cantore e indovino fu Filammone di origine tracia figlio di Apollo che avrebbe istituito i misteri di Demetra a Lerna e i cori a Delfi e avrebbe inventato i cori femminili Figlio di Filammone e della ninfa del Parnaso Argiope era detto il tracio Tamiri famoso per la sua bellezza e per lrsquoabilitagrave nel suonare la cetra (arte in cui sarebbe stato istruito da Lino) e nel cantare Tamiri si era vantato di poter vincere anche le Muse secondo una leggenda giagrave attestata in Iliade II 594-600
Dorio5 dove le Muse Srsquoincontrarono con il tracio Tamiri e posero fine al suo canto 595 Tamiri che veniva da Ecalia dalle case di Eurito e si vantava di superare nel canto chiunque anche le stesse Muse figlie di Zeus signore dellrsquoegida ed esse adirate lo mutilarono e gli tolsero il canto divino e gli fecero dimenticare la cetra 600
[Tr di G Paduano]6 Veniva ricordato anche come autore di poemi cosmogonici e teologici e di una Presa di Ecalia (Οἰχαλίας ἅλωσις) ed era considerato lrsquoinventore del modo musicale dorico NellrsquoOdissea compaiono quattro figure di ἀοιδοί ndash Demodoco alla corte dei Feaci Femio in quella di Odisseo a Itaca un aedo anonimo presso la reggia di Agamennone ad Argo (III 267 ss) e un altro alla corte di Menelao a Sparta (IV 17-19) ndash e per tutti costoro riscontriamo una forma di servizio piugrave o meno costante presso una corte Lrsquoerudizione antica interpretograve i brani dellrsquoOdissea relativi a Femio e a Demodoco come testimonianze su due aedi realmente esistiti nellrsquoetagrave piugrave antica Di conseguenza si attribuigrave a Femio un poema intitolato Il ritorno da Troia dei compagni di Agamennone sulla base di Odissea I 325 ss a Demodoco Le nozze di Afrodite ed Efesto e La presa di Ilio sulla base di Odissea VIII 267-366 e 499-520 Al di lagrave di queste invenzioni erudite egrave tuttavia significativa lrsquoosservazione di Eraclide Pontico (fr 157 Wehrli) secondo cui la poesia di Demodoco e di Femio avrebbe avuto strutture ritmiche non diverse da quelle adottate da Stesicoro e dagli antichi lirici mentre Demetrio Falereo (fr 192 Wehrli) accomunava Automede Demodoco Femio etc come compositori di laquoodi e canzoni per musica e cetra e βάρβιτος e ogni altro strumento musicaleraquo E in effetti possiamo notare che nel canto VIII dellrsquoOdissea viene approntato uno spazio per la danza (χορός) in cui alcuni giovani feaci eseguono evoluzioni orchestiche che accompagnano mimeticamente la rievocazione da parte di Demodoco degli amori segreti di Ares e Afrodite (vv 256-265)
e lrsquoaraldo srsquoalzograve per portare dalla casa del re la cetra incavata Tutti e nove si alzarono gli arbitri scelti del popolo che nelle gare preparavano bene ogni cosa spianarono un coro allargarono bene il campo di gara 260 Srsquoaccostograve lrsquoaraldo recando la cetra sonora a Demodoco ed egli avanzograve fino al centro Lrsquoattorniavano giovani nel primissimo fiore esperti di danze scandirono coi piedi la danza divina Odisseo guardava il balenare dei piedi e stupiva nellrsquoanimo 265
[Tr di GA Privitera]7 Analogamente in Odissea IV 15-19 il canto dellrsquoanonimo aedo presso la corte di Menelao a Sparta egrave associato alle figure di danza eseguite da una coppia di laquoacrobatiraquo8
5 Localitagrave della Trifilia nel Peloponneso 6 Omero Iliade Torino Einaudi-Gallimard 1997 7 OmeroOdissea II testo e commento di JB Hainsworth tr di GA Privitera Milano Mondadori 1981
Letteratura greca [1]
3
Essi cosigrave banchettavano nella gran sala dallrsquoalto soffitto i vicini e i parenti di Menelao glorioso Lietamente tra loro cantava lrsquoaedo divino suonando la cetra in mezzo ad essi due acrobati volteggiavano dando inizio alla danza
[Tr di GA Privitera]9 Alcuni studiosi ritengono che fra VIII e inizio del VII secolo aC ldquoOmerordquo si rivolgesse esclusivamente ai nobili e fondano questa ipotesi da un lato sulla tematica generale dei poemi sullrsquoambiente che fa da sfondo alle vicende narrate sulla mentalitagrave e i sentimenti sottesi alle affermazioni dei singoli personaggi sui rapporti interpersonali che fra di essi intercorrono dallrsquoaltro sullrsquoosservazione che i cantanti serbi di caffegrave-concerto i contadini i pastori e i portatori drsquoacqua neo-greci i pescatori russi etc che le odierne ricerche hanno via via assunto come termini di confronto mostrano unrsquoidentitagrave sociologica comunque diversa da quella dei bardi greci Ma pur se appare innegabile il carattere aristocratico di molta parte del mondo omerico crsquoegrave una serie di dati che suggeriscono per gli aedi una pluralitagrave di possibili uditoricirc fino a comprendere lrsquointera comunitagrave Cosigrave in Odissea XVII 385 lrsquoaedo egrave definito come un laquolavoratore per la collettivitagraveraquo (δημιοεργός) al pari dellrsquoindovino del medico e del carpentiere (un indizio altresigrave che gli aedi erano riuniti in corporazioni o gilde)10 Demodoco canta oltre che nel palazzo di Alcinoo anche di fronte a tutto il popolo dei Feaci (Odissea VIII 254 ss) Esiodo racconta di aver vinto a Calcide in Eubea un tripode nelle gare in onore di Anfidamante (Erga 654-659) e nel Certame di Omero ed Esiodo10 si racconta che Omero recitograve lrsquoinno ad Apollo alla festa panellenica di Delo altrettanto chiaramente collettivo e comunitario egrave lo scenario di pubblico presupposto nellrsquo ldquoomericordquo Inno ad Apollo Anche per quanto riguarda il punto di vista sociologico presupposto dai poemi non si puograve considerare irrilevante lrsquoinsistita preoccupazione nellrsquoOdissea percheacute venga garantita una giustizia capace di frenare i soprusi dei potenti (unrsquoottica che avvicina il poema alle ansie espresse negli Erga da Esiodo) Sembra perciograve piugrave corretto supporre che lrsquoepica omerica volesse e sapesse mediare attraverso il canto fra i valori di unrsquoaristocrazia desiderosa di autorealizzarsi nelle memorie degli avi (veri o presunti) e le prospettive di un piugrave vasto mondo sociale Fonte drsquoispirazione del canto dellrsquoaedo egrave la Musa come rileviamo tanto in relazione a Demodoco (Odissea VIII 44 s τῷ γὰρ ῥα θεὸς περὶ δῶκεν ἀοιδήν τέρπειν ὅππῃ θυμὸς ἐποτρύνῃσιν ἀείδειν laquoa lui in sommo grado un dio donograve il canto a darci diletto comunque il cuore lo spinge a cantareraquo)11 quanto per lrsquoitacese Femio Ma lrsquoazione ispiratrice della Musa non egrave sentita come limitazione della personale originalitagrave del cantore tanto che Femio dichiara a Odisseo ndash nel momento in cui lo supplica di risparmiargli la vita ndash che egli egrave laquoautodidattaraquo anche se un dio ha laquoimpiantatoraquo (ἐνέφυσε) nel suo animo le vie del canto (Odissea XXII 347-49)
αὐτοδίδακτος δ᾽ εἰμί θεὸς δέ μοι ἐν φρεσὶν οἴμας παντοίας ἐνέφυσενmiddot ἔοικα δέ τοι παραείδειν ὥς τε θεῷmiddot τῶ μή με λιλαίεο δειροτομῆσαι Da me solo ho imparato a me un dio nel cuore vie
8 E sullo scudo sbalzato da Efesto si dice (Iliade XVIII 603-605) che laquovʼera molta folla intorno alla danza graziosa rapita due acrobati intanto dando inizio alla festa roteavano intornoraquo [tr di R Calzecchi Onesti] 9 OmeroOdissea I testo e commento di S West tr di GA Privitera Milano Mondadori 1981 10 Anche Esiodo (Erga 25 s) pone lʼaedo accanto a figure artigianali come il vasaio e il carpentiere 11 Cfr anche vv 62 s τὸν πέρι Μοῦσ᾽ ἐφίλησε δίδου δ᾽ ἀγαθόν τε κακόν τε ὀφθαλμῶν μὲν ἄμερσε δίδου δ᾽ ἡδεῖαν ἀοιδήν laquola Musa molto lo amograve ma un bene e un male gli dava degli occhi lo fece privo e gli donograve il dolce cantoraquo e v 73 Μοῦσ᾽ ἄρ᾽ ἀοιδὸν ἀνῆκεν ἀειδέμεναι κλέα ἀνδρῶν laquola Musa ispirava il cantore a cantare imprese gloriose di uominiraquo
Letteratura greca [1]
4
molteplici impiantograve e credo che davanti a te canterei come davanti a un dio dunque non volermi trucidare
Come spesso accade in Omero azione umana e azione divina risultano complementari qui ciograve che appare una manifestazione di autonomia e di originalitagrave se osservato sul piano umano (Femio vuol dire che non ha avuto maestri nellrsquoarte e soprattutto che egrave solito cantare sospinto dallrsquoimpulso del suo θυμός cfr il giagrave ricordato Odissea VIII 45 ὅππῃ θυμὸς ἐποτρύνῃσιν ἀείδειν) si prospetta come azione esterna se considerato dal punto di vista dellrsquointervento divino Analogamente il carattere tradizionale dei temi e degli episodi sviluppati dagli aedi non blocca lrsquoaffermarsi di unrsquoesigenza di originalitagrave come dice Telemaco alla madre in Odissea I 351 s
τὴν γὰρ ἀοιδὴν μᾶλλον ἐπικλείουσ᾽ ἄνθρωποι ἥ τις ἀϊόντεσσι νεωτάτη ἀμφιπέληται quel canto piugrave celebrano gli uomini che intorno giunge piugrave nuovo agli uditori
Il canto epico egrave una οἴμη (Odissea VIII 481 e XXII 347) la laquoviaraquo o traccia narrativa che il poeta puograve scegliere allrsquointerno del repertorio tradizionale e seguire laquoper ordineraquo (κατὰ κόσμον) partendo da un punto determinato (cfr Iliade I 4 ἐξ οὗ laquoda quandoraquo Odissea VIII 500 ἔνθεν laquoda doveraquo) Di tanto in tanto lrsquoaedo sospende la sua esecuzione (Odissea VIII 87 ὅτε λήξειε ἀείδων laquoquando interrompeva il cantoraquo) poi riprende eventualmente sollecitato dal pubblico (ibid 90 s αὐτὰρ ὅτ᾽ ἂψ ἄρχοιτο καὶ ὀτρύνειαν ἀείδειν Φαιήκων οἱ ἄριστοι ἐπεὶ τέρποντ᾽ ἐπέεσσιν laquoma quando ricominciava e lo spingevano al canto i principi dei Feaci poicheacute godevano dei suoi versiraquo) Anche lrsquouditorio come abbiamo giagrave detto puograve infatti richiedere la scelta di un determinato tema come fa Odisseo quando in Odissea VIII 487 ss chiede che Demodoco gli canti la storia del Cavallo di legno Drsquoaltra parte la poesia orale tradizionale doveva avere un respiro limitato circoscritto al tempo di una singola esecuzione (un pomeriggio o una sera) e non a caso Femio e Demodoco eseguono pezzi che occupano una parte limitata delle ore successive alla cena Da questo punto di vista lrsquoautore (o gli autori) dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea ci appare come un poeta orale estraneo alla norma capace di esibirsi nellrsquoarco di molte ore (almeno una ventina) distribuite in diversi giorni e sedute La leggenda di Omero Ci sono giunte sette biografie di Omero tutte di etagrave post-classica anche se non egrave escluso che alcune parti e alcuni motivi narrativi risalgano fino allrsquoetagrave arcaica (e in particolare a Teagene di Reggio vissuto nel VI secolo aC) Costruita a posteriori ed esposta con ricchezza di dettagli in un racconto egrave anche la leggenda di un agone poetico svoltosi a Calcide in Eubea fra Omero ed Esiodo in occasione dei ludi funebri (a cui Esiodo effettivamente partecipograve come sappiamo da Erga 654-659) per il principe Anfidamante si tratta del cosiddetto Certamen Homeri et Hesiodi che nella forma in cui ci egrave pervenuto12 risale al II secolo dC ma si basa su modelli piugrave antichi (in particolare sul Museo del retore del IV secolo aC Alcidamante) La prova si apre con un gioco di domande e risposte fra i due poeti poi ciascuno recita un passo delle proprie opere il pubblico inclinerebbe a conferire il premio a Omero ma il figlio del defunto assegna la vittoria ad Esiodo in quanto poeta della pace e dellrsquoagricoltura (sect 13)
12 Cfr Homeri opera V 218-238 Allen Possediamo qualche resto di una versione piugrave antica grazie alla testimonianza di un papiro del III secolo aC (P Flinders Petrie 25) pubblicato nel 1891
Letteratura greca [1]
5
Anche in questa fase dellrsquoagone gli Elleni sbalorditi applaudivano Omero percheacute i versi erano superiori ad ogni aspettativa e chiedevano che gli assegnassero la vittoria Il re perograve incoronograve Esiodo dichiarando che era giusto che vincesse chi esortava allrsquoagricoltura e alla pace e non colui che narrava guerre e stragi
[Tr di F De Martino]13 LrsquoOmero della leggenda biografica (ne diamo qualche cenno prendendo come base la biografia falsamente attribuita ad Erodoto)14 si sarebbe chiamato Melesigene (laquoNato presso il Meleteraquo) e sarebbe nato a Smirne da una certa Creteide di Cuma resa incinta da uno sconosciuto e condotta dal padre adottivo (Cleanatte di Argo) presso un suo amico a Smirne appena fondata Da giovane Melesigene (che non egrave nato cieco) apprende i rudimenti dellrsquoarte epica da un certo Femio un maestro di cui eredita la scuola quindi srsquoimbarca sulla nave di un certo Mente di Leucade per conoscere il mondo e arriva (dopo aver visitato Etruria e Spagna) anche a Itaca dove si ammala e abbandonato da Mente viene ospitato dallrsquoitacese Mentore Ripreso il mare con Mente (tornato a Itaca a prelevarlo) a Colofone perde la vista (di qui piugrave tardi il soprannome di Omero in quanto ὁ μὴ ὁρῶν laquocolui che non vederaquo laquociecoraquo)15 Fatto ritorno nella nativa Smirne inizia il mestiere di poeta ha successo ma presto cade in miseria e decide di trasferirsi a Cuma dove (dopo un soggiorno in una colonia cumana presso il cuoiaio Tichio) recita i suoi versi nei ritrovi degli anziani La sua fama si diffonde al punto che Melesigene chiede di esser mantenuto a spese pubbliche Di fronte al rifiuto del Consiglio cittadino maledice Cuma e si trasferisce prima a Focea dove declama di nuovo i suoi poemi nelle sale pubbliche poi a Eritre e a Chio dove intende vendicarsi di un certo Testoride che a Focea gli aveva promesso cibo e alloggio in cambio del lascito ereditario dei poemi e invece era fuggito alla volta di Chio dopo averli trascritti sotto dettatura Ma a Chio MelesigeneOmero si smarrisce fincheacute arriva alla masseria di un pastore di capre di nome Glauco che lo conduce presso il suo signore a Bolisso Qui egrave assoldato come precettore e per i figli di costui posti sotto le sue cure compone fra lrsquoaltro la Batracomiomachia Indi si reca nella capitale dellrsquoisola apre una scuola di versificazione prende moglie (da cui ha due figlie) e intanto continua a lavorare a Iliade e Odissea Riprende i viaggi approdando prima a Samo e poi a Ios dove si ammala e giace infermo sulla spiaggia qui alcuni giovani pescatori gli propongono lrsquoindovinello dei pidocchi (laquoquanto prendemmo lasciammo ciograve che non prendemmo portiamoraquo) giagrave noto a Eraclito (22 B 56 D-K) e muore per la rabbia di non aver saputo risolverlo o per la fiacchezza (come lrsquoautore della biografia preferisce immaginare) Non sono mancati tentativi fra cui si distingue per acume quello compiuto da Wolfgang Schadewaldt16 di estrarre dalle Vite superstiti unrsquoimmagine di Omero almeno significativa per la comprensione del mestiere dellrsquoaedo nellrsquoVIII-VII secolo aC17 Senoncheacute come egrave stato
13 Omero quotidiano Vite di Omero Venosa Edizioni Osanna 1984 14 Molto dibattuta egrave la questione della data di origine della biografia pseudo-erodotea ma il testo che possediamo rappresenta probabilmente la piugrave tarda rielaborazione di un racconto composto nel V-IV secolo aC verosimilmente ndash come suppose F Jacoby (Kleine philologische Schriften I Berlino 1961 11 s) ndash un prodotto di cultura sofistica comparabile con il Certamen di Alcidamante 15 Senoncheacute ὅμηρος egrave parola greca e significa laquoostaggioraquo e in effetti testimonianze epigrafiche provano che in etagrave arcaica genitori greci potevano dare al proprio figlio questo nome 16 Homer und sein Jahrhundert in Id Von Homers Welt und Werk Stoccarda 19593 87-129 17 Per Eratostene Omero sarebbe stato contemporaneo della guerra di Troia da lui datata al 1194-1184 invece per Erodoto (II 53) Omero ed Esiodo sarebbero stati coetanei e sarebbero vissuti circa 400 anni prima di lui cioegrave alla metagrave del IX secolo (II 53 2 laquoRitengo che Esiodo e Omero mi abbiano preceduto in etagrave di quattrocento anni e non di piugrave Sono essi ad aver composto per i Greci una teogonia dando agli dei epiteti dividendo gli onori e le competenze indicando le loro formeraquo [tr di A Fraschetti] Lrsquoanonimo autore di un epigramma (AP XVI 298) dice che sette cittagrave (Smirne Chio Colofone Itaca Pilo Argo Atene) si contendevano i suoi natali
Letteratura greca [1]
6
opportunamente osservato18 non solo la maggior parte delle vicende di questa ldquobiografiardquo egrave desunta proprio dai poemi omerici e specialmente dallrsquoOdissea e non solo contiene molti elementi manifestamente ridicoli ma soprattutto laquolrsquoOmero di questa leggenda egrave un cantore mendicante cieco che si intrattiene con gente semplice con calzolai pescatori e vecchi nei ritrovi delle cittagrave portuali un precettore che insegna a leggere e a scrivere e che dunque ha rapporti soprattutto con fanciulli un estemporaneo coniatore di versi ammirato soltanto dalla piccola borghesia e una sola volta nellrsquoepisodio del signore di Bolisso in contatto con il ceto elevato davanti alle cui case del resto egrave solito andare a mendicare doni con canzoni da lui stesso composte [] Chi ha delineato questrsquoimmagine di poeta ndash non importa se con intenzioni parodistiche o meno ndash aveva davanti a seacute un compositore di versi collocato nella fascia bassa di un certo ceto professionale che si egrave potuto sviluppare in questa forma solo quando i commerci e gli affari le cittagrave e le comunitagrave avevano raggiunto una piena fioritura scalzando lrsquoantica struttura aristocratica della societagrave quando cioegrave giagrave dominava la borghesia e si richiedeva piugrave spirito imprenditoriale (si pensi alla fondazione di scuole) che beni patrimoniali La condizione professionale dei rapsodi era questa artisti di declamazione paragonabili ai nostri cantanti da concerto che allora come oggi andavano in tourneacutee e che si caratterizzavano per recitare non opere da loro stessi composte ma solo grandi capolavori altrui La leggenda di Omero attribuisce questa vita di rapsodo anche al grande poeta dellrsquoetagrave arcaica i creatori di tale leggenda non conoscevano infatti al loro tempo un altro tipo di aedoraquo Dunque gli antichi non conoscevano nulla di definito sulla vita e sulla personalitagrave di Omero ciograve che possiamo ricostruire si deve basare da un lato sul modello di aedo quale emerge dai poemi (e quale piugrave sopra abbiamo cercato di sintetizzare) dallrsquoaltro su una ricognizione degli elementi costitutivi dellrsquoarte epica Il verso dellʼepica Lrsquoesametro (giagrave Erodoto usa per lrsquoesametro dattilico espressioni come ἐν ἑξαμέτρῳ τόνῳ [I 47 2] e ἐν ἔπεσι ἑξαμέτροισι [VII 220 3]) si presenta esteriormente come una successione di sei dattili di cui lrsquoultimo catalettico (con la possibilitagrave per lrsquoultimo elemento in virtugrave della pausa di fine di verso di essere realizzato indifferentemente da sillaba breve o lunga u) Le due brevi dei singoli dattili potevano essere ldquosostituiterdquo da una lunga costituendo uno spondeo (di qui la denominazione per ciascun elemento in posizione pari di biceps y) una facoltagrave molto ridotta nel quinto dattilo che si presenta generalmente in forma pura (le eccezioni sono allincirca di un caso su 18 versi) Il verso appare articolato attraverso punti di incisione le cosiddette laquocesureraquo (τομαί laquotagliraquo) le piugrave frequenti interessano il terzo metro venendo a cadere o dopo il suo elemento lungo (cesura maschile o pentemimere laquodopo il quinto mezzo piederaquo) o tra le due brevi del biceps (cesura femminile o trocaica) piugrave rara la cesura dopo il quarto elemento lungo (eftemimere laquodopo il settimo mezzo piederaquo) e subordinata ad altra cesura principale quella dopo il secondo elemento lungo (tritemimere laquodopo il terzo mezzo piederaquo) Fine di parola puograve ricorrere anche dopo il quarto dattilo (dieresi [διαίρεσις laquodivisioneraquo] bucolica cosigrave denominata dal largo uso che ne faranno i poeti bucolici drsquoetagrave ellenistica) Di qui lo schema seguente
a1 a2 m f r b ndash y ndash y ndashkk ndash y ndash kk ndash u
18 J Latacz Omero il primo poeta dellrsquoOccidente (1989) Laterza Roma-Bari 1990 28 s
Letteratura greca [1]
7
dove a1 e a2 segnalano allrsquointerno della prima metagrave del verso le posizioni che in alternativa reciproca tendono a coincidere con fine di parola m e f le posizioni della cesura principale rispettivamente maschile o pentemimere (m) e femminile o trocaica (f) r la posizione della cesura eftemimere b la posizione della dieresi bucolica Viene evitata la fine di parola dopo il terzo metro cosigrave da escludere una bipartizione simmetrica del verso Un punto in cui la fine di parola egrave tendenzialmente evitata egrave quello dopo la prima breve del quarto biceps come fu osservato da G Hermann (donde lrsquoetichetta di laquoponte di Hermannraquo) Solo con Callimaco si afferma anche il divieto che una parola che inizi nel primo metron termini con la prima breve nel secondo biceps (laquoprima legge di Meyerraquo)
PER SAPERNE DI PIUrsquo Teorie sullrsquoorigine dellrsquoesametro Sul problema dellrsquoorigine dellrsquoesametro le teorie si sono succedute numerose allrsquointerno della fondamentale contrapposizione fra chi ha individuato nella sua struttura il risultato della fusione fra preesistenti unitagrave minori e chi invece come Hoekstra (1981) ne ha proposto unrsquointerpretazione fin dallrsquoorigine unitaria Ad es Th Bergk (1854) riconduceva la genesi dellrsquoesametro a due cola lirici preesistenti Wilamowitz (1884) ne faceva il risultato della lunga evoluzione di una struttura lirica avvenuta in parallelo col passaggio dalla canzone lirica (eolica) al laquopiccolo eposraquo e da questo al laquogrande eposraquo A Meillet (1923) postulava unrsquoereditagrave pre-greca (egea) Piugrave recentemente un ritorno alla posizione di Bergk si egrave avuto da parte di ML West (1973) con lrsquoipotesi di una derivazione dellrsquoesametro dallrsquoassociazione fra un hemiepes e un prosodiaco e alla posizione di Wilamowitz nel senso dellrsquoevoluzione di un ferecrateo espanso con lrsquoinserzione centrale di tre dattili con G Nagy (1974) B Gentili (1977) ha cercato di rintracciare coincidenze fra i segmenti costitutivi dellrsquoesametro e i cola della poesia lirica drsquoetagrave arcaica partendo dal dato per cui gli schemi metrici che appaiono in alcune iscrizioni arcaiche e nella lirica di Stesicoro (hemiepes enoplio reiziano coriambico adonio etc) sono gli stessi che sembrano plasmare tutte le formule piugrave tradizionali dellrsquoesametro omerico (per unrsquoesposizione sintetica di questa teoria cfr B Gentili-L Lomiento Metrica e ritmica Storia delle forme poetiche nella Grecia antica Milano Mondadori Universitagrave 2003 pp 279-283)
La formularitagrave Il fenomeno della formularitagrave si puograve definire come la ripetizione di versi interi o di segmenti di versi specialmente nellrsquoambito di situazioni tipiche ad es per laquoquando sorse lrsquoauroraraquo troviamo usato per due volte nellrsquoIliade e in ben venti casi nellrsquoOdissea il verso
ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς e quando mattutina apparve Aurora dalle dita di rosa
Ma il caso piugrave comune di formularitagrave egrave quello rappresentato dai nessi standardizzati nomeepiteto come quelli che vengono applicati ai rispettivi protagonisti dei due poemi πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς (31 volte) e πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς (38 volte) ambedue formule clausolari ma di diversa estensione poicheacute (se riandiamo allo schema riprodotto al paragrafo precedente) esse arrivano entrambe alla fine del verso ma partendo la prima da r la seconda da f Esempi
Letteratura greca [1]
8
r Iliade I 58 τοῖσι δrsquo ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς f Odissea VIII 97 Ὣς ἔφατrsquo οὐδrsquo ἐσάκουσε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς Piugrave in particolare se consideriamo le singole articolazioni minori del verso riscontriamo che a) nel segmento iniziale si incontrano con alta frequenza brevi nessi che contengono congiunzioni pronomi e particelle connettive o avversative ad es fino ad a1 () αὐτὰρ ὁ δή ποτε ὣς τότε καὶ τότε ὣς ὁ μέν fino ad a2 () αὐτὰρ ἐπεί ἀλλ᾽ ὅτε δή ἔνθ᾽ ἄλλοι τοὶ μὲν ἔπειτ᾽ b) nel segmento centrale che va da m o da f fino a r o a b compare spesso il predicato verbale su cui gravita la frase (si veda a titolo di esempio il verso di Iliade sopra citato nel quale μετέφη si estende appunto da m a r) m r Iliade I 58 τοῖσι δrsquo ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς c) il segmento finale (a partire da r o da b) rappresenta il piugrave ricco serbatoio di nessi formulari innanzi tutto come nel caso di πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς le formule nome proprioepiteto ma anche molti casi di associazione fra nome comune ed epiteto ad es ξίφος ἀργυρόηλον φόρμιγγα λίγειαν πατρίδος αἴης θούριδος ἀλκή μώνυχες ἵπποι ὀξέϊ χαλκῷ πότνια μήτηρ Le formule tendono a organizzarsi in sistemi caratterizzati dalle tendenze complementari allrsquoestensione e allrsquoeconomicitagrave a) il principio dellrsquoestensione si connette alla tendenza dellrsquoepica a produrre nessi formulari atti a coprire tutto ciograve che nella narrazione sia tipico costante ripetitivo e a dislocare le formule coprendo le varie partizioni del verso ad es per Ettore troviamo tre formule finali di diversa estensione (φαίδιμος Ἥκτωρ κορυθαίολος Ἥκτωρ e μέγας κορυθαίολος Ἥκτωρ e una formula iniziale (Ἥκτωρ Πριαμίδης) b) il principio complementare al primo dellrsquoeconomia (o del risparmio) corrisponde al fatto che per esprimere una medesima idea essenziale esiste generalmente nella dizione epica una e una sola espressione che occupi una determinata unitagrave minore del verso Casi come μελαινάων ἐπὶ νηῶν e ἐϋσσέλμων ἐπὶ νηῶν sono doppioni apparenti hanno sigrave la stessa misura metrica ma iniziano lrsquouno in consonante con la connessa possibilitagrave di evitare lo iato o di allungare la sillaba precedente lrsquoaltro in vocale Non mancano tuttavia vere eccezioni come per lrsquohemiepes iniziale νῆας ἐπ᾽ Ἀργείων di Iliade XXIV 298 rispetto al consueto νῆας ἐπὶ γλαφυράς (16 volte) Lrsquouso di formule e soprattutto di sistemi formulari rappresentava per il poeta epico una facilitazione nel comporre improvvisando ma nella lunga evoluzione dellrsquoepica e specialmente al momento della definitiva fissazione di poemi monumentali come lrsquoIliade e lrsquoOdissea la
Letteratura greca [1]
9
sempre piugrave estesa memorizzazione di ampie zone di testo il lavorio di riflessione sui singoli episodi e sui nessi e i parallelismi fra gli episodi stessi e la scoperta di inedite possibilitagrave espressive connesse alla modificazione di formule tradizionali dovettero incoraggiare i poeti a uno sfruttamento consapevole e artisticamente meditato del ldquogioco delle formulerdquo Da un lato procedimenti come lrsquoaddensamento degli epiteti la sostituzione di un epiteto convenzionale con uno non convenzionale (con la creazione di un nesso nuovo di struttura metrica eventualmente diversa) il trasferimento di un epiteto da un referente a un altro creano nei poemi una continua tensione tra formularitagrave e superamento della formularitagrave dallrsquoaltro la rete delle corrispondenze a distanza generata dalla ripetizione di un determinato modulo permette al poeta di variare e approfondire un motivo e di sottolineare i parallelismi o le dissonanze fra determinate situazioni La guerra di Troia Schliemann e la riscoperta di Troia In etagrave moderna la riscoperta della cittagrave di Troia situata sullrsquoodierna collina di Hissarlik e sovrastante la bassa pianura attraversata dallo Scamandro a sud del promontorio del Sigeo si lega agli scavi di Heinrich Schliemann (1822-1890) che a partire dal 1866 si dedicograve al disseppellimento delle rovine di Micene di Tirinto e di altri siti micenei e appunto di Troia Nel corso del tempo si egrave venuta creando attorno alla personalitagrave di questo archeologo dilettante una sorta di leggenda a cui egli stesso contribuigrave con le autobiografie Ilios (1881) e Troja (1884) nel senso di un dilettantismo romantico di scavi avventurosi condotti con sorprendenti successi ma senza alcun rigore di metodo di un amore cieco e totale per Omero e per lrsquoEllade E in effetti oggi sappiamo che lrsquoaver percorso la Grecia e lrsquoAsia minore sulle vie di Omero non impedigrave a Schliemann a Micene di attribuire allrsquoepoca di Agamennone tombe anche di quattro secoli piugrave antiche neacute a Troia di identificare con la cittagrave omerica uno strato risalente a una fase che va dal 2300 al 2100 aC Errori del genere non dipesero tuttavia da un entusiasmo velleitario quanto dalla carenza allrsquoepoca di competenze archeologiche che potessero orientarlo verso una piugrave plausibile cronologia di reperti e di strati Occorre poi tener conto che lo strato dei materiali riferibili alla Troia omerica (o almeno a quella che oggi noi identifichiamo con la cittagrave omerica Troia VIIa) era conservato unicamente nel suo margine esterno dato che gli strati superiori della collina di Hissarlik (con le fondamenta dei palazzi e dei templi) erano stati demoliti in epoca ellenistica per realizzare il terrazzamento del suolo su cui vennero edificati nuovi templi Fu soprattutto per questa ragione che Schliemann si spinse con le proprie maestranze a scavare sempre piugrave in profonditagrave saltando gli strati del secondo millennio Dove perograve il problema consisteva nellrsquoidentificazione di un sito sulla scorta della comparazione fra gli antichi racconti e il panorama attuale Schliemann conseguigrave notevoli successi in primo luogo identificando con la collina di Hissarlik quellrsquoacropoli omerica che lrsquoopinione comune dalla fine del XVIII secolo individuava invece nel villaggio di Bunarbaschi situato su un colle a 15 km dal promontorio del Sigeo e la disputa era stata viva giagrave nellrsquoantichitagrave Ellanico di Lesbo verso il 400 aC aveva sostenuto nei suoi Troica che la Ilio del suo tempo sorta presso la collina di Hissarlik e la Ilio omerica occupavano lo stesso sito invece Demetrio di Scepsi (fr 26 Gaede) si era pronunciato per una collina a circa 9 km a sud sullrsquoaltra riva dello Scamandro La missione americana guidata nel 1932-1938 da CW Blegen e le piugrave recenti indagini sul territorio hanno offerto un quadro molto piugrave articolato e differenziato Sulla base di un nuovo diagramma la cittagrave che sorgeva al momento in cui Eratostene di Cirene fissava la caduta di Troia (1184) viene a coincidere con Troia VIIa non piugrave con quella che Schliemann chiamava laquoterza cittagraveraquo (corrispondente a Troia II) ma nemmeno come voleva W Doumlrpfeld con Troia VI (andata in rovina verso il 1300 in seguito a un terremoto) Gli scavi piugrave recenti Secondo le conclusioni di Manfred Korfmann (cfr Korfmann 2002) che ha diretto lrsquoeacutequipe dellrsquoUniversitagrave di Tubinga negli scavi piugrave recenti lrsquoantica Troia intorno al 1184 cessograve di essere abitata ma lrsquoinsediamento continuograve nellrsquoarea della rocca per circa due secoli dopo la distruzione
Letteratura greca [1]
10
della cittagrave (Troia VIIb) Verso il 700 il luogo chiamato laquoIlioraquo era largamente in rovine anche se in etagrave arcaica dovette continuare a essere frequentato come luogo di culto Il problema che si dovettero porre nellrsquoVIII secolo aC lsquoOmerorsquo o i suoi modelli dovette essere quello di rendere il racconto della guerra di Troia plausibile a un pubblico che aveva familiaritagrave con la geografia locale (lrsquoIliade offre indicazioni realistiche ad es sulla navigazione dellrsquoEgeo in IX 362 s e sulla visibilitagrave dellrsquoisola di Samotracia dalla piana di Troia in XIII 11-14) che si trattasse di genti che risiedevano nel Sigeo o in altre cittagrave vicine o di abitanti della stessa Ilion che nellrsquoVIII secolo era di nuovo attiva sia pure soltanto come centro cultuale Il santuario sorgeva allrsquointerno di una depressione naturale a sud-ovest della rocca lungo la vecchia via che conduceva alla rocca stessa Omero menziona due templi quello di Apollo e quello di Atena e le loro loro rovine sono tuttora riconoscibili I visitatori che giungevano al santuario dal Sigeo attraverso la piana dello Scamandro potevano vedere le rovine della rocca Ma - ci si chiede - quando ebbe fine il nucleo della cittagrave di Troia cantata da Omero Nel bastione a nord-est della rocca egrave stata trovata una larga e profonda cisterna con un condotto che proviene da una sorgente La sorgente fu abbandonata al piugrave tardi al tempo di Troia VIIb2 prima del 1100 A partire dal 1000950 non rimase a Troia alcun insediamento significativo Troia era molto piugrave larga di quanto ritenesse Schliemann Un fossato largo 3 m e profondo 15 completato durante lrsquoultima fase di Troia VI o al principio di Troia VIIa (cioegrave intorno al 1300) la circondava Poi esso fu rimpiazzato a sud da un fossato piugrave ampio e concentrico al primo completato verso il 1200 Il sistema di fortificazione si estendeva per quasi 2 km e pertanto racchiudeva unrsquoarea di circa 270000 m2 La rocca e la cittagrave bassa dovevano presentarsi al tempo di Omero come un imponente complesso di rovine I nuovi colonizzatori del Sigeo e di altri siti incontrarono un vasto campo attraversato da sentieri che seguivano i vecchi tracciati Negli scavi fatti nei quartieri della cittagrave bassa a sud-ovest della rocca poco fuori del muro si egrave scoperto un deposito bruciato verso la fine di Troia VI e di nuovo verso la fine di Troia VIIa (verso il 1200) La prima devastazione egrave da ricollegarsi a un terremoto ma la seconda sembra dovuta a unrsquoazione di guerra come suggerisce anche il rinvenimento di corpi insepolti o semisepolti e di depositi contenenti armi non utilizzate Verso il 1300 la porta principale di Troia era stata bloccata e ostruita percheacute qui lrsquoantico muro era in condizioni precarie e pertanto rappresentava lrsquoanello piugrave vulnerabile nel sistema di difesa Giagrave W Doumlrpfeld aveva richiamato Iliade VI 433 s (Andromaca a Ettore)
Piazza lrsquoesercito presso il fico selvatico dove egrave piugrave facile Lrsquoaccesso alla cittagrave e il superamento delle mura
In questa zona solo poco piugrave di 80 m separavano il muro della cittagrave bassa dal muro della rocca Gli epiteti omerici di Troia - laquoben costruitaraquo laquofertileraquo laquovastaraquo laquosacraraquo laquoertaraquo laquoventosaraquo laquodalle belle muraraquo laquodai bel puledriraquo - si adattano ai dati topografici ossa di cavalli sono state trovate sul terreno forti venti soffiano continuamente in estate Anche le sorgenti sono identificabili presso la porta principale cfr Iliade XXII 145-157
Passarono oltre il posto di vedetta e lrsquoalbero di fico battuto dal vento e allontanandosi sempre piugrave dalle mura si lanciarono lungo la strada Giunsero alle fontane dalle belle acque dove sgorgano due correnti dello Scamandro impetuoso una di acqua calda da cui si leva un vapore come da fuoco ardente lrsquoaltra che in piena estate versa acqua gelata come la grandine la fredda neve o il ghiaccio Vi sono accanto dei lavatoi di pietra larghi belli dove le mogli e le belle figlie dei Teucri lavavano le splendide vesti prima in tempo di pace prima che giungessero i figli dei Danai
[Tr di MG Ciani] In effetti gli scavi nellrsquoarea della caverna in cui egrave situata la sorgente hanno portato alla luce una struttura simile a una miniera con tre gallerie e altri bracci tributari creata per fornire acqua Lrsquoacqua scorreva attraverso una superficie rocciosa e poi in un canale artificiale che a sua volta raggiungeva un sistema di quattro lsquodepressionirsquo o lsquofossersquo circolari scavate nella roccia della
Letteratura greca [1]
11
misura di quasi 1 m di diametro (appunto parrebbe i πλυνοί hellip λαΐνεοι i laquolavatoi di pietraraquo ricordati da Omero) Achei e Troiani Fra XIII e XII secolo aC Troia era un grande centro politico e commerciale in grado di controllare lrsquoaccesso ai Dardanelli (lrsquoantico Ellesponto) e il trasporto su terra di beni di vario genere dalla costa egea al Mar di Marmara (lrsquoantica Propontide) e al Mar Nero In Troia VIIa egrave stata rinvenuta ceramica micenea del periodo noto come Tardo Elladico IIIB che egrave anche il periodo di maggiore splendore dei palazzi micenei sul continente greco Ersquo suggestiva lrsquoidentificazione piugrave volte avanzata in tempi recenti di TroiaIlio con Wilusa la cittagrave menzionata spesso in testi hittiti e oggetto di contesa fra gli Hittiti e quegli Ahhiyawa il cui nome sembra identificarsi con quello degli laquoAcheiraquo (Ἀχαιοί) Il documento piugrave significativo in proposito egrave il preambolo del trattato stipulato verso il 1280 aC fra il re hittita Muwattali II e Alaksandu re di Wilusa che contiene un richiamo alle precedenti relazioni fra i due stati a partire dal 1600 pur ricordando che un tempo Wilusa era sotto il dominio hittita Muwatalli afferma di aver mantenuto relazioni pacifiche anche dopo che la cittagrave era divenuta indipendente Inoltre un testo religioso hittita rinvenuto a Hattusa la capitale dellrsquoimpero hittita e databile al XIII secolo ricorda nellrsquoambito di un rituale la recita di un poema in luvio (il luvio egrave una lingua indo-europea che si distingue solo superficialmente dallrsquohittita) di cui viene riportato il primo verso laquoQuando tornarono dallrsquoerta Wilusaraquo E a Troia negli scavi piugrave recenti egrave stato trovato un sigillo con unrsquoiscrizione in luvio Drsquoaltra parte in Omero la dinastia reale troiana di cui egrave a capo Priamo figlio di Laomedonte viene fatta risalire attraverso Erittonio Troo e Ilo fino a Dardano eponimo dei Dardani che si erano stanziati nella Troade a nord del monte Ida (Iliade ΧΧ 215 ss) I Dardani nellrsquoIliade compaiono fra i principali alleati dei Troiani accanto ai contingenti provenienti da Zelea (a nord-est lungo il fiume Esepo) e a quelli di localitagrave situate sulla Propontide come Adrestea e Pitea e sulla costa asiatica dellrsquoEllesponto come Abido e Arisbe Dalla costa europea arrivano invece i Traci i Ciconi e i Peoni da oriente i Paflagoni e gli Alizoni da sud-est i Misi e i Frigi dalla zona sud-occidentale dellrsquoAnatolia i Meoni i Cari e i Lici Se Dardani Peoni Ciconi e Traci fanno parte delle popolazioni traco-frigie che fra XII e XI secolo erano scese dai Balcani in direzione dellrsquoAnatolia (cfr Erodoto 7 73 e Xanto di Lidia FGrHist 765 F 14) i Meoni sono di stirpe lidia mentre i Cari e i Lici appartengono allrsquoambito culturale e linguistico luvio-hittita Comunque sia diversamente che per Erodoto il quale inserisce il rapimento di Elena nel quadro di una serie di torti reciproci in forma di rapimenti di donne fra Greci e barbari (I 2 1) e per i poeti tragici ateniesi del V secolo aC in Omero lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato come un contrasto fra culture diverse I Troiani mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei (detti anche laquoDanairaquo - cioegrave discendenti di Danao - o laquoArgiviraquo in relazione al contingente proveniente dallrsquoArgolide guidato da Agamennone il capo della spedizione) e lo stesso vale per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari in Iliade ΙΙ 867 come laquodi lingua stranieraraquo (βαρβαρόφωνοι) suggerisce che un tale epiteto non sarebbe stato applicabile ai Troiani Infine sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di unrsquoimbarcazione sono altrettanti esempi di quelle che W Arend denominograve laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini comportamentali e tecnologiche del gruppo che le condivide (vedi scheda p xxx) La societagrave omerica
Letteratura greca [1]
12
Nel rapporto fra il mondo omerico e la storia egrave innanzi tutto da sottolineare lrsquoesistenza di un duplice piano di riferimento con talune interferenze dellrsquouno nellrsquoaltro da un lato crsquoegrave lrsquoorizzonte dei fatti collocati in un passato glorioso dallrsquoaltro lrsquoorizzonte del poeta Giagrave gli studiosi alessandrini del resto notavano che dati come lrsquoarte di montare a cavallo i segnali per mezzo della tromba e lrsquouso di bollire la carne compaiono nellrsquoIliade solo allrsquointerno delle similitudini E il testo con una sorta di arcaismo intenzionale mostra talora la consapevolezza dellrsquoabisso che separa passato e presente come quando in Iliade XII 445-449 si dice
Ettore intanto un sasso afferrograve ndash e lo portava ndash che prima stava davanti alle porte largo di sotto ma sopra era a punta questo due uomini i piugrave forti del popolo difficilmente isserebbero da terra su un carro quali son ora i mortali egli da solo lo roteava a suo agio
[Tr di R Calzecchi Onesti] Per contro le condizioni sociali rappresentate nei poemi (un mondo di grandi proprietari terrieri che reggono aziende agricole autarchiche da cui hanno preso tuttavia a distaccarsi alcune figure di artigiani il fabbro il vasaio il carpentiere il medico lrsquoindovino lrsquoaedo) rispecchiano assai piugrave la situazione storica fra VIII e VII secolo a C che le strutture della societagrave micenea Inoltre i cadaveri vengono cremati secondo la prassi piugrave recente non inumati anche se molti riferimenti omerici non rispecchiano necessariamente la pratica normale del tempo di pace trattandosi di cremazioni che avvengono oltremare non ambigua egrave comunque la testimonianza relativa alla prassi umana in generale fornita da Odissea XI 216-222 (Anticlea a Odisseo)
Ohimegrave figlio mio il piugrave misero di tutti gli uomini Persefone la figlia di Zeus non ti inganna ma la legge degli uomini egrave questa quando si muore i nervi non reggono piugrave la carne e le ossa ma la furia violenta del fuoco ardente li disfa appena la vita abbandona le bianche ossa e lrsquoanima vagola volata via come un sogno
[Tr di GA Privitera]19 Un esempio significativo di sovrapposizione tra fasi culturali distinte si coglie osservando lrsquoinventario degli oggetti accanto ad armi vasi ornamenti tipici dellrsquoVIII-VII secolo troviamo relitti risalenti allrsquoepoca micenea come la coppa di Nestore ornata di colombe descritta in Iliade XI 632 ss (simile a una coppa drsquoargento rinvenuta a Micene che riproduce disegno e artigianato dellrsquoetagrave del bronzo) lrsquoelmo di cuoio con zanne di cinghiale che Merione dagrave a Odisseo (Iliade X 261 ss) e lo scudo lungo laquosimile a torreraquo di Aiace che egrave di un tipo inusitato dopo il XIII secolo Un oggetto non riferibile neacute al mondo miceneo neacute allrsquoetagrave della fissazione dei poemi bensigrave alla prima etagrave del ferro egrave invece la coppia di aste da lancio adottate verso il 900 aC e scomparse due secoli dopo con lo sviluppo del combattimento oplitico e la reintroduzione dellrsquoasta per colpire e la menzione delle navi fenicie (una volta nellrsquoIliade e cinque volte nellrsquoOdissea) riflette la loro comparsa nellrsquoEgeo nel IX secolo aC Non diversamente sembra avvenire anche per le istituzioni politiche lrsquo ἄναξ egrave visto a volte come figura di autocrate assoluto a volte fortemente limitato dai poteri delle assemblee ndash sia quella dei capi (βουλή) sia quella delle truppe (ἀγορή) ndash o insidiato dallrsquoascesa dei gruppi aristocratici mentre il βασιλεύς non egrave piugrave il dignitario della societagrave micenea ma genericamente un principe o un capo LʼIliade
19 Omero Odissea III intr testo e commento di A Hoekstra tr di GA Privitera Mondadori Milano 1984
Letteratura greca [1]
13
LrsquoIliade (Ἰλιάς) consta di circa 15690 esametri divisi secondo una partizione che potrebbe risalire al primo editore alessandrino (Zenodoto di Efeso) in 24 libri indicati con le lettere maiuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquounitagrave strutturale di parecchi canti che spesso finiscono col tramonto o iniziano con lrsquoalba e la coincidenza fra alcuni dei titoli attribuiti a ciascun canto nelle edizioni alessandrine e quelli che si rintracciano in autori precedenti (ad es Tucidide [I 10 4] cita il ldquoCatalogo delle navirdquo cioegrave il canto II) provano che non si trattograve di una divisione arbitraria bensigrave fondata almeno in certa misura sulle abitudini dei rapsodi Tema dellrsquoopera non egrave lrsquointero assedio decennale di Troia da parte dei Greci (di norma detti Achei o Danai o Argivi) provocato dal rapimento di Elena ad opera di Paride ma una porzione assai limitata del conflitto una sequenza narrativa che copre la durata di 51 giorni e si colloca verso la fine del nono anno di guerra lrsquoira di Achille contro lrsquoAtride Agamennone il suo ritiro dalla guerra e le relative conseguenze la fine dellrsquoira lrsquouccisione e i funerali di Ettore Fu proprio questa delimitazione tematica a consentire la realizzazione di quellrsquounitagrave e compiutezza dellrsquoazione che giagrave Aristotele individuava come uno dei pregi essenziali dellrsquoopera di Omero rispetto agli altri poemi epici arcaici (Poetica 1459a-b)20
anche in questo Omero deve apparire mirabile in confronto agli altri per non aver tentato di rappresentare intera la guerra anche se essa aveva un principio e una fine il racconto sarebbe risultato troppo grande e non abbracciabile con uno sguardo oppure pur misurato nella grandezza intricato per la varietagrave Ricavatane invece una parte ha fatto uso di molti episodi per esempio con il ldquoCatalogo delle navirdquo e con altri episodi fa procedere in lungo il poema Gli altri invece come lrsquoautore delle Ciprie o della Piccola Iliade compongono unrsquoazione multipla su unrsquounica persona o un unico tempo Di conseguenza mentre dallrsquoIliade e dallrsquoOdissea si ricava unrsquounica tragedia o soltanto due da ciascuna dalle Ciprie parecchie
[Tr di D Lanza]21
Canto I Lrsquoazione si apre sul campo degli Achei devastato dalle frecce scagliate da Apollo [T1] il dio ha scatenato una pestilenza percheacute Agamennone ha rifiutato il riscatto offerto dal sacerdote Crise per la liberazione della figlia Criseide divenuta schiava dellrsquoAtride Ai guerrieri convocati in assemblea lrsquoindovino Calcante rivela che la sola via di scampo egrave la restituzione di Criseide al padre Agamennone acconsente ma solo a patto che gli venga data in cambio Briseide la schiava che Achille tiene nella sua tenda come premio personale (γέρας) ricevuto dagli altri guerrieri Achille non puograve opporsi alla prevaricazione dellrsquoAtride ma non egrave disposto a subire passivamente lrsquooltraggio e insulta Agamennone anzi egrave giagrave pronto a estrarre la spada dal fodero per farsi giustizia quando viene trattenuto da Atena apparsa allrsquoimprovviso allora si ritira nella tenda giurando che non combatteragrave piugrave [T2] Quindi invoca la madre Tetide che dopo essere apparsa al figlio sulla riva del mare intercede presso Zeus e ottiene la promessa che i Greci non vinceranno la guerra e non espugneranno Troia fincheacute Achille non riceveragrave soddisfazione per lrsquooffesa subita Ma il piano di Zeus non resta celato ad Era che ingelosita provoca una lite nel corso del banchetto degli dei tuttavia la visione di Efesto zoppicante che funge da coppiere suscita lrsquoilaritagrave dei numi e riporta la serenitagrave Canto II Quella stessa notte Zeus manda ad Agamennone un sogno ingannatore per incitarlo ad attaccare Troia LrsquoAtride riferisce il sogno agli anziani e comanda lrsquoadunata dellrsquoesercito
20 Cfr anche 1462b ταῦτα τὰ ποιήματα συνέστηκεν ὡς ἐνδέχεται ἄριστα καὶ ὅτι μάλιστα μιᾶς πράξεως μίμησις (laquoQuesti poemi sono composti come meglio non si puograve e son il piugrave possibile imitazione di unrsquounica azioneraquo) 21 Aristotele Poetica Milano Rizzoli 19902
Letteratura greca [1]
14
con lrsquoidea stravagante di saggiare lrsquoumore delle truppe proponendo il ritorno in patria Gli uomini incitati da Tersite corrono alle navi pronti a salpare ma vengono bloccati da Odisseo e da Nestore Egrave significativo che Tersite lrsquoanti-eroe riecheggi le accuse di Achille ad Agamennone sottolineando gli onori di cui questi gode e prenda le parti di Achille [T3] Per tutta la seconda parte del libro lrsquoazione viene interrotta per far posto alla grandiosa uscita in armi dellrsquoesercito acheo dal recinto delle navi un quadro scintillante ornato da una catena di sei similitudini concatenate introdotte per illustrare il fulgore delle armi il rombo dei passi umani e degli zoccoli precipitosi lrsquoaspetto della schiera achea e la maestria dei condottieri Un ldquoCatalogo delle navirdquo contiene lrsquoelenco circostanziato delle genti greche che hanno preso parte allrsquoassedio ed egrave seguito da un catalogo piugrave breve e piugrave arido degli alleati dei Troiani accorsi in difesa di Ilio Canto III Lrsquoatteso scontro tra gli schieramenti appena passati in rassegna non ha luogo ParideAlessandro ottiene infatti una tregua per sfidare Menelao Iride la messaggera degli degravei spinge Elena ad accorrere alle mura presso le porte Scee per assistere al preannunciato duello di ligrave Priamo e gli altri anziani di Troia osservano la pianura Su richiesta del vecchio sovrano (una richiesta che sarebbe stata piugrave ldquoverosimilerdquo al primo anno di guerra) Elena nomina i piugrave prestigiosi campioni achei [T4] Nel duello che segue Paride si trova ben presto a mal partito contro Menelao ma Afrodite lo sottrae ai colpi del nemico avvolgendolo in una fitta nebbia e lo riporta nelle sue stanze dove dopo aver assunto lrsquoaspetto di una vecchia filatrice ordina a Elena di giacere con lui Elena si ribella ma la dea non transige Mentre Paride ed Elena si uniscono nellrsquoamplesso Menelao furibondo cerca fra la folla il nemico che sia i Greci che i Troiani sarebbero lieti di consegnargli pur di porre fine alla guerra Agamennone rivendicando la vittoria di Menelao pretende dai Troiani la restituzione di Elena e delle sue ricchezze noncheacute il pagamento di una forte ammenda Canto IV La tregua stipulata dopo la scomparsa di Paride viene infranta dallrsquoarciere Pandaro che sollecitato da Atena (scesa tra le schiere troiane su ordine di Zeus) ferisce con una freccia Menelao questi viene prontamente guarito dal medico Macaone figlio di Asclepio Agamennone passa fra le schiere incitandole a combattere incontra vari capi intenti a dare istruzioni ai propri uomini Solo Ulisse e Menesteo si tengono in disparte ricevendo i rimproveri di Agamennone ai quali Ulisse reagisce con indignazione Gli Achei muovono contro i Troiani con grande ordine e disciplina mentre i Troiani e i loro alleati schiamazzano come barbari Ha inizio la battaglia vera e propria nella quale lrsquoattenzione egrave focalizzata sui duelli individuali Ad assistere e rincuorare i Troiani compare Apollo sulla rocca di Troia mentre Atena infonde coraggio nei Greci Il canto si chiude sullrsquoinfuriare della battaglia la cui descrizione riprenderagrave nel canto successivo Canto V Balza in primo piano Diomede di cui viene presentata lrsquoἀριστεία lrsquoeroe laquoglorioso e chiaroraquo fa strage di nemici imperversando furiosamente fra le schiere troiane Nel pieno del combattimento viene ferito da una freccia scagliata da Pandaro il quale mena gran vanto del colpo andato a segno Diomede ottenuta unrsquoimmediata guarigione grazie allrsquointervento di Atena muove allora contro il nemico che nel frattempo era stato accolto sul carro di Enea Pandaro scaglia la sua lancia contro Diomede ma lo scudo di questi regge il colpo Diomede colpisce a sua volta uccidendo il nemico Enea scende dal cocchio per proteggere il cadavere di Pandaro dagli Achei che vorrebbero farne razzia ma Diomede lo colpisce con un grande masso fratturandogli il femore Enea viene salvato dallrsquointervento di Afrodite che lo avvolge nel suo manto mentre Diomede arriva addirittura a ferire al polso la dea che fugge sullrsquoOlimpo a farsi confortare dalla madre Dione Il figlio di Tideo attacca anche Apollo che aveva sottratto Enea alla sua furia ma
Letteratura greca [1]
15
egrave fermato dal grido di ammonimento del dio Incitati e aiutati da Ares ora i Troiani avanzano con impeto Intervengono Era e Atena e questrsquoultima assume il ruolo di auriga di Diomede Col suo aiuto questi ferisce al ventre Ares che fugge sullrsquoOlimpo Anche le dee vi fanno ritorno Canto VI Il canto VI egrave una naturale continuazione del V (tanto che Erodoto citeragrave come dallrsquoἀριστεία di Diomede un brano della prima parte del VI canto) La battaglia infuria nella pianura ma il furore di Diomede si stempera su una nota di cortesia quando lrsquoeroe dopo aver sfidato Glauco di Licia scopre di avere con lrsquoavversario antichi rapporti di ospitalitagrave I due si scambiano le armature (a detrimento di Glauco a cui laquoZeus Cronide levograve il senno cheacute scambiograve con Diomede Tidide armi drsquooro con armi di bronzo cento buoi con nove buoiraquo [vv 234-6]) Frattanto Ettore su invito dellrsquoindovino Eleno rientra in cittagrave dove le donne devono cercare di ottenere con offerte e voti il favore di Atena e incontra dapprima la madre Ecuba poi Paride (che intende ricondurre alla battaglia) vorrebbe salutare anche la moglie ma non la trova in casa bensigrave alle porte Scee dove Andromaca era accorsa piena drsquoangoscia insieme col figlioletto e con la nutrice Nel colloquio che segue ella lo implora di non esporre al pericolo se stessa e il figlio La replica di Ettore egrave esemplare per capire la prospettiva del poema e le motivazioni dellrsquoagire dei personaggi dominanti se Achille e gli eroi achei in genere cercano onore e gloria a questa motivazione (che pure non egrave assente) Ettore antepone lrsquoαἰδώς il senso di laquovergognaraquo e di responsabilitagrave nei confronti della comunitagrave e del nucleo familiare di cui egrave il difensore Poi si volta per prendere tra le braccia Astianatte ma lrsquoelmo lucente e il cimiero ondeggiante impauriscono il piccolo che si rifugia in seno alla nutrice Alla fine del canto Paride si incontra con Ettore e i due si avviano verso il campo di battaglia [T5] Canto VII A principio del canto VII Atena e Apollo si accordano per indurre Ettore a lanciare una sfida agli Achei per un duello Il sorteggio designa Aiace come campione greco Nello scontro Ettore lancia per primo lrsquoasta che penetra ma senza trapassarlo nello scudo di Aiace greve e massiccio (compaginato con sette strati di pelle bovina simile a una torre) Aiace di rimando lacera lo scudo e il pettorale della corazza ma non riesce a squarciare le carni del nemico percheacute Ettore si piega di lato Allora i due brandiscono di nuovo le aste poi ricorrono alle pietre Alla fine gli araldi arrestano il combattimento con la giustificazione che laquola notte giagrave viene ed egrave bene obbedire alla notteraquo (v 282) Su proposta di Nestore gli Achei decidono per il giorno seguente di seppellire i morti e di scavare una grande trincea difesa da un bastione sul margine del loro accampamento Respingono lrsquoofferta di pace dei Troiani (che prevederebbe la riconsegna dei tesori sottratti da Paride a Sparta) Il mattino seguente i morti vengono cremati e durante la giornata si erige il muro di protezione Canto VIII Nellrsquoassemblea degli degravei Zeus vieta ai numi di appoggiare lrsquouna o lrsquoaltra parte in conflitto Al mattino il combattimento riprende e a mezzogiorno Zeus pone i destini dei due popoli sulla bilancia che piega a favore dei Troiani Sul campo di battaglia Diomede salva Nestore Lrsquoazione di Ettore egrave travolgente fincheacute Zeus contravvenendo alla sua intenzione di favorire i Troiani accoglie la preghiera di Agamennone per risollevare il morale degli Achei che organizzano la difesa delle navi Nel corso degli scontri si segnala lrsquoarciere Teucro che colpisce i nemici muovendosi in sincronia con Aiace Telamonio che lo protegge con lo scudo Incitato da Agamennone egli prova a colpire anche Ettore ma soccombe colpito con una pietra A questa vista Era e Atena corrono ad armarsi per intervenire a favore degli Achei ma vengono distolte dalle minacce di Zeus che manifesta la propria intenzione di favorire i Troiani fino a quando i Greci non saranno ridotti alla disperazione tanto da scongiurare Achille percheacute ritorni Il sopraggiungere della notte
Letteratura greca [1]
16
interrompe i combattimenti Ettore galvanizzato dai successi ottenuti in quel giorno si illude che la vittoria sia a portata di mano e prospetta ai suoi una prossima ritirata degli Achei Il canto si chiude con il banchetto dei Troiani che banchettano nella pianura esaltati dalla speranza di vittoria Canto IX Agamennone affranto propone di fare ciograve che nel canto II aveva suggerito soltanto per mettere alla prova lrsquoesercito interrompere la guerra e tornare in patria Diomede si oppone e Nestore in un consiglio dei capi propone di tentare la riconciliazione con Achille Si invia alla tenda di Achille unrsquoambasceria (composta da Aiace Odisseo e Fenice antico pedagogo di Achille) per offrire doni ricchissimi Achille non cede anzi minaccia di salpare immediatamente verso la patria [T6] Inutilmente Fenice lrsquoantico precettore di Achille cerca di ammorbidire la determinazione del Pelide richiamando la vicenda dellrsquoeroe Meleagro [T7] Gli inviati riferiscono ad Agamennone la risposta di Achille egli torneragrave a combattere solo quando Ettore saragrave arrivato fino alle navi dei Mirmidoni Canto X Nella stessa notte si effettua una missione segreta nel corso della quale Odisseo e Diomede dapprima catturano la spia troiana Dolone (che Ettore aveva inviato alle navi achee promettendogli come ricompensa i cavalli di Achille) poi uccidono il re trace Reso appena arrivato presso i Troiani e ne rubano i magnifici cavalli Giagrave gli antichi ritenevano questo canto unrsquoaggiunta post-omerica e questi dubbi trovano riscontro in lati eccentrici della narrazione e nellrsquoimpiego di un linguaggio che spesso appare svincolato dal corrente repertorio formulare Canto XI Si apre una nuova giornata di battaglia (la cui narrazione si protrarragrave fino al canto XVIII) che ruota intorno allrsquoἀριστεία di Agamennone Quando lrsquoAtride viene ferito gli Achei ripiegano Diomede resta anchrsquoegli ferito Odisseo e Aiace evitano a stento la massa dei nemici Nestore salva sul suo carro Macaone Achille che dalla poppa della nave osserva la battaglia vuol sapere chi egrave condotto via da Nestore e manda Patroclo che viene accolto molto benevolmente e con cui Nestore intrattiene un lungo discorso egli dice di deplorare il comportamento di Achille e con atteggiamento consono alla sua condizione di anziano si dilunga nel raccontare le proprie gesta giovanili Egli esorta quindi Patroclo a far leva sulla sua amicizia per convincere Achille a riprendere il combattimento o - almeno - a concedere a Patroclo le sue armi per incutere timore nei Troiani Eccitato dalle parole del vecchio Patroclo si avvia verso la nave di Achille ma incontra Euripilo ferito che gli chiede aiuto ed egli impietositosi lo accompagna alla tenda e cura la ferita Canto XII Divisi in cinque contingenti i Troiani danno lrsquoassalto al muro eretto a difesa del campo acheo Sul campo di battaglia si manifesta un prodigio unrsquoaquila in cielo con un grosso serpente fra le zampe che riesce a ferire lrsquouccello e a sfuggire Polidamante che interpreta il segno come un presagio funesto consiglia di tornare indietro ma Ettore egrave di altro avviso Sarpedone e Glauco sferrano un attacco contro il muro e - pur rimanendo feriti - riescono ad aprire una breccia La battaglia infuria con esito incerto fincheacute Ettore con un macigno sfonda una delle porte consentendo ai Troiani di entrare in massa nel campo acheo mentre i Greci fuggono verso il mare Canto XIII Zeus distoglie lo sguardo dalla battaglia nella convinzione che nessuno fra gli dei avrebbe osato violare il divieto di intervenire ne approfitta invece Poseidone favorevole ai Greci Assunto lrsquoaspetto dellrsquoindovino Calcante il dio infonde nuovo vigore nei due Aiaci
Letteratura greca [1]
17
spronandoli al combattimento Gli Achei riconoscono lrsquointervento divino e riprendono fiducia I combattimenti si susseguono violentissimi Nella resistenza si distingue il re cretese Idomeneo Polidamante consiglia una seconda volta di interrompere la battaglia e accenna allrsquoimminente intervento di Achille Ettore non ascolta lrsquoammonimento e riprende lrsquoassalto Il canto si chiude con un suo scambio di insulti con Aiace Telamonio Canto XIV Mentre Diomede Odisseo e Agamennone tornano feriti allrsquoaccampamento Era per distogliere Zeus dalla battaglia e consentire a Poseidone di favorire gli Achei indossa la cintura magica di Afrodite e sollecita il consorte a un convegno amoroso sullrsquoIda dopo lrsquoamplesso Zeus cade in un sonno profondo e Hypnos (il Sonno) annuncia a Posidone che potragrave aiutare senza rischi gli Achei Ettore colpito con una pietra da Aiace resta a lungo in stato di incoscienza e i Troiani vengono respinti Canto XV Zeus si risveglia avvedendosi dellrsquoinganno subito e costringe Era a mandargli Iride e Apollo la prima allontaneragrave Posidone dal campo di battaglia Apollo inciteragrave Ettore a far retrocedere gli Achei fino alle navi dei Mirmidoni Riprende lrsquooffensiva troiana Apollo stesso abbatte il muro e scuotendo lrsquoegida atterrisce gli Achei Patroclo corre da Achille mentre i Troiani giagrave sono sul punto di appiccare il fuoco alle navi Canto XVI Patroclo in lacrime supplica Achille di intervenire o di mandare lui stesso al suo posto [T8] Achille gli consegna le proprie armi e gli fa promettere che non si avventureragrave oltre la zona delle navi Ma Patroclo trascinato dal suo stesso impeto oltrepassa il limite prescrittogli da Achille Abbatte Sarpedone figlio di Zeus attorno al cui cadavere infuria la lotta fincheacute Apollo lo sottrae alla mischia e Hypnos e Thanatos (il demone della morte) lo trasportano in Licia sua patria Patroclo continua lrsquoassalto alla testa dei Mirmidoni fin sotto le mura di Troia ma poco prima del tramonto al quarto assalto Apollo stesso assunto lrsquoaspetto di Asio lo percuote fra le spalle allora Euforbo lo colpisce con lrsquoasta ed Ettore lo trafigge Canto XVII Euforbo viene ucciso da Menelao ma Ettore riesce a catturare le armi di Achille indossate da Patroclo Vigorosamente sostenuti da Aiace gli Achei difendono il cadavere Una densa nebbia scende sui combattenti Zeus infonde nuovo ardimento nei cavalli di Achille piangenti per la fine di Patroclo [T9] Atena e Apollo arroventano la lotta attorno alla salma In seguito alla preghiera di Aiace Zeus dissolve la nebbia Menelao manda Antiloco figlio di Nestore a informare Achille della morte di Patroclo la cui salma viene intanto trascinata fuori della battaglia da Menelao e Merione mentre i due Aiaci offrono la necessaria copertura contro la furia incalzante dei nemici Canto XVIII Lo scoppio di selvaggio dolore a cui si abbandona Achille allrsquoudire della morte di Patroclo provoca lrsquoaccorrere dal mare di Tetide insieme con le Nereidi La madre gli promette di procurargli nuove armi Poicheacute la salma di Patroclo egrave tuttora contesa Achille fa la sua apparizione sul fossato e lancia un grido che atterrisce i nemici Efesto su preghiera di Tetide foggia le nuove armi fra cui un magnifico scudo su cui appaiono effigiati in bande concentriche gli aspetti salienti dellrsquoesistenza umana Canto XIX Il mattino seguente Tetide porta le armi al figlio e con lrsquoambrosia preserva la salma di Patroclo dalla decomposizione Achille convoca unrsquoassemblea dellrsquoesercito e rinuncia alla sua collera Agamennone lamenta di essere stato ldquoaccecatordquo da Zeus e promette doni
Letteratura greca [1]
18
riparatori [T10] Achille si lascia convincere a stento ad attendere che i soldati abbiano mangiato Poi gli armati si radunano e anche Achille si arma Il suo cavallo Xanto gli predice la prossima morte [T11] Canto XX Zeus consente agli degravei di partecipare alla nuova battaglia Enea scontratosi con Achille egrave tratto in salvo da Posidone Achille infuria come un incendio in una selva Canto XXI Achille colma di cadaveri il fiume Scamandro e cattura dodici giovani troiani che intende offrire in sacrificio a Patroclo non risparmia neppure Licaone figlio di Priamo che lo supplica con accenti di grande intensitagrave ma altrettanto intensa nella consapevolezza di un destino imminente egrave la pur spietata replica del Pelide [T12] Lo Scamandro solleva le proprie onde ma le fiamme di Efesto inaridiscono il terreno e domano la corrente Gli degravei si azzuffano Atena raggiunge Ares con una pietra Era rintuzza la furia di Artemide Infine tutti tornano sullrsquoOlimpo Apollo assunto lrsquoaspetto di Agenore respinge Achille percheacute i Troiani possano rifugiarsi allrsquointerno delle mura Canto XXII Il solo Ettore resta fuori nella pianura Invano Priamo ed Ecuba lo pregano di rientrare Mentre Achille si avvicina Ettore decide di affrontarlo ma quando quello gli egrave da presso col bronzo che gli lampeggia intorno laquosimile al raggio del fuoco ardente o del sole che sorgeraquo egrave afferrato dal panico e comincia a fuggire compiendo tre giri intorno alle mura Zeus pesa sulla bilancia i destini (le κῆρες) dei due eroi e quello di Ettore affonda in basso Allora Apollo lo abbandona e Atena apparsa a Ettore sotto le spoglie di suo fratello Deifobo gli si avvicina promettendogli aiuto e invece riporta ad Achille la lancia che gli era caduta fuori bersaglio Il colpo di risposta di Ettore rimbalza sullo scudo di Achille Ettore urla a Deifobo di passargli la sua lancia ma il falso Deifobo egrave scomparso ed Ettore comprende di trovarsi sullrsquoorlo dellrsquoabisso [T13] Achille gli trapassa la gola ed Ettore lo supplica di non oltraggiare la sua salma in risposta riceve la minaccia che finiragrave in pasto ai cani Achille trascina il cadavere alle navi attaccato al carro Priamo Ecuba e Andromaca si abbandonano al cordoglio a cui fanno eco le donne troiane Canto XXIII Viene preparato il banchetto funebre in onore di Patroclo la cui ombra nel corso della notte appare ad Achille chiedendo la sepoltura del corpo Il mattino seguente si appresta il rogo fra le offerte votive ci sono anche dodici giovani troiani Il giorno successivo si raccolgono le ossa di Patroclo Seguono i ludi funebri gare coi carri e con lrsquoarco duello in armi etc Canto XXIV Ogni giorno Achille trascina il cadavere di Ettore attorno alla tomba dellrsquoamico ma lo spettacolo offende gli degravei e al dodicesimo giorno Zeus decide di mandare Tetide percheacute induca suo figlio a restituire la salma di Ettore Iride viene inviata presso Priamo percheacute gli consigli di recarsi nel cuore della notte con un carro da trasporto e un copioso riscatto scortato da Ermes alla tenda di Achille Questi accoglie il vecchio con rispetto riconoscendo in lui lrsquoimmagine del padre lontano e si piega alla sua supplica [T14] Per volontagrave degli degravei il cadavere non egrave stato aggredito dalla putrefazione composto sul pianale del carro viene ricondotto dal padre a Troia Qui le lamentazioni rituali srsquoinnalzano dal gruppo delle donne (Andromaca Ecuba Elena) Si stipula una tregua di dodici giorni Per nove giorni i Troiani raccolgono legname poi anche il rogo di Ettore arde e si erige un tumulo
Letteratura greca [1]
19
Struttura e caratteri dellʼopera Poema di trama relativamente organica (soprattutto a partire dal canto XVI tutti gli avvenimenti tranne pochi episodi isolati ruotano attorno ai due principali antagonisti Ettore uccide Patroclo per vendicare Sarpedone e Achille uccide Ettore per vendicare Patroclo) pur se non privo di piugrave o meno cospicue incongruenze spiegabili in primo luogo con la lunga e complessa genesi orale dellrsquoopera lrsquoIliade lascia emergere in mezzo alle centinaia di nomi e alle intricate vicende alcuni caratteri delineati nella loro individualitagrave e innanzi tutto quelli di Achille e di Ettore accomunati dalla medesima coscienza di un destino di morte che sono pronti ad affrontare Appunto una tale attitudine a rappresentare i laquocaratteriraquo (ἤθη) dei suoi personaggi egrave un altro titolo di merito che Aristotele ascrive ad Omero (Poetica 1460a9-11)
dopo aver brevemente proemiato subito introduce un uomo una donna o un altro personaggio nessuno privo di caratterizzazione ma dotato di un carattere
Fondamentale per la struttura del poema egrave la novitagrave della prospettiva Possiamo presumere che i cosiddetti poemi ciclici22 mirassero a conservare lrsquoangolatura che era stata propria delle versioni pre-omeriche della saga troiana sigrave che puograve riuscire significativo il confronto fra lrsquoesordio della Piccola Iliade (dove muovendo da grandi entitagrave ndash la cittagrave il paese due popoli la guerra ndash viene lanciato secondo lrsquoespressione di J Latacz come laquouno sguardo dallrsquoesternoraquo)
Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην εὔπωλον ἧς πέρι πολλὰ πάθον Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος Canto Ilio e la terra dei Dardani dai bei puledri per la quale molti dolori patirono i Danai servitori di Ares
con lo laquosguardo internoraquo che caratterizza lrsquoinizio dellrsquoIliade
Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν ἡρώων αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν οἰωνοῖσί τε δαῖτα Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς Canta o dea di Achille figlio di Peleo la collera maledetta che pene innumerevoli inflisse agli Achei e molte scagliograve allrsquoAde vite possenti di eroi e ne faceva prede per i cani e pasto per gli uccelli e si avverava il volere di Zeus da quando primamente si separarono venuti a contesa LrsquoAtride sovrano di eroi e Achille magnifico
Argomento non egrave dunque come doveva avvenire nella tradizione del canto epico un evento complesso da inquadrare con un grandangolo onnicomprensivo e neppure come saragrave nellrsquoOdissea un personaggio colto nella multiforme varietagrave delle sue peregrinazioni egrave invece una reazione emotiva (lrsquoira di Achille) con le sue conseguenze (le innumerevoli morti degli Achei) Narrare di questa ira significa per il poeta cominciare da un punto preciso (laquoda quandoraquo) ossia dal momento della contesa e della separazione fra i due massimi eroi greci Agamennone il primo per potere (laquosovrano di eroiraquo) e Achille il primo per nobiltagrave e forza (δῖος) E sintomatica della bipolaritagrave del mondo epico in quanto mondo di degravei e di eroi egrave la sincronia per cui il taglio della narrazione coincide col decorso del laquovolere di Zeusraquo (Διὸς βουλή) forse da identificare con la promessa del dio a Tetide (rievocata piugrave oltre in questo
22 V cap II laquoLa tradizione omericaraquo
Letteratura greca [1]
20
stesso canto ai vv 518-527) di vendicare lrsquoaffronto subito da Achille o piugrave in generale con il corso degli eventi in quanto tutto come per definizione laquogiace sulle ginocchia di Zeusraquo Opera indubbiamente allrsquointerno del poema unrsquoidea formativa un progetto di qui un insieme monumentale unificato anche da una serie di corrispondenze a distanza fra cui particolare significato acquistano quelle fra primo e ultimo canto Nel canto I il vecchio Crise va come supplice presso Agamennone portando doni e supplicando la restituzione della figlia e Agamennone lo respinge aspramente minacciandolo di far ricorso alla violenza se dovesse tornare nel canto XXIV il vecchio Priamo va come supplice presso Achille portando doni e supplicando la restituzione del corpo del figlio Achille ha una prima reazione irosa (esordisce al v 560 con laquoSmetti di irritarmi vecchioraquo) ma poi accoglie la supplica E al di lagrave delle corrispondenze nelle linee dellrsquoazione si colgono fra principio e fine del poema alcuni importanti echi verbali in particolare fra XXIV 501 s
τοῦ νῦν εἵνεχ᾽ ἱκάνω νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενος παρὰ σεῖο φέρω δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα per lui [Ettore] vengo ora alle navi degli Achei per riscattarlo da te e ti porto compenso infinito
e I 12 s
ὁ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενός τε θυγάτρα φέρων δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα costui [Crise] venne alle navi rapide degli Achei per riscattare la figlia portando compenso infinito
fra XXIV 555-557
λῦσον ἵν᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδωmiddot σὺ δὲ δέξαι ἄποινα πολλά τά τοι φέρομενmiddot σὺ δὲ τῶνδrsquo ἀπόναιο καὶ ἔλθοις σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν restituiscimelo percheacute lo possa vedere con gli occhi e accogli il riscatto copioso che portiamo e tu possa goderne e tornare alla tua terra patria
e I 18-20
Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν εὖ δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκέσθαιmiddot παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην τὰ δ᾽ ἄποινα δέχεσθαι Atridi e voi altri Achei dai forti schinieri a voi concedano gli degravei che hanno le case in Olimpo di distruggere la cittagrave di Priamo e tornare facilmente in patria ma restituitemi la figlia e accettate il riscatto
fra XXIV 560 μηκέτι νῦν μ᾽ ἐρέθιζε (laquosmetti di irritarmiraquo) e I 32 μή μ᾽ ἐρέθιζε (laquonon mi irritareraquo) fra XXIV 568-570
τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς μή σε γέρον οὐδrsquo αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω καὶ ἱκέτην περ ἐόντα Διὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμάς Ora perciograve fra i dolori non mi eccitare lrsquoanimo ancora di piugrave bada o vecchio che non ti lasci neppure nella tenda
Letteratura greca [1]
21
bencheacute supplice e violi gli ordini di Zeus e I 26-28
μή σε γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω ἢ νῦν δηθύνοντ᾽ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο Mai te o vecchio io colga presso le concave navi ora a indugiare o piugrave tardi a tornare che piugrave non dovesse giovarti lo scettro e la benda del dio
(e infine XXIV 571 ὣς ἔφατ ἔδεισεν δ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ laquocosigrave diceva e il vecchio tremograve e obbediva alle paroleraquo ripete esattamente I 33) In effetti lrsquoepisodio terminale del poema col superamento dellrsquoira ad opera della pietagrave e del senso di unrsquoesistenza invasa dal dolore si propone come il rovesciamento consapevole dellrsquoepisodio iniziale che era apparso caratterizzato dalla cancellazione della pietagrave e del diritto dei supplici in nome della forza Al rifiuto iniziale del donoriscatto si oppone lrsquoaccettazione finale in consonanza con un principio-guida che opera nel poema secondo linee che alla fine si riunificano Agamennone restituisce Criseide al padre ma si appropria del dono fatto dagli altri Achei ad Achille (Briseide) Achille respinge i doni fatti da Agamennone per indurlo a riconciliarsi con lui ma dopo aver contestato nel IX canto la nozione che la vita umana possa essere barattata con una massa di beni torna alla lotta non in cambio di qualche premio da conquistare ma per vendicare lrsquouccisione dellrsquoamico Patroclo e tanto nella lotta sul campo di battaglia quanto nellrsquoinfierire sul cadavere di Ettore si abbandona a un furore cosigrave smisurato e patologico che puograve essere superato solo con lrsquoaccettare i doni di Priamo non tuttavia per il loro valore drsquouso ma percheacute in Priamo Achille riconosce lrsquoombra del padre lontano Cosigrave lrsquoIliade appare attraversata da un impulso fondamentale che muove dallrsquoideologia del dono e dalla conseguente centralitagrave assegnata allrsquoonore (τιμή) come ldquoprezzordquo che qualifica il valore del guerriero ma supera questo piano di valutazione dei rapporti umani attraverso la loro riformulazione nei termini di un umanesimo esistenziale che ha come punti di riferimento lrsquoidentitagrave universale dei condizionamenti oggettivi (la vecchiaia la malattia la morte) e i legami che uniscono padre e figlio compagno e compagno vivi e morti (il cordoglio finale di Andromaca Ecuba ed Elena sulla salma di Ettore) Entro questo orizzonte progressivamente allargato la guerra le lotte lo scontro mortale finiscono col rappresentare solo un momento e un aspetto dellrsquoesistenza graditi tanto agli degravei che vi assistono come spettatori interessati quanto agli uditori che riascoltano le antiche gesta eppure non tali da appiattire il poema in una prospettiva guerresca conclusa in se stessa Molto del fascino delle battaglie e delle ἀριστεῖαι dellrsquoIliade sta nella presenza recondita di un occhio che sa guardare al di lagrave di esse (e al di lagrave della stessa distinzione fra Greci e Troiani vincitori e vinti) e che puograve anche attraverso le similitudini lasciare irrompere il mondo della natura o del lavoro umano nel mezzo delle battaglie LʼOdissea LrsquoOdissea (Ὀδύσσεια) consta di circa 12100 esametri divisi anchrsquoessi in 24 libri e indicati con le lettere minuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquoargomento egrave costituito dalle avventure di Odisseo dalla distruzione di Troia al ritorno alla patria Itaca esposte secondo un ordine che entrando subito nel vivo degli avvenimenti (lrsquoinizio del poema mostra Odisseo nellrsquoisola di Calipso) rievoca poi i fatti giagrave trascorsi e li ricongiunge infine a partire dal libro XV (con lrsquoarrivo di Telemaco alla capanna di Eumeo dove giagrave si trova Odisseo) in unrsquoazione unitaria La trama del poema i cui avvenimenti sono concentrati cronologicamente nello spazio di 40 giorni (ma sono narrati solo gli avvenimenti di 16 giorni e 8 notti) si articola in tre parti la laquoTelemachiaraquo (canti I-IV) il laquoRitorno di Odisseoraquo (canti V-XIII) e la laquoVendetta di Odisseoraquo (canti XIV-XXIV)
Letteratura greca [1]
22
Canto I Tutti gli eroi superstiti sono ormai tornati da Troia alle loro case tranne Odisseo che pur desideroso di tornare egrave trattenuto dalla ninfa Calipso nellrsquoisola di Ogigia Gli degravei hanno pietagrave di lui tranne Posidone irato per lrsquoaccecamento del figlio il ciclope Polifemo Ma un consiglio degli degravei assente Posidone (che si egrave recato presso gli Etiopi) delibera il ritorno dellrsquoeroe si decide che Ermes andragrave subito da Calipso mentre Atena si avvia verso Itaca sotto lrsquoaspetto del signore dei Tafi Mente per incoraggiare il figlio di Odisseo Telemaco a tener testa ai pretendenti della madre i laquoprociraquo (i quali aspirano al regno tramite le nozze con Penelope) e per indurlo a intraprendere un viaggio in cerca di notizie sul padre Canto IΙ Telemaco segue il consiglio della dea e il giorno seguente nellrsquoassemblea popolare chiede una nave per andare in cerca del padre ma la sua richiesta non viene discussa e Leocrito scioglie lrsquoassemblea Grazie ad Atena che ora ha assunto le sembianze di Mentore (antico amico di Odisseo) Telemaco riesce tuttavia a trovare una nave con cui salpa nel corso della notte allrsquoinsaputa sia della madre che dei proci Canto IΙΙ Telemaco e MentoreAtena arrivano a Pilo e sul lido trovano Nestore che sta offrendo un sacrificio a Posidone Il vecchio eroe accoglie ospitalmente Telemaco e gli comunica molte notizie sul ritorno di altri Achei ma nessuna su Odisseo Alla sera Atena scompare in forma di aquila e il mattino seguente Telemaco salpa insieme con Pisistrato (figlio di Nestore) alla volta di Sparta dove arriva la sera del giorno successivo Canto IV A Sparta Menelao sta festeggiando il doppio matrimonio del figlio e della figlia Il giorno seguente Telemaco chiede del padre Menelao gli racconta il proprio ritorno durante il quale aveva incontrato Proteo il vecchio nume marino che gli aveva riferito come Odisseo fosse trattenuto nellrsquoisola di Calipso Intanto a Itaca i proci preparano insidie meditando di uccidere Telemaco al suo ritorno Penelope ne viene a conoscenza ma Atena le appare in sogno per confortarla Canto V Dopo un secondo concilio degli degravei (in effetti un ldquodoppionerdquo di quello del I canto) Zeus manda finalmente Ermes presso Calipso con lrsquoordine di lasciar partire Odisseo La ninfa aiuta lrsquoeroe a costruirsi una zattera Al diciottesimo giorno di navigazione Odisseo egrave in vista dellrsquoisola dei Feaci Scheria quando Posidone di ritorno dal suo soggiorno presso gli Etiopi lo vede e suscita una tempesta che distrugge la zattera Ma la dea marina Ino Leucotea impietositasi gli porge il proprio velo sostenuto dal quale lrsquoeroe giunge a nuoto alla riva di Scheria dove si abbandona esausto addormentandosi Canto VI In seguito a un sogno inviatole da Atena Nausicaa la figlia del re dei Feaci Alcinoo si reca nei pressi della spiaggia a lavare le vesti insieme con le ancelle Odisseo risvegliatosi atterrisce le fanciulle che fuggono tutte allrsquoinfuori di Nausicaa Lrsquoeroe supplica la giovane di porgerle aiuto ed ella lo fa rivestire e lo accompagna fino al bosco di Atena poco prima della cittagrave esortandolo a presentarsi a suo padre Canto VII Protetto dalla nebbia di cui Atena lo ha avvolto Odisseo entra nel palazzo abbraccia le ginocchia della regina Arete e la caligine scompare poi viene accolto con onore da Alcinoo Arete chiede a Odisseo donde provenga e chi gli abbia donato gli abiti (a lei ben noti) che indossa Lrsquoeroe inizia a raccontare le disavventure che gli sono occorse dopo la
Letteratura greca [1]
23
partenza dallrsquoisola di Calipso Alcinoo gli promette di farlo ricondurre a Itaca il giorno seguente Canto VIII Ma lrsquoindomani Alcinoo fa apprestare un banchetto durante il quale lrsquoaedo Demodoco canta della contesa insorta un giorno fra Achille e Odisseo Lrsquoeroe si copre il volto per nascondere le lacrime allora Alcinoo interrompe il canto e organizza una serie di gare nel corso delle quali Odisseo primeggia Poi Demodoco al margine di unrsquoarea per la danza dove si esibiscono i ballerini feaci canta gli amori di Ares e Afrodite e la vendetta di Efesto (che incatena i due amanti) La sera al ritorno nel palazzo Demodoco racconta la storia del Cavallo di legno Odisseo scoppia nuovamente in lacrime e Alcinoo gli chiede di rivelare il suo nome Canto IX Odisseo dichiara il proprio nome e dagrave inizio al racconto della propria storia a partire dalla caduta di Troia distruzione di Ismaro e perdite subite ad opera dei Ciconi sbarco presso i Lotofagi (che si nutrono di un cibo misterioso che fa dimenticare il ritorno) dopo una terribile tempesta scatenatasi durante il tentativo di doppiare il capo Malea arrivo allrsquoisola antistante quella dei Ciclopi dove Odisseo si trasferisce con una sola nave esplorazione dellrsquoisola perdita di alcuni compagni allrsquointerno della caverna del gigante monocolo accecamento del mostro e fuga Canto X Odisseo giunge allrsquoisola di Eolo signore dei venti che lo accoglie benevolmente e gli consegna alla partenza tutti i venti chiusi in un otre ma poi lo respinge con durezza quando ritorna presso di lui percheacute i compagni (sospettando che nellrsquootre siano racchiuse cospicue ricchezze) hanno sciolto i venti e da essi si egrave sprigionato un uragano che li ha risospinti sullrsquoisola Ripreso il mare Odisseo egrave trasportato fino ai Lestrigoni antropofagi il cui attacco priva lrsquoeroe di tutte le altre navi tranne la propria Con questa fugge fino allrsquoisola (Eea) della maga Circe Dopo che Circe ha trasformato in porci un gruppo di compagni mandati innanzi ad esplorare lrsquoisola Odisseo ha la meglio sulla maga (a cui impone di restituire forma umana ai compagni) grazie allrsquoerba moly fornitagli da Ermes Resta un anno presso Circe che al momento della partenza gli consiglia di recarsi al paese dei morti per interrogare il vate Tiresia Canto XI Approdato alla terra dei Cimmeri (che vivono immersi in una nebbia perenne sulla riva dellrsquoOceano) e scavata una fossa Odisseo sacrifica ai morti e immola una vittima speciale a Tiresia Le anime accorrono dapprima Elpenore caduto per caso giugrave dal tetto della casa di Circe (Odisseo gli promette sepoltura) poi la madre Anticlea (che gli racconta di esser morta di dolore per la sua assenza) quindi Tiresia che gli vaticina le sue vicende future fino alla morte (questa lo coglieragrave dopo una lunga vita in un paese straniero che non conosce neacute il sale neacute il remo) Da un certo punto in poi il poeta dimentica il presupposto per cui Odisseo aveva scavato una fossa alla quale i morti accorrevano per bere il sangue delle vittime e bevendolo riacquistavano per breve tempo una piena consapevolezza immagina invece che Odisseo sia allrsquointerno dellrsquoAde In questa sezione rientrano la descrizione di Aiace sdegnato di Minosse di Orione dei grandi peccatori di Eracle Poi Odisseo fa ritorno a Eea e ricevuti i consigli di Circe si imbarca per il ritorno in patria Canto XII Scampato alle Sirene che invano lo attirano col canto (si egrave fatto legare allrsquoalbero della nave i compagni che remano hanno le orecchie turate con la cera) passa tra Cariddi e Scilla (che gli rapisce sei uomini) ed egrave costretto dai compagni ad approdare in contrasto con le prescrizioni di Circe allrsquoisola Trinachia dove pascolano le greggi del Sole I
Letteratura greca [1]
24
compagni spronati da Euriloco se ne cibano nonostante il divieto dellrsquoeroe Il Sole sdegnato ottiene da Zeus che la nave sia colpita dal fulmine Tutti i compagni periscono ma Odisseo che ripassa tra Scilla e Cariddi si salva miracolosamente da questrsquoultima aggrappandosi a un fico selvatico fincheacute il gorgo restituisce i rottami della nave infine arriva remando con le mani allrsquoisola di Ogigia Canto XIII Terminato il racconto lrsquoeroe riceve doni dai Feaci e la notte seguente egrave ricondotto a Itaca e deposto addormentato sulla spiaggia presso un antro sacro alle Ninfe Al risveglio per la nebbia non riconosce la sua terra fincheacute Atena in veste di giovane pastore lo rassicura e poi rivelatasi gli dagrave istruzioni su come far strage dei proci e lo trasforma in un vecchio mendico Canto XIV Odisseo si reca allo stazzo del suo porcaio Eumeo che pur non riconoscendolo lo accoglie ospitalmente rifocillandolo e offrendogli un mantello per ripararsi dal gelo notturno Canto XV A questo punto la laquoTelemachiaraquo si riannoda allrsquoazione principale Telemaco che si trova ancora a Sparta viene indotto da Atena a tornare a Itaca sulla via del ritorno a Pilo accoglie a bordo lrsquoindovino Teoclimeno e grazie allrsquoaiuto della dea sfugge alle insidie dei proci sbarca a Itaca e si reca anchrsquoegli presso Eumeo Canto XVI Questi va da Penelope ad annunciargli il ritorno del figlio Intanto Odisseo rimosso lrsquoincantesimo si svela nel suo vero aspetto a Telemaco e con lui progetta la vendetta sui proci (che intanto tramano una nuova insidia ai danni di Telemaco) Eumeo torna al suo stazzo Canto XVII Il mattino seguente Telemaco si reca in cittagrave seguito in un secondo tempo da Eumeo e Odisseo (che ha riassunto lrsquoaspetto di mendico) Davanti al palazzo Odisseo egrave riconosciuto dal cane Argo Entra e va mendicando tra i proci Antinoo lo colpisce alla spalla destra con uno sgabello Canto XVIII Odisseo si batte al pugilato col mendicante Iro Penelope scesa nella sala prospetta ai proci lrsquoeventualitagrave di un nuovo matrimonio Odisseo egrave insultato dalla schiava Melanto e schiva uno sgabello scagliato da Eurinomo Canto XIX Insieme con Telemaco lrsquoeroe allontana le armi dalla sala poi conversa con Penelope che gli racconta un sogno e gli espone il suo piano per sedare le contese tra i proci concedendosi sposa a colui che riusciragrave a tendere lrsquoarco di Odisseo la prova avverragrave il giorno seguente al novilunio Durante il colloquio la fida schiava Euriclea lava i piedi di Odisseo e riconosciutolo da unrsquoantica cicatrice sta per rivelarne lrsquoidentitagrave ma lrsquoeroe la costringe a tacere Canto XX Al mattino Euriclea e le ancelle fanno i preparativi per il banchetto Giungono Eumeo Melanzio e il mandriano Filezio Un presagio mandato da Zeus dissuade i proci dal progetto di uccidere Telemaco Durante il banchetto Teoclimeno predice la loro imminente rovina
Letteratura greca [1]
25
Canto XXI Penelope conduce lrsquoarco nella sala dopo che parecchi fra i proci e lo stesso Telemaco hanno tentato invano di tenderne la corda Odisseo chiede di partecipare alla prova tende lrsquoarco senza fatica e riesce a far passare la freccia attraverso gli anelli di dodici scuri predisposte da Telemaco Canto XXII Poi scaglia le frecce sui proci e si rivela nella sua identitagrave Nella lotta che segue Telemaco Eumeo e Filezio aiutano il padrone contro i proci (appoggiati dal capraio Melanzio) Tutti i proci restano uccisi le ancelle infedeli sono impiccate Melanzio viene mutilato e ucciso soltanto lrsquoaedo Femio e lrsquoaraldo Medonte sono risparmiati Canto XXIII Nuovo colloquio fra Odisseo e Penelope che durante lrsquoeccidio dormiva ed egrave stata svegliata da Euriclea Penelope esita ancora a riconoscere il marito e non si arrende alla veritagrave fincheacute Odisseo non le descrive la posizione e la struttura del letto coniugale Canto XXIV Ermes conduce allrsquoAde le ombre dei proci Odisseo fa visita al padre Laerte nella masseria dove quello vive nello squallore e nellrsquoemarginazione e si fa riconoscere Intanto il padre di Antinoo incita gli Itacesi alla rivolta e il poema si conclude con lo scontro di Odisseo e dei suoi contro i concittadini lrsquoeroe ha la meglio e Zeus scagliato il fulmine pone fine alla battaglia Atena sotto lrsquoaspetto di Mentore stabilisce fra i contendenti un patto per il futuro36
Struttura e caratteri dellʼopera Giagrave la prima parola del proemio (ἄνδρα) non menziona come tema dellrsquoopera un determinato episodio della vita del protagonista ma il protagonista stesso (I 1-10)
Ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα πολύτροπον ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεmiddot πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περmiddot αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο νήπιοι οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιονmiddot αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ τῶν ἁμόθεν γε θεά θύγατερ Διός εἰπὲ καὶ ἡμῖν Dellrsquouomo multiforme a me racconta o Musa che molto errograve dopo che di Troia la sacra rocca distrusse di molti uomini vide le cittagrave riconobbe il pensiero e molti per il mare patigrave dolori nellrsquoanimo per salvare la sua vita e il ritorno dei compagni Eppure non li salvograve i compagni per quanto bramasse per la loro stessa follia si persero gli stolti i buoi del Sole Iperione mangiarono e quello rapigrave ad essi il digrave del ritorno Di questo da un punto qualsiasi narra anche a noi o dea figlia di Zeus
Storie favolose di naviganti racconti imperniati sul ritorno dei guerrieri achei che avevano combattuto a Troia e il particolare rientro in patria di Odisseo figlio di Laerte erano forse giagrave stati connessi e intrecciati nella precedente tradizione epica sigrave che il presente cantore poteva
Letteratura greca [1]
26
metter mano alla vicenda partendo (v 10) laquoda un punto qualsiasiraquo (ἁμόθεν) una notazione che certo presuppone la convenzione propria dellrsquoesordio tradizionale di un canto epico comparabile con i giagrave ricordati ἐξ οὗ (laquoda quandoraquo) di Iliade I 4 ed ἔνθεν (laquoda doveraquo) di Odissea VIII 500 Senoncheacute rispetto a queste indicazioni di tipo puntuale il tratto costituito dalla dimensione casuale quasi arbitraria inerente ad ἁμόθεν proprio mentre dichiara lrsquoassenza di un determinato piano compositivo implica in realtagrave che il racconto non si svolgeragrave per filo e per segno secondo lrsquoordine noto a poeta e uditori non si snoderagrave κατὰ κόσμον (laquoper ordineraquo) come il canto di Demodoco (VIII 489) ma seguiragrave un andamento originale Il ldquopunto qualsiasirdquo incipitario non rappresenta una scelta della Musa (figura dellrsquoarchivio tematico che conserva le laquovieraquo dellrsquoepica) bensigrave di questo cantore che ha deciso di far incominciare la narrazione in medias res e ha in serbo la sorpresa di far succedere al concilio degli degravei (che decide lrsquoinvio di Ermes presso Calipso) non lrsquoazione testeacute programmata (azione che viene differita con un ritardo che a piugrave riprese ha scandalizzato i lettori a principio del V canto) ma la partenza di Atena alla volta di Itaca e lrsquoavvio della laquoTelemachiaraquo Le due diverse vicende proposte a principio del poema quella di Telemaco e quella di Odisseo procedono infatti in parallelo coprendo un analogo lasso di tempo Piugrave oltre la decisione di trasformare la sequenza narrativa che va dalla partenza di Odisseo da Troia fino al suo arrivo nella terra dei Feaci in una rievocazione fatta dallrsquoeroe in prima persona al cospetto di Alcinoo e dei Feaci (la sezione detta degli ἀπόλογοι laquoraccontiraquo) crea una struttura ad anello che parte dal presente e ad esso fa ritorno dopo aver ricostruito le premesse della condizione attuale del protagonista Col canto XIII Odisseo egrave riportato dai Feaci a Itaca e questo permette la saldatura fra le vicende sue e quelle di Telemaco sia pure col differimento dellrsquoincontro e del riconoscimento fra padre e figlio fino al canto XVI Far scorrere in parallelo sequenze distinte organizzare programmi narrativi a corta e a lunga gittata tendere o allentare ad arte il ritmo della narrazione non si tratta davvero di procedimenti che potessero configurarsi come tradizionali dellrsquoarte epica quanto piuttosto di un momento sperimentale di una ricerca di soluzioni nuove al termine di una lunga e ormai consolidata sedimentazione di percorsi compiuti allrsquointerno di un determinato repertorio tematico unrsquoaudacia inventiva una πολυτροπίη degne del protagonista del poema che inevitabilmente comportavano rischi molteplici di incoerenze dissonanze occasionali avarie della macchina epica e che tuttavia erano destinate a conseguire un risultato assolutamente convincente allrsquoorecchio di chi si abbandonasse al fascino del racconto senza lrsquourgenza propria di altre etagrave e di altre mentalitagrave di puntare il dito sui singoli dettagli o le singole sfasature
PER SAPERNE DI PIUrsquo Difficoltagrave e incongruenze della narrazione omerica Forti della possibilitagrave di un controllo su un testo scritto che possiamo percorrere in avanti e a ritroso secondo ritmi di nostra scelta a noi non riesce difficile cogliere alcune delle difficoltagrave organizzative incontrate nella composizione del poema In proposito per ricordare un caso che saragrave allrsquoorigine delle discussioni di orientamento ldquoanaliticordquo intorno allrsquoOdissea possiamo leggere il discorso che Atena prese le sembianze di Mente re dei Tafi rivolge a Telemaco nel I canto (vv 253-305) Ah infelice ti manca molto davvero lrsquoassente Odisseo che getti le mani addosso ai pretendenti sfrontati Percheacute se ora tornato stesse sulla soglia 255 con una scure lo scudo e due lance cosigrave come io per la prima volta lo vidi in casa nostra che beveva e godeva di ritorno da Efira da Ilo di Mermero (andograve anche ligrave Odisseo con la nave veloce 260 in cerca del veleno omicida per averne da ungere le frecce di bronzo ma quello non glielo diede percheacute temeva gli dei che vivono eterni
Letteratura greca [1]
27
glielo diede invece mio padre percheacute lrsquoamava moltissimo) se stesse Odisseo tra i pretendenti cosigrave 265 essi avrebbero tutti rapida morte e nozze amare Ma sulle ginocchia degli dei questo giace se una volta tornato faragrave o no vendetta nella sua casa te invece io esorto a riflettere come cacciare i pretendenti da casa 270 Ebbene ora ascolta e alle mie parole darsquo retta Domattina chiamati gli eroi Achei a consiglio rivolgi a tutti un discorso e siano testimoni gli dei Ai pretendenti comanda drsquoandarsene per i fatti loro e tua madre se lrsquoanimo la spinge alle nozze 275 ritorni a casa del padre molto potente Prepareranno essi le nozze e disporranno i doni nuziali moltissimi quanti gli pare che debbano andare alla figlia A te darograve un saggio consiglio se vuoi ascoltarlo armata una nave con venti remi la migliore che crsquoegrave 280 Varsquo a domandare del padre partito da tempo se mai te ne parli un mortale o sentissi da Zeus la voce che divulga la fama tra gli uomini Anzitutto varsquo a Pilo e interroga il chiaro Nestore di ligrave poi varsquo a Sparta dal biondo Menelao 285 degli Achei vestiti di bronzo egli egrave tornato per ultimo Se senti dire qualcosa sulla vita e il ritorno del padre per quanto stremato potresti sopportare un altro anno se invece senti dire che egrave morto e non vive allora tornato nella cara terra patria 290 ergigli un tumulo e offrigli funebri offerte moltissime quanto conviene e darsquo tua madre a un marito E poi dopo aver compiuto e fatto ogni cosa allora medita nella mente e nellrsquoanimo come tu possa uccidere nelle tue case 295 i pretendenti con lrsquoinganno affrontandoli non devi piugrave avere i modi di un bimbo percheacute ormai non sei tale Non senti lrsquoillustre Oreste quale gloria ha acquistato fra tutti gli uomini percheacute uccise lrsquoassassino del padre Egisto esperto di inganni che gli uccise il nobile padre 300 Anche tu caro infatti molto bello e grande ti vedo sii valoroso percheacute ti lodi anche qualcuno dei posteri Ma io tornerograve adesso alla nave veloce dai compagni che forse impazienti mi aspettano Tu devi pensarci da te dammi retta 305
[Tr di GA Privitera] Le stranezze non mancano davvero e cosigrave sono state messe a fuoco da Stephanie West nel suo commento23 1 Atena sa evidentemente molto piugrave di quanto uno come Mente avrebbe potuto sapere in particolare ella sa che i proci ignoreranno lrsquoinvito di Telemaco a lasciare la sua casa e fatto piugrave importante che gli degravei tra breve ricondurranno in patria Odisseo A queste osservazioni si puograve replicare con la stessa West che laquosi sono esagerate difficoltagrave e
23 Omero Odissea I cit 219 ss
Letteratura greca [1]
28
incongruenze alle quali un pubblico di ascoltatori (o anche un lettore moderatamente attento) probabilmente non farebbe casoraquo 2 Il progetto di una pubblica denuncia dei proci dinanzi agli degravei e agli uomini ai vv 273-274 egrave ciograve che Atena sembra prefiggersi nel promuovere lrsquoassemblea degli Itacesi (assemblea che effettivamente avragrave luogo a principio del canto II) drsquoaltra parte le successive istruzioni di AtenaMente ai vv 295 s (medita come uccidere i pretendenti) presuppongono che di quella richiesta da formulare nel corso dellrsquoassembla essi non terranno alcun conto Anche a questa osservazione si puograve rispondere che laquoegrave ragionevole attendersi che Telemaco condivida la previsione di un esito negativo della sua iniziativaraquo e si puograve aggiungere che pure in caso di insuccesso il ricorso allrsquoassemblea potrebbe ottenere almeno il risultato di screditare i pretendenti presso la comunitagrave itacese legittimando un successivo ricorso alla violenza (e si tratta di una legittimazione di cui anche lrsquoultimo canto mostreragrave lrsquoesigenza) 3 Dopo che Telemaco aveva detto che la madre non intendeva risposarsi (vv 249-250) AtenaMente si esprime ai vv 275-278 come se Penelope desiderasse proprio nuove nozze e inoltre sarebbe assurdo che il padre di Penelope cominciasse a contrattare un secondo matrimonio prima del ritorno di Telemaco dal suo viaggio e che mettesse mano a preparativi che rischierebbero di essere annullati qualche tempo dopo con inevitabile imbarazzo se Telemaco venisse a sapere che Odisseo egrave ancora vivo In piugrave lrsquoandamento sintattico di questi versi presenta un anacoluto durissimo per cui a principio del v 275 lrsquoaccusativo μητέρα egrave seguito da un ἂψ ἴτω (laquovada indietroraquo laquotorniraquo) che richiederebbe come soggetto un nominativo μήτηρ Come hanno reagito i lettori di Omero Nellrsquoantichitagrave un grammatico rimasto anonimo cambiava come attesta uno scolio μητέρ᾽ in μήτηρ nel secolo XVIII Richard Bentley modificava ἴτω in ἴμεν (infinito eolico di εἶμι laquovadoraquo) nel XIX un altro grande della filologia europea Gottfried Hermann risolveva piugrave drasticamente la questione eliminando il complesso dei vv 275-278 e la stessa West mostra simpatia per tale proposta supponendo laquounrsquoaggiunta posteriore modellata sul corrispondente passo del libro IIraquo (dove i vv 196 s sono identici ai vv 277 s e il v 195 copre lo stesso contenuto dei vv 275 s) Si tratta di procedimenti adeguati ai dati di fatto Migliorano davvero il testo che ci egrave stato tramandato In realtagrave ambedue le ldquocorrezionirdquo appena ricordate (di μήτερ᾽ e di ἴτω) ottengono un risultato tanto lineare che egrave davvero difficile pensare che lrsquoanacoluto avrebbe potuto invadere tutta la tradizione se non fosse stato originario e quanto allrsquoespunzione dei vv 275-278 essa indubbiamente peggiorerebbe il ritmo del discorso determinando lrsquoavvicinamento fra i due versi (v 271 e v 279) molto simili fra loro che aprono le due sequenze occupate dai consigli di Mente E allora La via piugrave saggia egrave senzrsquoaltro quella di tenerci qui come quasi sempre di fronte al testo omerico contraddizioni e anacoluti riconoscendo in essi lrsquoeffetto dellrsquoattivitagrave di un cantore che pur sulla base di una traccia largamente memorizzata restava pur sempre legato a quella prassi orale per cui composizione ed esecuzione tendevano a coincidere E lrsquoanacoluto si spiega bene se cerchiamo di immedesimarci nel procedimento seguito dal poeta Egli ha affidato ad Atena un certo flusso argomentativo per cui la dea deve dar consigli a Telemaco sui suoi rapporti coi proci e con la madre e cosigrave colloca in fine di v 274 un ἄνωχθι (laquoordinaraquo) destinato a reggere gli accusativi simmetricamente dislocati in principio di verso (vv 274 e 275) μνηστῆρας e μητέρα Senoncheacute giunto a questa seconda parte dellrsquoargomentazione egli si avvede quanto sarebbe illogico che Telemaco sollecitasse la madre a nuove nozze di qui lrsquoimprovviso cambio di costruzione che svincola al prezzo di una sensibile slogatura sintattica lrsquoipotesi delle nuove nozze dallrsquoordine impartito a Telemaco e la prospetta invece come un desiderio eventuale della stessa Penelope Il poeta ha un progetto ben meditato brani e sequenze piugrave volte sperimentati ed egrave col supporto di questi materiali giagrave elaborati che egli si fa strada attraverso le insidie della
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
2
dellrsquoetagrave micenea ritenuto uno degli inventori della musica e della poesia fu Lino forse rappresentograve originariamente la personificazione di un canto di lamento fondato sullrsquoiterazione dellrsquoespressione di dolore αἴλινος Altro leggendario cantore e indovino fu Filammone di origine tracia figlio di Apollo che avrebbe istituito i misteri di Demetra a Lerna e i cori a Delfi e avrebbe inventato i cori femminili Figlio di Filammone e della ninfa del Parnaso Argiope era detto il tracio Tamiri famoso per la sua bellezza e per lrsquoabilitagrave nel suonare la cetra (arte in cui sarebbe stato istruito da Lino) e nel cantare Tamiri si era vantato di poter vincere anche le Muse secondo una leggenda giagrave attestata in Iliade II 594-600
Dorio5 dove le Muse Srsquoincontrarono con il tracio Tamiri e posero fine al suo canto 595 Tamiri che veniva da Ecalia dalle case di Eurito e si vantava di superare nel canto chiunque anche le stesse Muse figlie di Zeus signore dellrsquoegida ed esse adirate lo mutilarono e gli tolsero il canto divino e gli fecero dimenticare la cetra 600
[Tr di G Paduano]6 Veniva ricordato anche come autore di poemi cosmogonici e teologici e di una Presa di Ecalia (Οἰχαλίας ἅλωσις) ed era considerato lrsquoinventore del modo musicale dorico NellrsquoOdissea compaiono quattro figure di ἀοιδοί ndash Demodoco alla corte dei Feaci Femio in quella di Odisseo a Itaca un aedo anonimo presso la reggia di Agamennone ad Argo (III 267 ss) e un altro alla corte di Menelao a Sparta (IV 17-19) ndash e per tutti costoro riscontriamo una forma di servizio piugrave o meno costante presso una corte Lrsquoerudizione antica interpretograve i brani dellrsquoOdissea relativi a Femio e a Demodoco come testimonianze su due aedi realmente esistiti nellrsquoetagrave piugrave antica Di conseguenza si attribuigrave a Femio un poema intitolato Il ritorno da Troia dei compagni di Agamennone sulla base di Odissea I 325 ss a Demodoco Le nozze di Afrodite ed Efesto e La presa di Ilio sulla base di Odissea VIII 267-366 e 499-520 Al di lagrave di queste invenzioni erudite egrave tuttavia significativa lrsquoosservazione di Eraclide Pontico (fr 157 Wehrli) secondo cui la poesia di Demodoco e di Femio avrebbe avuto strutture ritmiche non diverse da quelle adottate da Stesicoro e dagli antichi lirici mentre Demetrio Falereo (fr 192 Wehrli) accomunava Automede Demodoco Femio etc come compositori di laquoodi e canzoni per musica e cetra e βάρβιτος e ogni altro strumento musicaleraquo E in effetti possiamo notare che nel canto VIII dellrsquoOdissea viene approntato uno spazio per la danza (χορός) in cui alcuni giovani feaci eseguono evoluzioni orchestiche che accompagnano mimeticamente la rievocazione da parte di Demodoco degli amori segreti di Ares e Afrodite (vv 256-265)
e lrsquoaraldo srsquoalzograve per portare dalla casa del re la cetra incavata Tutti e nove si alzarono gli arbitri scelti del popolo che nelle gare preparavano bene ogni cosa spianarono un coro allargarono bene il campo di gara 260 Srsquoaccostograve lrsquoaraldo recando la cetra sonora a Demodoco ed egli avanzograve fino al centro Lrsquoattorniavano giovani nel primissimo fiore esperti di danze scandirono coi piedi la danza divina Odisseo guardava il balenare dei piedi e stupiva nellrsquoanimo 265
[Tr di GA Privitera]7 Analogamente in Odissea IV 15-19 il canto dellrsquoanonimo aedo presso la corte di Menelao a Sparta egrave associato alle figure di danza eseguite da una coppia di laquoacrobatiraquo8
5 Localitagrave della Trifilia nel Peloponneso 6 Omero Iliade Torino Einaudi-Gallimard 1997 7 OmeroOdissea II testo e commento di JB Hainsworth tr di GA Privitera Milano Mondadori 1981
Letteratura greca [1]
3
Essi cosigrave banchettavano nella gran sala dallrsquoalto soffitto i vicini e i parenti di Menelao glorioso Lietamente tra loro cantava lrsquoaedo divino suonando la cetra in mezzo ad essi due acrobati volteggiavano dando inizio alla danza
[Tr di GA Privitera]9 Alcuni studiosi ritengono che fra VIII e inizio del VII secolo aC ldquoOmerordquo si rivolgesse esclusivamente ai nobili e fondano questa ipotesi da un lato sulla tematica generale dei poemi sullrsquoambiente che fa da sfondo alle vicende narrate sulla mentalitagrave e i sentimenti sottesi alle affermazioni dei singoli personaggi sui rapporti interpersonali che fra di essi intercorrono dallrsquoaltro sullrsquoosservazione che i cantanti serbi di caffegrave-concerto i contadini i pastori e i portatori drsquoacqua neo-greci i pescatori russi etc che le odierne ricerche hanno via via assunto come termini di confronto mostrano unrsquoidentitagrave sociologica comunque diversa da quella dei bardi greci Ma pur se appare innegabile il carattere aristocratico di molta parte del mondo omerico crsquoegrave una serie di dati che suggeriscono per gli aedi una pluralitagrave di possibili uditoricirc fino a comprendere lrsquointera comunitagrave Cosigrave in Odissea XVII 385 lrsquoaedo egrave definito come un laquolavoratore per la collettivitagraveraquo (δημιοεργός) al pari dellrsquoindovino del medico e del carpentiere (un indizio altresigrave che gli aedi erano riuniti in corporazioni o gilde)10 Demodoco canta oltre che nel palazzo di Alcinoo anche di fronte a tutto il popolo dei Feaci (Odissea VIII 254 ss) Esiodo racconta di aver vinto a Calcide in Eubea un tripode nelle gare in onore di Anfidamante (Erga 654-659) e nel Certame di Omero ed Esiodo10 si racconta che Omero recitograve lrsquoinno ad Apollo alla festa panellenica di Delo altrettanto chiaramente collettivo e comunitario egrave lo scenario di pubblico presupposto nellrsquo ldquoomericordquo Inno ad Apollo Anche per quanto riguarda il punto di vista sociologico presupposto dai poemi non si puograve considerare irrilevante lrsquoinsistita preoccupazione nellrsquoOdissea percheacute venga garantita una giustizia capace di frenare i soprusi dei potenti (unrsquoottica che avvicina il poema alle ansie espresse negli Erga da Esiodo) Sembra perciograve piugrave corretto supporre che lrsquoepica omerica volesse e sapesse mediare attraverso il canto fra i valori di unrsquoaristocrazia desiderosa di autorealizzarsi nelle memorie degli avi (veri o presunti) e le prospettive di un piugrave vasto mondo sociale Fonte drsquoispirazione del canto dellrsquoaedo egrave la Musa come rileviamo tanto in relazione a Demodoco (Odissea VIII 44 s τῷ γὰρ ῥα θεὸς περὶ δῶκεν ἀοιδήν τέρπειν ὅππῃ θυμὸς ἐποτρύνῃσιν ἀείδειν laquoa lui in sommo grado un dio donograve il canto a darci diletto comunque il cuore lo spinge a cantareraquo)11 quanto per lrsquoitacese Femio Ma lrsquoazione ispiratrice della Musa non egrave sentita come limitazione della personale originalitagrave del cantore tanto che Femio dichiara a Odisseo ndash nel momento in cui lo supplica di risparmiargli la vita ndash che egli egrave laquoautodidattaraquo anche se un dio ha laquoimpiantatoraquo (ἐνέφυσε) nel suo animo le vie del canto (Odissea XXII 347-49)
αὐτοδίδακτος δ᾽ εἰμί θεὸς δέ μοι ἐν φρεσὶν οἴμας παντοίας ἐνέφυσενmiddot ἔοικα δέ τοι παραείδειν ὥς τε θεῷmiddot τῶ μή με λιλαίεο δειροτομῆσαι Da me solo ho imparato a me un dio nel cuore vie
8 E sullo scudo sbalzato da Efesto si dice (Iliade XVIII 603-605) che laquovʼera molta folla intorno alla danza graziosa rapita due acrobati intanto dando inizio alla festa roteavano intornoraquo [tr di R Calzecchi Onesti] 9 OmeroOdissea I testo e commento di S West tr di GA Privitera Milano Mondadori 1981 10 Anche Esiodo (Erga 25 s) pone lʼaedo accanto a figure artigianali come il vasaio e il carpentiere 11 Cfr anche vv 62 s τὸν πέρι Μοῦσ᾽ ἐφίλησε δίδου δ᾽ ἀγαθόν τε κακόν τε ὀφθαλμῶν μὲν ἄμερσε δίδου δ᾽ ἡδεῖαν ἀοιδήν laquola Musa molto lo amograve ma un bene e un male gli dava degli occhi lo fece privo e gli donograve il dolce cantoraquo e v 73 Μοῦσ᾽ ἄρ᾽ ἀοιδὸν ἀνῆκεν ἀειδέμεναι κλέα ἀνδρῶν laquola Musa ispirava il cantore a cantare imprese gloriose di uominiraquo
Letteratura greca [1]
4
molteplici impiantograve e credo che davanti a te canterei come davanti a un dio dunque non volermi trucidare
Come spesso accade in Omero azione umana e azione divina risultano complementari qui ciograve che appare una manifestazione di autonomia e di originalitagrave se osservato sul piano umano (Femio vuol dire che non ha avuto maestri nellrsquoarte e soprattutto che egrave solito cantare sospinto dallrsquoimpulso del suo θυμός cfr il giagrave ricordato Odissea VIII 45 ὅππῃ θυμὸς ἐποτρύνῃσιν ἀείδειν) si prospetta come azione esterna se considerato dal punto di vista dellrsquointervento divino Analogamente il carattere tradizionale dei temi e degli episodi sviluppati dagli aedi non blocca lrsquoaffermarsi di unrsquoesigenza di originalitagrave come dice Telemaco alla madre in Odissea I 351 s
τὴν γὰρ ἀοιδὴν μᾶλλον ἐπικλείουσ᾽ ἄνθρωποι ἥ τις ἀϊόντεσσι νεωτάτη ἀμφιπέληται quel canto piugrave celebrano gli uomini che intorno giunge piugrave nuovo agli uditori
Il canto epico egrave una οἴμη (Odissea VIII 481 e XXII 347) la laquoviaraquo o traccia narrativa che il poeta puograve scegliere allrsquointerno del repertorio tradizionale e seguire laquoper ordineraquo (κατὰ κόσμον) partendo da un punto determinato (cfr Iliade I 4 ἐξ οὗ laquoda quandoraquo Odissea VIII 500 ἔνθεν laquoda doveraquo) Di tanto in tanto lrsquoaedo sospende la sua esecuzione (Odissea VIII 87 ὅτε λήξειε ἀείδων laquoquando interrompeva il cantoraquo) poi riprende eventualmente sollecitato dal pubblico (ibid 90 s αὐτὰρ ὅτ᾽ ἂψ ἄρχοιτο καὶ ὀτρύνειαν ἀείδειν Φαιήκων οἱ ἄριστοι ἐπεὶ τέρποντ᾽ ἐπέεσσιν laquoma quando ricominciava e lo spingevano al canto i principi dei Feaci poicheacute godevano dei suoi versiraquo) Anche lrsquouditorio come abbiamo giagrave detto puograve infatti richiedere la scelta di un determinato tema come fa Odisseo quando in Odissea VIII 487 ss chiede che Demodoco gli canti la storia del Cavallo di legno Drsquoaltra parte la poesia orale tradizionale doveva avere un respiro limitato circoscritto al tempo di una singola esecuzione (un pomeriggio o una sera) e non a caso Femio e Demodoco eseguono pezzi che occupano una parte limitata delle ore successive alla cena Da questo punto di vista lrsquoautore (o gli autori) dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea ci appare come un poeta orale estraneo alla norma capace di esibirsi nellrsquoarco di molte ore (almeno una ventina) distribuite in diversi giorni e sedute La leggenda di Omero Ci sono giunte sette biografie di Omero tutte di etagrave post-classica anche se non egrave escluso che alcune parti e alcuni motivi narrativi risalgano fino allrsquoetagrave arcaica (e in particolare a Teagene di Reggio vissuto nel VI secolo aC) Costruita a posteriori ed esposta con ricchezza di dettagli in un racconto egrave anche la leggenda di un agone poetico svoltosi a Calcide in Eubea fra Omero ed Esiodo in occasione dei ludi funebri (a cui Esiodo effettivamente partecipograve come sappiamo da Erga 654-659) per il principe Anfidamante si tratta del cosiddetto Certamen Homeri et Hesiodi che nella forma in cui ci egrave pervenuto12 risale al II secolo dC ma si basa su modelli piugrave antichi (in particolare sul Museo del retore del IV secolo aC Alcidamante) La prova si apre con un gioco di domande e risposte fra i due poeti poi ciascuno recita un passo delle proprie opere il pubblico inclinerebbe a conferire il premio a Omero ma il figlio del defunto assegna la vittoria ad Esiodo in quanto poeta della pace e dellrsquoagricoltura (sect 13)
12 Cfr Homeri opera V 218-238 Allen Possediamo qualche resto di una versione piugrave antica grazie alla testimonianza di un papiro del III secolo aC (P Flinders Petrie 25) pubblicato nel 1891
Letteratura greca [1]
5
Anche in questa fase dellrsquoagone gli Elleni sbalorditi applaudivano Omero percheacute i versi erano superiori ad ogni aspettativa e chiedevano che gli assegnassero la vittoria Il re perograve incoronograve Esiodo dichiarando che era giusto che vincesse chi esortava allrsquoagricoltura e alla pace e non colui che narrava guerre e stragi
[Tr di F De Martino]13 LrsquoOmero della leggenda biografica (ne diamo qualche cenno prendendo come base la biografia falsamente attribuita ad Erodoto)14 si sarebbe chiamato Melesigene (laquoNato presso il Meleteraquo) e sarebbe nato a Smirne da una certa Creteide di Cuma resa incinta da uno sconosciuto e condotta dal padre adottivo (Cleanatte di Argo) presso un suo amico a Smirne appena fondata Da giovane Melesigene (che non egrave nato cieco) apprende i rudimenti dellrsquoarte epica da un certo Femio un maestro di cui eredita la scuola quindi srsquoimbarca sulla nave di un certo Mente di Leucade per conoscere il mondo e arriva (dopo aver visitato Etruria e Spagna) anche a Itaca dove si ammala e abbandonato da Mente viene ospitato dallrsquoitacese Mentore Ripreso il mare con Mente (tornato a Itaca a prelevarlo) a Colofone perde la vista (di qui piugrave tardi il soprannome di Omero in quanto ὁ μὴ ὁρῶν laquocolui che non vederaquo laquociecoraquo)15 Fatto ritorno nella nativa Smirne inizia il mestiere di poeta ha successo ma presto cade in miseria e decide di trasferirsi a Cuma dove (dopo un soggiorno in una colonia cumana presso il cuoiaio Tichio) recita i suoi versi nei ritrovi degli anziani La sua fama si diffonde al punto che Melesigene chiede di esser mantenuto a spese pubbliche Di fronte al rifiuto del Consiglio cittadino maledice Cuma e si trasferisce prima a Focea dove declama di nuovo i suoi poemi nelle sale pubbliche poi a Eritre e a Chio dove intende vendicarsi di un certo Testoride che a Focea gli aveva promesso cibo e alloggio in cambio del lascito ereditario dei poemi e invece era fuggito alla volta di Chio dopo averli trascritti sotto dettatura Ma a Chio MelesigeneOmero si smarrisce fincheacute arriva alla masseria di un pastore di capre di nome Glauco che lo conduce presso il suo signore a Bolisso Qui egrave assoldato come precettore e per i figli di costui posti sotto le sue cure compone fra lrsquoaltro la Batracomiomachia Indi si reca nella capitale dellrsquoisola apre una scuola di versificazione prende moglie (da cui ha due figlie) e intanto continua a lavorare a Iliade e Odissea Riprende i viaggi approdando prima a Samo e poi a Ios dove si ammala e giace infermo sulla spiaggia qui alcuni giovani pescatori gli propongono lrsquoindovinello dei pidocchi (laquoquanto prendemmo lasciammo ciograve che non prendemmo portiamoraquo) giagrave noto a Eraclito (22 B 56 D-K) e muore per la rabbia di non aver saputo risolverlo o per la fiacchezza (come lrsquoautore della biografia preferisce immaginare) Non sono mancati tentativi fra cui si distingue per acume quello compiuto da Wolfgang Schadewaldt16 di estrarre dalle Vite superstiti unrsquoimmagine di Omero almeno significativa per la comprensione del mestiere dellrsquoaedo nellrsquoVIII-VII secolo aC17 Senoncheacute come egrave stato
13 Omero quotidiano Vite di Omero Venosa Edizioni Osanna 1984 14 Molto dibattuta egrave la questione della data di origine della biografia pseudo-erodotea ma il testo che possediamo rappresenta probabilmente la piugrave tarda rielaborazione di un racconto composto nel V-IV secolo aC verosimilmente ndash come suppose F Jacoby (Kleine philologische Schriften I Berlino 1961 11 s) ndash un prodotto di cultura sofistica comparabile con il Certamen di Alcidamante 15 Senoncheacute ὅμηρος egrave parola greca e significa laquoostaggioraquo e in effetti testimonianze epigrafiche provano che in etagrave arcaica genitori greci potevano dare al proprio figlio questo nome 16 Homer und sein Jahrhundert in Id Von Homers Welt und Werk Stoccarda 19593 87-129 17 Per Eratostene Omero sarebbe stato contemporaneo della guerra di Troia da lui datata al 1194-1184 invece per Erodoto (II 53) Omero ed Esiodo sarebbero stati coetanei e sarebbero vissuti circa 400 anni prima di lui cioegrave alla metagrave del IX secolo (II 53 2 laquoRitengo che Esiodo e Omero mi abbiano preceduto in etagrave di quattrocento anni e non di piugrave Sono essi ad aver composto per i Greci una teogonia dando agli dei epiteti dividendo gli onori e le competenze indicando le loro formeraquo [tr di A Fraschetti] Lrsquoanonimo autore di un epigramma (AP XVI 298) dice che sette cittagrave (Smirne Chio Colofone Itaca Pilo Argo Atene) si contendevano i suoi natali
Letteratura greca [1]
6
opportunamente osservato18 non solo la maggior parte delle vicende di questa ldquobiografiardquo egrave desunta proprio dai poemi omerici e specialmente dallrsquoOdissea e non solo contiene molti elementi manifestamente ridicoli ma soprattutto laquolrsquoOmero di questa leggenda egrave un cantore mendicante cieco che si intrattiene con gente semplice con calzolai pescatori e vecchi nei ritrovi delle cittagrave portuali un precettore che insegna a leggere e a scrivere e che dunque ha rapporti soprattutto con fanciulli un estemporaneo coniatore di versi ammirato soltanto dalla piccola borghesia e una sola volta nellrsquoepisodio del signore di Bolisso in contatto con il ceto elevato davanti alle cui case del resto egrave solito andare a mendicare doni con canzoni da lui stesso composte [] Chi ha delineato questrsquoimmagine di poeta ndash non importa se con intenzioni parodistiche o meno ndash aveva davanti a seacute un compositore di versi collocato nella fascia bassa di un certo ceto professionale che si egrave potuto sviluppare in questa forma solo quando i commerci e gli affari le cittagrave e le comunitagrave avevano raggiunto una piena fioritura scalzando lrsquoantica struttura aristocratica della societagrave quando cioegrave giagrave dominava la borghesia e si richiedeva piugrave spirito imprenditoriale (si pensi alla fondazione di scuole) che beni patrimoniali La condizione professionale dei rapsodi era questa artisti di declamazione paragonabili ai nostri cantanti da concerto che allora come oggi andavano in tourneacutee e che si caratterizzavano per recitare non opere da loro stessi composte ma solo grandi capolavori altrui La leggenda di Omero attribuisce questa vita di rapsodo anche al grande poeta dellrsquoetagrave arcaica i creatori di tale leggenda non conoscevano infatti al loro tempo un altro tipo di aedoraquo Dunque gli antichi non conoscevano nulla di definito sulla vita e sulla personalitagrave di Omero ciograve che possiamo ricostruire si deve basare da un lato sul modello di aedo quale emerge dai poemi (e quale piugrave sopra abbiamo cercato di sintetizzare) dallrsquoaltro su una ricognizione degli elementi costitutivi dellrsquoarte epica Il verso dellʼepica Lrsquoesametro (giagrave Erodoto usa per lrsquoesametro dattilico espressioni come ἐν ἑξαμέτρῳ τόνῳ [I 47 2] e ἐν ἔπεσι ἑξαμέτροισι [VII 220 3]) si presenta esteriormente come una successione di sei dattili di cui lrsquoultimo catalettico (con la possibilitagrave per lrsquoultimo elemento in virtugrave della pausa di fine di verso di essere realizzato indifferentemente da sillaba breve o lunga u) Le due brevi dei singoli dattili potevano essere ldquosostituiterdquo da una lunga costituendo uno spondeo (di qui la denominazione per ciascun elemento in posizione pari di biceps y) una facoltagrave molto ridotta nel quinto dattilo che si presenta generalmente in forma pura (le eccezioni sono allincirca di un caso su 18 versi) Il verso appare articolato attraverso punti di incisione le cosiddette laquocesureraquo (τομαί laquotagliraquo) le piugrave frequenti interessano il terzo metro venendo a cadere o dopo il suo elemento lungo (cesura maschile o pentemimere laquodopo il quinto mezzo piederaquo) o tra le due brevi del biceps (cesura femminile o trocaica) piugrave rara la cesura dopo il quarto elemento lungo (eftemimere laquodopo il settimo mezzo piederaquo) e subordinata ad altra cesura principale quella dopo il secondo elemento lungo (tritemimere laquodopo il terzo mezzo piederaquo) Fine di parola puograve ricorrere anche dopo il quarto dattilo (dieresi [διαίρεσις laquodivisioneraquo] bucolica cosigrave denominata dal largo uso che ne faranno i poeti bucolici drsquoetagrave ellenistica) Di qui lo schema seguente
a1 a2 m f r b ndash y ndash y ndashkk ndash y ndash kk ndash u
18 J Latacz Omero il primo poeta dellrsquoOccidente (1989) Laterza Roma-Bari 1990 28 s
Letteratura greca [1]
7
dove a1 e a2 segnalano allrsquointerno della prima metagrave del verso le posizioni che in alternativa reciproca tendono a coincidere con fine di parola m e f le posizioni della cesura principale rispettivamente maschile o pentemimere (m) e femminile o trocaica (f) r la posizione della cesura eftemimere b la posizione della dieresi bucolica Viene evitata la fine di parola dopo il terzo metro cosigrave da escludere una bipartizione simmetrica del verso Un punto in cui la fine di parola egrave tendenzialmente evitata egrave quello dopo la prima breve del quarto biceps come fu osservato da G Hermann (donde lrsquoetichetta di laquoponte di Hermannraquo) Solo con Callimaco si afferma anche il divieto che una parola che inizi nel primo metron termini con la prima breve nel secondo biceps (laquoprima legge di Meyerraquo)
PER SAPERNE DI PIUrsquo Teorie sullrsquoorigine dellrsquoesametro Sul problema dellrsquoorigine dellrsquoesametro le teorie si sono succedute numerose allrsquointerno della fondamentale contrapposizione fra chi ha individuato nella sua struttura il risultato della fusione fra preesistenti unitagrave minori e chi invece come Hoekstra (1981) ne ha proposto unrsquointerpretazione fin dallrsquoorigine unitaria Ad es Th Bergk (1854) riconduceva la genesi dellrsquoesametro a due cola lirici preesistenti Wilamowitz (1884) ne faceva il risultato della lunga evoluzione di una struttura lirica avvenuta in parallelo col passaggio dalla canzone lirica (eolica) al laquopiccolo eposraquo e da questo al laquogrande eposraquo A Meillet (1923) postulava unrsquoereditagrave pre-greca (egea) Piugrave recentemente un ritorno alla posizione di Bergk si egrave avuto da parte di ML West (1973) con lrsquoipotesi di una derivazione dellrsquoesametro dallrsquoassociazione fra un hemiepes e un prosodiaco e alla posizione di Wilamowitz nel senso dellrsquoevoluzione di un ferecrateo espanso con lrsquoinserzione centrale di tre dattili con G Nagy (1974) B Gentili (1977) ha cercato di rintracciare coincidenze fra i segmenti costitutivi dellrsquoesametro e i cola della poesia lirica drsquoetagrave arcaica partendo dal dato per cui gli schemi metrici che appaiono in alcune iscrizioni arcaiche e nella lirica di Stesicoro (hemiepes enoplio reiziano coriambico adonio etc) sono gli stessi che sembrano plasmare tutte le formule piugrave tradizionali dellrsquoesametro omerico (per unrsquoesposizione sintetica di questa teoria cfr B Gentili-L Lomiento Metrica e ritmica Storia delle forme poetiche nella Grecia antica Milano Mondadori Universitagrave 2003 pp 279-283)
La formularitagrave Il fenomeno della formularitagrave si puograve definire come la ripetizione di versi interi o di segmenti di versi specialmente nellrsquoambito di situazioni tipiche ad es per laquoquando sorse lrsquoauroraraquo troviamo usato per due volte nellrsquoIliade e in ben venti casi nellrsquoOdissea il verso
ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς e quando mattutina apparve Aurora dalle dita di rosa
Ma il caso piugrave comune di formularitagrave egrave quello rappresentato dai nessi standardizzati nomeepiteto come quelli che vengono applicati ai rispettivi protagonisti dei due poemi πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς (31 volte) e πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς (38 volte) ambedue formule clausolari ma di diversa estensione poicheacute (se riandiamo allo schema riprodotto al paragrafo precedente) esse arrivano entrambe alla fine del verso ma partendo la prima da r la seconda da f Esempi
Letteratura greca [1]
8
r Iliade I 58 τοῖσι δrsquo ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς f Odissea VIII 97 Ὣς ἔφατrsquo οὐδrsquo ἐσάκουσε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς Piugrave in particolare se consideriamo le singole articolazioni minori del verso riscontriamo che a) nel segmento iniziale si incontrano con alta frequenza brevi nessi che contengono congiunzioni pronomi e particelle connettive o avversative ad es fino ad a1 () αὐτὰρ ὁ δή ποτε ὣς τότε καὶ τότε ὣς ὁ μέν fino ad a2 () αὐτὰρ ἐπεί ἀλλ᾽ ὅτε δή ἔνθ᾽ ἄλλοι τοὶ μὲν ἔπειτ᾽ b) nel segmento centrale che va da m o da f fino a r o a b compare spesso il predicato verbale su cui gravita la frase (si veda a titolo di esempio il verso di Iliade sopra citato nel quale μετέφη si estende appunto da m a r) m r Iliade I 58 τοῖσι δrsquo ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς c) il segmento finale (a partire da r o da b) rappresenta il piugrave ricco serbatoio di nessi formulari innanzi tutto come nel caso di πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς le formule nome proprioepiteto ma anche molti casi di associazione fra nome comune ed epiteto ad es ξίφος ἀργυρόηλον φόρμιγγα λίγειαν πατρίδος αἴης θούριδος ἀλκή μώνυχες ἵπποι ὀξέϊ χαλκῷ πότνια μήτηρ Le formule tendono a organizzarsi in sistemi caratterizzati dalle tendenze complementari allrsquoestensione e allrsquoeconomicitagrave a) il principio dellrsquoestensione si connette alla tendenza dellrsquoepica a produrre nessi formulari atti a coprire tutto ciograve che nella narrazione sia tipico costante ripetitivo e a dislocare le formule coprendo le varie partizioni del verso ad es per Ettore troviamo tre formule finali di diversa estensione (φαίδιμος Ἥκτωρ κορυθαίολος Ἥκτωρ e μέγας κορυθαίολος Ἥκτωρ e una formula iniziale (Ἥκτωρ Πριαμίδης) b) il principio complementare al primo dellrsquoeconomia (o del risparmio) corrisponde al fatto che per esprimere una medesima idea essenziale esiste generalmente nella dizione epica una e una sola espressione che occupi una determinata unitagrave minore del verso Casi come μελαινάων ἐπὶ νηῶν e ἐϋσσέλμων ἐπὶ νηῶν sono doppioni apparenti hanno sigrave la stessa misura metrica ma iniziano lrsquouno in consonante con la connessa possibilitagrave di evitare lo iato o di allungare la sillaba precedente lrsquoaltro in vocale Non mancano tuttavia vere eccezioni come per lrsquohemiepes iniziale νῆας ἐπ᾽ Ἀργείων di Iliade XXIV 298 rispetto al consueto νῆας ἐπὶ γλαφυράς (16 volte) Lrsquouso di formule e soprattutto di sistemi formulari rappresentava per il poeta epico una facilitazione nel comporre improvvisando ma nella lunga evoluzione dellrsquoepica e specialmente al momento della definitiva fissazione di poemi monumentali come lrsquoIliade e lrsquoOdissea la
Letteratura greca [1]
9
sempre piugrave estesa memorizzazione di ampie zone di testo il lavorio di riflessione sui singoli episodi e sui nessi e i parallelismi fra gli episodi stessi e la scoperta di inedite possibilitagrave espressive connesse alla modificazione di formule tradizionali dovettero incoraggiare i poeti a uno sfruttamento consapevole e artisticamente meditato del ldquogioco delle formulerdquo Da un lato procedimenti come lrsquoaddensamento degli epiteti la sostituzione di un epiteto convenzionale con uno non convenzionale (con la creazione di un nesso nuovo di struttura metrica eventualmente diversa) il trasferimento di un epiteto da un referente a un altro creano nei poemi una continua tensione tra formularitagrave e superamento della formularitagrave dallrsquoaltro la rete delle corrispondenze a distanza generata dalla ripetizione di un determinato modulo permette al poeta di variare e approfondire un motivo e di sottolineare i parallelismi o le dissonanze fra determinate situazioni La guerra di Troia Schliemann e la riscoperta di Troia In etagrave moderna la riscoperta della cittagrave di Troia situata sullrsquoodierna collina di Hissarlik e sovrastante la bassa pianura attraversata dallo Scamandro a sud del promontorio del Sigeo si lega agli scavi di Heinrich Schliemann (1822-1890) che a partire dal 1866 si dedicograve al disseppellimento delle rovine di Micene di Tirinto e di altri siti micenei e appunto di Troia Nel corso del tempo si egrave venuta creando attorno alla personalitagrave di questo archeologo dilettante una sorta di leggenda a cui egli stesso contribuigrave con le autobiografie Ilios (1881) e Troja (1884) nel senso di un dilettantismo romantico di scavi avventurosi condotti con sorprendenti successi ma senza alcun rigore di metodo di un amore cieco e totale per Omero e per lrsquoEllade E in effetti oggi sappiamo che lrsquoaver percorso la Grecia e lrsquoAsia minore sulle vie di Omero non impedigrave a Schliemann a Micene di attribuire allrsquoepoca di Agamennone tombe anche di quattro secoli piugrave antiche neacute a Troia di identificare con la cittagrave omerica uno strato risalente a una fase che va dal 2300 al 2100 aC Errori del genere non dipesero tuttavia da un entusiasmo velleitario quanto dalla carenza allrsquoepoca di competenze archeologiche che potessero orientarlo verso una piugrave plausibile cronologia di reperti e di strati Occorre poi tener conto che lo strato dei materiali riferibili alla Troia omerica (o almeno a quella che oggi noi identifichiamo con la cittagrave omerica Troia VIIa) era conservato unicamente nel suo margine esterno dato che gli strati superiori della collina di Hissarlik (con le fondamenta dei palazzi e dei templi) erano stati demoliti in epoca ellenistica per realizzare il terrazzamento del suolo su cui vennero edificati nuovi templi Fu soprattutto per questa ragione che Schliemann si spinse con le proprie maestranze a scavare sempre piugrave in profonditagrave saltando gli strati del secondo millennio Dove perograve il problema consisteva nellrsquoidentificazione di un sito sulla scorta della comparazione fra gli antichi racconti e il panorama attuale Schliemann conseguigrave notevoli successi in primo luogo identificando con la collina di Hissarlik quellrsquoacropoli omerica che lrsquoopinione comune dalla fine del XVIII secolo individuava invece nel villaggio di Bunarbaschi situato su un colle a 15 km dal promontorio del Sigeo e la disputa era stata viva giagrave nellrsquoantichitagrave Ellanico di Lesbo verso il 400 aC aveva sostenuto nei suoi Troica che la Ilio del suo tempo sorta presso la collina di Hissarlik e la Ilio omerica occupavano lo stesso sito invece Demetrio di Scepsi (fr 26 Gaede) si era pronunciato per una collina a circa 9 km a sud sullrsquoaltra riva dello Scamandro La missione americana guidata nel 1932-1938 da CW Blegen e le piugrave recenti indagini sul territorio hanno offerto un quadro molto piugrave articolato e differenziato Sulla base di un nuovo diagramma la cittagrave che sorgeva al momento in cui Eratostene di Cirene fissava la caduta di Troia (1184) viene a coincidere con Troia VIIa non piugrave con quella che Schliemann chiamava laquoterza cittagraveraquo (corrispondente a Troia II) ma nemmeno come voleva W Doumlrpfeld con Troia VI (andata in rovina verso il 1300 in seguito a un terremoto) Gli scavi piugrave recenti Secondo le conclusioni di Manfred Korfmann (cfr Korfmann 2002) che ha diretto lrsquoeacutequipe dellrsquoUniversitagrave di Tubinga negli scavi piugrave recenti lrsquoantica Troia intorno al 1184 cessograve di essere abitata ma lrsquoinsediamento continuograve nellrsquoarea della rocca per circa due secoli dopo la distruzione
Letteratura greca [1]
10
della cittagrave (Troia VIIb) Verso il 700 il luogo chiamato laquoIlioraquo era largamente in rovine anche se in etagrave arcaica dovette continuare a essere frequentato come luogo di culto Il problema che si dovettero porre nellrsquoVIII secolo aC lsquoOmerorsquo o i suoi modelli dovette essere quello di rendere il racconto della guerra di Troia plausibile a un pubblico che aveva familiaritagrave con la geografia locale (lrsquoIliade offre indicazioni realistiche ad es sulla navigazione dellrsquoEgeo in IX 362 s e sulla visibilitagrave dellrsquoisola di Samotracia dalla piana di Troia in XIII 11-14) che si trattasse di genti che risiedevano nel Sigeo o in altre cittagrave vicine o di abitanti della stessa Ilion che nellrsquoVIII secolo era di nuovo attiva sia pure soltanto come centro cultuale Il santuario sorgeva allrsquointerno di una depressione naturale a sud-ovest della rocca lungo la vecchia via che conduceva alla rocca stessa Omero menziona due templi quello di Apollo e quello di Atena e le loro loro rovine sono tuttora riconoscibili I visitatori che giungevano al santuario dal Sigeo attraverso la piana dello Scamandro potevano vedere le rovine della rocca Ma - ci si chiede - quando ebbe fine il nucleo della cittagrave di Troia cantata da Omero Nel bastione a nord-est della rocca egrave stata trovata una larga e profonda cisterna con un condotto che proviene da una sorgente La sorgente fu abbandonata al piugrave tardi al tempo di Troia VIIb2 prima del 1100 A partire dal 1000950 non rimase a Troia alcun insediamento significativo Troia era molto piugrave larga di quanto ritenesse Schliemann Un fossato largo 3 m e profondo 15 completato durante lrsquoultima fase di Troia VI o al principio di Troia VIIa (cioegrave intorno al 1300) la circondava Poi esso fu rimpiazzato a sud da un fossato piugrave ampio e concentrico al primo completato verso il 1200 Il sistema di fortificazione si estendeva per quasi 2 km e pertanto racchiudeva unrsquoarea di circa 270000 m2 La rocca e la cittagrave bassa dovevano presentarsi al tempo di Omero come un imponente complesso di rovine I nuovi colonizzatori del Sigeo e di altri siti incontrarono un vasto campo attraversato da sentieri che seguivano i vecchi tracciati Negli scavi fatti nei quartieri della cittagrave bassa a sud-ovest della rocca poco fuori del muro si egrave scoperto un deposito bruciato verso la fine di Troia VI e di nuovo verso la fine di Troia VIIa (verso il 1200) La prima devastazione egrave da ricollegarsi a un terremoto ma la seconda sembra dovuta a unrsquoazione di guerra come suggerisce anche il rinvenimento di corpi insepolti o semisepolti e di depositi contenenti armi non utilizzate Verso il 1300 la porta principale di Troia era stata bloccata e ostruita percheacute qui lrsquoantico muro era in condizioni precarie e pertanto rappresentava lrsquoanello piugrave vulnerabile nel sistema di difesa Giagrave W Doumlrpfeld aveva richiamato Iliade VI 433 s (Andromaca a Ettore)
Piazza lrsquoesercito presso il fico selvatico dove egrave piugrave facile Lrsquoaccesso alla cittagrave e il superamento delle mura
In questa zona solo poco piugrave di 80 m separavano il muro della cittagrave bassa dal muro della rocca Gli epiteti omerici di Troia - laquoben costruitaraquo laquofertileraquo laquovastaraquo laquosacraraquo laquoertaraquo laquoventosaraquo laquodalle belle muraraquo laquodai bel puledriraquo - si adattano ai dati topografici ossa di cavalli sono state trovate sul terreno forti venti soffiano continuamente in estate Anche le sorgenti sono identificabili presso la porta principale cfr Iliade XXII 145-157
Passarono oltre il posto di vedetta e lrsquoalbero di fico battuto dal vento e allontanandosi sempre piugrave dalle mura si lanciarono lungo la strada Giunsero alle fontane dalle belle acque dove sgorgano due correnti dello Scamandro impetuoso una di acqua calda da cui si leva un vapore come da fuoco ardente lrsquoaltra che in piena estate versa acqua gelata come la grandine la fredda neve o il ghiaccio Vi sono accanto dei lavatoi di pietra larghi belli dove le mogli e le belle figlie dei Teucri lavavano le splendide vesti prima in tempo di pace prima che giungessero i figli dei Danai
[Tr di MG Ciani] In effetti gli scavi nellrsquoarea della caverna in cui egrave situata la sorgente hanno portato alla luce una struttura simile a una miniera con tre gallerie e altri bracci tributari creata per fornire acqua Lrsquoacqua scorreva attraverso una superficie rocciosa e poi in un canale artificiale che a sua volta raggiungeva un sistema di quattro lsquodepressionirsquo o lsquofossersquo circolari scavate nella roccia della
Letteratura greca [1]
11
misura di quasi 1 m di diametro (appunto parrebbe i πλυνοί hellip λαΐνεοι i laquolavatoi di pietraraquo ricordati da Omero) Achei e Troiani Fra XIII e XII secolo aC Troia era un grande centro politico e commerciale in grado di controllare lrsquoaccesso ai Dardanelli (lrsquoantico Ellesponto) e il trasporto su terra di beni di vario genere dalla costa egea al Mar di Marmara (lrsquoantica Propontide) e al Mar Nero In Troia VIIa egrave stata rinvenuta ceramica micenea del periodo noto come Tardo Elladico IIIB che egrave anche il periodo di maggiore splendore dei palazzi micenei sul continente greco Ersquo suggestiva lrsquoidentificazione piugrave volte avanzata in tempi recenti di TroiaIlio con Wilusa la cittagrave menzionata spesso in testi hittiti e oggetto di contesa fra gli Hittiti e quegli Ahhiyawa il cui nome sembra identificarsi con quello degli laquoAcheiraquo (Ἀχαιοί) Il documento piugrave significativo in proposito egrave il preambolo del trattato stipulato verso il 1280 aC fra il re hittita Muwattali II e Alaksandu re di Wilusa che contiene un richiamo alle precedenti relazioni fra i due stati a partire dal 1600 pur ricordando che un tempo Wilusa era sotto il dominio hittita Muwatalli afferma di aver mantenuto relazioni pacifiche anche dopo che la cittagrave era divenuta indipendente Inoltre un testo religioso hittita rinvenuto a Hattusa la capitale dellrsquoimpero hittita e databile al XIII secolo ricorda nellrsquoambito di un rituale la recita di un poema in luvio (il luvio egrave una lingua indo-europea che si distingue solo superficialmente dallrsquohittita) di cui viene riportato il primo verso laquoQuando tornarono dallrsquoerta Wilusaraquo E a Troia negli scavi piugrave recenti egrave stato trovato un sigillo con unrsquoiscrizione in luvio Drsquoaltra parte in Omero la dinastia reale troiana di cui egrave a capo Priamo figlio di Laomedonte viene fatta risalire attraverso Erittonio Troo e Ilo fino a Dardano eponimo dei Dardani che si erano stanziati nella Troade a nord del monte Ida (Iliade ΧΧ 215 ss) I Dardani nellrsquoIliade compaiono fra i principali alleati dei Troiani accanto ai contingenti provenienti da Zelea (a nord-est lungo il fiume Esepo) e a quelli di localitagrave situate sulla Propontide come Adrestea e Pitea e sulla costa asiatica dellrsquoEllesponto come Abido e Arisbe Dalla costa europea arrivano invece i Traci i Ciconi e i Peoni da oriente i Paflagoni e gli Alizoni da sud-est i Misi e i Frigi dalla zona sud-occidentale dellrsquoAnatolia i Meoni i Cari e i Lici Se Dardani Peoni Ciconi e Traci fanno parte delle popolazioni traco-frigie che fra XII e XI secolo erano scese dai Balcani in direzione dellrsquoAnatolia (cfr Erodoto 7 73 e Xanto di Lidia FGrHist 765 F 14) i Meoni sono di stirpe lidia mentre i Cari e i Lici appartengono allrsquoambito culturale e linguistico luvio-hittita Comunque sia diversamente che per Erodoto il quale inserisce il rapimento di Elena nel quadro di una serie di torti reciproci in forma di rapimenti di donne fra Greci e barbari (I 2 1) e per i poeti tragici ateniesi del V secolo aC in Omero lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato come un contrasto fra culture diverse I Troiani mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei (detti anche laquoDanairaquo - cioegrave discendenti di Danao - o laquoArgiviraquo in relazione al contingente proveniente dallrsquoArgolide guidato da Agamennone il capo della spedizione) e lo stesso vale per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari in Iliade ΙΙ 867 come laquodi lingua stranieraraquo (βαρβαρόφωνοι) suggerisce che un tale epiteto non sarebbe stato applicabile ai Troiani Infine sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di unrsquoimbarcazione sono altrettanti esempi di quelle che W Arend denominograve laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini comportamentali e tecnologiche del gruppo che le condivide (vedi scheda p xxx) La societagrave omerica
Letteratura greca [1]
12
Nel rapporto fra il mondo omerico e la storia egrave innanzi tutto da sottolineare lrsquoesistenza di un duplice piano di riferimento con talune interferenze dellrsquouno nellrsquoaltro da un lato crsquoegrave lrsquoorizzonte dei fatti collocati in un passato glorioso dallrsquoaltro lrsquoorizzonte del poeta Giagrave gli studiosi alessandrini del resto notavano che dati come lrsquoarte di montare a cavallo i segnali per mezzo della tromba e lrsquouso di bollire la carne compaiono nellrsquoIliade solo allrsquointerno delle similitudini E il testo con una sorta di arcaismo intenzionale mostra talora la consapevolezza dellrsquoabisso che separa passato e presente come quando in Iliade XII 445-449 si dice
Ettore intanto un sasso afferrograve ndash e lo portava ndash che prima stava davanti alle porte largo di sotto ma sopra era a punta questo due uomini i piugrave forti del popolo difficilmente isserebbero da terra su un carro quali son ora i mortali egli da solo lo roteava a suo agio
[Tr di R Calzecchi Onesti] Per contro le condizioni sociali rappresentate nei poemi (un mondo di grandi proprietari terrieri che reggono aziende agricole autarchiche da cui hanno preso tuttavia a distaccarsi alcune figure di artigiani il fabbro il vasaio il carpentiere il medico lrsquoindovino lrsquoaedo) rispecchiano assai piugrave la situazione storica fra VIII e VII secolo a C che le strutture della societagrave micenea Inoltre i cadaveri vengono cremati secondo la prassi piugrave recente non inumati anche se molti riferimenti omerici non rispecchiano necessariamente la pratica normale del tempo di pace trattandosi di cremazioni che avvengono oltremare non ambigua egrave comunque la testimonianza relativa alla prassi umana in generale fornita da Odissea XI 216-222 (Anticlea a Odisseo)
Ohimegrave figlio mio il piugrave misero di tutti gli uomini Persefone la figlia di Zeus non ti inganna ma la legge degli uomini egrave questa quando si muore i nervi non reggono piugrave la carne e le ossa ma la furia violenta del fuoco ardente li disfa appena la vita abbandona le bianche ossa e lrsquoanima vagola volata via come un sogno
[Tr di GA Privitera]19 Un esempio significativo di sovrapposizione tra fasi culturali distinte si coglie osservando lrsquoinventario degli oggetti accanto ad armi vasi ornamenti tipici dellrsquoVIII-VII secolo troviamo relitti risalenti allrsquoepoca micenea come la coppa di Nestore ornata di colombe descritta in Iliade XI 632 ss (simile a una coppa drsquoargento rinvenuta a Micene che riproduce disegno e artigianato dellrsquoetagrave del bronzo) lrsquoelmo di cuoio con zanne di cinghiale che Merione dagrave a Odisseo (Iliade X 261 ss) e lo scudo lungo laquosimile a torreraquo di Aiace che egrave di un tipo inusitato dopo il XIII secolo Un oggetto non riferibile neacute al mondo miceneo neacute allrsquoetagrave della fissazione dei poemi bensigrave alla prima etagrave del ferro egrave invece la coppia di aste da lancio adottate verso il 900 aC e scomparse due secoli dopo con lo sviluppo del combattimento oplitico e la reintroduzione dellrsquoasta per colpire e la menzione delle navi fenicie (una volta nellrsquoIliade e cinque volte nellrsquoOdissea) riflette la loro comparsa nellrsquoEgeo nel IX secolo aC Non diversamente sembra avvenire anche per le istituzioni politiche lrsquo ἄναξ egrave visto a volte come figura di autocrate assoluto a volte fortemente limitato dai poteri delle assemblee ndash sia quella dei capi (βουλή) sia quella delle truppe (ἀγορή) ndash o insidiato dallrsquoascesa dei gruppi aristocratici mentre il βασιλεύς non egrave piugrave il dignitario della societagrave micenea ma genericamente un principe o un capo LʼIliade
19 Omero Odissea III intr testo e commento di A Hoekstra tr di GA Privitera Mondadori Milano 1984
Letteratura greca [1]
13
LrsquoIliade (Ἰλιάς) consta di circa 15690 esametri divisi secondo una partizione che potrebbe risalire al primo editore alessandrino (Zenodoto di Efeso) in 24 libri indicati con le lettere maiuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquounitagrave strutturale di parecchi canti che spesso finiscono col tramonto o iniziano con lrsquoalba e la coincidenza fra alcuni dei titoli attribuiti a ciascun canto nelle edizioni alessandrine e quelli che si rintracciano in autori precedenti (ad es Tucidide [I 10 4] cita il ldquoCatalogo delle navirdquo cioegrave il canto II) provano che non si trattograve di una divisione arbitraria bensigrave fondata almeno in certa misura sulle abitudini dei rapsodi Tema dellrsquoopera non egrave lrsquointero assedio decennale di Troia da parte dei Greci (di norma detti Achei o Danai o Argivi) provocato dal rapimento di Elena ad opera di Paride ma una porzione assai limitata del conflitto una sequenza narrativa che copre la durata di 51 giorni e si colloca verso la fine del nono anno di guerra lrsquoira di Achille contro lrsquoAtride Agamennone il suo ritiro dalla guerra e le relative conseguenze la fine dellrsquoira lrsquouccisione e i funerali di Ettore Fu proprio questa delimitazione tematica a consentire la realizzazione di quellrsquounitagrave e compiutezza dellrsquoazione che giagrave Aristotele individuava come uno dei pregi essenziali dellrsquoopera di Omero rispetto agli altri poemi epici arcaici (Poetica 1459a-b)20
anche in questo Omero deve apparire mirabile in confronto agli altri per non aver tentato di rappresentare intera la guerra anche se essa aveva un principio e una fine il racconto sarebbe risultato troppo grande e non abbracciabile con uno sguardo oppure pur misurato nella grandezza intricato per la varietagrave Ricavatane invece una parte ha fatto uso di molti episodi per esempio con il ldquoCatalogo delle navirdquo e con altri episodi fa procedere in lungo il poema Gli altri invece come lrsquoautore delle Ciprie o della Piccola Iliade compongono unrsquoazione multipla su unrsquounica persona o un unico tempo Di conseguenza mentre dallrsquoIliade e dallrsquoOdissea si ricava unrsquounica tragedia o soltanto due da ciascuna dalle Ciprie parecchie
[Tr di D Lanza]21
Canto I Lrsquoazione si apre sul campo degli Achei devastato dalle frecce scagliate da Apollo [T1] il dio ha scatenato una pestilenza percheacute Agamennone ha rifiutato il riscatto offerto dal sacerdote Crise per la liberazione della figlia Criseide divenuta schiava dellrsquoAtride Ai guerrieri convocati in assemblea lrsquoindovino Calcante rivela che la sola via di scampo egrave la restituzione di Criseide al padre Agamennone acconsente ma solo a patto che gli venga data in cambio Briseide la schiava che Achille tiene nella sua tenda come premio personale (γέρας) ricevuto dagli altri guerrieri Achille non puograve opporsi alla prevaricazione dellrsquoAtride ma non egrave disposto a subire passivamente lrsquooltraggio e insulta Agamennone anzi egrave giagrave pronto a estrarre la spada dal fodero per farsi giustizia quando viene trattenuto da Atena apparsa allrsquoimprovviso allora si ritira nella tenda giurando che non combatteragrave piugrave [T2] Quindi invoca la madre Tetide che dopo essere apparsa al figlio sulla riva del mare intercede presso Zeus e ottiene la promessa che i Greci non vinceranno la guerra e non espugneranno Troia fincheacute Achille non riceveragrave soddisfazione per lrsquooffesa subita Ma il piano di Zeus non resta celato ad Era che ingelosita provoca una lite nel corso del banchetto degli dei tuttavia la visione di Efesto zoppicante che funge da coppiere suscita lrsquoilaritagrave dei numi e riporta la serenitagrave Canto II Quella stessa notte Zeus manda ad Agamennone un sogno ingannatore per incitarlo ad attaccare Troia LrsquoAtride riferisce il sogno agli anziani e comanda lrsquoadunata dellrsquoesercito
20 Cfr anche 1462b ταῦτα τὰ ποιήματα συνέστηκεν ὡς ἐνδέχεται ἄριστα καὶ ὅτι μάλιστα μιᾶς πράξεως μίμησις (laquoQuesti poemi sono composti come meglio non si puograve e son il piugrave possibile imitazione di unrsquounica azioneraquo) 21 Aristotele Poetica Milano Rizzoli 19902
Letteratura greca [1]
14
con lrsquoidea stravagante di saggiare lrsquoumore delle truppe proponendo il ritorno in patria Gli uomini incitati da Tersite corrono alle navi pronti a salpare ma vengono bloccati da Odisseo e da Nestore Egrave significativo che Tersite lrsquoanti-eroe riecheggi le accuse di Achille ad Agamennone sottolineando gli onori di cui questi gode e prenda le parti di Achille [T3] Per tutta la seconda parte del libro lrsquoazione viene interrotta per far posto alla grandiosa uscita in armi dellrsquoesercito acheo dal recinto delle navi un quadro scintillante ornato da una catena di sei similitudini concatenate introdotte per illustrare il fulgore delle armi il rombo dei passi umani e degli zoccoli precipitosi lrsquoaspetto della schiera achea e la maestria dei condottieri Un ldquoCatalogo delle navirdquo contiene lrsquoelenco circostanziato delle genti greche che hanno preso parte allrsquoassedio ed egrave seguito da un catalogo piugrave breve e piugrave arido degli alleati dei Troiani accorsi in difesa di Ilio Canto III Lrsquoatteso scontro tra gli schieramenti appena passati in rassegna non ha luogo ParideAlessandro ottiene infatti una tregua per sfidare Menelao Iride la messaggera degli degravei spinge Elena ad accorrere alle mura presso le porte Scee per assistere al preannunciato duello di ligrave Priamo e gli altri anziani di Troia osservano la pianura Su richiesta del vecchio sovrano (una richiesta che sarebbe stata piugrave ldquoverosimilerdquo al primo anno di guerra) Elena nomina i piugrave prestigiosi campioni achei [T4] Nel duello che segue Paride si trova ben presto a mal partito contro Menelao ma Afrodite lo sottrae ai colpi del nemico avvolgendolo in una fitta nebbia e lo riporta nelle sue stanze dove dopo aver assunto lrsquoaspetto di una vecchia filatrice ordina a Elena di giacere con lui Elena si ribella ma la dea non transige Mentre Paride ed Elena si uniscono nellrsquoamplesso Menelao furibondo cerca fra la folla il nemico che sia i Greci che i Troiani sarebbero lieti di consegnargli pur di porre fine alla guerra Agamennone rivendicando la vittoria di Menelao pretende dai Troiani la restituzione di Elena e delle sue ricchezze noncheacute il pagamento di una forte ammenda Canto IV La tregua stipulata dopo la scomparsa di Paride viene infranta dallrsquoarciere Pandaro che sollecitato da Atena (scesa tra le schiere troiane su ordine di Zeus) ferisce con una freccia Menelao questi viene prontamente guarito dal medico Macaone figlio di Asclepio Agamennone passa fra le schiere incitandole a combattere incontra vari capi intenti a dare istruzioni ai propri uomini Solo Ulisse e Menesteo si tengono in disparte ricevendo i rimproveri di Agamennone ai quali Ulisse reagisce con indignazione Gli Achei muovono contro i Troiani con grande ordine e disciplina mentre i Troiani e i loro alleati schiamazzano come barbari Ha inizio la battaglia vera e propria nella quale lrsquoattenzione egrave focalizzata sui duelli individuali Ad assistere e rincuorare i Troiani compare Apollo sulla rocca di Troia mentre Atena infonde coraggio nei Greci Il canto si chiude sullrsquoinfuriare della battaglia la cui descrizione riprenderagrave nel canto successivo Canto V Balza in primo piano Diomede di cui viene presentata lrsquoἀριστεία lrsquoeroe laquoglorioso e chiaroraquo fa strage di nemici imperversando furiosamente fra le schiere troiane Nel pieno del combattimento viene ferito da una freccia scagliata da Pandaro il quale mena gran vanto del colpo andato a segno Diomede ottenuta unrsquoimmediata guarigione grazie allrsquointervento di Atena muove allora contro il nemico che nel frattempo era stato accolto sul carro di Enea Pandaro scaglia la sua lancia contro Diomede ma lo scudo di questi regge il colpo Diomede colpisce a sua volta uccidendo il nemico Enea scende dal cocchio per proteggere il cadavere di Pandaro dagli Achei che vorrebbero farne razzia ma Diomede lo colpisce con un grande masso fratturandogli il femore Enea viene salvato dallrsquointervento di Afrodite che lo avvolge nel suo manto mentre Diomede arriva addirittura a ferire al polso la dea che fugge sullrsquoOlimpo a farsi confortare dalla madre Dione Il figlio di Tideo attacca anche Apollo che aveva sottratto Enea alla sua furia ma
Letteratura greca [1]
15
egrave fermato dal grido di ammonimento del dio Incitati e aiutati da Ares ora i Troiani avanzano con impeto Intervengono Era e Atena e questrsquoultima assume il ruolo di auriga di Diomede Col suo aiuto questi ferisce al ventre Ares che fugge sullrsquoOlimpo Anche le dee vi fanno ritorno Canto VI Il canto VI egrave una naturale continuazione del V (tanto che Erodoto citeragrave come dallrsquoἀριστεία di Diomede un brano della prima parte del VI canto) La battaglia infuria nella pianura ma il furore di Diomede si stempera su una nota di cortesia quando lrsquoeroe dopo aver sfidato Glauco di Licia scopre di avere con lrsquoavversario antichi rapporti di ospitalitagrave I due si scambiano le armature (a detrimento di Glauco a cui laquoZeus Cronide levograve il senno cheacute scambiograve con Diomede Tidide armi drsquooro con armi di bronzo cento buoi con nove buoiraquo [vv 234-6]) Frattanto Ettore su invito dellrsquoindovino Eleno rientra in cittagrave dove le donne devono cercare di ottenere con offerte e voti il favore di Atena e incontra dapprima la madre Ecuba poi Paride (che intende ricondurre alla battaglia) vorrebbe salutare anche la moglie ma non la trova in casa bensigrave alle porte Scee dove Andromaca era accorsa piena drsquoangoscia insieme col figlioletto e con la nutrice Nel colloquio che segue ella lo implora di non esporre al pericolo se stessa e il figlio La replica di Ettore egrave esemplare per capire la prospettiva del poema e le motivazioni dellrsquoagire dei personaggi dominanti se Achille e gli eroi achei in genere cercano onore e gloria a questa motivazione (che pure non egrave assente) Ettore antepone lrsquoαἰδώς il senso di laquovergognaraquo e di responsabilitagrave nei confronti della comunitagrave e del nucleo familiare di cui egrave il difensore Poi si volta per prendere tra le braccia Astianatte ma lrsquoelmo lucente e il cimiero ondeggiante impauriscono il piccolo che si rifugia in seno alla nutrice Alla fine del canto Paride si incontra con Ettore e i due si avviano verso il campo di battaglia [T5] Canto VII A principio del canto VII Atena e Apollo si accordano per indurre Ettore a lanciare una sfida agli Achei per un duello Il sorteggio designa Aiace come campione greco Nello scontro Ettore lancia per primo lrsquoasta che penetra ma senza trapassarlo nello scudo di Aiace greve e massiccio (compaginato con sette strati di pelle bovina simile a una torre) Aiace di rimando lacera lo scudo e il pettorale della corazza ma non riesce a squarciare le carni del nemico percheacute Ettore si piega di lato Allora i due brandiscono di nuovo le aste poi ricorrono alle pietre Alla fine gli araldi arrestano il combattimento con la giustificazione che laquola notte giagrave viene ed egrave bene obbedire alla notteraquo (v 282) Su proposta di Nestore gli Achei decidono per il giorno seguente di seppellire i morti e di scavare una grande trincea difesa da un bastione sul margine del loro accampamento Respingono lrsquoofferta di pace dei Troiani (che prevederebbe la riconsegna dei tesori sottratti da Paride a Sparta) Il mattino seguente i morti vengono cremati e durante la giornata si erige il muro di protezione Canto VIII Nellrsquoassemblea degli degravei Zeus vieta ai numi di appoggiare lrsquouna o lrsquoaltra parte in conflitto Al mattino il combattimento riprende e a mezzogiorno Zeus pone i destini dei due popoli sulla bilancia che piega a favore dei Troiani Sul campo di battaglia Diomede salva Nestore Lrsquoazione di Ettore egrave travolgente fincheacute Zeus contravvenendo alla sua intenzione di favorire i Troiani accoglie la preghiera di Agamennone per risollevare il morale degli Achei che organizzano la difesa delle navi Nel corso degli scontri si segnala lrsquoarciere Teucro che colpisce i nemici muovendosi in sincronia con Aiace Telamonio che lo protegge con lo scudo Incitato da Agamennone egli prova a colpire anche Ettore ma soccombe colpito con una pietra A questa vista Era e Atena corrono ad armarsi per intervenire a favore degli Achei ma vengono distolte dalle minacce di Zeus che manifesta la propria intenzione di favorire i Troiani fino a quando i Greci non saranno ridotti alla disperazione tanto da scongiurare Achille percheacute ritorni Il sopraggiungere della notte
Letteratura greca [1]
16
interrompe i combattimenti Ettore galvanizzato dai successi ottenuti in quel giorno si illude che la vittoria sia a portata di mano e prospetta ai suoi una prossima ritirata degli Achei Il canto si chiude con il banchetto dei Troiani che banchettano nella pianura esaltati dalla speranza di vittoria Canto IX Agamennone affranto propone di fare ciograve che nel canto II aveva suggerito soltanto per mettere alla prova lrsquoesercito interrompere la guerra e tornare in patria Diomede si oppone e Nestore in un consiglio dei capi propone di tentare la riconciliazione con Achille Si invia alla tenda di Achille unrsquoambasceria (composta da Aiace Odisseo e Fenice antico pedagogo di Achille) per offrire doni ricchissimi Achille non cede anzi minaccia di salpare immediatamente verso la patria [T6] Inutilmente Fenice lrsquoantico precettore di Achille cerca di ammorbidire la determinazione del Pelide richiamando la vicenda dellrsquoeroe Meleagro [T7] Gli inviati riferiscono ad Agamennone la risposta di Achille egli torneragrave a combattere solo quando Ettore saragrave arrivato fino alle navi dei Mirmidoni Canto X Nella stessa notte si effettua una missione segreta nel corso della quale Odisseo e Diomede dapprima catturano la spia troiana Dolone (che Ettore aveva inviato alle navi achee promettendogli come ricompensa i cavalli di Achille) poi uccidono il re trace Reso appena arrivato presso i Troiani e ne rubano i magnifici cavalli Giagrave gli antichi ritenevano questo canto unrsquoaggiunta post-omerica e questi dubbi trovano riscontro in lati eccentrici della narrazione e nellrsquoimpiego di un linguaggio che spesso appare svincolato dal corrente repertorio formulare Canto XI Si apre una nuova giornata di battaglia (la cui narrazione si protrarragrave fino al canto XVIII) che ruota intorno allrsquoἀριστεία di Agamennone Quando lrsquoAtride viene ferito gli Achei ripiegano Diomede resta anchrsquoegli ferito Odisseo e Aiace evitano a stento la massa dei nemici Nestore salva sul suo carro Macaone Achille che dalla poppa della nave osserva la battaglia vuol sapere chi egrave condotto via da Nestore e manda Patroclo che viene accolto molto benevolmente e con cui Nestore intrattiene un lungo discorso egli dice di deplorare il comportamento di Achille e con atteggiamento consono alla sua condizione di anziano si dilunga nel raccontare le proprie gesta giovanili Egli esorta quindi Patroclo a far leva sulla sua amicizia per convincere Achille a riprendere il combattimento o - almeno - a concedere a Patroclo le sue armi per incutere timore nei Troiani Eccitato dalle parole del vecchio Patroclo si avvia verso la nave di Achille ma incontra Euripilo ferito che gli chiede aiuto ed egli impietositosi lo accompagna alla tenda e cura la ferita Canto XII Divisi in cinque contingenti i Troiani danno lrsquoassalto al muro eretto a difesa del campo acheo Sul campo di battaglia si manifesta un prodigio unrsquoaquila in cielo con un grosso serpente fra le zampe che riesce a ferire lrsquouccello e a sfuggire Polidamante che interpreta il segno come un presagio funesto consiglia di tornare indietro ma Ettore egrave di altro avviso Sarpedone e Glauco sferrano un attacco contro il muro e - pur rimanendo feriti - riescono ad aprire una breccia La battaglia infuria con esito incerto fincheacute Ettore con un macigno sfonda una delle porte consentendo ai Troiani di entrare in massa nel campo acheo mentre i Greci fuggono verso il mare Canto XIII Zeus distoglie lo sguardo dalla battaglia nella convinzione che nessuno fra gli dei avrebbe osato violare il divieto di intervenire ne approfitta invece Poseidone favorevole ai Greci Assunto lrsquoaspetto dellrsquoindovino Calcante il dio infonde nuovo vigore nei due Aiaci
Letteratura greca [1]
17
spronandoli al combattimento Gli Achei riconoscono lrsquointervento divino e riprendono fiducia I combattimenti si susseguono violentissimi Nella resistenza si distingue il re cretese Idomeneo Polidamante consiglia una seconda volta di interrompere la battaglia e accenna allrsquoimminente intervento di Achille Ettore non ascolta lrsquoammonimento e riprende lrsquoassalto Il canto si chiude con un suo scambio di insulti con Aiace Telamonio Canto XIV Mentre Diomede Odisseo e Agamennone tornano feriti allrsquoaccampamento Era per distogliere Zeus dalla battaglia e consentire a Poseidone di favorire gli Achei indossa la cintura magica di Afrodite e sollecita il consorte a un convegno amoroso sullrsquoIda dopo lrsquoamplesso Zeus cade in un sonno profondo e Hypnos (il Sonno) annuncia a Posidone che potragrave aiutare senza rischi gli Achei Ettore colpito con una pietra da Aiace resta a lungo in stato di incoscienza e i Troiani vengono respinti Canto XV Zeus si risveglia avvedendosi dellrsquoinganno subito e costringe Era a mandargli Iride e Apollo la prima allontaneragrave Posidone dal campo di battaglia Apollo inciteragrave Ettore a far retrocedere gli Achei fino alle navi dei Mirmidoni Riprende lrsquooffensiva troiana Apollo stesso abbatte il muro e scuotendo lrsquoegida atterrisce gli Achei Patroclo corre da Achille mentre i Troiani giagrave sono sul punto di appiccare il fuoco alle navi Canto XVI Patroclo in lacrime supplica Achille di intervenire o di mandare lui stesso al suo posto [T8] Achille gli consegna le proprie armi e gli fa promettere che non si avventureragrave oltre la zona delle navi Ma Patroclo trascinato dal suo stesso impeto oltrepassa il limite prescrittogli da Achille Abbatte Sarpedone figlio di Zeus attorno al cui cadavere infuria la lotta fincheacute Apollo lo sottrae alla mischia e Hypnos e Thanatos (il demone della morte) lo trasportano in Licia sua patria Patroclo continua lrsquoassalto alla testa dei Mirmidoni fin sotto le mura di Troia ma poco prima del tramonto al quarto assalto Apollo stesso assunto lrsquoaspetto di Asio lo percuote fra le spalle allora Euforbo lo colpisce con lrsquoasta ed Ettore lo trafigge Canto XVII Euforbo viene ucciso da Menelao ma Ettore riesce a catturare le armi di Achille indossate da Patroclo Vigorosamente sostenuti da Aiace gli Achei difendono il cadavere Una densa nebbia scende sui combattenti Zeus infonde nuovo ardimento nei cavalli di Achille piangenti per la fine di Patroclo [T9] Atena e Apollo arroventano la lotta attorno alla salma In seguito alla preghiera di Aiace Zeus dissolve la nebbia Menelao manda Antiloco figlio di Nestore a informare Achille della morte di Patroclo la cui salma viene intanto trascinata fuori della battaglia da Menelao e Merione mentre i due Aiaci offrono la necessaria copertura contro la furia incalzante dei nemici Canto XVIII Lo scoppio di selvaggio dolore a cui si abbandona Achille allrsquoudire della morte di Patroclo provoca lrsquoaccorrere dal mare di Tetide insieme con le Nereidi La madre gli promette di procurargli nuove armi Poicheacute la salma di Patroclo egrave tuttora contesa Achille fa la sua apparizione sul fossato e lancia un grido che atterrisce i nemici Efesto su preghiera di Tetide foggia le nuove armi fra cui un magnifico scudo su cui appaiono effigiati in bande concentriche gli aspetti salienti dellrsquoesistenza umana Canto XIX Il mattino seguente Tetide porta le armi al figlio e con lrsquoambrosia preserva la salma di Patroclo dalla decomposizione Achille convoca unrsquoassemblea dellrsquoesercito e rinuncia alla sua collera Agamennone lamenta di essere stato ldquoaccecatordquo da Zeus e promette doni
Letteratura greca [1]
18
riparatori [T10] Achille si lascia convincere a stento ad attendere che i soldati abbiano mangiato Poi gli armati si radunano e anche Achille si arma Il suo cavallo Xanto gli predice la prossima morte [T11] Canto XX Zeus consente agli degravei di partecipare alla nuova battaglia Enea scontratosi con Achille egrave tratto in salvo da Posidone Achille infuria come un incendio in una selva Canto XXI Achille colma di cadaveri il fiume Scamandro e cattura dodici giovani troiani che intende offrire in sacrificio a Patroclo non risparmia neppure Licaone figlio di Priamo che lo supplica con accenti di grande intensitagrave ma altrettanto intensa nella consapevolezza di un destino imminente egrave la pur spietata replica del Pelide [T12] Lo Scamandro solleva le proprie onde ma le fiamme di Efesto inaridiscono il terreno e domano la corrente Gli degravei si azzuffano Atena raggiunge Ares con una pietra Era rintuzza la furia di Artemide Infine tutti tornano sullrsquoOlimpo Apollo assunto lrsquoaspetto di Agenore respinge Achille percheacute i Troiani possano rifugiarsi allrsquointerno delle mura Canto XXII Il solo Ettore resta fuori nella pianura Invano Priamo ed Ecuba lo pregano di rientrare Mentre Achille si avvicina Ettore decide di affrontarlo ma quando quello gli egrave da presso col bronzo che gli lampeggia intorno laquosimile al raggio del fuoco ardente o del sole che sorgeraquo egrave afferrato dal panico e comincia a fuggire compiendo tre giri intorno alle mura Zeus pesa sulla bilancia i destini (le κῆρες) dei due eroi e quello di Ettore affonda in basso Allora Apollo lo abbandona e Atena apparsa a Ettore sotto le spoglie di suo fratello Deifobo gli si avvicina promettendogli aiuto e invece riporta ad Achille la lancia che gli era caduta fuori bersaglio Il colpo di risposta di Ettore rimbalza sullo scudo di Achille Ettore urla a Deifobo di passargli la sua lancia ma il falso Deifobo egrave scomparso ed Ettore comprende di trovarsi sullrsquoorlo dellrsquoabisso [T13] Achille gli trapassa la gola ed Ettore lo supplica di non oltraggiare la sua salma in risposta riceve la minaccia che finiragrave in pasto ai cani Achille trascina il cadavere alle navi attaccato al carro Priamo Ecuba e Andromaca si abbandonano al cordoglio a cui fanno eco le donne troiane Canto XXIII Viene preparato il banchetto funebre in onore di Patroclo la cui ombra nel corso della notte appare ad Achille chiedendo la sepoltura del corpo Il mattino seguente si appresta il rogo fra le offerte votive ci sono anche dodici giovani troiani Il giorno successivo si raccolgono le ossa di Patroclo Seguono i ludi funebri gare coi carri e con lrsquoarco duello in armi etc Canto XXIV Ogni giorno Achille trascina il cadavere di Ettore attorno alla tomba dellrsquoamico ma lo spettacolo offende gli degravei e al dodicesimo giorno Zeus decide di mandare Tetide percheacute induca suo figlio a restituire la salma di Ettore Iride viene inviata presso Priamo percheacute gli consigli di recarsi nel cuore della notte con un carro da trasporto e un copioso riscatto scortato da Ermes alla tenda di Achille Questi accoglie il vecchio con rispetto riconoscendo in lui lrsquoimmagine del padre lontano e si piega alla sua supplica [T14] Per volontagrave degli degravei il cadavere non egrave stato aggredito dalla putrefazione composto sul pianale del carro viene ricondotto dal padre a Troia Qui le lamentazioni rituali srsquoinnalzano dal gruppo delle donne (Andromaca Ecuba Elena) Si stipula una tregua di dodici giorni Per nove giorni i Troiani raccolgono legname poi anche il rogo di Ettore arde e si erige un tumulo
Letteratura greca [1]
19
Struttura e caratteri dellʼopera Poema di trama relativamente organica (soprattutto a partire dal canto XVI tutti gli avvenimenti tranne pochi episodi isolati ruotano attorno ai due principali antagonisti Ettore uccide Patroclo per vendicare Sarpedone e Achille uccide Ettore per vendicare Patroclo) pur se non privo di piugrave o meno cospicue incongruenze spiegabili in primo luogo con la lunga e complessa genesi orale dellrsquoopera lrsquoIliade lascia emergere in mezzo alle centinaia di nomi e alle intricate vicende alcuni caratteri delineati nella loro individualitagrave e innanzi tutto quelli di Achille e di Ettore accomunati dalla medesima coscienza di un destino di morte che sono pronti ad affrontare Appunto una tale attitudine a rappresentare i laquocaratteriraquo (ἤθη) dei suoi personaggi egrave un altro titolo di merito che Aristotele ascrive ad Omero (Poetica 1460a9-11)
dopo aver brevemente proemiato subito introduce un uomo una donna o un altro personaggio nessuno privo di caratterizzazione ma dotato di un carattere
Fondamentale per la struttura del poema egrave la novitagrave della prospettiva Possiamo presumere che i cosiddetti poemi ciclici22 mirassero a conservare lrsquoangolatura che era stata propria delle versioni pre-omeriche della saga troiana sigrave che puograve riuscire significativo il confronto fra lrsquoesordio della Piccola Iliade (dove muovendo da grandi entitagrave ndash la cittagrave il paese due popoli la guerra ndash viene lanciato secondo lrsquoespressione di J Latacz come laquouno sguardo dallrsquoesternoraquo)
Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην εὔπωλον ἧς πέρι πολλὰ πάθον Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος Canto Ilio e la terra dei Dardani dai bei puledri per la quale molti dolori patirono i Danai servitori di Ares
con lo laquosguardo internoraquo che caratterizza lrsquoinizio dellrsquoIliade
Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν ἡρώων αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν οἰωνοῖσί τε δαῖτα Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς Canta o dea di Achille figlio di Peleo la collera maledetta che pene innumerevoli inflisse agli Achei e molte scagliograve allrsquoAde vite possenti di eroi e ne faceva prede per i cani e pasto per gli uccelli e si avverava il volere di Zeus da quando primamente si separarono venuti a contesa LrsquoAtride sovrano di eroi e Achille magnifico
Argomento non egrave dunque come doveva avvenire nella tradizione del canto epico un evento complesso da inquadrare con un grandangolo onnicomprensivo e neppure come saragrave nellrsquoOdissea un personaggio colto nella multiforme varietagrave delle sue peregrinazioni egrave invece una reazione emotiva (lrsquoira di Achille) con le sue conseguenze (le innumerevoli morti degli Achei) Narrare di questa ira significa per il poeta cominciare da un punto preciso (laquoda quandoraquo) ossia dal momento della contesa e della separazione fra i due massimi eroi greci Agamennone il primo per potere (laquosovrano di eroiraquo) e Achille il primo per nobiltagrave e forza (δῖος) E sintomatica della bipolaritagrave del mondo epico in quanto mondo di degravei e di eroi egrave la sincronia per cui il taglio della narrazione coincide col decorso del laquovolere di Zeusraquo (Διὸς βουλή) forse da identificare con la promessa del dio a Tetide (rievocata piugrave oltre in questo
22 V cap II laquoLa tradizione omericaraquo
Letteratura greca [1]
20
stesso canto ai vv 518-527) di vendicare lrsquoaffronto subito da Achille o piugrave in generale con il corso degli eventi in quanto tutto come per definizione laquogiace sulle ginocchia di Zeusraquo Opera indubbiamente allrsquointerno del poema unrsquoidea formativa un progetto di qui un insieme monumentale unificato anche da una serie di corrispondenze a distanza fra cui particolare significato acquistano quelle fra primo e ultimo canto Nel canto I il vecchio Crise va come supplice presso Agamennone portando doni e supplicando la restituzione della figlia e Agamennone lo respinge aspramente minacciandolo di far ricorso alla violenza se dovesse tornare nel canto XXIV il vecchio Priamo va come supplice presso Achille portando doni e supplicando la restituzione del corpo del figlio Achille ha una prima reazione irosa (esordisce al v 560 con laquoSmetti di irritarmi vecchioraquo) ma poi accoglie la supplica E al di lagrave delle corrispondenze nelle linee dellrsquoazione si colgono fra principio e fine del poema alcuni importanti echi verbali in particolare fra XXIV 501 s
τοῦ νῦν εἵνεχ᾽ ἱκάνω νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενος παρὰ σεῖο φέρω δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα per lui [Ettore] vengo ora alle navi degli Achei per riscattarlo da te e ti porto compenso infinito
e I 12 s
ὁ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενός τε θυγάτρα φέρων δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα costui [Crise] venne alle navi rapide degli Achei per riscattare la figlia portando compenso infinito
fra XXIV 555-557
λῦσον ἵν᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδωmiddot σὺ δὲ δέξαι ἄποινα πολλά τά τοι φέρομενmiddot σὺ δὲ τῶνδrsquo ἀπόναιο καὶ ἔλθοις σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν restituiscimelo percheacute lo possa vedere con gli occhi e accogli il riscatto copioso che portiamo e tu possa goderne e tornare alla tua terra patria
e I 18-20
Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν εὖ δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκέσθαιmiddot παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην τὰ δ᾽ ἄποινα δέχεσθαι Atridi e voi altri Achei dai forti schinieri a voi concedano gli degravei che hanno le case in Olimpo di distruggere la cittagrave di Priamo e tornare facilmente in patria ma restituitemi la figlia e accettate il riscatto
fra XXIV 560 μηκέτι νῦν μ᾽ ἐρέθιζε (laquosmetti di irritarmiraquo) e I 32 μή μ᾽ ἐρέθιζε (laquonon mi irritareraquo) fra XXIV 568-570
τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς μή σε γέρον οὐδrsquo αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω καὶ ἱκέτην περ ἐόντα Διὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμάς Ora perciograve fra i dolori non mi eccitare lrsquoanimo ancora di piugrave bada o vecchio che non ti lasci neppure nella tenda
Letteratura greca [1]
21
bencheacute supplice e violi gli ordini di Zeus e I 26-28
μή σε γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω ἢ νῦν δηθύνοντ᾽ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο Mai te o vecchio io colga presso le concave navi ora a indugiare o piugrave tardi a tornare che piugrave non dovesse giovarti lo scettro e la benda del dio
(e infine XXIV 571 ὣς ἔφατ ἔδεισεν δ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ laquocosigrave diceva e il vecchio tremograve e obbediva alle paroleraquo ripete esattamente I 33) In effetti lrsquoepisodio terminale del poema col superamento dellrsquoira ad opera della pietagrave e del senso di unrsquoesistenza invasa dal dolore si propone come il rovesciamento consapevole dellrsquoepisodio iniziale che era apparso caratterizzato dalla cancellazione della pietagrave e del diritto dei supplici in nome della forza Al rifiuto iniziale del donoriscatto si oppone lrsquoaccettazione finale in consonanza con un principio-guida che opera nel poema secondo linee che alla fine si riunificano Agamennone restituisce Criseide al padre ma si appropria del dono fatto dagli altri Achei ad Achille (Briseide) Achille respinge i doni fatti da Agamennone per indurlo a riconciliarsi con lui ma dopo aver contestato nel IX canto la nozione che la vita umana possa essere barattata con una massa di beni torna alla lotta non in cambio di qualche premio da conquistare ma per vendicare lrsquouccisione dellrsquoamico Patroclo e tanto nella lotta sul campo di battaglia quanto nellrsquoinfierire sul cadavere di Ettore si abbandona a un furore cosigrave smisurato e patologico che puograve essere superato solo con lrsquoaccettare i doni di Priamo non tuttavia per il loro valore drsquouso ma percheacute in Priamo Achille riconosce lrsquoombra del padre lontano Cosigrave lrsquoIliade appare attraversata da un impulso fondamentale che muove dallrsquoideologia del dono e dalla conseguente centralitagrave assegnata allrsquoonore (τιμή) come ldquoprezzordquo che qualifica il valore del guerriero ma supera questo piano di valutazione dei rapporti umani attraverso la loro riformulazione nei termini di un umanesimo esistenziale che ha come punti di riferimento lrsquoidentitagrave universale dei condizionamenti oggettivi (la vecchiaia la malattia la morte) e i legami che uniscono padre e figlio compagno e compagno vivi e morti (il cordoglio finale di Andromaca Ecuba ed Elena sulla salma di Ettore) Entro questo orizzonte progressivamente allargato la guerra le lotte lo scontro mortale finiscono col rappresentare solo un momento e un aspetto dellrsquoesistenza graditi tanto agli degravei che vi assistono come spettatori interessati quanto agli uditori che riascoltano le antiche gesta eppure non tali da appiattire il poema in una prospettiva guerresca conclusa in se stessa Molto del fascino delle battaglie e delle ἀριστεῖαι dellrsquoIliade sta nella presenza recondita di un occhio che sa guardare al di lagrave di esse (e al di lagrave della stessa distinzione fra Greci e Troiani vincitori e vinti) e che puograve anche attraverso le similitudini lasciare irrompere il mondo della natura o del lavoro umano nel mezzo delle battaglie LʼOdissea LrsquoOdissea (Ὀδύσσεια) consta di circa 12100 esametri divisi anchrsquoessi in 24 libri e indicati con le lettere minuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquoargomento egrave costituito dalle avventure di Odisseo dalla distruzione di Troia al ritorno alla patria Itaca esposte secondo un ordine che entrando subito nel vivo degli avvenimenti (lrsquoinizio del poema mostra Odisseo nellrsquoisola di Calipso) rievoca poi i fatti giagrave trascorsi e li ricongiunge infine a partire dal libro XV (con lrsquoarrivo di Telemaco alla capanna di Eumeo dove giagrave si trova Odisseo) in unrsquoazione unitaria La trama del poema i cui avvenimenti sono concentrati cronologicamente nello spazio di 40 giorni (ma sono narrati solo gli avvenimenti di 16 giorni e 8 notti) si articola in tre parti la laquoTelemachiaraquo (canti I-IV) il laquoRitorno di Odisseoraquo (canti V-XIII) e la laquoVendetta di Odisseoraquo (canti XIV-XXIV)
Letteratura greca [1]
22
Canto I Tutti gli eroi superstiti sono ormai tornati da Troia alle loro case tranne Odisseo che pur desideroso di tornare egrave trattenuto dalla ninfa Calipso nellrsquoisola di Ogigia Gli degravei hanno pietagrave di lui tranne Posidone irato per lrsquoaccecamento del figlio il ciclope Polifemo Ma un consiglio degli degravei assente Posidone (che si egrave recato presso gli Etiopi) delibera il ritorno dellrsquoeroe si decide che Ermes andragrave subito da Calipso mentre Atena si avvia verso Itaca sotto lrsquoaspetto del signore dei Tafi Mente per incoraggiare il figlio di Odisseo Telemaco a tener testa ai pretendenti della madre i laquoprociraquo (i quali aspirano al regno tramite le nozze con Penelope) e per indurlo a intraprendere un viaggio in cerca di notizie sul padre Canto IΙ Telemaco segue il consiglio della dea e il giorno seguente nellrsquoassemblea popolare chiede una nave per andare in cerca del padre ma la sua richiesta non viene discussa e Leocrito scioglie lrsquoassemblea Grazie ad Atena che ora ha assunto le sembianze di Mentore (antico amico di Odisseo) Telemaco riesce tuttavia a trovare una nave con cui salpa nel corso della notte allrsquoinsaputa sia della madre che dei proci Canto IΙΙ Telemaco e MentoreAtena arrivano a Pilo e sul lido trovano Nestore che sta offrendo un sacrificio a Posidone Il vecchio eroe accoglie ospitalmente Telemaco e gli comunica molte notizie sul ritorno di altri Achei ma nessuna su Odisseo Alla sera Atena scompare in forma di aquila e il mattino seguente Telemaco salpa insieme con Pisistrato (figlio di Nestore) alla volta di Sparta dove arriva la sera del giorno successivo Canto IV A Sparta Menelao sta festeggiando il doppio matrimonio del figlio e della figlia Il giorno seguente Telemaco chiede del padre Menelao gli racconta il proprio ritorno durante il quale aveva incontrato Proteo il vecchio nume marino che gli aveva riferito come Odisseo fosse trattenuto nellrsquoisola di Calipso Intanto a Itaca i proci preparano insidie meditando di uccidere Telemaco al suo ritorno Penelope ne viene a conoscenza ma Atena le appare in sogno per confortarla Canto V Dopo un secondo concilio degli degravei (in effetti un ldquodoppionerdquo di quello del I canto) Zeus manda finalmente Ermes presso Calipso con lrsquoordine di lasciar partire Odisseo La ninfa aiuta lrsquoeroe a costruirsi una zattera Al diciottesimo giorno di navigazione Odisseo egrave in vista dellrsquoisola dei Feaci Scheria quando Posidone di ritorno dal suo soggiorno presso gli Etiopi lo vede e suscita una tempesta che distrugge la zattera Ma la dea marina Ino Leucotea impietositasi gli porge il proprio velo sostenuto dal quale lrsquoeroe giunge a nuoto alla riva di Scheria dove si abbandona esausto addormentandosi Canto VI In seguito a un sogno inviatole da Atena Nausicaa la figlia del re dei Feaci Alcinoo si reca nei pressi della spiaggia a lavare le vesti insieme con le ancelle Odisseo risvegliatosi atterrisce le fanciulle che fuggono tutte allrsquoinfuori di Nausicaa Lrsquoeroe supplica la giovane di porgerle aiuto ed ella lo fa rivestire e lo accompagna fino al bosco di Atena poco prima della cittagrave esortandolo a presentarsi a suo padre Canto VII Protetto dalla nebbia di cui Atena lo ha avvolto Odisseo entra nel palazzo abbraccia le ginocchia della regina Arete e la caligine scompare poi viene accolto con onore da Alcinoo Arete chiede a Odisseo donde provenga e chi gli abbia donato gli abiti (a lei ben noti) che indossa Lrsquoeroe inizia a raccontare le disavventure che gli sono occorse dopo la
Letteratura greca [1]
23
partenza dallrsquoisola di Calipso Alcinoo gli promette di farlo ricondurre a Itaca il giorno seguente Canto VIII Ma lrsquoindomani Alcinoo fa apprestare un banchetto durante il quale lrsquoaedo Demodoco canta della contesa insorta un giorno fra Achille e Odisseo Lrsquoeroe si copre il volto per nascondere le lacrime allora Alcinoo interrompe il canto e organizza una serie di gare nel corso delle quali Odisseo primeggia Poi Demodoco al margine di unrsquoarea per la danza dove si esibiscono i ballerini feaci canta gli amori di Ares e Afrodite e la vendetta di Efesto (che incatena i due amanti) La sera al ritorno nel palazzo Demodoco racconta la storia del Cavallo di legno Odisseo scoppia nuovamente in lacrime e Alcinoo gli chiede di rivelare il suo nome Canto IX Odisseo dichiara il proprio nome e dagrave inizio al racconto della propria storia a partire dalla caduta di Troia distruzione di Ismaro e perdite subite ad opera dei Ciconi sbarco presso i Lotofagi (che si nutrono di un cibo misterioso che fa dimenticare il ritorno) dopo una terribile tempesta scatenatasi durante il tentativo di doppiare il capo Malea arrivo allrsquoisola antistante quella dei Ciclopi dove Odisseo si trasferisce con una sola nave esplorazione dellrsquoisola perdita di alcuni compagni allrsquointerno della caverna del gigante monocolo accecamento del mostro e fuga Canto X Odisseo giunge allrsquoisola di Eolo signore dei venti che lo accoglie benevolmente e gli consegna alla partenza tutti i venti chiusi in un otre ma poi lo respinge con durezza quando ritorna presso di lui percheacute i compagni (sospettando che nellrsquootre siano racchiuse cospicue ricchezze) hanno sciolto i venti e da essi si egrave sprigionato un uragano che li ha risospinti sullrsquoisola Ripreso il mare Odisseo egrave trasportato fino ai Lestrigoni antropofagi il cui attacco priva lrsquoeroe di tutte le altre navi tranne la propria Con questa fugge fino allrsquoisola (Eea) della maga Circe Dopo che Circe ha trasformato in porci un gruppo di compagni mandati innanzi ad esplorare lrsquoisola Odisseo ha la meglio sulla maga (a cui impone di restituire forma umana ai compagni) grazie allrsquoerba moly fornitagli da Ermes Resta un anno presso Circe che al momento della partenza gli consiglia di recarsi al paese dei morti per interrogare il vate Tiresia Canto XI Approdato alla terra dei Cimmeri (che vivono immersi in una nebbia perenne sulla riva dellrsquoOceano) e scavata una fossa Odisseo sacrifica ai morti e immola una vittima speciale a Tiresia Le anime accorrono dapprima Elpenore caduto per caso giugrave dal tetto della casa di Circe (Odisseo gli promette sepoltura) poi la madre Anticlea (che gli racconta di esser morta di dolore per la sua assenza) quindi Tiresia che gli vaticina le sue vicende future fino alla morte (questa lo coglieragrave dopo una lunga vita in un paese straniero che non conosce neacute il sale neacute il remo) Da un certo punto in poi il poeta dimentica il presupposto per cui Odisseo aveva scavato una fossa alla quale i morti accorrevano per bere il sangue delle vittime e bevendolo riacquistavano per breve tempo una piena consapevolezza immagina invece che Odisseo sia allrsquointerno dellrsquoAde In questa sezione rientrano la descrizione di Aiace sdegnato di Minosse di Orione dei grandi peccatori di Eracle Poi Odisseo fa ritorno a Eea e ricevuti i consigli di Circe si imbarca per il ritorno in patria Canto XII Scampato alle Sirene che invano lo attirano col canto (si egrave fatto legare allrsquoalbero della nave i compagni che remano hanno le orecchie turate con la cera) passa tra Cariddi e Scilla (che gli rapisce sei uomini) ed egrave costretto dai compagni ad approdare in contrasto con le prescrizioni di Circe allrsquoisola Trinachia dove pascolano le greggi del Sole I
Letteratura greca [1]
24
compagni spronati da Euriloco se ne cibano nonostante il divieto dellrsquoeroe Il Sole sdegnato ottiene da Zeus che la nave sia colpita dal fulmine Tutti i compagni periscono ma Odisseo che ripassa tra Scilla e Cariddi si salva miracolosamente da questrsquoultima aggrappandosi a un fico selvatico fincheacute il gorgo restituisce i rottami della nave infine arriva remando con le mani allrsquoisola di Ogigia Canto XIII Terminato il racconto lrsquoeroe riceve doni dai Feaci e la notte seguente egrave ricondotto a Itaca e deposto addormentato sulla spiaggia presso un antro sacro alle Ninfe Al risveglio per la nebbia non riconosce la sua terra fincheacute Atena in veste di giovane pastore lo rassicura e poi rivelatasi gli dagrave istruzioni su come far strage dei proci e lo trasforma in un vecchio mendico Canto XIV Odisseo si reca allo stazzo del suo porcaio Eumeo che pur non riconoscendolo lo accoglie ospitalmente rifocillandolo e offrendogli un mantello per ripararsi dal gelo notturno Canto XV A questo punto la laquoTelemachiaraquo si riannoda allrsquoazione principale Telemaco che si trova ancora a Sparta viene indotto da Atena a tornare a Itaca sulla via del ritorno a Pilo accoglie a bordo lrsquoindovino Teoclimeno e grazie allrsquoaiuto della dea sfugge alle insidie dei proci sbarca a Itaca e si reca anchrsquoegli presso Eumeo Canto XVI Questi va da Penelope ad annunciargli il ritorno del figlio Intanto Odisseo rimosso lrsquoincantesimo si svela nel suo vero aspetto a Telemaco e con lui progetta la vendetta sui proci (che intanto tramano una nuova insidia ai danni di Telemaco) Eumeo torna al suo stazzo Canto XVII Il mattino seguente Telemaco si reca in cittagrave seguito in un secondo tempo da Eumeo e Odisseo (che ha riassunto lrsquoaspetto di mendico) Davanti al palazzo Odisseo egrave riconosciuto dal cane Argo Entra e va mendicando tra i proci Antinoo lo colpisce alla spalla destra con uno sgabello Canto XVIII Odisseo si batte al pugilato col mendicante Iro Penelope scesa nella sala prospetta ai proci lrsquoeventualitagrave di un nuovo matrimonio Odisseo egrave insultato dalla schiava Melanto e schiva uno sgabello scagliato da Eurinomo Canto XIX Insieme con Telemaco lrsquoeroe allontana le armi dalla sala poi conversa con Penelope che gli racconta un sogno e gli espone il suo piano per sedare le contese tra i proci concedendosi sposa a colui che riusciragrave a tendere lrsquoarco di Odisseo la prova avverragrave il giorno seguente al novilunio Durante il colloquio la fida schiava Euriclea lava i piedi di Odisseo e riconosciutolo da unrsquoantica cicatrice sta per rivelarne lrsquoidentitagrave ma lrsquoeroe la costringe a tacere Canto XX Al mattino Euriclea e le ancelle fanno i preparativi per il banchetto Giungono Eumeo Melanzio e il mandriano Filezio Un presagio mandato da Zeus dissuade i proci dal progetto di uccidere Telemaco Durante il banchetto Teoclimeno predice la loro imminente rovina
Letteratura greca [1]
25
Canto XXI Penelope conduce lrsquoarco nella sala dopo che parecchi fra i proci e lo stesso Telemaco hanno tentato invano di tenderne la corda Odisseo chiede di partecipare alla prova tende lrsquoarco senza fatica e riesce a far passare la freccia attraverso gli anelli di dodici scuri predisposte da Telemaco Canto XXII Poi scaglia le frecce sui proci e si rivela nella sua identitagrave Nella lotta che segue Telemaco Eumeo e Filezio aiutano il padrone contro i proci (appoggiati dal capraio Melanzio) Tutti i proci restano uccisi le ancelle infedeli sono impiccate Melanzio viene mutilato e ucciso soltanto lrsquoaedo Femio e lrsquoaraldo Medonte sono risparmiati Canto XXIII Nuovo colloquio fra Odisseo e Penelope che durante lrsquoeccidio dormiva ed egrave stata svegliata da Euriclea Penelope esita ancora a riconoscere il marito e non si arrende alla veritagrave fincheacute Odisseo non le descrive la posizione e la struttura del letto coniugale Canto XXIV Ermes conduce allrsquoAde le ombre dei proci Odisseo fa visita al padre Laerte nella masseria dove quello vive nello squallore e nellrsquoemarginazione e si fa riconoscere Intanto il padre di Antinoo incita gli Itacesi alla rivolta e il poema si conclude con lo scontro di Odisseo e dei suoi contro i concittadini lrsquoeroe ha la meglio e Zeus scagliato il fulmine pone fine alla battaglia Atena sotto lrsquoaspetto di Mentore stabilisce fra i contendenti un patto per il futuro36
Struttura e caratteri dellʼopera Giagrave la prima parola del proemio (ἄνδρα) non menziona come tema dellrsquoopera un determinato episodio della vita del protagonista ma il protagonista stesso (I 1-10)
Ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα πολύτροπον ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεmiddot πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περmiddot αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο νήπιοι οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιονmiddot αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ τῶν ἁμόθεν γε θεά θύγατερ Διός εἰπὲ καὶ ἡμῖν Dellrsquouomo multiforme a me racconta o Musa che molto errograve dopo che di Troia la sacra rocca distrusse di molti uomini vide le cittagrave riconobbe il pensiero e molti per il mare patigrave dolori nellrsquoanimo per salvare la sua vita e il ritorno dei compagni Eppure non li salvograve i compagni per quanto bramasse per la loro stessa follia si persero gli stolti i buoi del Sole Iperione mangiarono e quello rapigrave ad essi il digrave del ritorno Di questo da un punto qualsiasi narra anche a noi o dea figlia di Zeus
Storie favolose di naviganti racconti imperniati sul ritorno dei guerrieri achei che avevano combattuto a Troia e il particolare rientro in patria di Odisseo figlio di Laerte erano forse giagrave stati connessi e intrecciati nella precedente tradizione epica sigrave che il presente cantore poteva
Letteratura greca [1]
26
metter mano alla vicenda partendo (v 10) laquoda un punto qualsiasiraquo (ἁμόθεν) una notazione che certo presuppone la convenzione propria dellrsquoesordio tradizionale di un canto epico comparabile con i giagrave ricordati ἐξ οὗ (laquoda quandoraquo) di Iliade I 4 ed ἔνθεν (laquoda doveraquo) di Odissea VIII 500 Senoncheacute rispetto a queste indicazioni di tipo puntuale il tratto costituito dalla dimensione casuale quasi arbitraria inerente ad ἁμόθεν proprio mentre dichiara lrsquoassenza di un determinato piano compositivo implica in realtagrave che il racconto non si svolgeragrave per filo e per segno secondo lrsquoordine noto a poeta e uditori non si snoderagrave κατὰ κόσμον (laquoper ordineraquo) come il canto di Demodoco (VIII 489) ma seguiragrave un andamento originale Il ldquopunto qualsiasirdquo incipitario non rappresenta una scelta della Musa (figura dellrsquoarchivio tematico che conserva le laquovieraquo dellrsquoepica) bensigrave di questo cantore che ha deciso di far incominciare la narrazione in medias res e ha in serbo la sorpresa di far succedere al concilio degli degravei (che decide lrsquoinvio di Ermes presso Calipso) non lrsquoazione testeacute programmata (azione che viene differita con un ritardo che a piugrave riprese ha scandalizzato i lettori a principio del V canto) ma la partenza di Atena alla volta di Itaca e lrsquoavvio della laquoTelemachiaraquo Le due diverse vicende proposte a principio del poema quella di Telemaco e quella di Odisseo procedono infatti in parallelo coprendo un analogo lasso di tempo Piugrave oltre la decisione di trasformare la sequenza narrativa che va dalla partenza di Odisseo da Troia fino al suo arrivo nella terra dei Feaci in una rievocazione fatta dallrsquoeroe in prima persona al cospetto di Alcinoo e dei Feaci (la sezione detta degli ἀπόλογοι laquoraccontiraquo) crea una struttura ad anello che parte dal presente e ad esso fa ritorno dopo aver ricostruito le premesse della condizione attuale del protagonista Col canto XIII Odisseo egrave riportato dai Feaci a Itaca e questo permette la saldatura fra le vicende sue e quelle di Telemaco sia pure col differimento dellrsquoincontro e del riconoscimento fra padre e figlio fino al canto XVI Far scorrere in parallelo sequenze distinte organizzare programmi narrativi a corta e a lunga gittata tendere o allentare ad arte il ritmo della narrazione non si tratta davvero di procedimenti che potessero configurarsi come tradizionali dellrsquoarte epica quanto piuttosto di un momento sperimentale di una ricerca di soluzioni nuove al termine di una lunga e ormai consolidata sedimentazione di percorsi compiuti allrsquointerno di un determinato repertorio tematico unrsquoaudacia inventiva una πολυτροπίη degne del protagonista del poema che inevitabilmente comportavano rischi molteplici di incoerenze dissonanze occasionali avarie della macchina epica e che tuttavia erano destinate a conseguire un risultato assolutamente convincente allrsquoorecchio di chi si abbandonasse al fascino del racconto senza lrsquourgenza propria di altre etagrave e di altre mentalitagrave di puntare il dito sui singoli dettagli o le singole sfasature
PER SAPERNE DI PIUrsquo Difficoltagrave e incongruenze della narrazione omerica Forti della possibilitagrave di un controllo su un testo scritto che possiamo percorrere in avanti e a ritroso secondo ritmi di nostra scelta a noi non riesce difficile cogliere alcune delle difficoltagrave organizzative incontrate nella composizione del poema In proposito per ricordare un caso che saragrave allrsquoorigine delle discussioni di orientamento ldquoanaliticordquo intorno allrsquoOdissea possiamo leggere il discorso che Atena prese le sembianze di Mente re dei Tafi rivolge a Telemaco nel I canto (vv 253-305) Ah infelice ti manca molto davvero lrsquoassente Odisseo che getti le mani addosso ai pretendenti sfrontati Percheacute se ora tornato stesse sulla soglia 255 con una scure lo scudo e due lance cosigrave come io per la prima volta lo vidi in casa nostra che beveva e godeva di ritorno da Efira da Ilo di Mermero (andograve anche ligrave Odisseo con la nave veloce 260 in cerca del veleno omicida per averne da ungere le frecce di bronzo ma quello non glielo diede percheacute temeva gli dei che vivono eterni
Letteratura greca [1]
27
glielo diede invece mio padre percheacute lrsquoamava moltissimo) se stesse Odisseo tra i pretendenti cosigrave 265 essi avrebbero tutti rapida morte e nozze amare Ma sulle ginocchia degli dei questo giace se una volta tornato faragrave o no vendetta nella sua casa te invece io esorto a riflettere come cacciare i pretendenti da casa 270 Ebbene ora ascolta e alle mie parole darsquo retta Domattina chiamati gli eroi Achei a consiglio rivolgi a tutti un discorso e siano testimoni gli dei Ai pretendenti comanda drsquoandarsene per i fatti loro e tua madre se lrsquoanimo la spinge alle nozze 275 ritorni a casa del padre molto potente Prepareranno essi le nozze e disporranno i doni nuziali moltissimi quanti gli pare che debbano andare alla figlia A te darograve un saggio consiglio se vuoi ascoltarlo armata una nave con venti remi la migliore che crsquoegrave 280 Varsquo a domandare del padre partito da tempo se mai te ne parli un mortale o sentissi da Zeus la voce che divulga la fama tra gli uomini Anzitutto varsquo a Pilo e interroga il chiaro Nestore di ligrave poi varsquo a Sparta dal biondo Menelao 285 degli Achei vestiti di bronzo egli egrave tornato per ultimo Se senti dire qualcosa sulla vita e il ritorno del padre per quanto stremato potresti sopportare un altro anno se invece senti dire che egrave morto e non vive allora tornato nella cara terra patria 290 ergigli un tumulo e offrigli funebri offerte moltissime quanto conviene e darsquo tua madre a un marito E poi dopo aver compiuto e fatto ogni cosa allora medita nella mente e nellrsquoanimo come tu possa uccidere nelle tue case 295 i pretendenti con lrsquoinganno affrontandoli non devi piugrave avere i modi di un bimbo percheacute ormai non sei tale Non senti lrsquoillustre Oreste quale gloria ha acquistato fra tutti gli uomini percheacute uccise lrsquoassassino del padre Egisto esperto di inganni che gli uccise il nobile padre 300 Anche tu caro infatti molto bello e grande ti vedo sii valoroso percheacute ti lodi anche qualcuno dei posteri Ma io tornerograve adesso alla nave veloce dai compagni che forse impazienti mi aspettano Tu devi pensarci da te dammi retta 305
[Tr di GA Privitera] Le stranezze non mancano davvero e cosigrave sono state messe a fuoco da Stephanie West nel suo commento23 1 Atena sa evidentemente molto piugrave di quanto uno come Mente avrebbe potuto sapere in particolare ella sa che i proci ignoreranno lrsquoinvito di Telemaco a lasciare la sua casa e fatto piugrave importante che gli degravei tra breve ricondurranno in patria Odisseo A queste osservazioni si puograve replicare con la stessa West che laquosi sono esagerate difficoltagrave e
23 Omero Odissea I cit 219 ss
Letteratura greca [1]
28
incongruenze alle quali un pubblico di ascoltatori (o anche un lettore moderatamente attento) probabilmente non farebbe casoraquo 2 Il progetto di una pubblica denuncia dei proci dinanzi agli degravei e agli uomini ai vv 273-274 egrave ciograve che Atena sembra prefiggersi nel promuovere lrsquoassemblea degli Itacesi (assemblea che effettivamente avragrave luogo a principio del canto II) drsquoaltra parte le successive istruzioni di AtenaMente ai vv 295 s (medita come uccidere i pretendenti) presuppongono che di quella richiesta da formulare nel corso dellrsquoassembla essi non terranno alcun conto Anche a questa osservazione si puograve rispondere che laquoegrave ragionevole attendersi che Telemaco condivida la previsione di un esito negativo della sua iniziativaraquo e si puograve aggiungere che pure in caso di insuccesso il ricorso allrsquoassemblea potrebbe ottenere almeno il risultato di screditare i pretendenti presso la comunitagrave itacese legittimando un successivo ricorso alla violenza (e si tratta di una legittimazione di cui anche lrsquoultimo canto mostreragrave lrsquoesigenza) 3 Dopo che Telemaco aveva detto che la madre non intendeva risposarsi (vv 249-250) AtenaMente si esprime ai vv 275-278 come se Penelope desiderasse proprio nuove nozze e inoltre sarebbe assurdo che il padre di Penelope cominciasse a contrattare un secondo matrimonio prima del ritorno di Telemaco dal suo viaggio e che mettesse mano a preparativi che rischierebbero di essere annullati qualche tempo dopo con inevitabile imbarazzo se Telemaco venisse a sapere che Odisseo egrave ancora vivo In piugrave lrsquoandamento sintattico di questi versi presenta un anacoluto durissimo per cui a principio del v 275 lrsquoaccusativo μητέρα egrave seguito da un ἂψ ἴτω (laquovada indietroraquo laquotorniraquo) che richiederebbe come soggetto un nominativo μήτηρ Come hanno reagito i lettori di Omero Nellrsquoantichitagrave un grammatico rimasto anonimo cambiava come attesta uno scolio μητέρ᾽ in μήτηρ nel secolo XVIII Richard Bentley modificava ἴτω in ἴμεν (infinito eolico di εἶμι laquovadoraquo) nel XIX un altro grande della filologia europea Gottfried Hermann risolveva piugrave drasticamente la questione eliminando il complesso dei vv 275-278 e la stessa West mostra simpatia per tale proposta supponendo laquounrsquoaggiunta posteriore modellata sul corrispondente passo del libro IIraquo (dove i vv 196 s sono identici ai vv 277 s e il v 195 copre lo stesso contenuto dei vv 275 s) Si tratta di procedimenti adeguati ai dati di fatto Migliorano davvero il testo che ci egrave stato tramandato In realtagrave ambedue le ldquocorrezionirdquo appena ricordate (di μήτερ᾽ e di ἴτω) ottengono un risultato tanto lineare che egrave davvero difficile pensare che lrsquoanacoluto avrebbe potuto invadere tutta la tradizione se non fosse stato originario e quanto allrsquoespunzione dei vv 275-278 essa indubbiamente peggiorerebbe il ritmo del discorso determinando lrsquoavvicinamento fra i due versi (v 271 e v 279) molto simili fra loro che aprono le due sequenze occupate dai consigli di Mente E allora La via piugrave saggia egrave senzrsquoaltro quella di tenerci qui come quasi sempre di fronte al testo omerico contraddizioni e anacoluti riconoscendo in essi lrsquoeffetto dellrsquoattivitagrave di un cantore che pur sulla base di una traccia largamente memorizzata restava pur sempre legato a quella prassi orale per cui composizione ed esecuzione tendevano a coincidere E lrsquoanacoluto si spiega bene se cerchiamo di immedesimarci nel procedimento seguito dal poeta Egli ha affidato ad Atena un certo flusso argomentativo per cui la dea deve dar consigli a Telemaco sui suoi rapporti coi proci e con la madre e cosigrave colloca in fine di v 274 un ἄνωχθι (laquoordinaraquo) destinato a reggere gli accusativi simmetricamente dislocati in principio di verso (vv 274 e 275) μνηστῆρας e μητέρα Senoncheacute giunto a questa seconda parte dellrsquoargomentazione egli si avvede quanto sarebbe illogico che Telemaco sollecitasse la madre a nuove nozze di qui lrsquoimprovviso cambio di costruzione che svincola al prezzo di una sensibile slogatura sintattica lrsquoipotesi delle nuove nozze dallrsquoordine impartito a Telemaco e la prospetta invece come un desiderio eventuale della stessa Penelope Il poeta ha un progetto ben meditato brani e sequenze piugrave volte sperimentati ed egrave col supporto di questi materiali giagrave elaborati che egli si fa strada attraverso le insidie della
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
3
Essi cosigrave banchettavano nella gran sala dallrsquoalto soffitto i vicini e i parenti di Menelao glorioso Lietamente tra loro cantava lrsquoaedo divino suonando la cetra in mezzo ad essi due acrobati volteggiavano dando inizio alla danza
[Tr di GA Privitera]9 Alcuni studiosi ritengono che fra VIII e inizio del VII secolo aC ldquoOmerordquo si rivolgesse esclusivamente ai nobili e fondano questa ipotesi da un lato sulla tematica generale dei poemi sullrsquoambiente che fa da sfondo alle vicende narrate sulla mentalitagrave e i sentimenti sottesi alle affermazioni dei singoli personaggi sui rapporti interpersonali che fra di essi intercorrono dallrsquoaltro sullrsquoosservazione che i cantanti serbi di caffegrave-concerto i contadini i pastori e i portatori drsquoacqua neo-greci i pescatori russi etc che le odierne ricerche hanno via via assunto come termini di confronto mostrano unrsquoidentitagrave sociologica comunque diversa da quella dei bardi greci Ma pur se appare innegabile il carattere aristocratico di molta parte del mondo omerico crsquoegrave una serie di dati che suggeriscono per gli aedi una pluralitagrave di possibili uditoricirc fino a comprendere lrsquointera comunitagrave Cosigrave in Odissea XVII 385 lrsquoaedo egrave definito come un laquolavoratore per la collettivitagraveraquo (δημιοεργός) al pari dellrsquoindovino del medico e del carpentiere (un indizio altresigrave che gli aedi erano riuniti in corporazioni o gilde)10 Demodoco canta oltre che nel palazzo di Alcinoo anche di fronte a tutto il popolo dei Feaci (Odissea VIII 254 ss) Esiodo racconta di aver vinto a Calcide in Eubea un tripode nelle gare in onore di Anfidamante (Erga 654-659) e nel Certame di Omero ed Esiodo10 si racconta che Omero recitograve lrsquoinno ad Apollo alla festa panellenica di Delo altrettanto chiaramente collettivo e comunitario egrave lo scenario di pubblico presupposto nellrsquo ldquoomericordquo Inno ad Apollo Anche per quanto riguarda il punto di vista sociologico presupposto dai poemi non si puograve considerare irrilevante lrsquoinsistita preoccupazione nellrsquoOdissea percheacute venga garantita una giustizia capace di frenare i soprusi dei potenti (unrsquoottica che avvicina il poema alle ansie espresse negli Erga da Esiodo) Sembra perciograve piugrave corretto supporre che lrsquoepica omerica volesse e sapesse mediare attraverso il canto fra i valori di unrsquoaristocrazia desiderosa di autorealizzarsi nelle memorie degli avi (veri o presunti) e le prospettive di un piugrave vasto mondo sociale Fonte drsquoispirazione del canto dellrsquoaedo egrave la Musa come rileviamo tanto in relazione a Demodoco (Odissea VIII 44 s τῷ γὰρ ῥα θεὸς περὶ δῶκεν ἀοιδήν τέρπειν ὅππῃ θυμὸς ἐποτρύνῃσιν ἀείδειν laquoa lui in sommo grado un dio donograve il canto a darci diletto comunque il cuore lo spinge a cantareraquo)11 quanto per lrsquoitacese Femio Ma lrsquoazione ispiratrice della Musa non egrave sentita come limitazione della personale originalitagrave del cantore tanto che Femio dichiara a Odisseo ndash nel momento in cui lo supplica di risparmiargli la vita ndash che egli egrave laquoautodidattaraquo anche se un dio ha laquoimpiantatoraquo (ἐνέφυσε) nel suo animo le vie del canto (Odissea XXII 347-49)
αὐτοδίδακτος δ᾽ εἰμί θεὸς δέ μοι ἐν φρεσὶν οἴμας παντοίας ἐνέφυσενmiddot ἔοικα δέ τοι παραείδειν ὥς τε θεῷmiddot τῶ μή με λιλαίεο δειροτομῆσαι Da me solo ho imparato a me un dio nel cuore vie
8 E sullo scudo sbalzato da Efesto si dice (Iliade XVIII 603-605) che laquovʼera molta folla intorno alla danza graziosa rapita due acrobati intanto dando inizio alla festa roteavano intornoraquo [tr di R Calzecchi Onesti] 9 OmeroOdissea I testo e commento di S West tr di GA Privitera Milano Mondadori 1981 10 Anche Esiodo (Erga 25 s) pone lʼaedo accanto a figure artigianali come il vasaio e il carpentiere 11 Cfr anche vv 62 s τὸν πέρι Μοῦσ᾽ ἐφίλησε δίδου δ᾽ ἀγαθόν τε κακόν τε ὀφθαλμῶν μὲν ἄμερσε δίδου δ᾽ ἡδεῖαν ἀοιδήν laquola Musa molto lo amograve ma un bene e un male gli dava degli occhi lo fece privo e gli donograve il dolce cantoraquo e v 73 Μοῦσ᾽ ἄρ᾽ ἀοιδὸν ἀνῆκεν ἀειδέμεναι κλέα ἀνδρῶν laquola Musa ispirava il cantore a cantare imprese gloriose di uominiraquo
Letteratura greca [1]
4
molteplici impiantograve e credo che davanti a te canterei come davanti a un dio dunque non volermi trucidare
Come spesso accade in Omero azione umana e azione divina risultano complementari qui ciograve che appare una manifestazione di autonomia e di originalitagrave se osservato sul piano umano (Femio vuol dire che non ha avuto maestri nellrsquoarte e soprattutto che egrave solito cantare sospinto dallrsquoimpulso del suo θυμός cfr il giagrave ricordato Odissea VIII 45 ὅππῃ θυμὸς ἐποτρύνῃσιν ἀείδειν) si prospetta come azione esterna se considerato dal punto di vista dellrsquointervento divino Analogamente il carattere tradizionale dei temi e degli episodi sviluppati dagli aedi non blocca lrsquoaffermarsi di unrsquoesigenza di originalitagrave come dice Telemaco alla madre in Odissea I 351 s
τὴν γὰρ ἀοιδὴν μᾶλλον ἐπικλείουσ᾽ ἄνθρωποι ἥ τις ἀϊόντεσσι νεωτάτη ἀμφιπέληται quel canto piugrave celebrano gli uomini che intorno giunge piugrave nuovo agli uditori
Il canto epico egrave una οἴμη (Odissea VIII 481 e XXII 347) la laquoviaraquo o traccia narrativa che il poeta puograve scegliere allrsquointerno del repertorio tradizionale e seguire laquoper ordineraquo (κατὰ κόσμον) partendo da un punto determinato (cfr Iliade I 4 ἐξ οὗ laquoda quandoraquo Odissea VIII 500 ἔνθεν laquoda doveraquo) Di tanto in tanto lrsquoaedo sospende la sua esecuzione (Odissea VIII 87 ὅτε λήξειε ἀείδων laquoquando interrompeva il cantoraquo) poi riprende eventualmente sollecitato dal pubblico (ibid 90 s αὐτὰρ ὅτ᾽ ἂψ ἄρχοιτο καὶ ὀτρύνειαν ἀείδειν Φαιήκων οἱ ἄριστοι ἐπεὶ τέρποντ᾽ ἐπέεσσιν laquoma quando ricominciava e lo spingevano al canto i principi dei Feaci poicheacute godevano dei suoi versiraquo) Anche lrsquouditorio come abbiamo giagrave detto puograve infatti richiedere la scelta di un determinato tema come fa Odisseo quando in Odissea VIII 487 ss chiede che Demodoco gli canti la storia del Cavallo di legno Drsquoaltra parte la poesia orale tradizionale doveva avere un respiro limitato circoscritto al tempo di una singola esecuzione (un pomeriggio o una sera) e non a caso Femio e Demodoco eseguono pezzi che occupano una parte limitata delle ore successive alla cena Da questo punto di vista lrsquoautore (o gli autori) dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea ci appare come un poeta orale estraneo alla norma capace di esibirsi nellrsquoarco di molte ore (almeno una ventina) distribuite in diversi giorni e sedute La leggenda di Omero Ci sono giunte sette biografie di Omero tutte di etagrave post-classica anche se non egrave escluso che alcune parti e alcuni motivi narrativi risalgano fino allrsquoetagrave arcaica (e in particolare a Teagene di Reggio vissuto nel VI secolo aC) Costruita a posteriori ed esposta con ricchezza di dettagli in un racconto egrave anche la leggenda di un agone poetico svoltosi a Calcide in Eubea fra Omero ed Esiodo in occasione dei ludi funebri (a cui Esiodo effettivamente partecipograve come sappiamo da Erga 654-659) per il principe Anfidamante si tratta del cosiddetto Certamen Homeri et Hesiodi che nella forma in cui ci egrave pervenuto12 risale al II secolo dC ma si basa su modelli piugrave antichi (in particolare sul Museo del retore del IV secolo aC Alcidamante) La prova si apre con un gioco di domande e risposte fra i due poeti poi ciascuno recita un passo delle proprie opere il pubblico inclinerebbe a conferire il premio a Omero ma il figlio del defunto assegna la vittoria ad Esiodo in quanto poeta della pace e dellrsquoagricoltura (sect 13)
12 Cfr Homeri opera V 218-238 Allen Possediamo qualche resto di una versione piugrave antica grazie alla testimonianza di un papiro del III secolo aC (P Flinders Petrie 25) pubblicato nel 1891
Letteratura greca [1]
5
Anche in questa fase dellrsquoagone gli Elleni sbalorditi applaudivano Omero percheacute i versi erano superiori ad ogni aspettativa e chiedevano che gli assegnassero la vittoria Il re perograve incoronograve Esiodo dichiarando che era giusto che vincesse chi esortava allrsquoagricoltura e alla pace e non colui che narrava guerre e stragi
[Tr di F De Martino]13 LrsquoOmero della leggenda biografica (ne diamo qualche cenno prendendo come base la biografia falsamente attribuita ad Erodoto)14 si sarebbe chiamato Melesigene (laquoNato presso il Meleteraquo) e sarebbe nato a Smirne da una certa Creteide di Cuma resa incinta da uno sconosciuto e condotta dal padre adottivo (Cleanatte di Argo) presso un suo amico a Smirne appena fondata Da giovane Melesigene (che non egrave nato cieco) apprende i rudimenti dellrsquoarte epica da un certo Femio un maestro di cui eredita la scuola quindi srsquoimbarca sulla nave di un certo Mente di Leucade per conoscere il mondo e arriva (dopo aver visitato Etruria e Spagna) anche a Itaca dove si ammala e abbandonato da Mente viene ospitato dallrsquoitacese Mentore Ripreso il mare con Mente (tornato a Itaca a prelevarlo) a Colofone perde la vista (di qui piugrave tardi il soprannome di Omero in quanto ὁ μὴ ὁρῶν laquocolui che non vederaquo laquociecoraquo)15 Fatto ritorno nella nativa Smirne inizia il mestiere di poeta ha successo ma presto cade in miseria e decide di trasferirsi a Cuma dove (dopo un soggiorno in una colonia cumana presso il cuoiaio Tichio) recita i suoi versi nei ritrovi degli anziani La sua fama si diffonde al punto che Melesigene chiede di esser mantenuto a spese pubbliche Di fronte al rifiuto del Consiglio cittadino maledice Cuma e si trasferisce prima a Focea dove declama di nuovo i suoi poemi nelle sale pubbliche poi a Eritre e a Chio dove intende vendicarsi di un certo Testoride che a Focea gli aveva promesso cibo e alloggio in cambio del lascito ereditario dei poemi e invece era fuggito alla volta di Chio dopo averli trascritti sotto dettatura Ma a Chio MelesigeneOmero si smarrisce fincheacute arriva alla masseria di un pastore di capre di nome Glauco che lo conduce presso il suo signore a Bolisso Qui egrave assoldato come precettore e per i figli di costui posti sotto le sue cure compone fra lrsquoaltro la Batracomiomachia Indi si reca nella capitale dellrsquoisola apre una scuola di versificazione prende moglie (da cui ha due figlie) e intanto continua a lavorare a Iliade e Odissea Riprende i viaggi approdando prima a Samo e poi a Ios dove si ammala e giace infermo sulla spiaggia qui alcuni giovani pescatori gli propongono lrsquoindovinello dei pidocchi (laquoquanto prendemmo lasciammo ciograve che non prendemmo portiamoraquo) giagrave noto a Eraclito (22 B 56 D-K) e muore per la rabbia di non aver saputo risolverlo o per la fiacchezza (come lrsquoautore della biografia preferisce immaginare) Non sono mancati tentativi fra cui si distingue per acume quello compiuto da Wolfgang Schadewaldt16 di estrarre dalle Vite superstiti unrsquoimmagine di Omero almeno significativa per la comprensione del mestiere dellrsquoaedo nellrsquoVIII-VII secolo aC17 Senoncheacute come egrave stato
13 Omero quotidiano Vite di Omero Venosa Edizioni Osanna 1984 14 Molto dibattuta egrave la questione della data di origine della biografia pseudo-erodotea ma il testo che possediamo rappresenta probabilmente la piugrave tarda rielaborazione di un racconto composto nel V-IV secolo aC verosimilmente ndash come suppose F Jacoby (Kleine philologische Schriften I Berlino 1961 11 s) ndash un prodotto di cultura sofistica comparabile con il Certamen di Alcidamante 15 Senoncheacute ὅμηρος egrave parola greca e significa laquoostaggioraquo e in effetti testimonianze epigrafiche provano che in etagrave arcaica genitori greci potevano dare al proprio figlio questo nome 16 Homer und sein Jahrhundert in Id Von Homers Welt und Werk Stoccarda 19593 87-129 17 Per Eratostene Omero sarebbe stato contemporaneo della guerra di Troia da lui datata al 1194-1184 invece per Erodoto (II 53) Omero ed Esiodo sarebbero stati coetanei e sarebbero vissuti circa 400 anni prima di lui cioegrave alla metagrave del IX secolo (II 53 2 laquoRitengo che Esiodo e Omero mi abbiano preceduto in etagrave di quattrocento anni e non di piugrave Sono essi ad aver composto per i Greci una teogonia dando agli dei epiteti dividendo gli onori e le competenze indicando le loro formeraquo [tr di A Fraschetti] Lrsquoanonimo autore di un epigramma (AP XVI 298) dice che sette cittagrave (Smirne Chio Colofone Itaca Pilo Argo Atene) si contendevano i suoi natali
Letteratura greca [1]
6
opportunamente osservato18 non solo la maggior parte delle vicende di questa ldquobiografiardquo egrave desunta proprio dai poemi omerici e specialmente dallrsquoOdissea e non solo contiene molti elementi manifestamente ridicoli ma soprattutto laquolrsquoOmero di questa leggenda egrave un cantore mendicante cieco che si intrattiene con gente semplice con calzolai pescatori e vecchi nei ritrovi delle cittagrave portuali un precettore che insegna a leggere e a scrivere e che dunque ha rapporti soprattutto con fanciulli un estemporaneo coniatore di versi ammirato soltanto dalla piccola borghesia e una sola volta nellrsquoepisodio del signore di Bolisso in contatto con il ceto elevato davanti alle cui case del resto egrave solito andare a mendicare doni con canzoni da lui stesso composte [] Chi ha delineato questrsquoimmagine di poeta ndash non importa se con intenzioni parodistiche o meno ndash aveva davanti a seacute un compositore di versi collocato nella fascia bassa di un certo ceto professionale che si egrave potuto sviluppare in questa forma solo quando i commerci e gli affari le cittagrave e le comunitagrave avevano raggiunto una piena fioritura scalzando lrsquoantica struttura aristocratica della societagrave quando cioegrave giagrave dominava la borghesia e si richiedeva piugrave spirito imprenditoriale (si pensi alla fondazione di scuole) che beni patrimoniali La condizione professionale dei rapsodi era questa artisti di declamazione paragonabili ai nostri cantanti da concerto che allora come oggi andavano in tourneacutee e che si caratterizzavano per recitare non opere da loro stessi composte ma solo grandi capolavori altrui La leggenda di Omero attribuisce questa vita di rapsodo anche al grande poeta dellrsquoetagrave arcaica i creatori di tale leggenda non conoscevano infatti al loro tempo un altro tipo di aedoraquo Dunque gli antichi non conoscevano nulla di definito sulla vita e sulla personalitagrave di Omero ciograve che possiamo ricostruire si deve basare da un lato sul modello di aedo quale emerge dai poemi (e quale piugrave sopra abbiamo cercato di sintetizzare) dallrsquoaltro su una ricognizione degli elementi costitutivi dellrsquoarte epica Il verso dellʼepica Lrsquoesametro (giagrave Erodoto usa per lrsquoesametro dattilico espressioni come ἐν ἑξαμέτρῳ τόνῳ [I 47 2] e ἐν ἔπεσι ἑξαμέτροισι [VII 220 3]) si presenta esteriormente come una successione di sei dattili di cui lrsquoultimo catalettico (con la possibilitagrave per lrsquoultimo elemento in virtugrave della pausa di fine di verso di essere realizzato indifferentemente da sillaba breve o lunga u) Le due brevi dei singoli dattili potevano essere ldquosostituiterdquo da una lunga costituendo uno spondeo (di qui la denominazione per ciascun elemento in posizione pari di biceps y) una facoltagrave molto ridotta nel quinto dattilo che si presenta generalmente in forma pura (le eccezioni sono allincirca di un caso su 18 versi) Il verso appare articolato attraverso punti di incisione le cosiddette laquocesureraquo (τομαί laquotagliraquo) le piugrave frequenti interessano il terzo metro venendo a cadere o dopo il suo elemento lungo (cesura maschile o pentemimere laquodopo il quinto mezzo piederaquo) o tra le due brevi del biceps (cesura femminile o trocaica) piugrave rara la cesura dopo il quarto elemento lungo (eftemimere laquodopo il settimo mezzo piederaquo) e subordinata ad altra cesura principale quella dopo il secondo elemento lungo (tritemimere laquodopo il terzo mezzo piederaquo) Fine di parola puograve ricorrere anche dopo il quarto dattilo (dieresi [διαίρεσις laquodivisioneraquo] bucolica cosigrave denominata dal largo uso che ne faranno i poeti bucolici drsquoetagrave ellenistica) Di qui lo schema seguente
a1 a2 m f r b ndash y ndash y ndashkk ndash y ndash kk ndash u
18 J Latacz Omero il primo poeta dellrsquoOccidente (1989) Laterza Roma-Bari 1990 28 s
Letteratura greca [1]
7
dove a1 e a2 segnalano allrsquointerno della prima metagrave del verso le posizioni che in alternativa reciproca tendono a coincidere con fine di parola m e f le posizioni della cesura principale rispettivamente maschile o pentemimere (m) e femminile o trocaica (f) r la posizione della cesura eftemimere b la posizione della dieresi bucolica Viene evitata la fine di parola dopo il terzo metro cosigrave da escludere una bipartizione simmetrica del verso Un punto in cui la fine di parola egrave tendenzialmente evitata egrave quello dopo la prima breve del quarto biceps come fu osservato da G Hermann (donde lrsquoetichetta di laquoponte di Hermannraquo) Solo con Callimaco si afferma anche il divieto che una parola che inizi nel primo metron termini con la prima breve nel secondo biceps (laquoprima legge di Meyerraquo)
PER SAPERNE DI PIUrsquo Teorie sullrsquoorigine dellrsquoesametro Sul problema dellrsquoorigine dellrsquoesametro le teorie si sono succedute numerose allrsquointerno della fondamentale contrapposizione fra chi ha individuato nella sua struttura il risultato della fusione fra preesistenti unitagrave minori e chi invece come Hoekstra (1981) ne ha proposto unrsquointerpretazione fin dallrsquoorigine unitaria Ad es Th Bergk (1854) riconduceva la genesi dellrsquoesametro a due cola lirici preesistenti Wilamowitz (1884) ne faceva il risultato della lunga evoluzione di una struttura lirica avvenuta in parallelo col passaggio dalla canzone lirica (eolica) al laquopiccolo eposraquo e da questo al laquogrande eposraquo A Meillet (1923) postulava unrsquoereditagrave pre-greca (egea) Piugrave recentemente un ritorno alla posizione di Bergk si egrave avuto da parte di ML West (1973) con lrsquoipotesi di una derivazione dellrsquoesametro dallrsquoassociazione fra un hemiepes e un prosodiaco e alla posizione di Wilamowitz nel senso dellrsquoevoluzione di un ferecrateo espanso con lrsquoinserzione centrale di tre dattili con G Nagy (1974) B Gentili (1977) ha cercato di rintracciare coincidenze fra i segmenti costitutivi dellrsquoesametro e i cola della poesia lirica drsquoetagrave arcaica partendo dal dato per cui gli schemi metrici che appaiono in alcune iscrizioni arcaiche e nella lirica di Stesicoro (hemiepes enoplio reiziano coriambico adonio etc) sono gli stessi che sembrano plasmare tutte le formule piugrave tradizionali dellrsquoesametro omerico (per unrsquoesposizione sintetica di questa teoria cfr B Gentili-L Lomiento Metrica e ritmica Storia delle forme poetiche nella Grecia antica Milano Mondadori Universitagrave 2003 pp 279-283)
La formularitagrave Il fenomeno della formularitagrave si puograve definire come la ripetizione di versi interi o di segmenti di versi specialmente nellrsquoambito di situazioni tipiche ad es per laquoquando sorse lrsquoauroraraquo troviamo usato per due volte nellrsquoIliade e in ben venti casi nellrsquoOdissea il verso
ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς e quando mattutina apparve Aurora dalle dita di rosa
Ma il caso piugrave comune di formularitagrave egrave quello rappresentato dai nessi standardizzati nomeepiteto come quelli che vengono applicati ai rispettivi protagonisti dei due poemi πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς (31 volte) e πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς (38 volte) ambedue formule clausolari ma di diversa estensione poicheacute (se riandiamo allo schema riprodotto al paragrafo precedente) esse arrivano entrambe alla fine del verso ma partendo la prima da r la seconda da f Esempi
Letteratura greca [1]
8
r Iliade I 58 τοῖσι δrsquo ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς f Odissea VIII 97 Ὣς ἔφατrsquo οὐδrsquo ἐσάκουσε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς Piugrave in particolare se consideriamo le singole articolazioni minori del verso riscontriamo che a) nel segmento iniziale si incontrano con alta frequenza brevi nessi che contengono congiunzioni pronomi e particelle connettive o avversative ad es fino ad a1 () αὐτὰρ ὁ δή ποτε ὣς τότε καὶ τότε ὣς ὁ μέν fino ad a2 () αὐτὰρ ἐπεί ἀλλ᾽ ὅτε δή ἔνθ᾽ ἄλλοι τοὶ μὲν ἔπειτ᾽ b) nel segmento centrale che va da m o da f fino a r o a b compare spesso il predicato verbale su cui gravita la frase (si veda a titolo di esempio il verso di Iliade sopra citato nel quale μετέφη si estende appunto da m a r) m r Iliade I 58 τοῖσι δrsquo ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς c) il segmento finale (a partire da r o da b) rappresenta il piugrave ricco serbatoio di nessi formulari innanzi tutto come nel caso di πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς le formule nome proprioepiteto ma anche molti casi di associazione fra nome comune ed epiteto ad es ξίφος ἀργυρόηλον φόρμιγγα λίγειαν πατρίδος αἴης θούριδος ἀλκή μώνυχες ἵπποι ὀξέϊ χαλκῷ πότνια μήτηρ Le formule tendono a organizzarsi in sistemi caratterizzati dalle tendenze complementari allrsquoestensione e allrsquoeconomicitagrave a) il principio dellrsquoestensione si connette alla tendenza dellrsquoepica a produrre nessi formulari atti a coprire tutto ciograve che nella narrazione sia tipico costante ripetitivo e a dislocare le formule coprendo le varie partizioni del verso ad es per Ettore troviamo tre formule finali di diversa estensione (φαίδιμος Ἥκτωρ κορυθαίολος Ἥκτωρ e μέγας κορυθαίολος Ἥκτωρ e una formula iniziale (Ἥκτωρ Πριαμίδης) b) il principio complementare al primo dellrsquoeconomia (o del risparmio) corrisponde al fatto che per esprimere una medesima idea essenziale esiste generalmente nella dizione epica una e una sola espressione che occupi una determinata unitagrave minore del verso Casi come μελαινάων ἐπὶ νηῶν e ἐϋσσέλμων ἐπὶ νηῶν sono doppioni apparenti hanno sigrave la stessa misura metrica ma iniziano lrsquouno in consonante con la connessa possibilitagrave di evitare lo iato o di allungare la sillaba precedente lrsquoaltro in vocale Non mancano tuttavia vere eccezioni come per lrsquohemiepes iniziale νῆας ἐπ᾽ Ἀργείων di Iliade XXIV 298 rispetto al consueto νῆας ἐπὶ γλαφυράς (16 volte) Lrsquouso di formule e soprattutto di sistemi formulari rappresentava per il poeta epico una facilitazione nel comporre improvvisando ma nella lunga evoluzione dellrsquoepica e specialmente al momento della definitiva fissazione di poemi monumentali come lrsquoIliade e lrsquoOdissea la
Letteratura greca [1]
9
sempre piugrave estesa memorizzazione di ampie zone di testo il lavorio di riflessione sui singoli episodi e sui nessi e i parallelismi fra gli episodi stessi e la scoperta di inedite possibilitagrave espressive connesse alla modificazione di formule tradizionali dovettero incoraggiare i poeti a uno sfruttamento consapevole e artisticamente meditato del ldquogioco delle formulerdquo Da un lato procedimenti come lrsquoaddensamento degli epiteti la sostituzione di un epiteto convenzionale con uno non convenzionale (con la creazione di un nesso nuovo di struttura metrica eventualmente diversa) il trasferimento di un epiteto da un referente a un altro creano nei poemi una continua tensione tra formularitagrave e superamento della formularitagrave dallrsquoaltro la rete delle corrispondenze a distanza generata dalla ripetizione di un determinato modulo permette al poeta di variare e approfondire un motivo e di sottolineare i parallelismi o le dissonanze fra determinate situazioni La guerra di Troia Schliemann e la riscoperta di Troia In etagrave moderna la riscoperta della cittagrave di Troia situata sullrsquoodierna collina di Hissarlik e sovrastante la bassa pianura attraversata dallo Scamandro a sud del promontorio del Sigeo si lega agli scavi di Heinrich Schliemann (1822-1890) che a partire dal 1866 si dedicograve al disseppellimento delle rovine di Micene di Tirinto e di altri siti micenei e appunto di Troia Nel corso del tempo si egrave venuta creando attorno alla personalitagrave di questo archeologo dilettante una sorta di leggenda a cui egli stesso contribuigrave con le autobiografie Ilios (1881) e Troja (1884) nel senso di un dilettantismo romantico di scavi avventurosi condotti con sorprendenti successi ma senza alcun rigore di metodo di un amore cieco e totale per Omero e per lrsquoEllade E in effetti oggi sappiamo che lrsquoaver percorso la Grecia e lrsquoAsia minore sulle vie di Omero non impedigrave a Schliemann a Micene di attribuire allrsquoepoca di Agamennone tombe anche di quattro secoli piugrave antiche neacute a Troia di identificare con la cittagrave omerica uno strato risalente a una fase che va dal 2300 al 2100 aC Errori del genere non dipesero tuttavia da un entusiasmo velleitario quanto dalla carenza allrsquoepoca di competenze archeologiche che potessero orientarlo verso una piugrave plausibile cronologia di reperti e di strati Occorre poi tener conto che lo strato dei materiali riferibili alla Troia omerica (o almeno a quella che oggi noi identifichiamo con la cittagrave omerica Troia VIIa) era conservato unicamente nel suo margine esterno dato che gli strati superiori della collina di Hissarlik (con le fondamenta dei palazzi e dei templi) erano stati demoliti in epoca ellenistica per realizzare il terrazzamento del suolo su cui vennero edificati nuovi templi Fu soprattutto per questa ragione che Schliemann si spinse con le proprie maestranze a scavare sempre piugrave in profonditagrave saltando gli strati del secondo millennio Dove perograve il problema consisteva nellrsquoidentificazione di un sito sulla scorta della comparazione fra gli antichi racconti e il panorama attuale Schliemann conseguigrave notevoli successi in primo luogo identificando con la collina di Hissarlik quellrsquoacropoli omerica che lrsquoopinione comune dalla fine del XVIII secolo individuava invece nel villaggio di Bunarbaschi situato su un colle a 15 km dal promontorio del Sigeo e la disputa era stata viva giagrave nellrsquoantichitagrave Ellanico di Lesbo verso il 400 aC aveva sostenuto nei suoi Troica che la Ilio del suo tempo sorta presso la collina di Hissarlik e la Ilio omerica occupavano lo stesso sito invece Demetrio di Scepsi (fr 26 Gaede) si era pronunciato per una collina a circa 9 km a sud sullrsquoaltra riva dello Scamandro La missione americana guidata nel 1932-1938 da CW Blegen e le piugrave recenti indagini sul territorio hanno offerto un quadro molto piugrave articolato e differenziato Sulla base di un nuovo diagramma la cittagrave che sorgeva al momento in cui Eratostene di Cirene fissava la caduta di Troia (1184) viene a coincidere con Troia VIIa non piugrave con quella che Schliemann chiamava laquoterza cittagraveraquo (corrispondente a Troia II) ma nemmeno come voleva W Doumlrpfeld con Troia VI (andata in rovina verso il 1300 in seguito a un terremoto) Gli scavi piugrave recenti Secondo le conclusioni di Manfred Korfmann (cfr Korfmann 2002) che ha diretto lrsquoeacutequipe dellrsquoUniversitagrave di Tubinga negli scavi piugrave recenti lrsquoantica Troia intorno al 1184 cessograve di essere abitata ma lrsquoinsediamento continuograve nellrsquoarea della rocca per circa due secoli dopo la distruzione
Letteratura greca [1]
10
della cittagrave (Troia VIIb) Verso il 700 il luogo chiamato laquoIlioraquo era largamente in rovine anche se in etagrave arcaica dovette continuare a essere frequentato come luogo di culto Il problema che si dovettero porre nellrsquoVIII secolo aC lsquoOmerorsquo o i suoi modelli dovette essere quello di rendere il racconto della guerra di Troia plausibile a un pubblico che aveva familiaritagrave con la geografia locale (lrsquoIliade offre indicazioni realistiche ad es sulla navigazione dellrsquoEgeo in IX 362 s e sulla visibilitagrave dellrsquoisola di Samotracia dalla piana di Troia in XIII 11-14) che si trattasse di genti che risiedevano nel Sigeo o in altre cittagrave vicine o di abitanti della stessa Ilion che nellrsquoVIII secolo era di nuovo attiva sia pure soltanto come centro cultuale Il santuario sorgeva allrsquointerno di una depressione naturale a sud-ovest della rocca lungo la vecchia via che conduceva alla rocca stessa Omero menziona due templi quello di Apollo e quello di Atena e le loro loro rovine sono tuttora riconoscibili I visitatori che giungevano al santuario dal Sigeo attraverso la piana dello Scamandro potevano vedere le rovine della rocca Ma - ci si chiede - quando ebbe fine il nucleo della cittagrave di Troia cantata da Omero Nel bastione a nord-est della rocca egrave stata trovata una larga e profonda cisterna con un condotto che proviene da una sorgente La sorgente fu abbandonata al piugrave tardi al tempo di Troia VIIb2 prima del 1100 A partire dal 1000950 non rimase a Troia alcun insediamento significativo Troia era molto piugrave larga di quanto ritenesse Schliemann Un fossato largo 3 m e profondo 15 completato durante lrsquoultima fase di Troia VI o al principio di Troia VIIa (cioegrave intorno al 1300) la circondava Poi esso fu rimpiazzato a sud da un fossato piugrave ampio e concentrico al primo completato verso il 1200 Il sistema di fortificazione si estendeva per quasi 2 km e pertanto racchiudeva unrsquoarea di circa 270000 m2 La rocca e la cittagrave bassa dovevano presentarsi al tempo di Omero come un imponente complesso di rovine I nuovi colonizzatori del Sigeo e di altri siti incontrarono un vasto campo attraversato da sentieri che seguivano i vecchi tracciati Negli scavi fatti nei quartieri della cittagrave bassa a sud-ovest della rocca poco fuori del muro si egrave scoperto un deposito bruciato verso la fine di Troia VI e di nuovo verso la fine di Troia VIIa (verso il 1200) La prima devastazione egrave da ricollegarsi a un terremoto ma la seconda sembra dovuta a unrsquoazione di guerra come suggerisce anche il rinvenimento di corpi insepolti o semisepolti e di depositi contenenti armi non utilizzate Verso il 1300 la porta principale di Troia era stata bloccata e ostruita percheacute qui lrsquoantico muro era in condizioni precarie e pertanto rappresentava lrsquoanello piugrave vulnerabile nel sistema di difesa Giagrave W Doumlrpfeld aveva richiamato Iliade VI 433 s (Andromaca a Ettore)
Piazza lrsquoesercito presso il fico selvatico dove egrave piugrave facile Lrsquoaccesso alla cittagrave e il superamento delle mura
In questa zona solo poco piugrave di 80 m separavano il muro della cittagrave bassa dal muro della rocca Gli epiteti omerici di Troia - laquoben costruitaraquo laquofertileraquo laquovastaraquo laquosacraraquo laquoertaraquo laquoventosaraquo laquodalle belle muraraquo laquodai bel puledriraquo - si adattano ai dati topografici ossa di cavalli sono state trovate sul terreno forti venti soffiano continuamente in estate Anche le sorgenti sono identificabili presso la porta principale cfr Iliade XXII 145-157
Passarono oltre il posto di vedetta e lrsquoalbero di fico battuto dal vento e allontanandosi sempre piugrave dalle mura si lanciarono lungo la strada Giunsero alle fontane dalle belle acque dove sgorgano due correnti dello Scamandro impetuoso una di acqua calda da cui si leva un vapore come da fuoco ardente lrsquoaltra che in piena estate versa acqua gelata come la grandine la fredda neve o il ghiaccio Vi sono accanto dei lavatoi di pietra larghi belli dove le mogli e le belle figlie dei Teucri lavavano le splendide vesti prima in tempo di pace prima che giungessero i figli dei Danai
[Tr di MG Ciani] In effetti gli scavi nellrsquoarea della caverna in cui egrave situata la sorgente hanno portato alla luce una struttura simile a una miniera con tre gallerie e altri bracci tributari creata per fornire acqua Lrsquoacqua scorreva attraverso una superficie rocciosa e poi in un canale artificiale che a sua volta raggiungeva un sistema di quattro lsquodepressionirsquo o lsquofossersquo circolari scavate nella roccia della
Letteratura greca [1]
11
misura di quasi 1 m di diametro (appunto parrebbe i πλυνοί hellip λαΐνεοι i laquolavatoi di pietraraquo ricordati da Omero) Achei e Troiani Fra XIII e XII secolo aC Troia era un grande centro politico e commerciale in grado di controllare lrsquoaccesso ai Dardanelli (lrsquoantico Ellesponto) e il trasporto su terra di beni di vario genere dalla costa egea al Mar di Marmara (lrsquoantica Propontide) e al Mar Nero In Troia VIIa egrave stata rinvenuta ceramica micenea del periodo noto come Tardo Elladico IIIB che egrave anche il periodo di maggiore splendore dei palazzi micenei sul continente greco Ersquo suggestiva lrsquoidentificazione piugrave volte avanzata in tempi recenti di TroiaIlio con Wilusa la cittagrave menzionata spesso in testi hittiti e oggetto di contesa fra gli Hittiti e quegli Ahhiyawa il cui nome sembra identificarsi con quello degli laquoAcheiraquo (Ἀχαιοί) Il documento piugrave significativo in proposito egrave il preambolo del trattato stipulato verso il 1280 aC fra il re hittita Muwattali II e Alaksandu re di Wilusa che contiene un richiamo alle precedenti relazioni fra i due stati a partire dal 1600 pur ricordando che un tempo Wilusa era sotto il dominio hittita Muwatalli afferma di aver mantenuto relazioni pacifiche anche dopo che la cittagrave era divenuta indipendente Inoltre un testo religioso hittita rinvenuto a Hattusa la capitale dellrsquoimpero hittita e databile al XIII secolo ricorda nellrsquoambito di un rituale la recita di un poema in luvio (il luvio egrave una lingua indo-europea che si distingue solo superficialmente dallrsquohittita) di cui viene riportato il primo verso laquoQuando tornarono dallrsquoerta Wilusaraquo E a Troia negli scavi piugrave recenti egrave stato trovato un sigillo con unrsquoiscrizione in luvio Drsquoaltra parte in Omero la dinastia reale troiana di cui egrave a capo Priamo figlio di Laomedonte viene fatta risalire attraverso Erittonio Troo e Ilo fino a Dardano eponimo dei Dardani che si erano stanziati nella Troade a nord del monte Ida (Iliade ΧΧ 215 ss) I Dardani nellrsquoIliade compaiono fra i principali alleati dei Troiani accanto ai contingenti provenienti da Zelea (a nord-est lungo il fiume Esepo) e a quelli di localitagrave situate sulla Propontide come Adrestea e Pitea e sulla costa asiatica dellrsquoEllesponto come Abido e Arisbe Dalla costa europea arrivano invece i Traci i Ciconi e i Peoni da oriente i Paflagoni e gli Alizoni da sud-est i Misi e i Frigi dalla zona sud-occidentale dellrsquoAnatolia i Meoni i Cari e i Lici Se Dardani Peoni Ciconi e Traci fanno parte delle popolazioni traco-frigie che fra XII e XI secolo erano scese dai Balcani in direzione dellrsquoAnatolia (cfr Erodoto 7 73 e Xanto di Lidia FGrHist 765 F 14) i Meoni sono di stirpe lidia mentre i Cari e i Lici appartengono allrsquoambito culturale e linguistico luvio-hittita Comunque sia diversamente che per Erodoto il quale inserisce il rapimento di Elena nel quadro di una serie di torti reciproci in forma di rapimenti di donne fra Greci e barbari (I 2 1) e per i poeti tragici ateniesi del V secolo aC in Omero lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato come un contrasto fra culture diverse I Troiani mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei (detti anche laquoDanairaquo - cioegrave discendenti di Danao - o laquoArgiviraquo in relazione al contingente proveniente dallrsquoArgolide guidato da Agamennone il capo della spedizione) e lo stesso vale per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari in Iliade ΙΙ 867 come laquodi lingua stranieraraquo (βαρβαρόφωνοι) suggerisce che un tale epiteto non sarebbe stato applicabile ai Troiani Infine sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di unrsquoimbarcazione sono altrettanti esempi di quelle che W Arend denominograve laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini comportamentali e tecnologiche del gruppo che le condivide (vedi scheda p xxx) La societagrave omerica
Letteratura greca [1]
12
Nel rapporto fra il mondo omerico e la storia egrave innanzi tutto da sottolineare lrsquoesistenza di un duplice piano di riferimento con talune interferenze dellrsquouno nellrsquoaltro da un lato crsquoegrave lrsquoorizzonte dei fatti collocati in un passato glorioso dallrsquoaltro lrsquoorizzonte del poeta Giagrave gli studiosi alessandrini del resto notavano che dati come lrsquoarte di montare a cavallo i segnali per mezzo della tromba e lrsquouso di bollire la carne compaiono nellrsquoIliade solo allrsquointerno delle similitudini E il testo con una sorta di arcaismo intenzionale mostra talora la consapevolezza dellrsquoabisso che separa passato e presente come quando in Iliade XII 445-449 si dice
Ettore intanto un sasso afferrograve ndash e lo portava ndash che prima stava davanti alle porte largo di sotto ma sopra era a punta questo due uomini i piugrave forti del popolo difficilmente isserebbero da terra su un carro quali son ora i mortali egli da solo lo roteava a suo agio
[Tr di R Calzecchi Onesti] Per contro le condizioni sociali rappresentate nei poemi (un mondo di grandi proprietari terrieri che reggono aziende agricole autarchiche da cui hanno preso tuttavia a distaccarsi alcune figure di artigiani il fabbro il vasaio il carpentiere il medico lrsquoindovino lrsquoaedo) rispecchiano assai piugrave la situazione storica fra VIII e VII secolo a C che le strutture della societagrave micenea Inoltre i cadaveri vengono cremati secondo la prassi piugrave recente non inumati anche se molti riferimenti omerici non rispecchiano necessariamente la pratica normale del tempo di pace trattandosi di cremazioni che avvengono oltremare non ambigua egrave comunque la testimonianza relativa alla prassi umana in generale fornita da Odissea XI 216-222 (Anticlea a Odisseo)
Ohimegrave figlio mio il piugrave misero di tutti gli uomini Persefone la figlia di Zeus non ti inganna ma la legge degli uomini egrave questa quando si muore i nervi non reggono piugrave la carne e le ossa ma la furia violenta del fuoco ardente li disfa appena la vita abbandona le bianche ossa e lrsquoanima vagola volata via come un sogno
[Tr di GA Privitera]19 Un esempio significativo di sovrapposizione tra fasi culturali distinte si coglie osservando lrsquoinventario degli oggetti accanto ad armi vasi ornamenti tipici dellrsquoVIII-VII secolo troviamo relitti risalenti allrsquoepoca micenea come la coppa di Nestore ornata di colombe descritta in Iliade XI 632 ss (simile a una coppa drsquoargento rinvenuta a Micene che riproduce disegno e artigianato dellrsquoetagrave del bronzo) lrsquoelmo di cuoio con zanne di cinghiale che Merione dagrave a Odisseo (Iliade X 261 ss) e lo scudo lungo laquosimile a torreraquo di Aiace che egrave di un tipo inusitato dopo il XIII secolo Un oggetto non riferibile neacute al mondo miceneo neacute allrsquoetagrave della fissazione dei poemi bensigrave alla prima etagrave del ferro egrave invece la coppia di aste da lancio adottate verso il 900 aC e scomparse due secoli dopo con lo sviluppo del combattimento oplitico e la reintroduzione dellrsquoasta per colpire e la menzione delle navi fenicie (una volta nellrsquoIliade e cinque volte nellrsquoOdissea) riflette la loro comparsa nellrsquoEgeo nel IX secolo aC Non diversamente sembra avvenire anche per le istituzioni politiche lrsquo ἄναξ egrave visto a volte come figura di autocrate assoluto a volte fortemente limitato dai poteri delle assemblee ndash sia quella dei capi (βουλή) sia quella delle truppe (ἀγορή) ndash o insidiato dallrsquoascesa dei gruppi aristocratici mentre il βασιλεύς non egrave piugrave il dignitario della societagrave micenea ma genericamente un principe o un capo LʼIliade
19 Omero Odissea III intr testo e commento di A Hoekstra tr di GA Privitera Mondadori Milano 1984
Letteratura greca [1]
13
LrsquoIliade (Ἰλιάς) consta di circa 15690 esametri divisi secondo una partizione che potrebbe risalire al primo editore alessandrino (Zenodoto di Efeso) in 24 libri indicati con le lettere maiuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquounitagrave strutturale di parecchi canti che spesso finiscono col tramonto o iniziano con lrsquoalba e la coincidenza fra alcuni dei titoli attribuiti a ciascun canto nelle edizioni alessandrine e quelli che si rintracciano in autori precedenti (ad es Tucidide [I 10 4] cita il ldquoCatalogo delle navirdquo cioegrave il canto II) provano che non si trattograve di una divisione arbitraria bensigrave fondata almeno in certa misura sulle abitudini dei rapsodi Tema dellrsquoopera non egrave lrsquointero assedio decennale di Troia da parte dei Greci (di norma detti Achei o Danai o Argivi) provocato dal rapimento di Elena ad opera di Paride ma una porzione assai limitata del conflitto una sequenza narrativa che copre la durata di 51 giorni e si colloca verso la fine del nono anno di guerra lrsquoira di Achille contro lrsquoAtride Agamennone il suo ritiro dalla guerra e le relative conseguenze la fine dellrsquoira lrsquouccisione e i funerali di Ettore Fu proprio questa delimitazione tematica a consentire la realizzazione di quellrsquounitagrave e compiutezza dellrsquoazione che giagrave Aristotele individuava come uno dei pregi essenziali dellrsquoopera di Omero rispetto agli altri poemi epici arcaici (Poetica 1459a-b)20
anche in questo Omero deve apparire mirabile in confronto agli altri per non aver tentato di rappresentare intera la guerra anche se essa aveva un principio e una fine il racconto sarebbe risultato troppo grande e non abbracciabile con uno sguardo oppure pur misurato nella grandezza intricato per la varietagrave Ricavatane invece una parte ha fatto uso di molti episodi per esempio con il ldquoCatalogo delle navirdquo e con altri episodi fa procedere in lungo il poema Gli altri invece come lrsquoautore delle Ciprie o della Piccola Iliade compongono unrsquoazione multipla su unrsquounica persona o un unico tempo Di conseguenza mentre dallrsquoIliade e dallrsquoOdissea si ricava unrsquounica tragedia o soltanto due da ciascuna dalle Ciprie parecchie
[Tr di D Lanza]21
Canto I Lrsquoazione si apre sul campo degli Achei devastato dalle frecce scagliate da Apollo [T1] il dio ha scatenato una pestilenza percheacute Agamennone ha rifiutato il riscatto offerto dal sacerdote Crise per la liberazione della figlia Criseide divenuta schiava dellrsquoAtride Ai guerrieri convocati in assemblea lrsquoindovino Calcante rivela che la sola via di scampo egrave la restituzione di Criseide al padre Agamennone acconsente ma solo a patto che gli venga data in cambio Briseide la schiava che Achille tiene nella sua tenda come premio personale (γέρας) ricevuto dagli altri guerrieri Achille non puograve opporsi alla prevaricazione dellrsquoAtride ma non egrave disposto a subire passivamente lrsquooltraggio e insulta Agamennone anzi egrave giagrave pronto a estrarre la spada dal fodero per farsi giustizia quando viene trattenuto da Atena apparsa allrsquoimprovviso allora si ritira nella tenda giurando che non combatteragrave piugrave [T2] Quindi invoca la madre Tetide che dopo essere apparsa al figlio sulla riva del mare intercede presso Zeus e ottiene la promessa che i Greci non vinceranno la guerra e non espugneranno Troia fincheacute Achille non riceveragrave soddisfazione per lrsquooffesa subita Ma il piano di Zeus non resta celato ad Era che ingelosita provoca una lite nel corso del banchetto degli dei tuttavia la visione di Efesto zoppicante che funge da coppiere suscita lrsquoilaritagrave dei numi e riporta la serenitagrave Canto II Quella stessa notte Zeus manda ad Agamennone un sogno ingannatore per incitarlo ad attaccare Troia LrsquoAtride riferisce il sogno agli anziani e comanda lrsquoadunata dellrsquoesercito
20 Cfr anche 1462b ταῦτα τὰ ποιήματα συνέστηκεν ὡς ἐνδέχεται ἄριστα καὶ ὅτι μάλιστα μιᾶς πράξεως μίμησις (laquoQuesti poemi sono composti come meglio non si puograve e son il piugrave possibile imitazione di unrsquounica azioneraquo) 21 Aristotele Poetica Milano Rizzoli 19902
Letteratura greca [1]
14
con lrsquoidea stravagante di saggiare lrsquoumore delle truppe proponendo il ritorno in patria Gli uomini incitati da Tersite corrono alle navi pronti a salpare ma vengono bloccati da Odisseo e da Nestore Egrave significativo che Tersite lrsquoanti-eroe riecheggi le accuse di Achille ad Agamennone sottolineando gli onori di cui questi gode e prenda le parti di Achille [T3] Per tutta la seconda parte del libro lrsquoazione viene interrotta per far posto alla grandiosa uscita in armi dellrsquoesercito acheo dal recinto delle navi un quadro scintillante ornato da una catena di sei similitudini concatenate introdotte per illustrare il fulgore delle armi il rombo dei passi umani e degli zoccoli precipitosi lrsquoaspetto della schiera achea e la maestria dei condottieri Un ldquoCatalogo delle navirdquo contiene lrsquoelenco circostanziato delle genti greche che hanno preso parte allrsquoassedio ed egrave seguito da un catalogo piugrave breve e piugrave arido degli alleati dei Troiani accorsi in difesa di Ilio Canto III Lrsquoatteso scontro tra gli schieramenti appena passati in rassegna non ha luogo ParideAlessandro ottiene infatti una tregua per sfidare Menelao Iride la messaggera degli degravei spinge Elena ad accorrere alle mura presso le porte Scee per assistere al preannunciato duello di ligrave Priamo e gli altri anziani di Troia osservano la pianura Su richiesta del vecchio sovrano (una richiesta che sarebbe stata piugrave ldquoverosimilerdquo al primo anno di guerra) Elena nomina i piugrave prestigiosi campioni achei [T4] Nel duello che segue Paride si trova ben presto a mal partito contro Menelao ma Afrodite lo sottrae ai colpi del nemico avvolgendolo in una fitta nebbia e lo riporta nelle sue stanze dove dopo aver assunto lrsquoaspetto di una vecchia filatrice ordina a Elena di giacere con lui Elena si ribella ma la dea non transige Mentre Paride ed Elena si uniscono nellrsquoamplesso Menelao furibondo cerca fra la folla il nemico che sia i Greci che i Troiani sarebbero lieti di consegnargli pur di porre fine alla guerra Agamennone rivendicando la vittoria di Menelao pretende dai Troiani la restituzione di Elena e delle sue ricchezze noncheacute il pagamento di una forte ammenda Canto IV La tregua stipulata dopo la scomparsa di Paride viene infranta dallrsquoarciere Pandaro che sollecitato da Atena (scesa tra le schiere troiane su ordine di Zeus) ferisce con una freccia Menelao questi viene prontamente guarito dal medico Macaone figlio di Asclepio Agamennone passa fra le schiere incitandole a combattere incontra vari capi intenti a dare istruzioni ai propri uomini Solo Ulisse e Menesteo si tengono in disparte ricevendo i rimproveri di Agamennone ai quali Ulisse reagisce con indignazione Gli Achei muovono contro i Troiani con grande ordine e disciplina mentre i Troiani e i loro alleati schiamazzano come barbari Ha inizio la battaglia vera e propria nella quale lrsquoattenzione egrave focalizzata sui duelli individuali Ad assistere e rincuorare i Troiani compare Apollo sulla rocca di Troia mentre Atena infonde coraggio nei Greci Il canto si chiude sullrsquoinfuriare della battaglia la cui descrizione riprenderagrave nel canto successivo Canto V Balza in primo piano Diomede di cui viene presentata lrsquoἀριστεία lrsquoeroe laquoglorioso e chiaroraquo fa strage di nemici imperversando furiosamente fra le schiere troiane Nel pieno del combattimento viene ferito da una freccia scagliata da Pandaro il quale mena gran vanto del colpo andato a segno Diomede ottenuta unrsquoimmediata guarigione grazie allrsquointervento di Atena muove allora contro il nemico che nel frattempo era stato accolto sul carro di Enea Pandaro scaglia la sua lancia contro Diomede ma lo scudo di questi regge il colpo Diomede colpisce a sua volta uccidendo il nemico Enea scende dal cocchio per proteggere il cadavere di Pandaro dagli Achei che vorrebbero farne razzia ma Diomede lo colpisce con un grande masso fratturandogli il femore Enea viene salvato dallrsquointervento di Afrodite che lo avvolge nel suo manto mentre Diomede arriva addirittura a ferire al polso la dea che fugge sullrsquoOlimpo a farsi confortare dalla madre Dione Il figlio di Tideo attacca anche Apollo che aveva sottratto Enea alla sua furia ma
Letteratura greca [1]
15
egrave fermato dal grido di ammonimento del dio Incitati e aiutati da Ares ora i Troiani avanzano con impeto Intervengono Era e Atena e questrsquoultima assume il ruolo di auriga di Diomede Col suo aiuto questi ferisce al ventre Ares che fugge sullrsquoOlimpo Anche le dee vi fanno ritorno Canto VI Il canto VI egrave una naturale continuazione del V (tanto che Erodoto citeragrave come dallrsquoἀριστεία di Diomede un brano della prima parte del VI canto) La battaglia infuria nella pianura ma il furore di Diomede si stempera su una nota di cortesia quando lrsquoeroe dopo aver sfidato Glauco di Licia scopre di avere con lrsquoavversario antichi rapporti di ospitalitagrave I due si scambiano le armature (a detrimento di Glauco a cui laquoZeus Cronide levograve il senno cheacute scambiograve con Diomede Tidide armi drsquooro con armi di bronzo cento buoi con nove buoiraquo [vv 234-6]) Frattanto Ettore su invito dellrsquoindovino Eleno rientra in cittagrave dove le donne devono cercare di ottenere con offerte e voti il favore di Atena e incontra dapprima la madre Ecuba poi Paride (che intende ricondurre alla battaglia) vorrebbe salutare anche la moglie ma non la trova in casa bensigrave alle porte Scee dove Andromaca era accorsa piena drsquoangoscia insieme col figlioletto e con la nutrice Nel colloquio che segue ella lo implora di non esporre al pericolo se stessa e il figlio La replica di Ettore egrave esemplare per capire la prospettiva del poema e le motivazioni dellrsquoagire dei personaggi dominanti se Achille e gli eroi achei in genere cercano onore e gloria a questa motivazione (che pure non egrave assente) Ettore antepone lrsquoαἰδώς il senso di laquovergognaraquo e di responsabilitagrave nei confronti della comunitagrave e del nucleo familiare di cui egrave il difensore Poi si volta per prendere tra le braccia Astianatte ma lrsquoelmo lucente e il cimiero ondeggiante impauriscono il piccolo che si rifugia in seno alla nutrice Alla fine del canto Paride si incontra con Ettore e i due si avviano verso il campo di battaglia [T5] Canto VII A principio del canto VII Atena e Apollo si accordano per indurre Ettore a lanciare una sfida agli Achei per un duello Il sorteggio designa Aiace come campione greco Nello scontro Ettore lancia per primo lrsquoasta che penetra ma senza trapassarlo nello scudo di Aiace greve e massiccio (compaginato con sette strati di pelle bovina simile a una torre) Aiace di rimando lacera lo scudo e il pettorale della corazza ma non riesce a squarciare le carni del nemico percheacute Ettore si piega di lato Allora i due brandiscono di nuovo le aste poi ricorrono alle pietre Alla fine gli araldi arrestano il combattimento con la giustificazione che laquola notte giagrave viene ed egrave bene obbedire alla notteraquo (v 282) Su proposta di Nestore gli Achei decidono per il giorno seguente di seppellire i morti e di scavare una grande trincea difesa da un bastione sul margine del loro accampamento Respingono lrsquoofferta di pace dei Troiani (che prevederebbe la riconsegna dei tesori sottratti da Paride a Sparta) Il mattino seguente i morti vengono cremati e durante la giornata si erige il muro di protezione Canto VIII Nellrsquoassemblea degli degravei Zeus vieta ai numi di appoggiare lrsquouna o lrsquoaltra parte in conflitto Al mattino il combattimento riprende e a mezzogiorno Zeus pone i destini dei due popoli sulla bilancia che piega a favore dei Troiani Sul campo di battaglia Diomede salva Nestore Lrsquoazione di Ettore egrave travolgente fincheacute Zeus contravvenendo alla sua intenzione di favorire i Troiani accoglie la preghiera di Agamennone per risollevare il morale degli Achei che organizzano la difesa delle navi Nel corso degli scontri si segnala lrsquoarciere Teucro che colpisce i nemici muovendosi in sincronia con Aiace Telamonio che lo protegge con lo scudo Incitato da Agamennone egli prova a colpire anche Ettore ma soccombe colpito con una pietra A questa vista Era e Atena corrono ad armarsi per intervenire a favore degli Achei ma vengono distolte dalle minacce di Zeus che manifesta la propria intenzione di favorire i Troiani fino a quando i Greci non saranno ridotti alla disperazione tanto da scongiurare Achille percheacute ritorni Il sopraggiungere della notte
Letteratura greca [1]
16
interrompe i combattimenti Ettore galvanizzato dai successi ottenuti in quel giorno si illude che la vittoria sia a portata di mano e prospetta ai suoi una prossima ritirata degli Achei Il canto si chiude con il banchetto dei Troiani che banchettano nella pianura esaltati dalla speranza di vittoria Canto IX Agamennone affranto propone di fare ciograve che nel canto II aveva suggerito soltanto per mettere alla prova lrsquoesercito interrompere la guerra e tornare in patria Diomede si oppone e Nestore in un consiglio dei capi propone di tentare la riconciliazione con Achille Si invia alla tenda di Achille unrsquoambasceria (composta da Aiace Odisseo e Fenice antico pedagogo di Achille) per offrire doni ricchissimi Achille non cede anzi minaccia di salpare immediatamente verso la patria [T6] Inutilmente Fenice lrsquoantico precettore di Achille cerca di ammorbidire la determinazione del Pelide richiamando la vicenda dellrsquoeroe Meleagro [T7] Gli inviati riferiscono ad Agamennone la risposta di Achille egli torneragrave a combattere solo quando Ettore saragrave arrivato fino alle navi dei Mirmidoni Canto X Nella stessa notte si effettua una missione segreta nel corso della quale Odisseo e Diomede dapprima catturano la spia troiana Dolone (che Ettore aveva inviato alle navi achee promettendogli come ricompensa i cavalli di Achille) poi uccidono il re trace Reso appena arrivato presso i Troiani e ne rubano i magnifici cavalli Giagrave gli antichi ritenevano questo canto unrsquoaggiunta post-omerica e questi dubbi trovano riscontro in lati eccentrici della narrazione e nellrsquoimpiego di un linguaggio che spesso appare svincolato dal corrente repertorio formulare Canto XI Si apre una nuova giornata di battaglia (la cui narrazione si protrarragrave fino al canto XVIII) che ruota intorno allrsquoἀριστεία di Agamennone Quando lrsquoAtride viene ferito gli Achei ripiegano Diomede resta anchrsquoegli ferito Odisseo e Aiace evitano a stento la massa dei nemici Nestore salva sul suo carro Macaone Achille che dalla poppa della nave osserva la battaglia vuol sapere chi egrave condotto via da Nestore e manda Patroclo che viene accolto molto benevolmente e con cui Nestore intrattiene un lungo discorso egli dice di deplorare il comportamento di Achille e con atteggiamento consono alla sua condizione di anziano si dilunga nel raccontare le proprie gesta giovanili Egli esorta quindi Patroclo a far leva sulla sua amicizia per convincere Achille a riprendere il combattimento o - almeno - a concedere a Patroclo le sue armi per incutere timore nei Troiani Eccitato dalle parole del vecchio Patroclo si avvia verso la nave di Achille ma incontra Euripilo ferito che gli chiede aiuto ed egli impietositosi lo accompagna alla tenda e cura la ferita Canto XII Divisi in cinque contingenti i Troiani danno lrsquoassalto al muro eretto a difesa del campo acheo Sul campo di battaglia si manifesta un prodigio unrsquoaquila in cielo con un grosso serpente fra le zampe che riesce a ferire lrsquouccello e a sfuggire Polidamante che interpreta il segno come un presagio funesto consiglia di tornare indietro ma Ettore egrave di altro avviso Sarpedone e Glauco sferrano un attacco contro il muro e - pur rimanendo feriti - riescono ad aprire una breccia La battaglia infuria con esito incerto fincheacute Ettore con un macigno sfonda una delle porte consentendo ai Troiani di entrare in massa nel campo acheo mentre i Greci fuggono verso il mare Canto XIII Zeus distoglie lo sguardo dalla battaglia nella convinzione che nessuno fra gli dei avrebbe osato violare il divieto di intervenire ne approfitta invece Poseidone favorevole ai Greci Assunto lrsquoaspetto dellrsquoindovino Calcante il dio infonde nuovo vigore nei due Aiaci
Letteratura greca [1]
17
spronandoli al combattimento Gli Achei riconoscono lrsquointervento divino e riprendono fiducia I combattimenti si susseguono violentissimi Nella resistenza si distingue il re cretese Idomeneo Polidamante consiglia una seconda volta di interrompere la battaglia e accenna allrsquoimminente intervento di Achille Ettore non ascolta lrsquoammonimento e riprende lrsquoassalto Il canto si chiude con un suo scambio di insulti con Aiace Telamonio Canto XIV Mentre Diomede Odisseo e Agamennone tornano feriti allrsquoaccampamento Era per distogliere Zeus dalla battaglia e consentire a Poseidone di favorire gli Achei indossa la cintura magica di Afrodite e sollecita il consorte a un convegno amoroso sullrsquoIda dopo lrsquoamplesso Zeus cade in un sonno profondo e Hypnos (il Sonno) annuncia a Posidone che potragrave aiutare senza rischi gli Achei Ettore colpito con una pietra da Aiace resta a lungo in stato di incoscienza e i Troiani vengono respinti Canto XV Zeus si risveglia avvedendosi dellrsquoinganno subito e costringe Era a mandargli Iride e Apollo la prima allontaneragrave Posidone dal campo di battaglia Apollo inciteragrave Ettore a far retrocedere gli Achei fino alle navi dei Mirmidoni Riprende lrsquooffensiva troiana Apollo stesso abbatte il muro e scuotendo lrsquoegida atterrisce gli Achei Patroclo corre da Achille mentre i Troiani giagrave sono sul punto di appiccare il fuoco alle navi Canto XVI Patroclo in lacrime supplica Achille di intervenire o di mandare lui stesso al suo posto [T8] Achille gli consegna le proprie armi e gli fa promettere che non si avventureragrave oltre la zona delle navi Ma Patroclo trascinato dal suo stesso impeto oltrepassa il limite prescrittogli da Achille Abbatte Sarpedone figlio di Zeus attorno al cui cadavere infuria la lotta fincheacute Apollo lo sottrae alla mischia e Hypnos e Thanatos (il demone della morte) lo trasportano in Licia sua patria Patroclo continua lrsquoassalto alla testa dei Mirmidoni fin sotto le mura di Troia ma poco prima del tramonto al quarto assalto Apollo stesso assunto lrsquoaspetto di Asio lo percuote fra le spalle allora Euforbo lo colpisce con lrsquoasta ed Ettore lo trafigge Canto XVII Euforbo viene ucciso da Menelao ma Ettore riesce a catturare le armi di Achille indossate da Patroclo Vigorosamente sostenuti da Aiace gli Achei difendono il cadavere Una densa nebbia scende sui combattenti Zeus infonde nuovo ardimento nei cavalli di Achille piangenti per la fine di Patroclo [T9] Atena e Apollo arroventano la lotta attorno alla salma In seguito alla preghiera di Aiace Zeus dissolve la nebbia Menelao manda Antiloco figlio di Nestore a informare Achille della morte di Patroclo la cui salma viene intanto trascinata fuori della battaglia da Menelao e Merione mentre i due Aiaci offrono la necessaria copertura contro la furia incalzante dei nemici Canto XVIII Lo scoppio di selvaggio dolore a cui si abbandona Achille allrsquoudire della morte di Patroclo provoca lrsquoaccorrere dal mare di Tetide insieme con le Nereidi La madre gli promette di procurargli nuove armi Poicheacute la salma di Patroclo egrave tuttora contesa Achille fa la sua apparizione sul fossato e lancia un grido che atterrisce i nemici Efesto su preghiera di Tetide foggia le nuove armi fra cui un magnifico scudo su cui appaiono effigiati in bande concentriche gli aspetti salienti dellrsquoesistenza umana Canto XIX Il mattino seguente Tetide porta le armi al figlio e con lrsquoambrosia preserva la salma di Patroclo dalla decomposizione Achille convoca unrsquoassemblea dellrsquoesercito e rinuncia alla sua collera Agamennone lamenta di essere stato ldquoaccecatordquo da Zeus e promette doni
Letteratura greca [1]
18
riparatori [T10] Achille si lascia convincere a stento ad attendere che i soldati abbiano mangiato Poi gli armati si radunano e anche Achille si arma Il suo cavallo Xanto gli predice la prossima morte [T11] Canto XX Zeus consente agli degravei di partecipare alla nuova battaglia Enea scontratosi con Achille egrave tratto in salvo da Posidone Achille infuria come un incendio in una selva Canto XXI Achille colma di cadaveri il fiume Scamandro e cattura dodici giovani troiani che intende offrire in sacrificio a Patroclo non risparmia neppure Licaone figlio di Priamo che lo supplica con accenti di grande intensitagrave ma altrettanto intensa nella consapevolezza di un destino imminente egrave la pur spietata replica del Pelide [T12] Lo Scamandro solleva le proprie onde ma le fiamme di Efesto inaridiscono il terreno e domano la corrente Gli degravei si azzuffano Atena raggiunge Ares con una pietra Era rintuzza la furia di Artemide Infine tutti tornano sullrsquoOlimpo Apollo assunto lrsquoaspetto di Agenore respinge Achille percheacute i Troiani possano rifugiarsi allrsquointerno delle mura Canto XXII Il solo Ettore resta fuori nella pianura Invano Priamo ed Ecuba lo pregano di rientrare Mentre Achille si avvicina Ettore decide di affrontarlo ma quando quello gli egrave da presso col bronzo che gli lampeggia intorno laquosimile al raggio del fuoco ardente o del sole che sorgeraquo egrave afferrato dal panico e comincia a fuggire compiendo tre giri intorno alle mura Zeus pesa sulla bilancia i destini (le κῆρες) dei due eroi e quello di Ettore affonda in basso Allora Apollo lo abbandona e Atena apparsa a Ettore sotto le spoglie di suo fratello Deifobo gli si avvicina promettendogli aiuto e invece riporta ad Achille la lancia che gli era caduta fuori bersaglio Il colpo di risposta di Ettore rimbalza sullo scudo di Achille Ettore urla a Deifobo di passargli la sua lancia ma il falso Deifobo egrave scomparso ed Ettore comprende di trovarsi sullrsquoorlo dellrsquoabisso [T13] Achille gli trapassa la gola ed Ettore lo supplica di non oltraggiare la sua salma in risposta riceve la minaccia che finiragrave in pasto ai cani Achille trascina il cadavere alle navi attaccato al carro Priamo Ecuba e Andromaca si abbandonano al cordoglio a cui fanno eco le donne troiane Canto XXIII Viene preparato il banchetto funebre in onore di Patroclo la cui ombra nel corso della notte appare ad Achille chiedendo la sepoltura del corpo Il mattino seguente si appresta il rogo fra le offerte votive ci sono anche dodici giovani troiani Il giorno successivo si raccolgono le ossa di Patroclo Seguono i ludi funebri gare coi carri e con lrsquoarco duello in armi etc Canto XXIV Ogni giorno Achille trascina il cadavere di Ettore attorno alla tomba dellrsquoamico ma lo spettacolo offende gli degravei e al dodicesimo giorno Zeus decide di mandare Tetide percheacute induca suo figlio a restituire la salma di Ettore Iride viene inviata presso Priamo percheacute gli consigli di recarsi nel cuore della notte con un carro da trasporto e un copioso riscatto scortato da Ermes alla tenda di Achille Questi accoglie il vecchio con rispetto riconoscendo in lui lrsquoimmagine del padre lontano e si piega alla sua supplica [T14] Per volontagrave degli degravei il cadavere non egrave stato aggredito dalla putrefazione composto sul pianale del carro viene ricondotto dal padre a Troia Qui le lamentazioni rituali srsquoinnalzano dal gruppo delle donne (Andromaca Ecuba Elena) Si stipula una tregua di dodici giorni Per nove giorni i Troiani raccolgono legname poi anche il rogo di Ettore arde e si erige un tumulo
Letteratura greca [1]
19
Struttura e caratteri dellʼopera Poema di trama relativamente organica (soprattutto a partire dal canto XVI tutti gli avvenimenti tranne pochi episodi isolati ruotano attorno ai due principali antagonisti Ettore uccide Patroclo per vendicare Sarpedone e Achille uccide Ettore per vendicare Patroclo) pur se non privo di piugrave o meno cospicue incongruenze spiegabili in primo luogo con la lunga e complessa genesi orale dellrsquoopera lrsquoIliade lascia emergere in mezzo alle centinaia di nomi e alle intricate vicende alcuni caratteri delineati nella loro individualitagrave e innanzi tutto quelli di Achille e di Ettore accomunati dalla medesima coscienza di un destino di morte che sono pronti ad affrontare Appunto una tale attitudine a rappresentare i laquocaratteriraquo (ἤθη) dei suoi personaggi egrave un altro titolo di merito che Aristotele ascrive ad Omero (Poetica 1460a9-11)
dopo aver brevemente proemiato subito introduce un uomo una donna o un altro personaggio nessuno privo di caratterizzazione ma dotato di un carattere
Fondamentale per la struttura del poema egrave la novitagrave della prospettiva Possiamo presumere che i cosiddetti poemi ciclici22 mirassero a conservare lrsquoangolatura che era stata propria delle versioni pre-omeriche della saga troiana sigrave che puograve riuscire significativo il confronto fra lrsquoesordio della Piccola Iliade (dove muovendo da grandi entitagrave ndash la cittagrave il paese due popoli la guerra ndash viene lanciato secondo lrsquoespressione di J Latacz come laquouno sguardo dallrsquoesternoraquo)
Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην εὔπωλον ἧς πέρι πολλὰ πάθον Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος Canto Ilio e la terra dei Dardani dai bei puledri per la quale molti dolori patirono i Danai servitori di Ares
con lo laquosguardo internoraquo che caratterizza lrsquoinizio dellrsquoIliade
Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν ἡρώων αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν οἰωνοῖσί τε δαῖτα Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς Canta o dea di Achille figlio di Peleo la collera maledetta che pene innumerevoli inflisse agli Achei e molte scagliograve allrsquoAde vite possenti di eroi e ne faceva prede per i cani e pasto per gli uccelli e si avverava il volere di Zeus da quando primamente si separarono venuti a contesa LrsquoAtride sovrano di eroi e Achille magnifico
Argomento non egrave dunque come doveva avvenire nella tradizione del canto epico un evento complesso da inquadrare con un grandangolo onnicomprensivo e neppure come saragrave nellrsquoOdissea un personaggio colto nella multiforme varietagrave delle sue peregrinazioni egrave invece una reazione emotiva (lrsquoira di Achille) con le sue conseguenze (le innumerevoli morti degli Achei) Narrare di questa ira significa per il poeta cominciare da un punto preciso (laquoda quandoraquo) ossia dal momento della contesa e della separazione fra i due massimi eroi greci Agamennone il primo per potere (laquosovrano di eroiraquo) e Achille il primo per nobiltagrave e forza (δῖος) E sintomatica della bipolaritagrave del mondo epico in quanto mondo di degravei e di eroi egrave la sincronia per cui il taglio della narrazione coincide col decorso del laquovolere di Zeusraquo (Διὸς βουλή) forse da identificare con la promessa del dio a Tetide (rievocata piugrave oltre in questo
22 V cap II laquoLa tradizione omericaraquo
Letteratura greca [1]
20
stesso canto ai vv 518-527) di vendicare lrsquoaffronto subito da Achille o piugrave in generale con il corso degli eventi in quanto tutto come per definizione laquogiace sulle ginocchia di Zeusraquo Opera indubbiamente allrsquointerno del poema unrsquoidea formativa un progetto di qui un insieme monumentale unificato anche da una serie di corrispondenze a distanza fra cui particolare significato acquistano quelle fra primo e ultimo canto Nel canto I il vecchio Crise va come supplice presso Agamennone portando doni e supplicando la restituzione della figlia e Agamennone lo respinge aspramente minacciandolo di far ricorso alla violenza se dovesse tornare nel canto XXIV il vecchio Priamo va come supplice presso Achille portando doni e supplicando la restituzione del corpo del figlio Achille ha una prima reazione irosa (esordisce al v 560 con laquoSmetti di irritarmi vecchioraquo) ma poi accoglie la supplica E al di lagrave delle corrispondenze nelle linee dellrsquoazione si colgono fra principio e fine del poema alcuni importanti echi verbali in particolare fra XXIV 501 s
τοῦ νῦν εἵνεχ᾽ ἱκάνω νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενος παρὰ σεῖο φέρω δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα per lui [Ettore] vengo ora alle navi degli Achei per riscattarlo da te e ti porto compenso infinito
e I 12 s
ὁ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενός τε θυγάτρα φέρων δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα costui [Crise] venne alle navi rapide degli Achei per riscattare la figlia portando compenso infinito
fra XXIV 555-557
λῦσον ἵν᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδωmiddot σὺ δὲ δέξαι ἄποινα πολλά τά τοι φέρομενmiddot σὺ δὲ τῶνδrsquo ἀπόναιο καὶ ἔλθοις σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν restituiscimelo percheacute lo possa vedere con gli occhi e accogli il riscatto copioso che portiamo e tu possa goderne e tornare alla tua terra patria
e I 18-20
Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν εὖ δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκέσθαιmiddot παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην τὰ δ᾽ ἄποινα δέχεσθαι Atridi e voi altri Achei dai forti schinieri a voi concedano gli degravei che hanno le case in Olimpo di distruggere la cittagrave di Priamo e tornare facilmente in patria ma restituitemi la figlia e accettate il riscatto
fra XXIV 560 μηκέτι νῦν μ᾽ ἐρέθιζε (laquosmetti di irritarmiraquo) e I 32 μή μ᾽ ἐρέθιζε (laquonon mi irritareraquo) fra XXIV 568-570
τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς μή σε γέρον οὐδrsquo αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω καὶ ἱκέτην περ ἐόντα Διὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμάς Ora perciograve fra i dolori non mi eccitare lrsquoanimo ancora di piugrave bada o vecchio che non ti lasci neppure nella tenda
Letteratura greca [1]
21
bencheacute supplice e violi gli ordini di Zeus e I 26-28
μή σε γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω ἢ νῦν δηθύνοντ᾽ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο Mai te o vecchio io colga presso le concave navi ora a indugiare o piugrave tardi a tornare che piugrave non dovesse giovarti lo scettro e la benda del dio
(e infine XXIV 571 ὣς ἔφατ ἔδεισεν δ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ laquocosigrave diceva e il vecchio tremograve e obbediva alle paroleraquo ripete esattamente I 33) In effetti lrsquoepisodio terminale del poema col superamento dellrsquoira ad opera della pietagrave e del senso di unrsquoesistenza invasa dal dolore si propone come il rovesciamento consapevole dellrsquoepisodio iniziale che era apparso caratterizzato dalla cancellazione della pietagrave e del diritto dei supplici in nome della forza Al rifiuto iniziale del donoriscatto si oppone lrsquoaccettazione finale in consonanza con un principio-guida che opera nel poema secondo linee che alla fine si riunificano Agamennone restituisce Criseide al padre ma si appropria del dono fatto dagli altri Achei ad Achille (Briseide) Achille respinge i doni fatti da Agamennone per indurlo a riconciliarsi con lui ma dopo aver contestato nel IX canto la nozione che la vita umana possa essere barattata con una massa di beni torna alla lotta non in cambio di qualche premio da conquistare ma per vendicare lrsquouccisione dellrsquoamico Patroclo e tanto nella lotta sul campo di battaglia quanto nellrsquoinfierire sul cadavere di Ettore si abbandona a un furore cosigrave smisurato e patologico che puograve essere superato solo con lrsquoaccettare i doni di Priamo non tuttavia per il loro valore drsquouso ma percheacute in Priamo Achille riconosce lrsquoombra del padre lontano Cosigrave lrsquoIliade appare attraversata da un impulso fondamentale che muove dallrsquoideologia del dono e dalla conseguente centralitagrave assegnata allrsquoonore (τιμή) come ldquoprezzordquo che qualifica il valore del guerriero ma supera questo piano di valutazione dei rapporti umani attraverso la loro riformulazione nei termini di un umanesimo esistenziale che ha come punti di riferimento lrsquoidentitagrave universale dei condizionamenti oggettivi (la vecchiaia la malattia la morte) e i legami che uniscono padre e figlio compagno e compagno vivi e morti (il cordoglio finale di Andromaca Ecuba ed Elena sulla salma di Ettore) Entro questo orizzonte progressivamente allargato la guerra le lotte lo scontro mortale finiscono col rappresentare solo un momento e un aspetto dellrsquoesistenza graditi tanto agli degravei che vi assistono come spettatori interessati quanto agli uditori che riascoltano le antiche gesta eppure non tali da appiattire il poema in una prospettiva guerresca conclusa in se stessa Molto del fascino delle battaglie e delle ἀριστεῖαι dellrsquoIliade sta nella presenza recondita di un occhio che sa guardare al di lagrave di esse (e al di lagrave della stessa distinzione fra Greci e Troiani vincitori e vinti) e che puograve anche attraverso le similitudini lasciare irrompere il mondo della natura o del lavoro umano nel mezzo delle battaglie LʼOdissea LrsquoOdissea (Ὀδύσσεια) consta di circa 12100 esametri divisi anchrsquoessi in 24 libri e indicati con le lettere minuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquoargomento egrave costituito dalle avventure di Odisseo dalla distruzione di Troia al ritorno alla patria Itaca esposte secondo un ordine che entrando subito nel vivo degli avvenimenti (lrsquoinizio del poema mostra Odisseo nellrsquoisola di Calipso) rievoca poi i fatti giagrave trascorsi e li ricongiunge infine a partire dal libro XV (con lrsquoarrivo di Telemaco alla capanna di Eumeo dove giagrave si trova Odisseo) in unrsquoazione unitaria La trama del poema i cui avvenimenti sono concentrati cronologicamente nello spazio di 40 giorni (ma sono narrati solo gli avvenimenti di 16 giorni e 8 notti) si articola in tre parti la laquoTelemachiaraquo (canti I-IV) il laquoRitorno di Odisseoraquo (canti V-XIII) e la laquoVendetta di Odisseoraquo (canti XIV-XXIV)
Letteratura greca [1]
22
Canto I Tutti gli eroi superstiti sono ormai tornati da Troia alle loro case tranne Odisseo che pur desideroso di tornare egrave trattenuto dalla ninfa Calipso nellrsquoisola di Ogigia Gli degravei hanno pietagrave di lui tranne Posidone irato per lrsquoaccecamento del figlio il ciclope Polifemo Ma un consiglio degli degravei assente Posidone (che si egrave recato presso gli Etiopi) delibera il ritorno dellrsquoeroe si decide che Ermes andragrave subito da Calipso mentre Atena si avvia verso Itaca sotto lrsquoaspetto del signore dei Tafi Mente per incoraggiare il figlio di Odisseo Telemaco a tener testa ai pretendenti della madre i laquoprociraquo (i quali aspirano al regno tramite le nozze con Penelope) e per indurlo a intraprendere un viaggio in cerca di notizie sul padre Canto IΙ Telemaco segue il consiglio della dea e il giorno seguente nellrsquoassemblea popolare chiede una nave per andare in cerca del padre ma la sua richiesta non viene discussa e Leocrito scioglie lrsquoassemblea Grazie ad Atena che ora ha assunto le sembianze di Mentore (antico amico di Odisseo) Telemaco riesce tuttavia a trovare una nave con cui salpa nel corso della notte allrsquoinsaputa sia della madre che dei proci Canto IΙΙ Telemaco e MentoreAtena arrivano a Pilo e sul lido trovano Nestore che sta offrendo un sacrificio a Posidone Il vecchio eroe accoglie ospitalmente Telemaco e gli comunica molte notizie sul ritorno di altri Achei ma nessuna su Odisseo Alla sera Atena scompare in forma di aquila e il mattino seguente Telemaco salpa insieme con Pisistrato (figlio di Nestore) alla volta di Sparta dove arriva la sera del giorno successivo Canto IV A Sparta Menelao sta festeggiando il doppio matrimonio del figlio e della figlia Il giorno seguente Telemaco chiede del padre Menelao gli racconta il proprio ritorno durante il quale aveva incontrato Proteo il vecchio nume marino che gli aveva riferito come Odisseo fosse trattenuto nellrsquoisola di Calipso Intanto a Itaca i proci preparano insidie meditando di uccidere Telemaco al suo ritorno Penelope ne viene a conoscenza ma Atena le appare in sogno per confortarla Canto V Dopo un secondo concilio degli degravei (in effetti un ldquodoppionerdquo di quello del I canto) Zeus manda finalmente Ermes presso Calipso con lrsquoordine di lasciar partire Odisseo La ninfa aiuta lrsquoeroe a costruirsi una zattera Al diciottesimo giorno di navigazione Odisseo egrave in vista dellrsquoisola dei Feaci Scheria quando Posidone di ritorno dal suo soggiorno presso gli Etiopi lo vede e suscita una tempesta che distrugge la zattera Ma la dea marina Ino Leucotea impietositasi gli porge il proprio velo sostenuto dal quale lrsquoeroe giunge a nuoto alla riva di Scheria dove si abbandona esausto addormentandosi Canto VI In seguito a un sogno inviatole da Atena Nausicaa la figlia del re dei Feaci Alcinoo si reca nei pressi della spiaggia a lavare le vesti insieme con le ancelle Odisseo risvegliatosi atterrisce le fanciulle che fuggono tutte allrsquoinfuori di Nausicaa Lrsquoeroe supplica la giovane di porgerle aiuto ed ella lo fa rivestire e lo accompagna fino al bosco di Atena poco prima della cittagrave esortandolo a presentarsi a suo padre Canto VII Protetto dalla nebbia di cui Atena lo ha avvolto Odisseo entra nel palazzo abbraccia le ginocchia della regina Arete e la caligine scompare poi viene accolto con onore da Alcinoo Arete chiede a Odisseo donde provenga e chi gli abbia donato gli abiti (a lei ben noti) che indossa Lrsquoeroe inizia a raccontare le disavventure che gli sono occorse dopo la
Letteratura greca [1]
23
partenza dallrsquoisola di Calipso Alcinoo gli promette di farlo ricondurre a Itaca il giorno seguente Canto VIII Ma lrsquoindomani Alcinoo fa apprestare un banchetto durante il quale lrsquoaedo Demodoco canta della contesa insorta un giorno fra Achille e Odisseo Lrsquoeroe si copre il volto per nascondere le lacrime allora Alcinoo interrompe il canto e organizza una serie di gare nel corso delle quali Odisseo primeggia Poi Demodoco al margine di unrsquoarea per la danza dove si esibiscono i ballerini feaci canta gli amori di Ares e Afrodite e la vendetta di Efesto (che incatena i due amanti) La sera al ritorno nel palazzo Demodoco racconta la storia del Cavallo di legno Odisseo scoppia nuovamente in lacrime e Alcinoo gli chiede di rivelare il suo nome Canto IX Odisseo dichiara il proprio nome e dagrave inizio al racconto della propria storia a partire dalla caduta di Troia distruzione di Ismaro e perdite subite ad opera dei Ciconi sbarco presso i Lotofagi (che si nutrono di un cibo misterioso che fa dimenticare il ritorno) dopo una terribile tempesta scatenatasi durante il tentativo di doppiare il capo Malea arrivo allrsquoisola antistante quella dei Ciclopi dove Odisseo si trasferisce con una sola nave esplorazione dellrsquoisola perdita di alcuni compagni allrsquointerno della caverna del gigante monocolo accecamento del mostro e fuga Canto X Odisseo giunge allrsquoisola di Eolo signore dei venti che lo accoglie benevolmente e gli consegna alla partenza tutti i venti chiusi in un otre ma poi lo respinge con durezza quando ritorna presso di lui percheacute i compagni (sospettando che nellrsquootre siano racchiuse cospicue ricchezze) hanno sciolto i venti e da essi si egrave sprigionato un uragano che li ha risospinti sullrsquoisola Ripreso il mare Odisseo egrave trasportato fino ai Lestrigoni antropofagi il cui attacco priva lrsquoeroe di tutte le altre navi tranne la propria Con questa fugge fino allrsquoisola (Eea) della maga Circe Dopo che Circe ha trasformato in porci un gruppo di compagni mandati innanzi ad esplorare lrsquoisola Odisseo ha la meglio sulla maga (a cui impone di restituire forma umana ai compagni) grazie allrsquoerba moly fornitagli da Ermes Resta un anno presso Circe che al momento della partenza gli consiglia di recarsi al paese dei morti per interrogare il vate Tiresia Canto XI Approdato alla terra dei Cimmeri (che vivono immersi in una nebbia perenne sulla riva dellrsquoOceano) e scavata una fossa Odisseo sacrifica ai morti e immola una vittima speciale a Tiresia Le anime accorrono dapprima Elpenore caduto per caso giugrave dal tetto della casa di Circe (Odisseo gli promette sepoltura) poi la madre Anticlea (che gli racconta di esser morta di dolore per la sua assenza) quindi Tiresia che gli vaticina le sue vicende future fino alla morte (questa lo coglieragrave dopo una lunga vita in un paese straniero che non conosce neacute il sale neacute il remo) Da un certo punto in poi il poeta dimentica il presupposto per cui Odisseo aveva scavato una fossa alla quale i morti accorrevano per bere il sangue delle vittime e bevendolo riacquistavano per breve tempo una piena consapevolezza immagina invece che Odisseo sia allrsquointerno dellrsquoAde In questa sezione rientrano la descrizione di Aiace sdegnato di Minosse di Orione dei grandi peccatori di Eracle Poi Odisseo fa ritorno a Eea e ricevuti i consigli di Circe si imbarca per il ritorno in patria Canto XII Scampato alle Sirene che invano lo attirano col canto (si egrave fatto legare allrsquoalbero della nave i compagni che remano hanno le orecchie turate con la cera) passa tra Cariddi e Scilla (che gli rapisce sei uomini) ed egrave costretto dai compagni ad approdare in contrasto con le prescrizioni di Circe allrsquoisola Trinachia dove pascolano le greggi del Sole I
Letteratura greca [1]
24
compagni spronati da Euriloco se ne cibano nonostante il divieto dellrsquoeroe Il Sole sdegnato ottiene da Zeus che la nave sia colpita dal fulmine Tutti i compagni periscono ma Odisseo che ripassa tra Scilla e Cariddi si salva miracolosamente da questrsquoultima aggrappandosi a un fico selvatico fincheacute il gorgo restituisce i rottami della nave infine arriva remando con le mani allrsquoisola di Ogigia Canto XIII Terminato il racconto lrsquoeroe riceve doni dai Feaci e la notte seguente egrave ricondotto a Itaca e deposto addormentato sulla spiaggia presso un antro sacro alle Ninfe Al risveglio per la nebbia non riconosce la sua terra fincheacute Atena in veste di giovane pastore lo rassicura e poi rivelatasi gli dagrave istruzioni su come far strage dei proci e lo trasforma in un vecchio mendico Canto XIV Odisseo si reca allo stazzo del suo porcaio Eumeo che pur non riconoscendolo lo accoglie ospitalmente rifocillandolo e offrendogli un mantello per ripararsi dal gelo notturno Canto XV A questo punto la laquoTelemachiaraquo si riannoda allrsquoazione principale Telemaco che si trova ancora a Sparta viene indotto da Atena a tornare a Itaca sulla via del ritorno a Pilo accoglie a bordo lrsquoindovino Teoclimeno e grazie allrsquoaiuto della dea sfugge alle insidie dei proci sbarca a Itaca e si reca anchrsquoegli presso Eumeo Canto XVI Questi va da Penelope ad annunciargli il ritorno del figlio Intanto Odisseo rimosso lrsquoincantesimo si svela nel suo vero aspetto a Telemaco e con lui progetta la vendetta sui proci (che intanto tramano una nuova insidia ai danni di Telemaco) Eumeo torna al suo stazzo Canto XVII Il mattino seguente Telemaco si reca in cittagrave seguito in un secondo tempo da Eumeo e Odisseo (che ha riassunto lrsquoaspetto di mendico) Davanti al palazzo Odisseo egrave riconosciuto dal cane Argo Entra e va mendicando tra i proci Antinoo lo colpisce alla spalla destra con uno sgabello Canto XVIII Odisseo si batte al pugilato col mendicante Iro Penelope scesa nella sala prospetta ai proci lrsquoeventualitagrave di un nuovo matrimonio Odisseo egrave insultato dalla schiava Melanto e schiva uno sgabello scagliato da Eurinomo Canto XIX Insieme con Telemaco lrsquoeroe allontana le armi dalla sala poi conversa con Penelope che gli racconta un sogno e gli espone il suo piano per sedare le contese tra i proci concedendosi sposa a colui che riusciragrave a tendere lrsquoarco di Odisseo la prova avverragrave il giorno seguente al novilunio Durante il colloquio la fida schiava Euriclea lava i piedi di Odisseo e riconosciutolo da unrsquoantica cicatrice sta per rivelarne lrsquoidentitagrave ma lrsquoeroe la costringe a tacere Canto XX Al mattino Euriclea e le ancelle fanno i preparativi per il banchetto Giungono Eumeo Melanzio e il mandriano Filezio Un presagio mandato da Zeus dissuade i proci dal progetto di uccidere Telemaco Durante il banchetto Teoclimeno predice la loro imminente rovina
Letteratura greca [1]
25
Canto XXI Penelope conduce lrsquoarco nella sala dopo che parecchi fra i proci e lo stesso Telemaco hanno tentato invano di tenderne la corda Odisseo chiede di partecipare alla prova tende lrsquoarco senza fatica e riesce a far passare la freccia attraverso gli anelli di dodici scuri predisposte da Telemaco Canto XXII Poi scaglia le frecce sui proci e si rivela nella sua identitagrave Nella lotta che segue Telemaco Eumeo e Filezio aiutano il padrone contro i proci (appoggiati dal capraio Melanzio) Tutti i proci restano uccisi le ancelle infedeli sono impiccate Melanzio viene mutilato e ucciso soltanto lrsquoaedo Femio e lrsquoaraldo Medonte sono risparmiati Canto XXIII Nuovo colloquio fra Odisseo e Penelope che durante lrsquoeccidio dormiva ed egrave stata svegliata da Euriclea Penelope esita ancora a riconoscere il marito e non si arrende alla veritagrave fincheacute Odisseo non le descrive la posizione e la struttura del letto coniugale Canto XXIV Ermes conduce allrsquoAde le ombre dei proci Odisseo fa visita al padre Laerte nella masseria dove quello vive nello squallore e nellrsquoemarginazione e si fa riconoscere Intanto il padre di Antinoo incita gli Itacesi alla rivolta e il poema si conclude con lo scontro di Odisseo e dei suoi contro i concittadini lrsquoeroe ha la meglio e Zeus scagliato il fulmine pone fine alla battaglia Atena sotto lrsquoaspetto di Mentore stabilisce fra i contendenti un patto per il futuro36
Struttura e caratteri dellʼopera Giagrave la prima parola del proemio (ἄνδρα) non menziona come tema dellrsquoopera un determinato episodio della vita del protagonista ma il protagonista stesso (I 1-10)
Ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα πολύτροπον ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεmiddot πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περmiddot αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο νήπιοι οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιονmiddot αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ τῶν ἁμόθεν γε θεά θύγατερ Διός εἰπὲ καὶ ἡμῖν Dellrsquouomo multiforme a me racconta o Musa che molto errograve dopo che di Troia la sacra rocca distrusse di molti uomini vide le cittagrave riconobbe il pensiero e molti per il mare patigrave dolori nellrsquoanimo per salvare la sua vita e il ritorno dei compagni Eppure non li salvograve i compagni per quanto bramasse per la loro stessa follia si persero gli stolti i buoi del Sole Iperione mangiarono e quello rapigrave ad essi il digrave del ritorno Di questo da un punto qualsiasi narra anche a noi o dea figlia di Zeus
Storie favolose di naviganti racconti imperniati sul ritorno dei guerrieri achei che avevano combattuto a Troia e il particolare rientro in patria di Odisseo figlio di Laerte erano forse giagrave stati connessi e intrecciati nella precedente tradizione epica sigrave che il presente cantore poteva
Letteratura greca [1]
26
metter mano alla vicenda partendo (v 10) laquoda un punto qualsiasiraquo (ἁμόθεν) una notazione che certo presuppone la convenzione propria dellrsquoesordio tradizionale di un canto epico comparabile con i giagrave ricordati ἐξ οὗ (laquoda quandoraquo) di Iliade I 4 ed ἔνθεν (laquoda doveraquo) di Odissea VIII 500 Senoncheacute rispetto a queste indicazioni di tipo puntuale il tratto costituito dalla dimensione casuale quasi arbitraria inerente ad ἁμόθεν proprio mentre dichiara lrsquoassenza di un determinato piano compositivo implica in realtagrave che il racconto non si svolgeragrave per filo e per segno secondo lrsquoordine noto a poeta e uditori non si snoderagrave κατὰ κόσμον (laquoper ordineraquo) come il canto di Demodoco (VIII 489) ma seguiragrave un andamento originale Il ldquopunto qualsiasirdquo incipitario non rappresenta una scelta della Musa (figura dellrsquoarchivio tematico che conserva le laquovieraquo dellrsquoepica) bensigrave di questo cantore che ha deciso di far incominciare la narrazione in medias res e ha in serbo la sorpresa di far succedere al concilio degli degravei (che decide lrsquoinvio di Ermes presso Calipso) non lrsquoazione testeacute programmata (azione che viene differita con un ritardo che a piugrave riprese ha scandalizzato i lettori a principio del V canto) ma la partenza di Atena alla volta di Itaca e lrsquoavvio della laquoTelemachiaraquo Le due diverse vicende proposte a principio del poema quella di Telemaco e quella di Odisseo procedono infatti in parallelo coprendo un analogo lasso di tempo Piugrave oltre la decisione di trasformare la sequenza narrativa che va dalla partenza di Odisseo da Troia fino al suo arrivo nella terra dei Feaci in una rievocazione fatta dallrsquoeroe in prima persona al cospetto di Alcinoo e dei Feaci (la sezione detta degli ἀπόλογοι laquoraccontiraquo) crea una struttura ad anello che parte dal presente e ad esso fa ritorno dopo aver ricostruito le premesse della condizione attuale del protagonista Col canto XIII Odisseo egrave riportato dai Feaci a Itaca e questo permette la saldatura fra le vicende sue e quelle di Telemaco sia pure col differimento dellrsquoincontro e del riconoscimento fra padre e figlio fino al canto XVI Far scorrere in parallelo sequenze distinte organizzare programmi narrativi a corta e a lunga gittata tendere o allentare ad arte il ritmo della narrazione non si tratta davvero di procedimenti che potessero configurarsi come tradizionali dellrsquoarte epica quanto piuttosto di un momento sperimentale di una ricerca di soluzioni nuove al termine di una lunga e ormai consolidata sedimentazione di percorsi compiuti allrsquointerno di un determinato repertorio tematico unrsquoaudacia inventiva una πολυτροπίη degne del protagonista del poema che inevitabilmente comportavano rischi molteplici di incoerenze dissonanze occasionali avarie della macchina epica e che tuttavia erano destinate a conseguire un risultato assolutamente convincente allrsquoorecchio di chi si abbandonasse al fascino del racconto senza lrsquourgenza propria di altre etagrave e di altre mentalitagrave di puntare il dito sui singoli dettagli o le singole sfasature
PER SAPERNE DI PIUrsquo Difficoltagrave e incongruenze della narrazione omerica Forti della possibilitagrave di un controllo su un testo scritto che possiamo percorrere in avanti e a ritroso secondo ritmi di nostra scelta a noi non riesce difficile cogliere alcune delle difficoltagrave organizzative incontrate nella composizione del poema In proposito per ricordare un caso che saragrave allrsquoorigine delle discussioni di orientamento ldquoanaliticordquo intorno allrsquoOdissea possiamo leggere il discorso che Atena prese le sembianze di Mente re dei Tafi rivolge a Telemaco nel I canto (vv 253-305) Ah infelice ti manca molto davvero lrsquoassente Odisseo che getti le mani addosso ai pretendenti sfrontati Percheacute se ora tornato stesse sulla soglia 255 con una scure lo scudo e due lance cosigrave come io per la prima volta lo vidi in casa nostra che beveva e godeva di ritorno da Efira da Ilo di Mermero (andograve anche ligrave Odisseo con la nave veloce 260 in cerca del veleno omicida per averne da ungere le frecce di bronzo ma quello non glielo diede percheacute temeva gli dei che vivono eterni
Letteratura greca [1]
27
glielo diede invece mio padre percheacute lrsquoamava moltissimo) se stesse Odisseo tra i pretendenti cosigrave 265 essi avrebbero tutti rapida morte e nozze amare Ma sulle ginocchia degli dei questo giace se una volta tornato faragrave o no vendetta nella sua casa te invece io esorto a riflettere come cacciare i pretendenti da casa 270 Ebbene ora ascolta e alle mie parole darsquo retta Domattina chiamati gli eroi Achei a consiglio rivolgi a tutti un discorso e siano testimoni gli dei Ai pretendenti comanda drsquoandarsene per i fatti loro e tua madre se lrsquoanimo la spinge alle nozze 275 ritorni a casa del padre molto potente Prepareranno essi le nozze e disporranno i doni nuziali moltissimi quanti gli pare che debbano andare alla figlia A te darograve un saggio consiglio se vuoi ascoltarlo armata una nave con venti remi la migliore che crsquoegrave 280 Varsquo a domandare del padre partito da tempo se mai te ne parli un mortale o sentissi da Zeus la voce che divulga la fama tra gli uomini Anzitutto varsquo a Pilo e interroga il chiaro Nestore di ligrave poi varsquo a Sparta dal biondo Menelao 285 degli Achei vestiti di bronzo egli egrave tornato per ultimo Se senti dire qualcosa sulla vita e il ritorno del padre per quanto stremato potresti sopportare un altro anno se invece senti dire che egrave morto e non vive allora tornato nella cara terra patria 290 ergigli un tumulo e offrigli funebri offerte moltissime quanto conviene e darsquo tua madre a un marito E poi dopo aver compiuto e fatto ogni cosa allora medita nella mente e nellrsquoanimo come tu possa uccidere nelle tue case 295 i pretendenti con lrsquoinganno affrontandoli non devi piugrave avere i modi di un bimbo percheacute ormai non sei tale Non senti lrsquoillustre Oreste quale gloria ha acquistato fra tutti gli uomini percheacute uccise lrsquoassassino del padre Egisto esperto di inganni che gli uccise il nobile padre 300 Anche tu caro infatti molto bello e grande ti vedo sii valoroso percheacute ti lodi anche qualcuno dei posteri Ma io tornerograve adesso alla nave veloce dai compagni che forse impazienti mi aspettano Tu devi pensarci da te dammi retta 305
[Tr di GA Privitera] Le stranezze non mancano davvero e cosigrave sono state messe a fuoco da Stephanie West nel suo commento23 1 Atena sa evidentemente molto piugrave di quanto uno come Mente avrebbe potuto sapere in particolare ella sa che i proci ignoreranno lrsquoinvito di Telemaco a lasciare la sua casa e fatto piugrave importante che gli degravei tra breve ricondurranno in patria Odisseo A queste osservazioni si puograve replicare con la stessa West che laquosi sono esagerate difficoltagrave e
23 Omero Odissea I cit 219 ss
Letteratura greca [1]
28
incongruenze alle quali un pubblico di ascoltatori (o anche un lettore moderatamente attento) probabilmente non farebbe casoraquo 2 Il progetto di una pubblica denuncia dei proci dinanzi agli degravei e agli uomini ai vv 273-274 egrave ciograve che Atena sembra prefiggersi nel promuovere lrsquoassemblea degli Itacesi (assemblea che effettivamente avragrave luogo a principio del canto II) drsquoaltra parte le successive istruzioni di AtenaMente ai vv 295 s (medita come uccidere i pretendenti) presuppongono che di quella richiesta da formulare nel corso dellrsquoassembla essi non terranno alcun conto Anche a questa osservazione si puograve rispondere che laquoegrave ragionevole attendersi che Telemaco condivida la previsione di un esito negativo della sua iniziativaraquo e si puograve aggiungere che pure in caso di insuccesso il ricorso allrsquoassemblea potrebbe ottenere almeno il risultato di screditare i pretendenti presso la comunitagrave itacese legittimando un successivo ricorso alla violenza (e si tratta di una legittimazione di cui anche lrsquoultimo canto mostreragrave lrsquoesigenza) 3 Dopo che Telemaco aveva detto che la madre non intendeva risposarsi (vv 249-250) AtenaMente si esprime ai vv 275-278 come se Penelope desiderasse proprio nuove nozze e inoltre sarebbe assurdo che il padre di Penelope cominciasse a contrattare un secondo matrimonio prima del ritorno di Telemaco dal suo viaggio e che mettesse mano a preparativi che rischierebbero di essere annullati qualche tempo dopo con inevitabile imbarazzo se Telemaco venisse a sapere che Odisseo egrave ancora vivo In piugrave lrsquoandamento sintattico di questi versi presenta un anacoluto durissimo per cui a principio del v 275 lrsquoaccusativo μητέρα egrave seguito da un ἂψ ἴτω (laquovada indietroraquo laquotorniraquo) che richiederebbe come soggetto un nominativo μήτηρ Come hanno reagito i lettori di Omero Nellrsquoantichitagrave un grammatico rimasto anonimo cambiava come attesta uno scolio μητέρ᾽ in μήτηρ nel secolo XVIII Richard Bentley modificava ἴτω in ἴμεν (infinito eolico di εἶμι laquovadoraquo) nel XIX un altro grande della filologia europea Gottfried Hermann risolveva piugrave drasticamente la questione eliminando il complesso dei vv 275-278 e la stessa West mostra simpatia per tale proposta supponendo laquounrsquoaggiunta posteriore modellata sul corrispondente passo del libro IIraquo (dove i vv 196 s sono identici ai vv 277 s e il v 195 copre lo stesso contenuto dei vv 275 s) Si tratta di procedimenti adeguati ai dati di fatto Migliorano davvero il testo che ci egrave stato tramandato In realtagrave ambedue le ldquocorrezionirdquo appena ricordate (di μήτερ᾽ e di ἴτω) ottengono un risultato tanto lineare che egrave davvero difficile pensare che lrsquoanacoluto avrebbe potuto invadere tutta la tradizione se non fosse stato originario e quanto allrsquoespunzione dei vv 275-278 essa indubbiamente peggiorerebbe il ritmo del discorso determinando lrsquoavvicinamento fra i due versi (v 271 e v 279) molto simili fra loro che aprono le due sequenze occupate dai consigli di Mente E allora La via piugrave saggia egrave senzrsquoaltro quella di tenerci qui come quasi sempre di fronte al testo omerico contraddizioni e anacoluti riconoscendo in essi lrsquoeffetto dellrsquoattivitagrave di un cantore che pur sulla base di una traccia largamente memorizzata restava pur sempre legato a quella prassi orale per cui composizione ed esecuzione tendevano a coincidere E lrsquoanacoluto si spiega bene se cerchiamo di immedesimarci nel procedimento seguito dal poeta Egli ha affidato ad Atena un certo flusso argomentativo per cui la dea deve dar consigli a Telemaco sui suoi rapporti coi proci e con la madre e cosigrave colloca in fine di v 274 un ἄνωχθι (laquoordinaraquo) destinato a reggere gli accusativi simmetricamente dislocati in principio di verso (vv 274 e 275) μνηστῆρας e μητέρα Senoncheacute giunto a questa seconda parte dellrsquoargomentazione egli si avvede quanto sarebbe illogico che Telemaco sollecitasse la madre a nuove nozze di qui lrsquoimprovviso cambio di costruzione che svincola al prezzo di una sensibile slogatura sintattica lrsquoipotesi delle nuove nozze dallrsquoordine impartito a Telemaco e la prospetta invece come un desiderio eventuale della stessa Penelope Il poeta ha un progetto ben meditato brani e sequenze piugrave volte sperimentati ed egrave col supporto di questi materiali giagrave elaborati che egli si fa strada attraverso le insidie della
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
4
molteplici impiantograve e credo che davanti a te canterei come davanti a un dio dunque non volermi trucidare
Come spesso accade in Omero azione umana e azione divina risultano complementari qui ciograve che appare una manifestazione di autonomia e di originalitagrave se osservato sul piano umano (Femio vuol dire che non ha avuto maestri nellrsquoarte e soprattutto che egrave solito cantare sospinto dallrsquoimpulso del suo θυμός cfr il giagrave ricordato Odissea VIII 45 ὅππῃ θυμὸς ἐποτρύνῃσιν ἀείδειν) si prospetta come azione esterna se considerato dal punto di vista dellrsquointervento divino Analogamente il carattere tradizionale dei temi e degli episodi sviluppati dagli aedi non blocca lrsquoaffermarsi di unrsquoesigenza di originalitagrave come dice Telemaco alla madre in Odissea I 351 s
τὴν γὰρ ἀοιδὴν μᾶλλον ἐπικλείουσ᾽ ἄνθρωποι ἥ τις ἀϊόντεσσι νεωτάτη ἀμφιπέληται quel canto piugrave celebrano gli uomini che intorno giunge piugrave nuovo agli uditori
Il canto epico egrave una οἴμη (Odissea VIII 481 e XXII 347) la laquoviaraquo o traccia narrativa che il poeta puograve scegliere allrsquointerno del repertorio tradizionale e seguire laquoper ordineraquo (κατὰ κόσμον) partendo da un punto determinato (cfr Iliade I 4 ἐξ οὗ laquoda quandoraquo Odissea VIII 500 ἔνθεν laquoda doveraquo) Di tanto in tanto lrsquoaedo sospende la sua esecuzione (Odissea VIII 87 ὅτε λήξειε ἀείδων laquoquando interrompeva il cantoraquo) poi riprende eventualmente sollecitato dal pubblico (ibid 90 s αὐτὰρ ὅτ᾽ ἂψ ἄρχοιτο καὶ ὀτρύνειαν ἀείδειν Φαιήκων οἱ ἄριστοι ἐπεὶ τέρποντ᾽ ἐπέεσσιν laquoma quando ricominciava e lo spingevano al canto i principi dei Feaci poicheacute godevano dei suoi versiraquo) Anche lrsquouditorio come abbiamo giagrave detto puograve infatti richiedere la scelta di un determinato tema come fa Odisseo quando in Odissea VIII 487 ss chiede che Demodoco gli canti la storia del Cavallo di legno Drsquoaltra parte la poesia orale tradizionale doveva avere un respiro limitato circoscritto al tempo di una singola esecuzione (un pomeriggio o una sera) e non a caso Femio e Demodoco eseguono pezzi che occupano una parte limitata delle ore successive alla cena Da questo punto di vista lrsquoautore (o gli autori) dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea ci appare come un poeta orale estraneo alla norma capace di esibirsi nellrsquoarco di molte ore (almeno una ventina) distribuite in diversi giorni e sedute La leggenda di Omero Ci sono giunte sette biografie di Omero tutte di etagrave post-classica anche se non egrave escluso che alcune parti e alcuni motivi narrativi risalgano fino allrsquoetagrave arcaica (e in particolare a Teagene di Reggio vissuto nel VI secolo aC) Costruita a posteriori ed esposta con ricchezza di dettagli in un racconto egrave anche la leggenda di un agone poetico svoltosi a Calcide in Eubea fra Omero ed Esiodo in occasione dei ludi funebri (a cui Esiodo effettivamente partecipograve come sappiamo da Erga 654-659) per il principe Anfidamante si tratta del cosiddetto Certamen Homeri et Hesiodi che nella forma in cui ci egrave pervenuto12 risale al II secolo dC ma si basa su modelli piugrave antichi (in particolare sul Museo del retore del IV secolo aC Alcidamante) La prova si apre con un gioco di domande e risposte fra i due poeti poi ciascuno recita un passo delle proprie opere il pubblico inclinerebbe a conferire il premio a Omero ma il figlio del defunto assegna la vittoria ad Esiodo in quanto poeta della pace e dellrsquoagricoltura (sect 13)
12 Cfr Homeri opera V 218-238 Allen Possediamo qualche resto di una versione piugrave antica grazie alla testimonianza di un papiro del III secolo aC (P Flinders Petrie 25) pubblicato nel 1891
Letteratura greca [1]
5
Anche in questa fase dellrsquoagone gli Elleni sbalorditi applaudivano Omero percheacute i versi erano superiori ad ogni aspettativa e chiedevano che gli assegnassero la vittoria Il re perograve incoronograve Esiodo dichiarando che era giusto che vincesse chi esortava allrsquoagricoltura e alla pace e non colui che narrava guerre e stragi
[Tr di F De Martino]13 LrsquoOmero della leggenda biografica (ne diamo qualche cenno prendendo come base la biografia falsamente attribuita ad Erodoto)14 si sarebbe chiamato Melesigene (laquoNato presso il Meleteraquo) e sarebbe nato a Smirne da una certa Creteide di Cuma resa incinta da uno sconosciuto e condotta dal padre adottivo (Cleanatte di Argo) presso un suo amico a Smirne appena fondata Da giovane Melesigene (che non egrave nato cieco) apprende i rudimenti dellrsquoarte epica da un certo Femio un maestro di cui eredita la scuola quindi srsquoimbarca sulla nave di un certo Mente di Leucade per conoscere il mondo e arriva (dopo aver visitato Etruria e Spagna) anche a Itaca dove si ammala e abbandonato da Mente viene ospitato dallrsquoitacese Mentore Ripreso il mare con Mente (tornato a Itaca a prelevarlo) a Colofone perde la vista (di qui piugrave tardi il soprannome di Omero in quanto ὁ μὴ ὁρῶν laquocolui che non vederaquo laquociecoraquo)15 Fatto ritorno nella nativa Smirne inizia il mestiere di poeta ha successo ma presto cade in miseria e decide di trasferirsi a Cuma dove (dopo un soggiorno in una colonia cumana presso il cuoiaio Tichio) recita i suoi versi nei ritrovi degli anziani La sua fama si diffonde al punto che Melesigene chiede di esser mantenuto a spese pubbliche Di fronte al rifiuto del Consiglio cittadino maledice Cuma e si trasferisce prima a Focea dove declama di nuovo i suoi poemi nelle sale pubbliche poi a Eritre e a Chio dove intende vendicarsi di un certo Testoride che a Focea gli aveva promesso cibo e alloggio in cambio del lascito ereditario dei poemi e invece era fuggito alla volta di Chio dopo averli trascritti sotto dettatura Ma a Chio MelesigeneOmero si smarrisce fincheacute arriva alla masseria di un pastore di capre di nome Glauco che lo conduce presso il suo signore a Bolisso Qui egrave assoldato come precettore e per i figli di costui posti sotto le sue cure compone fra lrsquoaltro la Batracomiomachia Indi si reca nella capitale dellrsquoisola apre una scuola di versificazione prende moglie (da cui ha due figlie) e intanto continua a lavorare a Iliade e Odissea Riprende i viaggi approdando prima a Samo e poi a Ios dove si ammala e giace infermo sulla spiaggia qui alcuni giovani pescatori gli propongono lrsquoindovinello dei pidocchi (laquoquanto prendemmo lasciammo ciograve che non prendemmo portiamoraquo) giagrave noto a Eraclito (22 B 56 D-K) e muore per la rabbia di non aver saputo risolverlo o per la fiacchezza (come lrsquoautore della biografia preferisce immaginare) Non sono mancati tentativi fra cui si distingue per acume quello compiuto da Wolfgang Schadewaldt16 di estrarre dalle Vite superstiti unrsquoimmagine di Omero almeno significativa per la comprensione del mestiere dellrsquoaedo nellrsquoVIII-VII secolo aC17 Senoncheacute come egrave stato
13 Omero quotidiano Vite di Omero Venosa Edizioni Osanna 1984 14 Molto dibattuta egrave la questione della data di origine della biografia pseudo-erodotea ma il testo che possediamo rappresenta probabilmente la piugrave tarda rielaborazione di un racconto composto nel V-IV secolo aC verosimilmente ndash come suppose F Jacoby (Kleine philologische Schriften I Berlino 1961 11 s) ndash un prodotto di cultura sofistica comparabile con il Certamen di Alcidamante 15 Senoncheacute ὅμηρος egrave parola greca e significa laquoostaggioraquo e in effetti testimonianze epigrafiche provano che in etagrave arcaica genitori greci potevano dare al proprio figlio questo nome 16 Homer und sein Jahrhundert in Id Von Homers Welt und Werk Stoccarda 19593 87-129 17 Per Eratostene Omero sarebbe stato contemporaneo della guerra di Troia da lui datata al 1194-1184 invece per Erodoto (II 53) Omero ed Esiodo sarebbero stati coetanei e sarebbero vissuti circa 400 anni prima di lui cioegrave alla metagrave del IX secolo (II 53 2 laquoRitengo che Esiodo e Omero mi abbiano preceduto in etagrave di quattrocento anni e non di piugrave Sono essi ad aver composto per i Greci una teogonia dando agli dei epiteti dividendo gli onori e le competenze indicando le loro formeraquo [tr di A Fraschetti] Lrsquoanonimo autore di un epigramma (AP XVI 298) dice che sette cittagrave (Smirne Chio Colofone Itaca Pilo Argo Atene) si contendevano i suoi natali
Letteratura greca [1]
6
opportunamente osservato18 non solo la maggior parte delle vicende di questa ldquobiografiardquo egrave desunta proprio dai poemi omerici e specialmente dallrsquoOdissea e non solo contiene molti elementi manifestamente ridicoli ma soprattutto laquolrsquoOmero di questa leggenda egrave un cantore mendicante cieco che si intrattiene con gente semplice con calzolai pescatori e vecchi nei ritrovi delle cittagrave portuali un precettore che insegna a leggere e a scrivere e che dunque ha rapporti soprattutto con fanciulli un estemporaneo coniatore di versi ammirato soltanto dalla piccola borghesia e una sola volta nellrsquoepisodio del signore di Bolisso in contatto con il ceto elevato davanti alle cui case del resto egrave solito andare a mendicare doni con canzoni da lui stesso composte [] Chi ha delineato questrsquoimmagine di poeta ndash non importa se con intenzioni parodistiche o meno ndash aveva davanti a seacute un compositore di versi collocato nella fascia bassa di un certo ceto professionale che si egrave potuto sviluppare in questa forma solo quando i commerci e gli affari le cittagrave e le comunitagrave avevano raggiunto una piena fioritura scalzando lrsquoantica struttura aristocratica della societagrave quando cioegrave giagrave dominava la borghesia e si richiedeva piugrave spirito imprenditoriale (si pensi alla fondazione di scuole) che beni patrimoniali La condizione professionale dei rapsodi era questa artisti di declamazione paragonabili ai nostri cantanti da concerto che allora come oggi andavano in tourneacutee e che si caratterizzavano per recitare non opere da loro stessi composte ma solo grandi capolavori altrui La leggenda di Omero attribuisce questa vita di rapsodo anche al grande poeta dellrsquoetagrave arcaica i creatori di tale leggenda non conoscevano infatti al loro tempo un altro tipo di aedoraquo Dunque gli antichi non conoscevano nulla di definito sulla vita e sulla personalitagrave di Omero ciograve che possiamo ricostruire si deve basare da un lato sul modello di aedo quale emerge dai poemi (e quale piugrave sopra abbiamo cercato di sintetizzare) dallrsquoaltro su una ricognizione degli elementi costitutivi dellrsquoarte epica Il verso dellʼepica Lrsquoesametro (giagrave Erodoto usa per lrsquoesametro dattilico espressioni come ἐν ἑξαμέτρῳ τόνῳ [I 47 2] e ἐν ἔπεσι ἑξαμέτροισι [VII 220 3]) si presenta esteriormente come una successione di sei dattili di cui lrsquoultimo catalettico (con la possibilitagrave per lrsquoultimo elemento in virtugrave della pausa di fine di verso di essere realizzato indifferentemente da sillaba breve o lunga u) Le due brevi dei singoli dattili potevano essere ldquosostituiterdquo da una lunga costituendo uno spondeo (di qui la denominazione per ciascun elemento in posizione pari di biceps y) una facoltagrave molto ridotta nel quinto dattilo che si presenta generalmente in forma pura (le eccezioni sono allincirca di un caso su 18 versi) Il verso appare articolato attraverso punti di incisione le cosiddette laquocesureraquo (τομαί laquotagliraquo) le piugrave frequenti interessano il terzo metro venendo a cadere o dopo il suo elemento lungo (cesura maschile o pentemimere laquodopo il quinto mezzo piederaquo) o tra le due brevi del biceps (cesura femminile o trocaica) piugrave rara la cesura dopo il quarto elemento lungo (eftemimere laquodopo il settimo mezzo piederaquo) e subordinata ad altra cesura principale quella dopo il secondo elemento lungo (tritemimere laquodopo il terzo mezzo piederaquo) Fine di parola puograve ricorrere anche dopo il quarto dattilo (dieresi [διαίρεσις laquodivisioneraquo] bucolica cosigrave denominata dal largo uso che ne faranno i poeti bucolici drsquoetagrave ellenistica) Di qui lo schema seguente
a1 a2 m f r b ndash y ndash y ndashkk ndash y ndash kk ndash u
18 J Latacz Omero il primo poeta dellrsquoOccidente (1989) Laterza Roma-Bari 1990 28 s
Letteratura greca [1]
7
dove a1 e a2 segnalano allrsquointerno della prima metagrave del verso le posizioni che in alternativa reciproca tendono a coincidere con fine di parola m e f le posizioni della cesura principale rispettivamente maschile o pentemimere (m) e femminile o trocaica (f) r la posizione della cesura eftemimere b la posizione della dieresi bucolica Viene evitata la fine di parola dopo il terzo metro cosigrave da escludere una bipartizione simmetrica del verso Un punto in cui la fine di parola egrave tendenzialmente evitata egrave quello dopo la prima breve del quarto biceps come fu osservato da G Hermann (donde lrsquoetichetta di laquoponte di Hermannraquo) Solo con Callimaco si afferma anche il divieto che una parola che inizi nel primo metron termini con la prima breve nel secondo biceps (laquoprima legge di Meyerraquo)
PER SAPERNE DI PIUrsquo Teorie sullrsquoorigine dellrsquoesametro Sul problema dellrsquoorigine dellrsquoesametro le teorie si sono succedute numerose allrsquointerno della fondamentale contrapposizione fra chi ha individuato nella sua struttura il risultato della fusione fra preesistenti unitagrave minori e chi invece come Hoekstra (1981) ne ha proposto unrsquointerpretazione fin dallrsquoorigine unitaria Ad es Th Bergk (1854) riconduceva la genesi dellrsquoesametro a due cola lirici preesistenti Wilamowitz (1884) ne faceva il risultato della lunga evoluzione di una struttura lirica avvenuta in parallelo col passaggio dalla canzone lirica (eolica) al laquopiccolo eposraquo e da questo al laquogrande eposraquo A Meillet (1923) postulava unrsquoereditagrave pre-greca (egea) Piugrave recentemente un ritorno alla posizione di Bergk si egrave avuto da parte di ML West (1973) con lrsquoipotesi di una derivazione dellrsquoesametro dallrsquoassociazione fra un hemiepes e un prosodiaco e alla posizione di Wilamowitz nel senso dellrsquoevoluzione di un ferecrateo espanso con lrsquoinserzione centrale di tre dattili con G Nagy (1974) B Gentili (1977) ha cercato di rintracciare coincidenze fra i segmenti costitutivi dellrsquoesametro e i cola della poesia lirica drsquoetagrave arcaica partendo dal dato per cui gli schemi metrici che appaiono in alcune iscrizioni arcaiche e nella lirica di Stesicoro (hemiepes enoplio reiziano coriambico adonio etc) sono gli stessi che sembrano plasmare tutte le formule piugrave tradizionali dellrsquoesametro omerico (per unrsquoesposizione sintetica di questa teoria cfr B Gentili-L Lomiento Metrica e ritmica Storia delle forme poetiche nella Grecia antica Milano Mondadori Universitagrave 2003 pp 279-283)
La formularitagrave Il fenomeno della formularitagrave si puograve definire come la ripetizione di versi interi o di segmenti di versi specialmente nellrsquoambito di situazioni tipiche ad es per laquoquando sorse lrsquoauroraraquo troviamo usato per due volte nellrsquoIliade e in ben venti casi nellrsquoOdissea il verso
ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς e quando mattutina apparve Aurora dalle dita di rosa
Ma il caso piugrave comune di formularitagrave egrave quello rappresentato dai nessi standardizzati nomeepiteto come quelli che vengono applicati ai rispettivi protagonisti dei due poemi πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς (31 volte) e πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς (38 volte) ambedue formule clausolari ma di diversa estensione poicheacute (se riandiamo allo schema riprodotto al paragrafo precedente) esse arrivano entrambe alla fine del verso ma partendo la prima da r la seconda da f Esempi
Letteratura greca [1]
8
r Iliade I 58 τοῖσι δrsquo ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς f Odissea VIII 97 Ὣς ἔφατrsquo οὐδrsquo ἐσάκουσε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς Piugrave in particolare se consideriamo le singole articolazioni minori del verso riscontriamo che a) nel segmento iniziale si incontrano con alta frequenza brevi nessi che contengono congiunzioni pronomi e particelle connettive o avversative ad es fino ad a1 () αὐτὰρ ὁ δή ποτε ὣς τότε καὶ τότε ὣς ὁ μέν fino ad a2 () αὐτὰρ ἐπεί ἀλλ᾽ ὅτε δή ἔνθ᾽ ἄλλοι τοὶ μὲν ἔπειτ᾽ b) nel segmento centrale che va da m o da f fino a r o a b compare spesso il predicato verbale su cui gravita la frase (si veda a titolo di esempio il verso di Iliade sopra citato nel quale μετέφη si estende appunto da m a r) m r Iliade I 58 τοῖσι δrsquo ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς c) il segmento finale (a partire da r o da b) rappresenta il piugrave ricco serbatoio di nessi formulari innanzi tutto come nel caso di πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς le formule nome proprioepiteto ma anche molti casi di associazione fra nome comune ed epiteto ad es ξίφος ἀργυρόηλον φόρμιγγα λίγειαν πατρίδος αἴης θούριδος ἀλκή μώνυχες ἵπποι ὀξέϊ χαλκῷ πότνια μήτηρ Le formule tendono a organizzarsi in sistemi caratterizzati dalle tendenze complementari allrsquoestensione e allrsquoeconomicitagrave a) il principio dellrsquoestensione si connette alla tendenza dellrsquoepica a produrre nessi formulari atti a coprire tutto ciograve che nella narrazione sia tipico costante ripetitivo e a dislocare le formule coprendo le varie partizioni del verso ad es per Ettore troviamo tre formule finali di diversa estensione (φαίδιμος Ἥκτωρ κορυθαίολος Ἥκτωρ e μέγας κορυθαίολος Ἥκτωρ e una formula iniziale (Ἥκτωρ Πριαμίδης) b) il principio complementare al primo dellrsquoeconomia (o del risparmio) corrisponde al fatto che per esprimere una medesima idea essenziale esiste generalmente nella dizione epica una e una sola espressione che occupi una determinata unitagrave minore del verso Casi come μελαινάων ἐπὶ νηῶν e ἐϋσσέλμων ἐπὶ νηῶν sono doppioni apparenti hanno sigrave la stessa misura metrica ma iniziano lrsquouno in consonante con la connessa possibilitagrave di evitare lo iato o di allungare la sillaba precedente lrsquoaltro in vocale Non mancano tuttavia vere eccezioni come per lrsquohemiepes iniziale νῆας ἐπ᾽ Ἀργείων di Iliade XXIV 298 rispetto al consueto νῆας ἐπὶ γλαφυράς (16 volte) Lrsquouso di formule e soprattutto di sistemi formulari rappresentava per il poeta epico una facilitazione nel comporre improvvisando ma nella lunga evoluzione dellrsquoepica e specialmente al momento della definitiva fissazione di poemi monumentali come lrsquoIliade e lrsquoOdissea la
Letteratura greca [1]
9
sempre piugrave estesa memorizzazione di ampie zone di testo il lavorio di riflessione sui singoli episodi e sui nessi e i parallelismi fra gli episodi stessi e la scoperta di inedite possibilitagrave espressive connesse alla modificazione di formule tradizionali dovettero incoraggiare i poeti a uno sfruttamento consapevole e artisticamente meditato del ldquogioco delle formulerdquo Da un lato procedimenti come lrsquoaddensamento degli epiteti la sostituzione di un epiteto convenzionale con uno non convenzionale (con la creazione di un nesso nuovo di struttura metrica eventualmente diversa) il trasferimento di un epiteto da un referente a un altro creano nei poemi una continua tensione tra formularitagrave e superamento della formularitagrave dallrsquoaltro la rete delle corrispondenze a distanza generata dalla ripetizione di un determinato modulo permette al poeta di variare e approfondire un motivo e di sottolineare i parallelismi o le dissonanze fra determinate situazioni La guerra di Troia Schliemann e la riscoperta di Troia In etagrave moderna la riscoperta della cittagrave di Troia situata sullrsquoodierna collina di Hissarlik e sovrastante la bassa pianura attraversata dallo Scamandro a sud del promontorio del Sigeo si lega agli scavi di Heinrich Schliemann (1822-1890) che a partire dal 1866 si dedicograve al disseppellimento delle rovine di Micene di Tirinto e di altri siti micenei e appunto di Troia Nel corso del tempo si egrave venuta creando attorno alla personalitagrave di questo archeologo dilettante una sorta di leggenda a cui egli stesso contribuigrave con le autobiografie Ilios (1881) e Troja (1884) nel senso di un dilettantismo romantico di scavi avventurosi condotti con sorprendenti successi ma senza alcun rigore di metodo di un amore cieco e totale per Omero e per lrsquoEllade E in effetti oggi sappiamo che lrsquoaver percorso la Grecia e lrsquoAsia minore sulle vie di Omero non impedigrave a Schliemann a Micene di attribuire allrsquoepoca di Agamennone tombe anche di quattro secoli piugrave antiche neacute a Troia di identificare con la cittagrave omerica uno strato risalente a una fase che va dal 2300 al 2100 aC Errori del genere non dipesero tuttavia da un entusiasmo velleitario quanto dalla carenza allrsquoepoca di competenze archeologiche che potessero orientarlo verso una piugrave plausibile cronologia di reperti e di strati Occorre poi tener conto che lo strato dei materiali riferibili alla Troia omerica (o almeno a quella che oggi noi identifichiamo con la cittagrave omerica Troia VIIa) era conservato unicamente nel suo margine esterno dato che gli strati superiori della collina di Hissarlik (con le fondamenta dei palazzi e dei templi) erano stati demoliti in epoca ellenistica per realizzare il terrazzamento del suolo su cui vennero edificati nuovi templi Fu soprattutto per questa ragione che Schliemann si spinse con le proprie maestranze a scavare sempre piugrave in profonditagrave saltando gli strati del secondo millennio Dove perograve il problema consisteva nellrsquoidentificazione di un sito sulla scorta della comparazione fra gli antichi racconti e il panorama attuale Schliemann conseguigrave notevoli successi in primo luogo identificando con la collina di Hissarlik quellrsquoacropoli omerica che lrsquoopinione comune dalla fine del XVIII secolo individuava invece nel villaggio di Bunarbaschi situato su un colle a 15 km dal promontorio del Sigeo e la disputa era stata viva giagrave nellrsquoantichitagrave Ellanico di Lesbo verso il 400 aC aveva sostenuto nei suoi Troica che la Ilio del suo tempo sorta presso la collina di Hissarlik e la Ilio omerica occupavano lo stesso sito invece Demetrio di Scepsi (fr 26 Gaede) si era pronunciato per una collina a circa 9 km a sud sullrsquoaltra riva dello Scamandro La missione americana guidata nel 1932-1938 da CW Blegen e le piugrave recenti indagini sul territorio hanno offerto un quadro molto piugrave articolato e differenziato Sulla base di un nuovo diagramma la cittagrave che sorgeva al momento in cui Eratostene di Cirene fissava la caduta di Troia (1184) viene a coincidere con Troia VIIa non piugrave con quella che Schliemann chiamava laquoterza cittagraveraquo (corrispondente a Troia II) ma nemmeno come voleva W Doumlrpfeld con Troia VI (andata in rovina verso il 1300 in seguito a un terremoto) Gli scavi piugrave recenti Secondo le conclusioni di Manfred Korfmann (cfr Korfmann 2002) che ha diretto lrsquoeacutequipe dellrsquoUniversitagrave di Tubinga negli scavi piugrave recenti lrsquoantica Troia intorno al 1184 cessograve di essere abitata ma lrsquoinsediamento continuograve nellrsquoarea della rocca per circa due secoli dopo la distruzione
Letteratura greca [1]
10
della cittagrave (Troia VIIb) Verso il 700 il luogo chiamato laquoIlioraquo era largamente in rovine anche se in etagrave arcaica dovette continuare a essere frequentato come luogo di culto Il problema che si dovettero porre nellrsquoVIII secolo aC lsquoOmerorsquo o i suoi modelli dovette essere quello di rendere il racconto della guerra di Troia plausibile a un pubblico che aveva familiaritagrave con la geografia locale (lrsquoIliade offre indicazioni realistiche ad es sulla navigazione dellrsquoEgeo in IX 362 s e sulla visibilitagrave dellrsquoisola di Samotracia dalla piana di Troia in XIII 11-14) che si trattasse di genti che risiedevano nel Sigeo o in altre cittagrave vicine o di abitanti della stessa Ilion che nellrsquoVIII secolo era di nuovo attiva sia pure soltanto come centro cultuale Il santuario sorgeva allrsquointerno di una depressione naturale a sud-ovest della rocca lungo la vecchia via che conduceva alla rocca stessa Omero menziona due templi quello di Apollo e quello di Atena e le loro loro rovine sono tuttora riconoscibili I visitatori che giungevano al santuario dal Sigeo attraverso la piana dello Scamandro potevano vedere le rovine della rocca Ma - ci si chiede - quando ebbe fine il nucleo della cittagrave di Troia cantata da Omero Nel bastione a nord-est della rocca egrave stata trovata una larga e profonda cisterna con un condotto che proviene da una sorgente La sorgente fu abbandonata al piugrave tardi al tempo di Troia VIIb2 prima del 1100 A partire dal 1000950 non rimase a Troia alcun insediamento significativo Troia era molto piugrave larga di quanto ritenesse Schliemann Un fossato largo 3 m e profondo 15 completato durante lrsquoultima fase di Troia VI o al principio di Troia VIIa (cioegrave intorno al 1300) la circondava Poi esso fu rimpiazzato a sud da un fossato piugrave ampio e concentrico al primo completato verso il 1200 Il sistema di fortificazione si estendeva per quasi 2 km e pertanto racchiudeva unrsquoarea di circa 270000 m2 La rocca e la cittagrave bassa dovevano presentarsi al tempo di Omero come un imponente complesso di rovine I nuovi colonizzatori del Sigeo e di altri siti incontrarono un vasto campo attraversato da sentieri che seguivano i vecchi tracciati Negli scavi fatti nei quartieri della cittagrave bassa a sud-ovest della rocca poco fuori del muro si egrave scoperto un deposito bruciato verso la fine di Troia VI e di nuovo verso la fine di Troia VIIa (verso il 1200) La prima devastazione egrave da ricollegarsi a un terremoto ma la seconda sembra dovuta a unrsquoazione di guerra come suggerisce anche il rinvenimento di corpi insepolti o semisepolti e di depositi contenenti armi non utilizzate Verso il 1300 la porta principale di Troia era stata bloccata e ostruita percheacute qui lrsquoantico muro era in condizioni precarie e pertanto rappresentava lrsquoanello piugrave vulnerabile nel sistema di difesa Giagrave W Doumlrpfeld aveva richiamato Iliade VI 433 s (Andromaca a Ettore)
Piazza lrsquoesercito presso il fico selvatico dove egrave piugrave facile Lrsquoaccesso alla cittagrave e il superamento delle mura
In questa zona solo poco piugrave di 80 m separavano il muro della cittagrave bassa dal muro della rocca Gli epiteti omerici di Troia - laquoben costruitaraquo laquofertileraquo laquovastaraquo laquosacraraquo laquoertaraquo laquoventosaraquo laquodalle belle muraraquo laquodai bel puledriraquo - si adattano ai dati topografici ossa di cavalli sono state trovate sul terreno forti venti soffiano continuamente in estate Anche le sorgenti sono identificabili presso la porta principale cfr Iliade XXII 145-157
Passarono oltre il posto di vedetta e lrsquoalbero di fico battuto dal vento e allontanandosi sempre piugrave dalle mura si lanciarono lungo la strada Giunsero alle fontane dalle belle acque dove sgorgano due correnti dello Scamandro impetuoso una di acqua calda da cui si leva un vapore come da fuoco ardente lrsquoaltra che in piena estate versa acqua gelata come la grandine la fredda neve o il ghiaccio Vi sono accanto dei lavatoi di pietra larghi belli dove le mogli e le belle figlie dei Teucri lavavano le splendide vesti prima in tempo di pace prima che giungessero i figli dei Danai
[Tr di MG Ciani] In effetti gli scavi nellrsquoarea della caverna in cui egrave situata la sorgente hanno portato alla luce una struttura simile a una miniera con tre gallerie e altri bracci tributari creata per fornire acqua Lrsquoacqua scorreva attraverso una superficie rocciosa e poi in un canale artificiale che a sua volta raggiungeva un sistema di quattro lsquodepressionirsquo o lsquofossersquo circolari scavate nella roccia della
Letteratura greca [1]
11
misura di quasi 1 m di diametro (appunto parrebbe i πλυνοί hellip λαΐνεοι i laquolavatoi di pietraraquo ricordati da Omero) Achei e Troiani Fra XIII e XII secolo aC Troia era un grande centro politico e commerciale in grado di controllare lrsquoaccesso ai Dardanelli (lrsquoantico Ellesponto) e il trasporto su terra di beni di vario genere dalla costa egea al Mar di Marmara (lrsquoantica Propontide) e al Mar Nero In Troia VIIa egrave stata rinvenuta ceramica micenea del periodo noto come Tardo Elladico IIIB che egrave anche il periodo di maggiore splendore dei palazzi micenei sul continente greco Ersquo suggestiva lrsquoidentificazione piugrave volte avanzata in tempi recenti di TroiaIlio con Wilusa la cittagrave menzionata spesso in testi hittiti e oggetto di contesa fra gli Hittiti e quegli Ahhiyawa il cui nome sembra identificarsi con quello degli laquoAcheiraquo (Ἀχαιοί) Il documento piugrave significativo in proposito egrave il preambolo del trattato stipulato verso il 1280 aC fra il re hittita Muwattali II e Alaksandu re di Wilusa che contiene un richiamo alle precedenti relazioni fra i due stati a partire dal 1600 pur ricordando che un tempo Wilusa era sotto il dominio hittita Muwatalli afferma di aver mantenuto relazioni pacifiche anche dopo che la cittagrave era divenuta indipendente Inoltre un testo religioso hittita rinvenuto a Hattusa la capitale dellrsquoimpero hittita e databile al XIII secolo ricorda nellrsquoambito di un rituale la recita di un poema in luvio (il luvio egrave una lingua indo-europea che si distingue solo superficialmente dallrsquohittita) di cui viene riportato il primo verso laquoQuando tornarono dallrsquoerta Wilusaraquo E a Troia negli scavi piugrave recenti egrave stato trovato un sigillo con unrsquoiscrizione in luvio Drsquoaltra parte in Omero la dinastia reale troiana di cui egrave a capo Priamo figlio di Laomedonte viene fatta risalire attraverso Erittonio Troo e Ilo fino a Dardano eponimo dei Dardani che si erano stanziati nella Troade a nord del monte Ida (Iliade ΧΧ 215 ss) I Dardani nellrsquoIliade compaiono fra i principali alleati dei Troiani accanto ai contingenti provenienti da Zelea (a nord-est lungo il fiume Esepo) e a quelli di localitagrave situate sulla Propontide come Adrestea e Pitea e sulla costa asiatica dellrsquoEllesponto come Abido e Arisbe Dalla costa europea arrivano invece i Traci i Ciconi e i Peoni da oriente i Paflagoni e gli Alizoni da sud-est i Misi e i Frigi dalla zona sud-occidentale dellrsquoAnatolia i Meoni i Cari e i Lici Se Dardani Peoni Ciconi e Traci fanno parte delle popolazioni traco-frigie che fra XII e XI secolo erano scese dai Balcani in direzione dellrsquoAnatolia (cfr Erodoto 7 73 e Xanto di Lidia FGrHist 765 F 14) i Meoni sono di stirpe lidia mentre i Cari e i Lici appartengono allrsquoambito culturale e linguistico luvio-hittita Comunque sia diversamente che per Erodoto il quale inserisce il rapimento di Elena nel quadro di una serie di torti reciproci in forma di rapimenti di donne fra Greci e barbari (I 2 1) e per i poeti tragici ateniesi del V secolo aC in Omero lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato come un contrasto fra culture diverse I Troiani mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei (detti anche laquoDanairaquo - cioegrave discendenti di Danao - o laquoArgiviraquo in relazione al contingente proveniente dallrsquoArgolide guidato da Agamennone il capo della spedizione) e lo stesso vale per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari in Iliade ΙΙ 867 come laquodi lingua stranieraraquo (βαρβαρόφωνοι) suggerisce che un tale epiteto non sarebbe stato applicabile ai Troiani Infine sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di unrsquoimbarcazione sono altrettanti esempi di quelle che W Arend denominograve laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini comportamentali e tecnologiche del gruppo che le condivide (vedi scheda p xxx) La societagrave omerica
Letteratura greca [1]
12
Nel rapporto fra il mondo omerico e la storia egrave innanzi tutto da sottolineare lrsquoesistenza di un duplice piano di riferimento con talune interferenze dellrsquouno nellrsquoaltro da un lato crsquoegrave lrsquoorizzonte dei fatti collocati in un passato glorioso dallrsquoaltro lrsquoorizzonte del poeta Giagrave gli studiosi alessandrini del resto notavano che dati come lrsquoarte di montare a cavallo i segnali per mezzo della tromba e lrsquouso di bollire la carne compaiono nellrsquoIliade solo allrsquointerno delle similitudini E il testo con una sorta di arcaismo intenzionale mostra talora la consapevolezza dellrsquoabisso che separa passato e presente come quando in Iliade XII 445-449 si dice
Ettore intanto un sasso afferrograve ndash e lo portava ndash che prima stava davanti alle porte largo di sotto ma sopra era a punta questo due uomini i piugrave forti del popolo difficilmente isserebbero da terra su un carro quali son ora i mortali egli da solo lo roteava a suo agio
[Tr di R Calzecchi Onesti] Per contro le condizioni sociali rappresentate nei poemi (un mondo di grandi proprietari terrieri che reggono aziende agricole autarchiche da cui hanno preso tuttavia a distaccarsi alcune figure di artigiani il fabbro il vasaio il carpentiere il medico lrsquoindovino lrsquoaedo) rispecchiano assai piugrave la situazione storica fra VIII e VII secolo a C che le strutture della societagrave micenea Inoltre i cadaveri vengono cremati secondo la prassi piugrave recente non inumati anche se molti riferimenti omerici non rispecchiano necessariamente la pratica normale del tempo di pace trattandosi di cremazioni che avvengono oltremare non ambigua egrave comunque la testimonianza relativa alla prassi umana in generale fornita da Odissea XI 216-222 (Anticlea a Odisseo)
Ohimegrave figlio mio il piugrave misero di tutti gli uomini Persefone la figlia di Zeus non ti inganna ma la legge degli uomini egrave questa quando si muore i nervi non reggono piugrave la carne e le ossa ma la furia violenta del fuoco ardente li disfa appena la vita abbandona le bianche ossa e lrsquoanima vagola volata via come un sogno
[Tr di GA Privitera]19 Un esempio significativo di sovrapposizione tra fasi culturali distinte si coglie osservando lrsquoinventario degli oggetti accanto ad armi vasi ornamenti tipici dellrsquoVIII-VII secolo troviamo relitti risalenti allrsquoepoca micenea come la coppa di Nestore ornata di colombe descritta in Iliade XI 632 ss (simile a una coppa drsquoargento rinvenuta a Micene che riproduce disegno e artigianato dellrsquoetagrave del bronzo) lrsquoelmo di cuoio con zanne di cinghiale che Merione dagrave a Odisseo (Iliade X 261 ss) e lo scudo lungo laquosimile a torreraquo di Aiace che egrave di un tipo inusitato dopo il XIII secolo Un oggetto non riferibile neacute al mondo miceneo neacute allrsquoetagrave della fissazione dei poemi bensigrave alla prima etagrave del ferro egrave invece la coppia di aste da lancio adottate verso il 900 aC e scomparse due secoli dopo con lo sviluppo del combattimento oplitico e la reintroduzione dellrsquoasta per colpire e la menzione delle navi fenicie (una volta nellrsquoIliade e cinque volte nellrsquoOdissea) riflette la loro comparsa nellrsquoEgeo nel IX secolo aC Non diversamente sembra avvenire anche per le istituzioni politiche lrsquo ἄναξ egrave visto a volte come figura di autocrate assoluto a volte fortemente limitato dai poteri delle assemblee ndash sia quella dei capi (βουλή) sia quella delle truppe (ἀγορή) ndash o insidiato dallrsquoascesa dei gruppi aristocratici mentre il βασιλεύς non egrave piugrave il dignitario della societagrave micenea ma genericamente un principe o un capo LʼIliade
19 Omero Odissea III intr testo e commento di A Hoekstra tr di GA Privitera Mondadori Milano 1984
Letteratura greca [1]
13
LrsquoIliade (Ἰλιάς) consta di circa 15690 esametri divisi secondo una partizione che potrebbe risalire al primo editore alessandrino (Zenodoto di Efeso) in 24 libri indicati con le lettere maiuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquounitagrave strutturale di parecchi canti che spesso finiscono col tramonto o iniziano con lrsquoalba e la coincidenza fra alcuni dei titoli attribuiti a ciascun canto nelle edizioni alessandrine e quelli che si rintracciano in autori precedenti (ad es Tucidide [I 10 4] cita il ldquoCatalogo delle navirdquo cioegrave il canto II) provano che non si trattograve di una divisione arbitraria bensigrave fondata almeno in certa misura sulle abitudini dei rapsodi Tema dellrsquoopera non egrave lrsquointero assedio decennale di Troia da parte dei Greci (di norma detti Achei o Danai o Argivi) provocato dal rapimento di Elena ad opera di Paride ma una porzione assai limitata del conflitto una sequenza narrativa che copre la durata di 51 giorni e si colloca verso la fine del nono anno di guerra lrsquoira di Achille contro lrsquoAtride Agamennone il suo ritiro dalla guerra e le relative conseguenze la fine dellrsquoira lrsquouccisione e i funerali di Ettore Fu proprio questa delimitazione tematica a consentire la realizzazione di quellrsquounitagrave e compiutezza dellrsquoazione che giagrave Aristotele individuava come uno dei pregi essenziali dellrsquoopera di Omero rispetto agli altri poemi epici arcaici (Poetica 1459a-b)20
anche in questo Omero deve apparire mirabile in confronto agli altri per non aver tentato di rappresentare intera la guerra anche se essa aveva un principio e una fine il racconto sarebbe risultato troppo grande e non abbracciabile con uno sguardo oppure pur misurato nella grandezza intricato per la varietagrave Ricavatane invece una parte ha fatto uso di molti episodi per esempio con il ldquoCatalogo delle navirdquo e con altri episodi fa procedere in lungo il poema Gli altri invece come lrsquoautore delle Ciprie o della Piccola Iliade compongono unrsquoazione multipla su unrsquounica persona o un unico tempo Di conseguenza mentre dallrsquoIliade e dallrsquoOdissea si ricava unrsquounica tragedia o soltanto due da ciascuna dalle Ciprie parecchie
[Tr di D Lanza]21
Canto I Lrsquoazione si apre sul campo degli Achei devastato dalle frecce scagliate da Apollo [T1] il dio ha scatenato una pestilenza percheacute Agamennone ha rifiutato il riscatto offerto dal sacerdote Crise per la liberazione della figlia Criseide divenuta schiava dellrsquoAtride Ai guerrieri convocati in assemblea lrsquoindovino Calcante rivela che la sola via di scampo egrave la restituzione di Criseide al padre Agamennone acconsente ma solo a patto che gli venga data in cambio Briseide la schiava che Achille tiene nella sua tenda come premio personale (γέρας) ricevuto dagli altri guerrieri Achille non puograve opporsi alla prevaricazione dellrsquoAtride ma non egrave disposto a subire passivamente lrsquooltraggio e insulta Agamennone anzi egrave giagrave pronto a estrarre la spada dal fodero per farsi giustizia quando viene trattenuto da Atena apparsa allrsquoimprovviso allora si ritira nella tenda giurando che non combatteragrave piugrave [T2] Quindi invoca la madre Tetide che dopo essere apparsa al figlio sulla riva del mare intercede presso Zeus e ottiene la promessa che i Greci non vinceranno la guerra e non espugneranno Troia fincheacute Achille non riceveragrave soddisfazione per lrsquooffesa subita Ma il piano di Zeus non resta celato ad Era che ingelosita provoca una lite nel corso del banchetto degli dei tuttavia la visione di Efesto zoppicante che funge da coppiere suscita lrsquoilaritagrave dei numi e riporta la serenitagrave Canto II Quella stessa notte Zeus manda ad Agamennone un sogno ingannatore per incitarlo ad attaccare Troia LrsquoAtride riferisce il sogno agli anziani e comanda lrsquoadunata dellrsquoesercito
20 Cfr anche 1462b ταῦτα τὰ ποιήματα συνέστηκεν ὡς ἐνδέχεται ἄριστα καὶ ὅτι μάλιστα μιᾶς πράξεως μίμησις (laquoQuesti poemi sono composti come meglio non si puograve e son il piugrave possibile imitazione di unrsquounica azioneraquo) 21 Aristotele Poetica Milano Rizzoli 19902
Letteratura greca [1]
14
con lrsquoidea stravagante di saggiare lrsquoumore delle truppe proponendo il ritorno in patria Gli uomini incitati da Tersite corrono alle navi pronti a salpare ma vengono bloccati da Odisseo e da Nestore Egrave significativo che Tersite lrsquoanti-eroe riecheggi le accuse di Achille ad Agamennone sottolineando gli onori di cui questi gode e prenda le parti di Achille [T3] Per tutta la seconda parte del libro lrsquoazione viene interrotta per far posto alla grandiosa uscita in armi dellrsquoesercito acheo dal recinto delle navi un quadro scintillante ornato da una catena di sei similitudini concatenate introdotte per illustrare il fulgore delle armi il rombo dei passi umani e degli zoccoli precipitosi lrsquoaspetto della schiera achea e la maestria dei condottieri Un ldquoCatalogo delle navirdquo contiene lrsquoelenco circostanziato delle genti greche che hanno preso parte allrsquoassedio ed egrave seguito da un catalogo piugrave breve e piugrave arido degli alleati dei Troiani accorsi in difesa di Ilio Canto III Lrsquoatteso scontro tra gli schieramenti appena passati in rassegna non ha luogo ParideAlessandro ottiene infatti una tregua per sfidare Menelao Iride la messaggera degli degravei spinge Elena ad accorrere alle mura presso le porte Scee per assistere al preannunciato duello di ligrave Priamo e gli altri anziani di Troia osservano la pianura Su richiesta del vecchio sovrano (una richiesta che sarebbe stata piugrave ldquoverosimilerdquo al primo anno di guerra) Elena nomina i piugrave prestigiosi campioni achei [T4] Nel duello che segue Paride si trova ben presto a mal partito contro Menelao ma Afrodite lo sottrae ai colpi del nemico avvolgendolo in una fitta nebbia e lo riporta nelle sue stanze dove dopo aver assunto lrsquoaspetto di una vecchia filatrice ordina a Elena di giacere con lui Elena si ribella ma la dea non transige Mentre Paride ed Elena si uniscono nellrsquoamplesso Menelao furibondo cerca fra la folla il nemico che sia i Greci che i Troiani sarebbero lieti di consegnargli pur di porre fine alla guerra Agamennone rivendicando la vittoria di Menelao pretende dai Troiani la restituzione di Elena e delle sue ricchezze noncheacute il pagamento di una forte ammenda Canto IV La tregua stipulata dopo la scomparsa di Paride viene infranta dallrsquoarciere Pandaro che sollecitato da Atena (scesa tra le schiere troiane su ordine di Zeus) ferisce con una freccia Menelao questi viene prontamente guarito dal medico Macaone figlio di Asclepio Agamennone passa fra le schiere incitandole a combattere incontra vari capi intenti a dare istruzioni ai propri uomini Solo Ulisse e Menesteo si tengono in disparte ricevendo i rimproveri di Agamennone ai quali Ulisse reagisce con indignazione Gli Achei muovono contro i Troiani con grande ordine e disciplina mentre i Troiani e i loro alleati schiamazzano come barbari Ha inizio la battaglia vera e propria nella quale lrsquoattenzione egrave focalizzata sui duelli individuali Ad assistere e rincuorare i Troiani compare Apollo sulla rocca di Troia mentre Atena infonde coraggio nei Greci Il canto si chiude sullrsquoinfuriare della battaglia la cui descrizione riprenderagrave nel canto successivo Canto V Balza in primo piano Diomede di cui viene presentata lrsquoἀριστεία lrsquoeroe laquoglorioso e chiaroraquo fa strage di nemici imperversando furiosamente fra le schiere troiane Nel pieno del combattimento viene ferito da una freccia scagliata da Pandaro il quale mena gran vanto del colpo andato a segno Diomede ottenuta unrsquoimmediata guarigione grazie allrsquointervento di Atena muove allora contro il nemico che nel frattempo era stato accolto sul carro di Enea Pandaro scaglia la sua lancia contro Diomede ma lo scudo di questi regge il colpo Diomede colpisce a sua volta uccidendo il nemico Enea scende dal cocchio per proteggere il cadavere di Pandaro dagli Achei che vorrebbero farne razzia ma Diomede lo colpisce con un grande masso fratturandogli il femore Enea viene salvato dallrsquointervento di Afrodite che lo avvolge nel suo manto mentre Diomede arriva addirittura a ferire al polso la dea che fugge sullrsquoOlimpo a farsi confortare dalla madre Dione Il figlio di Tideo attacca anche Apollo che aveva sottratto Enea alla sua furia ma
Letteratura greca [1]
15
egrave fermato dal grido di ammonimento del dio Incitati e aiutati da Ares ora i Troiani avanzano con impeto Intervengono Era e Atena e questrsquoultima assume il ruolo di auriga di Diomede Col suo aiuto questi ferisce al ventre Ares che fugge sullrsquoOlimpo Anche le dee vi fanno ritorno Canto VI Il canto VI egrave una naturale continuazione del V (tanto che Erodoto citeragrave come dallrsquoἀριστεία di Diomede un brano della prima parte del VI canto) La battaglia infuria nella pianura ma il furore di Diomede si stempera su una nota di cortesia quando lrsquoeroe dopo aver sfidato Glauco di Licia scopre di avere con lrsquoavversario antichi rapporti di ospitalitagrave I due si scambiano le armature (a detrimento di Glauco a cui laquoZeus Cronide levograve il senno cheacute scambiograve con Diomede Tidide armi drsquooro con armi di bronzo cento buoi con nove buoiraquo [vv 234-6]) Frattanto Ettore su invito dellrsquoindovino Eleno rientra in cittagrave dove le donne devono cercare di ottenere con offerte e voti il favore di Atena e incontra dapprima la madre Ecuba poi Paride (che intende ricondurre alla battaglia) vorrebbe salutare anche la moglie ma non la trova in casa bensigrave alle porte Scee dove Andromaca era accorsa piena drsquoangoscia insieme col figlioletto e con la nutrice Nel colloquio che segue ella lo implora di non esporre al pericolo se stessa e il figlio La replica di Ettore egrave esemplare per capire la prospettiva del poema e le motivazioni dellrsquoagire dei personaggi dominanti se Achille e gli eroi achei in genere cercano onore e gloria a questa motivazione (che pure non egrave assente) Ettore antepone lrsquoαἰδώς il senso di laquovergognaraquo e di responsabilitagrave nei confronti della comunitagrave e del nucleo familiare di cui egrave il difensore Poi si volta per prendere tra le braccia Astianatte ma lrsquoelmo lucente e il cimiero ondeggiante impauriscono il piccolo che si rifugia in seno alla nutrice Alla fine del canto Paride si incontra con Ettore e i due si avviano verso il campo di battaglia [T5] Canto VII A principio del canto VII Atena e Apollo si accordano per indurre Ettore a lanciare una sfida agli Achei per un duello Il sorteggio designa Aiace come campione greco Nello scontro Ettore lancia per primo lrsquoasta che penetra ma senza trapassarlo nello scudo di Aiace greve e massiccio (compaginato con sette strati di pelle bovina simile a una torre) Aiace di rimando lacera lo scudo e il pettorale della corazza ma non riesce a squarciare le carni del nemico percheacute Ettore si piega di lato Allora i due brandiscono di nuovo le aste poi ricorrono alle pietre Alla fine gli araldi arrestano il combattimento con la giustificazione che laquola notte giagrave viene ed egrave bene obbedire alla notteraquo (v 282) Su proposta di Nestore gli Achei decidono per il giorno seguente di seppellire i morti e di scavare una grande trincea difesa da un bastione sul margine del loro accampamento Respingono lrsquoofferta di pace dei Troiani (che prevederebbe la riconsegna dei tesori sottratti da Paride a Sparta) Il mattino seguente i morti vengono cremati e durante la giornata si erige il muro di protezione Canto VIII Nellrsquoassemblea degli degravei Zeus vieta ai numi di appoggiare lrsquouna o lrsquoaltra parte in conflitto Al mattino il combattimento riprende e a mezzogiorno Zeus pone i destini dei due popoli sulla bilancia che piega a favore dei Troiani Sul campo di battaglia Diomede salva Nestore Lrsquoazione di Ettore egrave travolgente fincheacute Zeus contravvenendo alla sua intenzione di favorire i Troiani accoglie la preghiera di Agamennone per risollevare il morale degli Achei che organizzano la difesa delle navi Nel corso degli scontri si segnala lrsquoarciere Teucro che colpisce i nemici muovendosi in sincronia con Aiace Telamonio che lo protegge con lo scudo Incitato da Agamennone egli prova a colpire anche Ettore ma soccombe colpito con una pietra A questa vista Era e Atena corrono ad armarsi per intervenire a favore degli Achei ma vengono distolte dalle minacce di Zeus che manifesta la propria intenzione di favorire i Troiani fino a quando i Greci non saranno ridotti alla disperazione tanto da scongiurare Achille percheacute ritorni Il sopraggiungere della notte
Letteratura greca [1]
16
interrompe i combattimenti Ettore galvanizzato dai successi ottenuti in quel giorno si illude che la vittoria sia a portata di mano e prospetta ai suoi una prossima ritirata degli Achei Il canto si chiude con il banchetto dei Troiani che banchettano nella pianura esaltati dalla speranza di vittoria Canto IX Agamennone affranto propone di fare ciograve che nel canto II aveva suggerito soltanto per mettere alla prova lrsquoesercito interrompere la guerra e tornare in patria Diomede si oppone e Nestore in un consiglio dei capi propone di tentare la riconciliazione con Achille Si invia alla tenda di Achille unrsquoambasceria (composta da Aiace Odisseo e Fenice antico pedagogo di Achille) per offrire doni ricchissimi Achille non cede anzi minaccia di salpare immediatamente verso la patria [T6] Inutilmente Fenice lrsquoantico precettore di Achille cerca di ammorbidire la determinazione del Pelide richiamando la vicenda dellrsquoeroe Meleagro [T7] Gli inviati riferiscono ad Agamennone la risposta di Achille egli torneragrave a combattere solo quando Ettore saragrave arrivato fino alle navi dei Mirmidoni Canto X Nella stessa notte si effettua una missione segreta nel corso della quale Odisseo e Diomede dapprima catturano la spia troiana Dolone (che Ettore aveva inviato alle navi achee promettendogli come ricompensa i cavalli di Achille) poi uccidono il re trace Reso appena arrivato presso i Troiani e ne rubano i magnifici cavalli Giagrave gli antichi ritenevano questo canto unrsquoaggiunta post-omerica e questi dubbi trovano riscontro in lati eccentrici della narrazione e nellrsquoimpiego di un linguaggio che spesso appare svincolato dal corrente repertorio formulare Canto XI Si apre una nuova giornata di battaglia (la cui narrazione si protrarragrave fino al canto XVIII) che ruota intorno allrsquoἀριστεία di Agamennone Quando lrsquoAtride viene ferito gli Achei ripiegano Diomede resta anchrsquoegli ferito Odisseo e Aiace evitano a stento la massa dei nemici Nestore salva sul suo carro Macaone Achille che dalla poppa della nave osserva la battaglia vuol sapere chi egrave condotto via da Nestore e manda Patroclo che viene accolto molto benevolmente e con cui Nestore intrattiene un lungo discorso egli dice di deplorare il comportamento di Achille e con atteggiamento consono alla sua condizione di anziano si dilunga nel raccontare le proprie gesta giovanili Egli esorta quindi Patroclo a far leva sulla sua amicizia per convincere Achille a riprendere il combattimento o - almeno - a concedere a Patroclo le sue armi per incutere timore nei Troiani Eccitato dalle parole del vecchio Patroclo si avvia verso la nave di Achille ma incontra Euripilo ferito che gli chiede aiuto ed egli impietositosi lo accompagna alla tenda e cura la ferita Canto XII Divisi in cinque contingenti i Troiani danno lrsquoassalto al muro eretto a difesa del campo acheo Sul campo di battaglia si manifesta un prodigio unrsquoaquila in cielo con un grosso serpente fra le zampe che riesce a ferire lrsquouccello e a sfuggire Polidamante che interpreta il segno come un presagio funesto consiglia di tornare indietro ma Ettore egrave di altro avviso Sarpedone e Glauco sferrano un attacco contro il muro e - pur rimanendo feriti - riescono ad aprire una breccia La battaglia infuria con esito incerto fincheacute Ettore con un macigno sfonda una delle porte consentendo ai Troiani di entrare in massa nel campo acheo mentre i Greci fuggono verso il mare Canto XIII Zeus distoglie lo sguardo dalla battaglia nella convinzione che nessuno fra gli dei avrebbe osato violare il divieto di intervenire ne approfitta invece Poseidone favorevole ai Greci Assunto lrsquoaspetto dellrsquoindovino Calcante il dio infonde nuovo vigore nei due Aiaci
Letteratura greca [1]
17
spronandoli al combattimento Gli Achei riconoscono lrsquointervento divino e riprendono fiducia I combattimenti si susseguono violentissimi Nella resistenza si distingue il re cretese Idomeneo Polidamante consiglia una seconda volta di interrompere la battaglia e accenna allrsquoimminente intervento di Achille Ettore non ascolta lrsquoammonimento e riprende lrsquoassalto Il canto si chiude con un suo scambio di insulti con Aiace Telamonio Canto XIV Mentre Diomede Odisseo e Agamennone tornano feriti allrsquoaccampamento Era per distogliere Zeus dalla battaglia e consentire a Poseidone di favorire gli Achei indossa la cintura magica di Afrodite e sollecita il consorte a un convegno amoroso sullrsquoIda dopo lrsquoamplesso Zeus cade in un sonno profondo e Hypnos (il Sonno) annuncia a Posidone che potragrave aiutare senza rischi gli Achei Ettore colpito con una pietra da Aiace resta a lungo in stato di incoscienza e i Troiani vengono respinti Canto XV Zeus si risveglia avvedendosi dellrsquoinganno subito e costringe Era a mandargli Iride e Apollo la prima allontaneragrave Posidone dal campo di battaglia Apollo inciteragrave Ettore a far retrocedere gli Achei fino alle navi dei Mirmidoni Riprende lrsquooffensiva troiana Apollo stesso abbatte il muro e scuotendo lrsquoegida atterrisce gli Achei Patroclo corre da Achille mentre i Troiani giagrave sono sul punto di appiccare il fuoco alle navi Canto XVI Patroclo in lacrime supplica Achille di intervenire o di mandare lui stesso al suo posto [T8] Achille gli consegna le proprie armi e gli fa promettere che non si avventureragrave oltre la zona delle navi Ma Patroclo trascinato dal suo stesso impeto oltrepassa il limite prescrittogli da Achille Abbatte Sarpedone figlio di Zeus attorno al cui cadavere infuria la lotta fincheacute Apollo lo sottrae alla mischia e Hypnos e Thanatos (il demone della morte) lo trasportano in Licia sua patria Patroclo continua lrsquoassalto alla testa dei Mirmidoni fin sotto le mura di Troia ma poco prima del tramonto al quarto assalto Apollo stesso assunto lrsquoaspetto di Asio lo percuote fra le spalle allora Euforbo lo colpisce con lrsquoasta ed Ettore lo trafigge Canto XVII Euforbo viene ucciso da Menelao ma Ettore riesce a catturare le armi di Achille indossate da Patroclo Vigorosamente sostenuti da Aiace gli Achei difendono il cadavere Una densa nebbia scende sui combattenti Zeus infonde nuovo ardimento nei cavalli di Achille piangenti per la fine di Patroclo [T9] Atena e Apollo arroventano la lotta attorno alla salma In seguito alla preghiera di Aiace Zeus dissolve la nebbia Menelao manda Antiloco figlio di Nestore a informare Achille della morte di Patroclo la cui salma viene intanto trascinata fuori della battaglia da Menelao e Merione mentre i due Aiaci offrono la necessaria copertura contro la furia incalzante dei nemici Canto XVIII Lo scoppio di selvaggio dolore a cui si abbandona Achille allrsquoudire della morte di Patroclo provoca lrsquoaccorrere dal mare di Tetide insieme con le Nereidi La madre gli promette di procurargli nuove armi Poicheacute la salma di Patroclo egrave tuttora contesa Achille fa la sua apparizione sul fossato e lancia un grido che atterrisce i nemici Efesto su preghiera di Tetide foggia le nuove armi fra cui un magnifico scudo su cui appaiono effigiati in bande concentriche gli aspetti salienti dellrsquoesistenza umana Canto XIX Il mattino seguente Tetide porta le armi al figlio e con lrsquoambrosia preserva la salma di Patroclo dalla decomposizione Achille convoca unrsquoassemblea dellrsquoesercito e rinuncia alla sua collera Agamennone lamenta di essere stato ldquoaccecatordquo da Zeus e promette doni
Letteratura greca [1]
18
riparatori [T10] Achille si lascia convincere a stento ad attendere che i soldati abbiano mangiato Poi gli armati si radunano e anche Achille si arma Il suo cavallo Xanto gli predice la prossima morte [T11] Canto XX Zeus consente agli degravei di partecipare alla nuova battaglia Enea scontratosi con Achille egrave tratto in salvo da Posidone Achille infuria come un incendio in una selva Canto XXI Achille colma di cadaveri il fiume Scamandro e cattura dodici giovani troiani che intende offrire in sacrificio a Patroclo non risparmia neppure Licaone figlio di Priamo che lo supplica con accenti di grande intensitagrave ma altrettanto intensa nella consapevolezza di un destino imminente egrave la pur spietata replica del Pelide [T12] Lo Scamandro solleva le proprie onde ma le fiamme di Efesto inaridiscono il terreno e domano la corrente Gli degravei si azzuffano Atena raggiunge Ares con una pietra Era rintuzza la furia di Artemide Infine tutti tornano sullrsquoOlimpo Apollo assunto lrsquoaspetto di Agenore respinge Achille percheacute i Troiani possano rifugiarsi allrsquointerno delle mura Canto XXII Il solo Ettore resta fuori nella pianura Invano Priamo ed Ecuba lo pregano di rientrare Mentre Achille si avvicina Ettore decide di affrontarlo ma quando quello gli egrave da presso col bronzo che gli lampeggia intorno laquosimile al raggio del fuoco ardente o del sole che sorgeraquo egrave afferrato dal panico e comincia a fuggire compiendo tre giri intorno alle mura Zeus pesa sulla bilancia i destini (le κῆρες) dei due eroi e quello di Ettore affonda in basso Allora Apollo lo abbandona e Atena apparsa a Ettore sotto le spoglie di suo fratello Deifobo gli si avvicina promettendogli aiuto e invece riporta ad Achille la lancia che gli era caduta fuori bersaglio Il colpo di risposta di Ettore rimbalza sullo scudo di Achille Ettore urla a Deifobo di passargli la sua lancia ma il falso Deifobo egrave scomparso ed Ettore comprende di trovarsi sullrsquoorlo dellrsquoabisso [T13] Achille gli trapassa la gola ed Ettore lo supplica di non oltraggiare la sua salma in risposta riceve la minaccia che finiragrave in pasto ai cani Achille trascina il cadavere alle navi attaccato al carro Priamo Ecuba e Andromaca si abbandonano al cordoglio a cui fanno eco le donne troiane Canto XXIII Viene preparato il banchetto funebre in onore di Patroclo la cui ombra nel corso della notte appare ad Achille chiedendo la sepoltura del corpo Il mattino seguente si appresta il rogo fra le offerte votive ci sono anche dodici giovani troiani Il giorno successivo si raccolgono le ossa di Patroclo Seguono i ludi funebri gare coi carri e con lrsquoarco duello in armi etc Canto XXIV Ogni giorno Achille trascina il cadavere di Ettore attorno alla tomba dellrsquoamico ma lo spettacolo offende gli degravei e al dodicesimo giorno Zeus decide di mandare Tetide percheacute induca suo figlio a restituire la salma di Ettore Iride viene inviata presso Priamo percheacute gli consigli di recarsi nel cuore della notte con un carro da trasporto e un copioso riscatto scortato da Ermes alla tenda di Achille Questi accoglie il vecchio con rispetto riconoscendo in lui lrsquoimmagine del padre lontano e si piega alla sua supplica [T14] Per volontagrave degli degravei il cadavere non egrave stato aggredito dalla putrefazione composto sul pianale del carro viene ricondotto dal padre a Troia Qui le lamentazioni rituali srsquoinnalzano dal gruppo delle donne (Andromaca Ecuba Elena) Si stipula una tregua di dodici giorni Per nove giorni i Troiani raccolgono legname poi anche il rogo di Ettore arde e si erige un tumulo
Letteratura greca [1]
19
Struttura e caratteri dellʼopera Poema di trama relativamente organica (soprattutto a partire dal canto XVI tutti gli avvenimenti tranne pochi episodi isolati ruotano attorno ai due principali antagonisti Ettore uccide Patroclo per vendicare Sarpedone e Achille uccide Ettore per vendicare Patroclo) pur se non privo di piugrave o meno cospicue incongruenze spiegabili in primo luogo con la lunga e complessa genesi orale dellrsquoopera lrsquoIliade lascia emergere in mezzo alle centinaia di nomi e alle intricate vicende alcuni caratteri delineati nella loro individualitagrave e innanzi tutto quelli di Achille e di Ettore accomunati dalla medesima coscienza di un destino di morte che sono pronti ad affrontare Appunto una tale attitudine a rappresentare i laquocaratteriraquo (ἤθη) dei suoi personaggi egrave un altro titolo di merito che Aristotele ascrive ad Omero (Poetica 1460a9-11)
dopo aver brevemente proemiato subito introduce un uomo una donna o un altro personaggio nessuno privo di caratterizzazione ma dotato di un carattere
Fondamentale per la struttura del poema egrave la novitagrave della prospettiva Possiamo presumere che i cosiddetti poemi ciclici22 mirassero a conservare lrsquoangolatura che era stata propria delle versioni pre-omeriche della saga troiana sigrave che puograve riuscire significativo il confronto fra lrsquoesordio della Piccola Iliade (dove muovendo da grandi entitagrave ndash la cittagrave il paese due popoli la guerra ndash viene lanciato secondo lrsquoespressione di J Latacz come laquouno sguardo dallrsquoesternoraquo)
Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην εὔπωλον ἧς πέρι πολλὰ πάθον Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος Canto Ilio e la terra dei Dardani dai bei puledri per la quale molti dolori patirono i Danai servitori di Ares
con lo laquosguardo internoraquo che caratterizza lrsquoinizio dellrsquoIliade
Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν ἡρώων αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν οἰωνοῖσί τε δαῖτα Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς Canta o dea di Achille figlio di Peleo la collera maledetta che pene innumerevoli inflisse agli Achei e molte scagliograve allrsquoAde vite possenti di eroi e ne faceva prede per i cani e pasto per gli uccelli e si avverava il volere di Zeus da quando primamente si separarono venuti a contesa LrsquoAtride sovrano di eroi e Achille magnifico
Argomento non egrave dunque come doveva avvenire nella tradizione del canto epico un evento complesso da inquadrare con un grandangolo onnicomprensivo e neppure come saragrave nellrsquoOdissea un personaggio colto nella multiforme varietagrave delle sue peregrinazioni egrave invece una reazione emotiva (lrsquoira di Achille) con le sue conseguenze (le innumerevoli morti degli Achei) Narrare di questa ira significa per il poeta cominciare da un punto preciso (laquoda quandoraquo) ossia dal momento della contesa e della separazione fra i due massimi eroi greci Agamennone il primo per potere (laquosovrano di eroiraquo) e Achille il primo per nobiltagrave e forza (δῖος) E sintomatica della bipolaritagrave del mondo epico in quanto mondo di degravei e di eroi egrave la sincronia per cui il taglio della narrazione coincide col decorso del laquovolere di Zeusraquo (Διὸς βουλή) forse da identificare con la promessa del dio a Tetide (rievocata piugrave oltre in questo
22 V cap II laquoLa tradizione omericaraquo
Letteratura greca [1]
20
stesso canto ai vv 518-527) di vendicare lrsquoaffronto subito da Achille o piugrave in generale con il corso degli eventi in quanto tutto come per definizione laquogiace sulle ginocchia di Zeusraquo Opera indubbiamente allrsquointerno del poema unrsquoidea formativa un progetto di qui un insieme monumentale unificato anche da una serie di corrispondenze a distanza fra cui particolare significato acquistano quelle fra primo e ultimo canto Nel canto I il vecchio Crise va come supplice presso Agamennone portando doni e supplicando la restituzione della figlia e Agamennone lo respinge aspramente minacciandolo di far ricorso alla violenza se dovesse tornare nel canto XXIV il vecchio Priamo va come supplice presso Achille portando doni e supplicando la restituzione del corpo del figlio Achille ha una prima reazione irosa (esordisce al v 560 con laquoSmetti di irritarmi vecchioraquo) ma poi accoglie la supplica E al di lagrave delle corrispondenze nelle linee dellrsquoazione si colgono fra principio e fine del poema alcuni importanti echi verbali in particolare fra XXIV 501 s
τοῦ νῦν εἵνεχ᾽ ἱκάνω νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενος παρὰ σεῖο φέρω δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα per lui [Ettore] vengo ora alle navi degli Achei per riscattarlo da te e ti porto compenso infinito
e I 12 s
ὁ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενός τε θυγάτρα φέρων δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα costui [Crise] venne alle navi rapide degli Achei per riscattare la figlia portando compenso infinito
fra XXIV 555-557
λῦσον ἵν᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδωmiddot σὺ δὲ δέξαι ἄποινα πολλά τά τοι φέρομενmiddot σὺ δὲ τῶνδrsquo ἀπόναιο καὶ ἔλθοις σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν restituiscimelo percheacute lo possa vedere con gli occhi e accogli il riscatto copioso che portiamo e tu possa goderne e tornare alla tua terra patria
e I 18-20
Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν εὖ δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκέσθαιmiddot παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην τὰ δ᾽ ἄποινα δέχεσθαι Atridi e voi altri Achei dai forti schinieri a voi concedano gli degravei che hanno le case in Olimpo di distruggere la cittagrave di Priamo e tornare facilmente in patria ma restituitemi la figlia e accettate il riscatto
fra XXIV 560 μηκέτι νῦν μ᾽ ἐρέθιζε (laquosmetti di irritarmiraquo) e I 32 μή μ᾽ ἐρέθιζε (laquonon mi irritareraquo) fra XXIV 568-570
τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς μή σε γέρον οὐδrsquo αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω καὶ ἱκέτην περ ἐόντα Διὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμάς Ora perciograve fra i dolori non mi eccitare lrsquoanimo ancora di piugrave bada o vecchio che non ti lasci neppure nella tenda
Letteratura greca [1]
21
bencheacute supplice e violi gli ordini di Zeus e I 26-28
μή σε γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω ἢ νῦν δηθύνοντ᾽ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο Mai te o vecchio io colga presso le concave navi ora a indugiare o piugrave tardi a tornare che piugrave non dovesse giovarti lo scettro e la benda del dio
(e infine XXIV 571 ὣς ἔφατ ἔδεισεν δ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ laquocosigrave diceva e il vecchio tremograve e obbediva alle paroleraquo ripete esattamente I 33) In effetti lrsquoepisodio terminale del poema col superamento dellrsquoira ad opera della pietagrave e del senso di unrsquoesistenza invasa dal dolore si propone come il rovesciamento consapevole dellrsquoepisodio iniziale che era apparso caratterizzato dalla cancellazione della pietagrave e del diritto dei supplici in nome della forza Al rifiuto iniziale del donoriscatto si oppone lrsquoaccettazione finale in consonanza con un principio-guida che opera nel poema secondo linee che alla fine si riunificano Agamennone restituisce Criseide al padre ma si appropria del dono fatto dagli altri Achei ad Achille (Briseide) Achille respinge i doni fatti da Agamennone per indurlo a riconciliarsi con lui ma dopo aver contestato nel IX canto la nozione che la vita umana possa essere barattata con una massa di beni torna alla lotta non in cambio di qualche premio da conquistare ma per vendicare lrsquouccisione dellrsquoamico Patroclo e tanto nella lotta sul campo di battaglia quanto nellrsquoinfierire sul cadavere di Ettore si abbandona a un furore cosigrave smisurato e patologico che puograve essere superato solo con lrsquoaccettare i doni di Priamo non tuttavia per il loro valore drsquouso ma percheacute in Priamo Achille riconosce lrsquoombra del padre lontano Cosigrave lrsquoIliade appare attraversata da un impulso fondamentale che muove dallrsquoideologia del dono e dalla conseguente centralitagrave assegnata allrsquoonore (τιμή) come ldquoprezzordquo che qualifica il valore del guerriero ma supera questo piano di valutazione dei rapporti umani attraverso la loro riformulazione nei termini di un umanesimo esistenziale che ha come punti di riferimento lrsquoidentitagrave universale dei condizionamenti oggettivi (la vecchiaia la malattia la morte) e i legami che uniscono padre e figlio compagno e compagno vivi e morti (il cordoglio finale di Andromaca Ecuba ed Elena sulla salma di Ettore) Entro questo orizzonte progressivamente allargato la guerra le lotte lo scontro mortale finiscono col rappresentare solo un momento e un aspetto dellrsquoesistenza graditi tanto agli degravei che vi assistono come spettatori interessati quanto agli uditori che riascoltano le antiche gesta eppure non tali da appiattire il poema in una prospettiva guerresca conclusa in se stessa Molto del fascino delle battaglie e delle ἀριστεῖαι dellrsquoIliade sta nella presenza recondita di un occhio che sa guardare al di lagrave di esse (e al di lagrave della stessa distinzione fra Greci e Troiani vincitori e vinti) e che puograve anche attraverso le similitudini lasciare irrompere il mondo della natura o del lavoro umano nel mezzo delle battaglie LʼOdissea LrsquoOdissea (Ὀδύσσεια) consta di circa 12100 esametri divisi anchrsquoessi in 24 libri e indicati con le lettere minuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquoargomento egrave costituito dalle avventure di Odisseo dalla distruzione di Troia al ritorno alla patria Itaca esposte secondo un ordine che entrando subito nel vivo degli avvenimenti (lrsquoinizio del poema mostra Odisseo nellrsquoisola di Calipso) rievoca poi i fatti giagrave trascorsi e li ricongiunge infine a partire dal libro XV (con lrsquoarrivo di Telemaco alla capanna di Eumeo dove giagrave si trova Odisseo) in unrsquoazione unitaria La trama del poema i cui avvenimenti sono concentrati cronologicamente nello spazio di 40 giorni (ma sono narrati solo gli avvenimenti di 16 giorni e 8 notti) si articola in tre parti la laquoTelemachiaraquo (canti I-IV) il laquoRitorno di Odisseoraquo (canti V-XIII) e la laquoVendetta di Odisseoraquo (canti XIV-XXIV)
Letteratura greca [1]
22
Canto I Tutti gli eroi superstiti sono ormai tornati da Troia alle loro case tranne Odisseo che pur desideroso di tornare egrave trattenuto dalla ninfa Calipso nellrsquoisola di Ogigia Gli degravei hanno pietagrave di lui tranne Posidone irato per lrsquoaccecamento del figlio il ciclope Polifemo Ma un consiglio degli degravei assente Posidone (che si egrave recato presso gli Etiopi) delibera il ritorno dellrsquoeroe si decide che Ermes andragrave subito da Calipso mentre Atena si avvia verso Itaca sotto lrsquoaspetto del signore dei Tafi Mente per incoraggiare il figlio di Odisseo Telemaco a tener testa ai pretendenti della madre i laquoprociraquo (i quali aspirano al regno tramite le nozze con Penelope) e per indurlo a intraprendere un viaggio in cerca di notizie sul padre Canto IΙ Telemaco segue il consiglio della dea e il giorno seguente nellrsquoassemblea popolare chiede una nave per andare in cerca del padre ma la sua richiesta non viene discussa e Leocrito scioglie lrsquoassemblea Grazie ad Atena che ora ha assunto le sembianze di Mentore (antico amico di Odisseo) Telemaco riesce tuttavia a trovare una nave con cui salpa nel corso della notte allrsquoinsaputa sia della madre che dei proci Canto IΙΙ Telemaco e MentoreAtena arrivano a Pilo e sul lido trovano Nestore che sta offrendo un sacrificio a Posidone Il vecchio eroe accoglie ospitalmente Telemaco e gli comunica molte notizie sul ritorno di altri Achei ma nessuna su Odisseo Alla sera Atena scompare in forma di aquila e il mattino seguente Telemaco salpa insieme con Pisistrato (figlio di Nestore) alla volta di Sparta dove arriva la sera del giorno successivo Canto IV A Sparta Menelao sta festeggiando il doppio matrimonio del figlio e della figlia Il giorno seguente Telemaco chiede del padre Menelao gli racconta il proprio ritorno durante il quale aveva incontrato Proteo il vecchio nume marino che gli aveva riferito come Odisseo fosse trattenuto nellrsquoisola di Calipso Intanto a Itaca i proci preparano insidie meditando di uccidere Telemaco al suo ritorno Penelope ne viene a conoscenza ma Atena le appare in sogno per confortarla Canto V Dopo un secondo concilio degli degravei (in effetti un ldquodoppionerdquo di quello del I canto) Zeus manda finalmente Ermes presso Calipso con lrsquoordine di lasciar partire Odisseo La ninfa aiuta lrsquoeroe a costruirsi una zattera Al diciottesimo giorno di navigazione Odisseo egrave in vista dellrsquoisola dei Feaci Scheria quando Posidone di ritorno dal suo soggiorno presso gli Etiopi lo vede e suscita una tempesta che distrugge la zattera Ma la dea marina Ino Leucotea impietositasi gli porge il proprio velo sostenuto dal quale lrsquoeroe giunge a nuoto alla riva di Scheria dove si abbandona esausto addormentandosi Canto VI In seguito a un sogno inviatole da Atena Nausicaa la figlia del re dei Feaci Alcinoo si reca nei pressi della spiaggia a lavare le vesti insieme con le ancelle Odisseo risvegliatosi atterrisce le fanciulle che fuggono tutte allrsquoinfuori di Nausicaa Lrsquoeroe supplica la giovane di porgerle aiuto ed ella lo fa rivestire e lo accompagna fino al bosco di Atena poco prima della cittagrave esortandolo a presentarsi a suo padre Canto VII Protetto dalla nebbia di cui Atena lo ha avvolto Odisseo entra nel palazzo abbraccia le ginocchia della regina Arete e la caligine scompare poi viene accolto con onore da Alcinoo Arete chiede a Odisseo donde provenga e chi gli abbia donato gli abiti (a lei ben noti) che indossa Lrsquoeroe inizia a raccontare le disavventure che gli sono occorse dopo la
Letteratura greca [1]
23
partenza dallrsquoisola di Calipso Alcinoo gli promette di farlo ricondurre a Itaca il giorno seguente Canto VIII Ma lrsquoindomani Alcinoo fa apprestare un banchetto durante il quale lrsquoaedo Demodoco canta della contesa insorta un giorno fra Achille e Odisseo Lrsquoeroe si copre il volto per nascondere le lacrime allora Alcinoo interrompe il canto e organizza una serie di gare nel corso delle quali Odisseo primeggia Poi Demodoco al margine di unrsquoarea per la danza dove si esibiscono i ballerini feaci canta gli amori di Ares e Afrodite e la vendetta di Efesto (che incatena i due amanti) La sera al ritorno nel palazzo Demodoco racconta la storia del Cavallo di legno Odisseo scoppia nuovamente in lacrime e Alcinoo gli chiede di rivelare il suo nome Canto IX Odisseo dichiara il proprio nome e dagrave inizio al racconto della propria storia a partire dalla caduta di Troia distruzione di Ismaro e perdite subite ad opera dei Ciconi sbarco presso i Lotofagi (che si nutrono di un cibo misterioso che fa dimenticare il ritorno) dopo una terribile tempesta scatenatasi durante il tentativo di doppiare il capo Malea arrivo allrsquoisola antistante quella dei Ciclopi dove Odisseo si trasferisce con una sola nave esplorazione dellrsquoisola perdita di alcuni compagni allrsquointerno della caverna del gigante monocolo accecamento del mostro e fuga Canto X Odisseo giunge allrsquoisola di Eolo signore dei venti che lo accoglie benevolmente e gli consegna alla partenza tutti i venti chiusi in un otre ma poi lo respinge con durezza quando ritorna presso di lui percheacute i compagni (sospettando che nellrsquootre siano racchiuse cospicue ricchezze) hanno sciolto i venti e da essi si egrave sprigionato un uragano che li ha risospinti sullrsquoisola Ripreso il mare Odisseo egrave trasportato fino ai Lestrigoni antropofagi il cui attacco priva lrsquoeroe di tutte le altre navi tranne la propria Con questa fugge fino allrsquoisola (Eea) della maga Circe Dopo che Circe ha trasformato in porci un gruppo di compagni mandati innanzi ad esplorare lrsquoisola Odisseo ha la meglio sulla maga (a cui impone di restituire forma umana ai compagni) grazie allrsquoerba moly fornitagli da Ermes Resta un anno presso Circe che al momento della partenza gli consiglia di recarsi al paese dei morti per interrogare il vate Tiresia Canto XI Approdato alla terra dei Cimmeri (che vivono immersi in una nebbia perenne sulla riva dellrsquoOceano) e scavata una fossa Odisseo sacrifica ai morti e immola una vittima speciale a Tiresia Le anime accorrono dapprima Elpenore caduto per caso giugrave dal tetto della casa di Circe (Odisseo gli promette sepoltura) poi la madre Anticlea (che gli racconta di esser morta di dolore per la sua assenza) quindi Tiresia che gli vaticina le sue vicende future fino alla morte (questa lo coglieragrave dopo una lunga vita in un paese straniero che non conosce neacute il sale neacute il remo) Da un certo punto in poi il poeta dimentica il presupposto per cui Odisseo aveva scavato una fossa alla quale i morti accorrevano per bere il sangue delle vittime e bevendolo riacquistavano per breve tempo una piena consapevolezza immagina invece che Odisseo sia allrsquointerno dellrsquoAde In questa sezione rientrano la descrizione di Aiace sdegnato di Minosse di Orione dei grandi peccatori di Eracle Poi Odisseo fa ritorno a Eea e ricevuti i consigli di Circe si imbarca per il ritorno in patria Canto XII Scampato alle Sirene che invano lo attirano col canto (si egrave fatto legare allrsquoalbero della nave i compagni che remano hanno le orecchie turate con la cera) passa tra Cariddi e Scilla (che gli rapisce sei uomini) ed egrave costretto dai compagni ad approdare in contrasto con le prescrizioni di Circe allrsquoisola Trinachia dove pascolano le greggi del Sole I
Letteratura greca [1]
24
compagni spronati da Euriloco se ne cibano nonostante il divieto dellrsquoeroe Il Sole sdegnato ottiene da Zeus che la nave sia colpita dal fulmine Tutti i compagni periscono ma Odisseo che ripassa tra Scilla e Cariddi si salva miracolosamente da questrsquoultima aggrappandosi a un fico selvatico fincheacute il gorgo restituisce i rottami della nave infine arriva remando con le mani allrsquoisola di Ogigia Canto XIII Terminato il racconto lrsquoeroe riceve doni dai Feaci e la notte seguente egrave ricondotto a Itaca e deposto addormentato sulla spiaggia presso un antro sacro alle Ninfe Al risveglio per la nebbia non riconosce la sua terra fincheacute Atena in veste di giovane pastore lo rassicura e poi rivelatasi gli dagrave istruzioni su come far strage dei proci e lo trasforma in un vecchio mendico Canto XIV Odisseo si reca allo stazzo del suo porcaio Eumeo che pur non riconoscendolo lo accoglie ospitalmente rifocillandolo e offrendogli un mantello per ripararsi dal gelo notturno Canto XV A questo punto la laquoTelemachiaraquo si riannoda allrsquoazione principale Telemaco che si trova ancora a Sparta viene indotto da Atena a tornare a Itaca sulla via del ritorno a Pilo accoglie a bordo lrsquoindovino Teoclimeno e grazie allrsquoaiuto della dea sfugge alle insidie dei proci sbarca a Itaca e si reca anchrsquoegli presso Eumeo Canto XVI Questi va da Penelope ad annunciargli il ritorno del figlio Intanto Odisseo rimosso lrsquoincantesimo si svela nel suo vero aspetto a Telemaco e con lui progetta la vendetta sui proci (che intanto tramano una nuova insidia ai danni di Telemaco) Eumeo torna al suo stazzo Canto XVII Il mattino seguente Telemaco si reca in cittagrave seguito in un secondo tempo da Eumeo e Odisseo (che ha riassunto lrsquoaspetto di mendico) Davanti al palazzo Odisseo egrave riconosciuto dal cane Argo Entra e va mendicando tra i proci Antinoo lo colpisce alla spalla destra con uno sgabello Canto XVIII Odisseo si batte al pugilato col mendicante Iro Penelope scesa nella sala prospetta ai proci lrsquoeventualitagrave di un nuovo matrimonio Odisseo egrave insultato dalla schiava Melanto e schiva uno sgabello scagliato da Eurinomo Canto XIX Insieme con Telemaco lrsquoeroe allontana le armi dalla sala poi conversa con Penelope che gli racconta un sogno e gli espone il suo piano per sedare le contese tra i proci concedendosi sposa a colui che riusciragrave a tendere lrsquoarco di Odisseo la prova avverragrave il giorno seguente al novilunio Durante il colloquio la fida schiava Euriclea lava i piedi di Odisseo e riconosciutolo da unrsquoantica cicatrice sta per rivelarne lrsquoidentitagrave ma lrsquoeroe la costringe a tacere Canto XX Al mattino Euriclea e le ancelle fanno i preparativi per il banchetto Giungono Eumeo Melanzio e il mandriano Filezio Un presagio mandato da Zeus dissuade i proci dal progetto di uccidere Telemaco Durante il banchetto Teoclimeno predice la loro imminente rovina
Letteratura greca [1]
25
Canto XXI Penelope conduce lrsquoarco nella sala dopo che parecchi fra i proci e lo stesso Telemaco hanno tentato invano di tenderne la corda Odisseo chiede di partecipare alla prova tende lrsquoarco senza fatica e riesce a far passare la freccia attraverso gli anelli di dodici scuri predisposte da Telemaco Canto XXII Poi scaglia le frecce sui proci e si rivela nella sua identitagrave Nella lotta che segue Telemaco Eumeo e Filezio aiutano il padrone contro i proci (appoggiati dal capraio Melanzio) Tutti i proci restano uccisi le ancelle infedeli sono impiccate Melanzio viene mutilato e ucciso soltanto lrsquoaedo Femio e lrsquoaraldo Medonte sono risparmiati Canto XXIII Nuovo colloquio fra Odisseo e Penelope che durante lrsquoeccidio dormiva ed egrave stata svegliata da Euriclea Penelope esita ancora a riconoscere il marito e non si arrende alla veritagrave fincheacute Odisseo non le descrive la posizione e la struttura del letto coniugale Canto XXIV Ermes conduce allrsquoAde le ombre dei proci Odisseo fa visita al padre Laerte nella masseria dove quello vive nello squallore e nellrsquoemarginazione e si fa riconoscere Intanto il padre di Antinoo incita gli Itacesi alla rivolta e il poema si conclude con lo scontro di Odisseo e dei suoi contro i concittadini lrsquoeroe ha la meglio e Zeus scagliato il fulmine pone fine alla battaglia Atena sotto lrsquoaspetto di Mentore stabilisce fra i contendenti un patto per il futuro36
Struttura e caratteri dellʼopera Giagrave la prima parola del proemio (ἄνδρα) non menziona come tema dellrsquoopera un determinato episodio della vita del protagonista ma il protagonista stesso (I 1-10)
Ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα πολύτροπον ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεmiddot πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περmiddot αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο νήπιοι οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιονmiddot αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ τῶν ἁμόθεν γε θεά θύγατερ Διός εἰπὲ καὶ ἡμῖν Dellrsquouomo multiforme a me racconta o Musa che molto errograve dopo che di Troia la sacra rocca distrusse di molti uomini vide le cittagrave riconobbe il pensiero e molti per il mare patigrave dolori nellrsquoanimo per salvare la sua vita e il ritorno dei compagni Eppure non li salvograve i compagni per quanto bramasse per la loro stessa follia si persero gli stolti i buoi del Sole Iperione mangiarono e quello rapigrave ad essi il digrave del ritorno Di questo da un punto qualsiasi narra anche a noi o dea figlia di Zeus
Storie favolose di naviganti racconti imperniati sul ritorno dei guerrieri achei che avevano combattuto a Troia e il particolare rientro in patria di Odisseo figlio di Laerte erano forse giagrave stati connessi e intrecciati nella precedente tradizione epica sigrave che il presente cantore poteva
Letteratura greca [1]
26
metter mano alla vicenda partendo (v 10) laquoda un punto qualsiasiraquo (ἁμόθεν) una notazione che certo presuppone la convenzione propria dellrsquoesordio tradizionale di un canto epico comparabile con i giagrave ricordati ἐξ οὗ (laquoda quandoraquo) di Iliade I 4 ed ἔνθεν (laquoda doveraquo) di Odissea VIII 500 Senoncheacute rispetto a queste indicazioni di tipo puntuale il tratto costituito dalla dimensione casuale quasi arbitraria inerente ad ἁμόθεν proprio mentre dichiara lrsquoassenza di un determinato piano compositivo implica in realtagrave che il racconto non si svolgeragrave per filo e per segno secondo lrsquoordine noto a poeta e uditori non si snoderagrave κατὰ κόσμον (laquoper ordineraquo) come il canto di Demodoco (VIII 489) ma seguiragrave un andamento originale Il ldquopunto qualsiasirdquo incipitario non rappresenta una scelta della Musa (figura dellrsquoarchivio tematico che conserva le laquovieraquo dellrsquoepica) bensigrave di questo cantore che ha deciso di far incominciare la narrazione in medias res e ha in serbo la sorpresa di far succedere al concilio degli degravei (che decide lrsquoinvio di Ermes presso Calipso) non lrsquoazione testeacute programmata (azione che viene differita con un ritardo che a piugrave riprese ha scandalizzato i lettori a principio del V canto) ma la partenza di Atena alla volta di Itaca e lrsquoavvio della laquoTelemachiaraquo Le due diverse vicende proposte a principio del poema quella di Telemaco e quella di Odisseo procedono infatti in parallelo coprendo un analogo lasso di tempo Piugrave oltre la decisione di trasformare la sequenza narrativa che va dalla partenza di Odisseo da Troia fino al suo arrivo nella terra dei Feaci in una rievocazione fatta dallrsquoeroe in prima persona al cospetto di Alcinoo e dei Feaci (la sezione detta degli ἀπόλογοι laquoraccontiraquo) crea una struttura ad anello che parte dal presente e ad esso fa ritorno dopo aver ricostruito le premesse della condizione attuale del protagonista Col canto XIII Odisseo egrave riportato dai Feaci a Itaca e questo permette la saldatura fra le vicende sue e quelle di Telemaco sia pure col differimento dellrsquoincontro e del riconoscimento fra padre e figlio fino al canto XVI Far scorrere in parallelo sequenze distinte organizzare programmi narrativi a corta e a lunga gittata tendere o allentare ad arte il ritmo della narrazione non si tratta davvero di procedimenti che potessero configurarsi come tradizionali dellrsquoarte epica quanto piuttosto di un momento sperimentale di una ricerca di soluzioni nuove al termine di una lunga e ormai consolidata sedimentazione di percorsi compiuti allrsquointerno di un determinato repertorio tematico unrsquoaudacia inventiva una πολυτροπίη degne del protagonista del poema che inevitabilmente comportavano rischi molteplici di incoerenze dissonanze occasionali avarie della macchina epica e che tuttavia erano destinate a conseguire un risultato assolutamente convincente allrsquoorecchio di chi si abbandonasse al fascino del racconto senza lrsquourgenza propria di altre etagrave e di altre mentalitagrave di puntare il dito sui singoli dettagli o le singole sfasature
PER SAPERNE DI PIUrsquo Difficoltagrave e incongruenze della narrazione omerica Forti della possibilitagrave di un controllo su un testo scritto che possiamo percorrere in avanti e a ritroso secondo ritmi di nostra scelta a noi non riesce difficile cogliere alcune delle difficoltagrave organizzative incontrate nella composizione del poema In proposito per ricordare un caso che saragrave allrsquoorigine delle discussioni di orientamento ldquoanaliticordquo intorno allrsquoOdissea possiamo leggere il discorso che Atena prese le sembianze di Mente re dei Tafi rivolge a Telemaco nel I canto (vv 253-305) Ah infelice ti manca molto davvero lrsquoassente Odisseo che getti le mani addosso ai pretendenti sfrontati Percheacute se ora tornato stesse sulla soglia 255 con una scure lo scudo e due lance cosigrave come io per la prima volta lo vidi in casa nostra che beveva e godeva di ritorno da Efira da Ilo di Mermero (andograve anche ligrave Odisseo con la nave veloce 260 in cerca del veleno omicida per averne da ungere le frecce di bronzo ma quello non glielo diede percheacute temeva gli dei che vivono eterni
Letteratura greca [1]
27
glielo diede invece mio padre percheacute lrsquoamava moltissimo) se stesse Odisseo tra i pretendenti cosigrave 265 essi avrebbero tutti rapida morte e nozze amare Ma sulle ginocchia degli dei questo giace se una volta tornato faragrave o no vendetta nella sua casa te invece io esorto a riflettere come cacciare i pretendenti da casa 270 Ebbene ora ascolta e alle mie parole darsquo retta Domattina chiamati gli eroi Achei a consiglio rivolgi a tutti un discorso e siano testimoni gli dei Ai pretendenti comanda drsquoandarsene per i fatti loro e tua madre se lrsquoanimo la spinge alle nozze 275 ritorni a casa del padre molto potente Prepareranno essi le nozze e disporranno i doni nuziali moltissimi quanti gli pare che debbano andare alla figlia A te darograve un saggio consiglio se vuoi ascoltarlo armata una nave con venti remi la migliore che crsquoegrave 280 Varsquo a domandare del padre partito da tempo se mai te ne parli un mortale o sentissi da Zeus la voce che divulga la fama tra gli uomini Anzitutto varsquo a Pilo e interroga il chiaro Nestore di ligrave poi varsquo a Sparta dal biondo Menelao 285 degli Achei vestiti di bronzo egli egrave tornato per ultimo Se senti dire qualcosa sulla vita e il ritorno del padre per quanto stremato potresti sopportare un altro anno se invece senti dire che egrave morto e non vive allora tornato nella cara terra patria 290 ergigli un tumulo e offrigli funebri offerte moltissime quanto conviene e darsquo tua madre a un marito E poi dopo aver compiuto e fatto ogni cosa allora medita nella mente e nellrsquoanimo come tu possa uccidere nelle tue case 295 i pretendenti con lrsquoinganno affrontandoli non devi piugrave avere i modi di un bimbo percheacute ormai non sei tale Non senti lrsquoillustre Oreste quale gloria ha acquistato fra tutti gli uomini percheacute uccise lrsquoassassino del padre Egisto esperto di inganni che gli uccise il nobile padre 300 Anche tu caro infatti molto bello e grande ti vedo sii valoroso percheacute ti lodi anche qualcuno dei posteri Ma io tornerograve adesso alla nave veloce dai compagni che forse impazienti mi aspettano Tu devi pensarci da te dammi retta 305
[Tr di GA Privitera] Le stranezze non mancano davvero e cosigrave sono state messe a fuoco da Stephanie West nel suo commento23 1 Atena sa evidentemente molto piugrave di quanto uno come Mente avrebbe potuto sapere in particolare ella sa che i proci ignoreranno lrsquoinvito di Telemaco a lasciare la sua casa e fatto piugrave importante che gli degravei tra breve ricondurranno in patria Odisseo A queste osservazioni si puograve replicare con la stessa West che laquosi sono esagerate difficoltagrave e
23 Omero Odissea I cit 219 ss
Letteratura greca [1]
28
incongruenze alle quali un pubblico di ascoltatori (o anche un lettore moderatamente attento) probabilmente non farebbe casoraquo 2 Il progetto di una pubblica denuncia dei proci dinanzi agli degravei e agli uomini ai vv 273-274 egrave ciograve che Atena sembra prefiggersi nel promuovere lrsquoassemblea degli Itacesi (assemblea che effettivamente avragrave luogo a principio del canto II) drsquoaltra parte le successive istruzioni di AtenaMente ai vv 295 s (medita come uccidere i pretendenti) presuppongono che di quella richiesta da formulare nel corso dellrsquoassembla essi non terranno alcun conto Anche a questa osservazione si puograve rispondere che laquoegrave ragionevole attendersi che Telemaco condivida la previsione di un esito negativo della sua iniziativaraquo e si puograve aggiungere che pure in caso di insuccesso il ricorso allrsquoassemblea potrebbe ottenere almeno il risultato di screditare i pretendenti presso la comunitagrave itacese legittimando un successivo ricorso alla violenza (e si tratta di una legittimazione di cui anche lrsquoultimo canto mostreragrave lrsquoesigenza) 3 Dopo che Telemaco aveva detto che la madre non intendeva risposarsi (vv 249-250) AtenaMente si esprime ai vv 275-278 come se Penelope desiderasse proprio nuove nozze e inoltre sarebbe assurdo che il padre di Penelope cominciasse a contrattare un secondo matrimonio prima del ritorno di Telemaco dal suo viaggio e che mettesse mano a preparativi che rischierebbero di essere annullati qualche tempo dopo con inevitabile imbarazzo se Telemaco venisse a sapere che Odisseo egrave ancora vivo In piugrave lrsquoandamento sintattico di questi versi presenta un anacoluto durissimo per cui a principio del v 275 lrsquoaccusativo μητέρα egrave seguito da un ἂψ ἴτω (laquovada indietroraquo laquotorniraquo) che richiederebbe come soggetto un nominativo μήτηρ Come hanno reagito i lettori di Omero Nellrsquoantichitagrave un grammatico rimasto anonimo cambiava come attesta uno scolio μητέρ᾽ in μήτηρ nel secolo XVIII Richard Bentley modificava ἴτω in ἴμεν (infinito eolico di εἶμι laquovadoraquo) nel XIX un altro grande della filologia europea Gottfried Hermann risolveva piugrave drasticamente la questione eliminando il complesso dei vv 275-278 e la stessa West mostra simpatia per tale proposta supponendo laquounrsquoaggiunta posteriore modellata sul corrispondente passo del libro IIraquo (dove i vv 196 s sono identici ai vv 277 s e il v 195 copre lo stesso contenuto dei vv 275 s) Si tratta di procedimenti adeguati ai dati di fatto Migliorano davvero il testo che ci egrave stato tramandato In realtagrave ambedue le ldquocorrezionirdquo appena ricordate (di μήτερ᾽ e di ἴτω) ottengono un risultato tanto lineare che egrave davvero difficile pensare che lrsquoanacoluto avrebbe potuto invadere tutta la tradizione se non fosse stato originario e quanto allrsquoespunzione dei vv 275-278 essa indubbiamente peggiorerebbe il ritmo del discorso determinando lrsquoavvicinamento fra i due versi (v 271 e v 279) molto simili fra loro che aprono le due sequenze occupate dai consigli di Mente E allora La via piugrave saggia egrave senzrsquoaltro quella di tenerci qui come quasi sempre di fronte al testo omerico contraddizioni e anacoluti riconoscendo in essi lrsquoeffetto dellrsquoattivitagrave di un cantore che pur sulla base di una traccia largamente memorizzata restava pur sempre legato a quella prassi orale per cui composizione ed esecuzione tendevano a coincidere E lrsquoanacoluto si spiega bene se cerchiamo di immedesimarci nel procedimento seguito dal poeta Egli ha affidato ad Atena un certo flusso argomentativo per cui la dea deve dar consigli a Telemaco sui suoi rapporti coi proci e con la madre e cosigrave colloca in fine di v 274 un ἄνωχθι (laquoordinaraquo) destinato a reggere gli accusativi simmetricamente dislocati in principio di verso (vv 274 e 275) μνηστῆρας e μητέρα Senoncheacute giunto a questa seconda parte dellrsquoargomentazione egli si avvede quanto sarebbe illogico che Telemaco sollecitasse la madre a nuove nozze di qui lrsquoimprovviso cambio di costruzione che svincola al prezzo di una sensibile slogatura sintattica lrsquoipotesi delle nuove nozze dallrsquoordine impartito a Telemaco e la prospetta invece come un desiderio eventuale della stessa Penelope Il poeta ha un progetto ben meditato brani e sequenze piugrave volte sperimentati ed egrave col supporto di questi materiali giagrave elaborati che egli si fa strada attraverso le insidie della
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
5
Anche in questa fase dellrsquoagone gli Elleni sbalorditi applaudivano Omero percheacute i versi erano superiori ad ogni aspettativa e chiedevano che gli assegnassero la vittoria Il re perograve incoronograve Esiodo dichiarando che era giusto che vincesse chi esortava allrsquoagricoltura e alla pace e non colui che narrava guerre e stragi
[Tr di F De Martino]13 LrsquoOmero della leggenda biografica (ne diamo qualche cenno prendendo come base la biografia falsamente attribuita ad Erodoto)14 si sarebbe chiamato Melesigene (laquoNato presso il Meleteraquo) e sarebbe nato a Smirne da una certa Creteide di Cuma resa incinta da uno sconosciuto e condotta dal padre adottivo (Cleanatte di Argo) presso un suo amico a Smirne appena fondata Da giovane Melesigene (che non egrave nato cieco) apprende i rudimenti dellrsquoarte epica da un certo Femio un maestro di cui eredita la scuola quindi srsquoimbarca sulla nave di un certo Mente di Leucade per conoscere il mondo e arriva (dopo aver visitato Etruria e Spagna) anche a Itaca dove si ammala e abbandonato da Mente viene ospitato dallrsquoitacese Mentore Ripreso il mare con Mente (tornato a Itaca a prelevarlo) a Colofone perde la vista (di qui piugrave tardi il soprannome di Omero in quanto ὁ μὴ ὁρῶν laquocolui che non vederaquo laquociecoraquo)15 Fatto ritorno nella nativa Smirne inizia il mestiere di poeta ha successo ma presto cade in miseria e decide di trasferirsi a Cuma dove (dopo un soggiorno in una colonia cumana presso il cuoiaio Tichio) recita i suoi versi nei ritrovi degli anziani La sua fama si diffonde al punto che Melesigene chiede di esser mantenuto a spese pubbliche Di fronte al rifiuto del Consiglio cittadino maledice Cuma e si trasferisce prima a Focea dove declama di nuovo i suoi poemi nelle sale pubbliche poi a Eritre e a Chio dove intende vendicarsi di un certo Testoride che a Focea gli aveva promesso cibo e alloggio in cambio del lascito ereditario dei poemi e invece era fuggito alla volta di Chio dopo averli trascritti sotto dettatura Ma a Chio MelesigeneOmero si smarrisce fincheacute arriva alla masseria di un pastore di capre di nome Glauco che lo conduce presso il suo signore a Bolisso Qui egrave assoldato come precettore e per i figli di costui posti sotto le sue cure compone fra lrsquoaltro la Batracomiomachia Indi si reca nella capitale dellrsquoisola apre una scuola di versificazione prende moglie (da cui ha due figlie) e intanto continua a lavorare a Iliade e Odissea Riprende i viaggi approdando prima a Samo e poi a Ios dove si ammala e giace infermo sulla spiaggia qui alcuni giovani pescatori gli propongono lrsquoindovinello dei pidocchi (laquoquanto prendemmo lasciammo ciograve che non prendemmo portiamoraquo) giagrave noto a Eraclito (22 B 56 D-K) e muore per la rabbia di non aver saputo risolverlo o per la fiacchezza (come lrsquoautore della biografia preferisce immaginare) Non sono mancati tentativi fra cui si distingue per acume quello compiuto da Wolfgang Schadewaldt16 di estrarre dalle Vite superstiti unrsquoimmagine di Omero almeno significativa per la comprensione del mestiere dellrsquoaedo nellrsquoVIII-VII secolo aC17 Senoncheacute come egrave stato
13 Omero quotidiano Vite di Omero Venosa Edizioni Osanna 1984 14 Molto dibattuta egrave la questione della data di origine della biografia pseudo-erodotea ma il testo che possediamo rappresenta probabilmente la piugrave tarda rielaborazione di un racconto composto nel V-IV secolo aC verosimilmente ndash come suppose F Jacoby (Kleine philologische Schriften I Berlino 1961 11 s) ndash un prodotto di cultura sofistica comparabile con il Certamen di Alcidamante 15 Senoncheacute ὅμηρος egrave parola greca e significa laquoostaggioraquo e in effetti testimonianze epigrafiche provano che in etagrave arcaica genitori greci potevano dare al proprio figlio questo nome 16 Homer und sein Jahrhundert in Id Von Homers Welt und Werk Stoccarda 19593 87-129 17 Per Eratostene Omero sarebbe stato contemporaneo della guerra di Troia da lui datata al 1194-1184 invece per Erodoto (II 53) Omero ed Esiodo sarebbero stati coetanei e sarebbero vissuti circa 400 anni prima di lui cioegrave alla metagrave del IX secolo (II 53 2 laquoRitengo che Esiodo e Omero mi abbiano preceduto in etagrave di quattrocento anni e non di piugrave Sono essi ad aver composto per i Greci una teogonia dando agli dei epiteti dividendo gli onori e le competenze indicando le loro formeraquo [tr di A Fraschetti] Lrsquoanonimo autore di un epigramma (AP XVI 298) dice che sette cittagrave (Smirne Chio Colofone Itaca Pilo Argo Atene) si contendevano i suoi natali
Letteratura greca [1]
6
opportunamente osservato18 non solo la maggior parte delle vicende di questa ldquobiografiardquo egrave desunta proprio dai poemi omerici e specialmente dallrsquoOdissea e non solo contiene molti elementi manifestamente ridicoli ma soprattutto laquolrsquoOmero di questa leggenda egrave un cantore mendicante cieco che si intrattiene con gente semplice con calzolai pescatori e vecchi nei ritrovi delle cittagrave portuali un precettore che insegna a leggere e a scrivere e che dunque ha rapporti soprattutto con fanciulli un estemporaneo coniatore di versi ammirato soltanto dalla piccola borghesia e una sola volta nellrsquoepisodio del signore di Bolisso in contatto con il ceto elevato davanti alle cui case del resto egrave solito andare a mendicare doni con canzoni da lui stesso composte [] Chi ha delineato questrsquoimmagine di poeta ndash non importa se con intenzioni parodistiche o meno ndash aveva davanti a seacute un compositore di versi collocato nella fascia bassa di un certo ceto professionale che si egrave potuto sviluppare in questa forma solo quando i commerci e gli affari le cittagrave e le comunitagrave avevano raggiunto una piena fioritura scalzando lrsquoantica struttura aristocratica della societagrave quando cioegrave giagrave dominava la borghesia e si richiedeva piugrave spirito imprenditoriale (si pensi alla fondazione di scuole) che beni patrimoniali La condizione professionale dei rapsodi era questa artisti di declamazione paragonabili ai nostri cantanti da concerto che allora come oggi andavano in tourneacutee e che si caratterizzavano per recitare non opere da loro stessi composte ma solo grandi capolavori altrui La leggenda di Omero attribuisce questa vita di rapsodo anche al grande poeta dellrsquoetagrave arcaica i creatori di tale leggenda non conoscevano infatti al loro tempo un altro tipo di aedoraquo Dunque gli antichi non conoscevano nulla di definito sulla vita e sulla personalitagrave di Omero ciograve che possiamo ricostruire si deve basare da un lato sul modello di aedo quale emerge dai poemi (e quale piugrave sopra abbiamo cercato di sintetizzare) dallrsquoaltro su una ricognizione degli elementi costitutivi dellrsquoarte epica Il verso dellʼepica Lrsquoesametro (giagrave Erodoto usa per lrsquoesametro dattilico espressioni come ἐν ἑξαμέτρῳ τόνῳ [I 47 2] e ἐν ἔπεσι ἑξαμέτροισι [VII 220 3]) si presenta esteriormente come una successione di sei dattili di cui lrsquoultimo catalettico (con la possibilitagrave per lrsquoultimo elemento in virtugrave della pausa di fine di verso di essere realizzato indifferentemente da sillaba breve o lunga u) Le due brevi dei singoli dattili potevano essere ldquosostituiterdquo da una lunga costituendo uno spondeo (di qui la denominazione per ciascun elemento in posizione pari di biceps y) una facoltagrave molto ridotta nel quinto dattilo che si presenta generalmente in forma pura (le eccezioni sono allincirca di un caso su 18 versi) Il verso appare articolato attraverso punti di incisione le cosiddette laquocesureraquo (τομαί laquotagliraquo) le piugrave frequenti interessano il terzo metro venendo a cadere o dopo il suo elemento lungo (cesura maschile o pentemimere laquodopo il quinto mezzo piederaquo) o tra le due brevi del biceps (cesura femminile o trocaica) piugrave rara la cesura dopo il quarto elemento lungo (eftemimere laquodopo il settimo mezzo piederaquo) e subordinata ad altra cesura principale quella dopo il secondo elemento lungo (tritemimere laquodopo il terzo mezzo piederaquo) Fine di parola puograve ricorrere anche dopo il quarto dattilo (dieresi [διαίρεσις laquodivisioneraquo] bucolica cosigrave denominata dal largo uso che ne faranno i poeti bucolici drsquoetagrave ellenistica) Di qui lo schema seguente
a1 a2 m f r b ndash y ndash y ndashkk ndash y ndash kk ndash u
18 J Latacz Omero il primo poeta dellrsquoOccidente (1989) Laterza Roma-Bari 1990 28 s
Letteratura greca [1]
7
dove a1 e a2 segnalano allrsquointerno della prima metagrave del verso le posizioni che in alternativa reciproca tendono a coincidere con fine di parola m e f le posizioni della cesura principale rispettivamente maschile o pentemimere (m) e femminile o trocaica (f) r la posizione della cesura eftemimere b la posizione della dieresi bucolica Viene evitata la fine di parola dopo il terzo metro cosigrave da escludere una bipartizione simmetrica del verso Un punto in cui la fine di parola egrave tendenzialmente evitata egrave quello dopo la prima breve del quarto biceps come fu osservato da G Hermann (donde lrsquoetichetta di laquoponte di Hermannraquo) Solo con Callimaco si afferma anche il divieto che una parola che inizi nel primo metron termini con la prima breve nel secondo biceps (laquoprima legge di Meyerraquo)
PER SAPERNE DI PIUrsquo Teorie sullrsquoorigine dellrsquoesametro Sul problema dellrsquoorigine dellrsquoesametro le teorie si sono succedute numerose allrsquointerno della fondamentale contrapposizione fra chi ha individuato nella sua struttura il risultato della fusione fra preesistenti unitagrave minori e chi invece come Hoekstra (1981) ne ha proposto unrsquointerpretazione fin dallrsquoorigine unitaria Ad es Th Bergk (1854) riconduceva la genesi dellrsquoesametro a due cola lirici preesistenti Wilamowitz (1884) ne faceva il risultato della lunga evoluzione di una struttura lirica avvenuta in parallelo col passaggio dalla canzone lirica (eolica) al laquopiccolo eposraquo e da questo al laquogrande eposraquo A Meillet (1923) postulava unrsquoereditagrave pre-greca (egea) Piugrave recentemente un ritorno alla posizione di Bergk si egrave avuto da parte di ML West (1973) con lrsquoipotesi di una derivazione dellrsquoesametro dallrsquoassociazione fra un hemiepes e un prosodiaco e alla posizione di Wilamowitz nel senso dellrsquoevoluzione di un ferecrateo espanso con lrsquoinserzione centrale di tre dattili con G Nagy (1974) B Gentili (1977) ha cercato di rintracciare coincidenze fra i segmenti costitutivi dellrsquoesametro e i cola della poesia lirica drsquoetagrave arcaica partendo dal dato per cui gli schemi metrici che appaiono in alcune iscrizioni arcaiche e nella lirica di Stesicoro (hemiepes enoplio reiziano coriambico adonio etc) sono gli stessi che sembrano plasmare tutte le formule piugrave tradizionali dellrsquoesametro omerico (per unrsquoesposizione sintetica di questa teoria cfr B Gentili-L Lomiento Metrica e ritmica Storia delle forme poetiche nella Grecia antica Milano Mondadori Universitagrave 2003 pp 279-283)
La formularitagrave Il fenomeno della formularitagrave si puograve definire come la ripetizione di versi interi o di segmenti di versi specialmente nellrsquoambito di situazioni tipiche ad es per laquoquando sorse lrsquoauroraraquo troviamo usato per due volte nellrsquoIliade e in ben venti casi nellrsquoOdissea il verso
ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς e quando mattutina apparve Aurora dalle dita di rosa
Ma il caso piugrave comune di formularitagrave egrave quello rappresentato dai nessi standardizzati nomeepiteto come quelli che vengono applicati ai rispettivi protagonisti dei due poemi πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς (31 volte) e πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς (38 volte) ambedue formule clausolari ma di diversa estensione poicheacute (se riandiamo allo schema riprodotto al paragrafo precedente) esse arrivano entrambe alla fine del verso ma partendo la prima da r la seconda da f Esempi
Letteratura greca [1]
8
r Iliade I 58 τοῖσι δrsquo ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς f Odissea VIII 97 Ὣς ἔφατrsquo οὐδrsquo ἐσάκουσε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς Piugrave in particolare se consideriamo le singole articolazioni minori del verso riscontriamo che a) nel segmento iniziale si incontrano con alta frequenza brevi nessi che contengono congiunzioni pronomi e particelle connettive o avversative ad es fino ad a1 () αὐτὰρ ὁ δή ποτε ὣς τότε καὶ τότε ὣς ὁ μέν fino ad a2 () αὐτὰρ ἐπεί ἀλλ᾽ ὅτε δή ἔνθ᾽ ἄλλοι τοὶ μὲν ἔπειτ᾽ b) nel segmento centrale che va da m o da f fino a r o a b compare spesso il predicato verbale su cui gravita la frase (si veda a titolo di esempio il verso di Iliade sopra citato nel quale μετέφη si estende appunto da m a r) m r Iliade I 58 τοῖσι δrsquo ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς c) il segmento finale (a partire da r o da b) rappresenta il piugrave ricco serbatoio di nessi formulari innanzi tutto come nel caso di πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς le formule nome proprioepiteto ma anche molti casi di associazione fra nome comune ed epiteto ad es ξίφος ἀργυρόηλον φόρμιγγα λίγειαν πατρίδος αἴης θούριδος ἀλκή μώνυχες ἵπποι ὀξέϊ χαλκῷ πότνια μήτηρ Le formule tendono a organizzarsi in sistemi caratterizzati dalle tendenze complementari allrsquoestensione e allrsquoeconomicitagrave a) il principio dellrsquoestensione si connette alla tendenza dellrsquoepica a produrre nessi formulari atti a coprire tutto ciograve che nella narrazione sia tipico costante ripetitivo e a dislocare le formule coprendo le varie partizioni del verso ad es per Ettore troviamo tre formule finali di diversa estensione (φαίδιμος Ἥκτωρ κορυθαίολος Ἥκτωρ e μέγας κορυθαίολος Ἥκτωρ e una formula iniziale (Ἥκτωρ Πριαμίδης) b) il principio complementare al primo dellrsquoeconomia (o del risparmio) corrisponde al fatto che per esprimere una medesima idea essenziale esiste generalmente nella dizione epica una e una sola espressione che occupi una determinata unitagrave minore del verso Casi come μελαινάων ἐπὶ νηῶν e ἐϋσσέλμων ἐπὶ νηῶν sono doppioni apparenti hanno sigrave la stessa misura metrica ma iniziano lrsquouno in consonante con la connessa possibilitagrave di evitare lo iato o di allungare la sillaba precedente lrsquoaltro in vocale Non mancano tuttavia vere eccezioni come per lrsquohemiepes iniziale νῆας ἐπ᾽ Ἀργείων di Iliade XXIV 298 rispetto al consueto νῆας ἐπὶ γλαφυράς (16 volte) Lrsquouso di formule e soprattutto di sistemi formulari rappresentava per il poeta epico una facilitazione nel comporre improvvisando ma nella lunga evoluzione dellrsquoepica e specialmente al momento della definitiva fissazione di poemi monumentali come lrsquoIliade e lrsquoOdissea la
Letteratura greca [1]
9
sempre piugrave estesa memorizzazione di ampie zone di testo il lavorio di riflessione sui singoli episodi e sui nessi e i parallelismi fra gli episodi stessi e la scoperta di inedite possibilitagrave espressive connesse alla modificazione di formule tradizionali dovettero incoraggiare i poeti a uno sfruttamento consapevole e artisticamente meditato del ldquogioco delle formulerdquo Da un lato procedimenti come lrsquoaddensamento degli epiteti la sostituzione di un epiteto convenzionale con uno non convenzionale (con la creazione di un nesso nuovo di struttura metrica eventualmente diversa) il trasferimento di un epiteto da un referente a un altro creano nei poemi una continua tensione tra formularitagrave e superamento della formularitagrave dallrsquoaltro la rete delle corrispondenze a distanza generata dalla ripetizione di un determinato modulo permette al poeta di variare e approfondire un motivo e di sottolineare i parallelismi o le dissonanze fra determinate situazioni La guerra di Troia Schliemann e la riscoperta di Troia In etagrave moderna la riscoperta della cittagrave di Troia situata sullrsquoodierna collina di Hissarlik e sovrastante la bassa pianura attraversata dallo Scamandro a sud del promontorio del Sigeo si lega agli scavi di Heinrich Schliemann (1822-1890) che a partire dal 1866 si dedicograve al disseppellimento delle rovine di Micene di Tirinto e di altri siti micenei e appunto di Troia Nel corso del tempo si egrave venuta creando attorno alla personalitagrave di questo archeologo dilettante una sorta di leggenda a cui egli stesso contribuigrave con le autobiografie Ilios (1881) e Troja (1884) nel senso di un dilettantismo romantico di scavi avventurosi condotti con sorprendenti successi ma senza alcun rigore di metodo di un amore cieco e totale per Omero e per lrsquoEllade E in effetti oggi sappiamo che lrsquoaver percorso la Grecia e lrsquoAsia minore sulle vie di Omero non impedigrave a Schliemann a Micene di attribuire allrsquoepoca di Agamennone tombe anche di quattro secoli piugrave antiche neacute a Troia di identificare con la cittagrave omerica uno strato risalente a una fase che va dal 2300 al 2100 aC Errori del genere non dipesero tuttavia da un entusiasmo velleitario quanto dalla carenza allrsquoepoca di competenze archeologiche che potessero orientarlo verso una piugrave plausibile cronologia di reperti e di strati Occorre poi tener conto che lo strato dei materiali riferibili alla Troia omerica (o almeno a quella che oggi noi identifichiamo con la cittagrave omerica Troia VIIa) era conservato unicamente nel suo margine esterno dato che gli strati superiori della collina di Hissarlik (con le fondamenta dei palazzi e dei templi) erano stati demoliti in epoca ellenistica per realizzare il terrazzamento del suolo su cui vennero edificati nuovi templi Fu soprattutto per questa ragione che Schliemann si spinse con le proprie maestranze a scavare sempre piugrave in profonditagrave saltando gli strati del secondo millennio Dove perograve il problema consisteva nellrsquoidentificazione di un sito sulla scorta della comparazione fra gli antichi racconti e il panorama attuale Schliemann conseguigrave notevoli successi in primo luogo identificando con la collina di Hissarlik quellrsquoacropoli omerica che lrsquoopinione comune dalla fine del XVIII secolo individuava invece nel villaggio di Bunarbaschi situato su un colle a 15 km dal promontorio del Sigeo e la disputa era stata viva giagrave nellrsquoantichitagrave Ellanico di Lesbo verso il 400 aC aveva sostenuto nei suoi Troica che la Ilio del suo tempo sorta presso la collina di Hissarlik e la Ilio omerica occupavano lo stesso sito invece Demetrio di Scepsi (fr 26 Gaede) si era pronunciato per una collina a circa 9 km a sud sullrsquoaltra riva dello Scamandro La missione americana guidata nel 1932-1938 da CW Blegen e le piugrave recenti indagini sul territorio hanno offerto un quadro molto piugrave articolato e differenziato Sulla base di un nuovo diagramma la cittagrave che sorgeva al momento in cui Eratostene di Cirene fissava la caduta di Troia (1184) viene a coincidere con Troia VIIa non piugrave con quella che Schliemann chiamava laquoterza cittagraveraquo (corrispondente a Troia II) ma nemmeno come voleva W Doumlrpfeld con Troia VI (andata in rovina verso il 1300 in seguito a un terremoto) Gli scavi piugrave recenti Secondo le conclusioni di Manfred Korfmann (cfr Korfmann 2002) che ha diretto lrsquoeacutequipe dellrsquoUniversitagrave di Tubinga negli scavi piugrave recenti lrsquoantica Troia intorno al 1184 cessograve di essere abitata ma lrsquoinsediamento continuograve nellrsquoarea della rocca per circa due secoli dopo la distruzione
Letteratura greca [1]
10
della cittagrave (Troia VIIb) Verso il 700 il luogo chiamato laquoIlioraquo era largamente in rovine anche se in etagrave arcaica dovette continuare a essere frequentato come luogo di culto Il problema che si dovettero porre nellrsquoVIII secolo aC lsquoOmerorsquo o i suoi modelli dovette essere quello di rendere il racconto della guerra di Troia plausibile a un pubblico che aveva familiaritagrave con la geografia locale (lrsquoIliade offre indicazioni realistiche ad es sulla navigazione dellrsquoEgeo in IX 362 s e sulla visibilitagrave dellrsquoisola di Samotracia dalla piana di Troia in XIII 11-14) che si trattasse di genti che risiedevano nel Sigeo o in altre cittagrave vicine o di abitanti della stessa Ilion che nellrsquoVIII secolo era di nuovo attiva sia pure soltanto come centro cultuale Il santuario sorgeva allrsquointerno di una depressione naturale a sud-ovest della rocca lungo la vecchia via che conduceva alla rocca stessa Omero menziona due templi quello di Apollo e quello di Atena e le loro loro rovine sono tuttora riconoscibili I visitatori che giungevano al santuario dal Sigeo attraverso la piana dello Scamandro potevano vedere le rovine della rocca Ma - ci si chiede - quando ebbe fine il nucleo della cittagrave di Troia cantata da Omero Nel bastione a nord-est della rocca egrave stata trovata una larga e profonda cisterna con un condotto che proviene da una sorgente La sorgente fu abbandonata al piugrave tardi al tempo di Troia VIIb2 prima del 1100 A partire dal 1000950 non rimase a Troia alcun insediamento significativo Troia era molto piugrave larga di quanto ritenesse Schliemann Un fossato largo 3 m e profondo 15 completato durante lrsquoultima fase di Troia VI o al principio di Troia VIIa (cioegrave intorno al 1300) la circondava Poi esso fu rimpiazzato a sud da un fossato piugrave ampio e concentrico al primo completato verso il 1200 Il sistema di fortificazione si estendeva per quasi 2 km e pertanto racchiudeva unrsquoarea di circa 270000 m2 La rocca e la cittagrave bassa dovevano presentarsi al tempo di Omero come un imponente complesso di rovine I nuovi colonizzatori del Sigeo e di altri siti incontrarono un vasto campo attraversato da sentieri che seguivano i vecchi tracciati Negli scavi fatti nei quartieri della cittagrave bassa a sud-ovest della rocca poco fuori del muro si egrave scoperto un deposito bruciato verso la fine di Troia VI e di nuovo verso la fine di Troia VIIa (verso il 1200) La prima devastazione egrave da ricollegarsi a un terremoto ma la seconda sembra dovuta a unrsquoazione di guerra come suggerisce anche il rinvenimento di corpi insepolti o semisepolti e di depositi contenenti armi non utilizzate Verso il 1300 la porta principale di Troia era stata bloccata e ostruita percheacute qui lrsquoantico muro era in condizioni precarie e pertanto rappresentava lrsquoanello piugrave vulnerabile nel sistema di difesa Giagrave W Doumlrpfeld aveva richiamato Iliade VI 433 s (Andromaca a Ettore)
Piazza lrsquoesercito presso il fico selvatico dove egrave piugrave facile Lrsquoaccesso alla cittagrave e il superamento delle mura
In questa zona solo poco piugrave di 80 m separavano il muro della cittagrave bassa dal muro della rocca Gli epiteti omerici di Troia - laquoben costruitaraquo laquofertileraquo laquovastaraquo laquosacraraquo laquoertaraquo laquoventosaraquo laquodalle belle muraraquo laquodai bel puledriraquo - si adattano ai dati topografici ossa di cavalli sono state trovate sul terreno forti venti soffiano continuamente in estate Anche le sorgenti sono identificabili presso la porta principale cfr Iliade XXII 145-157
Passarono oltre il posto di vedetta e lrsquoalbero di fico battuto dal vento e allontanandosi sempre piugrave dalle mura si lanciarono lungo la strada Giunsero alle fontane dalle belle acque dove sgorgano due correnti dello Scamandro impetuoso una di acqua calda da cui si leva un vapore come da fuoco ardente lrsquoaltra che in piena estate versa acqua gelata come la grandine la fredda neve o il ghiaccio Vi sono accanto dei lavatoi di pietra larghi belli dove le mogli e le belle figlie dei Teucri lavavano le splendide vesti prima in tempo di pace prima che giungessero i figli dei Danai
[Tr di MG Ciani] In effetti gli scavi nellrsquoarea della caverna in cui egrave situata la sorgente hanno portato alla luce una struttura simile a una miniera con tre gallerie e altri bracci tributari creata per fornire acqua Lrsquoacqua scorreva attraverso una superficie rocciosa e poi in un canale artificiale che a sua volta raggiungeva un sistema di quattro lsquodepressionirsquo o lsquofossersquo circolari scavate nella roccia della
Letteratura greca [1]
11
misura di quasi 1 m di diametro (appunto parrebbe i πλυνοί hellip λαΐνεοι i laquolavatoi di pietraraquo ricordati da Omero) Achei e Troiani Fra XIII e XII secolo aC Troia era un grande centro politico e commerciale in grado di controllare lrsquoaccesso ai Dardanelli (lrsquoantico Ellesponto) e il trasporto su terra di beni di vario genere dalla costa egea al Mar di Marmara (lrsquoantica Propontide) e al Mar Nero In Troia VIIa egrave stata rinvenuta ceramica micenea del periodo noto come Tardo Elladico IIIB che egrave anche il periodo di maggiore splendore dei palazzi micenei sul continente greco Ersquo suggestiva lrsquoidentificazione piugrave volte avanzata in tempi recenti di TroiaIlio con Wilusa la cittagrave menzionata spesso in testi hittiti e oggetto di contesa fra gli Hittiti e quegli Ahhiyawa il cui nome sembra identificarsi con quello degli laquoAcheiraquo (Ἀχαιοί) Il documento piugrave significativo in proposito egrave il preambolo del trattato stipulato verso il 1280 aC fra il re hittita Muwattali II e Alaksandu re di Wilusa che contiene un richiamo alle precedenti relazioni fra i due stati a partire dal 1600 pur ricordando che un tempo Wilusa era sotto il dominio hittita Muwatalli afferma di aver mantenuto relazioni pacifiche anche dopo che la cittagrave era divenuta indipendente Inoltre un testo religioso hittita rinvenuto a Hattusa la capitale dellrsquoimpero hittita e databile al XIII secolo ricorda nellrsquoambito di un rituale la recita di un poema in luvio (il luvio egrave una lingua indo-europea che si distingue solo superficialmente dallrsquohittita) di cui viene riportato il primo verso laquoQuando tornarono dallrsquoerta Wilusaraquo E a Troia negli scavi piugrave recenti egrave stato trovato un sigillo con unrsquoiscrizione in luvio Drsquoaltra parte in Omero la dinastia reale troiana di cui egrave a capo Priamo figlio di Laomedonte viene fatta risalire attraverso Erittonio Troo e Ilo fino a Dardano eponimo dei Dardani che si erano stanziati nella Troade a nord del monte Ida (Iliade ΧΧ 215 ss) I Dardani nellrsquoIliade compaiono fra i principali alleati dei Troiani accanto ai contingenti provenienti da Zelea (a nord-est lungo il fiume Esepo) e a quelli di localitagrave situate sulla Propontide come Adrestea e Pitea e sulla costa asiatica dellrsquoEllesponto come Abido e Arisbe Dalla costa europea arrivano invece i Traci i Ciconi e i Peoni da oriente i Paflagoni e gli Alizoni da sud-est i Misi e i Frigi dalla zona sud-occidentale dellrsquoAnatolia i Meoni i Cari e i Lici Se Dardani Peoni Ciconi e Traci fanno parte delle popolazioni traco-frigie che fra XII e XI secolo erano scese dai Balcani in direzione dellrsquoAnatolia (cfr Erodoto 7 73 e Xanto di Lidia FGrHist 765 F 14) i Meoni sono di stirpe lidia mentre i Cari e i Lici appartengono allrsquoambito culturale e linguistico luvio-hittita Comunque sia diversamente che per Erodoto il quale inserisce il rapimento di Elena nel quadro di una serie di torti reciproci in forma di rapimenti di donne fra Greci e barbari (I 2 1) e per i poeti tragici ateniesi del V secolo aC in Omero lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato come un contrasto fra culture diverse I Troiani mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei (detti anche laquoDanairaquo - cioegrave discendenti di Danao - o laquoArgiviraquo in relazione al contingente proveniente dallrsquoArgolide guidato da Agamennone il capo della spedizione) e lo stesso vale per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari in Iliade ΙΙ 867 come laquodi lingua stranieraraquo (βαρβαρόφωνοι) suggerisce che un tale epiteto non sarebbe stato applicabile ai Troiani Infine sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di unrsquoimbarcazione sono altrettanti esempi di quelle che W Arend denominograve laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini comportamentali e tecnologiche del gruppo che le condivide (vedi scheda p xxx) La societagrave omerica
Letteratura greca [1]
12
Nel rapporto fra il mondo omerico e la storia egrave innanzi tutto da sottolineare lrsquoesistenza di un duplice piano di riferimento con talune interferenze dellrsquouno nellrsquoaltro da un lato crsquoegrave lrsquoorizzonte dei fatti collocati in un passato glorioso dallrsquoaltro lrsquoorizzonte del poeta Giagrave gli studiosi alessandrini del resto notavano che dati come lrsquoarte di montare a cavallo i segnali per mezzo della tromba e lrsquouso di bollire la carne compaiono nellrsquoIliade solo allrsquointerno delle similitudini E il testo con una sorta di arcaismo intenzionale mostra talora la consapevolezza dellrsquoabisso che separa passato e presente come quando in Iliade XII 445-449 si dice
Ettore intanto un sasso afferrograve ndash e lo portava ndash che prima stava davanti alle porte largo di sotto ma sopra era a punta questo due uomini i piugrave forti del popolo difficilmente isserebbero da terra su un carro quali son ora i mortali egli da solo lo roteava a suo agio
[Tr di R Calzecchi Onesti] Per contro le condizioni sociali rappresentate nei poemi (un mondo di grandi proprietari terrieri che reggono aziende agricole autarchiche da cui hanno preso tuttavia a distaccarsi alcune figure di artigiani il fabbro il vasaio il carpentiere il medico lrsquoindovino lrsquoaedo) rispecchiano assai piugrave la situazione storica fra VIII e VII secolo a C che le strutture della societagrave micenea Inoltre i cadaveri vengono cremati secondo la prassi piugrave recente non inumati anche se molti riferimenti omerici non rispecchiano necessariamente la pratica normale del tempo di pace trattandosi di cremazioni che avvengono oltremare non ambigua egrave comunque la testimonianza relativa alla prassi umana in generale fornita da Odissea XI 216-222 (Anticlea a Odisseo)
Ohimegrave figlio mio il piugrave misero di tutti gli uomini Persefone la figlia di Zeus non ti inganna ma la legge degli uomini egrave questa quando si muore i nervi non reggono piugrave la carne e le ossa ma la furia violenta del fuoco ardente li disfa appena la vita abbandona le bianche ossa e lrsquoanima vagola volata via come un sogno
[Tr di GA Privitera]19 Un esempio significativo di sovrapposizione tra fasi culturali distinte si coglie osservando lrsquoinventario degli oggetti accanto ad armi vasi ornamenti tipici dellrsquoVIII-VII secolo troviamo relitti risalenti allrsquoepoca micenea come la coppa di Nestore ornata di colombe descritta in Iliade XI 632 ss (simile a una coppa drsquoargento rinvenuta a Micene che riproduce disegno e artigianato dellrsquoetagrave del bronzo) lrsquoelmo di cuoio con zanne di cinghiale che Merione dagrave a Odisseo (Iliade X 261 ss) e lo scudo lungo laquosimile a torreraquo di Aiace che egrave di un tipo inusitato dopo il XIII secolo Un oggetto non riferibile neacute al mondo miceneo neacute allrsquoetagrave della fissazione dei poemi bensigrave alla prima etagrave del ferro egrave invece la coppia di aste da lancio adottate verso il 900 aC e scomparse due secoli dopo con lo sviluppo del combattimento oplitico e la reintroduzione dellrsquoasta per colpire e la menzione delle navi fenicie (una volta nellrsquoIliade e cinque volte nellrsquoOdissea) riflette la loro comparsa nellrsquoEgeo nel IX secolo aC Non diversamente sembra avvenire anche per le istituzioni politiche lrsquo ἄναξ egrave visto a volte come figura di autocrate assoluto a volte fortemente limitato dai poteri delle assemblee ndash sia quella dei capi (βουλή) sia quella delle truppe (ἀγορή) ndash o insidiato dallrsquoascesa dei gruppi aristocratici mentre il βασιλεύς non egrave piugrave il dignitario della societagrave micenea ma genericamente un principe o un capo LʼIliade
19 Omero Odissea III intr testo e commento di A Hoekstra tr di GA Privitera Mondadori Milano 1984
Letteratura greca [1]
13
LrsquoIliade (Ἰλιάς) consta di circa 15690 esametri divisi secondo una partizione che potrebbe risalire al primo editore alessandrino (Zenodoto di Efeso) in 24 libri indicati con le lettere maiuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquounitagrave strutturale di parecchi canti che spesso finiscono col tramonto o iniziano con lrsquoalba e la coincidenza fra alcuni dei titoli attribuiti a ciascun canto nelle edizioni alessandrine e quelli che si rintracciano in autori precedenti (ad es Tucidide [I 10 4] cita il ldquoCatalogo delle navirdquo cioegrave il canto II) provano che non si trattograve di una divisione arbitraria bensigrave fondata almeno in certa misura sulle abitudini dei rapsodi Tema dellrsquoopera non egrave lrsquointero assedio decennale di Troia da parte dei Greci (di norma detti Achei o Danai o Argivi) provocato dal rapimento di Elena ad opera di Paride ma una porzione assai limitata del conflitto una sequenza narrativa che copre la durata di 51 giorni e si colloca verso la fine del nono anno di guerra lrsquoira di Achille contro lrsquoAtride Agamennone il suo ritiro dalla guerra e le relative conseguenze la fine dellrsquoira lrsquouccisione e i funerali di Ettore Fu proprio questa delimitazione tematica a consentire la realizzazione di quellrsquounitagrave e compiutezza dellrsquoazione che giagrave Aristotele individuava come uno dei pregi essenziali dellrsquoopera di Omero rispetto agli altri poemi epici arcaici (Poetica 1459a-b)20
anche in questo Omero deve apparire mirabile in confronto agli altri per non aver tentato di rappresentare intera la guerra anche se essa aveva un principio e una fine il racconto sarebbe risultato troppo grande e non abbracciabile con uno sguardo oppure pur misurato nella grandezza intricato per la varietagrave Ricavatane invece una parte ha fatto uso di molti episodi per esempio con il ldquoCatalogo delle navirdquo e con altri episodi fa procedere in lungo il poema Gli altri invece come lrsquoautore delle Ciprie o della Piccola Iliade compongono unrsquoazione multipla su unrsquounica persona o un unico tempo Di conseguenza mentre dallrsquoIliade e dallrsquoOdissea si ricava unrsquounica tragedia o soltanto due da ciascuna dalle Ciprie parecchie
[Tr di D Lanza]21
Canto I Lrsquoazione si apre sul campo degli Achei devastato dalle frecce scagliate da Apollo [T1] il dio ha scatenato una pestilenza percheacute Agamennone ha rifiutato il riscatto offerto dal sacerdote Crise per la liberazione della figlia Criseide divenuta schiava dellrsquoAtride Ai guerrieri convocati in assemblea lrsquoindovino Calcante rivela che la sola via di scampo egrave la restituzione di Criseide al padre Agamennone acconsente ma solo a patto che gli venga data in cambio Briseide la schiava che Achille tiene nella sua tenda come premio personale (γέρας) ricevuto dagli altri guerrieri Achille non puograve opporsi alla prevaricazione dellrsquoAtride ma non egrave disposto a subire passivamente lrsquooltraggio e insulta Agamennone anzi egrave giagrave pronto a estrarre la spada dal fodero per farsi giustizia quando viene trattenuto da Atena apparsa allrsquoimprovviso allora si ritira nella tenda giurando che non combatteragrave piugrave [T2] Quindi invoca la madre Tetide che dopo essere apparsa al figlio sulla riva del mare intercede presso Zeus e ottiene la promessa che i Greci non vinceranno la guerra e non espugneranno Troia fincheacute Achille non riceveragrave soddisfazione per lrsquooffesa subita Ma il piano di Zeus non resta celato ad Era che ingelosita provoca una lite nel corso del banchetto degli dei tuttavia la visione di Efesto zoppicante che funge da coppiere suscita lrsquoilaritagrave dei numi e riporta la serenitagrave Canto II Quella stessa notte Zeus manda ad Agamennone un sogno ingannatore per incitarlo ad attaccare Troia LrsquoAtride riferisce il sogno agli anziani e comanda lrsquoadunata dellrsquoesercito
20 Cfr anche 1462b ταῦτα τὰ ποιήματα συνέστηκεν ὡς ἐνδέχεται ἄριστα καὶ ὅτι μάλιστα μιᾶς πράξεως μίμησις (laquoQuesti poemi sono composti come meglio non si puograve e son il piugrave possibile imitazione di unrsquounica azioneraquo) 21 Aristotele Poetica Milano Rizzoli 19902
Letteratura greca [1]
14
con lrsquoidea stravagante di saggiare lrsquoumore delle truppe proponendo il ritorno in patria Gli uomini incitati da Tersite corrono alle navi pronti a salpare ma vengono bloccati da Odisseo e da Nestore Egrave significativo che Tersite lrsquoanti-eroe riecheggi le accuse di Achille ad Agamennone sottolineando gli onori di cui questi gode e prenda le parti di Achille [T3] Per tutta la seconda parte del libro lrsquoazione viene interrotta per far posto alla grandiosa uscita in armi dellrsquoesercito acheo dal recinto delle navi un quadro scintillante ornato da una catena di sei similitudini concatenate introdotte per illustrare il fulgore delle armi il rombo dei passi umani e degli zoccoli precipitosi lrsquoaspetto della schiera achea e la maestria dei condottieri Un ldquoCatalogo delle navirdquo contiene lrsquoelenco circostanziato delle genti greche che hanno preso parte allrsquoassedio ed egrave seguito da un catalogo piugrave breve e piugrave arido degli alleati dei Troiani accorsi in difesa di Ilio Canto III Lrsquoatteso scontro tra gli schieramenti appena passati in rassegna non ha luogo ParideAlessandro ottiene infatti una tregua per sfidare Menelao Iride la messaggera degli degravei spinge Elena ad accorrere alle mura presso le porte Scee per assistere al preannunciato duello di ligrave Priamo e gli altri anziani di Troia osservano la pianura Su richiesta del vecchio sovrano (una richiesta che sarebbe stata piugrave ldquoverosimilerdquo al primo anno di guerra) Elena nomina i piugrave prestigiosi campioni achei [T4] Nel duello che segue Paride si trova ben presto a mal partito contro Menelao ma Afrodite lo sottrae ai colpi del nemico avvolgendolo in una fitta nebbia e lo riporta nelle sue stanze dove dopo aver assunto lrsquoaspetto di una vecchia filatrice ordina a Elena di giacere con lui Elena si ribella ma la dea non transige Mentre Paride ed Elena si uniscono nellrsquoamplesso Menelao furibondo cerca fra la folla il nemico che sia i Greci che i Troiani sarebbero lieti di consegnargli pur di porre fine alla guerra Agamennone rivendicando la vittoria di Menelao pretende dai Troiani la restituzione di Elena e delle sue ricchezze noncheacute il pagamento di una forte ammenda Canto IV La tregua stipulata dopo la scomparsa di Paride viene infranta dallrsquoarciere Pandaro che sollecitato da Atena (scesa tra le schiere troiane su ordine di Zeus) ferisce con una freccia Menelao questi viene prontamente guarito dal medico Macaone figlio di Asclepio Agamennone passa fra le schiere incitandole a combattere incontra vari capi intenti a dare istruzioni ai propri uomini Solo Ulisse e Menesteo si tengono in disparte ricevendo i rimproveri di Agamennone ai quali Ulisse reagisce con indignazione Gli Achei muovono contro i Troiani con grande ordine e disciplina mentre i Troiani e i loro alleati schiamazzano come barbari Ha inizio la battaglia vera e propria nella quale lrsquoattenzione egrave focalizzata sui duelli individuali Ad assistere e rincuorare i Troiani compare Apollo sulla rocca di Troia mentre Atena infonde coraggio nei Greci Il canto si chiude sullrsquoinfuriare della battaglia la cui descrizione riprenderagrave nel canto successivo Canto V Balza in primo piano Diomede di cui viene presentata lrsquoἀριστεία lrsquoeroe laquoglorioso e chiaroraquo fa strage di nemici imperversando furiosamente fra le schiere troiane Nel pieno del combattimento viene ferito da una freccia scagliata da Pandaro il quale mena gran vanto del colpo andato a segno Diomede ottenuta unrsquoimmediata guarigione grazie allrsquointervento di Atena muove allora contro il nemico che nel frattempo era stato accolto sul carro di Enea Pandaro scaglia la sua lancia contro Diomede ma lo scudo di questi regge il colpo Diomede colpisce a sua volta uccidendo il nemico Enea scende dal cocchio per proteggere il cadavere di Pandaro dagli Achei che vorrebbero farne razzia ma Diomede lo colpisce con un grande masso fratturandogli il femore Enea viene salvato dallrsquointervento di Afrodite che lo avvolge nel suo manto mentre Diomede arriva addirittura a ferire al polso la dea che fugge sullrsquoOlimpo a farsi confortare dalla madre Dione Il figlio di Tideo attacca anche Apollo che aveva sottratto Enea alla sua furia ma
Letteratura greca [1]
15
egrave fermato dal grido di ammonimento del dio Incitati e aiutati da Ares ora i Troiani avanzano con impeto Intervengono Era e Atena e questrsquoultima assume il ruolo di auriga di Diomede Col suo aiuto questi ferisce al ventre Ares che fugge sullrsquoOlimpo Anche le dee vi fanno ritorno Canto VI Il canto VI egrave una naturale continuazione del V (tanto che Erodoto citeragrave come dallrsquoἀριστεία di Diomede un brano della prima parte del VI canto) La battaglia infuria nella pianura ma il furore di Diomede si stempera su una nota di cortesia quando lrsquoeroe dopo aver sfidato Glauco di Licia scopre di avere con lrsquoavversario antichi rapporti di ospitalitagrave I due si scambiano le armature (a detrimento di Glauco a cui laquoZeus Cronide levograve il senno cheacute scambiograve con Diomede Tidide armi drsquooro con armi di bronzo cento buoi con nove buoiraquo [vv 234-6]) Frattanto Ettore su invito dellrsquoindovino Eleno rientra in cittagrave dove le donne devono cercare di ottenere con offerte e voti il favore di Atena e incontra dapprima la madre Ecuba poi Paride (che intende ricondurre alla battaglia) vorrebbe salutare anche la moglie ma non la trova in casa bensigrave alle porte Scee dove Andromaca era accorsa piena drsquoangoscia insieme col figlioletto e con la nutrice Nel colloquio che segue ella lo implora di non esporre al pericolo se stessa e il figlio La replica di Ettore egrave esemplare per capire la prospettiva del poema e le motivazioni dellrsquoagire dei personaggi dominanti se Achille e gli eroi achei in genere cercano onore e gloria a questa motivazione (che pure non egrave assente) Ettore antepone lrsquoαἰδώς il senso di laquovergognaraquo e di responsabilitagrave nei confronti della comunitagrave e del nucleo familiare di cui egrave il difensore Poi si volta per prendere tra le braccia Astianatte ma lrsquoelmo lucente e il cimiero ondeggiante impauriscono il piccolo che si rifugia in seno alla nutrice Alla fine del canto Paride si incontra con Ettore e i due si avviano verso il campo di battaglia [T5] Canto VII A principio del canto VII Atena e Apollo si accordano per indurre Ettore a lanciare una sfida agli Achei per un duello Il sorteggio designa Aiace come campione greco Nello scontro Ettore lancia per primo lrsquoasta che penetra ma senza trapassarlo nello scudo di Aiace greve e massiccio (compaginato con sette strati di pelle bovina simile a una torre) Aiace di rimando lacera lo scudo e il pettorale della corazza ma non riesce a squarciare le carni del nemico percheacute Ettore si piega di lato Allora i due brandiscono di nuovo le aste poi ricorrono alle pietre Alla fine gli araldi arrestano il combattimento con la giustificazione che laquola notte giagrave viene ed egrave bene obbedire alla notteraquo (v 282) Su proposta di Nestore gli Achei decidono per il giorno seguente di seppellire i morti e di scavare una grande trincea difesa da un bastione sul margine del loro accampamento Respingono lrsquoofferta di pace dei Troiani (che prevederebbe la riconsegna dei tesori sottratti da Paride a Sparta) Il mattino seguente i morti vengono cremati e durante la giornata si erige il muro di protezione Canto VIII Nellrsquoassemblea degli degravei Zeus vieta ai numi di appoggiare lrsquouna o lrsquoaltra parte in conflitto Al mattino il combattimento riprende e a mezzogiorno Zeus pone i destini dei due popoli sulla bilancia che piega a favore dei Troiani Sul campo di battaglia Diomede salva Nestore Lrsquoazione di Ettore egrave travolgente fincheacute Zeus contravvenendo alla sua intenzione di favorire i Troiani accoglie la preghiera di Agamennone per risollevare il morale degli Achei che organizzano la difesa delle navi Nel corso degli scontri si segnala lrsquoarciere Teucro che colpisce i nemici muovendosi in sincronia con Aiace Telamonio che lo protegge con lo scudo Incitato da Agamennone egli prova a colpire anche Ettore ma soccombe colpito con una pietra A questa vista Era e Atena corrono ad armarsi per intervenire a favore degli Achei ma vengono distolte dalle minacce di Zeus che manifesta la propria intenzione di favorire i Troiani fino a quando i Greci non saranno ridotti alla disperazione tanto da scongiurare Achille percheacute ritorni Il sopraggiungere della notte
Letteratura greca [1]
16
interrompe i combattimenti Ettore galvanizzato dai successi ottenuti in quel giorno si illude che la vittoria sia a portata di mano e prospetta ai suoi una prossima ritirata degli Achei Il canto si chiude con il banchetto dei Troiani che banchettano nella pianura esaltati dalla speranza di vittoria Canto IX Agamennone affranto propone di fare ciograve che nel canto II aveva suggerito soltanto per mettere alla prova lrsquoesercito interrompere la guerra e tornare in patria Diomede si oppone e Nestore in un consiglio dei capi propone di tentare la riconciliazione con Achille Si invia alla tenda di Achille unrsquoambasceria (composta da Aiace Odisseo e Fenice antico pedagogo di Achille) per offrire doni ricchissimi Achille non cede anzi minaccia di salpare immediatamente verso la patria [T6] Inutilmente Fenice lrsquoantico precettore di Achille cerca di ammorbidire la determinazione del Pelide richiamando la vicenda dellrsquoeroe Meleagro [T7] Gli inviati riferiscono ad Agamennone la risposta di Achille egli torneragrave a combattere solo quando Ettore saragrave arrivato fino alle navi dei Mirmidoni Canto X Nella stessa notte si effettua una missione segreta nel corso della quale Odisseo e Diomede dapprima catturano la spia troiana Dolone (che Ettore aveva inviato alle navi achee promettendogli come ricompensa i cavalli di Achille) poi uccidono il re trace Reso appena arrivato presso i Troiani e ne rubano i magnifici cavalli Giagrave gli antichi ritenevano questo canto unrsquoaggiunta post-omerica e questi dubbi trovano riscontro in lati eccentrici della narrazione e nellrsquoimpiego di un linguaggio che spesso appare svincolato dal corrente repertorio formulare Canto XI Si apre una nuova giornata di battaglia (la cui narrazione si protrarragrave fino al canto XVIII) che ruota intorno allrsquoἀριστεία di Agamennone Quando lrsquoAtride viene ferito gli Achei ripiegano Diomede resta anchrsquoegli ferito Odisseo e Aiace evitano a stento la massa dei nemici Nestore salva sul suo carro Macaone Achille che dalla poppa della nave osserva la battaglia vuol sapere chi egrave condotto via da Nestore e manda Patroclo che viene accolto molto benevolmente e con cui Nestore intrattiene un lungo discorso egli dice di deplorare il comportamento di Achille e con atteggiamento consono alla sua condizione di anziano si dilunga nel raccontare le proprie gesta giovanili Egli esorta quindi Patroclo a far leva sulla sua amicizia per convincere Achille a riprendere il combattimento o - almeno - a concedere a Patroclo le sue armi per incutere timore nei Troiani Eccitato dalle parole del vecchio Patroclo si avvia verso la nave di Achille ma incontra Euripilo ferito che gli chiede aiuto ed egli impietositosi lo accompagna alla tenda e cura la ferita Canto XII Divisi in cinque contingenti i Troiani danno lrsquoassalto al muro eretto a difesa del campo acheo Sul campo di battaglia si manifesta un prodigio unrsquoaquila in cielo con un grosso serpente fra le zampe che riesce a ferire lrsquouccello e a sfuggire Polidamante che interpreta il segno come un presagio funesto consiglia di tornare indietro ma Ettore egrave di altro avviso Sarpedone e Glauco sferrano un attacco contro il muro e - pur rimanendo feriti - riescono ad aprire una breccia La battaglia infuria con esito incerto fincheacute Ettore con un macigno sfonda una delle porte consentendo ai Troiani di entrare in massa nel campo acheo mentre i Greci fuggono verso il mare Canto XIII Zeus distoglie lo sguardo dalla battaglia nella convinzione che nessuno fra gli dei avrebbe osato violare il divieto di intervenire ne approfitta invece Poseidone favorevole ai Greci Assunto lrsquoaspetto dellrsquoindovino Calcante il dio infonde nuovo vigore nei due Aiaci
Letteratura greca [1]
17
spronandoli al combattimento Gli Achei riconoscono lrsquointervento divino e riprendono fiducia I combattimenti si susseguono violentissimi Nella resistenza si distingue il re cretese Idomeneo Polidamante consiglia una seconda volta di interrompere la battaglia e accenna allrsquoimminente intervento di Achille Ettore non ascolta lrsquoammonimento e riprende lrsquoassalto Il canto si chiude con un suo scambio di insulti con Aiace Telamonio Canto XIV Mentre Diomede Odisseo e Agamennone tornano feriti allrsquoaccampamento Era per distogliere Zeus dalla battaglia e consentire a Poseidone di favorire gli Achei indossa la cintura magica di Afrodite e sollecita il consorte a un convegno amoroso sullrsquoIda dopo lrsquoamplesso Zeus cade in un sonno profondo e Hypnos (il Sonno) annuncia a Posidone che potragrave aiutare senza rischi gli Achei Ettore colpito con una pietra da Aiace resta a lungo in stato di incoscienza e i Troiani vengono respinti Canto XV Zeus si risveglia avvedendosi dellrsquoinganno subito e costringe Era a mandargli Iride e Apollo la prima allontaneragrave Posidone dal campo di battaglia Apollo inciteragrave Ettore a far retrocedere gli Achei fino alle navi dei Mirmidoni Riprende lrsquooffensiva troiana Apollo stesso abbatte il muro e scuotendo lrsquoegida atterrisce gli Achei Patroclo corre da Achille mentre i Troiani giagrave sono sul punto di appiccare il fuoco alle navi Canto XVI Patroclo in lacrime supplica Achille di intervenire o di mandare lui stesso al suo posto [T8] Achille gli consegna le proprie armi e gli fa promettere che non si avventureragrave oltre la zona delle navi Ma Patroclo trascinato dal suo stesso impeto oltrepassa il limite prescrittogli da Achille Abbatte Sarpedone figlio di Zeus attorno al cui cadavere infuria la lotta fincheacute Apollo lo sottrae alla mischia e Hypnos e Thanatos (il demone della morte) lo trasportano in Licia sua patria Patroclo continua lrsquoassalto alla testa dei Mirmidoni fin sotto le mura di Troia ma poco prima del tramonto al quarto assalto Apollo stesso assunto lrsquoaspetto di Asio lo percuote fra le spalle allora Euforbo lo colpisce con lrsquoasta ed Ettore lo trafigge Canto XVII Euforbo viene ucciso da Menelao ma Ettore riesce a catturare le armi di Achille indossate da Patroclo Vigorosamente sostenuti da Aiace gli Achei difendono il cadavere Una densa nebbia scende sui combattenti Zeus infonde nuovo ardimento nei cavalli di Achille piangenti per la fine di Patroclo [T9] Atena e Apollo arroventano la lotta attorno alla salma In seguito alla preghiera di Aiace Zeus dissolve la nebbia Menelao manda Antiloco figlio di Nestore a informare Achille della morte di Patroclo la cui salma viene intanto trascinata fuori della battaglia da Menelao e Merione mentre i due Aiaci offrono la necessaria copertura contro la furia incalzante dei nemici Canto XVIII Lo scoppio di selvaggio dolore a cui si abbandona Achille allrsquoudire della morte di Patroclo provoca lrsquoaccorrere dal mare di Tetide insieme con le Nereidi La madre gli promette di procurargli nuove armi Poicheacute la salma di Patroclo egrave tuttora contesa Achille fa la sua apparizione sul fossato e lancia un grido che atterrisce i nemici Efesto su preghiera di Tetide foggia le nuove armi fra cui un magnifico scudo su cui appaiono effigiati in bande concentriche gli aspetti salienti dellrsquoesistenza umana Canto XIX Il mattino seguente Tetide porta le armi al figlio e con lrsquoambrosia preserva la salma di Patroclo dalla decomposizione Achille convoca unrsquoassemblea dellrsquoesercito e rinuncia alla sua collera Agamennone lamenta di essere stato ldquoaccecatordquo da Zeus e promette doni
Letteratura greca [1]
18
riparatori [T10] Achille si lascia convincere a stento ad attendere che i soldati abbiano mangiato Poi gli armati si radunano e anche Achille si arma Il suo cavallo Xanto gli predice la prossima morte [T11] Canto XX Zeus consente agli degravei di partecipare alla nuova battaglia Enea scontratosi con Achille egrave tratto in salvo da Posidone Achille infuria come un incendio in una selva Canto XXI Achille colma di cadaveri il fiume Scamandro e cattura dodici giovani troiani che intende offrire in sacrificio a Patroclo non risparmia neppure Licaone figlio di Priamo che lo supplica con accenti di grande intensitagrave ma altrettanto intensa nella consapevolezza di un destino imminente egrave la pur spietata replica del Pelide [T12] Lo Scamandro solleva le proprie onde ma le fiamme di Efesto inaridiscono il terreno e domano la corrente Gli degravei si azzuffano Atena raggiunge Ares con una pietra Era rintuzza la furia di Artemide Infine tutti tornano sullrsquoOlimpo Apollo assunto lrsquoaspetto di Agenore respinge Achille percheacute i Troiani possano rifugiarsi allrsquointerno delle mura Canto XXII Il solo Ettore resta fuori nella pianura Invano Priamo ed Ecuba lo pregano di rientrare Mentre Achille si avvicina Ettore decide di affrontarlo ma quando quello gli egrave da presso col bronzo che gli lampeggia intorno laquosimile al raggio del fuoco ardente o del sole che sorgeraquo egrave afferrato dal panico e comincia a fuggire compiendo tre giri intorno alle mura Zeus pesa sulla bilancia i destini (le κῆρες) dei due eroi e quello di Ettore affonda in basso Allora Apollo lo abbandona e Atena apparsa a Ettore sotto le spoglie di suo fratello Deifobo gli si avvicina promettendogli aiuto e invece riporta ad Achille la lancia che gli era caduta fuori bersaglio Il colpo di risposta di Ettore rimbalza sullo scudo di Achille Ettore urla a Deifobo di passargli la sua lancia ma il falso Deifobo egrave scomparso ed Ettore comprende di trovarsi sullrsquoorlo dellrsquoabisso [T13] Achille gli trapassa la gola ed Ettore lo supplica di non oltraggiare la sua salma in risposta riceve la minaccia che finiragrave in pasto ai cani Achille trascina il cadavere alle navi attaccato al carro Priamo Ecuba e Andromaca si abbandonano al cordoglio a cui fanno eco le donne troiane Canto XXIII Viene preparato il banchetto funebre in onore di Patroclo la cui ombra nel corso della notte appare ad Achille chiedendo la sepoltura del corpo Il mattino seguente si appresta il rogo fra le offerte votive ci sono anche dodici giovani troiani Il giorno successivo si raccolgono le ossa di Patroclo Seguono i ludi funebri gare coi carri e con lrsquoarco duello in armi etc Canto XXIV Ogni giorno Achille trascina il cadavere di Ettore attorno alla tomba dellrsquoamico ma lo spettacolo offende gli degravei e al dodicesimo giorno Zeus decide di mandare Tetide percheacute induca suo figlio a restituire la salma di Ettore Iride viene inviata presso Priamo percheacute gli consigli di recarsi nel cuore della notte con un carro da trasporto e un copioso riscatto scortato da Ermes alla tenda di Achille Questi accoglie il vecchio con rispetto riconoscendo in lui lrsquoimmagine del padre lontano e si piega alla sua supplica [T14] Per volontagrave degli degravei il cadavere non egrave stato aggredito dalla putrefazione composto sul pianale del carro viene ricondotto dal padre a Troia Qui le lamentazioni rituali srsquoinnalzano dal gruppo delle donne (Andromaca Ecuba Elena) Si stipula una tregua di dodici giorni Per nove giorni i Troiani raccolgono legname poi anche il rogo di Ettore arde e si erige un tumulo
Letteratura greca [1]
19
Struttura e caratteri dellʼopera Poema di trama relativamente organica (soprattutto a partire dal canto XVI tutti gli avvenimenti tranne pochi episodi isolati ruotano attorno ai due principali antagonisti Ettore uccide Patroclo per vendicare Sarpedone e Achille uccide Ettore per vendicare Patroclo) pur se non privo di piugrave o meno cospicue incongruenze spiegabili in primo luogo con la lunga e complessa genesi orale dellrsquoopera lrsquoIliade lascia emergere in mezzo alle centinaia di nomi e alle intricate vicende alcuni caratteri delineati nella loro individualitagrave e innanzi tutto quelli di Achille e di Ettore accomunati dalla medesima coscienza di un destino di morte che sono pronti ad affrontare Appunto una tale attitudine a rappresentare i laquocaratteriraquo (ἤθη) dei suoi personaggi egrave un altro titolo di merito che Aristotele ascrive ad Omero (Poetica 1460a9-11)
dopo aver brevemente proemiato subito introduce un uomo una donna o un altro personaggio nessuno privo di caratterizzazione ma dotato di un carattere
Fondamentale per la struttura del poema egrave la novitagrave della prospettiva Possiamo presumere che i cosiddetti poemi ciclici22 mirassero a conservare lrsquoangolatura che era stata propria delle versioni pre-omeriche della saga troiana sigrave che puograve riuscire significativo il confronto fra lrsquoesordio della Piccola Iliade (dove muovendo da grandi entitagrave ndash la cittagrave il paese due popoli la guerra ndash viene lanciato secondo lrsquoespressione di J Latacz come laquouno sguardo dallrsquoesternoraquo)
Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην εὔπωλον ἧς πέρι πολλὰ πάθον Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος Canto Ilio e la terra dei Dardani dai bei puledri per la quale molti dolori patirono i Danai servitori di Ares
con lo laquosguardo internoraquo che caratterizza lrsquoinizio dellrsquoIliade
Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν ἡρώων αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν οἰωνοῖσί τε δαῖτα Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς Canta o dea di Achille figlio di Peleo la collera maledetta che pene innumerevoli inflisse agli Achei e molte scagliograve allrsquoAde vite possenti di eroi e ne faceva prede per i cani e pasto per gli uccelli e si avverava il volere di Zeus da quando primamente si separarono venuti a contesa LrsquoAtride sovrano di eroi e Achille magnifico
Argomento non egrave dunque come doveva avvenire nella tradizione del canto epico un evento complesso da inquadrare con un grandangolo onnicomprensivo e neppure come saragrave nellrsquoOdissea un personaggio colto nella multiforme varietagrave delle sue peregrinazioni egrave invece una reazione emotiva (lrsquoira di Achille) con le sue conseguenze (le innumerevoli morti degli Achei) Narrare di questa ira significa per il poeta cominciare da un punto preciso (laquoda quandoraquo) ossia dal momento della contesa e della separazione fra i due massimi eroi greci Agamennone il primo per potere (laquosovrano di eroiraquo) e Achille il primo per nobiltagrave e forza (δῖος) E sintomatica della bipolaritagrave del mondo epico in quanto mondo di degravei e di eroi egrave la sincronia per cui il taglio della narrazione coincide col decorso del laquovolere di Zeusraquo (Διὸς βουλή) forse da identificare con la promessa del dio a Tetide (rievocata piugrave oltre in questo
22 V cap II laquoLa tradizione omericaraquo
Letteratura greca [1]
20
stesso canto ai vv 518-527) di vendicare lrsquoaffronto subito da Achille o piugrave in generale con il corso degli eventi in quanto tutto come per definizione laquogiace sulle ginocchia di Zeusraquo Opera indubbiamente allrsquointerno del poema unrsquoidea formativa un progetto di qui un insieme monumentale unificato anche da una serie di corrispondenze a distanza fra cui particolare significato acquistano quelle fra primo e ultimo canto Nel canto I il vecchio Crise va come supplice presso Agamennone portando doni e supplicando la restituzione della figlia e Agamennone lo respinge aspramente minacciandolo di far ricorso alla violenza se dovesse tornare nel canto XXIV il vecchio Priamo va come supplice presso Achille portando doni e supplicando la restituzione del corpo del figlio Achille ha una prima reazione irosa (esordisce al v 560 con laquoSmetti di irritarmi vecchioraquo) ma poi accoglie la supplica E al di lagrave delle corrispondenze nelle linee dellrsquoazione si colgono fra principio e fine del poema alcuni importanti echi verbali in particolare fra XXIV 501 s
τοῦ νῦν εἵνεχ᾽ ἱκάνω νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενος παρὰ σεῖο φέρω δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα per lui [Ettore] vengo ora alle navi degli Achei per riscattarlo da te e ti porto compenso infinito
e I 12 s
ὁ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενός τε θυγάτρα φέρων δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα costui [Crise] venne alle navi rapide degli Achei per riscattare la figlia portando compenso infinito
fra XXIV 555-557
λῦσον ἵν᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδωmiddot σὺ δὲ δέξαι ἄποινα πολλά τά τοι φέρομενmiddot σὺ δὲ τῶνδrsquo ἀπόναιο καὶ ἔλθοις σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν restituiscimelo percheacute lo possa vedere con gli occhi e accogli il riscatto copioso che portiamo e tu possa goderne e tornare alla tua terra patria
e I 18-20
Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν εὖ δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκέσθαιmiddot παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην τὰ δ᾽ ἄποινα δέχεσθαι Atridi e voi altri Achei dai forti schinieri a voi concedano gli degravei che hanno le case in Olimpo di distruggere la cittagrave di Priamo e tornare facilmente in patria ma restituitemi la figlia e accettate il riscatto
fra XXIV 560 μηκέτι νῦν μ᾽ ἐρέθιζε (laquosmetti di irritarmiraquo) e I 32 μή μ᾽ ἐρέθιζε (laquonon mi irritareraquo) fra XXIV 568-570
τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς μή σε γέρον οὐδrsquo αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω καὶ ἱκέτην περ ἐόντα Διὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμάς Ora perciograve fra i dolori non mi eccitare lrsquoanimo ancora di piugrave bada o vecchio che non ti lasci neppure nella tenda
Letteratura greca [1]
21
bencheacute supplice e violi gli ordini di Zeus e I 26-28
μή σε γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω ἢ νῦν δηθύνοντ᾽ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο Mai te o vecchio io colga presso le concave navi ora a indugiare o piugrave tardi a tornare che piugrave non dovesse giovarti lo scettro e la benda del dio
(e infine XXIV 571 ὣς ἔφατ ἔδεισεν δ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ laquocosigrave diceva e il vecchio tremograve e obbediva alle paroleraquo ripete esattamente I 33) In effetti lrsquoepisodio terminale del poema col superamento dellrsquoira ad opera della pietagrave e del senso di unrsquoesistenza invasa dal dolore si propone come il rovesciamento consapevole dellrsquoepisodio iniziale che era apparso caratterizzato dalla cancellazione della pietagrave e del diritto dei supplici in nome della forza Al rifiuto iniziale del donoriscatto si oppone lrsquoaccettazione finale in consonanza con un principio-guida che opera nel poema secondo linee che alla fine si riunificano Agamennone restituisce Criseide al padre ma si appropria del dono fatto dagli altri Achei ad Achille (Briseide) Achille respinge i doni fatti da Agamennone per indurlo a riconciliarsi con lui ma dopo aver contestato nel IX canto la nozione che la vita umana possa essere barattata con una massa di beni torna alla lotta non in cambio di qualche premio da conquistare ma per vendicare lrsquouccisione dellrsquoamico Patroclo e tanto nella lotta sul campo di battaglia quanto nellrsquoinfierire sul cadavere di Ettore si abbandona a un furore cosigrave smisurato e patologico che puograve essere superato solo con lrsquoaccettare i doni di Priamo non tuttavia per il loro valore drsquouso ma percheacute in Priamo Achille riconosce lrsquoombra del padre lontano Cosigrave lrsquoIliade appare attraversata da un impulso fondamentale che muove dallrsquoideologia del dono e dalla conseguente centralitagrave assegnata allrsquoonore (τιμή) come ldquoprezzordquo che qualifica il valore del guerriero ma supera questo piano di valutazione dei rapporti umani attraverso la loro riformulazione nei termini di un umanesimo esistenziale che ha come punti di riferimento lrsquoidentitagrave universale dei condizionamenti oggettivi (la vecchiaia la malattia la morte) e i legami che uniscono padre e figlio compagno e compagno vivi e morti (il cordoglio finale di Andromaca Ecuba ed Elena sulla salma di Ettore) Entro questo orizzonte progressivamente allargato la guerra le lotte lo scontro mortale finiscono col rappresentare solo un momento e un aspetto dellrsquoesistenza graditi tanto agli degravei che vi assistono come spettatori interessati quanto agli uditori che riascoltano le antiche gesta eppure non tali da appiattire il poema in una prospettiva guerresca conclusa in se stessa Molto del fascino delle battaglie e delle ἀριστεῖαι dellrsquoIliade sta nella presenza recondita di un occhio che sa guardare al di lagrave di esse (e al di lagrave della stessa distinzione fra Greci e Troiani vincitori e vinti) e che puograve anche attraverso le similitudini lasciare irrompere il mondo della natura o del lavoro umano nel mezzo delle battaglie LʼOdissea LrsquoOdissea (Ὀδύσσεια) consta di circa 12100 esametri divisi anchrsquoessi in 24 libri e indicati con le lettere minuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquoargomento egrave costituito dalle avventure di Odisseo dalla distruzione di Troia al ritorno alla patria Itaca esposte secondo un ordine che entrando subito nel vivo degli avvenimenti (lrsquoinizio del poema mostra Odisseo nellrsquoisola di Calipso) rievoca poi i fatti giagrave trascorsi e li ricongiunge infine a partire dal libro XV (con lrsquoarrivo di Telemaco alla capanna di Eumeo dove giagrave si trova Odisseo) in unrsquoazione unitaria La trama del poema i cui avvenimenti sono concentrati cronologicamente nello spazio di 40 giorni (ma sono narrati solo gli avvenimenti di 16 giorni e 8 notti) si articola in tre parti la laquoTelemachiaraquo (canti I-IV) il laquoRitorno di Odisseoraquo (canti V-XIII) e la laquoVendetta di Odisseoraquo (canti XIV-XXIV)
Letteratura greca [1]
22
Canto I Tutti gli eroi superstiti sono ormai tornati da Troia alle loro case tranne Odisseo che pur desideroso di tornare egrave trattenuto dalla ninfa Calipso nellrsquoisola di Ogigia Gli degravei hanno pietagrave di lui tranne Posidone irato per lrsquoaccecamento del figlio il ciclope Polifemo Ma un consiglio degli degravei assente Posidone (che si egrave recato presso gli Etiopi) delibera il ritorno dellrsquoeroe si decide che Ermes andragrave subito da Calipso mentre Atena si avvia verso Itaca sotto lrsquoaspetto del signore dei Tafi Mente per incoraggiare il figlio di Odisseo Telemaco a tener testa ai pretendenti della madre i laquoprociraquo (i quali aspirano al regno tramite le nozze con Penelope) e per indurlo a intraprendere un viaggio in cerca di notizie sul padre Canto IΙ Telemaco segue il consiglio della dea e il giorno seguente nellrsquoassemblea popolare chiede una nave per andare in cerca del padre ma la sua richiesta non viene discussa e Leocrito scioglie lrsquoassemblea Grazie ad Atena che ora ha assunto le sembianze di Mentore (antico amico di Odisseo) Telemaco riesce tuttavia a trovare una nave con cui salpa nel corso della notte allrsquoinsaputa sia della madre che dei proci Canto IΙΙ Telemaco e MentoreAtena arrivano a Pilo e sul lido trovano Nestore che sta offrendo un sacrificio a Posidone Il vecchio eroe accoglie ospitalmente Telemaco e gli comunica molte notizie sul ritorno di altri Achei ma nessuna su Odisseo Alla sera Atena scompare in forma di aquila e il mattino seguente Telemaco salpa insieme con Pisistrato (figlio di Nestore) alla volta di Sparta dove arriva la sera del giorno successivo Canto IV A Sparta Menelao sta festeggiando il doppio matrimonio del figlio e della figlia Il giorno seguente Telemaco chiede del padre Menelao gli racconta il proprio ritorno durante il quale aveva incontrato Proteo il vecchio nume marino che gli aveva riferito come Odisseo fosse trattenuto nellrsquoisola di Calipso Intanto a Itaca i proci preparano insidie meditando di uccidere Telemaco al suo ritorno Penelope ne viene a conoscenza ma Atena le appare in sogno per confortarla Canto V Dopo un secondo concilio degli degravei (in effetti un ldquodoppionerdquo di quello del I canto) Zeus manda finalmente Ermes presso Calipso con lrsquoordine di lasciar partire Odisseo La ninfa aiuta lrsquoeroe a costruirsi una zattera Al diciottesimo giorno di navigazione Odisseo egrave in vista dellrsquoisola dei Feaci Scheria quando Posidone di ritorno dal suo soggiorno presso gli Etiopi lo vede e suscita una tempesta che distrugge la zattera Ma la dea marina Ino Leucotea impietositasi gli porge il proprio velo sostenuto dal quale lrsquoeroe giunge a nuoto alla riva di Scheria dove si abbandona esausto addormentandosi Canto VI In seguito a un sogno inviatole da Atena Nausicaa la figlia del re dei Feaci Alcinoo si reca nei pressi della spiaggia a lavare le vesti insieme con le ancelle Odisseo risvegliatosi atterrisce le fanciulle che fuggono tutte allrsquoinfuori di Nausicaa Lrsquoeroe supplica la giovane di porgerle aiuto ed ella lo fa rivestire e lo accompagna fino al bosco di Atena poco prima della cittagrave esortandolo a presentarsi a suo padre Canto VII Protetto dalla nebbia di cui Atena lo ha avvolto Odisseo entra nel palazzo abbraccia le ginocchia della regina Arete e la caligine scompare poi viene accolto con onore da Alcinoo Arete chiede a Odisseo donde provenga e chi gli abbia donato gli abiti (a lei ben noti) che indossa Lrsquoeroe inizia a raccontare le disavventure che gli sono occorse dopo la
Letteratura greca [1]
23
partenza dallrsquoisola di Calipso Alcinoo gli promette di farlo ricondurre a Itaca il giorno seguente Canto VIII Ma lrsquoindomani Alcinoo fa apprestare un banchetto durante il quale lrsquoaedo Demodoco canta della contesa insorta un giorno fra Achille e Odisseo Lrsquoeroe si copre il volto per nascondere le lacrime allora Alcinoo interrompe il canto e organizza una serie di gare nel corso delle quali Odisseo primeggia Poi Demodoco al margine di unrsquoarea per la danza dove si esibiscono i ballerini feaci canta gli amori di Ares e Afrodite e la vendetta di Efesto (che incatena i due amanti) La sera al ritorno nel palazzo Demodoco racconta la storia del Cavallo di legno Odisseo scoppia nuovamente in lacrime e Alcinoo gli chiede di rivelare il suo nome Canto IX Odisseo dichiara il proprio nome e dagrave inizio al racconto della propria storia a partire dalla caduta di Troia distruzione di Ismaro e perdite subite ad opera dei Ciconi sbarco presso i Lotofagi (che si nutrono di un cibo misterioso che fa dimenticare il ritorno) dopo una terribile tempesta scatenatasi durante il tentativo di doppiare il capo Malea arrivo allrsquoisola antistante quella dei Ciclopi dove Odisseo si trasferisce con una sola nave esplorazione dellrsquoisola perdita di alcuni compagni allrsquointerno della caverna del gigante monocolo accecamento del mostro e fuga Canto X Odisseo giunge allrsquoisola di Eolo signore dei venti che lo accoglie benevolmente e gli consegna alla partenza tutti i venti chiusi in un otre ma poi lo respinge con durezza quando ritorna presso di lui percheacute i compagni (sospettando che nellrsquootre siano racchiuse cospicue ricchezze) hanno sciolto i venti e da essi si egrave sprigionato un uragano che li ha risospinti sullrsquoisola Ripreso il mare Odisseo egrave trasportato fino ai Lestrigoni antropofagi il cui attacco priva lrsquoeroe di tutte le altre navi tranne la propria Con questa fugge fino allrsquoisola (Eea) della maga Circe Dopo che Circe ha trasformato in porci un gruppo di compagni mandati innanzi ad esplorare lrsquoisola Odisseo ha la meglio sulla maga (a cui impone di restituire forma umana ai compagni) grazie allrsquoerba moly fornitagli da Ermes Resta un anno presso Circe che al momento della partenza gli consiglia di recarsi al paese dei morti per interrogare il vate Tiresia Canto XI Approdato alla terra dei Cimmeri (che vivono immersi in una nebbia perenne sulla riva dellrsquoOceano) e scavata una fossa Odisseo sacrifica ai morti e immola una vittima speciale a Tiresia Le anime accorrono dapprima Elpenore caduto per caso giugrave dal tetto della casa di Circe (Odisseo gli promette sepoltura) poi la madre Anticlea (che gli racconta di esser morta di dolore per la sua assenza) quindi Tiresia che gli vaticina le sue vicende future fino alla morte (questa lo coglieragrave dopo una lunga vita in un paese straniero che non conosce neacute il sale neacute il remo) Da un certo punto in poi il poeta dimentica il presupposto per cui Odisseo aveva scavato una fossa alla quale i morti accorrevano per bere il sangue delle vittime e bevendolo riacquistavano per breve tempo una piena consapevolezza immagina invece che Odisseo sia allrsquointerno dellrsquoAde In questa sezione rientrano la descrizione di Aiace sdegnato di Minosse di Orione dei grandi peccatori di Eracle Poi Odisseo fa ritorno a Eea e ricevuti i consigli di Circe si imbarca per il ritorno in patria Canto XII Scampato alle Sirene che invano lo attirano col canto (si egrave fatto legare allrsquoalbero della nave i compagni che remano hanno le orecchie turate con la cera) passa tra Cariddi e Scilla (che gli rapisce sei uomini) ed egrave costretto dai compagni ad approdare in contrasto con le prescrizioni di Circe allrsquoisola Trinachia dove pascolano le greggi del Sole I
Letteratura greca [1]
24
compagni spronati da Euriloco se ne cibano nonostante il divieto dellrsquoeroe Il Sole sdegnato ottiene da Zeus che la nave sia colpita dal fulmine Tutti i compagni periscono ma Odisseo che ripassa tra Scilla e Cariddi si salva miracolosamente da questrsquoultima aggrappandosi a un fico selvatico fincheacute il gorgo restituisce i rottami della nave infine arriva remando con le mani allrsquoisola di Ogigia Canto XIII Terminato il racconto lrsquoeroe riceve doni dai Feaci e la notte seguente egrave ricondotto a Itaca e deposto addormentato sulla spiaggia presso un antro sacro alle Ninfe Al risveglio per la nebbia non riconosce la sua terra fincheacute Atena in veste di giovane pastore lo rassicura e poi rivelatasi gli dagrave istruzioni su come far strage dei proci e lo trasforma in un vecchio mendico Canto XIV Odisseo si reca allo stazzo del suo porcaio Eumeo che pur non riconoscendolo lo accoglie ospitalmente rifocillandolo e offrendogli un mantello per ripararsi dal gelo notturno Canto XV A questo punto la laquoTelemachiaraquo si riannoda allrsquoazione principale Telemaco che si trova ancora a Sparta viene indotto da Atena a tornare a Itaca sulla via del ritorno a Pilo accoglie a bordo lrsquoindovino Teoclimeno e grazie allrsquoaiuto della dea sfugge alle insidie dei proci sbarca a Itaca e si reca anchrsquoegli presso Eumeo Canto XVI Questi va da Penelope ad annunciargli il ritorno del figlio Intanto Odisseo rimosso lrsquoincantesimo si svela nel suo vero aspetto a Telemaco e con lui progetta la vendetta sui proci (che intanto tramano una nuova insidia ai danni di Telemaco) Eumeo torna al suo stazzo Canto XVII Il mattino seguente Telemaco si reca in cittagrave seguito in un secondo tempo da Eumeo e Odisseo (che ha riassunto lrsquoaspetto di mendico) Davanti al palazzo Odisseo egrave riconosciuto dal cane Argo Entra e va mendicando tra i proci Antinoo lo colpisce alla spalla destra con uno sgabello Canto XVIII Odisseo si batte al pugilato col mendicante Iro Penelope scesa nella sala prospetta ai proci lrsquoeventualitagrave di un nuovo matrimonio Odisseo egrave insultato dalla schiava Melanto e schiva uno sgabello scagliato da Eurinomo Canto XIX Insieme con Telemaco lrsquoeroe allontana le armi dalla sala poi conversa con Penelope che gli racconta un sogno e gli espone il suo piano per sedare le contese tra i proci concedendosi sposa a colui che riusciragrave a tendere lrsquoarco di Odisseo la prova avverragrave il giorno seguente al novilunio Durante il colloquio la fida schiava Euriclea lava i piedi di Odisseo e riconosciutolo da unrsquoantica cicatrice sta per rivelarne lrsquoidentitagrave ma lrsquoeroe la costringe a tacere Canto XX Al mattino Euriclea e le ancelle fanno i preparativi per il banchetto Giungono Eumeo Melanzio e il mandriano Filezio Un presagio mandato da Zeus dissuade i proci dal progetto di uccidere Telemaco Durante il banchetto Teoclimeno predice la loro imminente rovina
Letteratura greca [1]
25
Canto XXI Penelope conduce lrsquoarco nella sala dopo che parecchi fra i proci e lo stesso Telemaco hanno tentato invano di tenderne la corda Odisseo chiede di partecipare alla prova tende lrsquoarco senza fatica e riesce a far passare la freccia attraverso gli anelli di dodici scuri predisposte da Telemaco Canto XXII Poi scaglia le frecce sui proci e si rivela nella sua identitagrave Nella lotta che segue Telemaco Eumeo e Filezio aiutano il padrone contro i proci (appoggiati dal capraio Melanzio) Tutti i proci restano uccisi le ancelle infedeli sono impiccate Melanzio viene mutilato e ucciso soltanto lrsquoaedo Femio e lrsquoaraldo Medonte sono risparmiati Canto XXIII Nuovo colloquio fra Odisseo e Penelope che durante lrsquoeccidio dormiva ed egrave stata svegliata da Euriclea Penelope esita ancora a riconoscere il marito e non si arrende alla veritagrave fincheacute Odisseo non le descrive la posizione e la struttura del letto coniugale Canto XXIV Ermes conduce allrsquoAde le ombre dei proci Odisseo fa visita al padre Laerte nella masseria dove quello vive nello squallore e nellrsquoemarginazione e si fa riconoscere Intanto il padre di Antinoo incita gli Itacesi alla rivolta e il poema si conclude con lo scontro di Odisseo e dei suoi contro i concittadini lrsquoeroe ha la meglio e Zeus scagliato il fulmine pone fine alla battaglia Atena sotto lrsquoaspetto di Mentore stabilisce fra i contendenti un patto per il futuro36
Struttura e caratteri dellʼopera Giagrave la prima parola del proemio (ἄνδρα) non menziona come tema dellrsquoopera un determinato episodio della vita del protagonista ma il protagonista stesso (I 1-10)
Ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα πολύτροπον ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεmiddot πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περmiddot αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο νήπιοι οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιονmiddot αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ τῶν ἁμόθεν γε θεά θύγατερ Διός εἰπὲ καὶ ἡμῖν Dellrsquouomo multiforme a me racconta o Musa che molto errograve dopo che di Troia la sacra rocca distrusse di molti uomini vide le cittagrave riconobbe il pensiero e molti per il mare patigrave dolori nellrsquoanimo per salvare la sua vita e il ritorno dei compagni Eppure non li salvograve i compagni per quanto bramasse per la loro stessa follia si persero gli stolti i buoi del Sole Iperione mangiarono e quello rapigrave ad essi il digrave del ritorno Di questo da un punto qualsiasi narra anche a noi o dea figlia di Zeus
Storie favolose di naviganti racconti imperniati sul ritorno dei guerrieri achei che avevano combattuto a Troia e il particolare rientro in patria di Odisseo figlio di Laerte erano forse giagrave stati connessi e intrecciati nella precedente tradizione epica sigrave che il presente cantore poteva
Letteratura greca [1]
26
metter mano alla vicenda partendo (v 10) laquoda un punto qualsiasiraquo (ἁμόθεν) una notazione che certo presuppone la convenzione propria dellrsquoesordio tradizionale di un canto epico comparabile con i giagrave ricordati ἐξ οὗ (laquoda quandoraquo) di Iliade I 4 ed ἔνθεν (laquoda doveraquo) di Odissea VIII 500 Senoncheacute rispetto a queste indicazioni di tipo puntuale il tratto costituito dalla dimensione casuale quasi arbitraria inerente ad ἁμόθεν proprio mentre dichiara lrsquoassenza di un determinato piano compositivo implica in realtagrave che il racconto non si svolgeragrave per filo e per segno secondo lrsquoordine noto a poeta e uditori non si snoderagrave κατὰ κόσμον (laquoper ordineraquo) come il canto di Demodoco (VIII 489) ma seguiragrave un andamento originale Il ldquopunto qualsiasirdquo incipitario non rappresenta una scelta della Musa (figura dellrsquoarchivio tematico che conserva le laquovieraquo dellrsquoepica) bensigrave di questo cantore che ha deciso di far incominciare la narrazione in medias res e ha in serbo la sorpresa di far succedere al concilio degli degravei (che decide lrsquoinvio di Ermes presso Calipso) non lrsquoazione testeacute programmata (azione che viene differita con un ritardo che a piugrave riprese ha scandalizzato i lettori a principio del V canto) ma la partenza di Atena alla volta di Itaca e lrsquoavvio della laquoTelemachiaraquo Le due diverse vicende proposte a principio del poema quella di Telemaco e quella di Odisseo procedono infatti in parallelo coprendo un analogo lasso di tempo Piugrave oltre la decisione di trasformare la sequenza narrativa che va dalla partenza di Odisseo da Troia fino al suo arrivo nella terra dei Feaci in una rievocazione fatta dallrsquoeroe in prima persona al cospetto di Alcinoo e dei Feaci (la sezione detta degli ἀπόλογοι laquoraccontiraquo) crea una struttura ad anello che parte dal presente e ad esso fa ritorno dopo aver ricostruito le premesse della condizione attuale del protagonista Col canto XIII Odisseo egrave riportato dai Feaci a Itaca e questo permette la saldatura fra le vicende sue e quelle di Telemaco sia pure col differimento dellrsquoincontro e del riconoscimento fra padre e figlio fino al canto XVI Far scorrere in parallelo sequenze distinte organizzare programmi narrativi a corta e a lunga gittata tendere o allentare ad arte il ritmo della narrazione non si tratta davvero di procedimenti che potessero configurarsi come tradizionali dellrsquoarte epica quanto piuttosto di un momento sperimentale di una ricerca di soluzioni nuove al termine di una lunga e ormai consolidata sedimentazione di percorsi compiuti allrsquointerno di un determinato repertorio tematico unrsquoaudacia inventiva una πολυτροπίη degne del protagonista del poema che inevitabilmente comportavano rischi molteplici di incoerenze dissonanze occasionali avarie della macchina epica e che tuttavia erano destinate a conseguire un risultato assolutamente convincente allrsquoorecchio di chi si abbandonasse al fascino del racconto senza lrsquourgenza propria di altre etagrave e di altre mentalitagrave di puntare il dito sui singoli dettagli o le singole sfasature
PER SAPERNE DI PIUrsquo Difficoltagrave e incongruenze della narrazione omerica Forti della possibilitagrave di un controllo su un testo scritto che possiamo percorrere in avanti e a ritroso secondo ritmi di nostra scelta a noi non riesce difficile cogliere alcune delle difficoltagrave organizzative incontrate nella composizione del poema In proposito per ricordare un caso che saragrave allrsquoorigine delle discussioni di orientamento ldquoanaliticordquo intorno allrsquoOdissea possiamo leggere il discorso che Atena prese le sembianze di Mente re dei Tafi rivolge a Telemaco nel I canto (vv 253-305) Ah infelice ti manca molto davvero lrsquoassente Odisseo che getti le mani addosso ai pretendenti sfrontati Percheacute se ora tornato stesse sulla soglia 255 con una scure lo scudo e due lance cosigrave come io per la prima volta lo vidi in casa nostra che beveva e godeva di ritorno da Efira da Ilo di Mermero (andograve anche ligrave Odisseo con la nave veloce 260 in cerca del veleno omicida per averne da ungere le frecce di bronzo ma quello non glielo diede percheacute temeva gli dei che vivono eterni
Letteratura greca [1]
27
glielo diede invece mio padre percheacute lrsquoamava moltissimo) se stesse Odisseo tra i pretendenti cosigrave 265 essi avrebbero tutti rapida morte e nozze amare Ma sulle ginocchia degli dei questo giace se una volta tornato faragrave o no vendetta nella sua casa te invece io esorto a riflettere come cacciare i pretendenti da casa 270 Ebbene ora ascolta e alle mie parole darsquo retta Domattina chiamati gli eroi Achei a consiglio rivolgi a tutti un discorso e siano testimoni gli dei Ai pretendenti comanda drsquoandarsene per i fatti loro e tua madre se lrsquoanimo la spinge alle nozze 275 ritorni a casa del padre molto potente Prepareranno essi le nozze e disporranno i doni nuziali moltissimi quanti gli pare che debbano andare alla figlia A te darograve un saggio consiglio se vuoi ascoltarlo armata una nave con venti remi la migliore che crsquoegrave 280 Varsquo a domandare del padre partito da tempo se mai te ne parli un mortale o sentissi da Zeus la voce che divulga la fama tra gli uomini Anzitutto varsquo a Pilo e interroga il chiaro Nestore di ligrave poi varsquo a Sparta dal biondo Menelao 285 degli Achei vestiti di bronzo egli egrave tornato per ultimo Se senti dire qualcosa sulla vita e il ritorno del padre per quanto stremato potresti sopportare un altro anno se invece senti dire che egrave morto e non vive allora tornato nella cara terra patria 290 ergigli un tumulo e offrigli funebri offerte moltissime quanto conviene e darsquo tua madre a un marito E poi dopo aver compiuto e fatto ogni cosa allora medita nella mente e nellrsquoanimo come tu possa uccidere nelle tue case 295 i pretendenti con lrsquoinganno affrontandoli non devi piugrave avere i modi di un bimbo percheacute ormai non sei tale Non senti lrsquoillustre Oreste quale gloria ha acquistato fra tutti gli uomini percheacute uccise lrsquoassassino del padre Egisto esperto di inganni che gli uccise il nobile padre 300 Anche tu caro infatti molto bello e grande ti vedo sii valoroso percheacute ti lodi anche qualcuno dei posteri Ma io tornerograve adesso alla nave veloce dai compagni che forse impazienti mi aspettano Tu devi pensarci da te dammi retta 305
[Tr di GA Privitera] Le stranezze non mancano davvero e cosigrave sono state messe a fuoco da Stephanie West nel suo commento23 1 Atena sa evidentemente molto piugrave di quanto uno come Mente avrebbe potuto sapere in particolare ella sa che i proci ignoreranno lrsquoinvito di Telemaco a lasciare la sua casa e fatto piugrave importante che gli degravei tra breve ricondurranno in patria Odisseo A queste osservazioni si puograve replicare con la stessa West che laquosi sono esagerate difficoltagrave e
23 Omero Odissea I cit 219 ss
Letteratura greca [1]
28
incongruenze alle quali un pubblico di ascoltatori (o anche un lettore moderatamente attento) probabilmente non farebbe casoraquo 2 Il progetto di una pubblica denuncia dei proci dinanzi agli degravei e agli uomini ai vv 273-274 egrave ciograve che Atena sembra prefiggersi nel promuovere lrsquoassemblea degli Itacesi (assemblea che effettivamente avragrave luogo a principio del canto II) drsquoaltra parte le successive istruzioni di AtenaMente ai vv 295 s (medita come uccidere i pretendenti) presuppongono che di quella richiesta da formulare nel corso dellrsquoassembla essi non terranno alcun conto Anche a questa osservazione si puograve rispondere che laquoegrave ragionevole attendersi che Telemaco condivida la previsione di un esito negativo della sua iniziativaraquo e si puograve aggiungere che pure in caso di insuccesso il ricorso allrsquoassemblea potrebbe ottenere almeno il risultato di screditare i pretendenti presso la comunitagrave itacese legittimando un successivo ricorso alla violenza (e si tratta di una legittimazione di cui anche lrsquoultimo canto mostreragrave lrsquoesigenza) 3 Dopo che Telemaco aveva detto che la madre non intendeva risposarsi (vv 249-250) AtenaMente si esprime ai vv 275-278 come se Penelope desiderasse proprio nuove nozze e inoltre sarebbe assurdo che il padre di Penelope cominciasse a contrattare un secondo matrimonio prima del ritorno di Telemaco dal suo viaggio e che mettesse mano a preparativi che rischierebbero di essere annullati qualche tempo dopo con inevitabile imbarazzo se Telemaco venisse a sapere che Odisseo egrave ancora vivo In piugrave lrsquoandamento sintattico di questi versi presenta un anacoluto durissimo per cui a principio del v 275 lrsquoaccusativo μητέρα egrave seguito da un ἂψ ἴτω (laquovada indietroraquo laquotorniraquo) che richiederebbe come soggetto un nominativo μήτηρ Come hanno reagito i lettori di Omero Nellrsquoantichitagrave un grammatico rimasto anonimo cambiava come attesta uno scolio μητέρ᾽ in μήτηρ nel secolo XVIII Richard Bentley modificava ἴτω in ἴμεν (infinito eolico di εἶμι laquovadoraquo) nel XIX un altro grande della filologia europea Gottfried Hermann risolveva piugrave drasticamente la questione eliminando il complesso dei vv 275-278 e la stessa West mostra simpatia per tale proposta supponendo laquounrsquoaggiunta posteriore modellata sul corrispondente passo del libro IIraquo (dove i vv 196 s sono identici ai vv 277 s e il v 195 copre lo stesso contenuto dei vv 275 s) Si tratta di procedimenti adeguati ai dati di fatto Migliorano davvero il testo che ci egrave stato tramandato In realtagrave ambedue le ldquocorrezionirdquo appena ricordate (di μήτερ᾽ e di ἴτω) ottengono un risultato tanto lineare che egrave davvero difficile pensare che lrsquoanacoluto avrebbe potuto invadere tutta la tradizione se non fosse stato originario e quanto allrsquoespunzione dei vv 275-278 essa indubbiamente peggiorerebbe il ritmo del discorso determinando lrsquoavvicinamento fra i due versi (v 271 e v 279) molto simili fra loro che aprono le due sequenze occupate dai consigli di Mente E allora La via piugrave saggia egrave senzrsquoaltro quella di tenerci qui come quasi sempre di fronte al testo omerico contraddizioni e anacoluti riconoscendo in essi lrsquoeffetto dellrsquoattivitagrave di un cantore che pur sulla base di una traccia largamente memorizzata restava pur sempre legato a quella prassi orale per cui composizione ed esecuzione tendevano a coincidere E lrsquoanacoluto si spiega bene se cerchiamo di immedesimarci nel procedimento seguito dal poeta Egli ha affidato ad Atena un certo flusso argomentativo per cui la dea deve dar consigli a Telemaco sui suoi rapporti coi proci e con la madre e cosigrave colloca in fine di v 274 un ἄνωχθι (laquoordinaraquo) destinato a reggere gli accusativi simmetricamente dislocati in principio di verso (vv 274 e 275) μνηστῆρας e μητέρα Senoncheacute giunto a questa seconda parte dellrsquoargomentazione egli si avvede quanto sarebbe illogico che Telemaco sollecitasse la madre a nuove nozze di qui lrsquoimprovviso cambio di costruzione che svincola al prezzo di una sensibile slogatura sintattica lrsquoipotesi delle nuove nozze dallrsquoordine impartito a Telemaco e la prospetta invece come un desiderio eventuale della stessa Penelope Il poeta ha un progetto ben meditato brani e sequenze piugrave volte sperimentati ed egrave col supporto di questi materiali giagrave elaborati che egli si fa strada attraverso le insidie della
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
6
opportunamente osservato18 non solo la maggior parte delle vicende di questa ldquobiografiardquo egrave desunta proprio dai poemi omerici e specialmente dallrsquoOdissea e non solo contiene molti elementi manifestamente ridicoli ma soprattutto laquolrsquoOmero di questa leggenda egrave un cantore mendicante cieco che si intrattiene con gente semplice con calzolai pescatori e vecchi nei ritrovi delle cittagrave portuali un precettore che insegna a leggere e a scrivere e che dunque ha rapporti soprattutto con fanciulli un estemporaneo coniatore di versi ammirato soltanto dalla piccola borghesia e una sola volta nellrsquoepisodio del signore di Bolisso in contatto con il ceto elevato davanti alle cui case del resto egrave solito andare a mendicare doni con canzoni da lui stesso composte [] Chi ha delineato questrsquoimmagine di poeta ndash non importa se con intenzioni parodistiche o meno ndash aveva davanti a seacute un compositore di versi collocato nella fascia bassa di un certo ceto professionale che si egrave potuto sviluppare in questa forma solo quando i commerci e gli affari le cittagrave e le comunitagrave avevano raggiunto una piena fioritura scalzando lrsquoantica struttura aristocratica della societagrave quando cioegrave giagrave dominava la borghesia e si richiedeva piugrave spirito imprenditoriale (si pensi alla fondazione di scuole) che beni patrimoniali La condizione professionale dei rapsodi era questa artisti di declamazione paragonabili ai nostri cantanti da concerto che allora come oggi andavano in tourneacutee e che si caratterizzavano per recitare non opere da loro stessi composte ma solo grandi capolavori altrui La leggenda di Omero attribuisce questa vita di rapsodo anche al grande poeta dellrsquoetagrave arcaica i creatori di tale leggenda non conoscevano infatti al loro tempo un altro tipo di aedoraquo Dunque gli antichi non conoscevano nulla di definito sulla vita e sulla personalitagrave di Omero ciograve che possiamo ricostruire si deve basare da un lato sul modello di aedo quale emerge dai poemi (e quale piugrave sopra abbiamo cercato di sintetizzare) dallrsquoaltro su una ricognizione degli elementi costitutivi dellrsquoarte epica Il verso dellʼepica Lrsquoesametro (giagrave Erodoto usa per lrsquoesametro dattilico espressioni come ἐν ἑξαμέτρῳ τόνῳ [I 47 2] e ἐν ἔπεσι ἑξαμέτροισι [VII 220 3]) si presenta esteriormente come una successione di sei dattili di cui lrsquoultimo catalettico (con la possibilitagrave per lrsquoultimo elemento in virtugrave della pausa di fine di verso di essere realizzato indifferentemente da sillaba breve o lunga u) Le due brevi dei singoli dattili potevano essere ldquosostituiterdquo da una lunga costituendo uno spondeo (di qui la denominazione per ciascun elemento in posizione pari di biceps y) una facoltagrave molto ridotta nel quinto dattilo che si presenta generalmente in forma pura (le eccezioni sono allincirca di un caso su 18 versi) Il verso appare articolato attraverso punti di incisione le cosiddette laquocesureraquo (τομαί laquotagliraquo) le piugrave frequenti interessano il terzo metro venendo a cadere o dopo il suo elemento lungo (cesura maschile o pentemimere laquodopo il quinto mezzo piederaquo) o tra le due brevi del biceps (cesura femminile o trocaica) piugrave rara la cesura dopo il quarto elemento lungo (eftemimere laquodopo il settimo mezzo piederaquo) e subordinata ad altra cesura principale quella dopo il secondo elemento lungo (tritemimere laquodopo il terzo mezzo piederaquo) Fine di parola puograve ricorrere anche dopo il quarto dattilo (dieresi [διαίρεσις laquodivisioneraquo] bucolica cosigrave denominata dal largo uso che ne faranno i poeti bucolici drsquoetagrave ellenistica) Di qui lo schema seguente
a1 a2 m f r b ndash y ndash y ndashkk ndash y ndash kk ndash u
18 J Latacz Omero il primo poeta dellrsquoOccidente (1989) Laterza Roma-Bari 1990 28 s
Letteratura greca [1]
7
dove a1 e a2 segnalano allrsquointerno della prima metagrave del verso le posizioni che in alternativa reciproca tendono a coincidere con fine di parola m e f le posizioni della cesura principale rispettivamente maschile o pentemimere (m) e femminile o trocaica (f) r la posizione della cesura eftemimere b la posizione della dieresi bucolica Viene evitata la fine di parola dopo il terzo metro cosigrave da escludere una bipartizione simmetrica del verso Un punto in cui la fine di parola egrave tendenzialmente evitata egrave quello dopo la prima breve del quarto biceps come fu osservato da G Hermann (donde lrsquoetichetta di laquoponte di Hermannraquo) Solo con Callimaco si afferma anche il divieto che una parola che inizi nel primo metron termini con la prima breve nel secondo biceps (laquoprima legge di Meyerraquo)
PER SAPERNE DI PIUrsquo Teorie sullrsquoorigine dellrsquoesametro Sul problema dellrsquoorigine dellrsquoesametro le teorie si sono succedute numerose allrsquointerno della fondamentale contrapposizione fra chi ha individuato nella sua struttura il risultato della fusione fra preesistenti unitagrave minori e chi invece come Hoekstra (1981) ne ha proposto unrsquointerpretazione fin dallrsquoorigine unitaria Ad es Th Bergk (1854) riconduceva la genesi dellrsquoesametro a due cola lirici preesistenti Wilamowitz (1884) ne faceva il risultato della lunga evoluzione di una struttura lirica avvenuta in parallelo col passaggio dalla canzone lirica (eolica) al laquopiccolo eposraquo e da questo al laquogrande eposraquo A Meillet (1923) postulava unrsquoereditagrave pre-greca (egea) Piugrave recentemente un ritorno alla posizione di Bergk si egrave avuto da parte di ML West (1973) con lrsquoipotesi di una derivazione dellrsquoesametro dallrsquoassociazione fra un hemiepes e un prosodiaco e alla posizione di Wilamowitz nel senso dellrsquoevoluzione di un ferecrateo espanso con lrsquoinserzione centrale di tre dattili con G Nagy (1974) B Gentili (1977) ha cercato di rintracciare coincidenze fra i segmenti costitutivi dellrsquoesametro e i cola della poesia lirica drsquoetagrave arcaica partendo dal dato per cui gli schemi metrici che appaiono in alcune iscrizioni arcaiche e nella lirica di Stesicoro (hemiepes enoplio reiziano coriambico adonio etc) sono gli stessi che sembrano plasmare tutte le formule piugrave tradizionali dellrsquoesametro omerico (per unrsquoesposizione sintetica di questa teoria cfr B Gentili-L Lomiento Metrica e ritmica Storia delle forme poetiche nella Grecia antica Milano Mondadori Universitagrave 2003 pp 279-283)
La formularitagrave Il fenomeno della formularitagrave si puograve definire come la ripetizione di versi interi o di segmenti di versi specialmente nellrsquoambito di situazioni tipiche ad es per laquoquando sorse lrsquoauroraraquo troviamo usato per due volte nellrsquoIliade e in ben venti casi nellrsquoOdissea il verso
ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς e quando mattutina apparve Aurora dalle dita di rosa
Ma il caso piugrave comune di formularitagrave egrave quello rappresentato dai nessi standardizzati nomeepiteto come quelli che vengono applicati ai rispettivi protagonisti dei due poemi πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς (31 volte) e πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς (38 volte) ambedue formule clausolari ma di diversa estensione poicheacute (se riandiamo allo schema riprodotto al paragrafo precedente) esse arrivano entrambe alla fine del verso ma partendo la prima da r la seconda da f Esempi
Letteratura greca [1]
8
r Iliade I 58 τοῖσι δrsquo ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς f Odissea VIII 97 Ὣς ἔφατrsquo οὐδrsquo ἐσάκουσε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς Piugrave in particolare se consideriamo le singole articolazioni minori del verso riscontriamo che a) nel segmento iniziale si incontrano con alta frequenza brevi nessi che contengono congiunzioni pronomi e particelle connettive o avversative ad es fino ad a1 () αὐτὰρ ὁ δή ποτε ὣς τότε καὶ τότε ὣς ὁ μέν fino ad a2 () αὐτὰρ ἐπεί ἀλλ᾽ ὅτε δή ἔνθ᾽ ἄλλοι τοὶ μὲν ἔπειτ᾽ b) nel segmento centrale che va da m o da f fino a r o a b compare spesso il predicato verbale su cui gravita la frase (si veda a titolo di esempio il verso di Iliade sopra citato nel quale μετέφη si estende appunto da m a r) m r Iliade I 58 τοῖσι δrsquo ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς c) il segmento finale (a partire da r o da b) rappresenta il piugrave ricco serbatoio di nessi formulari innanzi tutto come nel caso di πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς le formule nome proprioepiteto ma anche molti casi di associazione fra nome comune ed epiteto ad es ξίφος ἀργυρόηλον φόρμιγγα λίγειαν πατρίδος αἴης θούριδος ἀλκή μώνυχες ἵπποι ὀξέϊ χαλκῷ πότνια μήτηρ Le formule tendono a organizzarsi in sistemi caratterizzati dalle tendenze complementari allrsquoestensione e allrsquoeconomicitagrave a) il principio dellrsquoestensione si connette alla tendenza dellrsquoepica a produrre nessi formulari atti a coprire tutto ciograve che nella narrazione sia tipico costante ripetitivo e a dislocare le formule coprendo le varie partizioni del verso ad es per Ettore troviamo tre formule finali di diversa estensione (φαίδιμος Ἥκτωρ κορυθαίολος Ἥκτωρ e μέγας κορυθαίολος Ἥκτωρ e una formula iniziale (Ἥκτωρ Πριαμίδης) b) il principio complementare al primo dellrsquoeconomia (o del risparmio) corrisponde al fatto che per esprimere una medesima idea essenziale esiste generalmente nella dizione epica una e una sola espressione che occupi una determinata unitagrave minore del verso Casi come μελαινάων ἐπὶ νηῶν e ἐϋσσέλμων ἐπὶ νηῶν sono doppioni apparenti hanno sigrave la stessa misura metrica ma iniziano lrsquouno in consonante con la connessa possibilitagrave di evitare lo iato o di allungare la sillaba precedente lrsquoaltro in vocale Non mancano tuttavia vere eccezioni come per lrsquohemiepes iniziale νῆας ἐπ᾽ Ἀργείων di Iliade XXIV 298 rispetto al consueto νῆας ἐπὶ γλαφυράς (16 volte) Lrsquouso di formule e soprattutto di sistemi formulari rappresentava per il poeta epico una facilitazione nel comporre improvvisando ma nella lunga evoluzione dellrsquoepica e specialmente al momento della definitiva fissazione di poemi monumentali come lrsquoIliade e lrsquoOdissea la
Letteratura greca [1]
9
sempre piugrave estesa memorizzazione di ampie zone di testo il lavorio di riflessione sui singoli episodi e sui nessi e i parallelismi fra gli episodi stessi e la scoperta di inedite possibilitagrave espressive connesse alla modificazione di formule tradizionali dovettero incoraggiare i poeti a uno sfruttamento consapevole e artisticamente meditato del ldquogioco delle formulerdquo Da un lato procedimenti come lrsquoaddensamento degli epiteti la sostituzione di un epiteto convenzionale con uno non convenzionale (con la creazione di un nesso nuovo di struttura metrica eventualmente diversa) il trasferimento di un epiteto da un referente a un altro creano nei poemi una continua tensione tra formularitagrave e superamento della formularitagrave dallrsquoaltro la rete delle corrispondenze a distanza generata dalla ripetizione di un determinato modulo permette al poeta di variare e approfondire un motivo e di sottolineare i parallelismi o le dissonanze fra determinate situazioni La guerra di Troia Schliemann e la riscoperta di Troia In etagrave moderna la riscoperta della cittagrave di Troia situata sullrsquoodierna collina di Hissarlik e sovrastante la bassa pianura attraversata dallo Scamandro a sud del promontorio del Sigeo si lega agli scavi di Heinrich Schliemann (1822-1890) che a partire dal 1866 si dedicograve al disseppellimento delle rovine di Micene di Tirinto e di altri siti micenei e appunto di Troia Nel corso del tempo si egrave venuta creando attorno alla personalitagrave di questo archeologo dilettante una sorta di leggenda a cui egli stesso contribuigrave con le autobiografie Ilios (1881) e Troja (1884) nel senso di un dilettantismo romantico di scavi avventurosi condotti con sorprendenti successi ma senza alcun rigore di metodo di un amore cieco e totale per Omero e per lrsquoEllade E in effetti oggi sappiamo che lrsquoaver percorso la Grecia e lrsquoAsia minore sulle vie di Omero non impedigrave a Schliemann a Micene di attribuire allrsquoepoca di Agamennone tombe anche di quattro secoli piugrave antiche neacute a Troia di identificare con la cittagrave omerica uno strato risalente a una fase che va dal 2300 al 2100 aC Errori del genere non dipesero tuttavia da un entusiasmo velleitario quanto dalla carenza allrsquoepoca di competenze archeologiche che potessero orientarlo verso una piugrave plausibile cronologia di reperti e di strati Occorre poi tener conto che lo strato dei materiali riferibili alla Troia omerica (o almeno a quella che oggi noi identifichiamo con la cittagrave omerica Troia VIIa) era conservato unicamente nel suo margine esterno dato che gli strati superiori della collina di Hissarlik (con le fondamenta dei palazzi e dei templi) erano stati demoliti in epoca ellenistica per realizzare il terrazzamento del suolo su cui vennero edificati nuovi templi Fu soprattutto per questa ragione che Schliemann si spinse con le proprie maestranze a scavare sempre piugrave in profonditagrave saltando gli strati del secondo millennio Dove perograve il problema consisteva nellrsquoidentificazione di un sito sulla scorta della comparazione fra gli antichi racconti e il panorama attuale Schliemann conseguigrave notevoli successi in primo luogo identificando con la collina di Hissarlik quellrsquoacropoli omerica che lrsquoopinione comune dalla fine del XVIII secolo individuava invece nel villaggio di Bunarbaschi situato su un colle a 15 km dal promontorio del Sigeo e la disputa era stata viva giagrave nellrsquoantichitagrave Ellanico di Lesbo verso il 400 aC aveva sostenuto nei suoi Troica che la Ilio del suo tempo sorta presso la collina di Hissarlik e la Ilio omerica occupavano lo stesso sito invece Demetrio di Scepsi (fr 26 Gaede) si era pronunciato per una collina a circa 9 km a sud sullrsquoaltra riva dello Scamandro La missione americana guidata nel 1932-1938 da CW Blegen e le piugrave recenti indagini sul territorio hanno offerto un quadro molto piugrave articolato e differenziato Sulla base di un nuovo diagramma la cittagrave che sorgeva al momento in cui Eratostene di Cirene fissava la caduta di Troia (1184) viene a coincidere con Troia VIIa non piugrave con quella che Schliemann chiamava laquoterza cittagraveraquo (corrispondente a Troia II) ma nemmeno come voleva W Doumlrpfeld con Troia VI (andata in rovina verso il 1300 in seguito a un terremoto) Gli scavi piugrave recenti Secondo le conclusioni di Manfred Korfmann (cfr Korfmann 2002) che ha diretto lrsquoeacutequipe dellrsquoUniversitagrave di Tubinga negli scavi piugrave recenti lrsquoantica Troia intorno al 1184 cessograve di essere abitata ma lrsquoinsediamento continuograve nellrsquoarea della rocca per circa due secoli dopo la distruzione
Letteratura greca [1]
10
della cittagrave (Troia VIIb) Verso il 700 il luogo chiamato laquoIlioraquo era largamente in rovine anche se in etagrave arcaica dovette continuare a essere frequentato come luogo di culto Il problema che si dovettero porre nellrsquoVIII secolo aC lsquoOmerorsquo o i suoi modelli dovette essere quello di rendere il racconto della guerra di Troia plausibile a un pubblico che aveva familiaritagrave con la geografia locale (lrsquoIliade offre indicazioni realistiche ad es sulla navigazione dellrsquoEgeo in IX 362 s e sulla visibilitagrave dellrsquoisola di Samotracia dalla piana di Troia in XIII 11-14) che si trattasse di genti che risiedevano nel Sigeo o in altre cittagrave vicine o di abitanti della stessa Ilion che nellrsquoVIII secolo era di nuovo attiva sia pure soltanto come centro cultuale Il santuario sorgeva allrsquointerno di una depressione naturale a sud-ovest della rocca lungo la vecchia via che conduceva alla rocca stessa Omero menziona due templi quello di Apollo e quello di Atena e le loro loro rovine sono tuttora riconoscibili I visitatori che giungevano al santuario dal Sigeo attraverso la piana dello Scamandro potevano vedere le rovine della rocca Ma - ci si chiede - quando ebbe fine il nucleo della cittagrave di Troia cantata da Omero Nel bastione a nord-est della rocca egrave stata trovata una larga e profonda cisterna con un condotto che proviene da una sorgente La sorgente fu abbandonata al piugrave tardi al tempo di Troia VIIb2 prima del 1100 A partire dal 1000950 non rimase a Troia alcun insediamento significativo Troia era molto piugrave larga di quanto ritenesse Schliemann Un fossato largo 3 m e profondo 15 completato durante lrsquoultima fase di Troia VI o al principio di Troia VIIa (cioegrave intorno al 1300) la circondava Poi esso fu rimpiazzato a sud da un fossato piugrave ampio e concentrico al primo completato verso il 1200 Il sistema di fortificazione si estendeva per quasi 2 km e pertanto racchiudeva unrsquoarea di circa 270000 m2 La rocca e la cittagrave bassa dovevano presentarsi al tempo di Omero come un imponente complesso di rovine I nuovi colonizzatori del Sigeo e di altri siti incontrarono un vasto campo attraversato da sentieri che seguivano i vecchi tracciati Negli scavi fatti nei quartieri della cittagrave bassa a sud-ovest della rocca poco fuori del muro si egrave scoperto un deposito bruciato verso la fine di Troia VI e di nuovo verso la fine di Troia VIIa (verso il 1200) La prima devastazione egrave da ricollegarsi a un terremoto ma la seconda sembra dovuta a unrsquoazione di guerra come suggerisce anche il rinvenimento di corpi insepolti o semisepolti e di depositi contenenti armi non utilizzate Verso il 1300 la porta principale di Troia era stata bloccata e ostruita percheacute qui lrsquoantico muro era in condizioni precarie e pertanto rappresentava lrsquoanello piugrave vulnerabile nel sistema di difesa Giagrave W Doumlrpfeld aveva richiamato Iliade VI 433 s (Andromaca a Ettore)
Piazza lrsquoesercito presso il fico selvatico dove egrave piugrave facile Lrsquoaccesso alla cittagrave e il superamento delle mura
In questa zona solo poco piugrave di 80 m separavano il muro della cittagrave bassa dal muro della rocca Gli epiteti omerici di Troia - laquoben costruitaraquo laquofertileraquo laquovastaraquo laquosacraraquo laquoertaraquo laquoventosaraquo laquodalle belle muraraquo laquodai bel puledriraquo - si adattano ai dati topografici ossa di cavalli sono state trovate sul terreno forti venti soffiano continuamente in estate Anche le sorgenti sono identificabili presso la porta principale cfr Iliade XXII 145-157
Passarono oltre il posto di vedetta e lrsquoalbero di fico battuto dal vento e allontanandosi sempre piugrave dalle mura si lanciarono lungo la strada Giunsero alle fontane dalle belle acque dove sgorgano due correnti dello Scamandro impetuoso una di acqua calda da cui si leva un vapore come da fuoco ardente lrsquoaltra che in piena estate versa acqua gelata come la grandine la fredda neve o il ghiaccio Vi sono accanto dei lavatoi di pietra larghi belli dove le mogli e le belle figlie dei Teucri lavavano le splendide vesti prima in tempo di pace prima che giungessero i figli dei Danai
[Tr di MG Ciani] In effetti gli scavi nellrsquoarea della caverna in cui egrave situata la sorgente hanno portato alla luce una struttura simile a una miniera con tre gallerie e altri bracci tributari creata per fornire acqua Lrsquoacqua scorreva attraverso una superficie rocciosa e poi in un canale artificiale che a sua volta raggiungeva un sistema di quattro lsquodepressionirsquo o lsquofossersquo circolari scavate nella roccia della
Letteratura greca [1]
11
misura di quasi 1 m di diametro (appunto parrebbe i πλυνοί hellip λαΐνεοι i laquolavatoi di pietraraquo ricordati da Omero) Achei e Troiani Fra XIII e XII secolo aC Troia era un grande centro politico e commerciale in grado di controllare lrsquoaccesso ai Dardanelli (lrsquoantico Ellesponto) e il trasporto su terra di beni di vario genere dalla costa egea al Mar di Marmara (lrsquoantica Propontide) e al Mar Nero In Troia VIIa egrave stata rinvenuta ceramica micenea del periodo noto come Tardo Elladico IIIB che egrave anche il periodo di maggiore splendore dei palazzi micenei sul continente greco Ersquo suggestiva lrsquoidentificazione piugrave volte avanzata in tempi recenti di TroiaIlio con Wilusa la cittagrave menzionata spesso in testi hittiti e oggetto di contesa fra gli Hittiti e quegli Ahhiyawa il cui nome sembra identificarsi con quello degli laquoAcheiraquo (Ἀχαιοί) Il documento piugrave significativo in proposito egrave il preambolo del trattato stipulato verso il 1280 aC fra il re hittita Muwattali II e Alaksandu re di Wilusa che contiene un richiamo alle precedenti relazioni fra i due stati a partire dal 1600 pur ricordando che un tempo Wilusa era sotto il dominio hittita Muwatalli afferma di aver mantenuto relazioni pacifiche anche dopo che la cittagrave era divenuta indipendente Inoltre un testo religioso hittita rinvenuto a Hattusa la capitale dellrsquoimpero hittita e databile al XIII secolo ricorda nellrsquoambito di un rituale la recita di un poema in luvio (il luvio egrave una lingua indo-europea che si distingue solo superficialmente dallrsquohittita) di cui viene riportato il primo verso laquoQuando tornarono dallrsquoerta Wilusaraquo E a Troia negli scavi piugrave recenti egrave stato trovato un sigillo con unrsquoiscrizione in luvio Drsquoaltra parte in Omero la dinastia reale troiana di cui egrave a capo Priamo figlio di Laomedonte viene fatta risalire attraverso Erittonio Troo e Ilo fino a Dardano eponimo dei Dardani che si erano stanziati nella Troade a nord del monte Ida (Iliade ΧΧ 215 ss) I Dardani nellrsquoIliade compaiono fra i principali alleati dei Troiani accanto ai contingenti provenienti da Zelea (a nord-est lungo il fiume Esepo) e a quelli di localitagrave situate sulla Propontide come Adrestea e Pitea e sulla costa asiatica dellrsquoEllesponto come Abido e Arisbe Dalla costa europea arrivano invece i Traci i Ciconi e i Peoni da oriente i Paflagoni e gli Alizoni da sud-est i Misi e i Frigi dalla zona sud-occidentale dellrsquoAnatolia i Meoni i Cari e i Lici Se Dardani Peoni Ciconi e Traci fanno parte delle popolazioni traco-frigie che fra XII e XI secolo erano scese dai Balcani in direzione dellrsquoAnatolia (cfr Erodoto 7 73 e Xanto di Lidia FGrHist 765 F 14) i Meoni sono di stirpe lidia mentre i Cari e i Lici appartengono allrsquoambito culturale e linguistico luvio-hittita Comunque sia diversamente che per Erodoto il quale inserisce il rapimento di Elena nel quadro di una serie di torti reciproci in forma di rapimenti di donne fra Greci e barbari (I 2 1) e per i poeti tragici ateniesi del V secolo aC in Omero lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato come un contrasto fra culture diverse I Troiani mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei (detti anche laquoDanairaquo - cioegrave discendenti di Danao - o laquoArgiviraquo in relazione al contingente proveniente dallrsquoArgolide guidato da Agamennone il capo della spedizione) e lo stesso vale per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari in Iliade ΙΙ 867 come laquodi lingua stranieraraquo (βαρβαρόφωνοι) suggerisce che un tale epiteto non sarebbe stato applicabile ai Troiani Infine sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di unrsquoimbarcazione sono altrettanti esempi di quelle che W Arend denominograve laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini comportamentali e tecnologiche del gruppo che le condivide (vedi scheda p xxx) La societagrave omerica
Letteratura greca [1]
12
Nel rapporto fra il mondo omerico e la storia egrave innanzi tutto da sottolineare lrsquoesistenza di un duplice piano di riferimento con talune interferenze dellrsquouno nellrsquoaltro da un lato crsquoegrave lrsquoorizzonte dei fatti collocati in un passato glorioso dallrsquoaltro lrsquoorizzonte del poeta Giagrave gli studiosi alessandrini del resto notavano che dati come lrsquoarte di montare a cavallo i segnali per mezzo della tromba e lrsquouso di bollire la carne compaiono nellrsquoIliade solo allrsquointerno delle similitudini E il testo con una sorta di arcaismo intenzionale mostra talora la consapevolezza dellrsquoabisso che separa passato e presente come quando in Iliade XII 445-449 si dice
Ettore intanto un sasso afferrograve ndash e lo portava ndash che prima stava davanti alle porte largo di sotto ma sopra era a punta questo due uomini i piugrave forti del popolo difficilmente isserebbero da terra su un carro quali son ora i mortali egli da solo lo roteava a suo agio
[Tr di R Calzecchi Onesti] Per contro le condizioni sociali rappresentate nei poemi (un mondo di grandi proprietari terrieri che reggono aziende agricole autarchiche da cui hanno preso tuttavia a distaccarsi alcune figure di artigiani il fabbro il vasaio il carpentiere il medico lrsquoindovino lrsquoaedo) rispecchiano assai piugrave la situazione storica fra VIII e VII secolo a C che le strutture della societagrave micenea Inoltre i cadaveri vengono cremati secondo la prassi piugrave recente non inumati anche se molti riferimenti omerici non rispecchiano necessariamente la pratica normale del tempo di pace trattandosi di cremazioni che avvengono oltremare non ambigua egrave comunque la testimonianza relativa alla prassi umana in generale fornita da Odissea XI 216-222 (Anticlea a Odisseo)
Ohimegrave figlio mio il piugrave misero di tutti gli uomini Persefone la figlia di Zeus non ti inganna ma la legge degli uomini egrave questa quando si muore i nervi non reggono piugrave la carne e le ossa ma la furia violenta del fuoco ardente li disfa appena la vita abbandona le bianche ossa e lrsquoanima vagola volata via come un sogno
[Tr di GA Privitera]19 Un esempio significativo di sovrapposizione tra fasi culturali distinte si coglie osservando lrsquoinventario degli oggetti accanto ad armi vasi ornamenti tipici dellrsquoVIII-VII secolo troviamo relitti risalenti allrsquoepoca micenea come la coppa di Nestore ornata di colombe descritta in Iliade XI 632 ss (simile a una coppa drsquoargento rinvenuta a Micene che riproduce disegno e artigianato dellrsquoetagrave del bronzo) lrsquoelmo di cuoio con zanne di cinghiale che Merione dagrave a Odisseo (Iliade X 261 ss) e lo scudo lungo laquosimile a torreraquo di Aiace che egrave di un tipo inusitato dopo il XIII secolo Un oggetto non riferibile neacute al mondo miceneo neacute allrsquoetagrave della fissazione dei poemi bensigrave alla prima etagrave del ferro egrave invece la coppia di aste da lancio adottate verso il 900 aC e scomparse due secoli dopo con lo sviluppo del combattimento oplitico e la reintroduzione dellrsquoasta per colpire e la menzione delle navi fenicie (una volta nellrsquoIliade e cinque volte nellrsquoOdissea) riflette la loro comparsa nellrsquoEgeo nel IX secolo aC Non diversamente sembra avvenire anche per le istituzioni politiche lrsquo ἄναξ egrave visto a volte come figura di autocrate assoluto a volte fortemente limitato dai poteri delle assemblee ndash sia quella dei capi (βουλή) sia quella delle truppe (ἀγορή) ndash o insidiato dallrsquoascesa dei gruppi aristocratici mentre il βασιλεύς non egrave piugrave il dignitario della societagrave micenea ma genericamente un principe o un capo LʼIliade
19 Omero Odissea III intr testo e commento di A Hoekstra tr di GA Privitera Mondadori Milano 1984
Letteratura greca [1]
13
LrsquoIliade (Ἰλιάς) consta di circa 15690 esametri divisi secondo una partizione che potrebbe risalire al primo editore alessandrino (Zenodoto di Efeso) in 24 libri indicati con le lettere maiuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquounitagrave strutturale di parecchi canti che spesso finiscono col tramonto o iniziano con lrsquoalba e la coincidenza fra alcuni dei titoli attribuiti a ciascun canto nelle edizioni alessandrine e quelli che si rintracciano in autori precedenti (ad es Tucidide [I 10 4] cita il ldquoCatalogo delle navirdquo cioegrave il canto II) provano che non si trattograve di una divisione arbitraria bensigrave fondata almeno in certa misura sulle abitudini dei rapsodi Tema dellrsquoopera non egrave lrsquointero assedio decennale di Troia da parte dei Greci (di norma detti Achei o Danai o Argivi) provocato dal rapimento di Elena ad opera di Paride ma una porzione assai limitata del conflitto una sequenza narrativa che copre la durata di 51 giorni e si colloca verso la fine del nono anno di guerra lrsquoira di Achille contro lrsquoAtride Agamennone il suo ritiro dalla guerra e le relative conseguenze la fine dellrsquoira lrsquouccisione e i funerali di Ettore Fu proprio questa delimitazione tematica a consentire la realizzazione di quellrsquounitagrave e compiutezza dellrsquoazione che giagrave Aristotele individuava come uno dei pregi essenziali dellrsquoopera di Omero rispetto agli altri poemi epici arcaici (Poetica 1459a-b)20
anche in questo Omero deve apparire mirabile in confronto agli altri per non aver tentato di rappresentare intera la guerra anche se essa aveva un principio e una fine il racconto sarebbe risultato troppo grande e non abbracciabile con uno sguardo oppure pur misurato nella grandezza intricato per la varietagrave Ricavatane invece una parte ha fatto uso di molti episodi per esempio con il ldquoCatalogo delle navirdquo e con altri episodi fa procedere in lungo il poema Gli altri invece come lrsquoautore delle Ciprie o della Piccola Iliade compongono unrsquoazione multipla su unrsquounica persona o un unico tempo Di conseguenza mentre dallrsquoIliade e dallrsquoOdissea si ricava unrsquounica tragedia o soltanto due da ciascuna dalle Ciprie parecchie
[Tr di D Lanza]21
Canto I Lrsquoazione si apre sul campo degli Achei devastato dalle frecce scagliate da Apollo [T1] il dio ha scatenato una pestilenza percheacute Agamennone ha rifiutato il riscatto offerto dal sacerdote Crise per la liberazione della figlia Criseide divenuta schiava dellrsquoAtride Ai guerrieri convocati in assemblea lrsquoindovino Calcante rivela che la sola via di scampo egrave la restituzione di Criseide al padre Agamennone acconsente ma solo a patto che gli venga data in cambio Briseide la schiava che Achille tiene nella sua tenda come premio personale (γέρας) ricevuto dagli altri guerrieri Achille non puograve opporsi alla prevaricazione dellrsquoAtride ma non egrave disposto a subire passivamente lrsquooltraggio e insulta Agamennone anzi egrave giagrave pronto a estrarre la spada dal fodero per farsi giustizia quando viene trattenuto da Atena apparsa allrsquoimprovviso allora si ritira nella tenda giurando che non combatteragrave piugrave [T2] Quindi invoca la madre Tetide che dopo essere apparsa al figlio sulla riva del mare intercede presso Zeus e ottiene la promessa che i Greci non vinceranno la guerra e non espugneranno Troia fincheacute Achille non riceveragrave soddisfazione per lrsquooffesa subita Ma il piano di Zeus non resta celato ad Era che ingelosita provoca una lite nel corso del banchetto degli dei tuttavia la visione di Efesto zoppicante che funge da coppiere suscita lrsquoilaritagrave dei numi e riporta la serenitagrave Canto II Quella stessa notte Zeus manda ad Agamennone un sogno ingannatore per incitarlo ad attaccare Troia LrsquoAtride riferisce il sogno agli anziani e comanda lrsquoadunata dellrsquoesercito
20 Cfr anche 1462b ταῦτα τὰ ποιήματα συνέστηκεν ὡς ἐνδέχεται ἄριστα καὶ ὅτι μάλιστα μιᾶς πράξεως μίμησις (laquoQuesti poemi sono composti come meglio non si puograve e son il piugrave possibile imitazione di unrsquounica azioneraquo) 21 Aristotele Poetica Milano Rizzoli 19902
Letteratura greca [1]
14
con lrsquoidea stravagante di saggiare lrsquoumore delle truppe proponendo il ritorno in patria Gli uomini incitati da Tersite corrono alle navi pronti a salpare ma vengono bloccati da Odisseo e da Nestore Egrave significativo che Tersite lrsquoanti-eroe riecheggi le accuse di Achille ad Agamennone sottolineando gli onori di cui questi gode e prenda le parti di Achille [T3] Per tutta la seconda parte del libro lrsquoazione viene interrotta per far posto alla grandiosa uscita in armi dellrsquoesercito acheo dal recinto delle navi un quadro scintillante ornato da una catena di sei similitudini concatenate introdotte per illustrare il fulgore delle armi il rombo dei passi umani e degli zoccoli precipitosi lrsquoaspetto della schiera achea e la maestria dei condottieri Un ldquoCatalogo delle navirdquo contiene lrsquoelenco circostanziato delle genti greche che hanno preso parte allrsquoassedio ed egrave seguito da un catalogo piugrave breve e piugrave arido degli alleati dei Troiani accorsi in difesa di Ilio Canto III Lrsquoatteso scontro tra gli schieramenti appena passati in rassegna non ha luogo ParideAlessandro ottiene infatti una tregua per sfidare Menelao Iride la messaggera degli degravei spinge Elena ad accorrere alle mura presso le porte Scee per assistere al preannunciato duello di ligrave Priamo e gli altri anziani di Troia osservano la pianura Su richiesta del vecchio sovrano (una richiesta che sarebbe stata piugrave ldquoverosimilerdquo al primo anno di guerra) Elena nomina i piugrave prestigiosi campioni achei [T4] Nel duello che segue Paride si trova ben presto a mal partito contro Menelao ma Afrodite lo sottrae ai colpi del nemico avvolgendolo in una fitta nebbia e lo riporta nelle sue stanze dove dopo aver assunto lrsquoaspetto di una vecchia filatrice ordina a Elena di giacere con lui Elena si ribella ma la dea non transige Mentre Paride ed Elena si uniscono nellrsquoamplesso Menelao furibondo cerca fra la folla il nemico che sia i Greci che i Troiani sarebbero lieti di consegnargli pur di porre fine alla guerra Agamennone rivendicando la vittoria di Menelao pretende dai Troiani la restituzione di Elena e delle sue ricchezze noncheacute il pagamento di una forte ammenda Canto IV La tregua stipulata dopo la scomparsa di Paride viene infranta dallrsquoarciere Pandaro che sollecitato da Atena (scesa tra le schiere troiane su ordine di Zeus) ferisce con una freccia Menelao questi viene prontamente guarito dal medico Macaone figlio di Asclepio Agamennone passa fra le schiere incitandole a combattere incontra vari capi intenti a dare istruzioni ai propri uomini Solo Ulisse e Menesteo si tengono in disparte ricevendo i rimproveri di Agamennone ai quali Ulisse reagisce con indignazione Gli Achei muovono contro i Troiani con grande ordine e disciplina mentre i Troiani e i loro alleati schiamazzano come barbari Ha inizio la battaglia vera e propria nella quale lrsquoattenzione egrave focalizzata sui duelli individuali Ad assistere e rincuorare i Troiani compare Apollo sulla rocca di Troia mentre Atena infonde coraggio nei Greci Il canto si chiude sullrsquoinfuriare della battaglia la cui descrizione riprenderagrave nel canto successivo Canto V Balza in primo piano Diomede di cui viene presentata lrsquoἀριστεία lrsquoeroe laquoglorioso e chiaroraquo fa strage di nemici imperversando furiosamente fra le schiere troiane Nel pieno del combattimento viene ferito da una freccia scagliata da Pandaro il quale mena gran vanto del colpo andato a segno Diomede ottenuta unrsquoimmediata guarigione grazie allrsquointervento di Atena muove allora contro il nemico che nel frattempo era stato accolto sul carro di Enea Pandaro scaglia la sua lancia contro Diomede ma lo scudo di questi regge il colpo Diomede colpisce a sua volta uccidendo il nemico Enea scende dal cocchio per proteggere il cadavere di Pandaro dagli Achei che vorrebbero farne razzia ma Diomede lo colpisce con un grande masso fratturandogli il femore Enea viene salvato dallrsquointervento di Afrodite che lo avvolge nel suo manto mentre Diomede arriva addirittura a ferire al polso la dea che fugge sullrsquoOlimpo a farsi confortare dalla madre Dione Il figlio di Tideo attacca anche Apollo che aveva sottratto Enea alla sua furia ma
Letteratura greca [1]
15
egrave fermato dal grido di ammonimento del dio Incitati e aiutati da Ares ora i Troiani avanzano con impeto Intervengono Era e Atena e questrsquoultima assume il ruolo di auriga di Diomede Col suo aiuto questi ferisce al ventre Ares che fugge sullrsquoOlimpo Anche le dee vi fanno ritorno Canto VI Il canto VI egrave una naturale continuazione del V (tanto che Erodoto citeragrave come dallrsquoἀριστεία di Diomede un brano della prima parte del VI canto) La battaglia infuria nella pianura ma il furore di Diomede si stempera su una nota di cortesia quando lrsquoeroe dopo aver sfidato Glauco di Licia scopre di avere con lrsquoavversario antichi rapporti di ospitalitagrave I due si scambiano le armature (a detrimento di Glauco a cui laquoZeus Cronide levograve il senno cheacute scambiograve con Diomede Tidide armi drsquooro con armi di bronzo cento buoi con nove buoiraquo [vv 234-6]) Frattanto Ettore su invito dellrsquoindovino Eleno rientra in cittagrave dove le donne devono cercare di ottenere con offerte e voti il favore di Atena e incontra dapprima la madre Ecuba poi Paride (che intende ricondurre alla battaglia) vorrebbe salutare anche la moglie ma non la trova in casa bensigrave alle porte Scee dove Andromaca era accorsa piena drsquoangoscia insieme col figlioletto e con la nutrice Nel colloquio che segue ella lo implora di non esporre al pericolo se stessa e il figlio La replica di Ettore egrave esemplare per capire la prospettiva del poema e le motivazioni dellrsquoagire dei personaggi dominanti se Achille e gli eroi achei in genere cercano onore e gloria a questa motivazione (che pure non egrave assente) Ettore antepone lrsquoαἰδώς il senso di laquovergognaraquo e di responsabilitagrave nei confronti della comunitagrave e del nucleo familiare di cui egrave il difensore Poi si volta per prendere tra le braccia Astianatte ma lrsquoelmo lucente e il cimiero ondeggiante impauriscono il piccolo che si rifugia in seno alla nutrice Alla fine del canto Paride si incontra con Ettore e i due si avviano verso il campo di battaglia [T5] Canto VII A principio del canto VII Atena e Apollo si accordano per indurre Ettore a lanciare una sfida agli Achei per un duello Il sorteggio designa Aiace come campione greco Nello scontro Ettore lancia per primo lrsquoasta che penetra ma senza trapassarlo nello scudo di Aiace greve e massiccio (compaginato con sette strati di pelle bovina simile a una torre) Aiace di rimando lacera lo scudo e il pettorale della corazza ma non riesce a squarciare le carni del nemico percheacute Ettore si piega di lato Allora i due brandiscono di nuovo le aste poi ricorrono alle pietre Alla fine gli araldi arrestano il combattimento con la giustificazione che laquola notte giagrave viene ed egrave bene obbedire alla notteraquo (v 282) Su proposta di Nestore gli Achei decidono per il giorno seguente di seppellire i morti e di scavare una grande trincea difesa da un bastione sul margine del loro accampamento Respingono lrsquoofferta di pace dei Troiani (che prevederebbe la riconsegna dei tesori sottratti da Paride a Sparta) Il mattino seguente i morti vengono cremati e durante la giornata si erige il muro di protezione Canto VIII Nellrsquoassemblea degli degravei Zeus vieta ai numi di appoggiare lrsquouna o lrsquoaltra parte in conflitto Al mattino il combattimento riprende e a mezzogiorno Zeus pone i destini dei due popoli sulla bilancia che piega a favore dei Troiani Sul campo di battaglia Diomede salva Nestore Lrsquoazione di Ettore egrave travolgente fincheacute Zeus contravvenendo alla sua intenzione di favorire i Troiani accoglie la preghiera di Agamennone per risollevare il morale degli Achei che organizzano la difesa delle navi Nel corso degli scontri si segnala lrsquoarciere Teucro che colpisce i nemici muovendosi in sincronia con Aiace Telamonio che lo protegge con lo scudo Incitato da Agamennone egli prova a colpire anche Ettore ma soccombe colpito con una pietra A questa vista Era e Atena corrono ad armarsi per intervenire a favore degli Achei ma vengono distolte dalle minacce di Zeus che manifesta la propria intenzione di favorire i Troiani fino a quando i Greci non saranno ridotti alla disperazione tanto da scongiurare Achille percheacute ritorni Il sopraggiungere della notte
Letteratura greca [1]
16
interrompe i combattimenti Ettore galvanizzato dai successi ottenuti in quel giorno si illude che la vittoria sia a portata di mano e prospetta ai suoi una prossima ritirata degli Achei Il canto si chiude con il banchetto dei Troiani che banchettano nella pianura esaltati dalla speranza di vittoria Canto IX Agamennone affranto propone di fare ciograve che nel canto II aveva suggerito soltanto per mettere alla prova lrsquoesercito interrompere la guerra e tornare in patria Diomede si oppone e Nestore in un consiglio dei capi propone di tentare la riconciliazione con Achille Si invia alla tenda di Achille unrsquoambasceria (composta da Aiace Odisseo e Fenice antico pedagogo di Achille) per offrire doni ricchissimi Achille non cede anzi minaccia di salpare immediatamente verso la patria [T6] Inutilmente Fenice lrsquoantico precettore di Achille cerca di ammorbidire la determinazione del Pelide richiamando la vicenda dellrsquoeroe Meleagro [T7] Gli inviati riferiscono ad Agamennone la risposta di Achille egli torneragrave a combattere solo quando Ettore saragrave arrivato fino alle navi dei Mirmidoni Canto X Nella stessa notte si effettua una missione segreta nel corso della quale Odisseo e Diomede dapprima catturano la spia troiana Dolone (che Ettore aveva inviato alle navi achee promettendogli come ricompensa i cavalli di Achille) poi uccidono il re trace Reso appena arrivato presso i Troiani e ne rubano i magnifici cavalli Giagrave gli antichi ritenevano questo canto unrsquoaggiunta post-omerica e questi dubbi trovano riscontro in lati eccentrici della narrazione e nellrsquoimpiego di un linguaggio che spesso appare svincolato dal corrente repertorio formulare Canto XI Si apre una nuova giornata di battaglia (la cui narrazione si protrarragrave fino al canto XVIII) che ruota intorno allrsquoἀριστεία di Agamennone Quando lrsquoAtride viene ferito gli Achei ripiegano Diomede resta anchrsquoegli ferito Odisseo e Aiace evitano a stento la massa dei nemici Nestore salva sul suo carro Macaone Achille che dalla poppa della nave osserva la battaglia vuol sapere chi egrave condotto via da Nestore e manda Patroclo che viene accolto molto benevolmente e con cui Nestore intrattiene un lungo discorso egli dice di deplorare il comportamento di Achille e con atteggiamento consono alla sua condizione di anziano si dilunga nel raccontare le proprie gesta giovanili Egli esorta quindi Patroclo a far leva sulla sua amicizia per convincere Achille a riprendere il combattimento o - almeno - a concedere a Patroclo le sue armi per incutere timore nei Troiani Eccitato dalle parole del vecchio Patroclo si avvia verso la nave di Achille ma incontra Euripilo ferito che gli chiede aiuto ed egli impietositosi lo accompagna alla tenda e cura la ferita Canto XII Divisi in cinque contingenti i Troiani danno lrsquoassalto al muro eretto a difesa del campo acheo Sul campo di battaglia si manifesta un prodigio unrsquoaquila in cielo con un grosso serpente fra le zampe che riesce a ferire lrsquouccello e a sfuggire Polidamante che interpreta il segno come un presagio funesto consiglia di tornare indietro ma Ettore egrave di altro avviso Sarpedone e Glauco sferrano un attacco contro il muro e - pur rimanendo feriti - riescono ad aprire una breccia La battaglia infuria con esito incerto fincheacute Ettore con un macigno sfonda una delle porte consentendo ai Troiani di entrare in massa nel campo acheo mentre i Greci fuggono verso il mare Canto XIII Zeus distoglie lo sguardo dalla battaglia nella convinzione che nessuno fra gli dei avrebbe osato violare il divieto di intervenire ne approfitta invece Poseidone favorevole ai Greci Assunto lrsquoaspetto dellrsquoindovino Calcante il dio infonde nuovo vigore nei due Aiaci
Letteratura greca [1]
17
spronandoli al combattimento Gli Achei riconoscono lrsquointervento divino e riprendono fiducia I combattimenti si susseguono violentissimi Nella resistenza si distingue il re cretese Idomeneo Polidamante consiglia una seconda volta di interrompere la battaglia e accenna allrsquoimminente intervento di Achille Ettore non ascolta lrsquoammonimento e riprende lrsquoassalto Il canto si chiude con un suo scambio di insulti con Aiace Telamonio Canto XIV Mentre Diomede Odisseo e Agamennone tornano feriti allrsquoaccampamento Era per distogliere Zeus dalla battaglia e consentire a Poseidone di favorire gli Achei indossa la cintura magica di Afrodite e sollecita il consorte a un convegno amoroso sullrsquoIda dopo lrsquoamplesso Zeus cade in un sonno profondo e Hypnos (il Sonno) annuncia a Posidone che potragrave aiutare senza rischi gli Achei Ettore colpito con una pietra da Aiace resta a lungo in stato di incoscienza e i Troiani vengono respinti Canto XV Zeus si risveglia avvedendosi dellrsquoinganno subito e costringe Era a mandargli Iride e Apollo la prima allontaneragrave Posidone dal campo di battaglia Apollo inciteragrave Ettore a far retrocedere gli Achei fino alle navi dei Mirmidoni Riprende lrsquooffensiva troiana Apollo stesso abbatte il muro e scuotendo lrsquoegida atterrisce gli Achei Patroclo corre da Achille mentre i Troiani giagrave sono sul punto di appiccare il fuoco alle navi Canto XVI Patroclo in lacrime supplica Achille di intervenire o di mandare lui stesso al suo posto [T8] Achille gli consegna le proprie armi e gli fa promettere che non si avventureragrave oltre la zona delle navi Ma Patroclo trascinato dal suo stesso impeto oltrepassa il limite prescrittogli da Achille Abbatte Sarpedone figlio di Zeus attorno al cui cadavere infuria la lotta fincheacute Apollo lo sottrae alla mischia e Hypnos e Thanatos (il demone della morte) lo trasportano in Licia sua patria Patroclo continua lrsquoassalto alla testa dei Mirmidoni fin sotto le mura di Troia ma poco prima del tramonto al quarto assalto Apollo stesso assunto lrsquoaspetto di Asio lo percuote fra le spalle allora Euforbo lo colpisce con lrsquoasta ed Ettore lo trafigge Canto XVII Euforbo viene ucciso da Menelao ma Ettore riesce a catturare le armi di Achille indossate da Patroclo Vigorosamente sostenuti da Aiace gli Achei difendono il cadavere Una densa nebbia scende sui combattenti Zeus infonde nuovo ardimento nei cavalli di Achille piangenti per la fine di Patroclo [T9] Atena e Apollo arroventano la lotta attorno alla salma In seguito alla preghiera di Aiace Zeus dissolve la nebbia Menelao manda Antiloco figlio di Nestore a informare Achille della morte di Patroclo la cui salma viene intanto trascinata fuori della battaglia da Menelao e Merione mentre i due Aiaci offrono la necessaria copertura contro la furia incalzante dei nemici Canto XVIII Lo scoppio di selvaggio dolore a cui si abbandona Achille allrsquoudire della morte di Patroclo provoca lrsquoaccorrere dal mare di Tetide insieme con le Nereidi La madre gli promette di procurargli nuove armi Poicheacute la salma di Patroclo egrave tuttora contesa Achille fa la sua apparizione sul fossato e lancia un grido che atterrisce i nemici Efesto su preghiera di Tetide foggia le nuove armi fra cui un magnifico scudo su cui appaiono effigiati in bande concentriche gli aspetti salienti dellrsquoesistenza umana Canto XIX Il mattino seguente Tetide porta le armi al figlio e con lrsquoambrosia preserva la salma di Patroclo dalla decomposizione Achille convoca unrsquoassemblea dellrsquoesercito e rinuncia alla sua collera Agamennone lamenta di essere stato ldquoaccecatordquo da Zeus e promette doni
Letteratura greca [1]
18
riparatori [T10] Achille si lascia convincere a stento ad attendere che i soldati abbiano mangiato Poi gli armati si radunano e anche Achille si arma Il suo cavallo Xanto gli predice la prossima morte [T11] Canto XX Zeus consente agli degravei di partecipare alla nuova battaglia Enea scontratosi con Achille egrave tratto in salvo da Posidone Achille infuria come un incendio in una selva Canto XXI Achille colma di cadaveri il fiume Scamandro e cattura dodici giovani troiani che intende offrire in sacrificio a Patroclo non risparmia neppure Licaone figlio di Priamo che lo supplica con accenti di grande intensitagrave ma altrettanto intensa nella consapevolezza di un destino imminente egrave la pur spietata replica del Pelide [T12] Lo Scamandro solleva le proprie onde ma le fiamme di Efesto inaridiscono il terreno e domano la corrente Gli degravei si azzuffano Atena raggiunge Ares con una pietra Era rintuzza la furia di Artemide Infine tutti tornano sullrsquoOlimpo Apollo assunto lrsquoaspetto di Agenore respinge Achille percheacute i Troiani possano rifugiarsi allrsquointerno delle mura Canto XXII Il solo Ettore resta fuori nella pianura Invano Priamo ed Ecuba lo pregano di rientrare Mentre Achille si avvicina Ettore decide di affrontarlo ma quando quello gli egrave da presso col bronzo che gli lampeggia intorno laquosimile al raggio del fuoco ardente o del sole che sorgeraquo egrave afferrato dal panico e comincia a fuggire compiendo tre giri intorno alle mura Zeus pesa sulla bilancia i destini (le κῆρες) dei due eroi e quello di Ettore affonda in basso Allora Apollo lo abbandona e Atena apparsa a Ettore sotto le spoglie di suo fratello Deifobo gli si avvicina promettendogli aiuto e invece riporta ad Achille la lancia che gli era caduta fuori bersaglio Il colpo di risposta di Ettore rimbalza sullo scudo di Achille Ettore urla a Deifobo di passargli la sua lancia ma il falso Deifobo egrave scomparso ed Ettore comprende di trovarsi sullrsquoorlo dellrsquoabisso [T13] Achille gli trapassa la gola ed Ettore lo supplica di non oltraggiare la sua salma in risposta riceve la minaccia che finiragrave in pasto ai cani Achille trascina il cadavere alle navi attaccato al carro Priamo Ecuba e Andromaca si abbandonano al cordoglio a cui fanno eco le donne troiane Canto XXIII Viene preparato il banchetto funebre in onore di Patroclo la cui ombra nel corso della notte appare ad Achille chiedendo la sepoltura del corpo Il mattino seguente si appresta il rogo fra le offerte votive ci sono anche dodici giovani troiani Il giorno successivo si raccolgono le ossa di Patroclo Seguono i ludi funebri gare coi carri e con lrsquoarco duello in armi etc Canto XXIV Ogni giorno Achille trascina il cadavere di Ettore attorno alla tomba dellrsquoamico ma lo spettacolo offende gli degravei e al dodicesimo giorno Zeus decide di mandare Tetide percheacute induca suo figlio a restituire la salma di Ettore Iride viene inviata presso Priamo percheacute gli consigli di recarsi nel cuore della notte con un carro da trasporto e un copioso riscatto scortato da Ermes alla tenda di Achille Questi accoglie il vecchio con rispetto riconoscendo in lui lrsquoimmagine del padre lontano e si piega alla sua supplica [T14] Per volontagrave degli degravei il cadavere non egrave stato aggredito dalla putrefazione composto sul pianale del carro viene ricondotto dal padre a Troia Qui le lamentazioni rituali srsquoinnalzano dal gruppo delle donne (Andromaca Ecuba Elena) Si stipula una tregua di dodici giorni Per nove giorni i Troiani raccolgono legname poi anche il rogo di Ettore arde e si erige un tumulo
Letteratura greca [1]
19
Struttura e caratteri dellʼopera Poema di trama relativamente organica (soprattutto a partire dal canto XVI tutti gli avvenimenti tranne pochi episodi isolati ruotano attorno ai due principali antagonisti Ettore uccide Patroclo per vendicare Sarpedone e Achille uccide Ettore per vendicare Patroclo) pur se non privo di piugrave o meno cospicue incongruenze spiegabili in primo luogo con la lunga e complessa genesi orale dellrsquoopera lrsquoIliade lascia emergere in mezzo alle centinaia di nomi e alle intricate vicende alcuni caratteri delineati nella loro individualitagrave e innanzi tutto quelli di Achille e di Ettore accomunati dalla medesima coscienza di un destino di morte che sono pronti ad affrontare Appunto una tale attitudine a rappresentare i laquocaratteriraquo (ἤθη) dei suoi personaggi egrave un altro titolo di merito che Aristotele ascrive ad Omero (Poetica 1460a9-11)
dopo aver brevemente proemiato subito introduce un uomo una donna o un altro personaggio nessuno privo di caratterizzazione ma dotato di un carattere
Fondamentale per la struttura del poema egrave la novitagrave della prospettiva Possiamo presumere che i cosiddetti poemi ciclici22 mirassero a conservare lrsquoangolatura che era stata propria delle versioni pre-omeriche della saga troiana sigrave che puograve riuscire significativo il confronto fra lrsquoesordio della Piccola Iliade (dove muovendo da grandi entitagrave ndash la cittagrave il paese due popoli la guerra ndash viene lanciato secondo lrsquoespressione di J Latacz come laquouno sguardo dallrsquoesternoraquo)
Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην εὔπωλον ἧς πέρι πολλὰ πάθον Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος Canto Ilio e la terra dei Dardani dai bei puledri per la quale molti dolori patirono i Danai servitori di Ares
con lo laquosguardo internoraquo che caratterizza lrsquoinizio dellrsquoIliade
Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν ἡρώων αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν οἰωνοῖσί τε δαῖτα Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς Canta o dea di Achille figlio di Peleo la collera maledetta che pene innumerevoli inflisse agli Achei e molte scagliograve allrsquoAde vite possenti di eroi e ne faceva prede per i cani e pasto per gli uccelli e si avverava il volere di Zeus da quando primamente si separarono venuti a contesa LrsquoAtride sovrano di eroi e Achille magnifico
Argomento non egrave dunque come doveva avvenire nella tradizione del canto epico un evento complesso da inquadrare con un grandangolo onnicomprensivo e neppure come saragrave nellrsquoOdissea un personaggio colto nella multiforme varietagrave delle sue peregrinazioni egrave invece una reazione emotiva (lrsquoira di Achille) con le sue conseguenze (le innumerevoli morti degli Achei) Narrare di questa ira significa per il poeta cominciare da un punto preciso (laquoda quandoraquo) ossia dal momento della contesa e della separazione fra i due massimi eroi greci Agamennone il primo per potere (laquosovrano di eroiraquo) e Achille il primo per nobiltagrave e forza (δῖος) E sintomatica della bipolaritagrave del mondo epico in quanto mondo di degravei e di eroi egrave la sincronia per cui il taglio della narrazione coincide col decorso del laquovolere di Zeusraquo (Διὸς βουλή) forse da identificare con la promessa del dio a Tetide (rievocata piugrave oltre in questo
22 V cap II laquoLa tradizione omericaraquo
Letteratura greca [1]
20
stesso canto ai vv 518-527) di vendicare lrsquoaffronto subito da Achille o piugrave in generale con il corso degli eventi in quanto tutto come per definizione laquogiace sulle ginocchia di Zeusraquo Opera indubbiamente allrsquointerno del poema unrsquoidea formativa un progetto di qui un insieme monumentale unificato anche da una serie di corrispondenze a distanza fra cui particolare significato acquistano quelle fra primo e ultimo canto Nel canto I il vecchio Crise va come supplice presso Agamennone portando doni e supplicando la restituzione della figlia e Agamennone lo respinge aspramente minacciandolo di far ricorso alla violenza se dovesse tornare nel canto XXIV il vecchio Priamo va come supplice presso Achille portando doni e supplicando la restituzione del corpo del figlio Achille ha una prima reazione irosa (esordisce al v 560 con laquoSmetti di irritarmi vecchioraquo) ma poi accoglie la supplica E al di lagrave delle corrispondenze nelle linee dellrsquoazione si colgono fra principio e fine del poema alcuni importanti echi verbali in particolare fra XXIV 501 s
τοῦ νῦν εἵνεχ᾽ ἱκάνω νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενος παρὰ σεῖο φέρω δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα per lui [Ettore] vengo ora alle navi degli Achei per riscattarlo da te e ti porto compenso infinito
e I 12 s
ὁ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενός τε θυγάτρα φέρων δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα costui [Crise] venne alle navi rapide degli Achei per riscattare la figlia portando compenso infinito
fra XXIV 555-557
λῦσον ἵν᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδωmiddot σὺ δὲ δέξαι ἄποινα πολλά τά τοι φέρομενmiddot σὺ δὲ τῶνδrsquo ἀπόναιο καὶ ἔλθοις σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν restituiscimelo percheacute lo possa vedere con gli occhi e accogli il riscatto copioso che portiamo e tu possa goderne e tornare alla tua terra patria
e I 18-20
Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν εὖ δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκέσθαιmiddot παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην τὰ δ᾽ ἄποινα δέχεσθαι Atridi e voi altri Achei dai forti schinieri a voi concedano gli degravei che hanno le case in Olimpo di distruggere la cittagrave di Priamo e tornare facilmente in patria ma restituitemi la figlia e accettate il riscatto
fra XXIV 560 μηκέτι νῦν μ᾽ ἐρέθιζε (laquosmetti di irritarmiraquo) e I 32 μή μ᾽ ἐρέθιζε (laquonon mi irritareraquo) fra XXIV 568-570
τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς μή σε γέρον οὐδrsquo αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω καὶ ἱκέτην περ ἐόντα Διὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμάς Ora perciograve fra i dolori non mi eccitare lrsquoanimo ancora di piugrave bada o vecchio che non ti lasci neppure nella tenda
Letteratura greca [1]
21
bencheacute supplice e violi gli ordini di Zeus e I 26-28
μή σε γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω ἢ νῦν δηθύνοντ᾽ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο Mai te o vecchio io colga presso le concave navi ora a indugiare o piugrave tardi a tornare che piugrave non dovesse giovarti lo scettro e la benda del dio
(e infine XXIV 571 ὣς ἔφατ ἔδεισεν δ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ laquocosigrave diceva e il vecchio tremograve e obbediva alle paroleraquo ripete esattamente I 33) In effetti lrsquoepisodio terminale del poema col superamento dellrsquoira ad opera della pietagrave e del senso di unrsquoesistenza invasa dal dolore si propone come il rovesciamento consapevole dellrsquoepisodio iniziale che era apparso caratterizzato dalla cancellazione della pietagrave e del diritto dei supplici in nome della forza Al rifiuto iniziale del donoriscatto si oppone lrsquoaccettazione finale in consonanza con un principio-guida che opera nel poema secondo linee che alla fine si riunificano Agamennone restituisce Criseide al padre ma si appropria del dono fatto dagli altri Achei ad Achille (Briseide) Achille respinge i doni fatti da Agamennone per indurlo a riconciliarsi con lui ma dopo aver contestato nel IX canto la nozione che la vita umana possa essere barattata con una massa di beni torna alla lotta non in cambio di qualche premio da conquistare ma per vendicare lrsquouccisione dellrsquoamico Patroclo e tanto nella lotta sul campo di battaglia quanto nellrsquoinfierire sul cadavere di Ettore si abbandona a un furore cosigrave smisurato e patologico che puograve essere superato solo con lrsquoaccettare i doni di Priamo non tuttavia per il loro valore drsquouso ma percheacute in Priamo Achille riconosce lrsquoombra del padre lontano Cosigrave lrsquoIliade appare attraversata da un impulso fondamentale che muove dallrsquoideologia del dono e dalla conseguente centralitagrave assegnata allrsquoonore (τιμή) come ldquoprezzordquo che qualifica il valore del guerriero ma supera questo piano di valutazione dei rapporti umani attraverso la loro riformulazione nei termini di un umanesimo esistenziale che ha come punti di riferimento lrsquoidentitagrave universale dei condizionamenti oggettivi (la vecchiaia la malattia la morte) e i legami che uniscono padre e figlio compagno e compagno vivi e morti (il cordoglio finale di Andromaca Ecuba ed Elena sulla salma di Ettore) Entro questo orizzonte progressivamente allargato la guerra le lotte lo scontro mortale finiscono col rappresentare solo un momento e un aspetto dellrsquoesistenza graditi tanto agli degravei che vi assistono come spettatori interessati quanto agli uditori che riascoltano le antiche gesta eppure non tali da appiattire il poema in una prospettiva guerresca conclusa in se stessa Molto del fascino delle battaglie e delle ἀριστεῖαι dellrsquoIliade sta nella presenza recondita di un occhio che sa guardare al di lagrave di esse (e al di lagrave della stessa distinzione fra Greci e Troiani vincitori e vinti) e che puograve anche attraverso le similitudini lasciare irrompere il mondo della natura o del lavoro umano nel mezzo delle battaglie LʼOdissea LrsquoOdissea (Ὀδύσσεια) consta di circa 12100 esametri divisi anchrsquoessi in 24 libri e indicati con le lettere minuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquoargomento egrave costituito dalle avventure di Odisseo dalla distruzione di Troia al ritorno alla patria Itaca esposte secondo un ordine che entrando subito nel vivo degli avvenimenti (lrsquoinizio del poema mostra Odisseo nellrsquoisola di Calipso) rievoca poi i fatti giagrave trascorsi e li ricongiunge infine a partire dal libro XV (con lrsquoarrivo di Telemaco alla capanna di Eumeo dove giagrave si trova Odisseo) in unrsquoazione unitaria La trama del poema i cui avvenimenti sono concentrati cronologicamente nello spazio di 40 giorni (ma sono narrati solo gli avvenimenti di 16 giorni e 8 notti) si articola in tre parti la laquoTelemachiaraquo (canti I-IV) il laquoRitorno di Odisseoraquo (canti V-XIII) e la laquoVendetta di Odisseoraquo (canti XIV-XXIV)
Letteratura greca [1]
22
Canto I Tutti gli eroi superstiti sono ormai tornati da Troia alle loro case tranne Odisseo che pur desideroso di tornare egrave trattenuto dalla ninfa Calipso nellrsquoisola di Ogigia Gli degravei hanno pietagrave di lui tranne Posidone irato per lrsquoaccecamento del figlio il ciclope Polifemo Ma un consiglio degli degravei assente Posidone (che si egrave recato presso gli Etiopi) delibera il ritorno dellrsquoeroe si decide che Ermes andragrave subito da Calipso mentre Atena si avvia verso Itaca sotto lrsquoaspetto del signore dei Tafi Mente per incoraggiare il figlio di Odisseo Telemaco a tener testa ai pretendenti della madre i laquoprociraquo (i quali aspirano al regno tramite le nozze con Penelope) e per indurlo a intraprendere un viaggio in cerca di notizie sul padre Canto IΙ Telemaco segue il consiglio della dea e il giorno seguente nellrsquoassemblea popolare chiede una nave per andare in cerca del padre ma la sua richiesta non viene discussa e Leocrito scioglie lrsquoassemblea Grazie ad Atena che ora ha assunto le sembianze di Mentore (antico amico di Odisseo) Telemaco riesce tuttavia a trovare una nave con cui salpa nel corso della notte allrsquoinsaputa sia della madre che dei proci Canto IΙΙ Telemaco e MentoreAtena arrivano a Pilo e sul lido trovano Nestore che sta offrendo un sacrificio a Posidone Il vecchio eroe accoglie ospitalmente Telemaco e gli comunica molte notizie sul ritorno di altri Achei ma nessuna su Odisseo Alla sera Atena scompare in forma di aquila e il mattino seguente Telemaco salpa insieme con Pisistrato (figlio di Nestore) alla volta di Sparta dove arriva la sera del giorno successivo Canto IV A Sparta Menelao sta festeggiando il doppio matrimonio del figlio e della figlia Il giorno seguente Telemaco chiede del padre Menelao gli racconta il proprio ritorno durante il quale aveva incontrato Proteo il vecchio nume marino che gli aveva riferito come Odisseo fosse trattenuto nellrsquoisola di Calipso Intanto a Itaca i proci preparano insidie meditando di uccidere Telemaco al suo ritorno Penelope ne viene a conoscenza ma Atena le appare in sogno per confortarla Canto V Dopo un secondo concilio degli degravei (in effetti un ldquodoppionerdquo di quello del I canto) Zeus manda finalmente Ermes presso Calipso con lrsquoordine di lasciar partire Odisseo La ninfa aiuta lrsquoeroe a costruirsi una zattera Al diciottesimo giorno di navigazione Odisseo egrave in vista dellrsquoisola dei Feaci Scheria quando Posidone di ritorno dal suo soggiorno presso gli Etiopi lo vede e suscita una tempesta che distrugge la zattera Ma la dea marina Ino Leucotea impietositasi gli porge il proprio velo sostenuto dal quale lrsquoeroe giunge a nuoto alla riva di Scheria dove si abbandona esausto addormentandosi Canto VI In seguito a un sogno inviatole da Atena Nausicaa la figlia del re dei Feaci Alcinoo si reca nei pressi della spiaggia a lavare le vesti insieme con le ancelle Odisseo risvegliatosi atterrisce le fanciulle che fuggono tutte allrsquoinfuori di Nausicaa Lrsquoeroe supplica la giovane di porgerle aiuto ed ella lo fa rivestire e lo accompagna fino al bosco di Atena poco prima della cittagrave esortandolo a presentarsi a suo padre Canto VII Protetto dalla nebbia di cui Atena lo ha avvolto Odisseo entra nel palazzo abbraccia le ginocchia della regina Arete e la caligine scompare poi viene accolto con onore da Alcinoo Arete chiede a Odisseo donde provenga e chi gli abbia donato gli abiti (a lei ben noti) che indossa Lrsquoeroe inizia a raccontare le disavventure che gli sono occorse dopo la
Letteratura greca [1]
23
partenza dallrsquoisola di Calipso Alcinoo gli promette di farlo ricondurre a Itaca il giorno seguente Canto VIII Ma lrsquoindomani Alcinoo fa apprestare un banchetto durante il quale lrsquoaedo Demodoco canta della contesa insorta un giorno fra Achille e Odisseo Lrsquoeroe si copre il volto per nascondere le lacrime allora Alcinoo interrompe il canto e organizza una serie di gare nel corso delle quali Odisseo primeggia Poi Demodoco al margine di unrsquoarea per la danza dove si esibiscono i ballerini feaci canta gli amori di Ares e Afrodite e la vendetta di Efesto (che incatena i due amanti) La sera al ritorno nel palazzo Demodoco racconta la storia del Cavallo di legno Odisseo scoppia nuovamente in lacrime e Alcinoo gli chiede di rivelare il suo nome Canto IX Odisseo dichiara il proprio nome e dagrave inizio al racconto della propria storia a partire dalla caduta di Troia distruzione di Ismaro e perdite subite ad opera dei Ciconi sbarco presso i Lotofagi (che si nutrono di un cibo misterioso che fa dimenticare il ritorno) dopo una terribile tempesta scatenatasi durante il tentativo di doppiare il capo Malea arrivo allrsquoisola antistante quella dei Ciclopi dove Odisseo si trasferisce con una sola nave esplorazione dellrsquoisola perdita di alcuni compagni allrsquointerno della caverna del gigante monocolo accecamento del mostro e fuga Canto X Odisseo giunge allrsquoisola di Eolo signore dei venti che lo accoglie benevolmente e gli consegna alla partenza tutti i venti chiusi in un otre ma poi lo respinge con durezza quando ritorna presso di lui percheacute i compagni (sospettando che nellrsquootre siano racchiuse cospicue ricchezze) hanno sciolto i venti e da essi si egrave sprigionato un uragano che li ha risospinti sullrsquoisola Ripreso il mare Odisseo egrave trasportato fino ai Lestrigoni antropofagi il cui attacco priva lrsquoeroe di tutte le altre navi tranne la propria Con questa fugge fino allrsquoisola (Eea) della maga Circe Dopo che Circe ha trasformato in porci un gruppo di compagni mandati innanzi ad esplorare lrsquoisola Odisseo ha la meglio sulla maga (a cui impone di restituire forma umana ai compagni) grazie allrsquoerba moly fornitagli da Ermes Resta un anno presso Circe che al momento della partenza gli consiglia di recarsi al paese dei morti per interrogare il vate Tiresia Canto XI Approdato alla terra dei Cimmeri (che vivono immersi in una nebbia perenne sulla riva dellrsquoOceano) e scavata una fossa Odisseo sacrifica ai morti e immola una vittima speciale a Tiresia Le anime accorrono dapprima Elpenore caduto per caso giugrave dal tetto della casa di Circe (Odisseo gli promette sepoltura) poi la madre Anticlea (che gli racconta di esser morta di dolore per la sua assenza) quindi Tiresia che gli vaticina le sue vicende future fino alla morte (questa lo coglieragrave dopo una lunga vita in un paese straniero che non conosce neacute il sale neacute il remo) Da un certo punto in poi il poeta dimentica il presupposto per cui Odisseo aveva scavato una fossa alla quale i morti accorrevano per bere il sangue delle vittime e bevendolo riacquistavano per breve tempo una piena consapevolezza immagina invece che Odisseo sia allrsquointerno dellrsquoAde In questa sezione rientrano la descrizione di Aiace sdegnato di Minosse di Orione dei grandi peccatori di Eracle Poi Odisseo fa ritorno a Eea e ricevuti i consigli di Circe si imbarca per il ritorno in patria Canto XII Scampato alle Sirene che invano lo attirano col canto (si egrave fatto legare allrsquoalbero della nave i compagni che remano hanno le orecchie turate con la cera) passa tra Cariddi e Scilla (che gli rapisce sei uomini) ed egrave costretto dai compagni ad approdare in contrasto con le prescrizioni di Circe allrsquoisola Trinachia dove pascolano le greggi del Sole I
Letteratura greca [1]
24
compagni spronati da Euriloco se ne cibano nonostante il divieto dellrsquoeroe Il Sole sdegnato ottiene da Zeus che la nave sia colpita dal fulmine Tutti i compagni periscono ma Odisseo che ripassa tra Scilla e Cariddi si salva miracolosamente da questrsquoultima aggrappandosi a un fico selvatico fincheacute il gorgo restituisce i rottami della nave infine arriva remando con le mani allrsquoisola di Ogigia Canto XIII Terminato il racconto lrsquoeroe riceve doni dai Feaci e la notte seguente egrave ricondotto a Itaca e deposto addormentato sulla spiaggia presso un antro sacro alle Ninfe Al risveglio per la nebbia non riconosce la sua terra fincheacute Atena in veste di giovane pastore lo rassicura e poi rivelatasi gli dagrave istruzioni su come far strage dei proci e lo trasforma in un vecchio mendico Canto XIV Odisseo si reca allo stazzo del suo porcaio Eumeo che pur non riconoscendolo lo accoglie ospitalmente rifocillandolo e offrendogli un mantello per ripararsi dal gelo notturno Canto XV A questo punto la laquoTelemachiaraquo si riannoda allrsquoazione principale Telemaco che si trova ancora a Sparta viene indotto da Atena a tornare a Itaca sulla via del ritorno a Pilo accoglie a bordo lrsquoindovino Teoclimeno e grazie allrsquoaiuto della dea sfugge alle insidie dei proci sbarca a Itaca e si reca anchrsquoegli presso Eumeo Canto XVI Questi va da Penelope ad annunciargli il ritorno del figlio Intanto Odisseo rimosso lrsquoincantesimo si svela nel suo vero aspetto a Telemaco e con lui progetta la vendetta sui proci (che intanto tramano una nuova insidia ai danni di Telemaco) Eumeo torna al suo stazzo Canto XVII Il mattino seguente Telemaco si reca in cittagrave seguito in un secondo tempo da Eumeo e Odisseo (che ha riassunto lrsquoaspetto di mendico) Davanti al palazzo Odisseo egrave riconosciuto dal cane Argo Entra e va mendicando tra i proci Antinoo lo colpisce alla spalla destra con uno sgabello Canto XVIII Odisseo si batte al pugilato col mendicante Iro Penelope scesa nella sala prospetta ai proci lrsquoeventualitagrave di un nuovo matrimonio Odisseo egrave insultato dalla schiava Melanto e schiva uno sgabello scagliato da Eurinomo Canto XIX Insieme con Telemaco lrsquoeroe allontana le armi dalla sala poi conversa con Penelope che gli racconta un sogno e gli espone il suo piano per sedare le contese tra i proci concedendosi sposa a colui che riusciragrave a tendere lrsquoarco di Odisseo la prova avverragrave il giorno seguente al novilunio Durante il colloquio la fida schiava Euriclea lava i piedi di Odisseo e riconosciutolo da unrsquoantica cicatrice sta per rivelarne lrsquoidentitagrave ma lrsquoeroe la costringe a tacere Canto XX Al mattino Euriclea e le ancelle fanno i preparativi per il banchetto Giungono Eumeo Melanzio e il mandriano Filezio Un presagio mandato da Zeus dissuade i proci dal progetto di uccidere Telemaco Durante il banchetto Teoclimeno predice la loro imminente rovina
Letteratura greca [1]
25
Canto XXI Penelope conduce lrsquoarco nella sala dopo che parecchi fra i proci e lo stesso Telemaco hanno tentato invano di tenderne la corda Odisseo chiede di partecipare alla prova tende lrsquoarco senza fatica e riesce a far passare la freccia attraverso gli anelli di dodici scuri predisposte da Telemaco Canto XXII Poi scaglia le frecce sui proci e si rivela nella sua identitagrave Nella lotta che segue Telemaco Eumeo e Filezio aiutano il padrone contro i proci (appoggiati dal capraio Melanzio) Tutti i proci restano uccisi le ancelle infedeli sono impiccate Melanzio viene mutilato e ucciso soltanto lrsquoaedo Femio e lrsquoaraldo Medonte sono risparmiati Canto XXIII Nuovo colloquio fra Odisseo e Penelope che durante lrsquoeccidio dormiva ed egrave stata svegliata da Euriclea Penelope esita ancora a riconoscere il marito e non si arrende alla veritagrave fincheacute Odisseo non le descrive la posizione e la struttura del letto coniugale Canto XXIV Ermes conduce allrsquoAde le ombre dei proci Odisseo fa visita al padre Laerte nella masseria dove quello vive nello squallore e nellrsquoemarginazione e si fa riconoscere Intanto il padre di Antinoo incita gli Itacesi alla rivolta e il poema si conclude con lo scontro di Odisseo e dei suoi contro i concittadini lrsquoeroe ha la meglio e Zeus scagliato il fulmine pone fine alla battaglia Atena sotto lrsquoaspetto di Mentore stabilisce fra i contendenti un patto per il futuro36
Struttura e caratteri dellʼopera Giagrave la prima parola del proemio (ἄνδρα) non menziona come tema dellrsquoopera un determinato episodio della vita del protagonista ma il protagonista stesso (I 1-10)
Ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα πολύτροπον ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεmiddot πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περmiddot αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο νήπιοι οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιονmiddot αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ τῶν ἁμόθεν γε θεά θύγατερ Διός εἰπὲ καὶ ἡμῖν Dellrsquouomo multiforme a me racconta o Musa che molto errograve dopo che di Troia la sacra rocca distrusse di molti uomini vide le cittagrave riconobbe il pensiero e molti per il mare patigrave dolori nellrsquoanimo per salvare la sua vita e il ritorno dei compagni Eppure non li salvograve i compagni per quanto bramasse per la loro stessa follia si persero gli stolti i buoi del Sole Iperione mangiarono e quello rapigrave ad essi il digrave del ritorno Di questo da un punto qualsiasi narra anche a noi o dea figlia di Zeus
Storie favolose di naviganti racconti imperniati sul ritorno dei guerrieri achei che avevano combattuto a Troia e il particolare rientro in patria di Odisseo figlio di Laerte erano forse giagrave stati connessi e intrecciati nella precedente tradizione epica sigrave che il presente cantore poteva
Letteratura greca [1]
26
metter mano alla vicenda partendo (v 10) laquoda un punto qualsiasiraquo (ἁμόθεν) una notazione che certo presuppone la convenzione propria dellrsquoesordio tradizionale di un canto epico comparabile con i giagrave ricordati ἐξ οὗ (laquoda quandoraquo) di Iliade I 4 ed ἔνθεν (laquoda doveraquo) di Odissea VIII 500 Senoncheacute rispetto a queste indicazioni di tipo puntuale il tratto costituito dalla dimensione casuale quasi arbitraria inerente ad ἁμόθεν proprio mentre dichiara lrsquoassenza di un determinato piano compositivo implica in realtagrave che il racconto non si svolgeragrave per filo e per segno secondo lrsquoordine noto a poeta e uditori non si snoderagrave κατὰ κόσμον (laquoper ordineraquo) come il canto di Demodoco (VIII 489) ma seguiragrave un andamento originale Il ldquopunto qualsiasirdquo incipitario non rappresenta una scelta della Musa (figura dellrsquoarchivio tematico che conserva le laquovieraquo dellrsquoepica) bensigrave di questo cantore che ha deciso di far incominciare la narrazione in medias res e ha in serbo la sorpresa di far succedere al concilio degli degravei (che decide lrsquoinvio di Ermes presso Calipso) non lrsquoazione testeacute programmata (azione che viene differita con un ritardo che a piugrave riprese ha scandalizzato i lettori a principio del V canto) ma la partenza di Atena alla volta di Itaca e lrsquoavvio della laquoTelemachiaraquo Le due diverse vicende proposte a principio del poema quella di Telemaco e quella di Odisseo procedono infatti in parallelo coprendo un analogo lasso di tempo Piugrave oltre la decisione di trasformare la sequenza narrativa che va dalla partenza di Odisseo da Troia fino al suo arrivo nella terra dei Feaci in una rievocazione fatta dallrsquoeroe in prima persona al cospetto di Alcinoo e dei Feaci (la sezione detta degli ἀπόλογοι laquoraccontiraquo) crea una struttura ad anello che parte dal presente e ad esso fa ritorno dopo aver ricostruito le premesse della condizione attuale del protagonista Col canto XIII Odisseo egrave riportato dai Feaci a Itaca e questo permette la saldatura fra le vicende sue e quelle di Telemaco sia pure col differimento dellrsquoincontro e del riconoscimento fra padre e figlio fino al canto XVI Far scorrere in parallelo sequenze distinte organizzare programmi narrativi a corta e a lunga gittata tendere o allentare ad arte il ritmo della narrazione non si tratta davvero di procedimenti che potessero configurarsi come tradizionali dellrsquoarte epica quanto piuttosto di un momento sperimentale di una ricerca di soluzioni nuove al termine di una lunga e ormai consolidata sedimentazione di percorsi compiuti allrsquointerno di un determinato repertorio tematico unrsquoaudacia inventiva una πολυτροπίη degne del protagonista del poema che inevitabilmente comportavano rischi molteplici di incoerenze dissonanze occasionali avarie della macchina epica e che tuttavia erano destinate a conseguire un risultato assolutamente convincente allrsquoorecchio di chi si abbandonasse al fascino del racconto senza lrsquourgenza propria di altre etagrave e di altre mentalitagrave di puntare il dito sui singoli dettagli o le singole sfasature
PER SAPERNE DI PIUrsquo Difficoltagrave e incongruenze della narrazione omerica Forti della possibilitagrave di un controllo su un testo scritto che possiamo percorrere in avanti e a ritroso secondo ritmi di nostra scelta a noi non riesce difficile cogliere alcune delle difficoltagrave organizzative incontrate nella composizione del poema In proposito per ricordare un caso che saragrave allrsquoorigine delle discussioni di orientamento ldquoanaliticordquo intorno allrsquoOdissea possiamo leggere il discorso che Atena prese le sembianze di Mente re dei Tafi rivolge a Telemaco nel I canto (vv 253-305) Ah infelice ti manca molto davvero lrsquoassente Odisseo che getti le mani addosso ai pretendenti sfrontati Percheacute se ora tornato stesse sulla soglia 255 con una scure lo scudo e due lance cosigrave come io per la prima volta lo vidi in casa nostra che beveva e godeva di ritorno da Efira da Ilo di Mermero (andograve anche ligrave Odisseo con la nave veloce 260 in cerca del veleno omicida per averne da ungere le frecce di bronzo ma quello non glielo diede percheacute temeva gli dei che vivono eterni
Letteratura greca [1]
27
glielo diede invece mio padre percheacute lrsquoamava moltissimo) se stesse Odisseo tra i pretendenti cosigrave 265 essi avrebbero tutti rapida morte e nozze amare Ma sulle ginocchia degli dei questo giace se una volta tornato faragrave o no vendetta nella sua casa te invece io esorto a riflettere come cacciare i pretendenti da casa 270 Ebbene ora ascolta e alle mie parole darsquo retta Domattina chiamati gli eroi Achei a consiglio rivolgi a tutti un discorso e siano testimoni gli dei Ai pretendenti comanda drsquoandarsene per i fatti loro e tua madre se lrsquoanimo la spinge alle nozze 275 ritorni a casa del padre molto potente Prepareranno essi le nozze e disporranno i doni nuziali moltissimi quanti gli pare che debbano andare alla figlia A te darograve un saggio consiglio se vuoi ascoltarlo armata una nave con venti remi la migliore che crsquoegrave 280 Varsquo a domandare del padre partito da tempo se mai te ne parli un mortale o sentissi da Zeus la voce che divulga la fama tra gli uomini Anzitutto varsquo a Pilo e interroga il chiaro Nestore di ligrave poi varsquo a Sparta dal biondo Menelao 285 degli Achei vestiti di bronzo egli egrave tornato per ultimo Se senti dire qualcosa sulla vita e il ritorno del padre per quanto stremato potresti sopportare un altro anno se invece senti dire che egrave morto e non vive allora tornato nella cara terra patria 290 ergigli un tumulo e offrigli funebri offerte moltissime quanto conviene e darsquo tua madre a un marito E poi dopo aver compiuto e fatto ogni cosa allora medita nella mente e nellrsquoanimo come tu possa uccidere nelle tue case 295 i pretendenti con lrsquoinganno affrontandoli non devi piugrave avere i modi di un bimbo percheacute ormai non sei tale Non senti lrsquoillustre Oreste quale gloria ha acquistato fra tutti gli uomini percheacute uccise lrsquoassassino del padre Egisto esperto di inganni che gli uccise il nobile padre 300 Anche tu caro infatti molto bello e grande ti vedo sii valoroso percheacute ti lodi anche qualcuno dei posteri Ma io tornerograve adesso alla nave veloce dai compagni che forse impazienti mi aspettano Tu devi pensarci da te dammi retta 305
[Tr di GA Privitera] Le stranezze non mancano davvero e cosigrave sono state messe a fuoco da Stephanie West nel suo commento23 1 Atena sa evidentemente molto piugrave di quanto uno come Mente avrebbe potuto sapere in particolare ella sa che i proci ignoreranno lrsquoinvito di Telemaco a lasciare la sua casa e fatto piugrave importante che gli degravei tra breve ricondurranno in patria Odisseo A queste osservazioni si puograve replicare con la stessa West che laquosi sono esagerate difficoltagrave e
23 Omero Odissea I cit 219 ss
Letteratura greca [1]
28
incongruenze alle quali un pubblico di ascoltatori (o anche un lettore moderatamente attento) probabilmente non farebbe casoraquo 2 Il progetto di una pubblica denuncia dei proci dinanzi agli degravei e agli uomini ai vv 273-274 egrave ciograve che Atena sembra prefiggersi nel promuovere lrsquoassemblea degli Itacesi (assemblea che effettivamente avragrave luogo a principio del canto II) drsquoaltra parte le successive istruzioni di AtenaMente ai vv 295 s (medita come uccidere i pretendenti) presuppongono che di quella richiesta da formulare nel corso dellrsquoassembla essi non terranno alcun conto Anche a questa osservazione si puograve rispondere che laquoegrave ragionevole attendersi che Telemaco condivida la previsione di un esito negativo della sua iniziativaraquo e si puograve aggiungere che pure in caso di insuccesso il ricorso allrsquoassemblea potrebbe ottenere almeno il risultato di screditare i pretendenti presso la comunitagrave itacese legittimando un successivo ricorso alla violenza (e si tratta di una legittimazione di cui anche lrsquoultimo canto mostreragrave lrsquoesigenza) 3 Dopo che Telemaco aveva detto che la madre non intendeva risposarsi (vv 249-250) AtenaMente si esprime ai vv 275-278 come se Penelope desiderasse proprio nuove nozze e inoltre sarebbe assurdo che il padre di Penelope cominciasse a contrattare un secondo matrimonio prima del ritorno di Telemaco dal suo viaggio e che mettesse mano a preparativi che rischierebbero di essere annullati qualche tempo dopo con inevitabile imbarazzo se Telemaco venisse a sapere che Odisseo egrave ancora vivo In piugrave lrsquoandamento sintattico di questi versi presenta un anacoluto durissimo per cui a principio del v 275 lrsquoaccusativo μητέρα egrave seguito da un ἂψ ἴτω (laquovada indietroraquo laquotorniraquo) che richiederebbe come soggetto un nominativo μήτηρ Come hanno reagito i lettori di Omero Nellrsquoantichitagrave un grammatico rimasto anonimo cambiava come attesta uno scolio μητέρ᾽ in μήτηρ nel secolo XVIII Richard Bentley modificava ἴτω in ἴμεν (infinito eolico di εἶμι laquovadoraquo) nel XIX un altro grande della filologia europea Gottfried Hermann risolveva piugrave drasticamente la questione eliminando il complesso dei vv 275-278 e la stessa West mostra simpatia per tale proposta supponendo laquounrsquoaggiunta posteriore modellata sul corrispondente passo del libro IIraquo (dove i vv 196 s sono identici ai vv 277 s e il v 195 copre lo stesso contenuto dei vv 275 s) Si tratta di procedimenti adeguati ai dati di fatto Migliorano davvero il testo che ci egrave stato tramandato In realtagrave ambedue le ldquocorrezionirdquo appena ricordate (di μήτερ᾽ e di ἴτω) ottengono un risultato tanto lineare che egrave davvero difficile pensare che lrsquoanacoluto avrebbe potuto invadere tutta la tradizione se non fosse stato originario e quanto allrsquoespunzione dei vv 275-278 essa indubbiamente peggiorerebbe il ritmo del discorso determinando lrsquoavvicinamento fra i due versi (v 271 e v 279) molto simili fra loro che aprono le due sequenze occupate dai consigli di Mente E allora La via piugrave saggia egrave senzrsquoaltro quella di tenerci qui come quasi sempre di fronte al testo omerico contraddizioni e anacoluti riconoscendo in essi lrsquoeffetto dellrsquoattivitagrave di un cantore che pur sulla base di una traccia largamente memorizzata restava pur sempre legato a quella prassi orale per cui composizione ed esecuzione tendevano a coincidere E lrsquoanacoluto si spiega bene se cerchiamo di immedesimarci nel procedimento seguito dal poeta Egli ha affidato ad Atena un certo flusso argomentativo per cui la dea deve dar consigli a Telemaco sui suoi rapporti coi proci e con la madre e cosigrave colloca in fine di v 274 un ἄνωχθι (laquoordinaraquo) destinato a reggere gli accusativi simmetricamente dislocati in principio di verso (vv 274 e 275) μνηστῆρας e μητέρα Senoncheacute giunto a questa seconda parte dellrsquoargomentazione egli si avvede quanto sarebbe illogico che Telemaco sollecitasse la madre a nuove nozze di qui lrsquoimprovviso cambio di costruzione che svincola al prezzo di una sensibile slogatura sintattica lrsquoipotesi delle nuove nozze dallrsquoordine impartito a Telemaco e la prospetta invece come un desiderio eventuale della stessa Penelope Il poeta ha un progetto ben meditato brani e sequenze piugrave volte sperimentati ed egrave col supporto di questi materiali giagrave elaborati che egli si fa strada attraverso le insidie della
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
7
dove a1 e a2 segnalano allrsquointerno della prima metagrave del verso le posizioni che in alternativa reciproca tendono a coincidere con fine di parola m e f le posizioni della cesura principale rispettivamente maschile o pentemimere (m) e femminile o trocaica (f) r la posizione della cesura eftemimere b la posizione della dieresi bucolica Viene evitata la fine di parola dopo il terzo metro cosigrave da escludere una bipartizione simmetrica del verso Un punto in cui la fine di parola egrave tendenzialmente evitata egrave quello dopo la prima breve del quarto biceps come fu osservato da G Hermann (donde lrsquoetichetta di laquoponte di Hermannraquo) Solo con Callimaco si afferma anche il divieto che una parola che inizi nel primo metron termini con la prima breve nel secondo biceps (laquoprima legge di Meyerraquo)
PER SAPERNE DI PIUrsquo Teorie sullrsquoorigine dellrsquoesametro Sul problema dellrsquoorigine dellrsquoesametro le teorie si sono succedute numerose allrsquointerno della fondamentale contrapposizione fra chi ha individuato nella sua struttura il risultato della fusione fra preesistenti unitagrave minori e chi invece come Hoekstra (1981) ne ha proposto unrsquointerpretazione fin dallrsquoorigine unitaria Ad es Th Bergk (1854) riconduceva la genesi dellrsquoesametro a due cola lirici preesistenti Wilamowitz (1884) ne faceva il risultato della lunga evoluzione di una struttura lirica avvenuta in parallelo col passaggio dalla canzone lirica (eolica) al laquopiccolo eposraquo e da questo al laquogrande eposraquo A Meillet (1923) postulava unrsquoereditagrave pre-greca (egea) Piugrave recentemente un ritorno alla posizione di Bergk si egrave avuto da parte di ML West (1973) con lrsquoipotesi di una derivazione dellrsquoesametro dallrsquoassociazione fra un hemiepes e un prosodiaco e alla posizione di Wilamowitz nel senso dellrsquoevoluzione di un ferecrateo espanso con lrsquoinserzione centrale di tre dattili con G Nagy (1974) B Gentili (1977) ha cercato di rintracciare coincidenze fra i segmenti costitutivi dellrsquoesametro e i cola della poesia lirica drsquoetagrave arcaica partendo dal dato per cui gli schemi metrici che appaiono in alcune iscrizioni arcaiche e nella lirica di Stesicoro (hemiepes enoplio reiziano coriambico adonio etc) sono gli stessi che sembrano plasmare tutte le formule piugrave tradizionali dellrsquoesametro omerico (per unrsquoesposizione sintetica di questa teoria cfr B Gentili-L Lomiento Metrica e ritmica Storia delle forme poetiche nella Grecia antica Milano Mondadori Universitagrave 2003 pp 279-283)
La formularitagrave Il fenomeno della formularitagrave si puograve definire come la ripetizione di versi interi o di segmenti di versi specialmente nellrsquoambito di situazioni tipiche ad es per laquoquando sorse lrsquoauroraraquo troviamo usato per due volte nellrsquoIliade e in ben venti casi nellrsquoOdissea il verso
ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς e quando mattutina apparve Aurora dalle dita di rosa
Ma il caso piugrave comune di formularitagrave egrave quello rappresentato dai nessi standardizzati nomeepiteto come quelli che vengono applicati ai rispettivi protagonisti dei due poemi πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς (31 volte) e πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς (38 volte) ambedue formule clausolari ma di diversa estensione poicheacute (se riandiamo allo schema riprodotto al paragrafo precedente) esse arrivano entrambe alla fine del verso ma partendo la prima da r la seconda da f Esempi
Letteratura greca [1]
8
r Iliade I 58 τοῖσι δrsquo ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς f Odissea VIII 97 Ὣς ἔφατrsquo οὐδrsquo ἐσάκουσε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς Piugrave in particolare se consideriamo le singole articolazioni minori del verso riscontriamo che a) nel segmento iniziale si incontrano con alta frequenza brevi nessi che contengono congiunzioni pronomi e particelle connettive o avversative ad es fino ad a1 () αὐτὰρ ὁ δή ποτε ὣς τότε καὶ τότε ὣς ὁ μέν fino ad a2 () αὐτὰρ ἐπεί ἀλλ᾽ ὅτε δή ἔνθ᾽ ἄλλοι τοὶ μὲν ἔπειτ᾽ b) nel segmento centrale che va da m o da f fino a r o a b compare spesso il predicato verbale su cui gravita la frase (si veda a titolo di esempio il verso di Iliade sopra citato nel quale μετέφη si estende appunto da m a r) m r Iliade I 58 τοῖσι δrsquo ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς c) il segmento finale (a partire da r o da b) rappresenta il piugrave ricco serbatoio di nessi formulari innanzi tutto come nel caso di πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς le formule nome proprioepiteto ma anche molti casi di associazione fra nome comune ed epiteto ad es ξίφος ἀργυρόηλον φόρμιγγα λίγειαν πατρίδος αἴης θούριδος ἀλκή μώνυχες ἵπποι ὀξέϊ χαλκῷ πότνια μήτηρ Le formule tendono a organizzarsi in sistemi caratterizzati dalle tendenze complementari allrsquoestensione e allrsquoeconomicitagrave a) il principio dellrsquoestensione si connette alla tendenza dellrsquoepica a produrre nessi formulari atti a coprire tutto ciograve che nella narrazione sia tipico costante ripetitivo e a dislocare le formule coprendo le varie partizioni del verso ad es per Ettore troviamo tre formule finali di diversa estensione (φαίδιμος Ἥκτωρ κορυθαίολος Ἥκτωρ e μέγας κορυθαίολος Ἥκτωρ e una formula iniziale (Ἥκτωρ Πριαμίδης) b) il principio complementare al primo dellrsquoeconomia (o del risparmio) corrisponde al fatto che per esprimere una medesima idea essenziale esiste generalmente nella dizione epica una e una sola espressione che occupi una determinata unitagrave minore del verso Casi come μελαινάων ἐπὶ νηῶν e ἐϋσσέλμων ἐπὶ νηῶν sono doppioni apparenti hanno sigrave la stessa misura metrica ma iniziano lrsquouno in consonante con la connessa possibilitagrave di evitare lo iato o di allungare la sillaba precedente lrsquoaltro in vocale Non mancano tuttavia vere eccezioni come per lrsquohemiepes iniziale νῆας ἐπ᾽ Ἀργείων di Iliade XXIV 298 rispetto al consueto νῆας ἐπὶ γλαφυράς (16 volte) Lrsquouso di formule e soprattutto di sistemi formulari rappresentava per il poeta epico una facilitazione nel comporre improvvisando ma nella lunga evoluzione dellrsquoepica e specialmente al momento della definitiva fissazione di poemi monumentali come lrsquoIliade e lrsquoOdissea la
Letteratura greca [1]
9
sempre piugrave estesa memorizzazione di ampie zone di testo il lavorio di riflessione sui singoli episodi e sui nessi e i parallelismi fra gli episodi stessi e la scoperta di inedite possibilitagrave espressive connesse alla modificazione di formule tradizionali dovettero incoraggiare i poeti a uno sfruttamento consapevole e artisticamente meditato del ldquogioco delle formulerdquo Da un lato procedimenti come lrsquoaddensamento degli epiteti la sostituzione di un epiteto convenzionale con uno non convenzionale (con la creazione di un nesso nuovo di struttura metrica eventualmente diversa) il trasferimento di un epiteto da un referente a un altro creano nei poemi una continua tensione tra formularitagrave e superamento della formularitagrave dallrsquoaltro la rete delle corrispondenze a distanza generata dalla ripetizione di un determinato modulo permette al poeta di variare e approfondire un motivo e di sottolineare i parallelismi o le dissonanze fra determinate situazioni La guerra di Troia Schliemann e la riscoperta di Troia In etagrave moderna la riscoperta della cittagrave di Troia situata sullrsquoodierna collina di Hissarlik e sovrastante la bassa pianura attraversata dallo Scamandro a sud del promontorio del Sigeo si lega agli scavi di Heinrich Schliemann (1822-1890) che a partire dal 1866 si dedicograve al disseppellimento delle rovine di Micene di Tirinto e di altri siti micenei e appunto di Troia Nel corso del tempo si egrave venuta creando attorno alla personalitagrave di questo archeologo dilettante una sorta di leggenda a cui egli stesso contribuigrave con le autobiografie Ilios (1881) e Troja (1884) nel senso di un dilettantismo romantico di scavi avventurosi condotti con sorprendenti successi ma senza alcun rigore di metodo di un amore cieco e totale per Omero e per lrsquoEllade E in effetti oggi sappiamo che lrsquoaver percorso la Grecia e lrsquoAsia minore sulle vie di Omero non impedigrave a Schliemann a Micene di attribuire allrsquoepoca di Agamennone tombe anche di quattro secoli piugrave antiche neacute a Troia di identificare con la cittagrave omerica uno strato risalente a una fase che va dal 2300 al 2100 aC Errori del genere non dipesero tuttavia da un entusiasmo velleitario quanto dalla carenza allrsquoepoca di competenze archeologiche che potessero orientarlo verso una piugrave plausibile cronologia di reperti e di strati Occorre poi tener conto che lo strato dei materiali riferibili alla Troia omerica (o almeno a quella che oggi noi identifichiamo con la cittagrave omerica Troia VIIa) era conservato unicamente nel suo margine esterno dato che gli strati superiori della collina di Hissarlik (con le fondamenta dei palazzi e dei templi) erano stati demoliti in epoca ellenistica per realizzare il terrazzamento del suolo su cui vennero edificati nuovi templi Fu soprattutto per questa ragione che Schliemann si spinse con le proprie maestranze a scavare sempre piugrave in profonditagrave saltando gli strati del secondo millennio Dove perograve il problema consisteva nellrsquoidentificazione di un sito sulla scorta della comparazione fra gli antichi racconti e il panorama attuale Schliemann conseguigrave notevoli successi in primo luogo identificando con la collina di Hissarlik quellrsquoacropoli omerica che lrsquoopinione comune dalla fine del XVIII secolo individuava invece nel villaggio di Bunarbaschi situato su un colle a 15 km dal promontorio del Sigeo e la disputa era stata viva giagrave nellrsquoantichitagrave Ellanico di Lesbo verso il 400 aC aveva sostenuto nei suoi Troica che la Ilio del suo tempo sorta presso la collina di Hissarlik e la Ilio omerica occupavano lo stesso sito invece Demetrio di Scepsi (fr 26 Gaede) si era pronunciato per una collina a circa 9 km a sud sullrsquoaltra riva dello Scamandro La missione americana guidata nel 1932-1938 da CW Blegen e le piugrave recenti indagini sul territorio hanno offerto un quadro molto piugrave articolato e differenziato Sulla base di un nuovo diagramma la cittagrave che sorgeva al momento in cui Eratostene di Cirene fissava la caduta di Troia (1184) viene a coincidere con Troia VIIa non piugrave con quella che Schliemann chiamava laquoterza cittagraveraquo (corrispondente a Troia II) ma nemmeno come voleva W Doumlrpfeld con Troia VI (andata in rovina verso il 1300 in seguito a un terremoto) Gli scavi piugrave recenti Secondo le conclusioni di Manfred Korfmann (cfr Korfmann 2002) che ha diretto lrsquoeacutequipe dellrsquoUniversitagrave di Tubinga negli scavi piugrave recenti lrsquoantica Troia intorno al 1184 cessograve di essere abitata ma lrsquoinsediamento continuograve nellrsquoarea della rocca per circa due secoli dopo la distruzione
Letteratura greca [1]
10
della cittagrave (Troia VIIb) Verso il 700 il luogo chiamato laquoIlioraquo era largamente in rovine anche se in etagrave arcaica dovette continuare a essere frequentato come luogo di culto Il problema che si dovettero porre nellrsquoVIII secolo aC lsquoOmerorsquo o i suoi modelli dovette essere quello di rendere il racconto della guerra di Troia plausibile a un pubblico che aveva familiaritagrave con la geografia locale (lrsquoIliade offre indicazioni realistiche ad es sulla navigazione dellrsquoEgeo in IX 362 s e sulla visibilitagrave dellrsquoisola di Samotracia dalla piana di Troia in XIII 11-14) che si trattasse di genti che risiedevano nel Sigeo o in altre cittagrave vicine o di abitanti della stessa Ilion che nellrsquoVIII secolo era di nuovo attiva sia pure soltanto come centro cultuale Il santuario sorgeva allrsquointerno di una depressione naturale a sud-ovest della rocca lungo la vecchia via che conduceva alla rocca stessa Omero menziona due templi quello di Apollo e quello di Atena e le loro loro rovine sono tuttora riconoscibili I visitatori che giungevano al santuario dal Sigeo attraverso la piana dello Scamandro potevano vedere le rovine della rocca Ma - ci si chiede - quando ebbe fine il nucleo della cittagrave di Troia cantata da Omero Nel bastione a nord-est della rocca egrave stata trovata una larga e profonda cisterna con un condotto che proviene da una sorgente La sorgente fu abbandonata al piugrave tardi al tempo di Troia VIIb2 prima del 1100 A partire dal 1000950 non rimase a Troia alcun insediamento significativo Troia era molto piugrave larga di quanto ritenesse Schliemann Un fossato largo 3 m e profondo 15 completato durante lrsquoultima fase di Troia VI o al principio di Troia VIIa (cioegrave intorno al 1300) la circondava Poi esso fu rimpiazzato a sud da un fossato piugrave ampio e concentrico al primo completato verso il 1200 Il sistema di fortificazione si estendeva per quasi 2 km e pertanto racchiudeva unrsquoarea di circa 270000 m2 La rocca e la cittagrave bassa dovevano presentarsi al tempo di Omero come un imponente complesso di rovine I nuovi colonizzatori del Sigeo e di altri siti incontrarono un vasto campo attraversato da sentieri che seguivano i vecchi tracciati Negli scavi fatti nei quartieri della cittagrave bassa a sud-ovest della rocca poco fuori del muro si egrave scoperto un deposito bruciato verso la fine di Troia VI e di nuovo verso la fine di Troia VIIa (verso il 1200) La prima devastazione egrave da ricollegarsi a un terremoto ma la seconda sembra dovuta a unrsquoazione di guerra come suggerisce anche il rinvenimento di corpi insepolti o semisepolti e di depositi contenenti armi non utilizzate Verso il 1300 la porta principale di Troia era stata bloccata e ostruita percheacute qui lrsquoantico muro era in condizioni precarie e pertanto rappresentava lrsquoanello piugrave vulnerabile nel sistema di difesa Giagrave W Doumlrpfeld aveva richiamato Iliade VI 433 s (Andromaca a Ettore)
Piazza lrsquoesercito presso il fico selvatico dove egrave piugrave facile Lrsquoaccesso alla cittagrave e il superamento delle mura
In questa zona solo poco piugrave di 80 m separavano il muro della cittagrave bassa dal muro della rocca Gli epiteti omerici di Troia - laquoben costruitaraquo laquofertileraquo laquovastaraquo laquosacraraquo laquoertaraquo laquoventosaraquo laquodalle belle muraraquo laquodai bel puledriraquo - si adattano ai dati topografici ossa di cavalli sono state trovate sul terreno forti venti soffiano continuamente in estate Anche le sorgenti sono identificabili presso la porta principale cfr Iliade XXII 145-157
Passarono oltre il posto di vedetta e lrsquoalbero di fico battuto dal vento e allontanandosi sempre piugrave dalle mura si lanciarono lungo la strada Giunsero alle fontane dalle belle acque dove sgorgano due correnti dello Scamandro impetuoso una di acqua calda da cui si leva un vapore come da fuoco ardente lrsquoaltra che in piena estate versa acqua gelata come la grandine la fredda neve o il ghiaccio Vi sono accanto dei lavatoi di pietra larghi belli dove le mogli e le belle figlie dei Teucri lavavano le splendide vesti prima in tempo di pace prima che giungessero i figli dei Danai
[Tr di MG Ciani] In effetti gli scavi nellrsquoarea della caverna in cui egrave situata la sorgente hanno portato alla luce una struttura simile a una miniera con tre gallerie e altri bracci tributari creata per fornire acqua Lrsquoacqua scorreva attraverso una superficie rocciosa e poi in un canale artificiale che a sua volta raggiungeva un sistema di quattro lsquodepressionirsquo o lsquofossersquo circolari scavate nella roccia della
Letteratura greca [1]
11
misura di quasi 1 m di diametro (appunto parrebbe i πλυνοί hellip λαΐνεοι i laquolavatoi di pietraraquo ricordati da Omero) Achei e Troiani Fra XIII e XII secolo aC Troia era un grande centro politico e commerciale in grado di controllare lrsquoaccesso ai Dardanelli (lrsquoantico Ellesponto) e il trasporto su terra di beni di vario genere dalla costa egea al Mar di Marmara (lrsquoantica Propontide) e al Mar Nero In Troia VIIa egrave stata rinvenuta ceramica micenea del periodo noto come Tardo Elladico IIIB che egrave anche il periodo di maggiore splendore dei palazzi micenei sul continente greco Ersquo suggestiva lrsquoidentificazione piugrave volte avanzata in tempi recenti di TroiaIlio con Wilusa la cittagrave menzionata spesso in testi hittiti e oggetto di contesa fra gli Hittiti e quegli Ahhiyawa il cui nome sembra identificarsi con quello degli laquoAcheiraquo (Ἀχαιοί) Il documento piugrave significativo in proposito egrave il preambolo del trattato stipulato verso il 1280 aC fra il re hittita Muwattali II e Alaksandu re di Wilusa che contiene un richiamo alle precedenti relazioni fra i due stati a partire dal 1600 pur ricordando che un tempo Wilusa era sotto il dominio hittita Muwatalli afferma di aver mantenuto relazioni pacifiche anche dopo che la cittagrave era divenuta indipendente Inoltre un testo religioso hittita rinvenuto a Hattusa la capitale dellrsquoimpero hittita e databile al XIII secolo ricorda nellrsquoambito di un rituale la recita di un poema in luvio (il luvio egrave una lingua indo-europea che si distingue solo superficialmente dallrsquohittita) di cui viene riportato il primo verso laquoQuando tornarono dallrsquoerta Wilusaraquo E a Troia negli scavi piugrave recenti egrave stato trovato un sigillo con unrsquoiscrizione in luvio Drsquoaltra parte in Omero la dinastia reale troiana di cui egrave a capo Priamo figlio di Laomedonte viene fatta risalire attraverso Erittonio Troo e Ilo fino a Dardano eponimo dei Dardani che si erano stanziati nella Troade a nord del monte Ida (Iliade ΧΧ 215 ss) I Dardani nellrsquoIliade compaiono fra i principali alleati dei Troiani accanto ai contingenti provenienti da Zelea (a nord-est lungo il fiume Esepo) e a quelli di localitagrave situate sulla Propontide come Adrestea e Pitea e sulla costa asiatica dellrsquoEllesponto come Abido e Arisbe Dalla costa europea arrivano invece i Traci i Ciconi e i Peoni da oriente i Paflagoni e gli Alizoni da sud-est i Misi e i Frigi dalla zona sud-occidentale dellrsquoAnatolia i Meoni i Cari e i Lici Se Dardani Peoni Ciconi e Traci fanno parte delle popolazioni traco-frigie che fra XII e XI secolo erano scese dai Balcani in direzione dellrsquoAnatolia (cfr Erodoto 7 73 e Xanto di Lidia FGrHist 765 F 14) i Meoni sono di stirpe lidia mentre i Cari e i Lici appartengono allrsquoambito culturale e linguistico luvio-hittita Comunque sia diversamente che per Erodoto il quale inserisce il rapimento di Elena nel quadro di una serie di torti reciproci in forma di rapimenti di donne fra Greci e barbari (I 2 1) e per i poeti tragici ateniesi del V secolo aC in Omero lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato come un contrasto fra culture diverse I Troiani mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei (detti anche laquoDanairaquo - cioegrave discendenti di Danao - o laquoArgiviraquo in relazione al contingente proveniente dallrsquoArgolide guidato da Agamennone il capo della spedizione) e lo stesso vale per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari in Iliade ΙΙ 867 come laquodi lingua stranieraraquo (βαρβαρόφωνοι) suggerisce che un tale epiteto non sarebbe stato applicabile ai Troiani Infine sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di unrsquoimbarcazione sono altrettanti esempi di quelle che W Arend denominograve laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini comportamentali e tecnologiche del gruppo che le condivide (vedi scheda p xxx) La societagrave omerica
Letteratura greca [1]
12
Nel rapporto fra il mondo omerico e la storia egrave innanzi tutto da sottolineare lrsquoesistenza di un duplice piano di riferimento con talune interferenze dellrsquouno nellrsquoaltro da un lato crsquoegrave lrsquoorizzonte dei fatti collocati in un passato glorioso dallrsquoaltro lrsquoorizzonte del poeta Giagrave gli studiosi alessandrini del resto notavano che dati come lrsquoarte di montare a cavallo i segnali per mezzo della tromba e lrsquouso di bollire la carne compaiono nellrsquoIliade solo allrsquointerno delle similitudini E il testo con una sorta di arcaismo intenzionale mostra talora la consapevolezza dellrsquoabisso che separa passato e presente come quando in Iliade XII 445-449 si dice
Ettore intanto un sasso afferrograve ndash e lo portava ndash che prima stava davanti alle porte largo di sotto ma sopra era a punta questo due uomini i piugrave forti del popolo difficilmente isserebbero da terra su un carro quali son ora i mortali egli da solo lo roteava a suo agio
[Tr di R Calzecchi Onesti] Per contro le condizioni sociali rappresentate nei poemi (un mondo di grandi proprietari terrieri che reggono aziende agricole autarchiche da cui hanno preso tuttavia a distaccarsi alcune figure di artigiani il fabbro il vasaio il carpentiere il medico lrsquoindovino lrsquoaedo) rispecchiano assai piugrave la situazione storica fra VIII e VII secolo a C che le strutture della societagrave micenea Inoltre i cadaveri vengono cremati secondo la prassi piugrave recente non inumati anche se molti riferimenti omerici non rispecchiano necessariamente la pratica normale del tempo di pace trattandosi di cremazioni che avvengono oltremare non ambigua egrave comunque la testimonianza relativa alla prassi umana in generale fornita da Odissea XI 216-222 (Anticlea a Odisseo)
Ohimegrave figlio mio il piugrave misero di tutti gli uomini Persefone la figlia di Zeus non ti inganna ma la legge degli uomini egrave questa quando si muore i nervi non reggono piugrave la carne e le ossa ma la furia violenta del fuoco ardente li disfa appena la vita abbandona le bianche ossa e lrsquoanima vagola volata via come un sogno
[Tr di GA Privitera]19 Un esempio significativo di sovrapposizione tra fasi culturali distinte si coglie osservando lrsquoinventario degli oggetti accanto ad armi vasi ornamenti tipici dellrsquoVIII-VII secolo troviamo relitti risalenti allrsquoepoca micenea come la coppa di Nestore ornata di colombe descritta in Iliade XI 632 ss (simile a una coppa drsquoargento rinvenuta a Micene che riproduce disegno e artigianato dellrsquoetagrave del bronzo) lrsquoelmo di cuoio con zanne di cinghiale che Merione dagrave a Odisseo (Iliade X 261 ss) e lo scudo lungo laquosimile a torreraquo di Aiace che egrave di un tipo inusitato dopo il XIII secolo Un oggetto non riferibile neacute al mondo miceneo neacute allrsquoetagrave della fissazione dei poemi bensigrave alla prima etagrave del ferro egrave invece la coppia di aste da lancio adottate verso il 900 aC e scomparse due secoli dopo con lo sviluppo del combattimento oplitico e la reintroduzione dellrsquoasta per colpire e la menzione delle navi fenicie (una volta nellrsquoIliade e cinque volte nellrsquoOdissea) riflette la loro comparsa nellrsquoEgeo nel IX secolo aC Non diversamente sembra avvenire anche per le istituzioni politiche lrsquo ἄναξ egrave visto a volte come figura di autocrate assoluto a volte fortemente limitato dai poteri delle assemblee ndash sia quella dei capi (βουλή) sia quella delle truppe (ἀγορή) ndash o insidiato dallrsquoascesa dei gruppi aristocratici mentre il βασιλεύς non egrave piugrave il dignitario della societagrave micenea ma genericamente un principe o un capo LʼIliade
19 Omero Odissea III intr testo e commento di A Hoekstra tr di GA Privitera Mondadori Milano 1984
Letteratura greca [1]
13
LrsquoIliade (Ἰλιάς) consta di circa 15690 esametri divisi secondo una partizione che potrebbe risalire al primo editore alessandrino (Zenodoto di Efeso) in 24 libri indicati con le lettere maiuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquounitagrave strutturale di parecchi canti che spesso finiscono col tramonto o iniziano con lrsquoalba e la coincidenza fra alcuni dei titoli attribuiti a ciascun canto nelle edizioni alessandrine e quelli che si rintracciano in autori precedenti (ad es Tucidide [I 10 4] cita il ldquoCatalogo delle navirdquo cioegrave il canto II) provano che non si trattograve di una divisione arbitraria bensigrave fondata almeno in certa misura sulle abitudini dei rapsodi Tema dellrsquoopera non egrave lrsquointero assedio decennale di Troia da parte dei Greci (di norma detti Achei o Danai o Argivi) provocato dal rapimento di Elena ad opera di Paride ma una porzione assai limitata del conflitto una sequenza narrativa che copre la durata di 51 giorni e si colloca verso la fine del nono anno di guerra lrsquoira di Achille contro lrsquoAtride Agamennone il suo ritiro dalla guerra e le relative conseguenze la fine dellrsquoira lrsquouccisione e i funerali di Ettore Fu proprio questa delimitazione tematica a consentire la realizzazione di quellrsquounitagrave e compiutezza dellrsquoazione che giagrave Aristotele individuava come uno dei pregi essenziali dellrsquoopera di Omero rispetto agli altri poemi epici arcaici (Poetica 1459a-b)20
anche in questo Omero deve apparire mirabile in confronto agli altri per non aver tentato di rappresentare intera la guerra anche se essa aveva un principio e una fine il racconto sarebbe risultato troppo grande e non abbracciabile con uno sguardo oppure pur misurato nella grandezza intricato per la varietagrave Ricavatane invece una parte ha fatto uso di molti episodi per esempio con il ldquoCatalogo delle navirdquo e con altri episodi fa procedere in lungo il poema Gli altri invece come lrsquoautore delle Ciprie o della Piccola Iliade compongono unrsquoazione multipla su unrsquounica persona o un unico tempo Di conseguenza mentre dallrsquoIliade e dallrsquoOdissea si ricava unrsquounica tragedia o soltanto due da ciascuna dalle Ciprie parecchie
[Tr di D Lanza]21
Canto I Lrsquoazione si apre sul campo degli Achei devastato dalle frecce scagliate da Apollo [T1] il dio ha scatenato una pestilenza percheacute Agamennone ha rifiutato il riscatto offerto dal sacerdote Crise per la liberazione della figlia Criseide divenuta schiava dellrsquoAtride Ai guerrieri convocati in assemblea lrsquoindovino Calcante rivela che la sola via di scampo egrave la restituzione di Criseide al padre Agamennone acconsente ma solo a patto che gli venga data in cambio Briseide la schiava che Achille tiene nella sua tenda come premio personale (γέρας) ricevuto dagli altri guerrieri Achille non puograve opporsi alla prevaricazione dellrsquoAtride ma non egrave disposto a subire passivamente lrsquooltraggio e insulta Agamennone anzi egrave giagrave pronto a estrarre la spada dal fodero per farsi giustizia quando viene trattenuto da Atena apparsa allrsquoimprovviso allora si ritira nella tenda giurando che non combatteragrave piugrave [T2] Quindi invoca la madre Tetide che dopo essere apparsa al figlio sulla riva del mare intercede presso Zeus e ottiene la promessa che i Greci non vinceranno la guerra e non espugneranno Troia fincheacute Achille non riceveragrave soddisfazione per lrsquooffesa subita Ma il piano di Zeus non resta celato ad Era che ingelosita provoca una lite nel corso del banchetto degli dei tuttavia la visione di Efesto zoppicante che funge da coppiere suscita lrsquoilaritagrave dei numi e riporta la serenitagrave Canto II Quella stessa notte Zeus manda ad Agamennone un sogno ingannatore per incitarlo ad attaccare Troia LrsquoAtride riferisce il sogno agli anziani e comanda lrsquoadunata dellrsquoesercito
20 Cfr anche 1462b ταῦτα τὰ ποιήματα συνέστηκεν ὡς ἐνδέχεται ἄριστα καὶ ὅτι μάλιστα μιᾶς πράξεως μίμησις (laquoQuesti poemi sono composti come meglio non si puograve e son il piugrave possibile imitazione di unrsquounica azioneraquo) 21 Aristotele Poetica Milano Rizzoli 19902
Letteratura greca [1]
14
con lrsquoidea stravagante di saggiare lrsquoumore delle truppe proponendo il ritorno in patria Gli uomini incitati da Tersite corrono alle navi pronti a salpare ma vengono bloccati da Odisseo e da Nestore Egrave significativo che Tersite lrsquoanti-eroe riecheggi le accuse di Achille ad Agamennone sottolineando gli onori di cui questi gode e prenda le parti di Achille [T3] Per tutta la seconda parte del libro lrsquoazione viene interrotta per far posto alla grandiosa uscita in armi dellrsquoesercito acheo dal recinto delle navi un quadro scintillante ornato da una catena di sei similitudini concatenate introdotte per illustrare il fulgore delle armi il rombo dei passi umani e degli zoccoli precipitosi lrsquoaspetto della schiera achea e la maestria dei condottieri Un ldquoCatalogo delle navirdquo contiene lrsquoelenco circostanziato delle genti greche che hanno preso parte allrsquoassedio ed egrave seguito da un catalogo piugrave breve e piugrave arido degli alleati dei Troiani accorsi in difesa di Ilio Canto III Lrsquoatteso scontro tra gli schieramenti appena passati in rassegna non ha luogo ParideAlessandro ottiene infatti una tregua per sfidare Menelao Iride la messaggera degli degravei spinge Elena ad accorrere alle mura presso le porte Scee per assistere al preannunciato duello di ligrave Priamo e gli altri anziani di Troia osservano la pianura Su richiesta del vecchio sovrano (una richiesta che sarebbe stata piugrave ldquoverosimilerdquo al primo anno di guerra) Elena nomina i piugrave prestigiosi campioni achei [T4] Nel duello che segue Paride si trova ben presto a mal partito contro Menelao ma Afrodite lo sottrae ai colpi del nemico avvolgendolo in una fitta nebbia e lo riporta nelle sue stanze dove dopo aver assunto lrsquoaspetto di una vecchia filatrice ordina a Elena di giacere con lui Elena si ribella ma la dea non transige Mentre Paride ed Elena si uniscono nellrsquoamplesso Menelao furibondo cerca fra la folla il nemico che sia i Greci che i Troiani sarebbero lieti di consegnargli pur di porre fine alla guerra Agamennone rivendicando la vittoria di Menelao pretende dai Troiani la restituzione di Elena e delle sue ricchezze noncheacute il pagamento di una forte ammenda Canto IV La tregua stipulata dopo la scomparsa di Paride viene infranta dallrsquoarciere Pandaro che sollecitato da Atena (scesa tra le schiere troiane su ordine di Zeus) ferisce con una freccia Menelao questi viene prontamente guarito dal medico Macaone figlio di Asclepio Agamennone passa fra le schiere incitandole a combattere incontra vari capi intenti a dare istruzioni ai propri uomini Solo Ulisse e Menesteo si tengono in disparte ricevendo i rimproveri di Agamennone ai quali Ulisse reagisce con indignazione Gli Achei muovono contro i Troiani con grande ordine e disciplina mentre i Troiani e i loro alleati schiamazzano come barbari Ha inizio la battaglia vera e propria nella quale lrsquoattenzione egrave focalizzata sui duelli individuali Ad assistere e rincuorare i Troiani compare Apollo sulla rocca di Troia mentre Atena infonde coraggio nei Greci Il canto si chiude sullrsquoinfuriare della battaglia la cui descrizione riprenderagrave nel canto successivo Canto V Balza in primo piano Diomede di cui viene presentata lrsquoἀριστεία lrsquoeroe laquoglorioso e chiaroraquo fa strage di nemici imperversando furiosamente fra le schiere troiane Nel pieno del combattimento viene ferito da una freccia scagliata da Pandaro il quale mena gran vanto del colpo andato a segno Diomede ottenuta unrsquoimmediata guarigione grazie allrsquointervento di Atena muove allora contro il nemico che nel frattempo era stato accolto sul carro di Enea Pandaro scaglia la sua lancia contro Diomede ma lo scudo di questi regge il colpo Diomede colpisce a sua volta uccidendo il nemico Enea scende dal cocchio per proteggere il cadavere di Pandaro dagli Achei che vorrebbero farne razzia ma Diomede lo colpisce con un grande masso fratturandogli il femore Enea viene salvato dallrsquointervento di Afrodite che lo avvolge nel suo manto mentre Diomede arriva addirittura a ferire al polso la dea che fugge sullrsquoOlimpo a farsi confortare dalla madre Dione Il figlio di Tideo attacca anche Apollo che aveva sottratto Enea alla sua furia ma
Letteratura greca [1]
15
egrave fermato dal grido di ammonimento del dio Incitati e aiutati da Ares ora i Troiani avanzano con impeto Intervengono Era e Atena e questrsquoultima assume il ruolo di auriga di Diomede Col suo aiuto questi ferisce al ventre Ares che fugge sullrsquoOlimpo Anche le dee vi fanno ritorno Canto VI Il canto VI egrave una naturale continuazione del V (tanto che Erodoto citeragrave come dallrsquoἀριστεία di Diomede un brano della prima parte del VI canto) La battaglia infuria nella pianura ma il furore di Diomede si stempera su una nota di cortesia quando lrsquoeroe dopo aver sfidato Glauco di Licia scopre di avere con lrsquoavversario antichi rapporti di ospitalitagrave I due si scambiano le armature (a detrimento di Glauco a cui laquoZeus Cronide levograve il senno cheacute scambiograve con Diomede Tidide armi drsquooro con armi di bronzo cento buoi con nove buoiraquo [vv 234-6]) Frattanto Ettore su invito dellrsquoindovino Eleno rientra in cittagrave dove le donne devono cercare di ottenere con offerte e voti il favore di Atena e incontra dapprima la madre Ecuba poi Paride (che intende ricondurre alla battaglia) vorrebbe salutare anche la moglie ma non la trova in casa bensigrave alle porte Scee dove Andromaca era accorsa piena drsquoangoscia insieme col figlioletto e con la nutrice Nel colloquio che segue ella lo implora di non esporre al pericolo se stessa e il figlio La replica di Ettore egrave esemplare per capire la prospettiva del poema e le motivazioni dellrsquoagire dei personaggi dominanti se Achille e gli eroi achei in genere cercano onore e gloria a questa motivazione (che pure non egrave assente) Ettore antepone lrsquoαἰδώς il senso di laquovergognaraquo e di responsabilitagrave nei confronti della comunitagrave e del nucleo familiare di cui egrave il difensore Poi si volta per prendere tra le braccia Astianatte ma lrsquoelmo lucente e il cimiero ondeggiante impauriscono il piccolo che si rifugia in seno alla nutrice Alla fine del canto Paride si incontra con Ettore e i due si avviano verso il campo di battaglia [T5] Canto VII A principio del canto VII Atena e Apollo si accordano per indurre Ettore a lanciare una sfida agli Achei per un duello Il sorteggio designa Aiace come campione greco Nello scontro Ettore lancia per primo lrsquoasta che penetra ma senza trapassarlo nello scudo di Aiace greve e massiccio (compaginato con sette strati di pelle bovina simile a una torre) Aiace di rimando lacera lo scudo e il pettorale della corazza ma non riesce a squarciare le carni del nemico percheacute Ettore si piega di lato Allora i due brandiscono di nuovo le aste poi ricorrono alle pietre Alla fine gli araldi arrestano il combattimento con la giustificazione che laquola notte giagrave viene ed egrave bene obbedire alla notteraquo (v 282) Su proposta di Nestore gli Achei decidono per il giorno seguente di seppellire i morti e di scavare una grande trincea difesa da un bastione sul margine del loro accampamento Respingono lrsquoofferta di pace dei Troiani (che prevederebbe la riconsegna dei tesori sottratti da Paride a Sparta) Il mattino seguente i morti vengono cremati e durante la giornata si erige il muro di protezione Canto VIII Nellrsquoassemblea degli degravei Zeus vieta ai numi di appoggiare lrsquouna o lrsquoaltra parte in conflitto Al mattino il combattimento riprende e a mezzogiorno Zeus pone i destini dei due popoli sulla bilancia che piega a favore dei Troiani Sul campo di battaglia Diomede salva Nestore Lrsquoazione di Ettore egrave travolgente fincheacute Zeus contravvenendo alla sua intenzione di favorire i Troiani accoglie la preghiera di Agamennone per risollevare il morale degli Achei che organizzano la difesa delle navi Nel corso degli scontri si segnala lrsquoarciere Teucro che colpisce i nemici muovendosi in sincronia con Aiace Telamonio che lo protegge con lo scudo Incitato da Agamennone egli prova a colpire anche Ettore ma soccombe colpito con una pietra A questa vista Era e Atena corrono ad armarsi per intervenire a favore degli Achei ma vengono distolte dalle minacce di Zeus che manifesta la propria intenzione di favorire i Troiani fino a quando i Greci non saranno ridotti alla disperazione tanto da scongiurare Achille percheacute ritorni Il sopraggiungere della notte
Letteratura greca [1]
16
interrompe i combattimenti Ettore galvanizzato dai successi ottenuti in quel giorno si illude che la vittoria sia a portata di mano e prospetta ai suoi una prossima ritirata degli Achei Il canto si chiude con il banchetto dei Troiani che banchettano nella pianura esaltati dalla speranza di vittoria Canto IX Agamennone affranto propone di fare ciograve che nel canto II aveva suggerito soltanto per mettere alla prova lrsquoesercito interrompere la guerra e tornare in patria Diomede si oppone e Nestore in un consiglio dei capi propone di tentare la riconciliazione con Achille Si invia alla tenda di Achille unrsquoambasceria (composta da Aiace Odisseo e Fenice antico pedagogo di Achille) per offrire doni ricchissimi Achille non cede anzi minaccia di salpare immediatamente verso la patria [T6] Inutilmente Fenice lrsquoantico precettore di Achille cerca di ammorbidire la determinazione del Pelide richiamando la vicenda dellrsquoeroe Meleagro [T7] Gli inviati riferiscono ad Agamennone la risposta di Achille egli torneragrave a combattere solo quando Ettore saragrave arrivato fino alle navi dei Mirmidoni Canto X Nella stessa notte si effettua una missione segreta nel corso della quale Odisseo e Diomede dapprima catturano la spia troiana Dolone (che Ettore aveva inviato alle navi achee promettendogli come ricompensa i cavalli di Achille) poi uccidono il re trace Reso appena arrivato presso i Troiani e ne rubano i magnifici cavalli Giagrave gli antichi ritenevano questo canto unrsquoaggiunta post-omerica e questi dubbi trovano riscontro in lati eccentrici della narrazione e nellrsquoimpiego di un linguaggio che spesso appare svincolato dal corrente repertorio formulare Canto XI Si apre una nuova giornata di battaglia (la cui narrazione si protrarragrave fino al canto XVIII) che ruota intorno allrsquoἀριστεία di Agamennone Quando lrsquoAtride viene ferito gli Achei ripiegano Diomede resta anchrsquoegli ferito Odisseo e Aiace evitano a stento la massa dei nemici Nestore salva sul suo carro Macaone Achille che dalla poppa della nave osserva la battaglia vuol sapere chi egrave condotto via da Nestore e manda Patroclo che viene accolto molto benevolmente e con cui Nestore intrattiene un lungo discorso egli dice di deplorare il comportamento di Achille e con atteggiamento consono alla sua condizione di anziano si dilunga nel raccontare le proprie gesta giovanili Egli esorta quindi Patroclo a far leva sulla sua amicizia per convincere Achille a riprendere il combattimento o - almeno - a concedere a Patroclo le sue armi per incutere timore nei Troiani Eccitato dalle parole del vecchio Patroclo si avvia verso la nave di Achille ma incontra Euripilo ferito che gli chiede aiuto ed egli impietositosi lo accompagna alla tenda e cura la ferita Canto XII Divisi in cinque contingenti i Troiani danno lrsquoassalto al muro eretto a difesa del campo acheo Sul campo di battaglia si manifesta un prodigio unrsquoaquila in cielo con un grosso serpente fra le zampe che riesce a ferire lrsquouccello e a sfuggire Polidamante che interpreta il segno come un presagio funesto consiglia di tornare indietro ma Ettore egrave di altro avviso Sarpedone e Glauco sferrano un attacco contro il muro e - pur rimanendo feriti - riescono ad aprire una breccia La battaglia infuria con esito incerto fincheacute Ettore con un macigno sfonda una delle porte consentendo ai Troiani di entrare in massa nel campo acheo mentre i Greci fuggono verso il mare Canto XIII Zeus distoglie lo sguardo dalla battaglia nella convinzione che nessuno fra gli dei avrebbe osato violare il divieto di intervenire ne approfitta invece Poseidone favorevole ai Greci Assunto lrsquoaspetto dellrsquoindovino Calcante il dio infonde nuovo vigore nei due Aiaci
Letteratura greca [1]
17
spronandoli al combattimento Gli Achei riconoscono lrsquointervento divino e riprendono fiducia I combattimenti si susseguono violentissimi Nella resistenza si distingue il re cretese Idomeneo Polidamante consiglia una seconda volta di interrompere la battaglia e accenna allrsquoimminente intervento di Achille Ettore non ascolta lrsquoammonimento e riprende lrsquoassalto Il canto si chiude con un suo scambio di insulti con Aiace Telamonio Canto XIV Mentre Diomede Odisseo e Agamennone tornano feriti allrsquoaccampamento Era per distogliere Zeus dalla battaglia e consentire a Poseidone di favorire gli Achei indossa la cintura magica di Afrodite e sollecita il consorte a un convegno amoroso sullrsquoIda dopo lrsquoamplesso Zeus cade in un sonno profondo e Hypnos (il Sonno) annuncia a Posidone che potragrave aiutare senza rischi gli Achei Ettore colpito con una pietra da Aiace resta a lungo in stato di incoscienza e i Troiani vengono respinti Canto XV Zeus si risveglia avvedendosi dellrsquoinganno subito e costringe Era a mandargli Iride e Apollo la prima allontaneragrave Posidone dal campo di battaglia Apollo inciteragrave Ettore a far retrocedere gli Achei fino alle navi dei Mirmidoni Riprende lrsquooffensiva troiana Apollo stesso abbatte il muro e scuotendo lrsquoegida atterrisce gli Achei Patroclo corre da Achille mentre i Troiani giagrave sono sul punto di appiccare il fuoco alle navi Canto XVI Patroclo in lacrime supplica Achille di intervenire o di mandare lui stesso al suo posto [T8] Achille gli consegna le proprie armi e gli fa promettere che non si avventureragrave oltre la zona delle navi Ma Patroclo trascinato dal suo stesso impeto oltrepassa il limite prescrittogli da Achille Abbatte Sarpedone figlio di Zeus attorno al cui cadavere infuria la lotta fincheacute Apollo lo sottrae alla mischia e Hypnos e Thanatos (il demone della morte) lo trasportano in Licia sua patria Patroclo continua lrsquoassalto alla testa dei Mirmidoni fin sotto le mura di Troia ma poco prima del tramonto al quarto assalto Apollo stesso assunto lrsquoaspetto di Asio lo percuote fra le spalle allora Euforbo lo colpisce con lrsquoasta ed Ettore lo trafigge Canto XVII Euforbo viene ucciso da Menelao ma Ettore riesce a catturare le armi di Achille indossate da Patroclo Vigorosamente sostenuti da Aiace gli Achei difendono il cadavere Una densa nebbia scende sui combattenti Zeus infonde nuovo ardimento nei cavalli di Achille piangenti per la fine di Patroclo [T9] Atena e Apollo arroventano la lotta attorno alla salma In seguito alla preghiera di Aiace Zeus dissolve la nebbia Menelao manda Antiloco figlio di Nestore a informare Achille della morte di Patroclo la cui salma viene intanto trascinata fuori della battaglia da Menelao e Merione mentre i due Aiaci offrono la necessaria copertura contro la furia incalzante dei nemici Canto XVIII Lo scoppio di selvaggio dolore a cui si abbandona Achille allrsquoudire della morte di Patroclo provoca lrsquoaccorrere dal mare di Tetide insieme con le Nereidi La madre gli promette di procurargli nuove armi Poicheacute la salma di Patroclo egrave tuttora contesa Achille fa la sua apparizione sul fossato e lancia un grido che atterrisce i nemici Efesto su preghiera di Tetide foggia le nuove armi fra cui un magnifico scudo su cui appaiono effigiati in bande concentriche gli aspetti salienti dellrsquoesistenza umana Canto XIX Il mattino seguente Tetide porta le armi al figlio e con lrsquoambrosia preserva la salma di Patroclo dalla decomposizione Achille convoca unrsquoassemblea dellrsquoesercito e rinuncia alla sua collera Agamennone lamenta di essere stato ldquoaccecatordquo da Zeus e promette doni
Letteratura greca [1]
18
riparatori [T10] Achille si lascia convincere a stento ad attendere che i soldati abbiano mangiato Poi gli armati si radunano e anche Achille si arma Il suo cavallo Xanto gli predice la prossima morte [T11] Canto XX Zeus consente agli degravei di partecipare alla nuova battaglia Enea scontratosi con Achille egrave tratto in salvo da Posidone Achille infuria come un incendio in una selva Canto XXI Achille colma di cadaveri il fiume Scamandro e cattura dodici giovani troiani che intende offrire in sacrificio a Patroclo non risparmia neppure Licaone figlio di Priamo che lo supplica con accenti di grande intensitagrave ma altrettanto intensa nella consapevolezza di un destino imminente egrave la pur spietata replica del Pelide [T12] Lo Scamandro solleva le proprie onde ma le fiamme di Efesto inaridiscono il terreno e domano la corrente Gli degravei si azzuffano Atena raggiunge Ares con una pietra Era rintuzza la furia di Artemide Infine tutti tornano sullrsquoOlimpo Apollo assunto lrsquoaspetto di Agenore respinge Achille percheacute i Troiani possano rifugiarsi allrsquointerno delle mura Canto XXII Il solo Ettore resta fuori nella pianura Invano Priamo ed Ecuba lo pregano di rientrare Mentre Achille si avvicina Ettore decide di affrontarlo ma quando quello gli egrave da presso col bronzo che gli lampeggia intorno laquosimile al raggio del fuoco ardente o del sole che sorgeraquo egrave afferrato dal panico e comincia a fuggire compiendo tre giri intorno alle mura Zeus pesa sulla bilancia i destini (le κῆρες) dei due eroi e quello di Ettore affonda in basso Allora Apollo lo abbandona e Atena apparsa a Ettore sotto le spoglie di suo fratello Deifobo gli si avvicina promettendogli aiuto e invece riporta ad Achille la lancia che gli era caduta fuori bersaglio Il colpo di risposta di Ettore rimbalza sullo scudo di Achille Ettore urla a Deifobo di passargli la sua lancia ma il falso Deifobo egrave scomparso ed Ettore comprende di trovarsi sullrsquoorlo dellrsquoabisso [T13] Achille gli trapassa la gola ed Ettore lo supplica di non oltraggiare la sua salma in risposta riceve la minaccia che finiragrave in pasto ai cani Achille trascina il cadavere alle navi attaccato al carro Priamo Ecuba e Andromaca si abbandonano al cordoglio a cui fanno eco le donne troiane Canto XXIII Viene preparato il banchetto funebre in onore di Patroclo la cui ombra nel corso della notte appare ad Achille chiedendo la sepoltura del corpo Il mattino seguente si appresta il rogo fra le offerte votive ci sono anche dodici giovani troiani Il giorno successivo si raccolgono le ossa di Patroclo Seguono i ludi funebri gare coi carri e con lrsquoarco duello in armi etc Canto XXIV Ogni giorno Achille trascina il cadavere di Ettore attorno alla tomba dellrsquoamico ma lo spettacolo offende gli degravei e al dodicesimo giorno Zeus decide di mandare Tetide percheacute induca suo figlio a restituire la salma di Ettore Iride viene inviata presso Priamo percheacute gli consigli di recarsi nel cuore della notte con un carro da trasporto e un copioso riscatto scortato da Ermes alla tenda di Achille Questi accoglie il vecchio con rispetto riconoscendo in lui lrsquoimmagine del padre lontano e si piega alla sua supplica [T14] Per volontagrave degli degravei il cadavere non egrave stato aggredito dalla putrefazione composto sul pianale del carro viene ricondotto dal padre a Troia Qui le lamentazioni rituali srsquoinnalzano dal gruppo delle donne (Andromaca Ecuba Elena) Si stipula una tregua di dodici giorni Per nove giorni i Troiani raccolgono legname poi anche il rogo di Ettore arde e si erige un tumulo
Letteratura greca [1]
19
Struttura e caratteri dellʼopera Poema di trama relativamente organica (soprattutto a partire dal canto XVI tutti gli avvenimenti tranne pochi episodi isolati ruotano attorno ai due principali antagonisti Ettore uccide Patroclo per vendicare Sarpedone e Achille uccide Ettore per vendicare Patroclo) pur se non privo di piugrave o meno cospicue incongruenze spiegabili in primo luogo con la lunga e complessa genesi orale dellrsquoopera lrsquoIliade lascia emergere in mezzo alle centinaia di nomi e alle intricate vicende alcuni caratteri delineati nella loro individualitagrave e innanzi tutto quelli di Achille e di Ettore accomunati dalla medesima coscienza di un destino di morte che sono pronti ad affrontare Appunto una tale attitudine a rappresentare i laquocaratteriraquo (ἤθη) dei suoi personaggi egrave un altro titolo di merito che Aristotele ascrive ad Omero (Poetica 1460a9-11)
dopo aver brevemente proemiato subito introduce un uomo una donna o un altro personaggio nessuno privo di caratterizzazione ma dotato di un carattere
Fondamentale per la struttura del poema egrave la novitagrave della prospettiva Possiamo presumere che i cosiddetti poemi ciclici22 mirassero a conservare lrsquoangolatura che era stata propria delle versioni pre-omeriche della saga troiana sigrave che puograve riuscire significativo il confronto fra lrsquoesordio della Piccola Iliade (dove muovendo da grandi entitagrave ndash la cittagrave il paese due popoli la guerra ndash viene lanciato secondo lrsquoespressione di J Latacz come laquouno sguardo dallrsquoesternoraquo)
Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην εὔπωλον ἧς πέρι πολλὰ πάθον Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος Canto Ilio e la terra dei Dardani dai bei puledri per la quale molti dolori patirono i Danai servitori di Ares
con lo laquosguardo internoraquo che caratterizza lrsquoinizio dellrsquoIliade
Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν ἡρώων αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν οἰωνοῖσί τε δαῖτα Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς Canta o dea di Achille figlio di Peleo la collera maledetta che pene innumerevoli inflisse agli Achei e molte scagliograve allrsquoAde vite possenti di eroi e ne faceva prede per i cani e pasto per gli uccelli e si avverava il volere di Zeus da quando primamente si separarono venuti a contesa LrsquoAtride sovrano di eroi e Achille magnifico
Argomento non egrave dunque come doveva avvenire nella tradizione del canto epico un evento complesso da inquadrare con un grandangolo onnicomprensivo e neppure come saragrave nellrsquoOdissea un personaggio colto nella multiforme varietagrave delle sue peregrinazioni egrave invece una reazione emotiva (lrsquoira di Achille) con le sue conseguenze (le innumerevoli morti degli Achei) Narrare di questa ira significa per il poeta cominciare da un punto preciso (laquoda quandoraquo) ossia dal momento della contesa e della separazione fra i due massimi eroi greci Agamennone il primo per potere (laquosovrano di eroiraquo) e Achille il primo per nobiltagrave e forza (δῖος) E sintomatica della bipolaritagrave del mondo epico in quanto mondo di degravei e di eroi egrave la sincronia per cui il taglio della narrazione coincide col decorso del laquovolere di Zeusraquo (Διὸς βουλή) forse da identificare con la promessa del dio a Tetide (rievocata piugrave oltre in questo
22 V cap II laquoLa tradizione omericaraquo
Letteratura greca [1]
20
stesso canto ai vv 518-527) di vendicare lrsquoaffronto subito da Achille o piugrave in generale con il corso degli eventi in quanto tutto come per definizione laquogiace sulle ginocchia di Zeusraquo Opera indubbiamente allrsquointerno del poema unrsquoidea formativa un progetto di qui un insieme monumentale unificato anche da una serie di corrispondenze a distanza fra cui particolare significato acquistano quelle fra primo e ultimo canto Nel canto I il vecchio Crise va come supplice presso Agamennone portando doni e supplicando la restituzione della figlia e Agamennone lo respinge aspramente minacciandolo di far ricorso alla violenza se dovesse tornare nel canto XXIV il vecchio Priamo va come supplice presso Achille portando doni e supplicando la restituzione del corpo del figlio Achille ha una prima reazione irosa (esordisce al v 560 con laquoSmetti di irritarmi vecchioraquo) ma poi accoglie la supplica E al di lagrave delle corrispondenze nelle linee dellrsquoazione si colgono fra principio e fine del poema alcuni importanti echi verbali in particolare fra XXIV 501 s
τοῦ νῦν εἵνεχ᾽ ἱκάνω νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενος παρὰ σεῖο φέρω δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα per lui [Ettore] vengo ora alle navi degli Achei per riscattarlo da te e ti porto compenso infinito
e I 12 s
ὁ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενός τε θυγάτρα φέρων δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα costui [Crise] venne alle navi rapide degli Achei per riscattare la figlia portando compenso infinito
fra XXIV 555-557
λῦσον ἵν᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδωmiddot σὺ δὲ δέξαι ἄποινα πολλά τά τοι φέρομενmiddot σὺ δὲ τῶνδrsquo ἀπόναιο καὶ ἔλθοις σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν restituiscimelo percheacute lo possa vedere con gli occhi e accogli il riscatto copioso che portiamo e tu possa goderne e tornare alla tua terra patria
e I 18-20
Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν εὖ δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκέσθαιmiddot παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην τὰ δ᾽ ἄποινα δέχεσθαι Atridi e voi altri Achei dai forti schinieri a voi concedano gli degravei che hanno le case in Olimpo di distruggere la cittagrave di Priamo e tornare facilmente in patria ma restituitemi la figlia e accettate il riscatto
fra XXIV 560 μηκέτι νῦν μ᾽ ἐρέθιζε (laquosmetti di irritarmiraquo) e I 32 μή μ᾽ ἐρέθιζε (laquonon mi irritareraquo) fra XXIV 568-570
τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς μή σε γέρον οὐδrsquo αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω καὶ ἱκέτην περ ἐόντα Διὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμάς Ora perciograve fra i dolori non mi eccitare lrsquoanimo ancora di piugrave bada o vecchio che non ti lasci neppure nella tenda
Letteratura greca [1]
21
bencheacute supplice e violi gli ordini di Zeus e I 26-28
μή σε γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω ἢ νῦν δηθύνοντ᾽ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο Mai te o vecchio io colga presso le concave navi ora a indugiare o piugrave tardi a tornare che piugrave non dovesse giovarti lo scettro e la benda del dio
(e infine XXIV 571 ὣς ἔφατ ἔδεισεν δ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ laquocosigrave diceva e il vecchio tremograve e obbediva alle paroleraquo ripete esattamente I 33) In effetti lrsquoepisodio terminale del poema col superamento dellrsquoira ad opera della pietagrave e del senso di unrsquoesistenza invasa dal dolore si propone come il rovesciamento consapevole dellrsquoepisodio iniziale che era apparso caratterizzato dalla cancellazione della pietagrave e del diritto dei supplici in nome della forza Al rifiuto iniziale del donoriscatto si oppone lrsquoaccettazione finale in consonanza con un principio-guida che opera nel poema secondo linee che alla fine si riunificano Agamennone restituisce Criseide al padre ma si appropria del dono fatto dagli altri Achei ad Achille (Briseide) Achille respinge i doni fatti da Agamennone per indurlo a riconciliarsi con lui ma dopo aver contestato nel IX canto la nozione che la vita umana possa essere barattata con una massa di beni torna alla lotta non in cambio di qualche premio da conquistare ma per vendicare lrsquouccisione dellrsquoamico Patroclo e tanto nella lotta sul campo di battaglia quanto nellrsquoinfierire sul cadavere di Ettore si abbandona a un furore cosigrave smisurato e patologico che puograve essere superato solo con lrsquoaccettare i doni di Priamo non tuttavia per il loro valore drsquouso ma percheacute in Priamo Achille riconosce lrsquoombra del padre lontano Cosigrave lrsquoIliade appare attraversata da un impulso fondamentale che muove dallrsquoideologia del dono e dalla conseguente centralitagrave assegnata allrsquoonore (τιμή) come ldquoprezzordquo che qualifica il valore del guerriero ma supera questo piano di valutazione dei rapporti umani attraverso la loro riformulazione nei termini di un umanesimo esistenziale che ha come punti di riferimento lrsquoidentitagrave universale dei condizionamenti oggettivi (la vecchiaia la malattia la morte) e i legami che uniscono padre e figlio compagno e compagno vivi e morti (il cordoglio finale di Andromaca Ecuba ed Elena sulla salma di Ettore) Entro questo orizzonte progressivamente allargato la guerra le lotte lo scontro mortale finiscono col rappresentare solo un momento e un aspetto dellrsquoesistenza graditi tanto agli degravei che vi assistono come spettatori interessati quanto agli uditori che riascoltano le antiche gesta eppure non tali da appiattire il poema in una prospettiva guerresca conclusa in se stessa Molto del fascino delle battaglie e delle ἀριστεῖαι dellrsquoIliade sta nella presenza recondita di un occhio che sa guardare al di lagrave di esse (e al di lagrave della stessa distinzione fra Greci e Troiani vincitori e vinti) e che puograve anche attraverso le similitudini lasciare irrompere il mondo della natura o del lavoro umano nel mezzo delle battaglie LʼOdissea LrsquoOdissea (Ὀδύσσεια) consta di circa 12100 esametri divisi anchrsquoessi in 24 libri e indicati con le lettere minuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquoargomento egrave costituito dalle avventure di Odisseo dalla distruzione di Troia al ritorno alla patria Itaca esposte secondo un ordine che entrando subito nel vivo degli avvenimenti (lrsquoinizio del poema mostra Odisseo nellrsquoisola di Calipso) rievoca poi i fatti giagrave trascorsi e li ricongiunge infine a partire dal libro XV (con lrsquoarrivo di Telemaco alla capanna di Eumeo dove giagrave si trova Odisseo) in unrsquoazione unitaria La trama del poema i cui avvenimenti sono concentrati cronologicamente nello spazio di 40 giorni (ma sono narrati solo gli avvenimenti di 16 giorni e 8 notti) si articola in tre parti la laquoTelemachiaraquo (canti I-IV) il laquoRitorno di Odisseoraquo (canti V-XIII) e la laquoVendetta di Odisseoraquo (canti XIV-XXIV)
Letteratura greca [1]
22
Canto I Tutti gli eroi superstiti sono ormai tornati da Troia alle loro case tranne Odisseo che pur desideroso di tornare egrave trattenuto dalla ninfa Calipso nellrsquoisola di Ogigia Gli degravei hanno pietagrave di lui tranne Posidone irato per lrsquoaccecamento del figlio il ciclope Polifemo Ma un consiglio degli degravei assente Posidone (che si egrave recato presso gli Etiopi) delibera il ritorno dellrsquoeroe si decide che Ermes andragrave subito da Calipso mentre Atena si avvia verso Itaca sotto lrsquoaspetto del signore dei Tafi Mente per incoraggiare il figlio di Odisseo Telemaco a tener testa ai pretendenti della madre i laquoprociraquo (i quali aspirano al regno tramite le nozze con Penelope) e per indurlo a intraprendere un viaggio in cerca di notizie sul padre Canto IΙ Telemaco segue il consiglio della dea e il giorno seguente nellrsquoassemblea popolare chiede una nave per andare in cerca del padre ma la sua richiesta non viene discussa e Leocrito scioglie lrsquoassemblea Grazie ad Atena che ora ha assunto le sembianze di Mentore (antico amico di Odisseo) Telemaco riesce tuttavia a trovare una nave con cui salpa nel corso della notte allrsquoinsaputa sia della madre che dei proci Canto IΙΙ Telemaco e MentoreAtena arrivano a Pilo e sul lido trovano Nestore che sta offrendo un sacrificio a Posidone Il vecchio eroe accoglie ospitalmente Telemaco e gli comunica molte notizie sul ritorno di altri Achei ma nessuna su Odisseo Alla sera Atena scompare in forma di aquila e il mattino seguente Telemaco salpa insieme con Pisistrato (figlio di Nestore) alla volta di Sparta dove arriva la sera del giorno successivo Canto IV A Sparta Menelao sta festeggiando il doppio matrimonio del figlio e della figlia Il giorno seguente Telemaco chiede del padre Menelao gli racconta il proprio ritorno durante il quale aveva incontrato Proteo il vecchio nume marino che gli aveva riferito come Odisseo fosse trattenuto nellrsquoisola di Calipso Intanto a Itaca i proci preparano insidie meditando di uccidere Telemaco al suo ritorno Penelope ne viene a conoscenza ma Atena le appare in sogno per confortarla Canto V Dopo un secondo concilio degli degravei (in effetti un ldquodoppionerdquo di quello del I canto) Zeus manda finalmente Ermes presso Calipso con lrsquoordine di lasciar partire Odisseo La ninfa aiuta lrsquoeroe a costruirsi una zattera Al diciottesimo giorno di navigazione Odisseo egrave in vista dellrsquoisola dei Feaci Scheria quando Posidone di ritorno dal suo soggiorno presso gli Etiopi lo vede e suscita una tempesta che distrugge la zattera Ma la dea marina Ino Leucotea impietositasi gli porge il proprio velo sostenuto dal quale lrsquoeroe giunge a nuoto alla riva di Scheria dove si abbandona esausto addormentandosi Canto VI In seguito a un sogno inviatole da Atena Nausicaa la figlia del re dei Feaci Alcinoo si reca nei pressi della spiaggia a lavare le vesti insieme con le ancelle Odisseo risvegliatosi atterrisce le fanciulle che fuggono tutte allrsquoinfuori di Nausicaa Lrsquoeroe supplica la giovane di porgerle aiuto ed ella lo fa rivestire e lo accompagna fino al bosco di Atena poco prima della cittagrave esortandolo a presentarsi a suo padre Canto VII Protetto dalla nebbia di cui Atena lo ha avvolto Odisseo entra nel palazzo abbraccia le ginocchia della regina Arete e la caligine scompare poi viene accolto con onore da Alcinoo Arete chiede a Odisseo donde provenga e chi gli abbia donato gli abiti (a lei ben noti) che indossa Lrsquoeroe inizia a raccontare le disavventure che gli sono occorse dopo la
Letteratura greca [1]
23
partenza dallrsquoisola di Calipso Alcinoo gli promette di farlo ricondurre a Itaca il giorno seguente Canto VIII Ma lrsquoindomani Alcinoo fa apprestare un banchetto durante il quale lrsquoaedo Demodoco canta della contesa insorta un giorno fra Achille e Odisseo Lrsquoeroe si copre il volto per nascondere le lacrime allora Alcinoo interrompe il canto e organizza una serie di gare nel corso delle quali Odisseo primeggia Poi Demodoco al margine di unrsquoarea per la danza dove si esibiscono i ballerini feaci canta gli amori di Ares e Afrodite e la vendetta di Efesto (che incatena i due amanti) La sera al ritorno nel palazzo Demodoco racconta la storia del Cavallo di legno Odisseo scoppia nuovamente in lacrime e Alcinoo gli chiede di rivelare il suo nome Canto IX Odisseo dichiara il proprio nome e dagrave inizio al racconto della propria storia a partire dalla caduta di Troia distruzione di Ismaro e perdite subite ad opera dei Ciconi sbarco presso i Lotofagi (che si nutrono di un cibo misterioso che fa dimenticare il ritorno) dopo una terribile tempesta scatenatasi durante il tentativo di doppiare il capo Malea arrivo allrsquoisola antistante quella dei Ciclopi dove Odisseo si trasferisce con una sola nave esplorazione dellrsquoisola perdita di alcuni compagni allrsquointerno della caverna del gigante monocolo accecamento del mostro e fuga Canto X Odisseo giunge allrsquoisola di Eolo signore dei venti che lo accoglie benevolmente e gli consegna alla partenza tutti i venti chiusi in un otre ma poi lo respinge con durezza quando ritorna presso di lui percheacute i compagni (sospettando che nellrsquootre siano racchiuse cospicue ricchezze) hanno sciolto i venti e da essi si egrave sprigionato un uragano che li ha risospinti sullrsquoisola Ripreso il mare Odisseo egrave trasportato fino ai Lestrigoni antropofagi il cui attacco priva lrsquoeroe di tutte le altre navi tranne la propria Con questa fugge fino allrsquoisola (Eea) della maga Circe Dopo che Circe ha trasformato in porci un gruppo di compagni mandati innanzi ad esplorare lrsquoisola Odisseo ha la meglio sulla maga (a cui impone di restituire forma umana ai compagni) grazie allrsquoerba moly fornitagli da Ermes Resta un anno presso Circe che al momento della partenza gli consiglia di recarsi al paese dei morti per interrogare il vate Tiresia Canto XI Approdato alla terra dei Cimmeri (che vivono immersi in una nebbia perenne sulla riva dellrsquoOceano) e scavata una fossa Odisseo sacrifica ai morti e immola una vittima speciale a Tiresia Le anime accorrono dapprima Elpenore caduto per caso giugrave dal tetto della casa di Circe (Odisseo gli promette sepoltura) poi la madre Anticlea (che gli racconta di esser morta di dolore per la sua assenza) quindi Tiresia che gli vaticina le sue vicende future fino alla morte (questa lo coglieragrave dopo una lunga vita in un paese straniero che non conosce neacute il sale neacute il remo) Da un certo punto in poi il poeta dimentica il presupposto per cui Odisseo aveva scavato una fossa alla quale i morti accorrevano per bere il sangue delle vittime e bevendolo riacquistavano per breve tempo una piena consapevolezza immagina invece che Odisseo sia allrsquointerno dellrsquoAde In questa sezione rientrano la descrizione di Aiace sdegnato di Minosse di Orione dei grandi peccatori di Eracle Poi Odisseo fa ritorno a Eea e ricevuti i consigli di Circe si imbarca per il ritorno in patria Canto XII Scampato alle Sirene che invano lo attirano col canto (si egrave fatto legare allrsquoalbero della nave i compagni che remano hanno le orecchie turate con la cera) passa tra Cariddi e Scilla (che gli rapisce sei uomini) ed egrave costretto dai compagni ad approdare in contrasto con le prescrizioni di Circe allrsquoisola Trinachia dove pascolano le greggi del Sole I
Letteratura greca [1]
24
compagni spronati da Euriloco se ne cibano nonostante il divieto dellrsquoeroe Il Sole sdegnato ottiene da Zeus che la nave sia colpita dal fulmine Tutti i compagni periscono ma Odisseo che ripassa tra Scilla e Cariddi si salva miracolosamente da questrsquoultima aggrappandosi a un fico selvatico fincheacute il gorgo restituisce i rottami della nave infine arriva remando con le mani allrsquoisola di Ogigia Canto XIII Terminato il racconto lrsquoeroe riceve doni dai Feaci e la notte seguente egrave ricondotto a Itaca e deposto addormentato sulla spiaggia presso un antro sacro alle Ninfe Al risveglio per la nebbia non riconosce la sua terra fincheacute Atena in veste di giovane pastore lo rassicura e poi rivelatasi gli dagrave istruzioni su come far strage dei proci e lo trasforma in un vecchio mendico Canto XIV Odisseo si reca allo stazzo del suo porcaio Eumeo che pur non riconoscendolo lo accoglie ospitalmente rifocillandolo e offrendogli un mantello per ripararsi dal gelo notturno Canto XV A questo punto la laquoTelemachiaraquo si riannoda allrsquoazione principale Telemaco che si trova ancora a Sparta viene indotto da Atena a tornare a Itaca sulla via del ritorno a Pilo accoglie a bordo lrsquoindovino Teoclimeno e grazie allrsquoaiuto della dea sfugge alle insidie dei proci sbarca a Itaca e si reca anchrsquoegli presso Eumeo Canto XVI Questi va da Penelope ad annunciargli il ritorno del figlio Intanto Odisseo rimosso lrsquoincantesimo si svela nel suo vero aspetto a Telemaco e con lui progetta la vendetta sui proci (che intanto tramano una nuova insidia ai danni di Telemaco) Eumeo torna al suo stazzo Canto XVII Il mattino seguente Telemaco si reca in cittagrave seguito in un secondo tempo da Eumeo e Odisseo (che ha riassunto lrsquoaspetto di mendico) Davanti al palazzo Odisseo egrave riconosciuto dal cane Argo Entra e va mendicando tra i proci Antinoo lo colpisce alla spalla destra con uno sgabello Canto XVIII Odisseo si batte al pugilato col mendicante Iro Penelope scesa nella sala prospetta ai proci lrsquoeventualitagrave di un nuovo matrimonio Odisseo egrave insultato dalla schiava Melanto e schiva uno sgabello scagliato da Eurinomo Canto XIX Insieme con Telemaco lrsquoeroe allontana le armi dalla sala poi conversa con Penelope che gli racconta un sogno e gli espone il suo piano per sedare le contese tra i proci concedendosi sposa a colui che riusciragrave a tendere lrsquoarco di Odisseo la prova avverragrave il giorno seguente al novilunio Durante il colloquio la fida schiava Euriclea lava i piedi di Odisseo e riconosciutolo da unrsquoantica cicatrice sta per rivelarne lrsquoidentitagrave ma lrsquoeroe la costringe a tacere Canto XX Al mattino Euriclea e le ancelle fanno i preparativi per il banchetto Giungono Eumeo Melanzio e il mandriano Filezio Un presagio mandato da Zeus dissuade i proci dal progetto di uccidere Telemaco Durante il banchetto Teoclimeno predice la loro imminente rovina
Letteratura greca [1]
25
Canto XXI Penelope conduce lrsquoarco nella sala dopo che parecchi fra i proci e lo stesso Telemaco hanno tentato invano di tenderne la corda Odisseo chiede di partecipare alla prova tende lrsquoarco senza fatica e riesce a far passare la freccia attraverso gli anelli di dodici scuri predisposte da Telemaco Canto XXII Poi scaglia le frecce sui proci e si rivela nella sua identitagrave Nella lotta che segue Telemaco Eumeo e Filezio aiutano il padrone contro i proci (appoggiati dal capraio Melanzio) Tutti i proci restano uccisi le ancelle infedeli sono impiccate Melanzio viene mutilato e ucciso soltanto lrsquoaedo Femio e lrsquoaraldo Medonte sono risparmiati Canto XXIII Nuovo colloquio fra Odisseo e Penelope che durante lrsquoeccidio dormiva ed egrave stata svegliata da Euriclea Penelope esita ancora a riconoscere il marito e non si arrende alla veritagrave fincheacute Odisseo non le descrive la posizione e la struttura del letto coniugale Canto XXIV Ermes conduce allrsquoAde le ombre dei proci Odisseo fa visita al padre Laerte nella masseria dove quello vive nello squallore e nellrsquoemarginazione e si fa riconoscere Intanto il padre di Antinoo incita gli Itacesi alla rivolta e il poema si conclude con lo scontro di Odisseo e dei suoi contro i concittadini lrsquoeroe ha la meglio e Zeus scagliato il fulmine pone fine alla battaglia Atena sotto lrsquoaspetto di Mentore stabilisce fra i contendenti un patto per il futuro36
Struttura e caratteri dellʼopera Giagrave la prima parola del proemio (ἄνδρα) non menziona come tema dellrsquoopera un determinato episodio della vita del protagonista ma il protagonista stesso (I 1-10)
Ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα πολύτροπον ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεmiddot πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περmiddot αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο νήπιοι οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιονmiddot αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ τῶν ἁμόθεν γε θεά θύγατερ Διός εἰπὲ καὶ ἡμῖν Dellrsquouomo multiforme a me racconta o Musa che molto errograve dopo che di Troia la sacra rocca distrusse di molti uomini vide le cittagrave riconobbe il pensiero e molti per il mare patigrave dolori nellrsquoanimo per salvare la sua vita e il ritorno dei compagni Eppure non li salvograve i compagni per quanto bramasse per la loro stessa follia si persero gli stolti i buoi del Sole Iperione mangiarono e quello rapigrave ad essi il digrave del ritorno Di questo da un punto qualsiasi narra anche a noi o dea figlia di Zeus
Storie favolose di naviganti racconti imperniati sul ritorno dei guerrieri achei che avevano combattuto a Troia e il particolare rientro in patria di Odisseo figlio di Laerte erano forse giagrave stati connessi e intrecciati nella precedente tradizione epica sigrave che il presente cantore poteva
Letteratura greca [1]
26
metter mano alla vicenda partendo (v 10) laquoda un punto qualsiasiraquo (ἁμόθεν) una notazione che certo presuppone la convenzione propria dellrsquoesordio tradizionale di un canto epico comparabile con i giagrave ricordati ἐξ οὗ (laquoda quandoraquo) di Iliade I 4 ed ἔνθεν (laquoda doveraquo) di Odissea VIII 500 Senoncheacute rispetto a queste indicazioni di tipo puntuale il tratto costituito dalla dimensione casuale quasi arbitraria inerente ad ἁμόθεν proprio mentre dichiara lrsquoassenza di un determinato piano compositivo implica in realtagrave che il racconto non si svolgeragrave per filo e per segno secondo lrsquoordine noto a poeta e uditori non si snoderagrave κατὰ κόσμον (laquoper ordineraquo) come il canto di Demodoco (VIII 489) ma seguiragrave un andamento originale Il ldquopunto qualsiasirdquo incipitario non rappresenta una scelta della Musa (figura dellrsquoarchivio tematico che conserva le laquovieraquo dellrsquoepica) bensigrave di questo cantore che ha deciso di far incominciare la narrazione in medias res e ha in serbo la sorpresa di far succedere al concilio degli degravei (che decide lrsquoinvio di Ermes presso Calipso) non lrsquoazione testeacute programmata (azione che viene differita con un ritardo che a piugrave riprese ha scandalizzato i lettori a principio del V canto) ma la partenza di Atena alla volta di Itaca e lrsquoavvio della laquoTelemachiaraquo Le due diverse vicende proposte a principio del poema quella di Telemaco e quella di Odisseo procedono infatti in parallelo coprendo un analogo lasso di tempo Piugrave oltre la decisione di trasformare la sequenza narrativa che va dalla partenza di Odisseo da Troia fino al suo arrivo nella terra dei Feaci in una rievocazione fatta dallrsquoeroe in prima persona al cospetto di Alcinoo e dei Feaci (la sezione detta degli ἀπόλογοι laquoraccontiraquo) crea una struttura ad anello che parte dal presente e ad esso fa ritorno dopo aver ricostruito le premesse della condizione attuale del protagonista Col canto XIII Odisseo egrave riportato dai Feaci a Itaca e questo permette la saldatura fra le vicende sue e quelle di Telemaco sia pure col differimento dellrsquoincontro e del riconoscimento fra padre e figlio fino al canto XVI Far scorrere in parallelo sequenze distinte organizzare programmi narrativi a corta e a lunga gittata tendere o allentare ad arte il ritmo della narrazione non si tratta davvero di procedimenti che potessero configurarsi come tradizionali dellrsquoarte epica quanto piuttosto di un momento sperimentale di una ricerca di soluzioni nuove al termine di una lunga e ormai consolidata sedimentazione di percorsi compiuti allrsquointerno di un determinato repertorio tematico unrsquoaudacia inventiva una πολυτροπίη degne del protagonista del poema che inevitabilmente comportavano rischi molteplici di incoerenze dissonanze occasionali avarie della macchina epica e che tuttavia erano destinate a conseguire un risultato assolutamente convincente allrsquoorecchio di chi si abbandonasse al fascino del racconto senza lrsquourgenza propria di altre etagrave e di altre mentalitagrave di puntare il dito sui singoli dettagli o le singole sfasature
PER SAPERNE DI PIUrsquo Difficoltagrave e incongruenze della narrazione omerica Forti della possibilitagrave di un controllo su un testo scritto che possiamo percorrere in avanti e a ritroso secondo ritmi di nostra scelta a noi non riesce difficile cogliere alcune delle difficoltagrave organizzative incontrate nella composizione del poema In proposito per ricordare un caso che saragrave allrsquoorigine delle discussioni di orientamento ldquoanaliticordquo intorno allrsquoOdissea possiamo leggere il discorso che Atena prese le sembianze di Mente re dei Tafi rivolge a Telemaco nel I canto (vv 253-305) Ah infelice ti manca molto davvero lrsquoassente Odisseo che getti le mani addosso ai pretendenti sfrontati Percheacute se ora tornato stesse sulla soglia 255 con una scure lo scudo e due lance cosigrave come io per la prima volta lo vidi in casa nostra che beveva e godeva di ritorno da Efira da Ilo di Mermero (andograve anche ligrave Odisseo con la nave veloce 260 in cerca del veleno omicida per averne da ungere le frecce di bronzo ma quello non glielo diede percheacute temeva gli dei che vivono eterni
Letteratura greca [1]
27
glielo diede invece mio padre percheacute lrsquoamava moltissimo) se stesse Odisseo tra i pretendenti cosigrave 265 essi avrebbero tutti rapida morte e nozze amare Ma sulle ginocchia degli dei questo giace se una volta tornato faragrave o no vendetta nella sua casa te invece io esorto a riflettere come cacciare i pretendenti da casa 270 Ebbene ora ascolta e alle mie parole darsquo retta Domattina chiamati gli eroi Achei a consiglio rivolgi a tutti un discorso e siano testimoni gli dei Ai pretendenti comanda drsquoandarsene per i fatti loro e tua madre se lrsquoanimo la spinge alle nozze 275 ritorni a casa del padre molto potente Prepareranno essi le nozze e disporranno i doni nuziali moltissimi quanti gli pare che debbano andare alla figlia A te darograve un saggio consiglio se vuoi ascoltarlo armata una nave con venti remi la migliore che crsquoegrave 280 Varsquo a domandare del padre partito da tempo se mai te ne parli un mortale o sentissi da Zeus la voce che divulga la fama tra gli uomini Anzitutto varsquo a Pilo e interroga il chiaro Nestore di ligrave poi varsquo a Sparta dal biondo Menelao 285 degli Achei vestiti di bronzo egli egrave tornato per ultimo Se senti dire qualcosa sulla vita e il ritorno del padre per quanto stremato potresti sopportare un altro anno se invece senti dire che egrave morto e non vive allora tornato nella cara terra patria 290 ergigli un tumulo e offrigli funebri offerte moltissime quanto conviene e darsquo tua madre a un marito E poi dopo aver compiuto e fatto ogni cosa allora medita nella mente e nellrsquoanimo come tu possa uccidere nelle tue case 295 i pretendenti con lrsquoinganno affrontandoli non devi piugrave avere i modi di un bimbo percheacute ormai non sei tale Non senti lrsquoillustre Oreste quale gloria ha acquistato fra tutti gli uomini percheacute uccise lrsquoassassino del padre Egisto esperto di inganni che gli uccise il nobile padre 300 Anche tu caro infatti molto bello e grande ti vedo sii valoroso percheacute ti lodi anche qualcuno dei posteri Ma io tornerograve adesso alla nave veloce dai compagni che forse impazienti mi aspettano Tu devi pensarci da te dammi retta 305
[Tr di GA Privitera] Le stranezze non mancano davvero e cosigrave sono state messe a fuoco da Stephanie West nel suo commento23 1 Atena sa evidentemente molto piugrave di quanto uno come Mente avrebbe potuto sapere in particolare ella sa che i proci ignoreranno lrsquoinvito di Telemaco a lasciare la sua casa e fatto piugrave importante che gli degravei tra breve ricondurranno in patria Odisseo A queste osservazioni si puograve replicare con la stessa West che laquosi sono esagerate difficoltagrave e
23 Omero Odissea I cit 219 ss
Letteratura greca [1]
28
incongruenze alle quali un pubblico di ascoltatori (o anche un lettore moderatamente attento) probabilmente non farebbe casoraquo 2 Il progetto di una pubblica denuncia dei proci dinanzi agli degravei e agli uomini ai vv 273-274 egrave ciograve che Atena sembra prefiggersi nel promuovere lrsquoassemblea degli Itacesi (assemblea che effettivamente avragrave luogo a principio del canto II) drsquoaltra parte le successive istruzioni di AtenaMente ai vv 295 s (medita come uccidere i pretendenti) presuppongono che di quella richiesta da formulare nel corso dellrsquoassembla essi non terranno alcun conto Anche a questa osservazione si puograve rispondere che laquoegrave ragionevole attendersi che Telemaco condivida la previsione di un esito negativo della sua iniziativaraquo e si puograve aggiungere che pure in caso di insuccesso il ricorso allrsquoassemblea potrebbe ottenere almeno il risultato di screditare i pretendenti presso la comunitagrave itacese legittimando un successivo ricorso alla violenza (e si tratta di una legittimazione di cui anche lrsquoultimo canto mostreragrave lrsquoesigenza) 3 Dopo che Telemaco aveva detto che la madre non intendeva risposarsi (vv 249-250) AtenaMente si esprime ai vv 275-278 come se Penelope desiderasse proprio nuove nozze e inoltre sarebbe assurdo che il padre di Penelope cominciasse a contrattare un secondo matrimonio prima del ritorno di Telemaco dal suo viaggio e che mettesse mano a preparativi che rischierebbero di essere annullati qualche tempo dopo con inevitabile imbarazzo se Telemaco venisse a sapere che Odisseo egrave ancora vivo In piugrave lrsquoandamento sintattico di questi versi presenta un anacoluto durissimo per cui a principio del v 275 lrsquoaccusativo μητέρα egrave seguito da un ἂψ ἴτω (laquovada indietroraquo laquotorniraquo) che richiederebbe come soggetto un nominativo μήτηρ Come hanno reagito i lettori di Omero Nellrsquoantichitagrave un grammatico rimasto anonimo cambiava come attesta uno scolio μητέρ᾽ in μήτηρ nel secolo XVIII Richard Bentley modificava ἴτω in ἴμεν (infinito eolico di εἶμι laquovadoraquo) nel XIX un altro grande della filologia europea Gottfried Hermann risolveva piugrave drasticamente la questione eliminando il complesso dei vv 275-278 e la stessa West mostra simpatia per tale proposta supponendo laquounrsquoaggiunta posteriore modellata sul corrispondente passo del libro IIraquo (dove i vv 196 s sono identici ai vv 277 s e il v 195 copre lo stesso contenuto dei vv 275 s) Si tratta di procedimenti adeguati ai dati di fatto Migliorano davvero il testo che ci egrave stato tramandato In realtagrave ambedue le ldquocorrezionirdquo appena ricordate (di μήτερ᾽ e di ἴτω) ottengono un risultato tanto lineare che egrave davvero difficile pensare che lrsquoanacoluto avrebbe potuto invadere tutta la tradizione se non fosse stato originario e quanto allrsquoespunzione dei vv 275-278 essa indubbiamente peggiorerebbe il ritmo del discorso determinando lrsquoavvicinamento fra i due versi (v 271 e v 279) molto simili fra loro che aprono le due sequenze occupate dai consigli di Mente E allora La via piugrave saggia egrave senzrsquoaltro quella di tenerci qui come quasi sempre di fronte al testo omerico contraddizioni e anacoluti riconoscendo in essi lrsquoeffetto dellrsquoattivitagrave di un cantore che pur sulla base di una traccia largamente memorizzata restava pur sempre legato a quella prassi orale per cui composizione ed esecuzione tendevano a coincidere E lrsquoanacoluto si spiega bene se cerchiamo di immedesimarci nel procedimento seguito dal poeta Egli ha affidato ad Atena un certo flusso argomentativo per cui la dea deve dar consigli a Telemaco sui suoi rapporti coi proci e con la madre e cosigrave colloca in fine di v 274 un ἄνωχθι (laquoordinaraquo) destinato a reggere gli accusativi simmetricamente dislocati in principio di verso (vv 274 e 275) μνηστῆρας e μητέρα Senoncheacute giunto a questa seconda parte dellrsquoargomentazione egli si avvede quanto sarebbe illogico che Telemaco sollecitasse la madre a nuove nozze di qui lrsquoimprovviso cambio di costruzione che svincola al prezzo di una sensibile slogatura sintattica lrsquoipotesi delle nuove nozze dallrsquoordine impartito a Telemaco e la prospetta invece come un desiderio eventuale della stessa Penelope Il poeta ha un progetto ben meditato brani e sequenze piugrave volte sperimentati ed egrave col supporto di questi materiali giagrave elaborati che egli si fa strada attraverso le insidie della
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
8
r Iliade I 58 τοῖσι δrsquo ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς f Odissea VIII 97 Ὣς ἔφατrsquo οὐδrsquo ἐσάκουσε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς Piugrave in particolare se consideriamo le singole articolazioni minori del verso riscontriamo che a) nel segmento iniziale si incontrano con alta frequenza brevi nessi che contengono congiunzioni pronomi e particelle connettive o avversative ad es fino ad a1 () αὐτὰρ ὁ δή ποτε ὣς τότε καὶ τότε ὣς ὁ μέν fino ad a2 () αὐτὰρ ἐπεί ἀλλ᾽ ὅτε δή ἔνθ᾽ ἄλλοι τοὶ μὲν ἔπειτ᾽ b) nel segmento centrale che va da m o da f fino a r o a b compare spesso il predicato verbale su cui gravita la frase (si veda a titolo di esempio il verso di Iliade sopra citato nel quale μετέφη si estende appunto da m a r) m r Iliade I 58 τοῖσι δrsquo ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς c) il segmento finale (a partire da r o da b) rappresenta il piugrave ricco serbatoio di nessi formulari innanzi tutto come nel caso di πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς le formule nome proprioepiteto ma anche molti casi di associazione fra nome comune ed epiteto ad es ξίφος ἀργυρόηλον φόρμιγγα λίγειαν πατρίδος αἴης θούριδος ἀλκή μώνυχες ἵπποι ὀξέϊ χαλκῷ πότνια μήτηρ Le formule tendono a organizzarsi in sistemi caratterizzati dalle tendenze complementari allrsquoestensione e allrsquoeconomicitagrave a) il principio dellrsquoestensione si connette alla tendenza dellrsquoepica a produrre nessi formulari atti a coprire tutto ciograve che nella narrazione sia tipico costante ripetitivo e a dislocare le formule coprendo le varie partizioni del verso ad es per Ettore troviamo tre formule finali di diversa estensione (φαίδιμος Ἥκτωρ κορυθαίολος Ἥκτωρ e μέγας κορυθαίολος Ἥκτωρ e una formula iniziale (Ἥκτωρ Πριαμίδης) b) il principio complementare al primo dellrsquoeconomia (o del risparmio) corrisponde al fatto che per esprimere una medesima idea essenziale esiste generalmente nella dizione epica una e una sola espressione che occupi una determinata unitagrave minore del verso Casi come μελαινάων ἐπὶ νηῶν e ἐϋσσέλμων ἐπὶ νηῶν sono doppioni apparenti hanno sigrave la stessa misura metrica ma iniziano lrsquouno in consonante con la connessa possibilitagrave di evitare lo iato o di allungare la sillaba precedente lrsquoaltro in vocale Non mancano tuttavia vere eccezioni come per lrsquohemiepes iniziale νῆας ἐπ᾽ Ἀργείων di Iliade XXIV 298 rispetto al consueto νῆας ἐπὶ γλαφυράς (16 volte) Lrsquouso di formule e soprattutto di sistemi formulari rappresentava per il poeta epico una facilitazione nel comporre improvvisando ma nella lunga evoluzione dellrsquoepica e specialmente al momento della definitiva fissazione di poemi monumentali come lrsquoIliade e lrsquoOdissea la
Letteratura greca [1]
9
sempre piugrave estesa memorizzazione di ampie zone di testo il lavorio di riflessione sui singoli episodi e sui nessi e i parallelismi fra gli episodi stessi e la scoperta di inedite possibilitagrave espressive connesse alla modificazione di formule tradizionali dovettero incoraggiare i poeti a uno sfruttamento consapevole e artisticamente meditato del ldquogioco delle formulerdquo Da un lato procedimenti come lrsquoaddensamento degli epiteti la sostituzione di un epiteto convenzionale con uno non convenzionale (con la creazione di un nesso nuovo di struttura metrica eventualmente diversa) il trasferimento di un epiteto da un referente a un altro creano nei poemi una continua tensione tra formularitagrave e superamento della formularitagrave dallrsquoaltro la rete delle corrispondenze a distanza generata dalla ripetizione di un determinato modulo permette al poeta di variare e approfondire un motivo e di sottolineare i parallelismi o le dissonanze fra determinate situazioni La guerra di Troia Schliemann e la riscoperta di Troia In etagrave moderna la riscoperta della cittagrave di Troia situata sullrsquoodierna collina di Hissarlik e sovrastante la bassa pianura attraversata dallo Scamandro a sud del promontorio del Sigeo si lega agli scavi di Heinrich Schliemann (1822-1890) che a partire dal 1866 si dedicograve al disseppellimento delle rovine di Micene di Tirinto e di altri siti micenei e appunto di Troia Nel corso del tempo si egrave venuta creando attorno alla personalitagrave di questo archeologo dilettante una sorta di leggenda a cui egli stesso contribuigrave con le autobiografie Ilios (1881) e Troja (1884) nel senso di un dilettantismo romantico di scavi avventurosi condotti con sorprendenti successi ma senza alcun rigore di metodo di un amore cieco e totale per Omero e per lrsquoEllade E in effetti oggi sappiamo che lrsquoaver percorso la Grecia e lrsquoAsia minore sulle vie di Omero non impedigrave a Schliemann a Micene di attribuire allrsquoepoca di Agamennone tombe anche di quattro secoli piugrave antiche neacute a Troia di identificare con la cittagrave omerica uno strato risalente a una fase che va dal 2300 al 2100 aC Errori del genere non dipesero tuttavia da un entusiasmo velleitario quanto dalla carenza allrsquoepoca di competenze archeologiche che potessero orientarlo verso una piugrave plausibile cronologia di reperti e di strati Occorre poi tener conto che lo strato dei materiali riferibili alla Troia omerica (o almeno a quella che oggi noi identifichiamo con la cittagrave omerica Troia VIIa) era conservato unicamente nel suo margine esterno dato che gli strati superiori della collina di Hissarlik (con le fondamenta dei palazzi e dei templi) erano stati demoliti in epoca ellenistica per realizzare il terrazzamento del suolo su cui vennero edificati nuovi templi Fu soprattutto per questa ragione che Schliemann si spinse con le proprie maestranze a scavare sempre piugrave in profonditagrave saltando gli strati del secondo millennio Dove perograve il problema consisteva nellrsquoidentificazione di un sito sulla scorta della comparazione fra gli antichi racconti e il panorama attuale Schliemann conseguigrave notevoli successi in primo luogo identificando con la collina di Hissarlik quellrsquoacropoli omerica che lrsquoopinione comune dalla fine del XVIII secolo individuava invece nel villaggio di Bunarbaschi situato su un colle a 15 km dal promontorio del Sigeo e la disputa era stata viva giagrave nellrsquoantichitagrave Ellanico di Lesbo verso il 400 aC aveva sostenuto nei suoi Troica che la Ilio del suo tempo sorta presso la collina di Hissarlik e la Ilio omerica occupavano lo stesso sito invece Demetrio di Scepsi (fr 26 Gaede) si era pronunciato per una collina a circa 9 km a sud sullrsquoaltra riva dello Scamandro La missione americana guidata nel 1932-1938 da CW Blegen e le piugrave recenti indagini sul territorio hanno offerto un quadro molto piugrave articolato e differenziato Sulla base di un nuovo diagramma la cittagrave che sorgeva al momento in cui Eratostene di Cirene fissava la caduta di Troia (1184) viene a coincidere con Troia VIIa non piugrave con quella che Schliemann chiamava laquoterza cittagraveraquo (corrispondente a Troia II) ma nemmeno come voleva W Doumlrpfeld con Troia VI (andata in rovina verso il 1300 in seguito a un terremoto) Gli scavi piugrave recenti Secondo le conclusioni di Manfred Korfmann (cfr Korfmann 2002) che ha diretto lrsquoeacutequipe dellrsquoUniversitagrave di Tubinga negli scavi piugrave recenti lrsquoantica Troia intorno al 1184 cessograve di essere abitata ma lrsquoinsediamento continuograve nellrsquoarea della rocca per circa due secoli dopo la distruzione
Letteratura greca [1]
10
della cittagrave (Troia VIIb) Verso il 700 il luogo chiamato laquoIlioraquo era largamente in rovine anche se in etagrave arcaica dovette continuare a essere frequentato come luogo di culto Il problema che si dovettero porre nellrsquoVIII secolo aC lsquoOmerorsquo o i suoi modelli dovette essere quello di rendere il racconto della guerra di Troia plausibile a un pubblico che aveva familiaritagrave con la geografia locale (lrsquoIliade offre indicazioni realistiche ad es sulla navigazione dellrsquoEgeo in IX 362 s e sulla visibilitagrave dellrsquoisola di Samotracia dalla piana di Troia in XIII 11-14) che si trattasse di genti che risiedevano nel Sigeo o in altre cittagrave vicine o di abitanti della stessa Ilion che nellrsquoVIII secolo era di nuovo attiva sia pure soltanto come centro cultuale Il santuario sorgeva allrsquointerno di una depressione naturale a sud-ovest della rocca lungo la vecchia via che conduceva alla rocca stessa Omero menziona due templi quello di Apollo e quello di Atena e le loro loro rovine sono tuttora riconoscibili I visitatori che giungevano al santuario dal Sigeo attraverso la piana dello Scamandro potevano vedere le rovine della rocca Ma - ci si chiede - quando ebbe fine il nucleo della cittagrave di Troia cantata da Omero Nel bastione a nord-est della rocca egrave stata trovata una larga e profonda cisterna con un condotto che proviene da una sorgente La sorgente fu abbandonata al piugrave tardi al tempo di Troia VIIb2 prima del 1100 A partire dal 1000950 non rimase a Troia alcun insediamento significativo Troia era molto piugrave larga di quanto ritenesse Schliemann Un fossato largo 3 m e profondo 15 completato durante lrsquoultima fase di Troia VI o al principio di Troia VIIa (cioegrave intorno al 1300) la circondava Poi esso fu rimpiazzato a sud da un fossato piugrave ampio e concentrico al primo completato verso il 1200 Il sistema di fortificazione si estendeva per quasi 2 km e pertanto racchiudeva unrsquoarea di circa 270000 m2 La rocca e la cittagrave bassa dovevano presentarsi al tempo di Omero come un imponente complesso di rovine I nuovi colonizzatori del Sigeo e di altri siti incontrarono un vasto campo attraversato da sentieri che seguivano i vecchi tracciati Negli scavi fatti nei quartieri della cittagrave bassa a sud-ovest della rocca poco fuori del muro si egrave scoperto un deposito bruciato verso la fine di Troia VI e di nuovo verso la fine di Troia VIIa (verso il 1200) La prima devastazione egrave da ricollegarsi a un terremoto ma la seconda sembra dovuta a unrsquoazione di guerra come suggerisce anche il rinvenimento di corpi insepolti o semisepolti e di depositi contenenti armi non utilizzate Verso il 1300 la porta principale di Troia era stata bloccata e ostruita percheacute qui lrsquoantico muro era in condizioni precarie e pertanto rappresentava lrsquoanello piugrave vulnerabile nel sistema di difesa Giagrave W Doumlrpfeld aveva richiamato Iliade VI 433 s (Andromaca a Ettore)
Piazza lrsquoesercito presso il fico selvatico dove egrave piugrave facile Lrsquoaccesso alla cittagrave e il superamento delle mura
In questa zona solo poco piugrave di 80 m separavano il muro della cittagrave bassa dal muro della rocca Gli epiteti omerici di Troia - laquoben costruitaraquo laquofertileraquo laquovastaraquo laquosacraraquo laquoertaraquo laquoventosaraquo laquodalle belle muraraquo laquodai bel puledriraquo - si adattano ai dati topografici ossa di cavalli sono state trovate sul terreno forti venti soffiano continuamente in estate Anche le sorgenti sono identificabili presso la porta principale cfr Iliade XXII 145-157
Passarono oltre il posto di vedetta e lrsquoalbero di fico battuto dal vento e allontanandosi sempre piugrave dalle mura si lanciarono lungo la strada Giunsero alle fontane dalle belle acque dove sgorgano due correnti dello Scamandro impetuoso una di acqua calda da cui si leva un vapore come da fuoco ardente lrsquoaltra che in piena estate versa acqua gelata come la grandine la fredda neve o il ghiaccio Vi sono accanto dei lavatoi di pietra larghi belli dove le mogli e le belle figlie dei Teucri lavavano le splendide vesti prima in tempo di pace prima che giungessero i figli dei Danai
[Tr di MG Ciani] In effetti gli scavi nellrsquoarea della caverna in cui egrave situata la sorgente hanno portato alla luce una struttura simile a una miniera con tre gallerie e altri bracci tributari creata per fornire acqua Lrsquoacqua scorreva attraverso una superficie rocciosa e poi in un canale artificiale che a sua volta raggiungeva un sistema di quattro lsquodepressionirsquo o lsquofossersquo circolari scavate nella roccia della
Letteratura greca [1]
11
misura di quasi 1 m di diametro (appunto parrebbe i πλυνοί hellip λαΐνεοι i laquolavatoi di pietraraquo ricordati da Omero) Achei e Troiani Fra XIII e XII secolo aC Troia era un grande centro politico e commerciale in grado di controllare lrsquoaccesso ai Dardanelli (lrsquoantico Ellesponto) e il trasporto su terra di beni di vario genere dalla costa egea al Mar di Marmara (lrsquoantica Propontide) e al Mar Nero In Troia VIIa egrave stata rinvenuta ceramica micenea del periodo noto come Tardo Elladico IIIB che egrave anche il periodo di maggiore splendore dei palazzi micenei sul continente greco Ersquo suggestiva lrsquoidentificazione piugrave volte avanzata in tempi recenti di TroiaIlio con Wilusa la cittagrave menzionata spesso in testi hittiti e oggetto di contesa fra gli Hittiti e quegli Ahhiyawa il cui nome sembra identificarsi con quello degli laquoAcheiraquo (Ἀχαιοί) Il documento piugrave significativo in proposito egrave il preambolo del trattato stipulato verso il 1280 aC fra il re hittita Muwattali II e Alaksandu re di Wilusa che contiene un richiamo alle precedenti relazioni fra i due stati a partire dal 1600 pur ricordando che un tempo Wilusa era sotto il dominio hittita Muwatalli afferma di aver mantenuto relazioni pacifiche anche dopo che la cittagrave era divenuta indipendente Inoltre un testo religioso hittita rinvenuto a Hattusa la capitale dellrsquoimpero hittita e databile al XIII secolo ricorda nellrsquoambito di un rituale la recita di un poema in luvio (il luvio egrave una lingua indo-europea che si distingue solo superficialmente dallrsquohittita) di cui viene riportato il primo verso laquoQuando tornarono dallrsquoerta Wilusaraquo E a Troia negli scavi piugrave recenti egrave stato trovato un sigillo con unrsquoiscrizione in luvio Drsquoaltra parte in Omero la dinastia reale troiana di cui egrave a capo Priamo figlio di Laomedonte viene fatta risalire attraverso Erittonio Troo e Ilo fino a Dardano eponimo dei Dardani che si erano stanziati nella Troade a nord del monte Ida (Iliade ΧΧ 215 ss) I Dardani nellrsquoIliade compaiono fra i principali alleati dei Troiani accanto ai contingenti provenienti da Zelea (a nord-est lungo il fiume Esepo) e a quelli di localitagrave situate sulla Propontide come Adrestea e Pitea e sulla costa asiatica dellrsquoEllesponto come Abido e Arisbe Dalla costa europea arrivano invece i Traci i Ciconi e i Peoni da oriente i Paflagoni e gli Alizoni da sud-est i Misi e i Frigi dalla zona sud-occidentale dellrsquoAnatolia i Meoni i Cari e i Lici Se Dardani Peoni Ciconi e Traci fanno parte delle popolazioni traco-frigie che fra XII e XI secolo erano scese dai Balcani in direzione dellrsquoAnatolia (cfr Erodoto 7 73 e Xanto di Lidia FGrHist 765 F 14) i Meoni sono di stirpe lidia mentre i Cari e i Lici appartengono allrsquoambito culturale e linguistico luvio-hittita Comunque sia diversamente che per Erodoto il quale inserisce il rapimento di Elena nel quadro di una serie di torti reciproci in forma di rapimenti di donne fra Greci e barbari (I 2 1) e per i poeti tragici ateniesi del V secolo aC in Omero lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato come un contrasto fra culture diverse I Troiani mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei (detti anche laquoDanairaquo - cioegrave discendenti di Danao - o laquoArgiviraquo in relazione al contingente proveniente dallrsquoArgolide guidato da Agamennone il capo della spedizione) e lo stesso vale per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari in Iliade ΙΙ 867 come laquodi lingua stranieraraquo (βαρβαρόφωνοι) suggerisce che un tale epiteto non sarebbe stato applicabile ai Troiani Infine sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di unrsquoimbarcazione sono altrettanti esempi di quelle che W Arend denominograve laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini comportamentali e tecnologiche del gruppo che le condivide (vedi scheda p xxx) La societagrave omerica
Letteratura greca [1]
12
Nel rapporto fra il mondo omerico e la storia egrave innanzi tutto da sottolineare lrsquoesistenza di un duplice piano di riferimento con talune interferenze dellrsquouno nellrsquoaltro da un lato crsquoegrave lrsquoorizzonte dei fatti collocati in un passato glorioso dallrsquoaltro lrsquoorizzonte del poeta Giagrave gli studiosi alessandrini del resto notavano che dati come lrsquoarte di montare a cavallo i segnali per mezzo della tromba e lrsquouso di bollire la carne compaiono nellrsquoIliade solo allrsquointerno delle similitudini E il testo con una sorta di arcaismo intenzionale mostra talora la consapevolezza dellrsquoabisso che separa passato e presente come quando in Iliade XII 445-449 si dice
Ettore intanto un sasso afferrograve ndash e lo portava ndash che prima stava davanti alle porte largo di sotto ma sopra era a punta questo due uomini i piugrave forti del popolo difficilmente isserebbero da terra su un carro quali son ora i mortali egli da solo lo roteava a suo agio
[Tr di R Calzecchi Onesti] Per contro le condizioni sociali rappresentate nei poemi (un mondo di grandi proprietari terrieri che reggono aziende agricole autarchiche da cui hanno preso tuttavia a distaccarsi alcune figure di artigiani il fabbro il vasaio il carpentiere il medico lrsquoindovino lrsquoaedo) rispecchiano assai piugrave la situazione storica fra VIII e VII secolo a C che le strutture della societagrave micenea Inoltre i cadaveri vengono cremati secondo la prassi piugrave recente non inumati anche se molti riferimenti omerici non rispecchiano necessariamente la pratica normale del tempo di pace trattandosi di cremazioni che avvengono oltremare non ambigua egrave comunque la testimonianza relativa alla prassi umana in generale fornita da Odissea XI 216-222 (Anticlea a Odisseo)
Ohimegrave figlio mio il piugrave misero di tutti gli uomini Persefone la figlia di Zeus non ti inganna ma la legge degli uomini egrave questa quando si muore i nervi non reggono piugrave la carne e le ossa ma la furia violenta del fuoco ardente li disfa appena la vita abbandona le bianche ossa e lrsquoanima vagola volata via come un sogno
[Tr di GA Privitera]19 Un esempio significativo di sovrapposizione tra fasi culturali distinte si coglie osservando lrsquoinventario degli oggetti accanto ad armi vasi ornamenti tipici dellrsquoVIII-VII secolo troviamo relitti risalenti allrsquoepoca micenea come la coppa di Nestore ornata di colombe descritta in Iliade XI 632 ss (simile a una coppa drsquoargento rinvenuta a Micene che riproduce disegno e artigianato dellrsquoetagrave del bronzo) lrsquoelmo di cuoio con zanne di cinghiale che Merione dagrave a Odisseo (Iliade X 261 ss) e lo scudo lungo laquosimile a torreraquo di Aiace che egrave di un tipo inusitato dopo il XIII secolo Un oggetto non riferibile neacute al mondo miceneo neacute allrsquoetagrave della fissazione dei poemi bensigrave alla prima etagrave del ferro egrave invece la coppia di aste da lancio adottate verso il 900 aC e scomparse due secoli dopo con lo sviluppo del combattimento oplitico e la reintroduzione dellrsquoasta per colpire e la menzione delle navi fenicie (una volta nellrsquoIliade e cinque volte nellrsquoOdissea) riflette la loro comparsa nellrsquoEgeo nel IX secolo aC Non diversamente sembra avvenire anche per le istituzioni politiche lrsquo ἄναξ egrave visto a volte come figura di autocrate assoluto a volte fortemente limitato dai poteri delle assemblee ndash sia quella dei capi (βουλή) sia quella delle truppe (ἀγορή) ndash o insidiato dallrsquoascesa dei gruppi aristocratici mentre il βασιλεύς non egrave piugrave il dignitario della societagrave micenea ma genericamente un principe o un capo LʼIliade
19 Omero Odissea III intr testo e commento di A Hoekstra tr di GA Privitera Mondadori Milano 1984
Letteratura greca [1]
13
LrsquoIliade (Ἰλιάς) consta di circa 15690 esametri divisi secondo una partizione che potrebbe risalire al primo editore alessandrino (Zenodoto di Efeso) in 24 libri indicati con le lettere maiuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquounitagrave strutturale di parecchi canti che spesso finiscono col tramonto o iniziano con lrsquoalba e la coincidenza fra alcuni dei titoli attribuiti a ciascun canto nelle edizioni alessandrine e quelli che si rintracciano in autori precedenti (ad es Tucidide [I 10 4] cita il ldquoCatalogo delle navirdquo cioegrave il canto II) provano che non si trattograve di una divisione arbitraria bensigrave fondata almeno in certa misura sulle abitudini dei rapsodi Tema dellrsquoopera non egrave lrsquointero assedio decennale di Troia da parte dei Greci (di norma detti Achei o Danai o Argivi) provocato dal rapimento di Elena ad opera di Paride ma una porzione assai limitata del conflitto una sequenza narrativa che copre la durata di 51 giorni e si colloca verso la fine del nono anno di guerra lrsquoira di Achille contro lrsquoAtride Agamennone il suo ritiro dalla guerra e le relative conseguenze la fine dellrsquoira lrsquouccisione e i funerali di Ettore Fu proprio questa delimitazione tematica a consentire la realizzazione di quellrsquounitagrave e compiutezza dellrsquoazione che giagrave Aristotele individuava come uno dei pregi essenziali dellrsquoopera di Omero rispetto agli altri poemi epici arcaici (Poetica 1459a-b)20
anche in questo Omero deve apparire mirabile in confronto agli altri per non aver tentato di rappresentare intera la guerra anche se essa aveva un principio e una fine il racconto sarebbe risultato troppo grande e non abbracciabile con uno sguardo oppure pur misurato nella grandezza intricato per la varietagrave Ricavatane invece una parte ha fatto uso di molti episodi per esempio con il ldquoCatalogo delle navirdquo e con altri episodi fa procedere in lungo il poema Gli altri invece come lrsquoautore delle Ciprie o della Piccola Iliade compongono unrsquoazione multipla su unrsquounica persona o un unico tempo Di conseguenza mentre dallrsquoIliade e dallrsquoOdissea si ricava unrsquounica tragedia o soltanto due da ciascuna dalle Ciprie parecchie
[Tr di D Lanza]21
Canto I Lrsquoazione si apre sul campo degli Achei devastato dalle frecce scagliate da Apollo [T1] il dio ha scatenato una pestilenza percheacute Agamennone ha rifiutato il riscatto offerto dal sacerdote Crise per la liberazione della figlia Criseide divenuta schiava dellrsquoAtride Ai guerrieri convocati in assemblea lrsquoindovino Calcante rivela che la sola via di scampo egrave la restituzione di Criseide al padre Agamennone acconsente ma solo a patto che gli venga data in cambio Briseide la schiava che Achille tiene nella sua tenda come premio personale (γέρας) ricevuto dagli altri guerrieri Achille non puograve opporsi alla prevaricazione dellrsquoAtride ma non egrave disposto a subire passivamente lrsquooltraggio e insulta Agamennone anzi egrave giagrave pronto a estrarre la spada dal fodero per farsi giustizia quando viene trattenuto da Atena apparsa allrsquoimprovviso allora si ritira nella tenda giurando che non combatteragrave piugrave [T2] Quindi invoca la madre Tetide che dopo essere apparsa al figlio sulla riva del mare intercede presso Zeus e ottiene la promessa che i Greci non vinceranno la guerra e non espugneranno Troia fincheacute Achille non riceveragrave soddisfazione per lrsquooffesa subita Ma il piano di Zeus non resta celato ad Era che ingelosita provoca una lite nel corso del banchetto degli dei tuttavia la visione di Efesto zoppicante che funge da coppiere suscita lrsquoilaritagrave dei numi e riporta la serenitagrave Canto II Quella stessa notte Zeus manda ad Agamennone un sogno ingannatore per incitarlo ad attaccare Troia LrsquoAtride riferisce il sogno agli anziani e comanda lrsquoadunata dellrsquoesercito
20 Cfr anche 1462b ταῦτα τὰ ποιήματα συνέστηκεν ὡς ἐνδέχεται ἄριστα καὶ ὅτι μάλιστα μιᾶς πράξεως μίμησις (laquoQuesti poemi sono composti come meglio non si puograve e son il piugrave possibile imitazione di unrsquounica azioneraquo) 21 Aristotele Poetica Milano Rizzoli 19902
Letteratura greca [1]
14
con lrsquoidea stravagante di saggiare lrsquoumore delle truppe proponendo il ritorno in patria Gli uomini incitati da Tersite corrono alle navi pronti a salpare ma vengono bloccati da Odisseo e da Nestore Egrave significativo che Tersite lrsquoanti-eroe riecheggi le accuse di Achille ad Agamennone sottolineando gli onori di cui questi gode e prenda le parti di Achille [T3] Per tutta la seconda parte del libro lrsquoazione viene interrotta per far posto alla grandiosa uscita in armi dellrsquoesercito acheo dal recinto delle navi un quadro scintillante ornato da una catena di sei similitudini concatenate introdotte per illustrare il fulgore delle armi il rombo dei passi umani e degli zoccoli precipitosi lrsquoaspetto della schiera achea e la maestria dei condottieri Un ldquoCatalogo delle navirdquo contiene lrsquoelenco circostanziato delle genti greche che hanno preso parte allrsquoassedio ed egrave seguito da un catalogo piugrave breve e piugrave arido degli alleati dei Troiani accorsi in difesa di Ilio Canto III Lrsquoatteso scontro tra gli schieramenti appena passati in rassegna non ha luogo ParideAlessandro ottiene infatti una tregua per sfidare Menelao Iride la messaggera degli degravei spinge Elena ad accorrere alle mura presso le porte Scee per assistere al preannunciato duello di ligrave Priamo e gli altri anziani di Troia osservano la pianura Su richiesta del vecchio sovrano (una richiesta che sarebbe stata piugrave ldquoverosimilerdquo al primo anno di guerra) Elena nomina i piugrave prestigiosi campioni achei [T4] Nel duello che segue Paride si trova ben presto a mal partito contro Menelao ma Afrodite lo sottrae ai colpi del nemico avvolgendolo in una fitta nebbia e lo riporta nelle sue stanze dove dopo aver assunto lrsquoaspetto di una vecchia filatrice ordina a Elena di giacere con lui Elena si ribella ma la dea non transige Mentre Paride ed Elena si uniscono nellrsquoamplesso Menelao furibondo cerca fra la folla il nemico che sia i Greci che i Troiani sarebbero lieti di consegnargli pur di porre fine alla guerra Agamennone rivendicando la vittoria di Menelao pretende dai Troiani la restituzione di Elena e delle sue ricchezze noncheacute il pagamento di una forte ammenda Canto IV La tregua stipulata dopo la scomparsa di Paride viene infranta dallrsquoarciere Pandaro che sollecitato da Atena (scesa tra le schiere troiane su ordine di Zeus) ferisce con una freccia Menelao questi viene prontamente guarito dal medico Macaone figlio di Asclepio Agamennone passa fra le schiere incitandole a combattere incontra vari capi intenti a dare istruzioni ai propri uomini Solo Ulisse e Menesteo si tengono in disparte ricevendo i rimproveri di Agamennone ai quali Ulisse reagisce con indignazione Gli Achei muovono contro i Troiani con grande ordine e disciplina mentre i Troiani e i loro alleati schiamazzano come barbari Ha inizio la battaglia vera e propria nella quale lrsquoattenzione egrave focalizzata sui duelli individuali Ad assistere e rincuorare i Troiani compare Apollo sulla rocca di Troia mentre Atena infonde coraggio nei Greci Il canto si chiude sullrsquoinfuriare della battaglia la cui descrizione riprenderagrave nel canto successivo Canto V Balza in primo piano Diomede di cui viene presentata lrsquoἀριστεία lrsquoeroe laquoglorioso e chiaroraquo fa strage di nemici imperversando furiosamente fra le schiere troiane Nel pieno del combattimento viene ferito da una freccia scagliata da Pandaro il quale mena gran vanto del colpo andato a segno Diomede ottenuta unrsquoimmediata guarigione grazie allrsquointervento di Atena muove allora contro il nemico che nel frattempo era stato accolto sul carro di Enea Pandaro scaglia la sua lancia contro Diomede ma lo scudo di questi regge il colpo Diomede colpisce a sua volta uccidendo il nemico Enea scende dal cocchio per proteggere il cadavere di Pandaro dagli Achei che vorrebbero farne razzia ma Diomede lo colpisce con un grande masso fratturandogli il femore Enea viene salvato dallrsquointervento di Afrodite che lo avvolge nel suo manto mentre Diomede arriva addirittura a ferire al polso la dea che fugge sullrsquoOlimpo a farsi confortare dalla madre Dione Il figlio di Tideo attacca anche Apollo che aveva sottratto Enea alla sua furia ma
Letteratura greca [1]
15
egrave fermato dal grido di ammonimento del dio Incitati e aiutati da Ares ora i Troiani avanzano con impeto Intervengono Era e Atena e questrsquoultima assume il ruolo di auriga di Diomede Col suo aiuto questi ferisce al ventre Ares che fugge sullrsquoOlimpo Anche le dee vi fanno ritorno Canto VI Il canto VI egrave una naturale continuazione del V (tanto che Erodoto citeragrave come dallrsquoἀριστεία di Diomede un brano della prima parte del VI canto) La battaglia infuria nella pianura ma il furore di Diomede si stempera su una nota di cortesia quando lrsquoeroe dopo aver sfidato Glauco di Licia scopre di avere con lrsquoavversario antichi rapporti di ospitalitagrave I due si scambiano le armature (a detrimento di Glauco a cui laquoZeus Cronide levograve il senno cheacute scambiograve con Diomede Tidide armi drsquooro con armi di bronzo cento buoi con nove buoiraquo [vv 234-6]) Frattanto Ettore su invito dellrsquoindovino Eleno rientra in cittagrave dove le donne devono cercare di ottenere con offerte e voti il favore di Atena e incontra dapprima la madre Ecuba poi Paride (che intende ricondurre alla battaglia) vorrebbe salutare anche la moglie ma non la trova in casa bensigrave alle porte Scee dove Andromaca era accorsa piena drsquoangoscia insieme col figlioletto e con la nutrice Nel colloquio che segue ella lo implora di non esporre al pericolo se stessa e il figlio La replica di Ettore egrave esemplare per capire la prospettiva del poema e le motivazioni dellrsquoagire dei personaggi dominanti se Achille e gli eroi achei in genere cercano onore e gloria a questa motivazione (che pure non egrave assente) Ettore antepone lrsquoαἰδώς il senso di laquovergognaraquo e di responsabilitagrave nei confronti della comunitagrave e del nucleo familiare di cui egrave il difensore Poi si volta per prendere tra le braccia Astianatte ma lrsquoelmo lucente e il cimiero ondeggiante impauriscono il piccolo che si rifugia in seno alla nutrice Alla fine del canto Paride si incontra con Ettore e i due si avviano verso il campo di battaglia [T5] Canto VII A principio del canto VII Atena e Apollo si accordano per indurre Ettore a lanciare una sfida agli Achei per un duello Il sorteggio designa Aiace come campione greco Nello scontro Ettore lancia per primo lrsquoasta che penetra ma senza trapassarlo nello scudo di Aiace greve e massiccio (compaginato con sette strati di pelle bovina simile a una torre) Aiace di rimando lacera lo scudo e il pettorale della corazza ma non riesce a squarciare le carni del nemico percheacute Ettore si piega di lato Allora i due brandiscono di nuovo le aste poi ricorrono alle pietre Alla fine gli araldi arrestano il combattimento con la giustificazione che laquola notte giagrave viene ed egrave bene obbedire alla notteraquo (v 282) Su proposta di Nestore gli Achei decidono per il giorno seguente di seppellire i morti e di scavare una grande trincea difesa da un bastione sul margine del loro accampamento Respingono lrsquoofferta di pace dei Troiani (che prevederebbe la riconsegna dei tesori sottratti da Paride a Sparta) Il mattino seguente i morti vengono cremati e durante la giornata si erige il muro di protezione Canto VIII Nellrsquoassemblea degli degravei Zeus vieta ai numi di appoggiare lrsquouna o lrsquoaltra parte in conflitto Al mattino il combattimento riprende e a mezzogiorno Zeus pone i destini dei due popoli sulla bilancia che piega a favore dei Troiani Sul campo di battaglia Diomede salva Nestore Lrsquoazione di Ettore egrave travolgente fincheacute Zeus contravvenendo alla sua intenzione di favorire i Troiani accoglie la preghiera di Agamennone per risollevare il morale degli Achei che organizzano la difesa delle navi Nel corso degli scontri si segnala lrsquoarciere Teucro che colpisce i nemici muovendosi in sincronia con Aiace Telamonio che lo protegge con lo scudo Incitato da Agamennone egli prova a colpire anche Ettore ma soccombe colpito con una pietra A questa vista Era e Atena corrono ad armarsi per intervenire a favore degli Achei ma vengono distolte dalle minacce di Zeus che manifesta la propria intenzione di favorire i Troiani fino a quando i Greci non saranno ridotti alla disperazione tanto da scongiurare Achille percheacute ritorni Il sopraggiungere della notte
Letteratura greca [1]
16
interrompe i combattimenti Ettore galvanizzato dai successi ottenuti in quel giorno si illude che la vittoria sia a portata di mano e prospetta ai suoi una prossima ritirata degli Achei Il canto si chiude con il banchetto dei Troiani che banchettano nella pianura esaltati dalla speranza di vittoria Canto IX Agamennone affranto propone di fare ciograve che nel canto II aveva suggerito soltanto per mettere alla prova lrsquoesercito interrompere la guerra e tornare in patria Diomede si oppone e Nestore in un consiglio dei capi propone di tentare la riconciliazione con Achille Si invia alla tenda di Achille unrsquoambasceria (composta da Aiace Odisseo e Fenice antico pedagogo di Achille) per offrire doni ricchissimi Achille non cede anzi minaccia di salpare immediatamente verso la patria [T6] Inutilmente Fenice lrsquoantico precettore di Achille cerca di ammorbidire la determinazione del Pelide richiamando la vicenda dellrsquoeroe Meleagro [T7] Gli inviati riferiscono ad Agamennone la risposta di Achille egli torneragrave a combattere solo quando Ettore saragrave arrivato fino alle navi dei Mirmidoni Canto X Nella stessa notte si effettua una missione segreta nel corso della quale Odisseo e Diomede dapprima catturano la spia troiana Dolone (che Ettore aveva inviato alle navi achee promettendogli come ricompensa i cavalli di Achille) poi uccidono il re trace Reso appena arrivato presso i Troiani e ne rubano i magnifici cavalli Giagrave gli antichi ritenevano questo canto unrsquoaggiunta post-omerica e questi dubbi trovano riscontro in lati eccentrici della narrazione e nellrsquoimpiego di un linguaggio che spesso appare svincolato dal corrente repertorio formulare Canto XI Si apre una nuova giornata di battaglia (la cui narrazione si protrarragrave fino al canto XVIII) che ruota intorno allrsquoἀριστεία di Agamennone Quando lrsquoAtride viene ferito gli Achei ripiegano Diomede resta anchrsquoegli ferito Odisseo e Aiace evitano a stento la massa dei nemici Nestore salva sul suo carro Macaone Achille che dalla poppa della nave osserva la battaglia vuol sapere chi egrave condotto via da Nestore e manda Patroclo che viene accolto molto benevolmente e con cui Nestore intrattiene un lungo discorso egli dice di deplorare il comportamento di Achille e con atteggiamento consono alla sua condizione di anziano si dilunga nel raccontare le proprie gesta giovanili Egli esorta quindi Patroclo a far leva sulla sua amicizia per convincere Achille a riprendere il combattimento o - almeno - a concedere a Patroclo le sue armi per incutere timore nei Troiani Eccitato dalle parole del vecchio Patroclo si avvia verso la nave di Achille ma incontra Euripilo ferito che gli chiede aiuto ed egli impietositosi lo accompagna alla tenda e cura la ferita Canto XII Divisi in cinque contingenti i Troiani danno lrsquoassalto al muro eretto a difesa del campo acheo Sul campo di battaglia si manifesta un prodigio unrsquoaquila in cielo con un grosso serpente fra le zampe che riesce a ferire lrsquouccello e a sfuggire Polidamante che interpreta il segno come un presagio funesto consiglia di tornare indietro ma Ettore egrave di altro avviso Sarpedone e Glauco sferrano un attacco contro il muro e - pur rimanendo feriti - riescono ad aprire una breccia La battaglia infuria con esito incerto fincheacute Ettore con un macigno sfonda una delle porte consentendo ai Troiani di entrare in massa nel campo acheo mentre i Greci fuggono verso il mare Canto XIII Zeus distoglie lo sguardo dalla battaglia nella convinzione che nessuno fra gli dei avrebbe osato violare il divieto di intervenire ne approfitta invece Poseidone favorevole ai Greci Assunto lrsquoaspetto dellrsquoindovino Calcante il dio infonde nuovo vigore nei due Aiaci
Letteratura greca [1]
17
spronandoli al combattimento Gli Achei riconoscono lrsquointervento divino e riprendono fiducia I combattimenti si susseguono violentissimi Nella resistenza si distingue il re cretese Idomeneo Polidamante consiglia una seconda volta di interrompere la battaglia e accenna allrsquoimminente intervento di Achille Ettore non ascolta lrsquoammonimento e riprende lrsquoassalto Il canto si chiude con un suo scambio di insulti con Aiace Telamonio Canto XIV Mentre Diomede Odisseo e Agamennone tornano feriti allrsquoaccampamento Era per distogliere Zeus dalla battaglia e consentire a Poseidone di favorire gli Achei indossa la cintura magica di Afrodite e sollecita il consorte a un convegno amoroso sullrsquoIda dopo lrsquoamplesso Zeus cade in un sonno profondo e Hypnos (il Sonno) annuncia a Posidone che potragrave aiutare senza rischi gli Achei Ettore colpito con una pietra da Aiace resta a lungo in stato di incoscienza e i Troiani vengono respinti Canto XV Zeus si risveglia avvedendosi dellrsquoinganno subito e costringe Era a mandargli Iride e Apollo la prima allontaneragrave Posidone dal campo di battaglia Apollo inciteragrave Ettore a far retrocedere gli Achei fino alle navi dei Mirmidoni Riprende lrsquooffensiva troiana Apollo stesso abbatte il muro e scuotendo lrsquoegida atterrisce gli Achei Patroclo corre da Achille mentre i Troiani giagrave sono sul punto di appiccare il fuoco alle navi Canto XVI Patroclo in lacrime supplica Achille di intervenire o di mandare lui stesso al suo posto [T8] Achille gli consegna le proprie armi e gli fa promettere che non si avventureragrave oltre la zona delle navi Ma Patroclo trascinato dal suo stesso impeto oltrepassa il limite prescrittogli da Achille Abbatte Sarpedone figlio di Zeus attorno al cui cadavere infuria la lotta fincheacute Apollo lo sottrae alla mischia e Hypnos e Thanatos (il demone della morte) lo trasportano in Licia sua patria Patroclo continua lrsquoassalto alla testa dei Mirmidoni fin sotto le mura di Troia ma poco prima del tramonto al quarto assalto Apollo stesso assunto lrsquoaspetto di Asio lo percuote fra le spalle allora Euforbo lo colpisce con lrsquoasta ed Ettore lo trafigge Canto XVII Euforbo viene ucciso da Menelao ma Ettore riesce a catturare le armi di Achille indossate da Patroclo Vigorosamente sostenuti da Aiace gli Achei difendono il cadavere Una densa nebbia scende sui combattenti Zeus infonde nuovo ardimento nei cavalli di Achille piangenti per la fine di Patroclo [T9] Atena e Apollo arroventano la lotta attorno alla salma In seguito alla preghiera di Aiace Zeus dissolve la nebbia Menelao manda Antiloco figlio di Nestore a informare Achille della morte di Patroclo la cui salma viene intanto trascinata fuori della battaglia da Menelao e Merione mentre i due Aiaci offrono la necessaria copertura contro la furia incalzante dei nemici Canto XVIII Lo scoppio di selvaggio dolore a cui si abbandona Achille allrsquoudire della morte di Patroclo provoca lrsquoaccorrere dal mare di Tetide insieme con le Nereidi La madre gli promette di procurargli nuove armi Poicheacute la salma di Patroclo egrave tuttora contesa Achille fa la sua apparizione sul fossato e lancia un grido che atterrisce i nemici Efesto su preghiera di Tetide foggia le nuove armi fra cui un magnifico scudo su cui appaiono effigiati in bande concentriche gli aspetti salienti dellrsquoesistenza umana Canto XIX Il mattino seguente Tetide porta le armi al figlio e con lrsquoambrosia preserva la salma di Patroclo dalla decomposizione Achille convoca unrsquoassemblea dellrsquoesercito e rinuncia alla sua collera Agamennone lamenta di essere stato ldquoaccecatordquo da Zeus e promette doni
Letteratura greca [1]
18
riparatori [T10] Achille si lascia convincere a stento ad attendere che i soldati abbiano mangiato Poi gli armati si radunano e anche Achille si arma Il suo cavallo Xanto gli predice la prossima morte [T11] Canto XX Zeus consente agli degravei di partecipare alla nuova battaglia Enea scontratosi con Achille egrave tratto in salvo da Posidone Achille infuria come un incendio in una selva Canto XXI Achille colma di cadaveri il fiume Scamandro e cattura dodici giovani troiani che intende offrire in sacrificio a Patroclo non risparmia neppure Licaone figlio di Priamo che lo supplica con accenti di grande intensitagrave ma altrettanto intensa nella consapevolezza di un destino imminente egrave la pur spietata replica del Pelide [T12] Lo Scamandro solleva le proprie onde ma le fiamme di Efesto inaridiscono il terreno e domano la corrente Gli degravei si azzuffano Atena raggiunge Ares con una pietra Era rintuzza la furia di Artemide Infine tutti tornano sullrsquoOlimpo Apollo assunto lrsquoaspetto di Agenore respinge Achille percheacute i Troiani possano rifugiarsi allrsquointerno delle mura Canto XXII Il solo Ettore resta fuori nella pianura Invano Priamo ed Ecuba lo pregano di rientrare Mentre Achille si avvicina Ettore decide di affrontarlo ma quando quello gli egrave da presso col bronzo che gli lampeggia intorno laquosimile al raggio del fuoco ardente o del sole che sorgeraquo egrave afferrato dal panico e comincia a fuggire compiendo tre giri intorno alle mura Zeus pesa sulla bilancia i destini (le κῆρες) dei due eroi e quello di Ettore affonda in basso Allora Apollo lo abbandona e Atena apparsa a Ettore sotto le spoglie di suo fratello Deifobo gli si avvicina promettendogli aiuto e invece riporta ad Achille la lancia che gli era caduta fuori bersaglio Il colpo di risposta di Ettore rimbalza sullo scudo di Achille Ettore urla a Deifobo di passargli la sua lancia ma il falso Deifobo egrave scomparso ed Ettore comprende di trovarsi sullrsquoorlo dellrsquoabisso [T13] Achille gli trapassa la gola ed Ettore lo supplica di non oltraggiare la sua salma in risposta riceve la minaccia che finiragrave in pasto ai cani Achille trascina il cadavere alle navi attaccato al carro Priamo Ecuba e Andromaca si abbandonano al cordoglio a cui fanno eco le donne troiane Canto XXIII Viene preparato il banchetto funebre in onore di Patroclo la cui ombra nel corso della notte appare ad Achille chiedendo la sepoltura del corpo Il mattino seguente si appresta il rogo fra le offerte votive ci sono anche dodici giovani troiani Il giorno successivo si raccolgono le ossa di Patroclo Seguono i ludi funebri gare coi carri e con lrsquoarco duello in armi etc Canto XXIV Ogni giorno Achille trascina il cadavere di Ettore attorno alla tomba dellrsquoamico ma lo spettacolo offende gli degravei e al dodicesimo giorno Zeus decide di mandare Tetide percheacute induca suo figlio a restituire la salma di Ettore Iride viene inviata presso Priamo percheacute gli consigli di recarsi nel cuore della notte con un carro da trasporto e un copioso riscatto scortato da Ermes alla tenda di Achille Questi accoglie il vecchio con rispetto riconoscendo in lui lrsquoimmagine del padre lontano e si piega alla sua supplica [T14] Per volontagrave degli degravei il cadavere non egrave stato aggredito dalla putrefazione composto sul pianale del carro viene ricondotto dal padre a Troia Qui le lamentazioni rituali srsquoinnalzano dal gruppo delle donne (Andromaca Ecuba Elena) Si stipula una tregua di dodici giorni Per nove giorni i Troiani raccolgono legname poi anche il rogo di Ettore arde e si erige un tumulo
Letteratura greca [1]
19
Struttura e caratteri dellʼopera Poema di trama relativamente organica (soprattutto a partire dal canto XVI tutti gli avvenimenti tranne pochi episodi isolati ruotano attorno ai due principali antagonisti Ettore uccide Patroclo per vendicare Sarpedone e Achille uccide Ettore per vendicare Patroclo) pur se non privo di piugrave o meno cospicue incongruenze spiegabili in primo luogo con la lunga e complessa genesi orale dellrsquoopera lrsquoIliade lascia emergere in mezzo alle centinaia di nomi e alle intricate vicende alcuni caratteri delineati nella loro individualitagrave e innanzi tutto quelli di Achille e di Ettore accomunati dalla medesima coscienza di un destino di morte che sono pronti ad affrontare Appunto una tale attitudine a rappresentare i laquocaratteriraquo (ἤθη) dei suoi personaggi egrave un altro titolo di merito che Aristotele ascrive ad Omero (Poetica 1460a9-11)
dopo aver brevemente proemiato subito introduce un uomo una donna o un altro personaggio nessuno privo di caratterizzazione ma dotato di un carattere
Fondamentale per la struttura del poema egrave la novitagrave della prospettiva Possiamo presumere che i cosiddetti poemi ciclici22 mirassero a conservare lrsquoangolatura che era stata propria delle versioni pre-omeriche della saga troiana sigrave che puograve riuscire significativo il confronto fra lrsquoesordio della Piccola Iliade (dove muovendo da grandi entitagrave ndash la cittagrave il paese due popoli la guerra ndash viene lanciato secondo lrsquoespressione di J Latacz come laquouno sguardo dallrsquoesternoraquo)
Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην εὔπωλον ἧς πέρι πολλὰ πάθον Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος Canto Ilio e la terra dei Dardani dai bei puledri per la quale molti dolori patirono i Danai servitori di Ares
con lo laquosguardo internoraquo che caratterizza lrsquoinizio dellrsquoIliade
Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν ἡρώων αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν οἰωνοῖσί τε δαῖτα Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς Canta o dea di Achille figlio di Peleo la collera maledetta che pene innumerevoli inflisse agli Achei e molte scagliograve allrsquoAde vite possenti di eroi e ne faceva prede per i cani e pasto per gli uccelli e si avverava il volere di Zeus da quando primamente si separarono venuti a contesa LrsquoAtride sovrano di eroi e Achille magnifico
Argomento non egrave dunque come doveva avvenire nella tradizione del canto epico un evento complesso da inquadrare con un grandangolo onnicomprensivo e neppure come saragrave nellrsquoOdissea un personaggio colto nella multiforme varietagrave delle sue peregrinazioni egrave invece una reazione emotiva (lrsquoira di Achille) con le sue conseguenze (le innumerevoli morti degli Achei) Narrare di questa ira significa per il poeta cominciare da un punto preciso (laquoda quandoraquo) ossia dal momento della contesa e della separazione fra i due massimi eroi greci Agamennone il primo per potere (laquosovrano di eroiraquo) e Achille il primo per nobiltagrave e forza (δῖος) E sintomatica della bipolaritagrave del mondo epico in quanto mondo di degravei e di eroi egrave la sincronia per cui il taglio della narrazione coincide col decorso del laquovolere di Zeusraquo (Διὸς βουλή) forse da identificare con la promessa del dio a Tetide (rievocata piugrave oltre in questo
22 V cap II laquoLa tradizione omericaraquo
Letteratura greca [1]
20
stesso canto ai vv 518-527) di vendicare lrsquoaffronto subito da Achille o piugrave in generale con il corso degli eventi in quanto tutto come per definizione laquogiace sulle ginocchia di Zeusraquo Opera indubbiamente allrsquointerno del poema unrsquoidea formativa un progetto di qui un insieme monumentale unificato anche da una serie di corrispondenze a distanza fra cui particolare significato acquistano quelle fra primo e ultimo canto Nel canto I il vecchio Crise va come supplice presso Agamennone portando doni e supplicando la restituzione della figlia e Agamennone lo respinge aspramente minacciandolo di far ricorso alla violenza se dovesse tornare nel canto XXIV il vecchio Priamo va come supplice presso Achille portando doni e supplicando la restituzione del corpo del figlio Achille ha una prima reazione irosa (esordisce al v 560 con laquoSmetti di irritarmi vecchioraquo) ma poi accoglie la supplica E al di lagrave delle corrispondenze nelle linee dellrsquoazione si colgono fra principio e fine del poema alcuni importanti echi verbali in particolare fra XXIV 501 s
τοῦ νῦν εἵνεχ᾽ ἱκάνω νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενος παρὰ σεῖο φέρω δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα per lui [Ettore] vengo ora alle navi degli Achei per riscattarlo da te e ti porto compenso infinito
e I 12 s
ὁ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενός τε θυγάτρα φέρων δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα costui [Crise] venne alle navi rapide degli Achei per riscattare la figlia portando compenso infinito
fra XXIV 555-557
λῦσον ἵν᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδωmiddot σὺ δὲ δέξαι ἄποινα πολλά τά τοι φέρομενmiddot σὺ δὲ τῶνδrsquo ἀπόναιο καὶ ἔλθοις σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν restituiscimelo percheacute lo possa vedere con gli occhi e accogli il riscatto copioso che portiamo e tu possa goderne e tornare alla tua terra patria
e I 18-20
Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν εὖ δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκέσθαιmiddot παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην τὰ δ᾽ ἄποινα δέχεσθαι Atridi e voi altri Achei dai forti schinieri a voi concedano gli degravei che hanno le case in Olimpo di distruggere la cittagrave di Priamo e tornare facilmente in patria ma restituitemi la figlia e accettate il riscatto
fra XXIV 560 μηκέτι νῦν μ᾽ ἐρέθιζε (laquosmetti di irritarmiraquo) e I 32 μή μ᾽ ἐρέθιζε (laquonon mi irritareraquo) fra XXIV 568-570
τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς μή σε γέρον οὐδrsquo αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω καὶ ἱκέτην περ ἐόντα Διὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμάς Ora perciograve fra i dolori non mi eccitare lrsquoanimo ancora di piugrave bada o vecchio che non ti lasci neppure nella tenda
Letteratura greca [1]
21
bencheacute supplice e violi gli ordini di Zeus e I 26-28
μή σε γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω ἢ νῦν δηθύνοντ᾽ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο Mai te o vecchio io colga presso le concave navi ora a indugiare o piugrave tardi a tornare che piugrave non dovesse giovarti lo scettro e la benda del dio
(e infine XXIV 571 ὣς ἔφατ ἔδεισεν δ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ laquocosigrave diceva e il vecchio tremograve e obbediva alle paroleraquo ripete esattamente I 33) In effetti lrsquoepisodio terminale del poema col superamento dellrsquoira ad opera della pietagrave e del senso di unrsquoesistenza invasa dal dolore si propone come il rovesciamento consapevole dellrsquoepisodio iniziale che era apparso caratterizzato dalla cancellazione della pietagrave e del diritto dei supplici in nome della forza Al rifiuto iniziale del donoriscatto si oppone lrsquoaccettazione finale in consonanza con un principio-guida che opera nel poema secondo linee che alla fine si riunificano Agamennone restituisce Criseide al padre ma si appropria del dono fatto dagli altri Achei ad Achille (Briseide) Achille respinge i doni fatti da Agamennone per indurlo a riconciliarsi con lui ma dopo aver contestato nel IX canto la nozione che la vita umana possa essere barattata con una massa di beni torna alla lotta non in cambio di qualche premio da conquistare ma per vendicare lrsquouccisione dellrsquoamico Patroclo e tanto nella lotta sul campo di battaglia quanto nellrsquoinfierire sul cadavere di Ettore si abbandona a un furore cosigrave smisurato e patologico che puograve essere superato solo con lrsquoaccettare i doni di Priamo non tuttavia per il loro valore drsquouso ma percheacute in Priamo Achille riconosce lrsquoombra del padre lontano Cosigrave lrsquoIliade appare attraversata da un impulso fondamentale che muove dallrsquoideologia del dono e dalla conseguente centralitagrave assegnata allrsquoonore (τιμή) come ldquoprezzordquo che qualifica il valore del guerriero ma supera questo piano di valutazione dei rapporti umani attraverso la loro riformulazione nei termini di un umanesimo esistenziale che ha come punti di riferimento lrsquoidentitagrave universale dei condizionamenti oggettivi (la vecchiaia la malattia la morte) e i legami che uniscono padre e figlio compagno e compagno vivi e morti (il cordoglio finale di Andromaca Ecuba ed Elena sulla salma di Ettore) Entro questo orizzonte progressivamente allargato la guerra le lotte lo scontro mortale finiscono col rappresentare solo un momento e un aspetto dellrsquoesistenza graditi tanto agli degravei che vi assistono come spettatori interessati quanto agli uditori che riascoltano le antiche gesta eppure non tali da appiattire il poema in una prospettiva guerresca conclusa in se stessa Molto del fascino delle battaglie e delle ἀριστεῖαι dellrsquoIliade sta nella presenza recondita di un occhio che sa guardare al di lagrave di esse (e al di lagrave della stessa distinzione fra Greci e Troiani vincitori e vinti) e che puograve anche attraverso le similitudini lasciare irrompere il mondo della natura o del lavoro umano nel mezzo delle battaglie LʼOdissea LrsquoOdissea (Ὀδύσσεια) consta di circa 12100 esametri divisi anchrsquoessi in 24 libri e indicati con le lettere minuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquoargomento egrave costituito dalle avventure di Odisseo dalla distruzione di Troia al ritorno alla patria Itaca esposte secondo un ordine che entrando subito nel vivo degli avvenimenti (lrsquoinizio del poema mostra Odisseo nellrsquoisola di Calipso) rievoca poi i fatti giagrave trascorsi e li ricongiunge infine a partire dal libro XV (con lrsquoarrivo di Telemaco alla capanna di Eumeo dove giagrave si trova Odisseo) in unrsquoazione unitaria La trama del poema i cui avvenimenti sono concentrati cronologicamente nello spazio di 40 giorni (ma sono narrati solo gli avvenimenti di 16 giorni e 8 notti) si articola in tre parti la laquoTelemachiaraquo (canti I-IV) il laquoRitorno di Odisseoraquo (canti V-XIII) e la laquoVendetta di Odisseoraquo (canti XIV-XXIV)
Letteratura greca [1]
22
Canto I Tutti gli eroi superstiti sono ormai tornati da Troia alle loro case tranne Odisseo che pur desideroso di tornare egrave trattenuto dalla ninfa Calipso nellrsquoisola di Ogigia Gli degravei hanno pietagrave di lui tranne Posidone irato per lrsquoaccecamento del figlio il ciclope Polifemo Ma un consiglio degli degravei assente Posidone (che si egrave recato presso gli Etiopi) delibera il ritorno dellrsquoeroe si decide che Ermes andragrave subito da Calipso mentre Atena si avvia verso Itaca sotto lrsquoaspetto del signore dei Tafi Mente per incoraggiare il figlio di Odisseo Telemaco a tener testa ai pretendenti della madre i laquoprociraquo (i quali aspirano al regno tramite le nozze con Penelope) e per indurlo a intraprendere un viaggio in cerca di notizie sul padre Canto IΙ Telemaco segue il consiglio della dea e il giorno seguente nellrsquoassemblea popolare chiede una nave per andare in cerca del padre ma la sua richiesta non viene discussa e Leocrito scioglie lrsquoassemblea Grazie ad Atena che ora ha assunto le sembianze di Mentore (antico amico di Odisseo) Telemaco riesce tuttavia a trovare una nave con cui salpa nel corso della notte allrsquoinsaputa sia della madre che dei proci Canto IΙΙ Telemaco e MentoreAtena arrivano a Pilo e sul lido trovano Nestore che sta offrendo un sacrificio a Posidone Il vecchio eroe accoglie ospitalmente Telemaco e gli comunica molte notizie sul ritorno di altri Achei ma nessuna su Odisseo Alla sera Atena scompare in forma di aquila e il mattino seguente Telemaco salpa insieme con Pisistrato (figlio di Nestore) alla volta di Sparta dove arriva la sera del giorno successivo Canto IV A Sparta Menelao sta festeggiando il doppio matrimonio del figlio e della figlia Il giorno seguente Telemaco chiede del padre Menelao gli racconta il proprio ritorno durante il quale aveva incontrato Proteo il vecchio nume marino che gli aveva riferito come Odisseo fosse trattenuto nellrsquoisola di Calipso Intanto a Itaca i proci preparano insidie meditando di uccidere Telemaco al suo ritorno Penelope ne viene a conoscenza ma Atena le appare in sogno per confortarla Canto V Dopo un secondo concilio degli degravei (in effetti un ldquodoppionerdquo di quello del I canto) Zeus manda finalmente Ermes presso Calipso con lrsquoordine di lasciar partire Odisseo La ninfa aiuta lrsquoeroe a costruirsi una zattera Al diciottesimo giorno di navigazione Odisseo egrave in vista dellrsquoisola dei Feaci Scheria quando Posidone di ritorno dal suo soggiorno presso gli Etiopi lo vede e suscita una tempesta che distrugge la zattera Ma la dea marina Ino Leucotea impietositasi gli porge il proprio velo sostenuto dal quale lrsquoeroe giunge a nuoto alla riva di Scheria dove si abbandona esausto addormentandosi Canto VI In seguito a un sogno inviatole da Atena Nausicaa la figlia del re dei Feaci Alcinoo si reca nei pressi della spiaggia a lavare le vesti insieme con le ancelle Odisseo risvegliatosi atterrisce le fanciulle che fuggono tutte allrsquoinfuori di Nausicaa Lrsquoeroe supplica la giovane di porgerle aiuto ed ella lo fa rivestire e lo accompagna fino al bosco di Atena poco prima della cittagrave esortandolo a presentarsi a suo padre Canto VII Protetto dalla nebbia di cui Atena lo ha avvolto Odisseo entra nel palazzo abbraccia le ginocchia della regina Arete e la caligine scompare poi viene accolto con onore da Alcinoo Arete chiede a Odisseo donde provenga e chi gli abbia donato gli abiti (a lei ben noti) che indossa Lrsquoeroe inizia a raccontare le disavventure che gli sono occorse dopo la
Letteratura greca [1]
23
partenza dallrsquoisola di Calipso Alcinoo gli promette di farlo ricondurre a Itaca il giorno seguente Canto VIII Ma lrsquoindomani Alcinoo fa apprestare un banchetto durante il quale lrsquoaedo Demodoco canta della contesa insorta un giorno fra Achille e Odisseo Lrsquoeroe si copre il volto per nascondere le lacrime allora Alcinoo interrompe il canto e organizza una serie di gare nel corso delle quali Odisseo primeggia Poi Demodoco al margine di unrsquoarea per la danza dove si esibiscono i ballerini feaci canta gli amori di Ares e Afrodite e la vendetta di Efesto (che incatena i due amanti) La sera al ritorno nel palazzo Demodoco racconta la storia del Cavallo di legno Odisseo scoppia nuovamente in lacrime e Alcinoo gli chiede di rivelare il suo nome Canto IX Odisseo dichiara il proprio nome e dagrave inizio al racconto della propria storia a partire dalla caduta di Troia distruzione di Ismaro e perdite subite ad opera dei Ciconi sbarco presso i Lotofagi (che si nutrono di un cibo misterioso che fa dimenticare il ritorno) dopo una terribile tempesta scatenatasi durante il tentativo di doppiare il capo Malea arrivo allrsquoisola antistante quella dei Ciclopi dove Odisseo si trasferisce con una sola nave esplorazione dellrsquoisola perdita di alcuni compagni allrsquointerno della caverna del gigante monocolo accecamento del mostro e fuga Canto X Odisseo giunge allrsquoisola di Eolo signore dei venti che lo accoglie benevolmente e gli consegna alla partenza tutti i venti chiusi in un otre ma poi lo respinge con durezza quando ritorna presso di lui percheacute i compagni (sospettando che nellrsquootre siano racchiuse cospicue ricchezze) hanno sciolto i venti e da essi si egrave sprigionato un uragano che li ha risospinti sullrsquoisola Ripreso il mare Odisseo egrave trasportato fino ai Lestrigoni antropofagi il cui attacco priva lrsquoeroe di tutte le altre navi tranne la propria Con questa fugge fino allrsquoisola (Eea) della maga Circe Dopo che Circe ha trasformato in porci un gruppo di compagni mandati innanzi ad esplorare lrsquoisola Odisseo ha la meglio sulla maga (a cui impone di restituire forma umana ai compagni) grazie allrsquoerba moly fornitagli da Ermes Resta un anno presso Circe che al momento della partenza gli consiglia di recarsi al paese dei morti per interrogare il vate Tiresia Canto XI Approdato alla terra dei Cimmeri (che vivono immersi in una nebbia perenne sulla riva dellrsquoOceano) e scavata una fossa Odisseo sacrifica ai morti e immola una vittima speciale a Tiresia Le anime accorrono dapprima Elpenore caduto per caso giugrave dal tetto della casa di Circe (Odisseo gli promette sepoltura) poi la madre Anticlea (che gli racconta di esser morta di dolore per la sua assenza) quindi Tiresia che gli vaticina le sue vicende future fino alla morte (questa lo coglieragrave dopo una lunga vita in un paese straniero che non conosce neacute il sale neacute il remo) Da un certo punto in poi il poeta dimentica il presupposto per cui Odisseo aveva scavato una fossa alla quale i morti accorrevano per bere il sangue delle vittime e bevendolo riacquistavano per breve tempo una piena consapevolezza immagina invece che Odisseo sia allrsquointerno dellrsquoAde In questa sezione rientrano la descrizione di Aiace sdegnato di Minosse di Orione dei grandi peccatori di Eracle Poi Odisseo fa ritorno a Eea e ricevuti i consigli di Circe si imbarca per il ritorno in patria Canto XII Scampato alle Sirene che invano lo attirano col canto (si egrave fatto legare allrsquoalbero della nave i compagni che remano hanno le orecchie turate con la cera) passa tra Cariddi e Scilla (che gli rapisce sei uomini) ed egrave costretto dai compagni ad approdare in contrasto con le prescrizioni di Circe allrsquoisola Trinachia dove pascolano le greggi del Sole I
Letteratura greca [1]
24
compagni spronati da Euriloco se ne cibano nonostante il divieto dellrsquoeroe Il Sole sdegnato ottiene da Zeus che la nave sia colpita dal fulmine Tutti i compagni periscono ma Odisseo che ripassa tra Scilla e Cariddi si salva miracolosamente da questrsquoultima aggrappandosi a un fico selvatico fincheacute il gorgo restituisce i rottami della nave infine arriva remando con le mani allrsquoisola di Ogigia Canto XIII Terminato il racconto lrsquoeroe riceve doni dai Feaci e la notte seguente egrave ricondotto a Itaca e deposto addormentato sulla spiaggia presso un antro sacro alle Ninfe Al risveglio per la nebbia non riconosce la sua terra fincheacute Atena in veste di giovane pastore lo rassicura e poi rivelatasi gli dagrave istruzioni su come far strage dei proci e lo trasforma in un vecchio mendico Canto XIV Odisseo si reca allo stazzo del suo porcaio Eumeo che pur non riconoscendolo lo accoglie ospitalmente rifocillandolo e offrendogli un mantello per ripararsi dal gelo notturno Canto XV A questo punto la laquoTelemachiaraquo si riannoda allrsquoazione principale Telemaco che si trova ancora a Sparta viene indotto da Atena a tornare a Itaca sulla via del ritorno a Pilo accoglie a bordo lrsquoindovino Teoclimeno e grazie allrsquoaiuto della dea sfugge alle insidie dei proci sbarca a Itaca e si reca anchrsquoegli presso Eumeo Canto XVI Questi va da Penelope ad annunciargli il ritorno del figlio Intanto Odisseo rimosso lrsquoincantesimo si svela nel suo vero aspetto a Telemaco e con lui progetta la vendetta sui proci (che intanto tramano una nuova insidia ai danni di Telemaco) Eumeo torna al suo stazzo Canto XVII Il mattino seguente Telemaco si reca in cittagrave seguito in un secondo tempo da Eumeo e Odisseo (che ha riassunto lrsquoaspetto di mendico) Davanti al palazzo Odisseo egrave riconosciuto dal cane Argo Entra e va mendicando tra i proci Antinoo lo colpisce alla spalla destra con uno sgabello Canto XVIII Odisseo si batte al pugilato col mendicante Iro Penelope scesa nella sala prospetta ai proci lrsquoeventualitagrave di un nuovo matrimonio Odisseo egrave insultato dalla schiava Melanto e schiva uno sgabello scagliato da Eurinomo Canto XIX Insieme con Telemaco lrsquoeroe allontana le armi dalla sala poi conversa con Penelope che gli racconta un sogno e gli espone il suo piano per sedare le contese tra i proci concedendosi sposa a colui che riusciragrave a tendere lrsquoarco di Odisseo la prova avverragrave il giorno seguente al novilunio Durante il colloquio la fida schiava Euriclea lava i piedi di Odisseo e riconosciutolo da unrsquoantica cicatrice sta per rivelarne lrsquoidentitagrave ma lrsquoeroe la costringe a tacere Canto XX Al mattino Euriclea e le ancelle fanno i preparativi per il banchetto Giungono Eumeo Melanzio e il mandriano Filezio Un presagio mandato da Zeus dissuade i proci dal progetto di uccidere Telemaco Durante il banchetto Teoclimeno predice la loro imminente rovina
Letteratura greca [1]
25
Canto XXI Penelope conduce lrsquoarco nella sala dopo che parecchi fra i proci e lo stesso Telemaco hanno tentato invano di tenderne la corda Odisseo chiede di partecipare alla prova tende lrsquoarco senza fatica e riesce a far passare la freccia attraverso gli anelli di dodici scuri predisposte da Telemaco Canto XXII Poi scaglia le frecce sui proci e si rivela nella sua identitagrave Nella lotta che segue Telemaco Eumeo e Filezio aiutano il padrone contro i proci (appoggiati dal capraio Melanzio) Tutti i proci restano uccisi le ancelle infedeli sono impiccate Melanzio viene mutilato e ucciso soltanto lrsquoaedo Femio e lrsquoaraldo Medonte sono risparmiati Canto XXIII Nuovo colloquio fra Odisseo e Penelope che durante lrsquoeccidio dormiva ed egrave stata svegliata da Euriclea Penelope esita ancora a riconoscere il marito e non si arrende alla veritagrave fincheacute Odisseo non le descrive la posizione e la struttura del letto coniugale Canto XXIV Ermes conduce allrsquoAde le ombre dei proci Odisseo fa visita al padre Laerte nella masseria dove quello vive nello squallore e nellrsquoemarginazione e si fa riconoscere Intanto il padre di Antinoo incita gli Itacesi alla rivolta e il poema si conclude con lo scontro di Odisseo e dei suoi contro i concittadini lrsquoeroe ha la meglio e Zeus scagliato il fulmine pone fine alla battaglia Atena sotto lrsquoaspetto di Mentore stabilisce fra i contendenti un patto per il futuro36
Struttura e caratteri dellʼopera Giagrave la prima parola del proemio (ἄνδρα) non menziona come tema dellrsquoopera un determinato episodio della vita del protagonista ma il protagonista stesso (I 1-10)
Ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα πολύτροπον ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεmiddot πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περmiddot αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο νήπιοι οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιονmiddot αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ τῶν ἁμόθεν γε θεά θύγατερ Διός εἰπὲ καὶ ἡμῖν Dellrsquouomo multiforme a me racconta o Musa che molto errograve dopo che di Troia la sacra rocca distrusse di molti uomini vide le cittagrave riconobbe il pensiero e molti per il mare patigrave dolori nellrsquoanimo per salvare la sua vita e il ritorno dei compagni Eppure non li salvograve i compagni per quanto bramasse per la loro stessa follia si persero gli stolti i buoi del Sole Iperione mangiarono e quello rapigrave ad essi il digrave del ritorno Di questo da un punto qualsiasi narra anche a noi o dea figlia di Zeus
Storie favolose di naviganti racconti imperniati sul ritorno dei guerrieri achei che avevano combattuto a Troia e il particolare rientro in patria di Odisseo figlio di Laerte erano forse giagrave stati connessi e intrecciati nella precedente tradizione epica sigrave che il presente cantore poteva
Letteratura greca [1]
26
metter mano alla vicenda partendo (v 10) laquoda un punto qualsiasiraquo (ἁμόθεν) una notazione che certo presuppone la convenzione propria dellrsquoesordio tradizionale di un canto epico comparabile con i giagrave ricordati ἐξ οὗ (laquoda quandoraquo) di Iliade I 4 ed ἔνθεν (laquoda doveraquo) di Odissea VIII 500 Senoncheacute rispetto a queste indicazioni di tipo puntuale il tratto costituito dalla dimensione casuale quasi arbitraria inerente ad ἁμόθεν proprio mentre dichiara lrsquoassenza di un determinato piano compositivo implica in realtagrave che il racconto non si svolgeragrave per filo e per segno secondo lrsquoordine noto a poeta e uditori non si snoderagrave κατὰ κόσμον (laquoper ordineraquo) come il canto di Demodoco (VIII 489) ma seguiragrave un andamento originale Il ldquopunto qualsiasirdquo incipitario non rappresenta una scelta della Musa (figura dellrsquoarchivio tematico che conserva le laquovieraquo dellrsquoepica) bensigrave di questo cantore che ha deciso di far incominciare la narrazione in medias res e ha in serbo la sorpresa di far succedere al concilio degli degravei (che decide lrsquoinvio di Ermes presso Calipso) non lrsquoazione testeacute programmata (azione che viene differita con un ritardo che a piugrave riprese ha scandalizzato i lettori a principio del V canto) ma la partenza di Atena alla volta di Itaca e lrsquoavvio della laquoTelemachiaraquo Le due diverse vicende proposte a principio del poema quella di Telemaco e quella di Odisseo procedono infatti in parallelo coprendo un analogo lasso di tempo Piugrave oltre la decisione di trasformare la sequenza narrativa che va dalla partenza di Odisseo da Troia fino al suo arrivo nella terra dei Feaci in una rievocazione fatta dallrsquoeroe in prima persona al cospetto di Alcinoo e dei Feaci (la sezione detta degli ἀπόλογοι laquoraccontiraquo) crea una struttura ad anello che parte dal presente e ad esso fa ritorno dopo aver ricostruito le premesse della condizione attuale del protagonista Col canto XIII Odisseo egrave riportato dai Feaci a Itaca e questo permette la saldatura fra le vicende sue e quelle di Telemaco sia pure col differimento dellrsquoincontro e del riconoscimento fra padre e figlio fino al canto XVI Far scorrere in parallelo sequenze distinte organizzare programmi narrativi a corta e a lunga gittata tendere o allentare ad arte il ritmo della narrazione non si tratta davvero di procedimenti che potessero configurarsi come tradizionali dellrsquoarte epica quanto piuttosto di un momento sperimentale di una ricerca di soluzioni nuove al termine di una lunga e ormai consolidata sedimentazione di percorsi compiuti allrsquointerno di un determinato repertorio tematico unrsquoaudacia inventiva una πολυτροπίη degne del protagonista del poema che inevitabilmente comportavano rischi molteplici di incoerenze dissonanze occasionali avarie della macchina epica e che tuttavia erano destinate a conseguire un risultato assolutamente convincente allrsquoorecchio di chi si abbandonasse al fascino del racconto senza lrsquourgenza propria di altre etagrave e di altre mentalitagrave di puntare il dito sui singoli dettagli o le singole sfasature
PER SAPERNE DI PIUrsquo Difficoltagrave e incongruenze della narrazione omerica Forti della possibilitagrave di un controllo su un testo scritto che possiamo percorrere in avanti e a ritroso secondo ritmi di nostra scelta a noi non riesce difficile cogliere alcune delle difficoltagrave organizzative incontrate nella composizione del poema In proposito per ricordare un caso che saragrave allrsquoorigine delle discussioni di orientamento ldquoanaliticordquo intorno allrsquoOdissea possiamo leggere il discorso che Atena prese le sembianze di Mente re dei Tafi rivolge a Telemaco nel I canto (vv 253-305) Ah infelice ti manca molto davvero lrsquoassente Odisseo che getti le mani addosso ai pretendenti sfrontati Percheacute se ora tornato stesse sulla soglia 255 con una scure lo scudo e due lance cosigrave come io per la prima volta lo vidi in casa nostra che beveva e godeva di ritorno da Efira da Ilo di Mermero (andograve anche ligrave Odisseo con la nave veloce 260 in cerca del veleno omicida per averne da ungere le frecce di bronzo ma quello non glielo diede percheacute temeva gli dei che vivono eterni
Letteratura greca [1]
27
glielo diede invece mio padre percheacute lrsquoamava moltissimo) se stesse Odisseo tra i pretendenti cosigrave 265 essi avrebbero tutti rapida morte e nozze amare Ma sulle ginocchia degli dei questo giace se una volta tornato faragrave o no vendetta nella sua casa te invece io esorto a riflettere come cacciare i pretendenti da casa 270 Ebbene ora ascolta e alle mie parole darsquo retta Domattina chiamati gli eroi Achei a consiglio rivolgi a tutti un discorso e siano testimoni gli dei Ai pretendenti comanda drsquoandarsene per i fatti loro e tua madre se lrsquoanimo la spinge alle nozze 275 ritorni a casa del padre molto potente Prepareranno essi le nozze e disporranno i doni nuziali moltissimi quanti gli pare che debbano andare alla figlia A te darograve un saggio consiglio se vuoi ascoltarlo armata una nave con venti remi la migliore che crsquoegrave 280 Varsquo a domandare del padre partito da tempo se mai te ne parli un mortale o sentissi da Zeus la voce che divulga la fama tra gli uomini Anzitutto varsquo a Pilo e interroga il chiaro Nestore di ligrave poi varsquo a Sparta dal biondo Menelao 285 degli Achei vestiti di bronzo egli egrave tornato per ultimo Se senti dire qualcosa sulla vita e il ritorno del padre per quanto stremato potresti sopportare un altro anno se invece senti dire che egrave morto e non vive allora tornato nella cara terra patria 290 ergigli un tumulo e offrigli funebri offerte moltissime quanto conviene e darsquo tua madre a un marito E poi dopo aver compiuto e fatto ogni cosa allora medita nella mente e nellrsquoanimo come tu possa uccidere nelle tue case 295 i pretendenti con lrsquoinganno affrontandoli non devi piugrave avere i modi di un bimbo percheacute ormai non sei tale Non senti lrsquoillustre Oreste quale gloria ha acquistato fra tutti gli uomini percheacute uccise lrsquoassassino del padre Egisto esperto di inganni che gli uccise il nobile padre 300 Anche tu caro infatti molto bello e grande ti vedo sii valoroso percheacute ti lodi anche qualcuno dei posteri Ma io tornerograve adesso alla nave veloce dai compagni che forse impazienti mi aspettano Tu devi pensarci da te dammi retta 305
[Tr di GA Privitera] Le stranezze non mancano davvero e cosigrave sono state messe a fuoco da Stephanie West nel suo commento23 1 Atena sa evidentemente molto piugrave di quanto uno come Mente avrebbe potuto sapere in particolare ella sa che i proci ignoreranno lrsquoinvito di Telemaco a lasciare la sua casa e fatto piugrave importante che gli degravei tra breve ricondurranno in patria Odisseo A queste osservazioni si puograve replicare con la stessa West che laquosi sono esagerate difficoltagrave e
23 Omero Odissea I cit 219 ss
Letteratura greca [1]
28
incongruenze alle quali un pubblico di ascoltatori (o anche un lettore moderatamente attento) probabilmente non farebbe casoraquo 2 Il progetto di una pubblica denuncia dei proci dinanzi agli degravei e agli uomini ai vv 273-274 egrave ciograve che Atena sembra prefiggersi nel promuovere lrsquoassemblea degli Itacesi (assemblea che effettivamente avragrave luogo a principio del canto II) drsquoaltra parte le successive istruzioni di AtenaMente ai vv 295 s (medita come uccidere i pretendenti) presuppongono che di quella richiesta da formulare nel corso dellrsquoassembla essi non terranno alcun conto Anche a questa osservazione si puograve rispondere che laquoegrave ragionevole attendersi che Telemaco condivida la previsione di un esito negativo della sua iniziativaraquo e si puograve aggiungere che pure in caso di insuccesso il ricorso allrsquoassemblea potrebbe ottenere almeno il risultato di screditare i pretendenti presso la comunitagrave itacese legittimando un successivo ricorso alla violenza (e si tratta di una legittimazione di cui anche lrsquoultimo canto mostreragrave lrsquoesigenza) 3 Dopo che Telemaco aveva detto che la madre non intendeva risposarsi (vv 249-250) AtenaMente si esprime ai vv 275-278 come se Penelope desiderasse proprio nuove nozze e inoltre sarebbe assurdo che il padre di Penelope cominciasse a contrattare un secondo matrimonio prima del ritorno di Telemaco dal suo viaggio e che mettesse mano a preparativi che rischierebbero di essere annullati qualche tempo dopo con inevitabile imbarazzo se Telemaco venisse a sapere che Odisseo egrave ancora vivo In piugrave lrsquoandamento sintattico di questi versi presenta un anacoluto durissimo per cui a principio del v 275 lrsquoaccusativo μητέρα egrave seguito da un ἂψ ἴτω (laquovada indietroraquo laquotorniraquo) che richiederebbe come soggetto un nominativo μήτηρ Come hanno reagito i lettori di Omero Nellrsquoantichitagrave un grammatico rimasto anonimo cambiava come attesta uno scolio μητέρ᾽ in μήτηρ nel secolo XVIII Richard Bentley modificava ἴτω in ἴμεν (infinito eolico di εἶμι laquovadoraquo) nel XIX un altro grande della filologia europea Gottfried Hermann risolveva piugrave drasticamente la questione eliminando il complesso dei vv 275-278 e la stessa West mostra simpatia per tale proposta supponendo laquounrsquoaggiunta posteriore modellata sul corrispondente passo del libro IIraquo (dove i vv 196 s sono identici ai vv 277 s e il v 195 copre lo stesso contenuto dei vv 275 s) Si tratta di procedimenti adeguati ai dati di fatto Migliorano davvero il testo che ci egrave stato tramandato In realtagrave ambedue le ldquocorrezionirdquo appena ricordate (di μήτερ᾽ e di ἴτω) ottengono un risultato tanto lineare che egrave davvero difficile pensare che lrsquoanacoluto avrebbe potuto invadere tutta la tradizione se non fosse stato originario e quanto allrsquoespunzione dei vv 275-278 essa indubbiamente peggiorerebbe il ritmo del discorso determinando lrsquoavvicinamento fra i due versi (v 271 e v 279) molto simili fra loro che aprono le due sequenze occupate dai consigli di Mente E allora La via piugrave saggia egrave senzrsquoaltro quella di tenerci qui come quasi sempre di fronte al testo omerico contraddizioni e anacoluti riconoscendo in essi lrsquoeffetto dellrsquoattivitagrave di un cantore che pur sulla base di una traccia largamente memorizzata restava pur sempre legato a quella prassi orale per cui composizione ed esecuzione tendevano a coincidere E lrsquoanacoluto si spiega bene se cerchiamo di immedesimarci nel procedimento seguito dal poeta Egli ha affidato ad Atena un certo flusso argomentativo per cui la dea deve dar consigli a Telemaco sui suoi rapporti coi proci e con la madre e cosigrave colloca in fine di v 274 un ἄνωχθι (laquoordinaraquo) destinato a reggere gli accusativi simmetricamente dislocati in principio di verso (vv 274 e 275) μνηστῆρας e μητέρα Senoncheacute giunto a questa seconda parte dellrsquoargomentazione egli si avvede quanto sarebbe illogico che Telemaco sollecitasse la madre a nuove nozze di qui lrsquoimprovviso cambio di costruzione che svincola al prezzo di una sensibile slogatura sintattica lrsquoipotesi delle nuove nozze dallrsquoordine impartito a Telemaco e la prospetta invece come un desiderio eventuale della stessa Penelope Il poeta ha un progetto ben meditato brani e sequenze piugrave volte sperimentati ed egrave col supporto di questi materiali giagrave elaborati che egli si fa strada attraverso le insidie della
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
9
sempre piugrave estesa memorizzazione di ampie zone di testo il lavorio di riflessione sui singoli episodi e sui nessi e i parallelismi fra gli episodi stessi e la scoperta di inedite possibilitagrave espressive connesse alla modificazione di formule tradizionali dovettero incoraggiare i poeti a uno sfruttamento consapevole e artisticamente meditato del ldquogioco delle formulerdquo Da un lato procedimenti come lrsquoaddensamento degli epiteti la sostituzione di un epiteto convenzionale con uno non convenzionale (con la creazione di un nesso nuovo di struttura metrica eventualmente diversa) il trasferimento di un epiteto da un referente a un altro creano nei poemi una continua tensione tra formularitagrave e superamento della formularitagrave dallrsquoaltro la rete delle corrispondenze a distanza generata dalla ripetizione di un determinato modulo permette al poeta di variare e approfondire un motivo e di sottolineare i parallelismi o le dissonanze fra determinate situazioni La guerra di Troia Schliemann e la riscoperta di Troia In etagrave moderna la riscoperta della cittagrave di Troia situata sullrsquoodierna collina di Hissarlik e sovrastante la bassa pianura attraversata dallo Scamandro a sud del promontorio del Sigeo si lega agli scavi di Heinrich Schliemann (1822-1890) che a partire dal 1866 si dedicograve al disseppellimento delle rovine di Micene di Tirinto e di altri siti micenei e appunto di Troia Nel corso del tempo si egrave venuta creando attorno alla personalitagrave di questo archeologo dilettante una sorta di leggenda a cui egli stesso contribuigrave con le autobiografie Ilios (1881) e Troja (1884) nel senso di un dilettantismo romantico di scavi avventurosi condotti con sorprendenti successi ma senza alcun rigore di metodo di un amore cieco e totale per Omero e per lrsquoEllade E in effetti oggi sappiamo che lrsquoaver percorso la Grecia e lrsquoAsia minore sulle vie di Omero non impedigrave a Schliemann a Micene di attribuire allrsquoepoca di Agamennone tombe anche di quattro secoli piugrave antiche neacute a Troia di identificare con la cittagrave omerica uno strato risalente a una fase che va dal 2300 al 2100 aC Errori del genere non dipesero tuttavia da un entusiasmo velleitario quanto dalla carenza allrsquoepoca di competenze archeologiche che potessero orientarlo verso una piugrave plausibile cronologia di reperti e di strati Occorre poi tener conto che lo strato dei materiali riferibili alla Troia omerica (o almeno a quella che oggi noi identifichiamo con la cittagrave omerica Troia VIIa) era conservato unicamente nel suo margine esterno dato che gli strati superiori della collina di Hissarlik (con le fondamenta dei palazzi e dei templi) erano stati demoliti in epoca ellenistica per realizzare il terrazzamento del suolo su cui vennero edificati nuovi templi Fu soprattutto per questa ragione che Schliemann si spinse con le proprie maestranze a scavare sempre piugrave in profonditagrave saltando gli strati del secondo millennio Dove perograve il problema consisteva nellrsquoidentificazione di un sito sulla scorta della comparazione fra gli antichi racconti e il panorama attuale Schliemann conseguigrave notevoli successi in primo luogo identificando con la collina di Hissarlik quellrsquoacropoli omerica che lrsquoopinione comune dalla fine del XVIII secolo individuava invece nel villaggio di Bunarbaschi situato su un colle a 15 km dal promontorio del Sigeo e la disputa era stata viva giagrave nellrsquoantichitagrave Ellanico di Lesbo verso il 400 aC aveva sostenuto nei suoi Troica che la Ilio del suo tempo sorta presso la collina di Hissarlik e la Ilio omerica occupavano lo stesso sito invece Demetrio di Scepsi (fr 26 Gaede) si era pronunciato per una collina a circa 9 km a sud sullrsquoaltra riva dello Scamandro La missione americana guidata nel 1932-1938 da CW Blegen e le piugrave recenti indagini sul territorio hanno offerto un quadro molto piugrave articolato e differenziato Sulla base di un nuovo diagramma la cittagrave che sorgeva al momento in cui Eratostene di Cirene fissava la caduta di Troia (1184) viene a coincidere con Troia VIIa non piugrave con quella che Schliemann chiamava laquoterza cittagraveraquo (corrispondente a Troia II) ma nemmeno come voleva W Doumlrpfeld con Troia VI (andata in rovina verso il 1300 in seguito a un terremoto) Gli scavi piugrave recenti Secondo le conclusioni di Manfred Korfmann (cfr Korfmann 2002) che ha diretto lrsquoeacutequipe dellrsquoUniversitagrave di Tubinga negli scavi piugrave recenti lrsquoantica Troia intorno al 1184 cessograve di essere abitata ma lrsquoinsediamento continuograve nellrsquoarea della rocca per circa due secoli dopo la distruzione
Letteratura greca [1]
10
della cittagrave (Troia VIIb) Verso il 700 il luogo chiamato laquoIlioraquo era largamente in rovine anche se in etagrave arcaica dovette continuare a essere frequentato come luogo di culto Il problema che si dovettero porre nellrsquoVIII secolo aC lsquoOmerorsquo o i suoi modelli dovette essere quello di rendere il racconto della guerra di Troia plausibile a un pubblico che aveva familiaritagrave con la geografia locale (lrsquoIliade offre indicazioni realistiche ad es sulla navigazione dellrsquoEgeo in IX 362 s e sulla visibilitagrave dellrsquoisola di Samotracia dalla piana di Troia in XIII 11-14) che si trattasse di genti che risiedevano nel Sigeo o in altre cittagrave vicine o di abitanti della stessa Ilion che nellrsquoVIII secolo era di nuovo attiva sia pure soltanto come centro cultuale Il santuario sorgeva allrsquointerno di una depressione naturale a sud-ovest della rocca lungo la vecchia via che conduceva alla rocca stessa Omero menziona due templi quello di Apollo e quello di Atena e le loro loro rovine sono tuttora riconoscibili I visitatori che giungevano al santuario dal Sigeo attraverso la piana dello Scamandro potevano vedere le rovine della rocca Ma - ci si chiede - quando ebbe fine il nucleo della cittagrave di Troia cantata da Omero Nel bastione a nord-est della rocca egrave stata trovata una larga e profonda cisterna con un condotto che proviene da una sorgente La sorgente fu abbandonata al piugrave tardi al tempo di Troia VIIb2 prima del 1100 A partire dal 1000950 non rimase a Troia alcun insediamento significativo Troia era molto piugrave larga di quanto ritenesse Schliemann Un fossato largo 3 m e profondo 15 completato durante lrsquoultima fase di Troia VI o al principio di Troia VIIa (cioegrave intorno al 1300) la circondava Poi esso fu rimpiazzato a sud da un fossato piugrave ampio e concentrico al primo completato verso il 1200 Il sistema di fortificazione si estendeva per quasi 2 km e pertanto racchiudeva unrsquoarea di circa 270000 m2 La rocca e la cittagrave bassa dovevano presentarsi al tempo di Omero come un imponente complesso di rovine I nuovi colonizzatori del Sigeo e di altri siti incontrarono un vasto campo attraversato da sentieri che seguivano i vecchi tracciati Negli scavi fatti nei quartieri della cittagrave bassa a sud-ovest della rocca poco fuori del muro si egrave scoperto un deposito bruciato verso la fine di Troia VI e di nuovo verso la fine di Troia VIIa (verso il 1200) La prima devastazione egrave da ricollegarsi a un terremoto ma la seconda sembra dovuta a unrsquoazione di guerra come suggerisce anche il rinvenimento di corpi insepolti o semisepolti e di depositi contenenti armi non utilizzate Verso il 1300 la porta principale di Troia era stata bloccata e ostruita percheacute qui lrsquoantico muro era in condizioni precarie e pertanto rappresentava lrsquoanello piugrave vulnerabile nel sistema di difesa Giagrave W Doumlrpfeld aveva richiamato Iliade VI 433 s (Andromaca a Ettore)
Piazza lrsquoesercito presso il fico selvatico dove egrave piugrave facile Lrsquoaccesso alla cittagrave e il superamento delle mura
In questa zona solo poco piugrave di 80 m separavano il muro della cittagrave bassa dal muro della rocca Gli epiteti omerici di Troia - laquoben costruitaraquo laquofertileraquo laquovastaraquo laquosacraraquo laquoertaraquo laquoventosaraquo laquodalle belle muraraquo laquodai bel puledriraquo - si adattano ai dati topografici ossa di cavalli sono state trovate sul terreno forti venti soffiano continuamente in estate Anche le sorgenti sono identificabili presso la porta principale cfr Iliade XXII 145-157
Passarono oltre il posto di vedetta e lrsquoalbero di fico battuto dal vento e allontanandosi sempre piugrave dalle mura si lanciarono lungo la strada Giunsero alle fontane dalle belle acque dove sgorgano due correnti dello Scamandro impetuoso una di acqua calda da cui si leva un vapore come da fuoco ardente lrsquoaltra che in piena estate versa acqua gelata come la grandine la fredda neve o il ghiaccio Vi sono accanto dei lavatoi di pietra larghi belli dove le mogli e le belle figlie dei Teucri lavavano le splendide vesti prima in tempo di pace prima che giungessero i figli dei Danai
[Tr di MG Ciani] In effetti gli scavi nellrsquoarea della caverna in cui egrave situata la sorgente hanno portato alla luce una struttura simile a una miniera con tre gallerie e altri bracci tributari creata per fornire acqua Lrsquoacqua scorreva attraverso una superficie rocciosa e poi in un canale artificiale che a sua volta raggiungeva un sistema di quattro lsquodepressionirsquo o lsquofossersquo circolari scavate nella roccia della
Letteratura greca [1]
11
misura di quasi 1 m di diametro (appunto parrebbe i πλυνοί hellip λαΐνεοι i laquolavatoi di pietraraquo ricordati da Omero) Achei e Troiani Fra XIII e XII secolo aC Troia era un grande centro politico e commerciale in grado di controllare lrsquoaccesso ai Dardanelli (lrsquoantico Ellesponto) e il trasporto su terra di beni di vario genere dalla costa egea al Mar di Marmara (lrsquoantica Propontide) e al Mar Nero In Troia VIIa egrave stata rinvenuta ceramica micenea del periodo noto come Tardo Elladico IIIB che egrave anche il periodo di maggiore splendore dei palazzi micenei sul continente greco Ersquo suggestiva lrsquoidentificazione piugrave volte avanzata in tempi recenti di TroiaIlio con Wilusa la cittagrave menzionata spesso in testi hittiti e oggetto di contesa fra gli Hittiti e quegli Ahhiyawa il cui nome sembra identificarsi con quello degli laquoAcheiraquo (Ἀχαιοί) Il documento piugrave significativo in proposito egrave il preambolo del trattato stipulato verso il 1280 aC fra il re hittita Muwattali II e Alaksandu re di Wilusa che contiene un richiamo alle precedenti relazioni fra i due stati a partire dal 1600 pur ricordando che un tempo Wilusa era sotto il dominio hittita Muwatalli afferma di aver mantenuto relazioni pacifiche anche dopo che la cittagrave era divenuta indipendente Inoltre un testo religioso hittita rinvenuto a Hattusa la capitale dellrsquoimpero hittita e databile al XIII secolo ricorda nellrsquoambito di un rituale la recita di un poema in luvio (il luvio egrave una lingua indo-europea che si distingue solo superficialmente dallrsquohittita) di cui viene riportato il primo verso laquoQuando tornarono dallrsquoerta Wilusaraquo E a Troia negli scavi piugrave recenti egrave stato trovato un sigillo con unrsquoiscrizione in luvio Drsquoaltra parte in Omero la dinastia reale troiana di cui egrave a capo Priamo figlio di Laomedonte viene fatta risalire attraverso Erittonio Troo e Ilo fino a Dardano eponimo dei Dardani che si erano stanziati nella Troade a nord del monte Ida (Iliade ΧΧ 215 ss) I Dardani nellrsquoIliade compaiono fra i principali alleati dei Troiani accanto ai contingenti provenienti da Zelea (a nord-est lungo il fiume Esepo) e a quelli di localitagrave situate sulla Propontide come Adrestea e Pitea e sulla costa asiatica dellrsquoEllesponto come Abido e Arisbe Dalla costa europea arrivano invece i Traci i Ciconi e i Peoni da oriente i Paflagoni e gli Alizoni da sud-est i Misi e i Frigi dalla zona sud-occidentale dellrsquoAnatolia i Meoni i Cari e i Lici Se Dardani Peoni Ciconi e Traci fanno parte delle popolazioni traco-frigie che fra XII e XI secolo erano scese dai Balcani in direzione dellrsquoAnatolia (cfr Erodoto 7 73 e Xanto di Lidia FGrHist 765 F 14) i Meoni sono di stirpe lidia mentre i Cari e i Lici appartengono allrsquoambito culturale e linguistico luvio-hittita Comunque sia diversamente che per Erodoto il quale inserisce il rapimento di Elena nel quadro di una serie di torti reciproci in forma di rapimenti di donne fra Greci e barbari (I 2 1) e per i poeti tragici ateniesi del V secolo aC in Omero lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato come un contrasto fra culture diverse I Troiani mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei (detti anche laquoDanairaquo - cioegrave discendenti di Danao - o laquoArgiviraquo in relazione al contingente proveniente dallrsquoArgolide guidato da Agamennone il capo della spedizione) e lo stesso vale per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari in Iliade ΙΙ 867 come laquodi lingua stranieraraquo (βαρβαρόφωνοι) suggerisce che un tale epiteto non sarebbe stato applicabile ai Troiani Infine sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di unrsquoimbarcazione sono altrettanti esempi di quelle che W Arend denominograve laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini comportamentali e tecnologiche del gruppo che le condivide (vedi scheda p xxx) La societagrave omerica
Letteratura greca [1]
12
Nel rapporto fra il mondo omerico e la storia egrave innanzi tutto da sottolineare lrsquoesistenza di un duplice piano di riferimento con talune interferenze dellrsquouno nellrsquoaltro da un lato crsquoegrave lrsquoorizzonte dei fatti collocati in un passato glorioso dallrsquoaltro lrsquoorizzonte del poeta Giagrave gli studiosi alessandrini del resto notavano che dati come lrsquoarte di montare a cavallo i segnali per mezzo della tromba e lrsquouso di bollire la carne compaiono nellrsquoIliade solo allrsquointerno delle similitudini E il testo con una sorta di arcaismo intenzionale mostra talora la consapevolezza dellrsquoabisso che separa passato e presente come quando in Iliade XII 445-449 si dice
Ettore intanto un sasso afferrograve ndash e lo portava ndash che prima stava davanti alle porte largo di sotto ma sopra era a punta questo due uomini i piugrave forti del popolo difficilmente isserebbero da terra su un carro quali son ora i mortali egli da solo lo roteava a suo agio
[Tr di R Calzecchi Onesti] Per contro le condizioni sociali rappresentate nei poemi (un mondo di grandi proprietari terrieri che reggono aziende agricole autarchiche da cui hanno preso tuttavia a distaccarsi alcune figure di artigiani il fabbro il vasaio il carpentiere il medico lrsquoindovino lrsquoaedo) rispecchiano assai piugrave la situazione storica fra VIII e VII secolo a C che le strutture della societagrave micenea Inoltre i cadaveri vengono cremati secondo la prassi piugrave recente non inumati anche se molti riferimenti omerici non rispecchiano necessariamente la pratica normale del tempo di pace trattandosi di cremazioni che avvengono oltremare non ambigua egrave comunque la testimonianza relativa alla prassi umana in generale fornita da Odissea XI 216-222 (Anticlea a Odisseo)
Ohimegrave figlio mio il piugrave misero di tutti gli uomini Persefone la figlia di Zeus non ti inganna ma la legge degli uomini egrave questa quando si muore i nervi non reggono piugrave la carne e le ossa ma la furia violenta del fuoco ardente li disfa appena la vita abbandona le bianche ossa e lrsquoanima vagola volata via come un sogno
[Tr di GA Privitera]19 Un esempio significativo di sovrapposizione tra fasi culturali distinte si coglie osservando lrsquoinventario degli oggetti accanto ad armi vasi ornamenti tipici dellrsquoVIII-VII secolo troviamo relitti risalenti allrsquoepoca micenea come la coppa di Nestore ornata di colombe descritta in Iliade XI 632 ss (simile a una coppa drsquoargento rinvenuta a Micene che riproduce disegno e artigianato dellrsquoetagrave del bronzo) lrsquoelmo di cuoio con zanne di cinghiale che Merione dagrave a Odisseo (Iliade X 261 ss) e lo scudo lungo laquosimile a torreraquo di Aiace che egrave di un tipo inusitato dopo il XIII secolo Un oggetto non riferibile neacute al mondo miceneo neacute allrsquoetagrave della fissazione dei poemi bensigrave alla prima etagrave del ferro egrave invece la coppia di aste da lancio adottate verso il 900 aC e scomparse due secoli dopo con lo sviluppo del combattimento oplitico e la reintroduzione dellrsquoasta per colpire e la menzione delle navi fenicie (una volta nellrsquoIliade e cinque volte nellrsquoOdissea) riflette la loro comparsa nellrsquoEgeo nel IX secolo aC Non diversamente sembra avvenire anche per le istituzioni politiche lrsquo ἄναξ egrave visto a volte come figura di autocrate assoluto a volte fortemente limitato dai poteri delle assemblee ndash sia quella dei capi (βουλή) sia quella delle truppe (ἀγορή) ndash o insidiato dallrsquoascesa dei gruppi aristocratici mentre il βασιλεύς non egrave piugrave il dignitario della societagrave micenea ma genericamente un principe o un capo LʼIliade
19 Omero Odissea III intr testo e commento di A Hoekstra tr di GA Privitera Mondadori Milano 1984
Letteratura greca [1]
13
LrsquoIliade (Ἰλιάς) consta di circa 15690 esametri divisi secondo una partizione che potrebbe risalire al primo editore alessandrino (Zenodoto di Efeso) in 24 libri indicati con le lettere maiuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquounitagrave strutturale di parecchi canti che spesso finiscono col tramonto o iniziano con lrsquoalba e la coincidenza fra alcuni dei titoli attribuiti a ciascun canto nelle edizioni alessandrine e quelli che si rintracciano in autori precedenti (ad es Tucidide [I 10 4] cita il ldquoCatalogo delle navirdquo cioegrave il canto II) provano che non si trattograve di una divisione arbitraria bensigrave fondata almeno in certa misura sulle abitudini dei rapsodi Tema dellrsquoopera non egrave lrsquointero assedio decennale di Troia da parte dei Greci (di norma detti Achei o Danai o Argivi) provocato dal rapimento di Elena ad opera di Paride ma una porzione assai limitata del conflitto una sequenza narrativa che copre la durata di 51 giorni e si colloca verso la fine del nono anno di guerra lrsquoira di Achille contro lrsquoAtride Agamennone il suo ritiro dalla guerra e le relative conseguenze la fine dellrsquoira lrsquouccisione e i funerali di Ettore Fu proprio questa delimitazione tematica a consentire la realizzazione di quellrsquounitagrave e compiutezza dellrsquoazione che giagrave Aristotele individuava come uno dei pregi essenziali dellrsquoopera di Omero rispetto agli altri poemi epici arcaici (Poetica 1459a-b)20
anche in questo Omero deve apparire mirabile in confronto agli altri per non aver tentato di rappresentare intera la guerra anche se essa aveva un principio e una fine il racconto sarebbe risultato troppo grande e non abbracciabile con uno sguardo oppure pur misurato nella grandezza intricato per la varietagrave Ricavatane invece una parte ha fatto uso di molti episodi per esempio con il ldquoCatalogo delle navirdquo e con altri episodi fa procedere in lungo il poema Gli altri invece come lrsquoautore delle Ciprie o della Piccola Iliade compongono unrsquoazione multipla su unrsquounica persona o un unico tempo Di conseguenza mentre dallrsquoIliade e dallrsquoOdissea si ricava unrsquounica tragedia o soltanto due da ciascuna dalle Ciprie parecchie
[Tr di D Lanza]21
Canto I Lrsquoazione si apre sul campo degli Achei devastato dalle frecce scagliate da Apollo [T1] il dio ha scatenato una pestilenza percheacute Agamennone ha rifiutato il riscatto offerto dal sacerdote Crise per la liberazione della figlia Criseide divenuta schiava dellrsquoAtride Ai guerrieri convocati in assemblea lrsquoindovino Calcante rivela che la sola via di scampo egrave la restituzione di Criseide al padre Agamennone acconsente ma solo a patto che gli venga data in cambio Briseide la schiava che Achille tiene nella sua tenda come premio personale (γέρας) ricevuto dagli altri guerrieri Achille non puograve opporsi alla prevaricazione dellrsquoAtride ma non egrave disposto a subire passivamente lrsquooltraggio e insulta Agamennone anzi egrave giagrave pronto a estrarre la spada dal fodero per farsi giustizia quando viene trattenuto da Atena apparsa allrsquoimprovviso allora si ritira nella tenda giurando che non combatteragrave piugrave [T2] Quindi invoca la madre Tetide che dopo essere apparsa al figlio sulla riva del mare intercede presso Zeus e ottiene la promessa che i Greci non vinceranno la guerra e non espugneranno Troia fincheacute Achille non riceveragrave soddisfazione per lrsquooffesa subita Ma il piano di Zeus non resta celato ad Era che ingelosita provoca una lite nel corso del banchetto degli dei tuttavia la visione di Efesto zoppicante che funge da coppiere suscita lrsquoilaritagrave dei numi e riporta la serenitagrave Canto II Quella stessa notte Zeus manda ad Agamennone un sogno ingannatore per incitarlo ad attaccare Troia LrsquoAtride riferisce il sogno agli anziani e comanda lrsquoadunata dellrsquoesercito
20 Cfr anche 1462b ταῦτα τὰ ποιήματα συνέστηκεν ὡς ἐνδέχεται ἄριστα καὶ ὅτι μάλιστα μιᾶς πράξεως μίμησις (laquoQuesti poemi sono composti come meglio non si puograve e son il piugrave possibile imitazione di unrsquounica azioneraquo) 21 Aristotele Poetica Milano Rizzoli 19902
Letteratura greca [1]
14
con lrsquoidea stravagante di saggiare lrsquoumore delle truppe proponendo il ritorno in patria Gli uomini incitati da Tersite corrono alle navi pronti a salpare ma vengono bloccati da Odisseo e da Nestore Egrave significativo che Tersite lrsquoanti-eroe riecheggi le accuse di Achille ad Agamennone sottolineando gli onori di cui questi gode e prenda le parti di Achille [T3] Per tutta la seconda parte del libro lrsquoazione viene interrotta per far posto alla grandiosa uscita in armi dellrsquoesercito acheo dal recinto delle navi un quadro scintillante ornato da una catena di sei similitudini concatenate introdotte per illustrare il fulgore delle armi il rombo dei passi umani e degli zoccoli precipitosi lrsquoaspetto della schiera achea e la maestria dei condottieri Un ldquoCatalogo delle navirdquo contiene lrsquoelenco circostanziato delle genti greche che hanno preso parte allrsquoassedio ed egrave seguito da un catalogo piugrave breve e piugrave arido degli alleati dei Troiani accorsi in difesa di Ilio Canto III Lrsquoatteso scontro tra gli schieramenti appena passati in rassegna non ha luogo ParideAlessandro ottiene infatti una tregua per sfidare Menelao Iride la messaggera degli degravei spinge Elena ad accorrere alle mura presso le porte Scee per assistere al preannunciato duello di ligrave Priamo e gli altri anziani di Troia osservano la pianura Su richiesta del vecchio sovrano (una richiesta che sarebbe stata piugrave ldquoverosimilerdquo al primo anno di guerra) Elena nomina i piugrave prestigiosi campioni achei [T4] Nel duello che segue Paride si trova ben presto a mal partito contro Menelao ma Afrodite lo sottrae ai colpi del nemico avvolgendolo in una fitta nebbia e lo riporta nelle sue stanze dove dopo aver assunto lrsquoaspetto di una vecchia filatrice ordina a Elena di giacere con lui Elena si ribella ma la dea non transige Mentre Paride ed Elena si uniscono nellrsquoamplesso Menelao furibondo cerca fra la folla il nemico che sia i Greci che i Troiani sarebbero lieti di consegnargli pur di porre fine alla guerra Agamennone rivendicando la vittoria di Menelao pretende dai Troiani la restituzione di Elena e delle sue ricchezze noncheacute il pagamento di una forte ammenda Canto IV La tregua stipulata dopo la scomparsa di Paride viene infranta dallrsquoarciere Pandaro che sollecitato da Atena (scesa tra le schiere troiane su ordine di Zeus) ferisce con una freccia Menelao questi viene prontamente guarito dal medico Macaone figlio di Asclepio Agamennone passa fra le schiere incitandole a combattere incontra vari capi intenti a dare istruzioni ai propri uomini Solo Ulisse e Menesteo si tengono in disparte ricevendo i rimproveri di Agamennone ai quali Ulisse reagisce con indignazione Gli Achei muovono contro i Troiani con grande ordine e disciplina mentre i Troiani e i loro alleati schiamazzano come barbari Ha inizio la battaglia vera e propria nella quale lrsquoattenzione egrave focalizzata sui duelli individuali Ad assistere e rincuorare i Troiani compare Apollo sulla rocca di Troia mentre Atena infonde coraggio nei Greci Il canto si chiude sullrsquoinfuriare della battaglia la cui descrizione riprenderagrave nel canto successivo Canto V Balza in primo piano Diomede di cui viene presentata lrsquoἀριστεία lrsquoeroe laquoglorioso e chiaroraquo fa strage di nemici imperversando furiosamente fra le schiere troiane Nel pieno del combattimento viene ferito da una freccia scagliata da Pandaro il quale mena gran vanto del colpo andato a segno Diomede ottenuta unrsquoimmediata guarigione grazie allrsquointervento di Atena muove allora contro il nemico che nel frattempo era stato accolto sul carro di Enea Pandaro scaglia la sua lancia contro Diomede ma lo scudo di questi regge il colpo Diomede colpisce a sua volta uccidendo il nemico Enea scende dal cocchio per proteggere il cadavere di Pandaro dagli Achei che vorrebbero farne razzia ma Diomede lo colpisce con un grande masso fratturandogli il femore Enea viene salvato dallrsquointervento di Afrodite che lo avvolge nel suo manto mentre Diomede arriva addirittura a ferire al polso la dea che fugge sullrsquoOlimpo a farsi confortare dalla madre Dione Il figlio di Tideo attacca anche Apollo che aveva sottratto Enea alla sua furia ma
Letteratura greca [1]
15
egrave fermato dal grido di ammonimento del dio Incitati e aiutati da Ares ora i Troiani avanzano con impeto Intervengono Era e Atena e questrsquoultima assume il ruolo di auriga di Diomede Col suo aiuto questi ferisce al ventre Ares che fugge sullrsquoOlimpo Anche le dee vi fanno ritorno Canto VI Il canto VI egrave una naturale continuazione del V (tanto che Erodoto citeragrave come dallrsquoἀριστεία di Diomede un brano della prima parte del VI canto) La battaglia infuria nella pianura ma il furore di Diomede si stempera su una nota di cortesia quando lrsquoeroe dopo aver sfidato Glauco di Licia scopre di avere con lrsquoavversario antichi rapporti di ospitalitagrave I due si scambiano le armature (a detrimento di Glauco a cui laquoZeus Cronide levograve il senno cheacute scambiograve con Diomede Tidide armi drsquooro con armi di bronzo cento buoi con nove buoiraquo [vv 234-6]) Frattanto Ettore su invito dellrsquoindovino Eleno rientra in cittagrave dove le donne devono cercare di ottenere con offerte e voti il favore di Atena e incontra dapprima la madre Ecuba poi Paride (che intende ricondurre alla battaglia) vorrebbe salutare anche la moglie ma non la trova in casa bensigrave alle porte Scee dove Andromaca era accorsa piena drsquoangoscia insieme col figlioletto e con la nutrice Nel colloquio che segue ella lo implora di non esporre al pericolo se stessa e il figlio La replica di Ettore egrave esemplare per capire la prospettiva del poema e le motivazioni dellrsquoagire dei personaggi dominanti se Achille e gli eroi achei in genere cercano onore e gloria a questa motivazione (che pure non egrave assente) Ettore antepone lrsquoαἰδώς il senso di laquovergognaraquo e di responsabilitagrave nei confronti della comunitagrave e del nucleo familiare di cui egrave il difensore Poi si volta per prendere tra le braccia Astianatte ma lrsquoelmo lucente e il cimiero ondeggiante impauriscono il piccolo che si rifugia in seno alla nutrice Alla fine del canto Paride si incontra con Ettore e i due si avviano verso il campo di battaglia [T5] Canto VII A principio del canto VII Atena e Apollo si accordano per indurre Ettore a lanciare una sfida agli Achei per un duello Il sorteggio designa Aiace come campione greco Nello scontro Ettore lancia per primo lrsquoasta che penetra ma senza trapassarlo nello scudo di Aiace greve e massiccio (compaginato con sette strati di pelle bovina simile a una torre) Aiace di rimando lacera lo scudo e il pettorale della corazza ma non riesce a squarciare le carni del nemico percheacute Ettore si piega di lato Allora i due brandiscono di nuovo le aste poi ricorrono alle pietre Alla fine gli araldi arrestano il combattimento con la giustificazione che laquola notte giagrave viene ed egrave bene obbedire alla notteraquo (v 282) Su proposta di Nestore gli Achei decidono per il giorno seguente di seppellire i morti e di scavare una grande trincea difesa da un bastione sul margine del loro accampamento Respingono lrsquoofferta di pace dei Troiani (che prevederebbe la riconsegna dei tesori sottratti da Paride a Sparta) Il mattino seguente i morti vengono cremati e durante la giornata si erige il muro di protezione Canto VIII Nellrsquoassemblea degli degravei Zeus vieta ai numi di appoggiare lrsquouna o lrsquoaltra parte in conflitto Al mattino il combattimento riprende e a mezzogiorno Zeus pone i destini dei due popoli sulla bilancia che piega a favore dei Troiani Sul campo di battaglia Diomede salva Nestore Lrsquoazione di Ettore egrave travolgente fincheacute Zeus contravvenendo alla sua intenzione di favorire i Troiani accoglie la preghiera di Agamennone per risollevare il morale degli Achei che organizzano la difesa delle navi Nel corso degli scontri si segnala lrsquoarciere Teucro che colpisce i nemici muovendosi in sincronia con Aiace Telamonio che lo protegge con lo scudo Incitato da Agamennone egli prova a colpire anche Ettore ma soccombe colpito con una pietra A questa vista Era e Atena corrono ad armarsi per intervenire a favore degli Achei ma vengono distolte dalle minacce di Zeus che manifesta la propria intenzione di favorire i Troiani fino a quando i Greci non saranno ridotti alla disperazione tanto da scongiurare Achille percheacute ritorni Il sopraggiungere della notte
Letteratura greca [1]
16
interrompe i combattimenti Ettore galvanizzato dai successi ottenuti in quel giorno si illude che la vittoria sia a portata di mano e prospetta ai suoi una prossima ritirata degli Achei Il canto si chiude con il banchetto dei Troiani che banchettano nella pianura esaltati dalla speranza di vittoria Canto IX Agamennone affranto propone di fare ciograve che nel canto II aveva suggerito soltanto per mettere alla prova lrsquoesercito interrompere la guerra e tornare in patria Diomede si oppone e Nestore in un consiglio dei capi propone di tentare la riconciliazione con Achille Si invia alla tenda di Achille unrsquoambasceria (composta da Aiace Odisseo e Fenice antico pedagogo di Achille) per offrire doni ricchissimi Achille non cede anzi minaccia di salpare immediatamente verso la patria [T6] Inutilmente Fenice lrsquoantico precettore di Achille cerca di ammorbidire la determinazione del Pelide richiamando la vicenda dellrsquoeroe Meleagro [T7] Gli inviati riferiscono ad Agamennone la risposta di Achille egli torneragrave a combattere solo quando Ettore saragrave arrivato fino alle navi dei Mirmidoni Canto X Nella stessa notte si effettua una missione segreta nel corso della quale Odisseo e Diomede dapprima catturano la spia troiana Dolone (che Ettore aveva inviato alle navi achee promettendogli come ricompensa i cavalli di Achille) poi uccidono il re trace Reso appena arrivato presso i Troiani e ne rubano i magnifici cavalli Giagrave gli antichi ritenevano questo canto unrsquoaggiunta post-omerica e questi dubbi trovano riscontro in lati eccentrici della narrazione e nellrsquoimpiego di un linguaggio che spesso appare svincolato dal corrente repertorio formulare Canto XI Si apre una nuova giornata di battaglia (la cui narrazione si protrarragrave fino al canto XVIII) che ruota intorno allrsquoἀριστεία di Agamennone Quando lrsquoAtride viene ferito gli Achei ripiegano Diomede resta anchrsquoegli ferito Odisseo e Aiace evitano a stento la massa dei nemici Nestore salva sul suo carro Macaone Achille che dalla poppa della nave osserva la battaglia vuol sapere chi egrave condotto via da Nestore e manda Patroclo che viene accolto molto benevolmente e con cui Nestore intrattiene un lungo discorso egli dice di deplorare il comportamento di Achille e con atteggiamento consono alla sua condizione di anziano si dilunga nel raccontare le proprie gesta giovanili Egli esorta quindi Patroclo a far leva sulla sua amicizia per convincere Achille a riprendere il combattimento o - almeno - a concedere a Patroclo le sue armi per incutere timore nei Troiani Eccitato dalle parole del vecchio Patroclo si avvia verso la nave di Achille ma incontra Euripilo ferito che gli chiede aiuto ed egli impietositosi lo accompagna alla tenda e cura la ferita Canto XII Divisi in cinque contingenti i Troiani danno lrsquoassalto al muro eretto a difesa del campo acheo Sul campo di battaglia si manifesta un prodigio unrsquoaquila in cielo con un grosso serpente fra le zampe che riesce a ferire lrsquouccello e a sfuggire Polidamante che interpreta il segno come un presagio funesto consiglia di tornare indietro ma Ettore egrave di altro avviso Sarpedone e Glauco sferrano un attacco contro il muro e - pur rimanendo feriti - riescono ad aprire una breccia La battaglia infuria con esito incerto fincheacute Ettore con un macigno sfonda una delle porte consentendo ai Troiani di entrare in massa nel campo acheo mentre i Greci fuggono verso il mare Canto XIII Zeus distoglie lo sguardo dalla battaglia nella convinzione che nessuno fra gli dei avrebbe osato violare il divieto di intervenire ne approfitta invece Poseidone favorevole ai Greci Assunto lrsquoaspetto dellrsquoindovino Calcante il dio infonde nuovo vigore nei due Aiaci
Letteratura greca [1]
17
spronandoli al combattimento Gli Achei riconoscono lrsquointervento divino e riprendono fiducia I combattimenti si susseguono violentissimi Nella resistenza si distingue il re cretese Idomeneo Polidamante consiglia una seconda volta di interrompere la battaglia e accenna allrsquoimminente intervento di Achille Ettore non ascolta lrsquoammonimento e riprende lrsquoassalto Il canto si chiude con un suo scambio di insulti con Aiace Telamonio Canto XIV Mentre Diomede Odisseo e Agamennone tornano feriti allrsquoaccampamento Era per distogliere Zeus dalla battaglia e consentire a Poseidone di favorire gli Achei indossa la cintura magica di Afrodite e sollecita il consorte a un convegno amoroso sullrsquoIda dopo lrsquoamplesso Zeus cade in un sonno profondo e Hypnos (il Sonno) annuncia a Posidone che potragrave aiutare senza rischi gli Achei Ettore colpito con una pietra da Aiace resta a lungo in stato di incoscienza e i Troiani vengono respinti Canto XV Zeus si risveglia avvedendosi dellrsquoinganno subito e costringe Era a mandargli Iride e Apollo la prima allontaneragrave Posidone dal campo di battaglia Apollo inciteragrave Ettore a far retrocedere gli Achei fino alle navi dei Mirmidoni Riprende lrsquooffensiva troiana Apollo stesso abbatte il muro e scuotendo lrsquoegida atterrisce gli Achei Patroclo corre da Achille mentre i Troiani giagrave sono sul punto di appiccare il fuoco alle navi Canto XVI Patroclo in lacrime supplica Achille di intervenire o di mandare lui stesso al suo posto [T8] Achille gli consegna le proprie armi e gli fa promettere che non si avventureragrave oltre la zona delle navi Ma Patroclo trascinato dal suo stesso impeto oltrepassa il limite prescrittogli da Achille Abbatte Sarpedone figlio di Zeus attorno al cui cadavere infuria la lotta fincheacute Apollo lo sottrae alla mischia e Hypnos e Thanatos (il demone della morte) lo trasportano in Licia sua patria Patroclo continua lrsquoassalto alla testa dei Mirmidoni fin sotto le mura di Troia ma poco prima del tramonto al quarto assalto Apollo stesso assunto lrsquoaspetto di Asio lo percuote fra le spalle allora Euforbo lo colpisce con lrsquoasta ed Ettore lo trafigge Canto XVII Euforbo viene ucciso da Menelao ma Ettore riesce a catturare le armi di Achille indossate da Patroclo Vigorosamente sostenuti da Aiace gli Achei difendono il cadavere Una densa nebbia scende sui combattenti Zeus infonde nuovo ardimento nei cavalli di Achille piangenti per la fine di Patroclo [T9] Atena e Apollo arroventano la lotta attorno alla salma In seguito alla preghiera di Aiace Zeus dissolve la nebbia Menelao manda Antiloco figlio di Nestore a informare Achille della morte di Patroclo la cui salma viene intanto trascinata fuori della battaglia da Menelao e Merione mentre i due Aiaci offrono la necessaria copertura contro la furia incalzante dei nemici Canto XVIII Lo scoppio di selvaggio dolore a cui si abbandona Achille allrsquoudire della morte di Patroclo provoca lrsquoaccorrere dal mare di Tetide insieme con le Nereidi La madre gli promette di procurargli nuove armi Poicheacute la salma di Patroclo egrave tuttora contesa Achille fa la sua apparizione sul fossato e lancia un grido che atterrisce i nemici Efesto su preghiera di Tetide foggia le nuove armi fra cui un magnifico scudo su cui appaiono effigiati in bande concentriche gli aspetti salienti dellrsquoesistenza umana Canto XIX Il mattino seguente Tetide porta le armi al figlio e con lrsquoambrosia preserva la salma di Patroclo dalla decomposizione Achille convoca unrsquoassemblea dellrsquoesercito e rinuncia alla sua collera Agamennone lamenta di essere stato ldquoaccecatordquo da Zeus e promette doni
Letteratura greca [1]
18
riparatori [T10] Achille si lascia convincere a stento ad attendere che i soldati abbiano mangiato Poi gli armati si radunano e anche Achille si arma Il suo cavallo Xanto gli predice la prossima morte [T11] Canto XX Zeus consente agli degravei di partecipare alla nuova battaglia Enea scontratosi con Achille egrave tratto in salvo da Posidone Achille infuria come un incendio in una selva Canto XXI Achille colma di cadaveri il fiume Scamandro e cattura dodici giovani troiani che intende offrire in sacrificio a Patroclo non risparmia neppure Licaone figlio di Priamo che lo supplica con accenti di grande intensitagrave ma altrettanto intensa nella consapevolezza di un destino imminente egrave la pur spietata replica del Pelide [T12] Lo Scamandro solleva le proprie onde ma le fiamme di Efesto inaridiscono il terreno e domano la corrente Gli degravei si azzuffano Atena raggiunge Ares con una pietra Era rintuzza la furia di Artemide Infine tutti tornano sullrsquoOlimpo Apollo assunto lrsquoaspetto di Agenore respinge Achille percheacute i Troiani possano rifugiarsi allrsquointerno delle mura Canto XXII Il solo Ettore resta fuori nella pianura Invano Priamo ed Ecuba lo pregano di rientrare Mentre Achille si avvicina Ettore decide di affrontarlo ma quando quello gli egrave da presso col bronzo che gli lampeggia intorno laquosimile al raggio del fuoco ardente o del sole che sorgeraquo egrave afferrato dal panico e comincia a fuggire compiendo tre giri intorno alle mura Zeus pesa sulla bilancia i destini (le κῆρες) dei due eroi e quello di Ettore affonda in basso Allora Apollo lo abbandona e Atena apparsa a Ettore sotto le spoglie di suo fratello Deifobo gli si avvicina promettendogli aiuto e invece riporta ad Achille la lancia che gli era caduta fuori bersaglio Il colpo di risposta di Ettore rimbalza sullo scudo di Achille Ettore urla a Deifobo di passargli la sua lancia ma il falso Deifobo egrave scomparso ed Ettore comprende di trovarsi sullrsquoorlo dellrsquoabisso [T13] Achille gli trapassa la gola ed Ettore lo supplica di non oltraggiare la sua salma in risposta riceve la minaccia che finiragrave in pasto ai cani Achille trascina il cadavere alle navi attaccato al carro Priamo Ecuba e Andromaca si abbandonano al cordoglio a cui fanno eco le donne troiane Canto XXIII Viene preparato il banchetto funebre in onore di Patroclo la cui ombra nel corso della notte appare ad Achille chiedendo la sepoltura del corpo Il mattino seguente si appresta il rogo fra le offerte votive ci sono anche dodici giovani troiani Il giorno successivo si raccolgono le ossa di Patroclo Seguono i ludi funebri gare coi carri e con lrsquoarco duello in armi etc Canto XXIV Ogni giorno Achille trascina il cadavere di Ettore attorno alla tomba dellrsquoamico ma lo spettacolo offende gli degravei e al dodicesimo giorno Zeus decide di mandare Tetide percheacute induca suo figlio a restituire la salma di Ettore Iride viene inviata presso Priamo percheacute gli consigli di recarsi nel cuore della notte con un carro da trasporto e un copioso riscatto scortato da Ermes alla tenda di Achille Questi accoglie il vecchio con rispetto riconoscendo in lui lrsquoimmagine del padre lontano e si piega alla sua supplica [T14] Per volontagrave degli degravei il cadavere non egrave stato aggredito dalla putrefazione composto sul pianale del carro viene ricondotto dal padre a Troia Qui le lamentazioni rituali srsquoinnalzano dal gruppo delle donne (Andromaca Ecuba Elena) Si stipula una tregua di dodici giorni Per nove giorni i Troiani raccolgono legname poi anche il rogo di Ettore arde e si erige un tumulo
Letteratura greca [1]
19
Struttura e caratteri dellʼopera Poema di trama relativamente organica (soprattutto a partire dal canto XVI tutti gli avvenimenti tranne pochi episodi isolati ruotano attorno ai due principali antagonisti Ettore uccide Patroclo per vendicare Sarpedone e Achille uccide Ettore per vendicare Patroclo) pur se non privo di piugrave o meno cospicue incongruenze spiegabili in primo luogo con la lunga e complessa genesi orale dellrsquoopera lrsquoIliade lascia emergere in mezzo alle centinaia di nomi e alle intricate vicende alcuni caratteri delineati nella loro individualitagrave e innanzi tutto quelli di Achille e di Ettore accomunati dalla medesima coscienza di un destino di morte che sono pronti ad affrontare Appunto una tale attitudine a rappresentare i laquocaratteriraquo (ἤθη) dei suoi personaggi egrave un altro titolo di merito che Aristotele ascrive ad Omero (Poetica 1460a9-11)
dopo aver brevemente proemiato subito introduce un uomo una donna o un altro personaggio nessuno privo di caratterizzazione ma dotato di un carattere
Fondamentale per la struttura del poema egrave la novitagrave della prospettiva Possiamo presumere che i cosiddetti poemi ciclici22 mirassero a conservare lrsquoangolatura che era stata propria delle versioni pre-omeriche della saga troiana sigrave che puograve riuscire significativo il confronto fra lrsquoesordio della Piccola Iliade (dove muovendo da grandi entitagrave ndash la cittagrave il paese due popoli la guerra ndash viene lanciato secondo lrsquoespressione di J Latacz come laquouno sguardo dallrsquoesternoraquo)
Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην εὔπωλον ἧς πέρι πολλὰ πάθον Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος Canto Ilio e la terra dei Dardani dai bei puledri per la quale molti dolori patirono i Danai servitori di Ares
con lo laquosguardo internoraquo che caratterizza lrsquoinizio dellrsquoIliade
Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν ἡρώων αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν οἰωνοῖσί τε δαῖτα Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς Canta o dea di Achille figlio di Peleo la collera maledetta che pene innumerevoli inflisse agli Achei e molte scagliograve allrsquoAde vite possenti di eroi e ne faceva prede per i cani e pasto per gli uccelli e si avverava il volere di Zeus da quando primamente si separarono venuti a contesa LrsquoAtride sovrano di eroi e Achille magnifico
Argomento non egrave dunque come doveva avvenire nella tradizione del canto epico un evento complesso da inquadrare con un grandangolo onnicomprensivo e neppure come saragrave nellrsquoOdissea un personaggio colto nella multiforme varietagrave delle sue peregrinazioni egrave invece una reazione emotiva (lrsquoira di Achille) con le sue conseguenze (le innumerevoli morti degli Achei) Narrare di questa ira significa per il poeta cominciare da un punto preciso (laquoda quandoraquo) ossia dal momento della contesa e della separazione fra i due massimi eroi greci Agamennone il primo per potere (laquosovrano di eroiraquo) e Achille il primo per nobiltagrave e forza (δῖος) E sintomatica della bipolaritagrave del mondo epico in quanto mondo di degravei e di eroi egrave la sincronia per cui il taglio della narrazione coincide col decorso del laquovolere di Zeusraquo (Διὸς βουλή) forse da identificare con la promessa del dio a Tetide (rievocata piugrave oltre in questo
22 V cap II laquoLa tradizione omericaraquo
Letteratura greca [1]
20
stesso canto ai vv 518-527) di vendicare lrsquoaffronto subito da Achille o piugrave in generale con il corso degli eventi in quanto tutto come per definizione laquogiace sulle ginocchia di Zeusraquo Opera indubbiamente allrsquointerno del poema unrsquoidea formativa un progetto di qui un insieme monumentale unificato anche da una serie di corrispondenze a distanza fra cui particolare significato acquistano quelle fra primo e ultimo canto Nel canto I il vecchio Crise va come supplice presso Agamennone portando doni e supplicando la restituzione della figlia e Agamennone lo respinge aspramente minacciandolo di far ricorso alla violenza se dovesse tornare nel canto XXIV il vecchio Priamo va come supplice presso Achille portando doni e supplicando la restituzione del corpo del figlio Achille ha una prima reazione irosa (esordisce al v 560 con laquoSmetti di irritarmi vecchioraquo) ma poi accoglie la supplica E al di lagrave delle corrispondenze nelle linee dellrsquoazione si colgono fra principio e fine del poema alcuni importanti echi verbali in particolare fra XXIV 501 s
τοῦ νῦν εἵνεχ᾽ ἱκάνω νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενος παρὰ σεῖο φέρω δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα per lui [Ettore] vengo ora alle navi degli Achei per riscattarlo da te e ti porto compenso infinito
e I 12 s
ὁ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενός τε θυγάτρα φέρων δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα costui [Crise] venne alle navi rapide degli Achei per riscattare la figlia portando compenso infinito
fra XXIV 555-557
λῦσον ἵν᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδωmiddot σὺ δὲ δέξαι ἄποινα πολλά τά τοι φέρομενmiddot σὺ δὲ τῶνδrsquo ἀπόναιο καὶ ἔλθοις σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν restituiscimelo percheacute lo possa vedere con gli occhi e accogli il riscatto copioso che portiamo e tu possa goderne e tornare alla tua terra patria
e I 18-20
Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν εὖ δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκέσθαιmiddot παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην τὰ δ᾽ ἄποινα δέχεσθαι Atridi e voi altri Achei dai forti schinieri a voi concedano gli degravei che hanno le case in Olimpo di distruggere la cittagrave di Priamo e tornare facilmente in patria ma restituitemi la figlia e accettate il riscatto
fra XXIV 560 μηκέτι νῦν μ᾽ ἐρέθιζε (laquosmetti di irritarmiraquo) e I 32 μή μ᾽ ἐρέθιζε (laquonon mi irritareraquo) fra XXIV 568-570
τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς μή σε γέρον οὐδrsquo αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω καὶ ἱκέτην περ ἐόντα Διὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμάς Ora perciograve fra i dolori non mi eccitare lrsquoanimo ancora di piugrave bada o vecchio che non ti lasci neppure nella tenda
Letteratura greca [1]
21
bencheacute supplice e violi gli ordini di Zeus e I 26-28
μή σε γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω ἢ νῦν δηθύνοντ᾽ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο Mai te o vecchio io colga presso le concave navi ora a indugiare o piugrave tardi a tornare che piugrave non dovesse giovarti lo scettro e la benda del dio
(e infine XXIV 571 ὣς ἔφατ ἔδεισεν δ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ laquocosigrave diceva e il vecchio tremograve e obbediva alle paroleraquo ripete esattamente I 33) In effetti lrsquoepisodio terminale del poema col superamento dellrsquoira ad opera della pietagrave e del senso di unrsquoesistenza invasa dal dolore si propone come il rovesciamento consapevole dellrsquoepisodio iniziale che era apparso caratterizzato dalla cancellazione della pietagrave e del diritto dei supplici in nome della forza Al rifiuto iniziale del donoriscatto si oppone lrsquoaccettazione finale in consonanza con un principio-guida che opera nel poema secondo linee che alla fine si riunificano Agamennone restituisce Criseide al padre ma si appropria del dono fatto dagli altri Achei ad Achille (Briseide) Achille respinge i doni fatti da Agamennone per indurlo a riconciliarsi con lui ma dopo aver contestato nel IX canto la nozione che la vita umana possa essere barattata con una massa di beni torna alla lotta non in cambio di qualche premio da conquistare ma per vendicare lrsquouccisione dellrsquoamico Patroclo e tanto nella lotta sul campo di battaglia quanto nellrsquoinfierire sul cadavere di Ettore si abbandona a un furore cosigrave smisurato e patologico che puograve essere superato solo con lrsquoaccettare i doni di Priamo non tuttavia per il loro valore drsquouso ma percheacute in Priamo Achille riconosce lrsquoombra del padre lontano Cosigrave lrsquoIliade appare attraversata da un impulso fondamentale che muove dallrsquoideologia del dono e dalla conseguente centralitagrave assegnata allrsquoonore (τιμή) come ldquoprezzordquo che qualifica il valore del guerriero ma supera questo piano di valutazione dei rapporti umani attraverso la loro riformulazione nei termini di un umanesimo esistenziale che ha come punti di riferimento lrsquoidentitagrave universale dei condizionamenti oggettivi (la vecchiaia la malattia la morte) e i legami che uniscono padre e figlio compagno e compagno vivi e morti (il cordoglio finale di Andromaca Ecuba ed Elena sulla salma di Ettore) Entro questo orizzonte progressivamente allargato la guerra le lotte lo scontro mortale finiscono col rappresentare solo un momento e un aspetto dellrsquoesistenza graditi tanto agli degravei che vi assistono come spettatori interessati quanto agli uditori che riascoltano le antiche gesta eppure non tali da appiattire il poema in una prospettiva guerresca conclusa in se stessa Molto del fascino delle battaglie e delle ἀριστεῖαι dellrsquoIliade sta nella presenza recondita di un occhio che sa guardare al di lagrave di esse (e al di lagrave della stessa distinzione fra Greci e Troiani vincitori e vinti) e che puograve anche attraverso le similitudini lasciare irrompere il mondo della natura o del lavoro umano nel mezzo delle battaglie LʼOdissea LrsquoOdissea (Ὀδύσσεια) consta di circa 12100 esametri divisi anchrsquoessi in 24 libri e indicati con le lettere minuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquoargomento egrave costituito dalle avventure di Odisseo dalla distruzione di Troia al ritorno alla patria Itaca esposte secondo un ordine che entrando subito nel vivo degli avvenimenti (lrsquoinizio del poema mostra Odisseo nellrsquoisola di Calipso) rievoca poi i fatti giagrave trascorsi e li ricongiunge infine a partire dal libro XV (con lrsquoarrivo di Telemaco alla capanna di Eumeo dove giagrave si trova Odisseo) in unrsquoazione unitaria La trama del poema i cui avvenimenti sono concentrati cronologicamente nello spazio di 40 giorni (ma sono narrati solo gli avvenimenti di 16 giorni e 8 notti) si articola in tre parti la laquoTelemachiaraquo (canti I-IV) il laquoRitorno di Odisseoraquo (canti V-XIII) e la laquoVendetta di Odisseoraquo (canti XIV-XXIV)
Letteratura greca [1]
22
Canto I Tutti gli eroi superstiti sono ormai tornati da Troia alle loro case tranne Odisseo che pur desideroso di tornare egrave trattenuto dalla ninfa Calipso nellrsquoisola di Ogigia Gli degravei hanno pietagrave di lui tranne Posidone irato per lrsquoaccecamento del figlio il ciclope Polifemo Ma un consiglio degli degravei assente Posidone (che si egrave recato presso gli Etiopi) delibera il ritorno dellrsquoeroe si decide che Ermes andragrave subito da Calipso mentre Atena si avvia verso Itaca sotto lrsquoaspetto del signore dei Tafi Mente per incoraggiare il figlio di Odisseo Telemaco a tener testa ai pretendenti della madre i laquoprociraquo (i quali aspirano al regno tramite le nozze con Penelope) e per indurlo a intraprendere un viaggio in cerca di notizie sul padre Canto IΙ Telemaco segue il consiglio della dea e il giorno seguente nellrsquoassemblea popolare chiede una nave per andare in cerca del padre ma la sua richiesta non viene discussa e Leocrito scioglie lrsquoassemblea Grazie ad Atena che ora ha assunto le sembianze di Mentore (antico amico di Odisseo) Telemaco riesce tuttavia a trovare una nave con cui salpa nel corso della notte allrsquoinsaputa sia della madre che dei proci Canto IΙΙ Telemaco e MentoreAtena arrivano a Pilo e sul lido trovano Nestore che sta offrendo un sacrificio a Posidone Il vecchio eroe accoglie ospitalmente Telemaco e gli comunica molte notizie sul ritorno di altri Achei ma nessuna su Odisseo Alla sera Atena scompare in forma di aquila e il mattino seguente Telemaco salpa insieme con Pisistrato (figlio di Nestore) alla volta di Sparta dove arriva la sera del giorno successivo Canto IV A Sparta Menelao sta festeggiando il doppio matrimonio del figlio e della figlia Il giorno seguente Telemaco chiede del padre Menelao gli racconta il proprio ritorno durante il quale aveva incontrato Proteo il vecchio nume marino che gli aveva riferito come Odisseo fosse trattenuto nellrsquoisola di Calipso Intanto a Itaca i proci preparano insidie meditando di uccidere Telemaco al suo ritorno Penelope ne viene a conoscenza ma Atena le appare in sogno per confortarla Canto V Dopo un secondo concilio degli degravei (in effetti un ldquodoppionerdquo di quello del I canto) Zeus manda finalmente Ermes presso Calipso con lrsquoordine di lasciar partire Odisseo La ninfa aiuta lrsquoeroe a costruirsi una zattera Al diciottesimo giorno di navigazione Odisseo egrave in vista dellrsquoisola dei Feaci Scheria quando Posidone di ritorno dal suo soggiorno presso gli Etiopi lo vede e suscita una tempesta che distrugge la zattera Ma la dea marina Ino Leucotea impietositasi gli porge il proprio velo sostenuto dal quale lrsquoeroe giunge a nuoto alla riva di Scheria dove si abbandona esausto addormentandosi Canto VI In seguito a un sogno inviatole da Atena Nausicaa la figlia del re dei Feaci Alcinoo si reca nei pressi della spiaggia a lavare le vesti insieme con le ancelle Odisseo risvegliatosi atterrisce le fanciulle che fuggono tutte allrsquoinfuori di Nausicaa Lrsquoeroe supplica la giovane di porgerle aiuto ed ella lo fa rivestire e lo accompagna fino al bosco di Atena poco prima della cittagrave esortandolo a presentarsi a suo padre Canto VII Protetto dalla nebbia di cui Atena lo ha avvolto Odisseo entra nel palazzo abbraccia le ginocchia della regina Arete e la caligine scompare poi viene accolto con onore da Alcinoo Arete chiede a Odisseo donde provenga e chi gli abbia donato gli abiti (a lei ben noti) che indossa Lrsquoeroe inizia a raccontare le disavventure che gli sono occorse dopo la
Letteratura greca [1]
23
partenza dallrsquoisola di Calipso Alcinoo gli promette di farlo ricondurre a Itaca il giorno seguente Canto VIII Ma lrsquoindomani Alcinoo fa apprestare un banchetto durante il quale lrsquoaedo Demodoco canta della contesa insorta un giorno fra Achille e Odisseo Lrsquoeroe si copre il volto per nascondere le lacrime allora Alcinoo interrompe il canto e organizza una serie di gare nel corso delle quali Odisseo primeggia Poi Demodoco al margine di unrsquoarea per la danza dove si esibiscono i ballerini feaci canta gli amori di Ares e Afrodite e la vendetta di Efesto (che incatena i due amanti) La sera al ritorno nel palazzo Demodoco racconta la storia del Cavallo di legno Odisseo scoppia nuovamente in lacrime e Alcinoo gli chiede di rivelare il suo nome Canto IX Odisseo dichiara il proprio nome e dagrave inizio al racconto della propria storia a partire dalla caduta di Troia distruzione di Ismaro e perdite subite ad opera dei Ciconi sbarco presso i Lotofagi (che si nutrono di un cibo misterioso che fa dimenticare il ritorno) dopo una terribile tempesta scatenatasi durante il tentativo di doppiare il capo Malea arrivo allrsquoisola antistante quella dei Ciclopi dove Odisseo si trasferisce con una sola nave esplorazione dellrsquoisola perdita di alcuni compagni allrsquointerno della caverna del gigante monocolo accecamento del mostro e fuga Canto X Odisseo giunge allrsquoisola di Eolo signore dei venti che lo accoglie benevolmente e gli consegna alla partenza tutti i venti chiusi in un otre ma poi lo respinge con durezza quando ritorna presso di lui percheacute i compagni (sospettando che nellrsquootre siano racchiuse cospicue ricchezze) hanno sciolto i venti e da essi si egrave sprigionato un uragano che li ha risospinti sullrsquoisola Ripreso il mare Odisseo egrave trasportato fino ai Lestrigoni antropofagi il cui attacco priva lrsquoeroe di tutte le altre navi tranne la propria Con questa fugge fino allrsquoisola (Eea) della maga Circe Dopo che Circe ha trasformato in porci un gruppo di compagni mandati innanzi ad esplorare lrsquoisola Odisseo ha la meglio sulla maga (a cui impone di restituire forma umana ai compagni) grazie allrsquoerba moly fornitagli da Ermes Resta un anno presso Circe che al momento della partenza gli consiglia di recarsi al paese dei morti per interrogare il vate Tiresia Canto XI Approdato alla terra dei Cimmeri (che vivono immersi in una nebbia perenne sulla riva dellrsquoOceano) e scavata una fossa Odisseo sacrifica ai morti e immola una vittima speciale a Tiresia Le anime accorrono dapprima Elpenore caduto per caso giugrave dal tetto della casa di Circe (Odisseo gli promette sepoltura) poi la madre Anticlea (che gli racconta di esser morta di dolore per la sua assenza) quindi Tiresia che gli vaticina le sue vicende future fino alla morte (questa lo coglieragrave dopo una lunga vita in un paese straniero che non conosce neacute il sale neacute il remo) Da un certo punto in poi il poeta dimentica il presupposto per cui Odisseo aveva scavato una fossa alla quale i morti accorrevano per bere il sangue delle vittime e bevendolo riacquistavano per breve tempo una piena consapevolezza immagina invece che Odisseo sia allrsquointerno dellrsquoAde In questa sezione rientrano la descrizione di Aiace sdegnato di Minosse di Orione dei grandi peccatori di Eracle Poi Odisseo fa ritorno a Eea e ricevuti i consigli di Circe si imbarca per il ritorno in patria Canto XII Scampato alle Sirene che invano lo attirano col canto (si egrave fatto legare allrsquoalbero della nave i compagni che remano hanno le orecchie turate con la cera) passa tra Cariddi e Scilla (che gli rapisce sei uomini) ed egrave costretto dai compagni ad approdare in contrasto con le prescrizioni di Circe allrsquoisola Trinachia dove pascolano le greggi del Sole I
Letteratura greca [1]
24
compagni spronati da Euriloco se ne cibano nonostante il divieto dellrsquoeroe Il Sole sdegnato ottiene da Zeus che la nave sia colpita dal fulmine Tutti i compagni periscono ma Odisseo che ripassa tra Scilla e Cariddi si salva miracolosamente da questrsquoultima aggrappandosi a un fico selvatico fincheacute il gorgo restituisce i rottami della nave infine arriva remando con le mani allrsquoisola di Ogigia Canto XIII Terminato il racconto lrsquoeroe riceve doni dai Feaci e la notte seguente egrave ricondotto a Itaca e deposto addormentato sulla spiaggia presso un antro sacro alle Ninfe Al risveglio per la nebbia non riconosce la sua terra fincheacute Atena in veste di giovane pastore lo rassicura e poi rivelatasi gli dagrave istruzioni su come far strage dei proci e lo trasforma in un vecchio mendico Canto XIV Odisseo si reca allo stazzo del suo porcaio Eumeo che pur non riconoscendolo lo accoglie ospitalmente rifocillandolo e offrendogli un mantello per ripararsi dal gelo notturno Canto XV A questo punto la laquoTelemachiaraquo si riannoda allrsquoazione principale Telemaco che si trova ancora a Sparta viene indotto da Atena a tornare a Itaca sulla via del ritorno a Pilo accoglie a bordo lrsquoindovino Teoclimeno e grazie allrsquoaiuto della dea sfugge alle insidie dei proci sbarca a Itaca e si reca anchrsquoegli presso Eumeo Canto XVI Questi va da Penelope ad annunciargli il ritorno del figlio Intanto Odisseo rimosso lrsquoincantesimo si svela nel suo vero aspetto a Telemaco e con lui progetta la vendetta sui proci (che intanto tramano una nuova insidia ai danni di Telemaco) Eumeo torna al suo stazzo Canto XVII Il mattino seguente Telemaco si reca in cittagrave seguito in un secondo tempo da Eumeo e Odisseo (che ha riassunto lrsquoaspetto di mendico) Davanti al palazzo Odisseo egrave riconosciuto dal cane Argo Entra e va mendicando tra i proci Antinoo lo colpisce alla spalla destra con uno sgabello Canto XVIII Odisseo si batte al pugilato col mendicante Iro Penelope scesa nella sala prospetta ai proci lrsquoeventualitagrave di un nuovo matrimonio Odisseo egrave insultato dalla schiava Melanto e schiva uno sgabello scagliato da Eurinomo Canto XIX Insieme con Telemaco lrsquoeroe allontana le armi dalla sala poi conversa con Penelope che gli racconta un sogno e gli espone il suo piano per sedare le contese tra i proci concedendosi sposa a colui che riusciragrave a tendere lrsquoarco di Odisseo la prova avverragrave il giorno seguente al novilunio Durante il colloquio la fida schiava Euriclea lava i piedi di Odisseo e riconosciutolo da unrsquoantica cicatrice sta per rivelarne lrsquoidentitagrave ma lrsquoeroe la costringe a tacere Canto XX Al mattino Euriclea e le ancelle fanno i preparativi per il banchetto Giungono Eumeo Melanzio e il mandriano Filezio Un presagio mandato da Zeus dissuade i proci dal progetto di uccidere Telemaco Durante il banchetto Teoclimeno predice la loro imminente rovina
Letteratura greca [1]
25
Canto XXI Penelope conduce lrsquoarco nella sala dopo che parecchi fra i proci e lo stesso Telemaco hanno tentato invano di tenderne la corda Odisseo chiede di partecipare alla prova tende lrsquoarco senza fatica e riesce a far passare la freccia attraverso gli anelli di dodici scuri predisposte da Telemaco Canto XXII Poi scaglia le frecce sui proci e si rivela nella sua identitagrave Nella lotta che segue Telemaco Eumeo e Filezio aiutano il padrone contro i proci (appoggiati dal capraio Melanzio) Tutti i proci restano uccisi le ancelle infedeli sono impiccate Melanzio viene mutilato e ucciso soltanto lrsquoaedo Femio e lrsquoaraldo Medonte sono risparmiati Canto XXIII Nuovo colloquio fra Odisseo e Penelope che durante lrsquoeccidio dormiva ed egrave stata svegliata da Euriclea Penelope esita ancora a riconoscere il marito e non si arrende alla veritagrave fincheacute Odisseo non le descrive la posizione e la struttura del letto coniugale Canto XXIV Ermes conduce allrsquoAde le ombre dei proci Odisseo fa visita al padre Laerte nella masseria dove quello vive nello squallore e nellrsquoemarginazione e si fa riconoscere Intanto il padre di Antinoo incita gli Itacesi alla rivolta e il poema si conclude con lo scontro di Odisseo e dei suoi contro i concittadini lrsquoeroe ha la meglio e Zeus scagliato il fulmine pone fine alla battaglia Atena sotto lrsquoaspetto di Mentore stabilisce fra i contendenti un patto per il futuro36
Struttura e caratteri dellʼopera Giagrave la prima parola del proemio (ἄνδρα) non menziona come tema dellrsquoopera un determinato episodio della vita del protagonista ma il protagonista stesso (I 1-10)
Ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα πολύτροπον ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεmiddot πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περmiddot αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο νήπιοι οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιονmiddot αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ τῶν ἁμόθεν γε θεά θύγατερ Διός εἰπὲ καὶ ἡμῖν Dellrsquouomo multiforme a me racconta o Musa che molto errograve dopo che di Troia la sacra rocca distrusse di molti uomini vide le cittagrave riconobbe il pensiero e molti per il mare patigrave dolori nellrsquoanimo per salvare la sua vita e il ritorno dei compagni Eppure non li salvograve i compagni per quanto bramasse per la loro stessa follia si persero gli stolti i buoi del Sole Iperione mangiarono e quello rapigrave ad essi il digrave del ritorno Di questo da un punto qualsiasi narra anche a noi o dea figlia di Zeus
Storie favolose di naviganti racconti imperniati sul ritorno dei guerrieri achei che avevano combattuto a Troia e il particolare rientro in patria di Odisseo figlio di Laerte erano forse giagrave stati connessi e intrecciati nella precedente tradizione epica sigrave che il presente cantore poteva
Letteratura greca [1]
26
metter mano alla vicenda partendo (v 10) laquoda un punto qualsiasiraquo (ἁμόθεν) una notazione che certo presuppone la convenzione propria dellrsquoesordio tradizionale di un canto epico comparabile con i giagrave ricordati ἐξ οὗ (laquoda quandoraquo) di Iliade I 4 ed ἔνθεν (laquoda doveraquo) di Odissea VIII 500 Senoncheacute rispetto a queste indicazioni di tipo puntuale il tratto costituito dalla dimensione casuale quasi arbitraria inerente ad ἁμόθεν proprio mentre dichiara lrsquoassenza di un determinato piano compositivo implica in realtagrave che il racconto non si svolgeragrave per filo e per segno secondo lrsquoordine noto a poeta e uditori non si snoderagrave κατὰ κόσμον (laquoper ordineraquo) come il canto di Demodoco (VIII 489) ma seguiragrave un andamento originale Il ldquopunto qualsiasirdquo incipitario non rappresenta una scelta della Musa (figura dellrsquoarchivio tematico che conserva le laquovieraquo dellrsquoepica) bensigrave di questo cantore che ha deciso di far incominciare la narrazione in medias res e ha in serbo la sorpresa di far succedere al concilio degli degravei (che decide lrsquoinvio di Ermes presso Calipso) non lrsquoazione testeacute programmata (azione che viene differita con un ritardo che a piugrave riprese ha scandalizzato i lettori a principio del V canto) ma la partenza di Atena alla volta di Itaca e lrsquoavvio della laquoTelemachiaraquo Le due diverse vicende proposte a principio del poema quella di Telemaco e quella di Odisseo procedono infatti in parallelo coprendo un analogo lasso di tempo Piugrave oltre la decisione di trasformare la sequenza narrativa che va dalla partenza di Odisseo da Troia fino al suo arrivo nella terra dei Feaci in una rievocazione fatta dallrsquoeroe in prima persona al cospetto di Alcinoo e dei Feaci (la sezione detta degli ἀπόλογοι laquoraccontiraquo) crea una struttura ad anello che parte dal presente e ad esso fa ritorno dopo aver ricostruito le premesse della condizione attuale del protagonista Col canto XIII Odisseo egrave riportato dai Feaci a Itaca e questo permette la saldatura fra le vicende sue e quelle di Telemaco sia pure col differimento dellrsquoincontro e del riconoscimento fra padre e figlio fino al canto XVI Far scorrere in parallelo sequenze distinte organizzare programmi narrativi a corta e a lunga gittata tendere o allentare ad arte il ritmo della narrazione non si tratta davvero di procedimenti che potessero configurarsi come tradizionali dellrsquoarte epica quanto piuttosto di un momento sperimentale di una ricerca di soluzioni nuove al termine di una lunga e ormai consolidata sedimentazione di percorsi compiuti allrsquointerno di un determinato repertorio tematico unrsquoaudacia inventiva una πολυτροπίη degne del protagonista del poema che inevitabilmente comportavano rischi molteplici di incoerenze dissonanze occasionali avarie della macchina epica e che tuttavia erano destinate a conseguire un risultato assolutamente convincente allrsquoorecchio di chi si abbandonasse al fascino del racconto senza lrsquourgenza propria di altre etagrave e di altre mentalitagrave di puntare il dito sui singoli dettagli o le singole sfasature
PER SAPERNE DI PIUrsquo Difficoltagrave e incongruenze della narrazione omerica Forti della possibilitagrave di un controllo su un testo scritto che possiamo percorrere in avanti e a ritroso secondo ritmi di nostra scelta a noi non riesce difficile cogliere alcune delle difficoltagrave organizzative incontrate nella composizione del poema In proposito per ricordare un caso che saragrave allrsquoorigine delle discussioni di orientamento ldquoanaliticordquo intorno allrsquoOdissea possiamo leggere il discorso che Atena prese le sembianze di Mente re dei Tafi rivolge a Telemaco nel I canto (vv 253-305) Ah infelice ti manca molto davvero lrsquoassente Odisseo che getti le mani addosso ai pretendenti sfrontati Percheacute se ora tornato stesse sulla soglia 255 con una scure lo scudo e due lance cosigrave come io per la prima volta lo vidi in casa nostra che beveva e godeva di ritorno da Efira da Ilo di Mermero (andograve anche ligrave Odisseo con la nave veloce 260 in cerca del veleno omicida per averne da ungere le frecce di bronzo ma quello non glielo diede percheacute temeva gli dei che vivono eterni
Letteratura greca [1]
27
glielo diede invece mio padre percheacute lrsquoamava moltissimo) se stesse Odisseo tra i pretendenti cosigrave 265 essi avrebbero tutti rapida morte e nozze amare Ma sulle ginocchia degli dei questo giace se una volta tornato faragrave o no vendetta nella sua casa te invece io esorto a riflettere come cacciare i pretendenti da casa 270 Ebbene ora ascolta e alle mie parole darsquo retta Domattina chiamati gli eroi Achei a consiglio rivolgi a tutti un discorso e siano testimoni gli dei Ai pretendenti comanda drsquoandarsene per i fatti loro e tua madre se lrsquoanimo la spinge alle nozze 275 ritorni a casa del padre molto potente Prepareranno essi le nozze e disporranno i doni nuziali moltissimi quanti gli pare che debbano andare alla figlia A te darograve un saggio consiglio se vuoi ascoltarlo armata una nave con venti remi la migliore che crsquoegrave 280 Varsquo a domandare del padre partito da tempo se mai te ne parli un mortale o sentissi da Zeus la voce che divulga la fama tra gli uomini Anzitutto varsquo a Pilo e interroga il chiaro Nestore di ligrave poi varsquo a Sparta dal biondo Menelao 285 degli Achei vestiti di bronzo egli egrave tornato per ultimo Se senti dire qualcosa sulla vita e il ritorno del padre per quanto stremato potresti sopportare un altro anno se invece senti dire che egrave morto e non vive allora tornato nella cara terra patria 290 ergigli un tumulo e offrigli funebri offerte moltissime quanto conviene e darsquo tua madre a un marito E poi dopo aver compiuto e fatto ogni cosa allora medita nella mente e nellrsquoanimo come tu possa uccidere nelle tue case 295 i pretendenti con lrsquoinganno affrontandoli non devi piugrave avere i modi di un bimbo percheacute ormai non sei tale Non senti lrsquoillustre Oreste quale gloria ha acquistato fra tutti gli uomini percheacute uccise lrsquoassassino del padre Egisto esperto di inganni che gli uccise il nobile padre 300 Anche tu caro infatti molto bello e grande ti vedo sii valoroso percheacute ti lodi anche qualcuno dei posteri Ma io tornerograve adesso alla nave veloce dai compagni che forse impazienti mi aspettano Tu devi pensarci da te dammi retta 305
[Tr di GA Privitera] Le stranezze non mancano davvero e cosigrave sono state messe a fuoco da Stephanie West nel suo commento23 1 Atena sa evidentemente molto piugrave di quanto uno come Mente avrebbe potuto sapere in particolare ella sa che i proci ignoreranno lrsquoinvito di Telemaco a lasciare la sua casa e fatto piugrave importante che gli degravei tra breve ricondurranno in patria Odisseo A queste osservazioni si puograve replicare con la stessa West che laquosi sono esagerate difficoltagrave e
23 Omero Odissea I cit 219 ss
Letteratura greca [1]
28
incongruenze alle quali un pubblico di ascoltatori (o anche un lettore moderatamente attento) probabilmente non farebbe casoraquo 2 Il progetto di una pubblica denuncia dei proci dinanzi agli degravei e agli uomini ai vv 273-274 egrave ciograve che Atena sembra prefiggersi nel promuovere lrsquoassemblea degli Itacesi (assemblea che effettivamente avragrave luogo a principio del canto II) drsquoaltra parte le successive istruzioni di AtenaMente ai vv 295 s (medita come uccidere i pretendenti) presuppongono che di quella richiesta da formulare nel corso dellrsquoassembla essi non terranno alcun conto Anche a questa osservazione si puograve rispondere che laquoegrave ragionevole attendersi che Telemaco condivida la previsione di un esito negativo della sua iniziativaraquo e si puograve aggiungere che pure in caso di insuccesso il ricorso allrsquoassemblea potrebbe ottenere almeno il risultato di screditare i pretendenti presso la comunitagrave itacese legittimando un successivo ricorso alla violenza (e si tratta di una legittimazione di cui anche lrsquoultimo canto mostreragrave lrsquoesigenza) 3 Dopo che Telemaco aveva detto che la madre non intendeva risposarsi (vv 249-250) AtenaMente si esprime ai vv 275-278 come se Penelope desiderasse proprio nuove nozze e inoltre sarebbe assurdo che il padre di Penelope cominciasse a contrattare un secondo matrimonio prima del ritorno di Telemaco dal suo viaggio e che mettesse mano a preparativi che rischierebbero di essere annullati qualche tempo dopo con inevitabile imbarazzo se Telemaco venisse a sapere che Odisseo egrave ancora vivo In piugrave lrsquoandamento sintattico di questi versi presenta un anacoluto durissimo per cui a principio del v 275 lrsquoaccusativo μητέρα egrave seguito da un ἂψ ἴτω (laquovada indietroraquo laquotorniraquo) che richiederebbe come soggetto un nominativo μήτηρ Come hanno reagito i lettori di Omero Nellrsquoantichitagrave un grammatico rimasto anonimo cambiava come attesta uno scolio μητέρ᾽ in μήτηρ nel secolo XVIII Richard Bentley modificava ἴτω in ἴμεν (infinito eolico di εἶμι laquovadoraquo) nel XIX un altro grande della filologia europea Gottfried Hermann risolveva piugrave drasticamente la questione eliminando il complesso dei vv 275-278 e la stessa West mostra simpatia per tale proposta supponendo laquounrsquoaggiunta posteriore modellata sul corrispondente passo del libro IIraquo (dove i vv 196 s sono identici ai vv 277 s e il v 195 copre lo stesso contenuto dei vv 275 s) Si tratta di procedimenti adeguati ai dati di fatto Migliorano davvero il testo che ci egrave stato tramandato In realtagrave ambedue le ldquocorrezionirdquo appena ricordate (di μήτερ᾽ e di ἴτω) ottengono un risultato tanto lineare che egrave davvero difficile pensare che lrsquoanacoluto avrebbe potuto invadere tutta la tradizione se non fosse stato originario e quanto allrsquoespunzione dei vv 275-278 essa indubbiamente peggiorerebbe il ritmo del discorso determinando lrsquoavvicinamento fra i due versi (v 271 e v 279) molto simili fra loro che aprono le due sequenze occupate dai consigli di Mente E allora La via piugrave saggia egrave senzrsquoaltro quella di tenerci qui come quasi sempre di fronte al testo omerico contraddizioni e anacoluti riconoscendo in essi lrsquoeffetto dellrsquoattivitagrave di un cantore che pur sulla base di una traccia largamente memorizzata restava pur sempre legato a quella prassi orale per cui composizione ed esecuzione tendevano a coincidere E lrsquoanacoluto si spiega bene se cerchiamo di immedesimarci nel procedimento seguito dal poeta Egli ha affidato ad Atena un certo flusso argomentativo per cui la dea deve dar consigli a Telemaco sui suoi rapporti coi proci e con la madre e cosigrave colloca in fine di v 274 un ἄνωχθι (laquoordinaraquo) destinato a reggere gli accusativi simmetricamente dislocati in principio di verso (vv 274 e 275) μνηστῆρας e μητέρα Senoncheacute giunto a questa seconda parte dellrsquoargomentazione egli si avvede quanto sarebbe illogico che Telemaco sollecitasse la madre a nuove nozze di qui lrsquoimprovviso cambio di costruzione che svincola al prezzo di una sensibile slogatura sintattica lrsquoipotesi delle nuove nozze dallrsquoordine impartito a Telemaco e la prospetta invece come un desiderio eventuale della stessa Penelope Il poeta ha un progetto ben meditato brani e sequenze piugrave volte sperimentati ed egrave col supporto di questi materiali giagrave elaborati che egli si fa strada attraverso le insidie della
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
10
della cittagrave (Troia VIIb) Verso il 700 il luogo chiamato laquoIlioraquo era largamente in rovine anche se in etagrave arcaica dovette continuare a essere frequentato come luogo di culto Il problema che si dovettero porre nellrsquoVIII secolo aC lsquoOmerorsquo o i suoi modelli dovette essere quello di rendere il racconto della guerra di Troia plausibile a un pubblico che aveva familiaritagrave con la geografia locale (lrsquoIliade offre indicazioni realistiche ad es sulla navigazione dellrsquoEgeo in IX 362 s e sulla visibilitagrave dellrsquoisola di Samotracia dalla piana di Troia in XIII 11-14) che si trattasse di genti che risiedevano nel Sigeo o in altre cittagrave vicine o di abitanti della stessa Ilion che nellrsquoVIII secolo era di nuovo attiva sia pure soltanto come centro cultuale Il santuario sorgeva allrsquointerno di una depressione naturale a sud-ovest della rocca lungo la vecchia via che conduceva alla rocca stessa Omero menziona due templi quello di Apollo e quello di Atena e le loro loro rovine sono tuttora riconoscibili I visitatori che giungevano al santuario dal Sigeo attraverso la piana dello Scamandro potevano vedere le rovine della rocca Ma - ci si chiede - quando ebbe fine il nucleo della cittagrave di Troia cantata da Omero Nel bastione a nord-est della rocca egrave stata trovata una larga e profonda cisterna con un condotto che proviene da una sorgente La sorgente fu abbandonata al piugrave tardi al tempo di Troia VIIb2 prima del 1100 A partire dal 1000950 non rimase a Troia alcun insediamento significativo Troia era molto piugrave larga di quanto ritenesse Schliemann Un fossato largo 3 m e profondo 15 completato durante lrsquoultima fase di Troia VI o al principio di Troia VIIa (cioegrave intorno al 1300) la circondava Poi esso fu rimpiazzato a sud da un fossato piugrave ampio e concentrico al primo completato verso il 1200 Il sistema di fortificazione si estendeva per quasi 2 km e pertanto racchiudeva unrsquoarea di circa 270000 m2 La rocca e la cittagrave bassa dovevano presentarsi al tempo di Omero come un imponente complesso di rovine I nuovi colonizzatori del Sigeo e di altri siti incontrarono un vasto campo attraversato da sentieri che seguivano i vecchi tracciati Negli scavi fatti nei quartieri della cittagrave bassa a sud-ovest della rocca poco fuori del muro si egrave scoperto un deposito bruciato verso la fine di Troia VI e di nuovo verso la fine di Troia VIIa (verso il 1200) La prima devastazione egrave da ricollegarsi a un terremoto ma la seconda sembra dovuta a unrsquoazione di guerra come suggerisce anche il rinvenimento di corpi insepolti o semisepolti e di depositi contenenti armi non utilizzate Verso il 1300 la porta principale di Troia era stata bloccata e ostruita percheacute qui lrsquoantico muro era in condizioni precarie e pertanto rappresentava lrsquoanello piugrave vulnerabile nel sistema di difesa Giagrave W Doumlrpfeld aveva richiamato Iliade VI 433 s (Andromaca a Ettore)
Piazza lrsquoesercito presso il fico selvatico dove egrave piugrave facile Lrsquoaccesso alla cittagrave e il superamento delle mura
In questa zona solo poco piugrave di 80 m separavano il muro della cittagrave bassa dal muro della rocca Gli epiteti omerici di Troia - laquoben costruitaraquo laquofertileraquo laquovastaraquo laquosacraraquo laquoertaraquo laquoventosaraquo laquodalle belle muraraquo laquodai bel puledriraquo - si adattano ai dati topografici ossa di cavalli sono state trovate sul terreno forti venti soffiano continuamente in estate Anche le sorgenti sono identificabili presso la porta principale cfr Iliade XXII 145-157
Passarono oltre il posto di vedetta e lrsquoalbero di fico battuto dal vento e allontanandosi sempre piugrave dalle mura si lanciarono lungo la strada Giunsero alle fontane dalle belle acque dove sgorgano due correnti dello Scamandro impetuoso una di acqua calda da cui si leva un vapore come da fuoco ardente lrsquoaltra che in piena estate versa acqua gelata come la grandine la fredda neve o il ghiaccio Vi sono accanto dei lavatoi di pietra larghi belli dove le mogli e le belle figlie dei Teucri lavavano le splendide vesti prima in tempo di pace prima che giungessero i figli dei Danai
[Tr di MG Ciani] In effetti gli scavi nellrsquoarea della caverna in cui egrave situata la sorgente hanno portato alla luce una struttura simile a una miniera con tre gallerie e altri bracci tributari creata per fornire acqua Lrsquoacqua scorreva attraverso una superficie rocciosa e poi in un canale artificiale che a sua volta raggiungeva un sistema di quattro lsquodepressionirsquo o lsquofossersquo circolari scavate nella roccia della
Letteratura greca [1]
11
misura di quasi 1 m di diametro (appunto parrebbe i πλυνοί hellip λαΐνεοι i laquolavatoi di pietraraquo ricordati da Omero) Achei e Troiani Fra XIII e XII secolo aC Troia era un grande centro politico e commerciale in grado di controllare lrsquoaccesso ai Dardanelli (lrsquoantico Ellesponto) e il trasporto su terra di beni di vario genere dalla costa egea al Mar di Marmara (lrsquoantica Propontide) e al Mar Nero In Troia VIIa egrave stata rinvenuta ceramica micenea del periodo noto come Tardo Elladico IIIB che egrave anche il periodo di maggiore splendore dei palazzi micenei sul continente greco Ersquo suggestiva lrsquoidentificazione piugrave volte avanzata in tempi recenti di TroiaIlio con Wilusa la cittagrave menzionata spesso in testi hittiti e oggetto di contesa fra gli Hittiti e quegli Ahhiyawa il cui nome sembra identificarsi con quello degli laquoAcheiraquo (Ἀχαιοί) Il documento piugrave significativo in proposito egrave il preambolo del trattato stipulato verso il 1280 aC fra il re hittita Muwattali II e Alaksandu re di Wilusa che contiene un richiamo alle precedenti relazioni fra i due stati a partire dal 1600 pur ricordando che un tempo Wilusa era sotto il dominio hittita Muwatalli afferma di aver mantenuto relazioni pacifiche anche dopo che la cittagrave era divenuta indipendente Inoltre un testo religioso hittita rinvenuto a Hattusa la capitale dellrsquoimpero hittita e databile al XIII secolo ricorda nellrsquoambito di un rituale la recita di un poema in luvio (il luvio egrave una lingua indo-europea che si distingue solo superficialmente dallrsquohittita) di cui viene riportato il primo verso laquoQuando tornarono dallrsquoerta Wilusaraquo E a Troia negli scavi piugrave recenti egrave stato trovato un sigillo con unrsquoiscrizione in luvio Drsquoaltra parte in Omero la dinastia reale troiana di cui egrave a capo Priamo figlio di Laomedonte viene fatta risalire attraverso Erittonio Troo e Ilo fino a Dardano eponimo dei Dardani che si erano stanziati nella Troade a nord del monte Ida (Iliade ΧΧ 215 ss) I Dardani nellrsquoIliade compaiono fra i principali alleati dei Troiani accanto ai contingenti provenienti da Zelea (a nord-est lungo il fiume Esepo) e a quelli di localitagrave situate sulla Propontide come Adrestea e Pitea e sulla costa asiatica dellrsquoEllesponto come Abido e Arisbe Dalla costa europea arrivano invece i Traci i Ciconi e i Peoni da oriente i Paflagoni e gli Alizoni da sud-est i Misi e i Frigi dalla zona sud-occidentale dellrsquoAnatolia i Meoni i Cari e i Lici Se Dardani Peoni Ciconi e Traci fanno parte delle popolazioni traco-frigie che fra XII e XI secolo erano scese dai Balcani in direzione dellrsquoAnatolia (cfr Erodoto 7 73 e Xanto di Lidia FGrHist 765 F 14) i Meoni sono di stirpe lidia mentre i Cari e i Lici appartengono allrsquoambito culturale e linguistico luvio-hittita Comunque sia diversamente che per Erodoto il quale inserisce il rapimento di Elena nel quadro di una serie di torti reciproci in forma di rapimenti di donne fra Greci e barbari (I 2 1) e per i poeti tragici ateniesi del V secolo aC in Omero lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato come un contrasto fra culture diverse I Troiani mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei (detti anche laquoDanairaquo - cioegrave discendenti di Danao - o laquoArgiviraquo in relazione al contingente proveniente dallrsquoArgolide guidato da Agamennone il capo della spedizione) e lo stesso vale per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari in Iliade ΙΙ 867 come laquodi lingua stranieraraquo (βαρβαρόφωνοι) suggerisce che un tale epiteto non sarebbe stato applicabile ai Troiani Infine sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di unrsquoimbarcazione sono altrettanti esempi di quelle che W Arend denominograve laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini comportamentali e tecnologiche del gruppo che le condivide (vedi scheda p xxx) La societagrave omerica
Letteratura greca [1]
12
Nel rapporto fra il mondo omerico e la storia egrave innanzi tutto da sottolineare lrsquoesistenza di un duplice piano di riferimento con talune interferenze dellrsquouno nellrsquoaltro da un lato crsquoegrave lrsquoorizzonte dei fatti collocati in un passato glorioso dallrsquoaltro lrsquoorizzonte del poeta Giagrave gli studiosi alessandrini del resto notavano che dati come lrsquoarte di montare a cavallo i segnali per mezzo della tromba e lrsquouso di bollire la carne compaiono nellrsquoIliade solo allrsquointerno delle similitudini E il testo con una sorta di arcaismo intenzionale mostra talora la consapevolezza dellrsquoabisso che separa passato e presente come quando in Iliade XII 445-449 si dice
Ettore intanto un sasso afferrograve ndash e lo portava ndash che prima stava davanti alle porte largo di sotto ma sopra era a punta questo due uomini i piugrave forti del popolo difficilmente isserebbero da terra su un carro quali son ora i mortali egli da solo lo roteava a suo agio
[Tr di R Calzecchi Onesti] Per contro le condizioni sociali rappresentate nei poemi (un mondo di grandi proprietari terrieri che reggono aziende agricole autarchiche da cui hanno preso tuttavia a distaccarsi alcune figure di artigiani il fabbro il vasaio il carpentiere il medico lrsquoindovino lrsquoaedo) rispecchiano assai piugrave la situazione storica fra VIII e VII secolo a C che le strutture della societagrave micenea Inoltre i cadaveri vengono cremati secondo la prassi piugrave recente non inumati anche se molti riferimenti omerici non rispecchiano necessariamente la pratica normale del tempo di pace trattandosi di cremazioni che avvengono oltremare non ambigua egrave comunque la testimonianza relativa alla prassi umana in generale fornita da Odissea XI 216-222 (Anticlea a Odisseo)
Ohimegrave figlio mio il piugrave misero di tutti gli uomini Persefone la figlia di Zeus non ti inganna ma la legge degli uomini egrave questa quando si muore i nervi non reggono piugrave la carne e le ossa ma la furia violenta del fuoco ardente li disfa appena la vita abbandona le bianche ossa e lrsquoanima vagola volata via come un sogno
[Tr di GA Privitera]19 Un esempio significativo di sovrapposizione tra fasi culturali distinte si coglie osservando lrsquoinventario degli oggetti accanto ad armi vasi ornamenti tipici dellrsquoVIII-VII secolo troviamo relitti risalenti allrsquoepoca micenea come la coppa di Nestore ornata di colombe descritta in Iliade XI 632 ss (simile a una coppa drsquoargento rinvenuta a Micene che riproduce disegno e artigianato dellrsquoetagrave del bronzo) lrsquoelmo di cuoio con zanne di cinghiale che Merione dagrave a Odisseo (Iliade X 261 ss) e lo scudo lungo laquosimile a torreraquo di Aiace che egrave di un tipo inusitato dopo il XIII secolo Un oggetto non riferibile neacute al mondo miceneo neacute allrsquoetagrave della fissazione dei poemi bensigrave alla prima etagrave del ferro egrave invece la coppia di aste da lancio adottate verso il 900 aC e scomparse due secoli dopo con lo sviluppo del combattimento oplitico e la reintroduzione dellrsquoasta per colpire e la menzione delle navi fenicie (una volta nellrsquoIliade e cinque volte nellrsquoOdissea) riflette la loro comparsa nellrsquoEgeo nel IX secolo aC Non diversamente sembra avvenire anche per le istituzioni politiche lrsquo ἄναξ egrave visto a volte come figura di autocrate assoluto a volte fortemente limitato dai poteri delle assemblee ndash sia quella dei capi (βουλή) sia quella delle truppe (ἀγορή) ndash o insidiato dallrsquoascesa dei gruppi aristocratici mentre il βασιλεύς non egrave piugrave il dignitario della societagrave micenea ma genericamente un principe o un capo LʼIliade
19 Omero Odissea III intr testo e commento di A Hoekstra tr di GA Privitera Mondadori Milano 1984
Letteratura greca [1]
13
LrsquoIliade (Ἰλιάς) consta di circa 15690 esametri divisi secondo una partizione che potrebbe risalire al primo editore alessandrino (Zenodoto di Efeso) in 24 libri indicati con le lettere maiuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquounitagrave strutturale di parecchi canti che spesso finiscono col tramonto o iniziano con lrsquoalba e la coincidenza fra alcuni dei titoli attribuiti a ciascun canto nelle edizioni alessandrine e quelli che si rintracciano in autori precedenti (ad es Tucidide [I 10 4] cita il ldquoCatalogo delle navirdquo cioegrave il canto II) provano che non si trattograve di una divisione arbitraria bensigrave fondata almeno in certa misura sulle abitudini dei rapsodi Tema dellrsquoopera non egrave lrsquointero assedio decennale di Troia da parte dei Greci (di norma detti Achei o Danai o Argivi) provocato dal rapimento di Elena ad opera di Paride ma una porzione assai limitata del conflitto una sequenza narrativa che copre la durata di 51 giorni e si colloca verso la fine del nono anno di guerra lrsquoira di Achille contro lrsquoAtride Agamennone il suo ritiro dalla guerra e le relative conseguenze la fine dellrsquoira lrsquouccisione e i funerali di Ettore Fu proprio questa delimitazione tematica a consentire la realizzazione di quellrsquounitagrave e compiutezza dellrsquoazione che giagrave Aristotele individuava come uno dei pregi essenziali dellrsquoopera di Omero rispetto agli altri poemi epici arcaici (Poetica 1459a-b)20
anche in questo Omero deve apparire mirabile in confronto agli altri per non aver tentato di rappresentare intera la guerra anche se essa aveva un principio e una fine il racconto sarebbe risultato troppo grande e non abbracciabile con uno sguardo oppure pur misurato nella grandezza intricato per la varietagrave Ricavatane invece una parte ha fatto uso di molti episodi per esempio con il ldquoCatalogo delle navirdquo e con altri episodi fa procedere in lungo il poema Gli altri invece come lrsquoautore delle Ciprie o della Piccola Iliade compongono unrsquoazione multipla su unrsquounica persona o un unico tempo Di conseguenza mentre dallrsquoIliade e dallrsquoOdissea si ricava unrsquounica tragedia o soltanto due da ciascuna dalle Ciprie parecchie
[Tr di D Lanza]21
Canto I Lrsquoazione si apre sul campo degli Achei devastato dalle frecce scagliate da Apollo [T1] il dio ha scatenato una pestilenza percheacute Agamennone ha rifiutato il riscatto offerto dal sacerdote Crise per la liberazione della figlia Criseide divenuta schiava dellrsquoAtride Ai guerrieri convocati in assemblea lrsquoindovino Calcante rivela che la sola via di scampo egrave la restituzione di Criseide al padre Agamennone acconsente ma solo a patto che gli venga data in cambio Briseide la schiava che Achille tiene nella sua tenda come premio personale (γέρας) ricevuto dagli altri guerrieri Achille non puograve opporsi alla prevaricazione dellrsquoAtride ma non egrave disposto a subire passivamente lrsquooltraggio e insulta Agamennone anzi egrave giagrave pronto a estrarre la spada dal fodero per farsi giustizia quando viene trattenuto da Atena apparsa allrsquoimprovviso allora si ritira nella tenda giurando che non combatteragrave piugrave [T2] Quindi invoca la madre Tetide che dopo essere apparsa al figlio sulla riva del mare intercede presso Zeus e ottiene la promessa che i Greci non vinceranno la guerra e non espugneranno Troia fincheacute Achille non riceveragrave soddisfazione per lrsquooffesa subita Ma il piano di Zeus non resta celato ad Era che ingelosita provoca una lite nel corso del banchetto degli dei tuttavia la visione di Efesto zoppicante che funge da coppiere suscita lrsquoilaritagrave dei numi e riporta la serenitagrave Canto II Quella stessa notte Zeus manda ad Agamennone un sogno ingannatore per incitarlo ad attaccare Troia LrsquoAtride riferisce il sogno agli anziani e comanda lrsquoadunata dellrsquoesercito
20 Cfr anche 1462b ταῦτα τὰ ποιήματα συνέστηκεν ὡς ἐνδέχεται ἄριστα καὶ ὅτι μάλιστα μιᾶς πράξεως μίμησις (laquoQuesti poemi sono composti come meglio non si puograve e son il piugrave possibile imitazione di unrsquounica azioneraquo) 21 Aristotele Poetica Milano Rizzoli 19902
Letteratura greca [1]
14
con lrsquoidea stravagante di saggiare lrsquoumore delle truppe proponendo il ritorno in patria Gli uomini incitati da Tersite corrono alle navi pronti a salpare ma vengono bloccati da Odisseo e da Nestore Egrave significativo che Tersite lrsquoanti-eroe riecheggi le accuse di Achille ad Agamennone sottolineando gli onori di cui questi gode e prenda le parti di Achille [T3] Per tutta la seconda parte del libro lrsquoazione viene interrotta per far posto alla grandiosa uscita in armi dellrsquoesercito acheo dal recinto delle navi un quadro scintillante ornato da una catena di sei similitudini concatenate introdotte per illustrare il fulgore delle armi il rombo dei passi umani e degli zoccoli precipitosi lrsquoaspetto della schiera achea e la maestria dei condottieri Un ldquoCatalogo delle navirdquo contiene lrsquoelenco circostanziato delle genti greche che hanno preso parte allrsquoassedio ed egrave seguito da un catalogo piugrave breve e piugrave arido degli alleati dei Troiani accorsi in difesa di Ilio Canto III Lrsquoatteso scontro tra gli schieramenti appena passati in rassegna non ha luogo ParideAlessandro ottiene infatti una tregua per sfidare Menelao Iride la messaggera degli degravei spinge Elena ad accorrere alle mura presso le porte Scee per assistere al preannunciato duello di ligrave Priamo e gli altri anziani di Troia osservano la pianura Su richiesta del vecchio sovrano (una richiesta che sarebbe stata piugrave ldquoverosimilerdquo al primo anno di guerra) Elena nomina i piugrave prestigiosi campioni achei [T4] Nel duello che segue Paride si trova ben presto a mal partito contro Menelao ma Afrodite lo sottrae ai colpi del nemico avvolgendolo in una fitta nebbia e lo riporta nelle sue stanze dove dopo aver assunto lrsquoaspetto di una vecchia filatrice ordina a Elena di giacere con lui Elena si ribella ma la dea non transige Mentre Paride ed Elena si uniscono nellrsquoamplesso Menelao furibondo cerca fra la folla il nemico che sia i Greci che i Troiani sarebbero lieti di consegnargli pur di porre fine alla guerra Agamennone rivendicando la vittoria di Menelao pretende dai Troiani la restituzione di Elena e delle sue ricchezze noncheacute il pagamento di una forte ammenda Canto IV La tregua stipulata dopo la scomparsa di Paride viene infranta dallrsquoarciere Pandaro che sollecitato da Atena (scesa tra le schiere troiane su ordine di Zeus) ferisce con una freccia Menelao questi viene prontamente guarito dal medico Macaone figlio di Asclepio Agamennone passa fra le schiere incitandole a combattere incontra vari capi intenti a dare istruzioni ai propri uomini Solo Ulisse e Menesteo si tengono in disparte ricevendo i rimproveri di Agamennone ai quali Ulisse reagisce con indignazione Gli Achei muovono contro i Troiani con grande ordine e disciplina mentre i Troiani e i loro alleati schiamazzano come barbari Ha inizio la battaglia vera e propria nella quale lrsquoattenzione egrave focalizzata sui duelli individuali Ad assistere e rincuorare i Troiani compare Apollo sulla rocca di Troia mentre Atena infonde coraggio nei Greci Il canto si chiude sullrsquoinfuriare della battaglia la cui descrizione riprenderagrave nel canto successivo Canto V Balza in primo piano Diomede di cui viene presentata lrsquoἀριστεία lrsquoeroe laquoglorioso e chiaroraquo fa strage di nemici imperversando furiosamente fra le schiere troiane Nel pieno del combattimento viene ferito da una freccia scagliata da Pandaro il quale mena gran vanto del colpo andato a segno Diomede ottenuta unrsquoimmediata guarigione grazie allrsquointervento di Atena muove allora contro il nemico che nel frattempo era stato accolto sul carro di Enea Pandaro scaglia la sua lancia contro Diomede ma lo scudo di questi regge il colpo Diomede colpisce a sua volta uccidendo il nemico Enea scende dal cocchio per proteggere il cadavere di Pandaro dagli Achei che vorrebbero farne razzia ma Diomede lo colpisce con un grande masso fratturandogli il femore Enea viene salvato dallrsquointervento di Afrodite che lo avvolge nel suo manto mentre Diomede arriva addirittura a ferire al polso la dea che fugge sullrsquoOlimpo a farsi confortare dalla madre Dione Il figlio di Tideo attacca anche Apollo che aveva sottratto Enea alla sua furia ma
Letteratura greca [1]
15
egrave fermato dal grido di ammonimento del dio Incitati e aiutati da Ares ora i Troiani avanzano con impeto Intervengono Era e Atena e questrsquoultima assume il ruolo di auriga di Diomede Col suo aiuto questi ferisce al ventre Ares che fugge sullrsquoOlimpo Anche le dee vi fanno ritorno Canto VI Il canto VI egrave una naturale continuazione del V (tanto che Erodoto citeragrave come dallrsquoἀριστεία di Diomede un brano della prima parte del VI canto) La battaglia infuria nella pianura ma il furore di Diomede si stempera su una nota di cortesia quando lrsquoeroe dopo aver sfidato Glauco di Licia scopre di avere con lrsquoavversario antichi rapporti di ospitalitagrave I due si scambiano le armature (a detrimento di Glauco a cui laquoZeus Cronide levograve il senno cheacute scambiograve con Diomede Tidide armi drsquooro con armi di bronzo cento buoi con nove buoiraquo [vv 234-6]) Frattanto Ettore su invito dellrsquoindovino Eleno rientra in cittagrave dove le donne devono cercare di ottenere con offerte e voti il favore di Atena e incontra dapprima la madre Ecuba poi Paride (che intende ricondurre alla battaglia) vorrebbe salutare anche la moglie ma non la trova in casa bensigrave alle porte Scee dove Andromaca era accorsa piena drsquoangoscia insieme col figlioletto e con la nutrice Nel colloquio che segue ella lo implora di non esporre al pericolo se stessa e il figlio La replica di Ettore egrave esemplare per capire la prospettiva del poema e le motivazioni dellrsquoagire dei personaggi dominanti se Achille e gli eroi achei in genere cercano onore e gloria a questa motivazione (che pure non egrave assente) Ettore antepone lrsquoαἰδώς il senso di laquovergognaraquo e di responsabilitagrave nei confronti della comunitagrave e del nucleo familiare di cui egrave il difensore Poi si volta per prendere tra le braccia Astianatte ma lrsquoelmo lucente e il cimiero ondeggiante impauriscono il piccolo che si rifugia in seno alla nutrice Alla fine del canto Paride si incontra con Ettore e i due si avviano verso il campo di battaglia [T5] Canto VII A principio del canto VII Atena e Apollo si accordano per indurre Ettore a lanciare una sfida agli Achei per un duello Il sorteggio designa Aiace come campione greco Nello scontro Ettore lancia per primo lrsquoasta che penetra ma senza trapassarlo nello scudo di Aiace greve e massiccio (compaginato con sette strati di pelle bovina simile a una torre) Aiace di rimando lacera lo scudo e il pettorale della corazza ma non riesce a squarciare le carni del nemico percheacute Ettore si piega di lato Allora i due brandiscono di nuovo le aste poi ricorrono alle pietre Alla fine gli araldi arrestano il combattimento con la giustificazione che laquola notte giagrave viene ed egrave bene obbedire alla notteraquo (v 282) Su proposta di Nestore gli Achei decidono per il giorno seguente di seppellire i morti e di scavare una grande trincea difesa da un bastione sul margine del loro accampamento Respingono lrsquoofferta di pace dei Troiani (che prevederebbe la riconsegna dei tesori sottratti da Paride a Sparta) Il mattino seguente i morti vengono cremati e durante la giornata si erige il muro di protezione Canto VIII Nellrsquoassemblea degli degravei Zeus vieta ai numi di appoggiare lrsquouna o lrsquoaltra parte in conflitto Al mattino il combattimento riprende e a mezzogiorno Zeus pone i destini dei due popoli sulla bilancia che piega a favore dei Troiani Sul campo di battaglia Diomede salva Nestore Lrsquoazione di Ettore egrave travolgente fincheacute Zeus contravvenendo alla sua intenzione di favorire i Troiani accoglie la preghiera di Agamennone per risollevare il morale degli Achei che organizzano la difesa delle navi Nel corso degli scontri si segnala lrsquoarciere Teucro che colpisce i nemici muovendosi in sincronia con Aiace Telamonio che lo protegge con lo scudo Incitato da Agamennone egli prova a colpire anche Ettore ma soccombe colpito con una pietra A questa vista Era e Atena corrono ad armarsi per intervenire a favore degli Achei ma vengono distolte dalle minacce di Zeus che manifesta la propria intenzione di favorire i Troiani fino a quando i Greci non saranno ridotti alla disperazione tanto da scongiurare Achille percheacute ritorni Il sopraggiungere della notte
Letteratura greca [1]
16
interrompe i combattimenti Ettore galvanizzato dai successi ottenuti in quel giorno si illude che la vittoria sia a portata di mano e prospetta ai suoi una prossima ritirata degli Achei Il canto si chiude con il banchetto dei Troiani che banchettano nella pianura esaltati dalla speranza di vittoria Canto IX Agamennone affranto propone di fare ciograve che nel canto II aveva suggerito soltanto per mettere alla prova lrsquoesercito interrompere la guerra e tornare in patria Diomede si oppone e Nestore in un consiglio dei capi propone di tentare la riconciliazione con Achille Si invia alla tenda di Achille unrsquoambasceria (composta da Aiace Odisseo e Fenice antico pedagogo di Achille) per offrire doni ricchissimi Achille non cede anzi minaccia di salpare immediatamente verso la patria [T6] Inutilmente Fenice lrsquoantico precettore di Achille cerca di ammorbidire la determinazione del Pelide richiamando la vicenda dellrsquoeroe Meleagro [T7] Gli inviati riferiscono ad Agamennone la risposta di Achille egli torneragrave a combattere solo quando Ettore saragrave arrivato fino alle navi dei Mirmidoni Canto X Nella stessa notte si effettua una missione segreta nel corso della quale Odisseo e Diomede dapprima catturano la spia troiana Dolone (che Ettore aveva inviato alle navi achee promettendogli come ricompensa i cavalli di Achille) poi uccidono il re trace Reso appena arrivato presso i Troiani e ne rubano i magnifici cavalli Giagrave gli antichi ritenevano questo canto unrsquoaggiunta post-omerica e questi dubbi trovano riscontro in lati eccentrici della narrazione e nellrsquoimpiego di un linguaggio che spesso appare svincolato dal corrente repertorio formulare Canto XI Si apre una nuova giornata di battaglia (la cui narrazione si protrarragrave fino al canto XVIII) che ruota intorno allrsquoἀριστεία di Agamennone Quando lrsquoAtride viene ferito gli Achei ripiegano Diomede resta anchrsquoegli ferito Odisseo e Aiace evitano a stento la massa dei nemici Nestore salva sul suo carro Macaone Achille che dalla poppa della nave osserva la battaglia vuol sapere chi egrave condotto via da Nestore e manda Patroclo che viene accolto molto benevolmente e con cui Nestore intrattiene un lungo discorso egli dice di deplorare il comportamento di Achille e con atteggiamento consono alla sua condizione di anziano si dilunga nel raccontare le proprie gesta giovanili Egli esorta quindi Patroclo a far leva sulla sua amicizia per convincere Achille a riprendere il combattimento o - almeno - a concedere a Patroclo le sue armi per incutere timore nei Troiani Eccitato dalle parole del vecchio Patroclo si avvia verso la nave di Achille ma incontra Euripilo ferito che gli chiede aiuto ed egli impietositosi lo accompagna alla tenda e cura la ferita Canto XII Divisi in cinque contingenti i Troiani danno lrsquoassalto al muro eretto a difesa del campo acheo Sul campo di battaglia si manifesta un prodigio unrsquoaquila in cielo con un grosso serpente fra le zampe che riesce a ferire lrsquouccello e a sfuggire Polidamante che interpreta il segno come un presagio funesto consiglia di tornare indietro ma Ettore egrave di altro avviso Sarpedone e Glauco sferrano un attacco contro il muro e - pur rimanendo feriti - riescono ad aprire una breccia La battaglia infuria con esito incerto fincheacute Ettore con un macigno sfonda una delle porte consentendo ai Troiani di entrare in massa nel campo acheo mentre i Greci fuggono verso il mare Canto XIII Zeus distoglie lo sguardo dalla battaglia nella convinzione che nessuno fra gli dei avrebbe osato violare il divieto di intervenire ne approfitta invece Poseidone favorevole ai Greci Assunto lrsquoaspetto dellrsquoindovino Calcante il dio infonde nuovo vigore nei due Aiaci
Letteratura greca [1]
17
spronandoli al combattimento Gli Achei riconoscono lrsquointervento divino e riprendono fiducia I combattimenti si susseguono violentissimi Nella resistenza si distingue il re cretese Idomeneo Polidamante consiglia una seconda volta di interrompere la battaglia e accenna allrsquoimminente intervento di Achille Ettore non ascolta lrsquoammonimento e riprende lrsquoassalto Il canto si chiude con un suo scambio di insulti con Aiace Telamonio Canto XIV Mentre Diomede Odisseo e Agamennone tornano feriti allrsquoaccampamento Era per distogliere Zeus dalla battaglia e consentire a Poseidone di favorire gli Achei indossa la cintura magica di Afrodite e sollecita il consorte a un convegno amoroso sullrsquoIda dopo lrsquoamplesso Zeus cade in un sonno profondo e Hypnos (il Sonno) annuncia a Posidone che potragrave aiutare senza rischi gli Achei Ettore colpito con una pietra da Aiace resta a lungo in stato di incoscienza e i Troiani vengono respinti Canto XV Zeus si risveglia avvedendosi dellrsquoinganno subito e costringe Era a mandargli Iride e Apollo la prima allontaneragrave Posidone dal campo di battaglia Apollo inciteragrave Ettore a far retrocedere gli Achei fino alle navi dei Mirmidoni Riprende lrsquooffensiva troiana Apollo stesso abbatte il muro e scuotendo lrsquoegida atterrisce gli Achei Patroclo corre da Achille mentre i Troiani giagrave sono sul punto di appiccare il fuoco alle navi Canto XVI Patroclo in lacrime supplica Achille di intervenire o di mandare lui stesso al suo posto [T8] Achille gli consegna le proprie armi e gli fa promettere che non si avventureragrave oltre la zona delle navi Ma Patroclo trascinato dal suo stesso impeto oltrepassa il limite prescrittogli da Achille Abbatte Sarpedone figlio di Zeus attorno al cui cadavere infuria la lotta fincheacute Apollo lo sottrae alla mischia e Hypnos e Thanatos (il demone della morte) lo trasportano in Licia sua patria Patroclo continua lrsquoassalto alla testa dei Mirmidoni fin sotto le mura di Troia ma poco prima del tramonto al quarto assalto Apollo stesso assunto lrsquoaspetto di Asio lo percuote fra le spalle allora Euforbo lo colpisce con lrsquoasta ed Ettore lo trafigge Canto XVII Euforbo viene ucciso da Menelao ma Ettore riesce a catturare le armi di Achille indossate da Patroclo Vigorosamente sostenuti da Aiace gli Achei difendono il cadavere Una densa nebbia scende sui combattenti Zeus infonde nuovo ardimento nei cavalli di Achille piangenti per la fine di Patroclo [T9] Atena e Apollo arroventano la lotta attorno alla salma In seguito alla preghiera di Aiace Zeus dissolve la nebbia Menelao manda Antiloco figlio di Nestore a informare Achille della morte di Patroclo la cui salma viene intanto trascinata fuori della battaglia da Menelao e Merione mentre i due Aiaci offrono la necessaria copertura contro la furia incalzante dei nemici Canto XVIII Lo scoppio di selvaggio dolore a cui si abbandona Achille allrsquoudire della morte di Patroclo provoca lrsquoaccorrere dal mare di Tetide insieme con le Nereidi La madre gli promette di procurargli nuove armi Poicheacute la salma di Patroclo egrave tuttora contesa Achille fa la sua apparizione sul fossato e lancia un grido che atterrisce i nemici Efesto su preghiera di Tetide foggia le nuove armi fra cui un magnifico scudo su cui appaiono effigiati in bande concentriche gli aspetti salienti dellrsquoesistenza umana Canto XIX Il mattino seguente Tetide porta le armi al figlio e con lrsquoambrosia preserva la salma di Patroclo dalla decomposizione Achille convoca unrsquoassemblea dellrsquoesercito e rinuncia alla sua collera Agamennone lamenta di essere stato ldquoaccecatordquo da Zeus e promette doni
Letteratura greca [1]
18
riparatori [T10] Achille si lascia convincere a stento ad attendere che i soldati abbiano mangiato Poi gli armati si radunano e anche Achille si arma Il suo cavallo Xanto gli predice la prossima morte [T11] Canto XX Zeus consente agli degravei di partecipare alla nuova battaglia Enea scontratosi con Achille egrave tratto in salvo da Posidone Achille infuria come un incendio in una selva Canto XXI Achille colma di cadaveri il fiume Scamandro e cattura dodici giovani troiani che intende offrire in sacrificio a Patroclo non risparmia neppure Licaone figlio di Priamo che lo supplica con accenti di grande intensitagrave ma altrettanto intensa nella consapevolezza di un destino imminente egrave la pur spietata replica del Pelide [T12] Lo Scamandro solleva le proprie onde ma le fiamme di Efesto inaridiscono il terreno e domano la corrente Gli degravei si azzuffano Atena raggiunge Ares con una pietra Era rintuzza la furia di Artemide Infine tutti tornano sullrsquoOlimpo Apollo assunto lrsquoaspetto di Agenore respinge Achille percheacute i Troiani possano rifugiarsi allrsquointerno delle mura Canto XXII Il solo Ettore resta fuori nella pianura Invano Priamo ed Ecuba lo pregano di rientrare Mentre Achille si avvicina Ettore decide di affrontarlo ma quando quello gli egrave da presso col bronzo che gli lampeggia intorno laquosimile al raggio del fuoco ardente o del sole che sorgeraquo egrave afferrato dal panico e comincia a fuggire compiendo tre giri intorno alle mura Zeus pesa sulla bilancia i destini (le κῆρες) dei due eroi e quello di Ettore affonda in basso Allora Apollo lo abbandona e Atena apparsa a Ettore sotto le spoglie di suo fratello Deifobo gli si avvicina promettendogli aiuto e invece riporta ad Achille la lancia che gli era caduta fuori bersaglio Il colpo di risposta di Ettore rimbalza sullo scudo di Achille Ettore urla a Deifobo di passargli la sua lancia ma il falso Deifobo egrave scomparso ed Ettore comprende di trovarsi sullrsquoorlo dellrsquoabisso [T13] Achille gli trapassa la gola ed Ettore lo supplica di non oltraggiare la sua salma in risposta riceve la minaccia che finiragrave in pasto ai cani Achille trascina il cadavere alle navi attaccato al carro Priamo Ecuba e Andromaca si abbandonano al cordoglio a cui fanno eco le donne troiane Canto XXIII Viene preparato il banchetto funebre in onore di Patroclo la cui ombra nel corso della notte appare ad Achille chiedendo la sepoltura del corpo Il mattino seguente si appresta il rogo fra le offerte votive ci sono anche dodici giovani troiani Il giorno successivo si raccolgono le ossa di Patroclo Seguono i ludi funebri gare coi carri e con lrsquoarco duello in armi etc Canto XXIV Ogni giorno Achille trascina il cadavere di Ettore attorno alla tomba dellrsquoamico ma lo spettacolo offende gli degravei e al dodicesimo giorno Zeus decide di mandare Tetide percheacute induca suo figlio a restituire la salma di Ettore Iride viene inviata presso Priamo percheacute gli consigli di recarsi nel cuore della notte con un carro da trasporto e un copioso riscatto scortato da Ermes alla tenda di Achille Questi accoglie il vecchio con rispetto riconoscendo in lui lrsquoimmagine del padre lontano e si piega alla sua supplica [T14] Per volontagrave degli degravei il cadavere non egrave stato aggredito dalla putrefazione composto sul pianale del carro viene ricondotto dal padre a Troia Qui le lamentazioni rituali srsquoinnalzano dal gruppo delle donne (Andromaca Ecuba Elena) Si stipula una tregua di dodici giorni Per nove giorni i Troiani raccolgono legname poi anche il rogo di Ettore arde e si erige un tumulo
Letteratura greca [1]
19
Struttura e caratteri dellʼopera Poema di trama relativamente organica (soprattutto a partire dal canto XVI tutti gli avvenimenti tranne pochi episodi isolati ruotano attorno ai due principali antagonisti Ettore uccide Patroclo per vendicare Sarpedone e Achille uccide Ettore per vendicare Patroclo) pur se non privo di piugrave o meno cospicue incongruenze spiegabili in primo luogo con la lunga e complessa genesi orale dellrsquoopera lrsquoIliade lascia emergere in mezzo alle centinaia di nomi e alle intricate vicende alcuni caratteri delineati nella loro individualitagrave e innanzi tutto quelli di Achille e di Ettore accomunati dalla medesima coscienza di un destino di morte che sono pronti ad affrontare Appunto una tale attitudine a rappresentare i laquocaratteriraquo (ἤθη) dei suoi personaggi egrave un altro titolo di merito che Aristotele ascrive ad Omero (Poetica 1460a9-11)
dopo aver brevemente proemiato subito introduce un uomo una donna o un altro personaggio nessuno privo di caratterizzazione ma dotato di un carattere
Fondamentale per la struttura del poema egrave la novitagrave della prospettiva Possiamo presumere che i cosiddetti poemi ciclici22 mirassero a conservare lrsquoangolatura che era stata propria delle versioni pre-omeriche della saga troiana sigrave che puograve riuscire significativo il confronto fra lrsquoesordio della Piccola Iliade (dove muovendo da grandi entitagrave ndash la cittagrave il paese due popoli la guerra ndash viene lanciato secondo lrsquoespressione di J Latacz come laquouno sguardo dallrsquoesternoraquo)
Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην εὔπωλον ἧς πέρι πολλὰ πάθον Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος Canto Ilio e la terra dei Dardani dai bei puledri per la quale molti dolori patirono i Danai servitori di Ares
con lo laquosguardo internoraquo che caratterizza lrsquoinizio dellrsquoIliade
Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν ἡρώων αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν οἰωνοῖσί τε δαῖτα Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς Canta o dea di Achille figlio di Peleo la collera maledetta che pene innumerevoli inflisse agli Achei e molte scagliograve allrsquoAde vite possenti di eroi e ne faceva prede per i cani e pasto per gli uccelli e si avverava il volere di Zeus da quando primamente si separarono venuti a contesa LrsquoAtride sovrano di eroi e Achille magnifico
Argomento non egrave dunque come doveva avvenire nella tradizione del canto epico un evento complesso da inquadrare con un grandangolo onnicomprensivo e neppure come saragrave nellrsquoOdissea un personaggio colto nella multiforme varietagrave delle sue peregrinazioni egrave invece una reazione emotiva (lrsquoira di Achille) con le sue conseguenze (le innumerevoli morti degli Achei) Narrare di questa ira significa per il poeta cominciare da un punto preciso (laquoda quandoraquo) ossia dal momento della contesa e della separazione fra i due massimi eroi greci Agamennone il primo per potere (laquosovrano di eroiraquo) e Achille il primo per nobiltagrave e forza (δῖος) E sintomatica della bipolaritagrave del mondo epico in quanto mondo di degravei e di eroi egrave la sincronia per cui il taglio della narrazione coincide col decorso del laquovolere di Zeusraquo (Διὸς βουλή) forse da identificare con la promessa del dio a Tetide (rievocata piugrave oltre in questo
22 V cap II laquoLa tradizione omericaraquo
Letteratura greca [1]
20
stesso canto ai vv 518-527) di vendicare lrsquoaffronto subito da Achille o piugrave in generale con il corso degli eventi in quanto tutto come per definizione laquogiace sulle ginocchia di Zeusraquo Opera indubbiamente allrsquointerno del poema unrsquoidea formativa un progetto di qui un insieme monumentale unificato anche da una serie di corrispondenze a distanza fra cui particolare significato acquistano quelle fra primo e ultimo canto Nel canto I il vecchio Crise va come supplice presso Agamennone portando doni e supplicando la restituzione della figlia e Agamennone lo respinge aspramente minacciandolo di far ricorso alla violenza se dovesse tornare nel canto XXIV il vecchio Priamo va come supplice presso Achille portando doni e supplicando la restituzione del corpo del figlio Achille ha una prima reazione irosa (esordisce al v 560 con laquoSmetti di irritarmi vecchioraquo) ma poi accoglie la supplica E al di lagrave delle corrispondenze nelle linee dellrsquoazione si colgono fra principio e fine del poema alcuni importanti echi verbali in particolare fra XXIV 501 s
τοῦ νῦν εἵνεχ᾽ ἱκάνω νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενος παρὰ σεῖο φέρω δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα per lui [Ettore] vengo ora alle navi degli Achei per riscattarlo da te e ti porto compenso infinito
e I 12 s
ὁ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενός τε θυγάτρα φέρων δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα costui [Crise] venne alle navi rapide degli Achei per riscattare la figlia portando compenso infinito
fra XXIV 555-557
λῦσον ἵν᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδωmiddot σὺ δὲ δέξαι ἄποινα πολλά τά τοι φέρομενmiddot σὺ δὲ τῶνδrsquo ἀπόναιο καὶ ἔλθοις σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν restituiscimelo percheacute lo possa vedere con gli occhi e accogli il riscatto copioso che portiamo e tu possa goderne e tornare alla tua terra patria
e I 18-20
Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν εὖ δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκέσθαιmiddot παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην τὰ δ᾽ ἄποινα δέχεσθαι Atridi e voi altri Achei dai forti schinieri a voi concedano gli degravei che hanno le case in Olimpo di distruggere la cittagrave di Priamo e tornare facilmente in patria ma restituitemi la figlia e accettate il riscatto
fra XXIV 560 μηκέτι νῦν μ᾽ ἐρέθιζε (laquosmetti di irritarmiraquo) e I 32 μή μ᾽ ἐρέθιζε (laquonon mi irritareraquo) fra XXIV 568-570
τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς μή σε γέρον οὐδrsquo αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω καὶ ἱκέτην περ ἐόντα Διὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμάς Ora perciograve fra i dolori non mi eccitare lrsquoanimo ancora di piugrave bada o vecchio che non ti lasci neppure nella tenda
Letteratura greca [1]
21
bencheacute supplice e violi gli ordini di Zeus e I 26-28
μή σε γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω ἢ νῦν δηθύνοντ᾽ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο Mai te o vecchio io colga presso le concave navi ora a indugiare o piugrave tardi a tornare che piugrave non dovesse giovarti lo scettro e la benda del dio
(e infine XXIV 571 ὣς ἔφατ ἔδεισεν δ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ laquocosigrave diceva e il vecchio tremograve e obbediva alle paroleraquo ripete esattamente I 33) In effetti lrsquoepisodio terminale del poema col superamento dellrsquoira ad opera della pietagrave e del senso di unrsquoesistenza invasa dal dolore si propone come il rovesciamento consapevole dellrsquoepisodio iniziale che era apparso caratterizzato dalla cancellazione della pietagrave e del diritto dei supplici in nome della forza Al rifiuto iniziale del donoriscatto si oppone lrsquoaccettazione finale in consonanza con un principio-guida che opera nel poema secondo linee che alla fine si riunificano Agamennone restituisce Criseide al padre ma si appropria del dono fatto dagli altri Achei ad Achille (Briseide) Achille respinge i doni fatti da Agamennone per indurlo a riconciliarsi con lui ma dopo aver contestato nel IX canto la nozione che la vita umana possa essere barattata con una massa di beni torna alla lotta non in cambio di qualche premio da conquistare ma per vendicare lrsquouccisione dellrsquoamico Patroclo e tanto nella lotta sul campo di battaglia quanto nellrsquoinfierire sul cadavere di Ettore si abbandona a un furore cosigrave smisurato e patologico che puograve essere superato solo con lrsquoaccettare i doni di Priamo non tuttavia per il loro valore drsquouso ma percheacute in Priamo Achille riconosce lrsquoombra del padre lontano Cosigrave lrsquoIliade appare attraversata da un impulso fondamentale che muove dallrsquoideologia del dono e dalla conseguente centralitagrave assegnata allrsquoonore (τιμή) come ldquoprezzordquo che qualifica il valore del guerriero ma supera questo piano di valutazione dei rapporti umani attraverso la loro riformulazione nei termini di un umanesimo esistenziale che ha come punti di riferimento lrsquoidentitagrave universale dei condizionamenti oggettivi (la vecchiaia la malattia la morte) e i legami che uniscono padre e figlio compagno e compagno vivi e morti (il cordoglio finale di Andromaca Ecuba ed Elena sulla salma di Ettore) Entro questo orizzonte progressivamente allargato la guerra le lotte lo scontro mortale finiscono col rappresentare solo un momento e un aspetto dellrsquoesistenza graditi tanto agli degravei che vi assistono come spettatori interessati quanto agli uditori che riascoltano le antiche gesta eppure non tali da appiattire il poema in una prospettiva guerresca conclusa in se stessa Molto del fascino delle battaglie e delle ἀριστεῖαι dellrsquoIliade sta nella presenza recondita di un occhio che sa guardare al di lagrave di esse (e al di lagrave della stessa distinzione fra Greci e Troiani vincitori e vinti) e che puograve anche attraverso le similitudini lasciare irrompere il mondo della natura o del lavoro umano nel mezzo delle battaglie LʼOdissea LrsquoOdissea (Ὀδύσσεια) consta di circa 12100 esametri divisi anchrsquoessi in 24 libri e indicati con le lettere minuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquoargomento egrave costituito dalle avventure di Odisseo dalla distruzione di Troia al ritorno alla patria Itaca esposte secondo un ordine che entrando subito nel vivo degli avvenimenti (lrsquoinizio del poema mostra Odisseo nellrsquoisola di Calipso) rievoca poi i fatti giagrave trascorsi e li ricongiunge infine a partire dal libro XV (con lrsquoarrivo di Telemaco alla capanna di Eumeo dove giagrave si trova Odisseo) in unrsquoazione unitaria La trama del poema i cui avvenimenti sono concentrati cronologicamente nello spazio di 40 giorni (ma sono narrati solo gli avvenimenti di 16 giorni e 8 notti) si articola in tre parti la laquoTelemachiaraquo (canti I-IV) il laquoRitorno di Odisseoraquo (canti V-XIII) e la laquoVendetta di Odisseoraquo (canti XIV-XXIV)
Letteratura greca [1]
22
Canto I Tutti gli eroi superstiti sono ormai tornati da Troia alle loro case tranne Odisseo che pur desideroso di tornare egrave trattenuto dalla ninfa Calipso nellrsquoisola di Ogigia Gli degravei hanno pietagrave di lui tranne Posidone irato per lrsquoaccecamento del figlio il ciclope Polifemo Ma un consiglio degli degravei assente Posidone (che si egrave recato presso gli Etiopi) delibera il ritorno dellrsquoeroe si decide che Ermes andragrave subito da Calipso mentre Atena si avvia verso Itaca sotto lrsquoaspetto del signore dei Tafi Mente per incoraggiare il figlio di Odisseo Telemaco a tener testa ai pretendenti della madre i laquoprociraquo (i quali aspirano al regno tramite le nozze con Penelope) e per indurlo a intraprendere un viaggio in cerca di notizie sul padre Canto IΙ Telemaco segue il consiglio della dea e il giorno seguente nellrsquoassemblea popolare chiede una nave per andare in cerca del padre ma la sua richiesta non viene discussa e Leocrito scioglie lrsquoassemblea Grazie ad Atena che ora ha assunto le sembianze di Mentore (antico amico di Odisseo) Telemaco riesce tuttavia a trovare una nave con cui salpa nel corso della notte allrsquoinsaputa sia della madre che dei proci Canto IΙΙ Telemaco e MentoreAtena arrivano a Pilo e sul lido trovano Nestore che sta offrendo un sacrificio a Posidone Il vecchio eroe accoglie ospitalmente Telemaco e gli comunica molte notizie sul ritorno di altri Achei ma nessuna su Odisseo Alla sera Atena scompare in forma di aquila e il mattino seguente Telemaco salpa insieme con Pisistrato (figlio di Nestore) alla volta di Sparta dove arriva la sera del giorno successivo Canto IV A Sparta Menelao sta festeggiando il doppio matrimonio del figlio e della figlia Il giorno seguente Telemaco chiede del padre Menelao gli racconta il proprio ritorno durante il quale aveva incontrato Proteo il vecchio nume marino che gli aveva riferito come Odisseo fosse trattenuto nellrsquoisola di Calipso Intanto a Itaca i proci preparano insidie meditando di uccidere Telemaco al suo ritorno Penelope ne viene a conoscenza ma Atena le appare in sogno per confortarla Canto V Dopo un secondo concilio degli degravei (in effetti un ldquodoppionerdquo di quello del I canto) Zeus manda finalmente Ermes presso Calipso con lrsquoordine di lasciar partire Odisseo La ninfa aiuta lrsquoeroe a costruirsi una zattera Al diciottesimo giorno di navigazione Odisseo egrave in vista dellrsquoisola dei Feaci Scheria quando Posidone di ritorno dal suo soggiorno presso gli Etiopi lo vede e suscita una tempesta che distrugge la zattera Ma la dea marina Ino Leucotea impietositasi gli porge il proprio velo sostenuto dal quale lrsquoeroe giunge a nuoto alla riva di Scheria dove si abbandona esausto addormentandosi Canto VI In seguito a un sogno inviatole da Atena Nausicaa la figlia del re dei Feaci Alcinoo si reca nei pressi della spiaggia a lavare le vesti insieme con le ancelle Odisseo risvegliatosi atterrisce le fanciulle che fuggono tutte allrsquoinfuori di Nausicaa Lrsquoeroe supplica la giovane di porgerle aiuto ed ella lo fa rivestire e lo accompagna fino al bosco di Atena poco prima della cittagrave esortandolo a presentarsi a suo padre Canto VII Protetto dalla nebbia di cui Atena lo ha avvolto Odisseo entra nel palazzo abbraccia le ginocchia della regina Arete e la caligine scompare poi viene accolto con onore da Alcinoo Arete chiede a Odisseo donde provenga e chi gli abbia donato gli abiti (a lei ben noti) che indossa Lrsquoeroe inizia a raccontare le disavventure che gli sono occorse dopo la
Letteratura greca [1]
23
partenza dallrsquoisola di Calipso Alcinoo gli promette di farlo ricondurre a Itaca il giorno seguente Canto VIII Ma lrsquoindomani Alcinoo fa apprestare un banchetto durante il quale lrsquoaedo Demodoco canta della contesa insorta un giorno fra Achille e Odisseo Lrsquoeroe si copre il volto per nascondere le lacrime allora Alcinoo interrompe il canto e organizza una serie di gare nel corso delle quali Odisseo primeggia Poi Demodoco al margine di unrsquoarea per la danza dove si esibiscono i ballerini feaci canta gli amori di Ares e Afrodite e la vendetta di Efesto (che incatena i due amanti) La sera al ritorno nel palazzo Demodoco racconta la storia del Cavallo di legno Odisseo scoppia nuovamente in lacrime e Alcinoo gli chiede di rivelare il suo nome Canto IX Odisseo dichiara il proprio nome e dagrave inizio al racconto della propria storia a partire dalla caduta di Troia distruzione di Ismaro e perdite subite ad opera dei Ciconi sbarco presso i Lotofagi (che si nutrono di un cibo misterioso che fa dimenticare il ritorno) dopo una terribile tempesta scatenatasi durante il tentativo di doppiare il capo Malea arrivo allrsquoisola antistante quella dei Ciclopi dove Odisseo si trasferisce con una sola nave esplorazione dellrsquoisola perdita di alcuni compagni allrsquointerno della caverna del gigante monocolo accecamento del mostro e fuga Canto X Odisseo giunge allrsquoisola di Eolo signore dei venti che lo accoglie benevolmente e gli consegna alla partenza tutti i venti chiusi in un otre ma poi lo respinge con durezza quando ritorna presso di lui percheacute i compagni (sospettando che nellrsquootre siano racchiuse cospicue ricchezze) hanno sciolto i venti e da essi si egrave sprigionato un uragano che li ha risospinti sullrsquoisola Ripreso il mare Odisseo egrave trasportato fino ai Lestrigoni antropofagi il cui attacco priva lrsquoeroe di tutte le altre navi tranne la propria Con questa fugge fino allrsquoisola (Eea) della maga Circe Dopo che Circe ha trasformato in porci un gruppo di compagni mandati innanzi ad esplorare lrsquoisola Odisseo ha la meglio sulla maga (a cui impone di restituire forma umana ai compagni) grazie allrsquoerba moly fornitagli da Ermes Resta un anno presso Circe che al momento della partenza gli consiglia di recarsi al paese dei morti per interrogare il vate Tiresia Canto XI Approdato alla terra dei Cimmeri (che vivono immersi in una nebbia perenne sulla riva dellrsquoOceano) e scavata una fossa Odisseo sacrifica ai morti e immola una vittima speciale a Tiresia Le anime accorrono dapprima Elpenore caduto per caso giugrave dal tetto della casa di Circe (Odisseo gli promette sepoltura) poi la madre Anticlea (che gli racconta di esser morta di dolore per la sua assenza) quindi Tiresia che gli vaticina le sue vicende future fino alla morte (questa lo coglieragrave dopo una lunga vita in un paese straniero che non conosce neacute il sale neacute il remo) Da un certo punto in poi il poeta dimentica il presupposto per cui Odisseo aveva scavato una fossa alla quale i morti accorrevano per bere il sangue delle vittime e bevendolo riacquistavano per breve tempo una piena consapevolezza immagina invece che Odisseo sia allrsquointerno dellrsquoAde In questa sezione rientrano la descrizione di Aiace sdegnato di Minosse di Orione dei grandi peccatori di Eracle Poi Odisseo fa ritorno a Eea e ricevuti i consigli di Circe si imbarca per il ritorno in patria Canto XII Scampato alle Sirene che invano lo attirano col canto (si egrave fatto legare allrsquoalbero della nave i compagni che remano hanno le orecchie turate con la cera) passa tra Cariddi e Scilla (che gli rapisce sei uomini) ed egrave costretto dai compagni ad approdare in contrasto con le prescrizioni di Circe allrsquoisola Trinachia dove pascolano le greggi del Sole I
Letteratura greca [1]
24
compagni spronati da Euriloco se ne cibano nonostante il divieto dellrsquoeroe Il Sole sdegnato ottiene da Zeus che la nave sia colpita dal fulmine Tutti i compagni periscono ma Odisseo che ripassa tra Scilla e Cariddi si salva miracolosamente da questrsquoultima aggrappandosi a un fico selvatico fincheacute il gorgo restituisce i rottami della nave infine arriva remando con le mani allrsquoisola di Ogigia Canto XIII Terminato il racconto lrsquoeroe riceve doni dai Feaci e la notte seguente egrave ricondotto a Itaca e deposto addormentato sulla spiaggia presso un antro sacro alle Ninfe Al risveglio per la nebbia non riconosce la sua terra fincheacute Atena in veste di giovane pastore lo rassicura e poi rivelatasi gli dagrave istruzioni su come far strage dei proci e lo trasforma in un vecchio mendico Canto XIV Odisseo si reca allo stazzo del suo porcaio Eumeo che pur non riconoscendolo lo accoglie ospitalmente rifocillandolo e offrendogli un mantello per ripararsi dal gelo notturno Canto XV A questo punto la laquoTelemachiaraquo si riannoda allrsquoazione principale Telemaco che si trova ancora a Sparta viene indotto da Atena a tornare a Itaca sulla via del ritorno a Pilo accoglie a bordo lrsquoindovino Teoclimeno e grazie allrsquoaiuto della dea sfugge alle insidie dei proci sbarca a Itaca e si reca anchrsquoegli presso Eumeo Canto XVI Questi va da Penelope ad annunciargli il ritorno del figlio Intanto Odisseo rimosso lrsquoincantesimo si svela nel suo vero aspetto a Telemaco e con lui progetta la vendetta sui proci (che intanto tramano una nuova insidia ai danni di Telemaco) Eumeo torna al suo stazzo Canto XVII Il mattino seguente Telemaco si reca in cittagrave seguito in un secondo tempo da Eumeo e Odisseo (che ha riassunto lrsquoaspetto di mendico) Davanti al palazzo Odisseo egrave riconosciuto dal cane Argo Entra e va mendicando tra i proci Antinoo lo colpisce alla spalla destra con uno sgabello Canto XVIII Odisseo si batte al pugilato col mendicante Iro Penelope scesa nella sala prospetta ai proci lrsquoeventualitagrave di un nuovo matrimonio Odisseo egrave insultato dalla schiava Melanto e schiva uno sgabello scagliato da Eurinomo Canto XIX Insieme con Telemaco lrsquoeroe allontana le armi dalla sala poi conversa con Penelope che gli racconta un sogno e gli espone il suo piano per sedare le contese tra i proci concedendosi sposa a colui che riusciragrave a tendere lrsquoarco di Odisseo la prova avverragrave il giorno seguente al novilunio Durante il colloquio la fida schiava Euriclea lava i piedi di Odisseo e riconosciutolo da unrsquoantica cicatrice sta per rivelarne lrsquoidentitagrave ma lrsquoeroe la costringe a tacere Canto XX Al mattino Euriclea e le ancelle fanno i preparativi per il banchetto Giungono Eumeo Melanzio e il mandriano Filezio Un presagio mandato da Zeus dissuade i proci dal progetto di uccidere Telemaco Durante il banchetto Teoclimeno predice la loro imminente rovina
Letteratura greca [1]
25
Canto XXI Penelope conduce lrsquoarco nella sala dopo che parecchi fra i proci e lo stesso Telemaco hanno tentato invano di tenderne la corda Odisseo chiede di partecipare alla prova tende lrsquoarco senza fatica e riesce a far passare la freccia attraverso gli anelli di dodici scuri predisposte da Telemaco Canto XXII Poi scaglia le frecce sui proci e si rivela nella sua identitagrave Nella lotta che segue Telemaco Eumeo e Filezio aiutano il padrone contro i proci (appoggiati dal capraio Melanzio) Tutti i proci restano uccisi le ancelle infedeli sono impiccate Melanzio viene mutilato e ucciso soltanto lrsquoaedo Femio e lrsquoaraldo Medonte sono risparmiati Canto XXIII Nuovo colloquio fra Odisseo e Penelope che durante lrsquoeccidio dormiva ed egrave stata svegliata da Euriclea Penelope esita ancora a riconoscere il marito e non si arrende alla veritagrave fincheacute Odisseo non le descrive la posizione e la struttura del letto coniugale Canto XXIV Ermes conduce allrsquoAde le ombre dei proci Odisseo fa visita al padre Laerte nella masseria dove quello vive nello squallore e nellrsquoemarginazione e si fa riconoscere Intanto il padre di Antinoo incita gli Itacesi alla rivolta e il poema si conclude con lo scontro di Odisseo e dei suoi contro i concittadini lrsquoeroe ha la meglio e Zeus scagliato il fulmine pone fine alla battaglia Atena sotto lrsquoaspetto di Mentore stabilisce fra i contendenti un patto per il futuro36
Struttura e caratteri dellʼopera Giagrave la prima parola del proemio (ἄνδρα) non menziona come tema dellrsquoopera un determinato episodio della vita del protagonista ma il protagonista stesso (I 1-10)
Ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα πολύτροπον ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεmiddot πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περmiddot αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο νήπιοι οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιονmiddot αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ τῶν ἁμόθεν γε θεά θύγατερ Διός εἰπὲ καὶ ἡμῖν Dellrsquouomo multiforme a me racconta o Musa che molto errograve dopo che di Troia la sacra rocca distrusse di molti uomini vide le cittagrave riconobbe il pensiero e molti per il mare patigrave dolori nellrsquoanimo per salvare la sua vita e il ritorno dei compagni Eppure non li salvograve i compagni per quanto bramasse per la loro stessa follia si persero gli stolti i buoi del Sole Iperione mangiarono e quello rapigrave ad essi il digrave del ritorno Di questo da un punto qualsiasi narra anche a noi o dea figlia di Zeus
Storie favolose di naviganti racconti imperniati sul ritorno dei guerrieri achei che avevano combattuto a Troia e il particolare rientro in patria di Odisseo figlio di Laerte erano forse giagrave stati connessi e intrecciati nella precedente tradizione epica sigrave che il presente cantore poteva
Letteratura greca [1]
26
metter mano alla vicenda partendo (v 10) laquoda un punto qualsiasiraquo (ἁμόθεν) una notazione che certo presuppone la convenzione propria dellrsquoesordio tradizionale di un canto epico comparabile con i giagrave ricordati ἐξ οὗ (laquoda quandoraquo) di Iliade I 4 ed ἔνθεν (laquoda doveraquo) di Odissea VIII 500 Senoncheacute rispetto a queste indicazioni di tipo puntuale il tratto costituito dalla dimensione casuale quasi arbitraria inerente ad ἁμόθεν proprio mentre dichiara lrsquoassenza di un determinato piano compositivo implica in realtagrave che il racconto non si svolgeragrave per filo e per segno secondo lrsquoordine noto a poeta e uditori non si snoderagrave κατὰ κόσμον (laquoper ordineraquo) come il canto di Demodoco (VIII 489) ma seguiragrave un andamento originale Il ldquopunto qualsiasirdquo incipitario non rappresenta una scelta della Musa (figura dellrsquoarchivio tematico che conserva le laquovieraquo dellrsquoepica) bensigrave di questo cantore che ha deciso di far incominciare la narrazione in medias res e ha in serbo la sorpresa di far succedere al concilio degli degravei (che decide lrsquoinvio di Ermes presso Calipso) non lrsquoazione testeacute programmata (azione che viene differita con un ritardo che a piugrave riprese ha scandalizzato i lettori a principio del V canto) ma la partenza di Atena alla volta di Itaca e lrsquoavvio della laquoTelemachiaraquo Le due diverse vicende proposte a principio del poema quella di Telemaco e quella di Odisseo procedono infatti in parallelo coprendo un analogo lasso di tempo Piugrave oltre la decisione di trasformare la sequenza narrativa che va dalla partenza di Odisseo da Troia fino al suo arrivo nella terra dei Feaci in una rievocazione fatta dallrsquoeroe in prima persona al cospetto di Alcinoo e dei Feaci (la sezione detta degli ἀπόλογοι laquoraccontiraquo) crea una struttura ad anello che parte dal presente e ad esso fa ritorno dopo aver ricostruito le premesse della condizione attuale del protagonista Col canto XIII Odisseo egrave riportato dai Feaci a Itaca e questo permette la saldatura fra le vicende sue e quelle di Telemaco sia pure col differimento dellrsquoincontro e del riconoscimento fra padre e figlio fino al canto XVI Far scorrere in parallelo sequenze distinte organizzare programmi narrativi a corta e a lunga gittata tendere o allentare ad arte il ritmo della narrazione non si tratta davvero di procedimenti che potessero configurarsi come tradizionali dellrsquoarte epica quanto piuttosto di un momento sperimentale di una ricerca di soluzioni nuove al termine di una lunga e ormai consolidata sedimentazione di percorsi compiuti allrsquointerno di un determinato repertorio tematico unrsquoaudacia inventiva una πολυτροπίη degne del protagonista del poema che inevitabilmente comportavano rischi molteplici di incoerenze dissonanze occasionali avarie della macchina epica e che tuttavia erano destinate a conseguire un risultato assolutamente convincente allrsquoorecchio di chi si abbandonasse al fascino del racconto senza lrsquourgenza propria di altre etagrave e di altre mentalitagrave di puntare il dito sui singoli dettagli o le singole sfasature
PER SAPERNE DI PIUrsquo Difficoltagrave e incongruenze della narrazione omerica Forti della possibilitagrave di un controllo su un testo scritto che possiamo percorrere in avanti e a ritroso secondo ritmi di nostra scelta a noi non riesce difficile cogliere alcune delle difficoltagrave organizzative incontrate nella composizione del poema In proposito per ricordare un caso che saragrave allrsquoorigine delle discussioni di orientamento ldquoanaliticordquo intorno allrsquoOdissea possiamo leggere il discorso che Atena prese le sembianze di Mente re dei Tafi rivolge a Telemaco nel I canto (vv 253-305) Ah infelice ti manca molto davvero lrsquoassente Odisseo che getti le mani addosso ai pretendenti sfrontati Percheacute se ora tornato stesse sulla soglia 255 con una scure lo scudo e due lance cosigrave come io per la prima volta lo vidi in casa nostra che beveva e godeva di ritorno da Efira da Ilo di Mermero (andograve anche ligrave Odisseo con la nave veloce 260 in cerca del veleno omicida per averne da ungere le frecce di bronzo ma quello non glielo diede percheacute temeva gli dei che vivono eterni
Letteratura greca [1]
27
glielo diede invece mio padre percheacute lrsquoamava moltissimo) se stesse Odisseo tra i pretendenti cosigrave 265 essi avrebbero tutti rapida morte e nozze amare Ma sulle ginocchia degli dei questo giace se una volta tornato faragrave o no vendetta nella sua casa te invece io esorto a riflettere come cacciare i pretendenti da casa 270 Ebbene ora ascolta e alle mie parole darsquo retta Domattina chiamati gli eroi Achei a consiglio rivolgi a tutti un discorso e siano testimoni gli dei Ai pretendenti comanda drsquoandarsene per i fatti loro e tua madre se lrsquoanimo la spinge alle nozze 275 ritorni a casa del padre molto potente Prepareranno essi le nozze e disporranno i doni nuziali moltissimi quanti gli pare che debbano andare alla figlia A te darograve un saggio consiglio se vuoi ascoltarlo armata una nave con venti remi la migliore che crsquoegrave 280 Varsquo a domandare del padre partito da tempo se mai te ne parli un mortale o sentissi da Zeus la voce che divulga la fama tra gli uomini Anzitutto varsquo a Pilo e interroga il chiaro Nestore di ligrave poi varsquo a Sparta dal biondo Menelao 285 degli Achei vestiti di bronzo egli egrave tornato per ultimo Se senti dire qualcosa sulla vita e il ritorno del padre per quanto stremato potresti sopportare un altro anno se invece senti dire che egrave morto e non vive allora tornato nella cara terra patria 290 ergigli un tumulo e offrigli funebri offerte moltissime quanto conviene e darsquo tua madre a un marito E poi dopo aver compiuto e fatto ogni cosa allora medita nella mente e nellrsquoanimo come tu possa uccidere nelle tue case 295 i pretendenti con lrsquoinganno affrontandoli non devi piugrave avere i modi di un bimbo percheacute ormai non sei tale Non senti lrsquoillustre Oreste quale gloria ha acquistato fra tutti gli uomini percheacute uccise lrsquoassassino del padre Egisto esperto di inganni che gli uccise il nobile padre 300 Anche tu caro infatti molto bello e grande ti vedo sii valoroso percheacute ti lodi anche qualcuno dei posteri Ma io tornerograve adesso alla nave veloce dai compagni che forse impazienti mi aspettano Tu devi pensarci da te dammi retta 305
[Tr di GA Privitera] Le stranezze non mancano davvero e cosigrave sono state messe a fuoco da Stephanie West nel suo commento23 1 Atena sa evidentemente molto piugrave di quanto uno come Mente avrebbe potuto sapere in particolare ella sa che i proci ignoreranno lrsquoinvito di Telemaco a lasciare la sua casa e fatto piugrave importante che gli degravei tra breve ricondurranno in patria Odisseo A queste osservazioni si puograve replicare con la stessa West che laquosi sono esagerate difficoltagrave e
23 Omero Odissea I cit 219 ss
Letteratura greca [1]
28
incongruenze alle quali un pubblico di ascoltatori (o anche un lettore moderatamente attento) probabilmente non farebbe casoraquo 2 Il progetto di una pubblica denuncia dei proci dinanzi agli degravei e agli uomini ai vv 273-274 egrave ciograve che Atena sembra prefiggersi nel promuovere lrsquoassemblea degli Itacesi (assemblea che effettivamente avragrave luogo a principio del canto II) drsquoaltra parte le successive istruzioni di AtenaMente ai vv 295 s (medita come uccidere i pretendenti) presuppongono che di quella richiesta da formulare nel corso dellrsquoassembla essi non terranno alcun conto Anche a questa osservazione si puograve rispondere che laquoegrave ragionevole attendersi che Telemaco condivida la previsione di un esito negativo della sua iniziativaraquo e si puograve aggiungere che pure in caso di insuccesso il ricorso allrsquoassemblea potrebbe ottenere almeno il risultato di screditare i pretendenti presso la comunitagrave itacese legittimando un successivo ricorso alla violenza (e si tratta di una legittimazione di cui anche lrsquoultimo canto mostreragrave lrsquoesigenza) 3 Dopo che Telemaco aveva detto che la madre non intendeva risposarsi (vv 249-250) AtenaMente si esprime ai vv 275-278 come se Penelope desiderasse proprio nuove nozze e inoltre sarebbe assurdo che il padre di Penelope cominciasse a contrattare un secondo matrimonio prima del ritorno di Telemaco dal suo viaggio e che mettesse mano a preparativi che rischierebbero di essere annullati qualche tempo dopo con inevitabile imbarazzo se Telemaco venisse a sapere che Odisseo egrave ancora vivo In piugrave lrsquoandamento sintattico di questi versi presenta un anacoluto durissimo per cui a principio del v 275 lrsquoaccusativo μητέρα egrave seguito da un ἂψ ἴτω (laquovada indietroraquo laquotorniraquo) che richiederebbe come soggetto un nominativo μήτηρ Come hanno reagito i lettori di Omero Nellrsquoantichitagrave un grammatico rimasto anonimo cambiava come attesta uno scolio μητέρ᾽ in μήτηρ nel secolo XVIII Richard Bentley modificava ἴτω in ἴμεν (infinito eolico di εἶμι laquovadoraquo) nel XIX un altro grande della filologia europea Gottfried Hermann risolveva piugrave drasticamente la questione eliminando il complesso dei vv 275-278 e la stessa West mostra simpatia per tale proposta supponendo laquounrsquoaggiunta posteriore modellata sul corrispondente passo del libro IIraquo (dove i vv 196 s sono identici ai vv 277 s e il v 195 copre lo stesso contenuto dei vv 275 s) Si tratta di procedimenti adeguati ai dati di fatto Migliorano davvero il testo che ci egrave stato tramandato In realtagrave ambedue le ldquocorrezionirdquo appena ricordate (di μήτερ᾽ e di ἴτω) ottengono un risultato tanto lineare che egrave davvero difficile pensare che lrsquoanacoluto avrebbe potuto invadere tutta la tradizione se non fosse stato originario e quanto allrsquoespunzione dei vv 275-278 essa indubbiamente peggiorerebbe il ritmo del discorso determinando lrsquoavvicinamento fra i due versi (v 271 e v 279) molto simili fra loro che aprono le due sequenze occupate dai consigli di Mente E allora La via piugrave saggia egrave senzrsquoaltro quella di tenerci qui come quasi sempre di fronte al testo omerico contraddizioni e anacoluti riconoscendo in essi lrsquoeffetto dellrsquoattivitagrave di un cantore che pur sulla base di una traccia largamente memorizzata restava pur sempre legato a quella prassi orale per cui composizione ed esecuzione tendevano a coincidere E lrsquoanacoluto si spiega bene se cerchiamo di immedesimarci nel procedimento seguito dal poeta Egli ha affidato ad Atena un certo flusso argomentativo per cui la dea deve dar consigli a Telemaco sui suoi rapporti coi proci e con la madre e cosigrave colloca in fine di v 274 un ἄνωχθι (laquoordinaraquo) destinato a reggere gli accusativi simmetricamente dislocati in principio di verso (vv 274 e 275) μνηστῆρας e μητέρα Senoncheacute giunto a questa seconda parte dellrsquoargomentazione egli si avvede quanto sarebbe illogico che Telemaco sollecitasse la madre a nuove nozze di qui lrsquoimprovviso cambio di costruzione che svincola al prezzo di una sensibile slogatura sintattica lrsquoipotesi delle nuove nozze dallrsquoordine impartito a Telemaco e la prospetta invece come un desiderio eventuale della stessa Penelope Il poeta ha un progetto ben meditato brani e sequenze piugrave volte sperimentati ed egrave col supporto di questi materiali giagrave elaborati che egli si fa strada attraverso le insidie della
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
11
misura di quasi 1 m di diametro (appunto parrebbe i πλυνοί hellip λαΐνεοι i laquolavatoi di pietraraquo ricordati da Omero) Achei e Troiani Fra XIII e XII secolo aC Troia era un grande centro politico e commerciale in grado di controllare lrsquoaccesso ai Dardanelli (lrsquoantico Ellesponto) e il trasporto su terra di beni di vario genere dalla costa egea al Mar di Marmara (lrsquoantica Propontide) e al Mar Nero In Troia VIIa egrave stata rinvenuta ceramica micenea del periodo noto come Tardo Elladico IIIB che egrave anche il periodo di maggiore splendore dei palazzi micenei sul continente greco Ersquo suggestiva lrsquoidentificazione piugrave volte avanzata in tempi recenti di TroiaIlio con Wilusa la cittagrave menzionata spesso in testi hittiti e oggetto di contesa fra gli Hittiti e quegli Ahhiyawa il cui nome sembra identificarsi con quello degli laquoAcheiraquo (Ἀχαιοί) Il documento piugrave significativo in proposito egrave il preambolo del trattato stipulato verso il 1280 aC fra il re hittita Muwattali II e Alaksandu re di Wilusa che contiene un richiamo alle precedenti relazioni fra i due stati a partire dal 1600 pur ricordando che un tempo Wilusa era sotto il dominio hittita Muwatalli afferma di aver mantenuto relazioni pacifiche anche dopo che la cittagrave era divenuta indipendente Inoltre un testo religioso hittita rinvenuto a Hattusa la capitale dellrsquoimpero hittita e databile al XIII secolo ricorda nellrsquoambito di un rituale la recita di un poema in luvio (il luvio egrave una lingua indo-europea che si distingue solo superficialmente dallrsquohittita) di cui viene riportato il primo verso laquoQuando tornarono dallrsquoerta Wilusaraquo E a Troia negli scavi piugrave recenti egrave stato trovato un sigillo con unrsquoiscrizione in luvio Drsquoaltra parte in Omero la dinastia reale troiana di cui egrave a capo Priamo figlio di Laomedonte viene fatta risalire attraverso Erittonio Troo e Ilo fino a Dardano eponimo dei Dardani che si erano stanziati nella Troade a nord del monte Ida (Iliade ΧΧ 215 ss) I Dardani nellrsquoIliade compaiono fra i principali alleati dei Troiani accanto ai contingenti provenienti da Zelea (a nord-est lungo il fiume Esepo) e a quelli di localitagrave situate sulla Propontide come Adrestea e Pitea e sulla costa asiatica dellrsquoEllesponto come Abido e Arisbe Dalla costa europea arrivano invece i Traci i Ciconi e i Peoni da oriente i Paflagoni e gli Alizoni da sud-est i Misi e i Frigi dalla zona sud-occidentale dellrsquoAnatolia i Meoni i Cari e i Lici Se Dardani Peoni Ciconi e Traci fanno parte delle popolazioni traco-frigie che fra XII e XI secolo erano scese dai Balcani in direzione dellrsquoAnatolia (cfr Erodoto 7 73 e Xanto di Lidia FGrHist 765 F 14) i Meoni sono di stirpe lidia mentre i Cari e i Lici appartengono allrsquoambito culturale e linguistico luvio-hittita Comunque sia diversamente che per Erodoto il quale inserisce il rapimento di Elena nel quadro di una serie di torti reciproci in forma di rapimenti di donne fra Greci e barbari (I 2 1) e per i poeti tragici ateniesi del V secolo aC in Omero lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato come un contrasto fra culture diverse I Troiani mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei (detti anche laquoDanairaquo - cioegrave discendenti di Danao - o laquoArgiviraquo in relazione al contingente proveniente dallrsquoArgolide guidato da Agamennone il capo della spedizione) e lo stesso vale per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari in Iliade ΙΙ 867 come laquodi lingua stranieraraquo (βαρβαρόφωνοι) suggerisce che un tale epiteto non sarebbe stato applicabile ai Troiani Infine sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di unrsquoimbarcazione sono altrettanti esempi di quelle che W Arend denominograve laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini comportamentali e tecnologiche del gruppo che le condivide (vedi scheda p xxx) La societagrave omerica
Letteratura greca [1]
12
Nel rapporto fra il mondo omerico e la storia egrave innanzi tutto da sottolineare lrsquoesistenza di un duplice piano di riferimento con talune interferenze dellrsquouno nellrsquoaltro da un lato crsquoegrave lrsquoorizzonte dei fatti collocati in un passato glorioso dallrsquoaltro lrsquoorizzonte del poeta Giagrave gli studiosi alessandrini del resto notavano che dati come lrsquoarte di montare a cavallo i segnali per mezzo della tromba e lrsquouso di bollire la carne compaiono nellrsquoIliade solo allrsquointerno delle similitudini E il testo con una sorta di arcaismo intenzionale mostra talora la consapevolezza dellrsquoabisso che separa passato e presente come quando in Iliade XII 445-449 si dice
Ettore intanto un sasso afferrograve ndash e lo portava ndash che prima stava davanti alle porte largo di sotto ma sopra era a punta questo due uomini i piugrave forti del popolo difficilmente isserebbero da terra su un carro quali son ora i mortali egli da solo lo roteava a suo agio
[Tr di R Calzecchi Onesti] Per contro le condizioni sociali rappresentate nei poemi (un mondo di grandi proprietari terrieri che reggono aziende agricole autarchiche da cui hanno preso tuttavia a distaccarsi alcune figure di artigiani il fabbro il vasaio il carpentiere il medico lrsquoindovino lrsquoaedo) rispecchiano assai piugrave la situazione storica fra VIII e VII secolo a C che le strutture della societagrave micenea Inoltre i cadaveri vengono cremati secondo la prassi piugrave recente non inumati anche se molti riferimenti omerici non rispecchiano necessariamente la pratica normale del tempo di pace trattandosi di cremazioni che avvengono oltremare non ambigua egrave comunque la testimonianza relativa alla prassi umana in generale fornita da Odissea XI 216-222 (Anticlea a Odisseo)
Ohimegrave figlio mio il piugrave misero di tutti gli uomini Persefone la figlia di Zeus non ti inganna ma la legge degli uomini egrave questa quando si muore i nervi non reggono piugrave la carne e le ossa ma la furia violenta del fuoco ardente li disfa appena la vita abbandona le bianche ossa e lrsquoanima vagola volata via come un sogno
[Tr di GA Privitera]19 Un esempio significativo di sovrapposizione tra fasi culturali distinte si coglie osservando lrsquoinventario degli oggetti accanto ad armi vasi ornamenti tipici dellrsquoVIII-VII secolo troviamo relitti risalenti allrsquoepoca micenea come la coppa di Nestore ornata di colombe descritta in Iliade XI 632 ss (simile a una coppa drsquoargento rinvenuta a Micene che riproduce disegno e artigianato dellrsquoetagrave del bronzo) lrsquoelmo di cuoio con zanne di cinghiale che Merione dagrave a Odisseo (Iliade X 261 ss) e lo scudo lungo laquosimile a torreraquo di Aiace che egrave di un tipo inusitato dopo il XIII secolo Un oggetto non riferibile neacute al mondo miceneo neacute allrsquoetagrave della fissazione dei poemi bensigrave alla prima etagrave del ferro egrave invece la coppia di aste da lancio adottate verso il 900 aC e scomparse due secoli dopo con lo sviluppo del combattimento oplitico e la reintroduzione dellrsquoasta per colpire e la menzione delle navi fenicie (una volta nellrsquoIliade e cinque volte nellrsquoOdissea) riflette la loro comparsa nellrsquoEgeo nel IX secolo aC Non diversamente sembra avvenire anche per le istituzioni politiche lrsquo ἄναξ egrave visto a volte come figura di autocrate assoluto a volte fortemente limitato dai poteri delle assemblee ndash sia quella dei capi (βουλή) sia quella delle truppe (ἀγορή) ndash o insidiato dallrsquoascesa dei gruppi aristocratici mentre il βασιλεύς non egrave piugrave il dignitario della societagrave micenea ma genericamente un principe o un capo LʼIliade
19 Omero Odissea III intr testo e commento di A Hoekstra tr di GA Privitera Mondadori Milano 1984
Letteratura greca [1]
13
LrsquoIliade (Ἰλιάς) consta di circa 15690 esametri divisi secondo una partizione che potrebbe risalire al primo editore alessandrino (Zenodoto di Efeso) in 24 libri indicati con le lettere maiuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquounitagrave strutturale di parecchi canti che spesso finiscono col tramonto o iniziano con lrsquoalba e la coincidenza fra alcuni dei titoli attribuiti a ciascun canto nelle edizioni alessandrine e quelli che si rintracciano in autori precedenti (ad es Tucidide [I 10 4] cita il ldquoCatalogo delle navirdquo cioegrave il canto II) provano che non si trattograve di una divisione arbitraria bensigrave fondata almeno in certa misura sulle abitudini dei rapsodi Tema dellrsquoopera non egrave lrsquointero assedio decennale di Troia da parte dei Greci (di norma detti Achei o Danai o Argivi) provocato dal rapimento di Elena ad opera di Paride ma una porzione assai limitata del conflitto una sequenza narrativa che copre la durata di 51 giorni e si colloca verso la fine del nono anno di guerra lrsquoira di Achille contro lrsquoAtride Agamennone il suo ritiro dalla guerra e le relative conseguenze la fine dellrsquoira lrsquouccisione e i funerali di Ettore Fu proprio questa delimitazione tematica a consentire la realizzazione di quellrsquounitagrave e compiutezza dellrsquoazione che giagrave Aristotele individuava come uno dei pregi essenziali dellrsquoopera di Omero rispetto agli altri poemi epici arcaici (Poetica 1459a-b)20
anche in questo Omero deve apparire mirabile in confronto agli altri per non aver tentato di rappresentare intera la guerra anche se essa aveva un principio e una fine il racconto sarebbe risultato troppo grande e non abbracciabile con uno sguardo oppure pur misurato nella grandezza intricato per la varietagrave Ricavatane invece una parte ha fatto uso di molti episodi per esempio con il ldquoCatalogo delle navirdquo e con altri episodi fa procedere in lungo il poema Gli altri invece come lrsquoautore delle Ciprie o della Piccola Iliade compongono unrsquoazione multipla su unrsquounica persona o un unico tempo Di conseguenza mentre dallrsquoIliade e dallrsquoOdissea si ricava unrsquounica tragedia o soltanto due da ciascuna dalle Ciprie parecchie
[Tr di D Lanza]21
Canto I Lrsquoazione si apre sul campo degli Achei devastato dalle frecce scagliate da Apollo [T1] il dio ha scatenato una pestilenza percheacute Agamennone ha rifiutato il riscatto offerto dal sacerdote Crise per la liberazione della figlia Criseide divenuta schiava dellrsquoAtride Ai guerrieri convocati in assemblea lrsquoindovino Calcante rivela che la sola via di scampo egrave la restituzione di Criseide al padre Agamennone acconsente ma solo a patto che gli venga data in cambio Briseide la schiava che Achille tiene nella sua tenda come premio personale (γέρας) ricevuto dagli altri guerrieri Achille non puograve opporsi alla prevaricazione dellrsquoAtride ma non egrave disposto a subire passivamente lrsquooltraggio e insulta Agamennone anzi egrave giagrave pronto a estrarre la spada dal fodero per farsi giustizia quando viene trattenuto da Atena apparsa allrsquoimprovviso allora si ritira nella tenda giurando che non combatteragrave piugrave [T2] Quindi invoca la madre Tetide che dopo essere apparsa al figlio sulla riva del mare intercede presso Zeus e ottiene la promessa che i Greci non vinceranno la guerra e non espugneranno Troia fincheacute Achille non riceveragrave soddisfazione per lrsquooffesa subita Ma il piano di Zeus non resta celato ad Era che ingelosita provoca una lite nel corso del banchetto degli dei tuttavia la visione di Efesto zoppicante che funge da coppiere suscita lrsquoilaritagrave dei numi e riporta la serenitagrave Canto II Quella stessa notte Zeus manda ad Agamennone un sogno ingannatore per incitarlo ad attaccare Troia LrsquoAtride riferisce il sogno agli anziani e comanda lrsquoadunata dellrsquoesercito
20 Cfr anche 1462b ταῦτα τὰ ποιήματα συνέστηκεν ὡς ἐνδέχεται ἄριστα καὶ ὅτι μάλιστα μιᾶς πράξεως μίμησις (laquoQuesti poemi sono composti come meglio non si puograve e son il piugrave possibile imitazione di unrsquounica azioneraquo) 21 Aristotele Poetica Milano Rizzoli 19902
Letteratura greca [1]
14
con lrsquoidea stravagante di saggiare lrsquoumore delle truppe proponendo il ritorno in patria Gli uomini incitati da Tersite corrono alle navi pronti a salpare ma vengono bloccati da Odisseo e da Nestore Egrave significativo che Tersite lrsquoanti-eroe riecheggi le accuse di Achille ad Agamennone sottolineando gli onori di cui questi gode e prenda le parti di Achille [T3] Per tutta la seconda parte del libro lrsquoazione viene interrotta per far posto alla grandiosa uscita in armi dellrsquoesercito acheo dal recinto delle navi un quadro scintillante ornato da una catena di sei similitudini concatenate introdotte per illustrare il fulgore delle armi il rombo dei passi umani e degli zoccoli precipitosi lrsquoaspetto della schiera achea e la maestria dei condottieri Un ldquoCatalogo delle navirdquo contiene lrsquoelenco circostanziato delle genti greche che hanno preso parte allrsquoassedio ed egrave seguito da un catalogo piugrave breve e piugrave arido degli alleati dei Troiani accorsi in difesa di Ilio Canto III Lrsquoatteso scontro tra gli schieramenti appena passati in rassegna non ha luogo ParideAlessandro ottiene infatti una tregua per sfidare Menelao Iride la messaggera degli degravei spinge Elena ad accorrere alle mura presso le porte Scee per assistere al preannunciato duello di ligrave Priamo e gli altri anziani di Troia osservano la pianura Su richiesta del vecchio sovrano (una richiesta che sarebbe stata piugrave ldquoverosimilerdquo al primo anno di guerra) Elena nomina i piugrave prestigiosi campioni achei [T4] Nel duello che segue Paride si trova ben presto a mal partito contro Menelao ma Afrodite lo sottrae ai colpi del nemico avvolgendolo in una fitta nebbia e lo riporta nelle sue stanze dove dopo aver assunto lrsquoaspetto di una vecchia filatrice ordina a Elena di giacere con lui Elena si ribella ma la dea non transige Mentre Paride ed Elena si uniscono nellrsquoamplesso Menelao furibondo cerca fra la folla il nemico che sia i Greci che i Troiani sarebbero lieti di consegnargli pur di porre fine alla guerra Agamennone rivendicando la vittoria di Menelao pretende dai Troiani la restituzione di Elena e delle sue ricchezze noncheacute il pagamento di una forte ammenda Canto IV La tregua stipulata dopo la scomparsa di Paride viene infranta dallrsquoarciere Pandaro che sollecitato da Atena (scesa tra le schiere troiane su ordine di Zeus) ferisce con una freccia Menelao questi viene prontamente guarito dal medico Macaone figlio di Asclepio Agamennone passa fra le schiere incitandole a combattere incontra vari capi intenti a dare istruzioni ai propri uomini Solo Ulisse e Menesteo si tengono in disparte ricevendo i rimproveri di Agamennone ai quali Ulisse reagisce con indignazione Gli Achei muovono contro i Troiani con grande ordine e disciplina mentre i Troiani e i loro alleati schiamazzano come barbari Ha inizio la battaglia vera e propria nella quale lrsquoattenzione egrave focalizzata sui duelli individuali Ad assistere e rincuorare i Troiani compare Apollo sulla rocca di Troia mentre Atena infonde coraggio nei Greci Il canto si chiude sullrsquoinfuriare della battaglia la cui descrizione riprenderagrave nel canto successivo Canto V Balza in primo piano Diomede di cui viene presentata lrsquoἀριστεία lrsquoeroe laquoglorioso e chiaroraquo fa strage di nemici imperversando furiosamente fra le schiere troiane Nel pieno del combattimento viene ferito da una freccia scagliata da Pandaro il quale mena gran vanto del colpo andato a segno Diomede ottenuta unrsquoimmediata guarigione grazie allrsquointervento di Atena muove allora contro il nemico che nel frattempo era stato accolto sul carro di Enea Pandaro scaglia la sua lancia contro Diomede ma lo scudo di questi regge il colpo Diomede colpisce a sua volta uccidendo il nemico Enea scende dal cocchio per proteggere il cadavere di Pandaro dagli Achei che vorrebbero farne razzia ma Diomede lo colpisce con un grande masso fratturandogli il femore Enea viene salvato dallrsquointervento di Afrodite che lo avvolge nel suo manto mentre Diomede arriva addirittura a ferire al polso la dea che fugge sullrsquoOlimpo a farsi confortare dalla madre Dione Il figlio di Tideo attacca anche Apollo che aveva sottratto Enea alla sua furia ma
Letteratura greca [1]
15
egrave fermato dal grido di ammonimento del dio Incitati e aiutati da Ares ora i Troiani avanzano con impeto Intervengono Era e Atena e questrsquoultima assume il ruolo di auriga di Diomede Col suo aiuto questi ferisce al ventre Ares che fugge sullrsquoOlimpo Anche le dee vi fanno ritorno Canto VI Il canto VI egrave una naturale continuazione del V (tanto che Erodoto citeragrave come dallrsquoἀριστεία di Diomede un brano della prima parte del VI canto) La battaglia infuria nella pianura ma il furore di Diomede si stempera su una nota di cortesia quando lrsquoeroe dopo aver sfidato Glauco di Licia scopre di avere con lrsquoavversario antichi rapporti di ospitalitagrave I due si scambiano le armature (a detrimento di Glauco a cui laquoZeus Cronide levograve il senno cheacute scambiograve con Diomede Tidide armi drsquooro con armi di bronzo cento buoi con nove buoiraquo [vv 234-6]) Frattanto Ettore su invito dellrsquoindovino Eleno rientra in cittagrave dove le donne devono cercare di ottenere con offerte e voti il favore di Atena e incontra dapprima la madre Ecuba poi Paride (che intende ricondurre alla battaglia) vorrebbe salutare anche la moglie ma non la trova in casa bensigrave alle porte Scee dove Andromaca era accorsa piena drsquoangoscia insieme col figlioletto e con la nutrice Nel colloquio che segue ella lo implora di non esporre al pericolo se stessa e il figlio La replica di Ettore egrave esemplare per capire la prospettiva del poema e le motivazioni dellrsquoagire dei personaggi dominanti se Achille e gli eroi achei in genere cercano onore e gloria a questa motivazione (che pure non egrave assente) Ettore antepone lrsquoαἰδώς il senso di laquovergognaraquo e di responsabilitagrave nei confronti della comunitagrave e del nucleo familiare di cui egrave il difensore Poi si volta per prendere tra le braccia Astianatte ma lrsquoelmo lucente e il cimiero ondeggiante impauriscono il piccolo che si rifugia in seno alla nutrice Alla fine del canto Paride si incontra con Ettore e i due si avviano verso il campo di battaglia [T5] Canto VII A principio del canto VII Atena e Apollo si accordano per indurre Ettore a lanciare una sfida agli Achei per un duello Il sorteggio designa Aiace come campione greco Nello scontro Ettore lancia per primo lrsquoasta che penetra ma senza trapassarlo nello scudo di Aiace greve e massiccio (compaginato con sette strati di pelle bovina simile a una torre) Aiace di rimando lacera lo scudo e il pettorale della corazza ma non riesce a squarciare le carni del nemico percheacute Ettore si piega di lato Allora i due brandiscono di nuovo le aste poi ricorrono alle pietre Alla fine gli araldi arrestano il combattimento con la giustificazione che laquola notte giagrave viene ed egrave bene obbedire alla notteraquo (v 282) Su proposta di Nestore gli Achei decidono per il giorno seguente di seppellire i morti e di scavare una grande trincea difesa da un bastione sul margine del loro accampamento Respingono lrsquoofferta di pace dei Troiani (che prevederebbe la riconsegna dei tesori sottratti da Paride a Sparta) Il mattino seguente i morti vengono cremati e durante la giornata si erige il muro di protezione Canto VIII Nellrsquoassemblea degli degravei Zeus vieta ai numi di appoggiare lrsquouna o lrsquoaltra parte in conflitto Al mattino il combattimento riprende e a mezzogiorno Zeus pone i destini dei due popoli sulla bilancia che piega a favore dei Troiani Sul campo di battaglia Diomede salva Nestore Lrsquoazione di Ettore egrave travolgente fincheacute Zeus contravvenendo alla sua intenzione di favorire i Troiani accoglie la preghiera di Agamennone per risollevare il morale degli Achei che organizzano la difesa delle navi Nel corso degli scontri si segnala lrsquoarciere Teucro che colpisce i nemici muovendosi in sincronia con Aiace Telamonio che lo protegge con lo scudo Incitato da Agamennone egli prova a colpire anche Ettore ma soccombe colpito con una pietra A questa vista Era e Atena corrono ad armarsi per intervenire a favore degli Achei ma vengono distolte dalle minacce di Zeus che manifesta la propria intenzione di favorire i Troiani fino a quando i Greci non saranno ridotti alla disperazione tanto da scongiurare Achille percheacute ritorni Il sopraggiungere della notte
Letteratura greca [1]
16
interrompe i combattimenti Ettore galvanizzato dai successi ottenuti in quel giorno si illude che la vittoria sia a portata di mano e prospetta ai suoi una prossima ritirata degli Achei Il canto si chiude con il banchetto dei Troiani che banchettano nella pianura esaltati dalla speranza di vittoria Canto IX Agamennone affranto propone di fare ciograve che nel canto II aveva suggerito soltanto per mettere alla prova lrsquoesercito interrompere la guerra e tornare in patria Diomede si oppone e Nestore in un consiglio dei capi propone di tentare la riconciliazione con Achille Si invia alla tenda di Achille unrsquoambasceria (composta da Aiace Odisseo e Fenice antico pedagogo di Achille) per offrire doni ricchissimi Achille non cede anzi minaccia di salpare immediatamente verso la patria [T6] Inutilmente Fenice lrsquoantico precettore di Achille cerca di ammorbidire la determinazione del Pelide richiamando la vicenda dellrsquoeroe Meleagro [T7] Gli inviati riferiscono ad Agamennone la risposta di Achille egli torneragrave a combattere solo quando Ettore saragrave arrivato fino alle navi dei Mirmidoni Canto X Nella stessa notte si effettua una missione segreta nel corso della quale Odisseo e Diomede dapprima catturano la spia troiana Dolone (che Ettore aveva inviato alle navi achee promettendogli come ricompensa i cavalli di Achille) poi uccidono il re trace Reso appena arrivato presso i Troiani e ne rubano i magnifici cavalli Giagrave gli antichi ritenevano questo canto unrsquoaggiunta post-omerica e questi dubbi trovano riscontro in lati eccentrici della narrazione e nellrsquoimpiego di un linguaggio che spesso appare svincolato dal corrente repertorio formulare Canto XI Si apre una nuova giornata di battaglia (la cui narrazione si protrarragrave fino al canto XVIII) che ruota intorno allrsquoἀριστεία di Agamennone Quando lrsquoAtride viene ferito gli Achei ripiegano Diomede resta anchrsquoegli ferito Odisseo e Aiace evitano a stento la massa dei nemici Nestore salva sul suo carro Macaone Achille che dalla poppa della nave osserva la battaglia vuol sapere chi egrave condotto via da Nestore e manda Patroclo che viene accolto molto benevolmente e con cui Nestore intrattiene un lungo discorso egli dice di deplorare il comportamento di Achille e con atteggiamento consono alla sua condizione di anziano si dilunga nel raccontare le proprie gesta giovanili Egli esorta quindi Patroclo a far leva sulla sua amicizia per convincere Achille a riprendere il combattimento o - almeno - a concedere a Patroclo le sue armi per incutere timore nei Troiani Eccitato dalle parole del vecchio Patroclo si avvia verso la nave di Achille ma incontra Euripilo ferito che gli chiede aiuto ed egli impietositosi lo accompagna alla tenda e cura la ferita Canto XII Divisi in cinque contingenti i Troiani danno lrsquoassalto al muro eretto a difesa del campo acheo Sul campo di battaglia si manifesta un prodigio unrsquoaquila in cielo con un grosso serpente fra le zampe che riesce a ferire lrsquouccello e a sfuggire Polidamante che interpreta il segno come un presagio funesto consiglia di tornare indietro ma Ettore egrave di altro avviso Sarpedone e Glauco sferrano un attacco contro il muro e - pur rimanendo feriti - riescono ad aprire una breccia La battaglia infuria con esito incerto fincheacute Ettore con un macigno sfonda una delle porte consentendo ai Troiani di entrare in massa nel campo acheo mentre i Greci fuggono verso il mare Canto XIII Zeus distoglie lo sguardo dalla battaglia nella convinzione che nessuno fra gli dei avrebbe osato violare il divieto di intervenire ne approfitta invece Poseidone favorevole ai Greci Assunto lrsquoaspetto dellrsquoindovino Calcante il dio infonde nuovo vigore nei due Aiaci
Letteratura greca [1]
17
spronandoli al combattimento Gli Achei riconoscono lrsquointervento divino e riprendono fiducia I combattimenti si susseguono violentissimi Nella resistenza si distingue il re cretese Idomeneo Polidamante consiglia una seconda volta di interrompere la battaglia e accenna allrsquoimminente intervento di Achille Ettore non ascolta lrsquoammonimento e riprende lrsquoassalto Il canto si chiude con un suo scambio di insulti con Aiace Telamonio Canto XIV Mentre Diomede Odisseo e Agamennone tornano feriti allrsquoaccampamento Era per distogliere Zeus dalla battaglia e consentire a Poseidone di favorire gli Achei indossa la cintura magica di Afrodite e sollecita il consorte a un convegno amoroso sullrsquoIda dopo lrsquoamplesso Zeus cade in un sonno profondo e Hypnos (il Sonno) annuncia a Posidone che potragrave aiutare senza rischi gli Achei Ettore colpito con una pietra da Aiace resta a lungo in stato di incoscienza e i Troiani vengono respinti Canto XV Zeus si risveglia avvedendosi dellrsquoinganno subito e costringe Era a mandargli Iride e Apollo la prima allontaneragrave Posidone dal campo di battaglia Apollo inciteragrave Ettore a far retrocedere gli Achei fino alle navi dei Mirmidoni Riprende lrsquooffensiva troiana Apollo stesso abbatte il muro e scuotendo lrsquoegida atterrisce gli Achei Patroclo corre da Achille mentre i Troiani giagrave sono sul punto di appiccare il fuoco alle navi Canto XVI Patroclo in lacrime supplica Achille di intervenire o di mandare lui stesso al suo posto [T8] Achille gli consegna le proprie armi e gli fa promettere che non si avventureragrave oltre la zona delle navi Ma Patroclo trascinato dal suo stesso impeto oltrepassa il limite prescrittogli da Achille Abbatte Sarpedone figlio di Zeus attorno al cui cadavere infuria la lotta fincheacute Apollo lo sottrae alla mischia e Hypnos e Thanatos (il demone della morte) lo trasportano in Licia sua patria Patroclo continua lrsquoassalto alla testa dei Mirmidoni fin sotto le mura di Troia ma poco prima del tramonto al quarto assalto Apollo stesso assunto lrsquoaspetto di Asio lo percuote fra le spalle allora Euforbo lo colpisce con lrsquoasta ed Ettore lo trafigge Canto XVII Euforbo viene ucciso da Menelao ma Ettore riesce a catturare le armi di Achille indossate da Patroclo Vigorosamente sostenuti da Aiace gli Achei difendono il cadavere Una densa nebbia scende sui combattenti Zeus infonde nuovo ardimento nei cavalli di Achille piangenti per la fine di Patroclo [T9] Atena e Apollo arroventano la lotta attorno alla salma In seguito alla preghiera di Aiace Zeus dissolve la nebbia Menelao manda Antiloco figlio di Nestore a informare Achille della morte di Patroclo la cui salma viene intanto trascinata fuori della battaglia da Menelao e Merione mentre i due Aiaci offrono la necessaria copertura contro la furia incalzante dei nemici Canto XVIII Lo scoppio di selvaggio dolore a cui si abbandona Achille allrsquoudire della morte di Patroclo provoca lrsquoaccorrere dal mare di Tetide insieme con le Nereidi La madre gli promette di procurargli nuove armi Poicheacute la salma di Patroclo egrave tuttora contesa Achille fa la sua apparizione sul fossato e lancia un grido che atterrisce i nemici Efesto su preghiera di Tetide foggia le nuove armi fra cui un magnifico scudo su cui appaiono effigiati in bande concentriche gli aspetti salienti dellrsquoesistenza umana Canto XIX Il mattino seguente Tetide porta le armi al figlio e con lrsquoambrosia preserva la salma di Patroclo dalla decomposizione Achille convoca unrsquoassemblea dellrsquoesercito e rinuncia alla sua collera Agamennone lamenta di essere stato ldquoaccecatordquo da Zeus e promette doni
Letteratura greca [1]
18
riparatori [T10] Achille si lascia convincere a stento ad attendere che i soldati abbiano mangiato Poi gli armati si radunano e anche Achille si arma Il suo cavallo Xanto gli predice la prossima morte [T11] Canto XX Zeus consente agli degravei di partecipare alla nuova battaglia Enea scontratosi con Achille egrave tratto in salvo da Posidone Achille infuria come un incendio in una selva Canto XXI Achille colma di cadaveri il fiume Scamandro e cattura dodici giovani troiani che intende offrire in sacrificio a Patroclo non risparmia neppure Licaone figlio di Priamo che lo supplica con accenti di grande intensitagrave ma altrettanto intensa nella consapevolezza di un destino imminente egrave la pur spietata replica del Pelide [T12] Lo Scamandro solleva le proprie onde ma le fiamme di Efesto inaridiscono il terreno e domano la corrente Gli degravei si azzuffano Atena raggiunge Ares con una pietra Era rintuzza la furia di Artemide Infine tutti tornano sullrsquoOlimpo Apollo assunto lrsquoaspetto di Agenore respinge Achille percheacute i Troiani possano rifugiarsi allrsquointerno delle mura Canto XXII Il solo Ettore resta fuori nella pianura Invano Priamo ed Ecuba lo pregano di rientrare Mentre Achille si avvicina Ettore decide di affrontarlo ma quando quello gli egrave da presso col bronzo che gli lampeggia intorno laquosimile al raggio del fuoco ardente o del sole che sorgeraquo egrave afferrato dal panico e comincia a fuggire compiendo tre giri intorno alle mura Zeus pesa sulla bilancia i destini (le κῆρες) dei due eroi e quello di Ettore affonda in basso Allora Apollo lo abbandona e Atena apparsa a Ettore sotto le spoglie di suo fratello Deifobo gli si avvicina promettendogli aiuto e invece riporta ad Achille la lancia che gli era caduta fuori bersaglio Il colpo di risposta di Ettore rimbalza sullo scudo di Achille Ettore urla a Deifobo di passargli la sua lancia ma il falso Deifobo egrave scomparso ed Ettore comprende di trovarsi sullrsquoorlo dellrsquoabisso [T13] Achille gli trapassa la gola ed Ettore lo supplica di non oltraggiare la sua salma in risposta riceve la minaccia che finiragrave in pasto ai cani Achille trascina il cadavere alle navi attaccato al carro Priamo Ecuba e Andromaca si abbandonano al cordoglio a cui fanno eco le donne troiane Canto XXIII Viene preparato il banchetto funebre in onore di Patroclo la cui ombra nel corso della notte appare ad Achille chiedendo la sepoltura del corpo Il mattino seguente si appresta il rogo fra le offerte votive ci sono anche dodici giovani troiani Il giorno successivo si raccolgono le ossa di Patroclo Seguono i ludi funebri gare coi carri e con lrsquoarco duello in armi etc Canto XXIV Ogni giorno Achille trascina il cadavere di Ettore attorno alla tomba dellrsquoamico ma lo spettacolo offende gli degravei e al dodicesimo giorno Zeus decide di mandare Tetide percheacute induca suo figlio a restituire la salma di Ettore Iride viene inviata presso Priamo percheacute gli consigli di recarsi nel cuore della notte con un carro da trasporto e un copioso riscatto scortato da Ermes alla tenda di Achille Questi accoglie il vecchio con rispetto riconoscendo in lui lrsquoimmagine del padre lontano e si piega alla sua supplica [T14] Per volontagrave degli degravei il cadavere non egrave stato aggredito dalla putrefazione composto sul pianale del carro viene ricondotto dal padre a Troia Qui le lamentazioni rituali srsquoinnalzano dal gruppo delle donne (Andromaca Ecuba Elena) Si stipula una tregua di dodici giorni Per nove giorni i Troiani raccolgono legname poi anche il rogo di Ettore arde e si erige un tumulo
Letteratura greca [1]
19
Struttura e caratteri dellʼopera Poema di trama relativamente organica (soprattutto a partire dal canto XVI tutti gli avvenimenti tranne pochi episodi isolati ruotano attorno ai due principali antagonisti Ettore uccide Patroclo per vendicare Sarpedone e Achille uccide Ettore per vendicare Patroclo) pur se non privo di piugrave o meno cospicue incongruenze spiegabili in primo luogo con la lunga e complessa genesi orale dellrsquoopera lrsquoIliade lascia emergere in mezzo alle centinaia di nomi e alle intricate vicende alcuni caratteri delineati nella loro individualitagrave e innanzi tutto quelli di Achille e di Ettore accomunati dalla medesima coscienza di un destino di morte che sono pronti ad affrontare Appunto una tale attitudine a rappresentare i laquocaratteriraquo (ἤθη) dei suoi personaggi egrave un altro titolo di merito che Aristotele ascrive ad Omero (Poetica 1460a9-11)
dopo aver brevemente proemiato subito introduce un uomo una donna o un altro personaggio nessuno privo di caratterizzazione ma dotato di un carattere
Fondamentale per la struttura del poema egrave la novitagrave della prospettiva Possiamo presumere che i cosiddetti poemi ciclici22 mirassero a conservare lrsquoangolatura che era stata propria delle versioni pre-omeriche della saga troiana sigrave che puograve riuscire significativo il confronto fra lrsquoesordio della Piccola Iliade (dove muovendo da grandi entitagrave ndash la cittagrave il paese due popoli la guerra ndash viene lanciato secondo lrsquoespressione di J Latacz come laquouno sguardo dallrsquoesternoraquo)
Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην εὔπωλον ἧς πέρι πολλὰ πάθον Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος Canto Ilio e la terra dei Dardani dai bei puledri per la quale molti dolori patirono i Danai servitori di Ares
con lo laquosguardo internoraquo che caratterizza lrsquoinizio dellrsquoIliade
Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν ἡρώων αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν οἰωνοῖσί τε δαῖτα Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς Canta o dea di Achille figlio di Peleo la collera maledetta che pene innumerevoli inflisse agli Achei e molte scagliograve allrsquoAde vite possenti di eroi e ne faceva prede per i cani e pasto per gli uccelli e si avverava il volere di Zeus da quando primamente si separarono venuti a contesa LrsquoAtride sovrano di eroi e Achille magnifico
Argomento non egrave dunque come doveva avvenire nella tradizione del canto epico un evento complesso da inquadrare con un grandangolo onnicomprensivo e neppure come saragrave nellrsquoOdissea un personaggio colto nella multiforme varietagrave delle sue peregrinazioni egrave invece una reazione emotiva (lrsquoira di Achille) con le sue conseguenze (le innumerevoli morti degli Achei) Narrare di questa ira significa per il poeta cominciare da un punto preciso (laquoda quandoraquo) ossia dal momento della contesa e della separazione fra i due massimi eroi greci Agamennone il primo per potere (laquosovrano di eroiraquo) e Achille il primo per nobiltagrave e forza (δῖος) E sintomatica della bipolaritagrave del mondo epico in quanto mondo di degravei e di eroi egrave la sincronia per cui il taglio della narrazione coincide col decorso del laquovolere di Zeusraquo (Διὸς βουλή) forse da identificare con la promessa del dio a Tetide (rievocata piugrave oltre in questo
22 V cap II laquoLa tradizione omericaraquo
Letteratura greca [1]
20
stesso canto ai vv 518-527) di vendicare lrsquoaffronto subito da Achille o piugrave in generale con il corso degli eventi in quanto tutto come per definizione laquogiace sulle ginocchia di Zeusraquo Opera indubbiamente allrsquointerno del poema unrsquoidea formativa un progetto di qui un insieme monumentale unificato anche da una serie di corrispondenze a distanza fra cui particolare significato acquistano quelle fra primo e ultimo canto Nel canto I il vecchio Crise va come supplice presso Agamennone portando doni e supplicando la restituzione della figlia e Agamennone lo respinge aspramente minacciandolo di far ricorso alla violenza se dovesse tornare nel canto XXIV il vecchio Priamo va come supplice presso Achille portando doni e supplicando la restituzione del corpo del figlio Achille ha una prima reazione irosa (esordisce al v 560 con laquoSmetti di irritarmi vecchioraquo) ma poi accoglie la supplica E al di lagrave delle corrispondenze nelle linee dellrsquoazione si colgono fra principio e fine del poema alcuni importanti echi verbali in particolare fra XXIV 501 s
τοῦ νῦν εἵνεχ᾽ ἱκάνω νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενος παρὰ σεῖο φέρω δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα per lui [Ettore] vengo ora alle navi degli Achei per riscattarlo da te e ti porto compenso infinito
e I 12 s
ὁ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενός τε θυγάτρα φέρων δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα costui [Crise] venne alle navi rapide degli Achei per riscattare la figlia portando compenso infinito
fra XXIV 555-557
λῦσον ἵν᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδωmiddot σὺ δὲ δέξαι ἄποινα πολλά τά τοι φέρομενmiddot σὺ δὲ τῶνδrsquo ἀπόναιο καὶ ἔλθοις σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν restituiscimelo percheacute lo possa vedere con gli occhi e accogli il riscatto copioso che portiamo e tu possa goderne e tornare alla tua terra patria
e I 18-20
Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν εὖ δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκέσθαιmiddot παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην τὰ δ᾽ ἄποινα δέχεσθαι Atridi e voi altri Achei dai forti schinieri a voi concedano gli degravei che hanno le case in Olimpo di distruggere la cittagrave di Priamo e tornare facilmente in patria ma restituitemi la figlia e accettate il riscatto
fra XXIV 560 μηκέτι νῦν μ᾽ ἐρέθιζε (laquosmetti di irritarmiraquo) e I 32 μή μ᾽ ἐρέθιζε (laquonon mi irritareraquo) fra XXIV 568-570
τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς μή σε γέρον οὐδrsquo αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω καὶ ἱκέτην περ ἐόντα Διὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμάς Ora perciograve fra i dolori non mi eccitare lrsquoanimo ancora di piugrave bada o vecchio che non ti lasci neppure nella tenda
Letteratura greca [1]
21
bencheacute supplice e violi gli ordini di Zeus e I 26-28
μή σε γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω ἢ νῦν δηθύνοντ᾽ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο Mai te o vecchio io colga presso le concave navi ora a indugiare o piugrave tardi a tornare che piugrave non dovesse giovarti lo scettro e la benda del dio
(e infine XXIV 571 ὣς ἔφατ ἔδεισεν δ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ laquocosigrave diceva e il vecchio tremograve e obbediva alle paroleraquo ripete esattamente I 33) In effetti lrsquoepisodio terminale del poema col superamento dellrsquoira ad opera della pietagrave e del senso di unrsquoesistenza invasa dal dolore si propone come il rovesciamento consapevole dellrsquoepisodio iniziale che era apparso caratterizzato dalla cancellazione della pietagrave e del diritto dei supplici in nome della forza Al rifiuto iniziale del donoriscatto si oppone lrsquoaccettazione finale in consonanza con un principio-guida che opera nel poema secondo linee che alla fine si riunificano Agamennone restituisce Criseide al padre ma si appropria del dono fatto dagli altri Achei ad Achille (Briseide) Achille respinge i doni fatti da Agamennone per indurlo a riconciliarsi con lui ma dopo aver contestato nel IX canto la nozione che la vita umana possa essere barattata con una massa di beni torna alla lotta non in cambio di qualche premio da conquistare ma per vendicare lrsquouccisione dellrsquoamico Patroclo e tanto nella lotta sul campo di battaglia quanto nellrsquoinfierire sul cadavere di Ettore si abbandona a un furore cosigrave smisurato e patologico che puograve essere superato solo con lrsquoaccettare i doni di Priamo non tuttavia per il loro valore drsquouso ma percheacute in Priamo Achille riconosce lrsquoombra del padre lontano Cosigrave lrsquoIliade appare attraversata da un impulso fondamentale che muove dallrsquoideologia del dono e dalla conseguente centralitagrave assegnata allrsquoonore (τιμή) come ldquoprezzordquo che qualifica il valore del guerriero ma supera questo piano di valutazione dei rapporti umani attraverso la loro riformulazione nei termini di un umanesimo esistenziale che ha come punti di riferimento lrsquoidentitagrave universale dei condizionamenti oggettivi (la vecchiaia la malattia la morte) e i legami che uniscono padre e figlio compagno e compagno vivi e morti (il cordoglio finale di Andromaca Ecuba ed Elena sulla salma di Ettore) Entro questo orizzonte progressivamente allargato la guerra le lotte lo scontro mortale finiscono col rappresentare solo un momento e un aspetto dellrsquoesistenza graditi tanto agli degravei che vi assistono come spettatori interessati quanto agli uditori che riascoltano le antiche gesta eppure non tali da appiattire il poema in una prospettiva guerresca conclusa in se stessa Molto del fascino delle battaglie e delle ἀριστεῖαι dellrsquoIliade sta nella presenza recondita di un occhio che sa guardare al di lagrave di esse (e al di lagrave della stessa distinzione fra Greci e Troiani vincitori e vinti) e che puograve anche attraverso le similitudini lasciare irrompere il mondo della natura o del lavoro umano nel mezzo delle battaglie LʼOdissea LrsquoOdissea (Ὀδύσσεια) consta di circa 12100 esametri divisi anchrsquoessi in 24 libri e indicati con le lettere minuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquoargomento egrave costituito dalle avventure di Odisseo dalla distruzione di Troia al ritorno alla patria Itaca esposte secondo un ordine che entrando subito nel vivo degli avvenimenti (lrsquoinizio del poema mostra Odisseo nellrsquoisola di Calipso) rievoca poi i fatti giagrave trascorsi e li ricongiunge infine a partire dal libro XV (con lrsquoarrivo di Telemaco alla capanna di Eumeo dove giagrave si trova Odisseo) in unrsquoazione unitaria La trama del poema i cui avvenimenti sono concentrati cronologicamente nello spazio di 40 giorni (ma sono narrati solo gli avvenimenti di 16 giorni e 8 notti) si articola in tre parti la laquoTelemachiaraquo (canti I-IV) il laquoRitorno di Odisseoraquo (canti V-XIII) e la laquoVendetta di Odisseoraquo (canti XIV-XXIV)
Letteratura greca [1]
22
Canto I Tutti gli eroi superstiti sono ormai tornati da Troia alle loro case tranne Odisseo che pur desideroso di tornare egrave trattenuto dalla ninfa Calipso nellrsquoisola di Ogigia Gli degravei hanno pietagrave di lui tranne Posidone irato per lrsquoaccecamento del figlio il ciclope Polifemo Ma un consiglio degli degravei assente Posidone (che si egrave recato presso gli Etiopi) delibera il ritorno dellrsquoeroe si decide che Ermes andragrave subito da Calipso mentre Atena si avvia verso Itaca sotto lrsquoaspetto del signore dei Tafi Mente per incoraggiare il figlio di Odisseo Telemaco a tener testa ai pretendenti della madre i laquoprociraquo (i quali aspirano al regno tramite le nozze con Penelope) e per indurlo a intraprendere un viaggio in cerca di notizie sul padre Canto IΙ Telemaco segue il consiglio della dea e il giorno seguente nellrsquoassemblea popolare chiede una nave per andare in cerca del padre ma la sua richiesta non viene discussa e Leocrito scioglie lrsquoassemblea Grazie ad Atena che ora ha assunto le sembianze di Mentore (antico amico di Odisseo) Telemaco riesce tuttavia a trovare una nave con cui salpa nel corso della notte allrsquoinsaputa sia della madre che dei proci Canto IΙΙ Telemaco e MentoreAtena arrivano a Pilo e sul lido trovano Nestore che sta offrendo un sacrificio a Posidone Il vecchio eroe accoglie ospitalmente Telemaco e gli comunica molte notizie sul ritorno di altri Achei ma nessuna su Odisseo Alla sera Atena scompare in forma di aquila e il mattino seguente Telemaco salpa insieme con Pisistrato (figlio di Nestore) alla volta di Sparta dove arriva la sera del giorno successivo Canto IV A Sparta Menelao sta festeggiando il doppio matrimonio del figlio e della figlia Il giorno seguente Telemaco chiede del padre Menelao gli racconta il proprio ritorno durante il quale aveva incontrato Proteo il vecchio nume marino che gli aveva riferito come Odisseo fosse trattenuto nellrsquoisola di Calipso Intanto a Itaca i proci preparano insidie meditando di uccidere Telemaco al suo ritorno Penelope ne viene a conoscenza ma Atena le appare in sogno per confortarla Canto V Dopo un secondo concilio degli degravei (in effetti un ldquodoppionerdquo di quello del I canto) Zeus manda finalmente Ermes presso Calipso con lrsquoordine di lasciar partire Odisseo La ninfa aiuta lrsquoeroe a costruirsi una zattera Al diciottesimo giorno di navigazione Odisseo egrave in vista dellrsquoisola dei Feaci Scheria quando Posidone di ritorno dal suo soggiorno presso gli Etiopi lo vede e suscita una tempesta che distrugge la zattera Ma la dea marina Ino Leucotea impietositasi gli porge il proprio velo sostenuto dal quale lrsquoeroe giunge a nuoto alla riva di Scheria dove si abbandona esausto addormentandosi Canto VI In seguito a un sogno inviatole da Atena Nausicaa la figlia del re dei Feaci Alcinoo si reca nei pressi della spiaggia a lavare le vesti insieme con le ancelle Odisseo risvegliatosi atterrisce le fanciulle che fuggono tutte allrsquoinfuori di Nausicaa Lrsquoeroe supplica la giovane di porgerle aiuto ed ella lo fa rivestire e lo accompagna fino al bosco di Atena poco prima della cittagrave esortandolo a presentarsi a suo padre Canto VII Protetto dalla nebbia di cui Atena lo ha avvolto Odisseo entra nel palazzo abbraccia le ginocchia della regina Arete e la caligine scompare poi viene accolto con onore da Alcinoo Arete chiede a Odisseo donde provenga e chi gli abbia donato gli abiti (a lei ben noti) che indossa Lrsquoeroe inizia a raccontare le disavventure che gli sono occorse dopo la
Letteratura greca [1]
23
partenza dallrsquoisola di Calipso Alcinoo gli promette di farlo ricondurre a Itaca il giorno seguente Canto VIII Ma lrsquoindomani Alcinoo fa apprestare un banchetto durante il quale lrsquoaedo Demodoco canta della contesa insorta un giorno fra Achille e Odisseo Lrsquoeroe si copre il volto per nascondere le lacrime allora Alcinoo interrompe il canto e organizza una serie di gare nel corso delle quali Odisseo primeggia Poi Demodoco al margine di unrsquoarea per la danza dove si esibiscono i ballerini feaci canta gli amori di Ares e Afrodite e la vendetta di Efesto (che incatena i due amanti) La sera al ritorno nel palazzo Demodoco racconta la storia del Cavallo di legno Odisseo scoppia nuovamente in lacrime e Alcinoo gli chiede di rivelare il suo nome Canto IX Odisseo dichiara il proprio nome e dagrave inizio al racconto della propria storia a partire dalla caduta di Troia distruzione di Ismaro e perdite subite ad opera dei Ciconi sbarco presso i Lotofagi (che si nutrono di un cibo misterioso che fa dimenticare il ritorno) dopo una terribile tempesta scatenatasi durante il tentativo di doppiare il capo Malea arrivo allrsquoisola antistante quella dei Ciclopi dove Odisseo si trasferisce con una sola nave esplorazione dellrsquoisola perdita di alcuni compagni allrsquointerno della caverna del gigante monocolo accecamento del mostro e fuga Canto X Odisseo giunge allrsquoisola di Eolo signore dei venti che lo accoglie benevolmente e gli consegna alla partenza tutti i venti chiusi in un otre ma poi lo respinge con durezza quando ritorna presso di lui percheacute i compagni (sospettando che nellrsquootre siano racchiuse cospicue ricchezze) hanno sciolto i venti e da essi si egrave sprigionato un uragano che li ha risospinti sullrsquoisola Ripreso il mare Odisseo egrave trasportato fino ai Lestrigoni antropofagi il cui attacco priva lrsquoeroe di tutte le altre navi tranne la propria Con questa fugge fino allrsquoisola (Eea) della maga Circe Dopo che Circe ha trasformato in porci un gruppo di compagni mandati innanzi ad esplorare lrsquoisola Odisseo ha la meglio sulla maga (a cui impone di restituire forma umana ai compagni) grazie allrsquoerba moly fornitagli da Ermes Resta un anno presso Circe che al momento della partenza gli consiglia di recarsi al paese dei morti per interrogare il vate Tiresia Canto XI Approdato alla terra dei Cimmeri (che vivono immersi in una nebbia perenne sulla riva dellrsquoOceano) e scavata una fossa Odisseo sacrifica ai morti e immola una vittima speciale a Tiresia Le anime accorrono dapprima Elpenore caduto per caso giugrave dal tetto della casa di Circe (Odisseo gli promette sepoltura) poi la madre Anticlea (che gli racconta di esser morta di dolore per la sua assenza) quindi Tiresia che gli vaticina le sue vicende future fino alla morte (questa lo coglieragrave dopo una lunga vita in un paese straniero che non conosce neacute il sale neacute il remo) Da un certo punto in poi il poeta dimentica il presupposto per cui Odisseo aveva scavato una fossa alla quale i morti accorrevano per bere il sangue delle vittime e bevendolo riacquistavano per breve tempo una piena consapevolezza immagina invece che Odisseo sia allrsquointerno dellrsquoAde In questa sezione rientrano la descrizione di Aiace sdegnato di Minosse di Orione dei grandi peccatori di Eracle Poi Odisseo fa ritorno a Eea e ricevuti i consigli di Circe si imbarca per il ritorno in patria Canto XII Scampato alle Sirene che invano lo attirano col canto (si egrave fatto legare allrsquoalbero della nave i compagni che remano hanno le orecchie turate con la cera) passa tra Cariddi e Scilla (che gli rapisce sei uomini) ed egrave costretto dai compagni ad approdare in contrasto con le prescrizioni di Circe allrsquoisola Trinachia dove pascolano le greggi del Sole I
Letteratura greca [1]
24
compagni spronati da Euriloco se ne cibano nonostante il divieto dellrsquoeroe Il Sole sdegnato ottiene da Zeus che la nave sia colpita dal fulmine Tutti i compagni periscono ma Odisseo che ripassa tra Scilla e Cariddi si salva miracolosamente da questrsquoultima aggrappandosi a un fico selvatico fincheacute il gorgo restituisce i rottami della nave infine arriva remando con le mani allrsquoisola di Ogigia Canto XIII Terminato il racconto lrsquoeroe riceve doni dai Feaci e la notte seguente egrave ricondotto a Itaca e deposto addormentato sulla spiaggia presso un antro sacro alle Ninfe Al risveglio per la nebbia non riconosce la sua terra fincheacute Atena in veste di giovane pastore lo rassicura e poi rivelatasi gli dagrave istruzioni su come far strage dei proci e lo trasforma in un vecchio mendico Canto XIV Odisseo si reca allo stazzo del suo porcaio Eumeo che pur non riconoscendolo lo accoglie ospitalmente rifocillandolo e offrendogli un mantello per ripararsi dal gelo notturno Canto XV A questo punto la laquoTelemachiaraquo si riannoda allrsquoazione principale Telemaco che si trova ancora a Sparta viene indotto da Atena a tornare a Itaca sulla via del ritorno a Pilo accoglie a bordo lrsquoindovino Teoclimeno e grazie allrsquoaiuto della dea sfugge alle insidie dei proci sbarca a Itaca e si reca anchrsquoegli presso Eumeo Canto XVI Questi va da Penelope ad annunciargli il ritorno del figlio Intanto Odisseo rimosso lrsquoincantesimo si svela nel suo vero aspetto a Telemaco e con lui progetta la vendetta sui proci (che intanto tramano una nuova insidia ai danni di Telemaco) Eumeo torna al suo stazzo Canto XVII Il mattino seguente Telemaco si reca in cittagrave seguito in un secondo tempo da Eumeo e Odisseo (che ha riassunto lrsquoaspetto di mendico) Davanti al palazzo Odisseo egrave riconosciuto dal cane Argo Entra e va mendicando tra i proci Antinoo lo colpisce alla spalla destra con uno sgabello Canto XVIII Odisseo si batte al pugilato col mendicante Iro Penelope scesa nella sala prospetta ai proci lrsquoeventualitagrave di un nuovo matrimonio Odisseo egrave insultato dalla schiava Melanto e schiva uno sgabello scagliato da Eurinomo Canto XIX Insieme con Telemaco lrsquoeroe allontana le armi dalla sala poi conversa con Penelope che gli racconta un sogno e gli espone il suo piano per sedare le contese tra i proci concedendosi sposa a colui che riusciragrave a tendere lrsquoarco di Odisseo la prova avverragrave il giorno seguente al novilunio Durante il colloquio la fida schiava Euriclea lava i piedi di Odisseo e riconosciutolo da unrsquoantica cicatrice sta per rivelarne lrsquoidentitagrave ma lrsquoeroe la costringe a tacere Canto XX Al mattino Euriclea e le ancelle fanno i preparativi per il banchetto Giungono Eumeo Melanzio e il mandriano Filezio Un presagio mandato da Zeus dissuade i proci dal progetto di uccidere Telemaco Durante il banchetto Teoclimeno predice la loro imminente rovina
Letteratura greca [1]
25
Canto XXI Penelope conduce lrsquoarco nella sala dopo che parecchi fra i proci e lo stesso Telemaco hanno tentato invano di tenderne la corda Odisseo chiede di partecipare alla prova tende lrsquoarco senza fatica e riesce a far passare la freccia attraverso gli anelli di dodici scuri predisposte da Telemaco Canto XXII Poi scaglia le frecce sui proci e si rivela nella sua identitagrave Nella lotta che segue Telemaco Eumeo e Filezio aiutano il padrone contro i proci (appoggiati dal capraio Melanzio) Tutti i proci restano uccisi le ancelle infedeli sono impiccate Melanzio viene mutilato e ucciso soltanto lrsquoaedo Femio e lrsquoaraldo Medonte sono risparmiati Canto XXIII Nuovo colloquio fra Odisseo e Penelope che durante lrsquoeccidio dormiva ed egrave stata svegliata da Euriclea Penelope esita ancora a riconoscere il marito e non si arrende alla veritagrave fincheacute Odisseo non le descrive la posizione e la struttura del letto coniugale Canto XXIV Ermes conduce allrsquoAde le ombre dei proci Odisseo fa visita al padre Laerte nella masseria dove quello vive nello squallore e nellrsquoemarginazione e si fa riconoscere Intanto il padre di Antinoo incita gli Itacesi alla rivolta e il poema si conclude con lo scontro di Odisseo e dei suoi contro i concittadini lrsquoeroe ha la meglio e Zeus scagliato il fulmine pone fine alla battaglia Atena sotto lrsquoaspetto di Mentore stabilisce fra i contendenti un patto per il futuro36
Struttura e caratteri dellʼopera Giagrave la prima parola del proemio (ἄνδρα) non menziona come tema dellrsquoopera un determinato episodio della vita del protagonista ma il protagonista stesso (I 1-10)
Ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα πολύτροπον ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεmiddot πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περmiddot αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο νήπιοι οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιονmiddot αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ τῶν ἁμόθεν γε θεά θύγατερ Διός εἰπὲ καὶ ἡμῖν Dellrsquouomo multiforme a me racconta o Musa che molto errograve dopo che di Troia la sacra rocca distrusse di molti uomini vide le cittagrave riconobbe il pensiero e molti per il mare patigrave dolori nellrsquoanimo per salvare la sua vita e il ritorno dei compagni Eppure non li salvograve i compagni per quanto bramasse per la loro stessa follia si persero gli stolti i buoi del Sole Iperione mangiarono e quello rapigrave ad essi il digrave del ritorno Di questo da un punto qualsiasi narra anche a noi o dea figlia di Zeus
Storie favolose di naviganti racconti imperniati sul ritorno dei guerrieri achei che avevano combattuto a Troia e il particolare rientro in patria di Odisseo figlio di Laerte erano forse giagrave stati connessi e intrecciati nella precedente tradizione epica sigrave che il presente cantore poteva
Letteratura greca [1]
26
metter mano alla vicenda partendo (v 10) laquoda un punto qualsiasiraquo (ἁμόθεν) una notazione che certo presuppone la convenzione propria dellrsquoesordio tradizionale di un canto epico comparabile con i giagrave ricordati ἐξ οὗ (laquoda quandoraquo) di Iliade I 4 ed ἔνθεν (laquoda doveraquo) di Odissea VIII 500 Senoncheacute rispetto a queste indicazioni di tipo puntuale il tratto costituito dalla dimensione casuale quasi arbitraria inerente ad ἁμόθεν proprio mentre dichiara lrsquoassenza di un determinato piano compositivo implica in realtagrave che il racconto non si svolgeragrave per filo e per segno secondo lrsquoordine noto a poeta e uditori non si snoderagrave κατὰ κόσμον (laquoper ordineraquo) come il canto di Demodoco (VIII 489) ma seguiragrave un andamento originale Il ldquopunto qualsiasirdquo incipitario non rappresenta una scelta della Musa (figura dellrsquoarchivio tematico che conserva le laquovieraquo dellrsquoepica) bensigrave di questo cantore che ha deciso di far incominciare la narrazione in medias res e ha in serbo la sorpresa di far succedere al concilio degli degravei (che decide lrsquoinvio di Ermes presso Calipso) non lrsquoazione testeacute programmata (azione che viene differita con un ritardo che a piugrave riprese ha scandalizzato i lettori a principio del V canto) ma la partenza di Atena alla volta di Itaca e lrsquoavvio della laquoTelemachiaraquo Le due diverse vicende proposte a principio del poema quella di Telemaco e quella di Odisseo procedono infatti in parallelo coprendo un analogo lasso di tempo Piugrave oltre la decisione di trasformare la sequenza narrativa che va dalla partenza di Odisseo da Troia fino al suo arrivo nella terra dei Feaci in una rievocazione fatta dallrsquoeroe in prima persona al cospetto di Alcinoo e dei Feaci (la sezione detta degli ἀπόλογοι laquoraccontiraquo) crea una struttura ad anello che parte dal presente e ad esso fa ritorno dopo aver ricostruito le premesse della condizione attuale del protagonista Col canto XIII Odisseo egrave riportato dai Feaci a Itaca e questo permette la saldatura fra le vicende sue e quelle di Telemaco sia pure col differimento dellrsquoincontro e del riconoscimento fra padre e figlio fino al canto XVI Far scorrere in parallelo sequenze distinte organizzare programmi narrativi a corta e a lunga gittata tendere o allentare ad arte il ritmo della narrazione non si tratta davvero di procedimenti che potessero configurarsi come tradizionali dellrsquoarte epica quanto piuttosto di un momento sperimentale di una ricerca di soluzioni nuove al termine di una lunga e ormai consolidata sedimentazione di percorsi compiuti allrsquointerno di un determinato repertorio tematico unrsquoaudacia inventiva una πολυτροπίη degne del protagonista del poema che inevitabilmente comportavano rischi molteplici di incoerenze dissonanze occasionali avarie della macchina epica e che tuttavia erano destinate a conseguire un risultato assolutamente convincente allrsquoorecchio di chi si abbandonasse al fascino del racconto senza lrsquourgenza propria di altre etagrave e di altre mentalitagrave di puntare il dito sui singoli dettagli o le singole sfasature
PER SAPERNE DI PIUrsquo Difficoltagrave e incongruenze della narrazione omerica Forti della possibilitagrave di un controllo su un testo scritto che possiamo percorrere in avanti e a ritroso secondo ritmi di nostra scelta a noi non riesce difficile cogliere alcune delle difficoltagrave organizzative incontrate nella composizione del poema In proposito per ricordare un caso che saragrave allrsquoorigine delle discussioni di orientamento ldquoanaliticordquo intorno allrsquoOdissea possiamo leggere il discorso che Atena prese le sembianze di Mente re dei Tafi rivolge a Telemaco nel I canto (vv 253-305) Ah infelice ti manca molto davvero lrsquoassente Odisseo che getti le mani addosso ai pretendenti sfrontati Percheacute se ora tornato stesse sulla soglia 255 con una scure lo scudo e due lance cosigrave come io per la prima volta lo vidi in casa nostra che beveva e godeva di ritorno da Efira da Ilo di Mermero (andograve anche ligrave Odisseo con la nave veloce 260 in cerca del veleno omicida per averne da ungere le frecce di bronzo ma quello non glielo diede percheacute temeva gli dei che vivono eterni
Letteratura greca [1]
27
glielo diede invece mio padre percheacute lrsquoamava moltissimo) se stesse Odisseo tra i pretendenti cosigrave 265 essi avrebbero tutti rapida morte e nozze amare Ma sulle ginocchia degli dei questo giace se una volta tornato faragrave o no vendetta nella sua casa te invece io esorto a riflettere come cacciare i pretendenti da casa 270 Ebbene ora ascolta e alle mie parole darsquo retta Domattina chiamati gli eroi Achei a consiglio rivolgi a tutti un discorso e siano testimoni gli dei Ai pretendenti comanda drsquoandarsene per i fatti loro e tua madre se lrsquoanimo la spinge alle nozze 275 ritorni a casa del padre molto potente Prepareranno essi le nozze e disporranno i doni nuziali moltissimi quanti gli pare che debbano andare alla figlia A te darograve un saggio consiglio se vuoi ascoltarlo armata una nave con venti remi la migliore che crsquoegrave 280 Varsquo a domandare del padre partito da tempo se mai te ne parli un mortale o sentissi da Zeus la voce che divulga la fama tra gli uomini Anzitutto varsquo a Pilo e interroga il chiaro Nestore di ligrave poi varsquo a Sparta dal biondo Menelao 285 degli Achei vestiti di bronzo egli egrave tornato per ultimo Se senti dire qualcosa sulla vita e il ritorno del padre per quanto stremato potresti sopportare un altro anno se invece senti dire che egrave morto e non vive allora tornato nella cara terra patria 290 ergigli un tumulo e offrigli funebri offerte moltissime quanto conviene e darsquo tua madre a un marito E poi dopo aver compiuto e fatto ogni cosa allora medita nella mente e nellrsquoanimo come tu possa uccidere nelle tue case 295 i pretendenti con lrsquoinganno affrontandoli non devi piugrave avere i modi di un bimbo percheacute ormai non sei tale Non senti lrsquoillustre Oreste quale gloria ha acquistato fra tutti gli uomini percheacute uccise lrsquoassassino del padre Egisto esperto di inganni che gli uccise il nobile padre 300 Anche tu caro infatti molto bello e grande ti vedo sii valoroso percheacute ti lodi anche qualcuno dei posteri Ma io tornerograve adesso alla nave veloce dai compagni che forse impazienti mi aspettano Tu devi pensarci da te dammi retta 305
[Tr di GA Privitera] Le stranezze non mancano davvero e cosigrave sono state messe a fuoco da Stephanie West nel suo commento23 1 Atena sa evidentemente molto piugrave di quanto uno come Mente avrebbe potuto sapere in particolare ella sa che i proci ignoreranno lrsquoinvito di Telemaco a lasciare la sua casa e fatto piugrave importante che gli degravei tra breve ricondurranno in patria Odisseo A queste osservazioni si puograve replicare con la stessa West che laquosi sono esagerate difficoltagrave e
23 Omero Odissea I cit 219 ss
Letteratura greca [1]
28
incongruenze alle quali un pubblico di ascoltatori (o anche un lettore moderatamente attento) probabilmente non farebbe casoraquo 2 Il progetto di una pubblica denuncia dei proci dinanzi agli degravei e agli uomini ai vv 273-274 egrave ciograve che Atena sembra prefiggersi nel promuovere lrsquoassemblea degli Itacesi (assemblea che effettivamente avragrave luogo a principio del canto II) drsquoaltra parte le successive istruzioni di AtenaMente ai vv 295 s (medita come uccidere i pretendenti) presuppongono che di quella richiesta da formulare nel corso dellrsquoassembla essi non terranno alcun conto Anche a questa osservazione si puograve rispondere che laquoegrave ragionevole attendersi che Telemaco condivida la previsione di un esito negativo della sua iniziativaraquo e si puograve aggiungere che pure in caso di insuccesso il ricorso allrsquoassemblea potrebbe ottenere almeno il risultato di screditare i pretendenti presso la comunitagrave itacese legittimando un successivo ricorso alla violenza (e si tratta di una legittimazione di cui anche lrsquoultimo canto mostreragrave lrsquoesigenza) 3 Dopo che Telemaco aveva detto che la madre non intendeva risposarsi (vv 249-250) AtenaMente si esprime ai vv 275-278 come se Penelope desiderasse proprio nuove nozze e inoltre sarebbe assurdo che il padre di Penelope cominciasse a contrattare un secondo matrimonio prima del ritorno di Telemaco dal suo viaggio e che mettesse mano a preparativi che rischierebbero di essere annullati qualche tempo dopo con inevitabile imbarazzo se Telemaco venisse a sapere che Odisseo egrave ancora vivo In piugrave lrsquoandamento sintattico di questi versi presenta un anacoluto durissimo per cui a principio del v 275 lrsquoaccusativo μητέρα egrave seguito da un ἂψ ἴτω (laquovada indietroraquo laquotorniraquo) che richiederebbe come soggetto un nominativo μήτηρ Come hanno reagito i lettori di Omero Nellrsquoantichitagrave un grammatico rimasto anonimo cambiava come attesta uno scolio μητέρ᾽ in μήτηρ nel secolo XVIII Richard Bentley modificava ἴτω in ἴμεν (infinito eolico di εἶμι laquovadoraquo) nel XIX un altro grande della filologia europea Gottfried Hermann risolveva piugrave drasticamente la questione eliminando il complesso dei vv 275-278 e la stessa West mostra simpatia per tale proposta supponendo laquounrsquoaggiunta posteriore modellata sul corrispondente passo del libro IIraquo (dove i vv 196 s sono identici ai vv 277 s e il v 195 copre lo stesso contenuto dei vv 275 s) Si tratta di procedimenti adeguati ai dati di fatto Migliorano davvero il testo che ci egrave stato tramandato In realtagrave ambedue le ldquocorrezionirdquo appena ricordate (di μήτερ᾽ e di ἴτω) ottengono un risultato tanto lineare che egrave davvero difficile pensare che lrsquoanacoluto avrebbe potuto invadere tutta la tradizione se non fosse stato originario e quanto allrsquoespunzione dei vv 275-278 essa indubbiamente peggiorerebbe il ritmo del discorso determinando lrsquoavvicinamento fra i due versi (v 271 e v 279) molto simili fra loro che aprono le due sequenze occupate dai consigli di Mente E allora La via piugrave saggia egrave senzrsquoaltro quella di tenerci qui come quasi sempre di fronte al testo omerico contraddizioni e anacoluti riconoscendo in essi lrsquoeffetto dellrsquoattivitagrave di un cantore che pur sulla base di una traccia largamente memorizzata restava pur sempre legato a quella prassi orale per cui composizione ed esecuzione tendevano a coincidere E lrsquoanacoluto si spiega bene se cerchiamo di immedesimarci nel procedimento seguito dal poeta Egli ha affidato ad Atena un certo flusso argomentativo per cui la dea deve dar consigli a Telemaco sui suoi rapporti coi proci e con la madre e cosigrave colloca in fine di v 274 un ἄνωχθι (laquoordinaraquo) destinato a reggere gli accusativi simmetricamente dislocati in principio di verso (vv 274 e 275) μνηστῆρας e μητέρα Senoncheacute giunto a questa seconda parte dellrsquoargomentazione egli si avvede quanto sarebbe illogico che Telemaco sollecitasse la madre a nuove nozze di qui lrsquoimprovviso cambio di costruzione che svincola al prezzo di una sensibile slogatura sintattica lrsquoipotesi delle nuove nozze dallrsquoordine impartito a Telemaco e la prospetta invece come un desiderio eventuale della stessa Penelope Il poeta ha un progetto ben meditato brani e sequenze piugrave volte sperimentati ed egrave col supporto di questi materiali giagrave elaborati che egli si fa strada attraverso le insidie della
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
12
Nel rapporto fra il mondo omerico e la storia egrave innanzi tutto da sottolineare lrsquoesistenza di un duplice piano di riferimento con talune interferenze dellrsquouno nellrsquoaltro da un lato crsquoegrave lrsquoorizzonte dei fatti collocati in un passato glorioso dallrsquoaltro lrsquoorizzonte del poeta Giagrave gli studiosi alessandrini del resto notavano che dati come lrsquoarte di montare a cavallo i segnali per mezzo della tromba e lrsquouso di bollire la carne compaiono nellrsquoIliade solo allrsquointerno delle similitudini E il testo con una sorta di arcaismo intenzionale mostra talora la consapevolezza dellrsquoabisso che separa passato e presente come quando in Iliade XII 445-449 si dice
Ettore intanto un sasso afferrograve ndash e lo portava ndash che prima stava davanti alle porte largo di sotto ma sopra era a punta questo due uomini i piugrave forti del popolo difficilmente isserebbero da terra su un carro quali son ora i mortali egli da solo lo roteava a suo agio
[Tr di R Calzecchi Onesti] Per contro le condizioni sociali rappresentate nei poemi (un mondo di grandi proprietari terrieri che reggono aziende agricole autarchiche da cui hanno preso tuttavia a distaccarsi alcune figure di artigiani il fabbro il vasaio il carpentiere il medico lrsquoindovino lrsquoaedo) rispecchiano assai piugrave la situazione storica fra VIII e VII secolo a C che le strutture della societagrave micenea Inoltre i cadaveri vengono cremati secondo la prassi piugrave recente non inumati anche se molti riferimenti omerici non rispecchiano necessariamente la pratica normale del tempo di pace trattandosi di cremazioni che avvengono oltremare non ambigua egrave comunque la testimonianza relativa alla prassi umana in generale fornita da Odissea XI 216-222 (Anticlea a Odisseo)
Ohimegrave figlio mio il piugrave misero di tutti gli uomini Persefone la figlia di Zeus non ti inganna ma la legge degli uomini egrave questa quando si muore i nervi non reggono piugrave la carne e le ossa ma la furia violenta del fuoco ardente li disfa appena la vita abbandona le bianche ossa e lrsquoanima vagola volata via come un sogno
[Tr di GA Privitera]19 Un esempio significativo di sovrapposizione tra fasi culturali distinte si coglie osservando lrsquoinventario degli oggetti accanto ad armi vasi ornamenti tipici dellrsquoVIII-VII secolo troviamo relitti risalenti allrsquoepoca micenea come la coppa di Nestore ornata di colombe descritta in Iliade XI 632 ss (simile a una coppa drsquoargento rinvenuta a Micene che riproduce disegno e artigianato dellrsquoetagrave del bronzo) lrsquoelmo di cuoio con zanne di cinghiale che Merione dagrave a Odisseo (Iliade X 261 ss) e lo scudo lungo laquosimile a torreraquo di Aiace che egrave di un tipo inusitato dopo il XIII secolo Un oggetto non riferibile neacute al mondo miceneo neacute allrsquoetagrave della fissazione dei poemi bensigrave alla prima etagrave del ferro egrave invece la coppia di aste da lancio adottate verso il 900 aC e scomparse due secoli dopo con lo sviluppo del combattimento oplitico e la reintroduzione dellrsquoasta per colpire e la menzione delle navi fenicie (una volta nellrsquoIliade e cinque volte nellrsquoOdissea) riflette la loro comparsa nellrsquoEgeo nel IX secolo aC Non diversamente sembra avvenire anche per le istituzioni politiche lrsquo ἄναξ egrave visto a volte come figura di autocrate assoluto a volte fortemente limitato dai poteri delle assemblee ndash sia quella dei capi (βουλή) sia quella delle truppe (ἀγορή) ndash o insidiato dallrsquoascesa dei gruppi aristocratici mentre il βασιλεύς non egrave piugrave il dignitario della societagrave micenea ma genericamente un principe o un capo LʼIliade
19 Omero Odissea III intr testo e commento di A Hoekstra tr di GA Privitera Mondadori Milano 1984
Letteratura greca [1]
13
LrsquoIliade (Ἰλιάς) consta di circa 15690 esametri divisi secondo una partizione che potrebbe risalire al primo editore alessandrino (Zenodoto di Efeso) in 24 libri indicati con le lettere maiuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquounitagrave strutturale di parecchi canti che spesso finiscono col tramonto o iniziano con lrsquoalba e la coincidenza fra alcuni dei titoli attribuiti a ciascun canto nelle edizioni alessandrine e quelli che si rintracciano in autori precedenti (ad es Tucidide [I 10 4] cita il ldquoCatalogo delle navirdquo cioegrave il canto II) provano che non si trattograve di una divisione arbitraria bensigrave fondata almeno in certa misura sulle abitudini dei rapsodi Tema dellrsquoopera non egrave lrsquointero assedio decennale di Troia da parte dei Greci (di norma detti Achei o Danai o Argivi) provocato dal rapimento di Elena ad opera di Paride ma una porzione assai limitata del conflitto una sequenza narrativa che copre la durata di 51 giorni e si colloca verso la fine del nono anno di guerra lrsquoira di Achille contro lrsquoAtride Agamennone il suo ritiro dalla guerra e le relative conseguenze la fine dellrsquoira lrsquouccisione e i funerali di Ettore Fu proprio questa delimitazione tematica a consentire la realizzazione di quellrsquounitagrave e compiutezza dellrsquoazione che giagrave Aristotele individuava come uno dei pregi essenziali dellrsquoopera di Omero rispetto agli altri poemi epici arcaici (Poetica 1459a-b)20
anche in questo Omero deve apparire mirabile in confronto agli altri per non aver tentato di rappresentare intera la guerra anche se essa aveva un principio e una fine il racconto sarebbe risultato troppo grande e non abbracciabile con uno sguardo oppure pur misurato nella grandezza intricato per la varietagrave Ricavatane invece una parte ha fatto uso di molti episodi per esempio con il ldquoCatalogo delle navirdquo e con altri episodi fa procedere in lungo il poema Gli altri invece come lrsquoautore delle Ciprie o della Piccola Iliade compongono unrsquoazione multipla su unrsquounica persona o un unico tempo Di conseguenza mentre dallrsquoIliade e dallrsquoOdissea si ricava unrsquounica tragedia o soltanto due da ciascuna dalle Ciprie parecchie
[Tr di D Lanza]21
Canto I Lrsquoazione si apre sul campo degli Achei devastato dalle frecce scagliate da Apollo [T1] il dio ha scatenato una pestilenza percheacute Agamennone ha rifiutato il riscatto offerto dal sacerdote Crise per la liberazione della figlia Criseide divenuta schiava dellrsquoAtride Ai guerrieri convocati in assemblea lrsquoindovino Calcante rivela che la sola via di scampo egrave la restituzione di Criseide al padre Agamennone acconsente ma solo a patto che gli venga data in cambio Briseide la schiava che Achille tiene nella sua tenda come premio personale (γέρας) ricevuto dagli altri guerrieri Achille non puograve opporsi alla prevaricazione dellrsquoAtride ma non egrave disposto a subire passivamente lrsquooltraggio e insulta Agamennone anzi egrave giagrave pronto a estrarre la spada dal fodero per farsi giustizia quando viene trattenuto da Atena apparsa allrsquoimprovviso allora si ritira nella tenda giurando che non combatteragrave piugrave [T2] Quindi invoca la madre Tetide che dopo essere apparsa al figlio sulla riva del mare intercede presso Zeus e ottiene la promessa che i Greci non vinceranno la guerra e non espugneranno Troia fincheacute Achille non riceveragrave soddisfazione per lrsquooffesa subita Ma il piano di Zeus non resta celato ad Era che ingelosita provoca una lite nel corso del banchetto degli dei tuttavia la visione di Efesto zoppicante che funge da coppiere suscita lrsquoilaritagrave dei numi e riporta la serenitagrave Canto II Quella stessa notte Zeus manda ad Agamennone un sogno ingannatore per incitarlo ad attaccare Troia LrsquoAtride riferisce il sogno agli anziani e comanda lrsquoadunata dellrsquoesercito
20 Cfr anche 1462b ταῦτα τὰ ποιήματα συνέστηκεν ὡς ἐνδέχεται ἄριστα καὶ ὅτι μάλιστα μιᾶς πράξεως μίμησις (laquoQuesti poemi sono composti come meglio non si puograve e son il piugrave possibile imitazione di unrsquounica azioneraquo) 21 Aristotele Poetica Milano Rizzoli 19902
Letteratura greca [1]
14
con lrsquoidea stravagante di saggiare lrsquoumore delle truppe proponendo il ritorno in patria Gli uomini incitati da Tersite corrono alle navi pronti a salpare ma vengono bloccati da Odisseo e da Nestore Egrave significativo che Tersite lrsquoanti-eroe riecheggi le accuse di Achille ad Agamennone sottolineando gli onori di cui questi gode e prenda le parti di Achille [T3] Per tutta la seconda parte del libro lrsquoazione viene interrotta per far posto alla grandiosa uscita in armi dellrsquoesercito acheo dal recinto delle navi un quadro scintillante ornato da una catena di sei similitudini concatenate introdotte per illustrare il fulgore delle armi il rombo dei passi umani e degli zoccoli precipitosi lrsquoaspetto della schiera achea e la maestria dei condottieri Un ldquoCatalogo delle navirdquo contiene lrsquoelenco circostanziato delle genti greche che hanno preso parte allrsquoassedio ed egrave seguito da un catalogo piugrave breve e piugrave arido degli alleati dei Troiani accorsi in difesa di Ilio Canto III Lrsquoatteso scontro tra gli schieramenti appena passati in rassegna non ha luogo ParideAlessandro ottiene infatti una tregua per sfidare Menelao Iride la messaggera degli degravei spinge Elena ad accorrere alle mura presso le porte Scee per assistere al preannunciato duello di ligrave Priamo e gli altri anziani di Troia osservano la pianura Su richiesta del vecchio sovrano (una richiesta che sarebbe stata piugrave ldquoverosimilerdquo al primo anno di guerra) Elena nomina i piugrave prestigiosi campioni achei [T4] Nel duello che segue Paride si trova ben presto a mal partito contro Menelao ma Afrodite lo sottrae ai colpi del nemico avvolgendolo in una fitta nebbia e lo riporta nelle sue stanze dove dopo aver assunto lrsquoaspetto di una vecchia filatrice ordina a Elena di giacere con lui Elena si ribella ma la dea non transige Mentre Paride ed Elena si uniscono nellrsquoamplesso Menelao furibondo cerca fra la folla il nemico che sia i Greci che i Troiani sarebbero lieti di consegnargli pur di porre fine alla guerra Agamennone rivendicando la vittoria di Menelao pretende dai Troiani la restituzione di Elena e delle sue ricchezze noncheacute il pagamento di una forte ammenda Canto IV La tregua stipulata dopo la scomparsa di Paride viene infranta dallrsquoarciere Pandaro che sollecitato da Atena (scesa tra le schiere troiane su ordine di Zeus) ferisce con una freccia Menelao questi viene prontamente guarito dal medico Macaone figlio di Asclepio Agamennone passa fra le schiere incitandole a combattere incontra vari capi intenti a dare istruzioni ai propri uomini Solo Ulisse e Menesteo si tengono in disparte ricevendo i rimproveri di Agamennone ai quali Ulisse reagisce con indignazione Gli Achei muovono contro i Troiani con grande ordine e disciplina mentre i Troiani e i loro alleati schiamazzano come barbari Ha inizio la battaglia vera e propria nella quale lrsquoattenzione egrave focalizzata sui duelli individuali Ad assistere e rincuorare i Troiani compare Apollo sulla rocca di Troia mentre Atena infonde coraggio nei Greci Il canto si chiude sullrsquoinfuriare della battaglia la cui descrizione riprenderagrave nel canto successivo Canto V Balza in primo piano Diomede di cui viene presentata lrsquoἀριστεία lrsquoeroe laquoglorioso e chiaroraquo fa strage di nemici imperversando furiosamente fra le schiere troiane Nel pieno del combattimento viene ferito da una freccia scagliata da Pandaro il quale mena gran vanto del colpo andato a segno Diomede ottenuta unrsquoimmediata guarigione grazie allrsquointervento di Atena muove allora contro il nemico che nel frattempo era stato accolto sul carro di Enea Pandaro scaglia la sua lancia contro Diomede ma lo scudo di questi regge il colpo Diomede colpisce a sua volta uccidendo il nemico Enea scende dal cocchio per proteggere il cadavere di Pandaro dagli Achei che vorrebbero farne razzia ma Diomede lo colpisce con un grande masso fratturandogli il femore Enea viene salvato dallrsquointervento di Afrodite che lo avvolge nel suo manto mentre Diomede arriva addirittura a ferire al polso la dea che fugge sullrsquoOlimpo a farsi confortare dalla madre Dione Il figlio di Tideo attacca anche Apollo che aveva sottratto Enea alla sua furia ma
Letteratura greca [1]
15
egrave fermato dal grido di ammonimento del dio Incitati e aiutati da Ares ora i Troiani avanzano con impeto Intervengono Era e Atena e questrsquoultima assume il ruolo di auriga di Diomede Col suo aiuto questi ferisce al ventre Ares che fugge sullrsquoOlimpo Anche le dee vi fanno ritorno Canto VI Il canto VI egrave una naturale continuazione del V (tanto che Erodoto citeragrave come dallrsquoἀριστεία di Diomede un brano della prima parte del VI canto) La battaglia infuria nella pianura ma il furore di Diomede si stempera su una nota di cortesia quando lrsquoeroe dopo aver sfidato Glauco di Licia scopre di avere con lrsquoavversario antichi rapporti di ospitalitagrave I due si scambiano le armature (a detrimento di Glauco a cui laquoZeus Cronide levograve il senno cheacute scambiograve con Diomede Tidide armi drsquooro con armi di bronzo cento buoi con nove buoiraquo [vv 234-6]) Frattanto Ettore su invito dellrsquoindovino Eleno rientra in cittagrave dove le donne devono cercare di ottenere con offerte e voti il favore di Atena e incontra dapprima la madre Ecuba poi Paride (che intende ricondurre alla battaglia) vorrebbe salutare anche la moglie ma non la trova in casa bensigrave alle porte Scee dove Andromaca era accorsa piena drsquoangoscia insieme col figlioletto e con la nutrice Nel colloquio che segue ella lo implora di non esporre al pericolo se stessa e il figlio La replica di Ettore egrave esemplare per capire la prospettiva del poema e le motivazioni dellrsquoagire dei personaggi dominanti se Achille e gli eroi achei in genere cercano onore e gloria a questa motivazione (che pure non egrave assente) Ettore antepone lrsquoαἰδώς il senso di laquovergognaraquo e di responsabilitagrave nei confronti della comunitagrave e del nucleo familiare di cui egrave il difensore Poi si volta per prendere tra le braccia Astianatte ma lrsquoelmo lucente e il cimiero ondeggiante impauriscono il piccolo che si rifugia in seno alla nutrice Alla fine del canto Paride si incontra con Ettore e i due si avviano verso il campo di battaglia [T5] Canto VII A principio del canto VII Atena e Apollo si accordano per indurre Ettore a lanciare una sfida agli Achei per un duello Il sorteggio designa Aiace come campione greco Nello scontro Ettore lancia per primo lrsquoasta che penetra ma senza trapassarlo nello scudo di Aiace greve e massiccio (compaginato con sette strati di pelle bovina simile a una torre) Aiace di rimando lacera lo scudo e il pettorale della corazza ma non riesce a squarciare le carni del nemico percheacute Ettore si piega di lato Allora i due brandiscono di nuovo le aste poi ricorrono alle pietre Alla fine gli araldi arrestano il combattimento con la giustificazione che laquola notte giagrave viene ed egrave bene obbedire alla notteraquo (v 282) Su proposta di Nestore gli Achei decidono per il giorno seguente di seppellire i morti e di scavare una grande trincea difesa da un bastione sul margine del loro accampamento Respingono lrsquoofferta di pace dei Troiani (che prevederebbe la riconsegna dei tesori sottratti da Paride a Sparta) Il mattino seguente i morti vengono cremati e durante la giornata si erige il muro di protezione Canto VIII Nellrsquoassemblea degli degravei Zeus vieta ai numi di appoggiare lrsquouna o lrsquoaltra parte in conflitto Al mattino il combattimento riprende e a mezzogiorno Zeus pone i destini dei due popoli sulla bilancia che piega a favore dei Troiani Sul campo di battaglia Diomede salva Nestore Lrsquoazione di Ettore egrave travolgente fincheacute Zeus contravvenendo alla sua intenzione di favorire i Troiani accoglie la preghiera di Agamennone per risollevare il morale degli Achei che organizzano la difesa delle navi Nel corso degli scontri si segnala lrsquoarciere Teucro che colpisce i nemici muovendosi in sincronia con Aiace Telamonio che lo protegge con lo scudo Incitato da Agamennone egli prova a colpire anche Ettore ma soccombe colpito con una pietra A questa vista Era e Atena corrono ad armarsi per intervenire a favore degli Achei ma vengono distolte dalle minacce di Zeus che manifesta la propria intenzione di favorire i Troiani fino a quando i Greci non saranno ridotti alla disperazione tanto da scongiurare Achille percheacute ritorni Il sopraggiungere della notte
Letteratura greca [1]
16
interrompe i combattimenti Ettore galvanizzato dai successi ottenuti in quel giorno si illude che la vittoria sia a portata di mano e prospetta ai suoi una prossima ritirata degli Achei Il canto si chiude con il banchetto dei Troiani che banchettano nella pianura esaltati dalla speranza di vittoria Canto IX Agamennone affranto propone di fare ciograve che nel canto II aveva suggerito soltanto per mettere alla prova lrsquoesercito interrompere la guerra e tornare in patria Diomede si oppone e Nestore in un consiglio dei capi propone di tentare la riconciliazione con Achille Si invia alla tenda di Achille unrsquoambasceria (composta da Aiace Odisseo e Fenice antico pedagogo di Achille) per offrire doni ricchissimi Achille non cede anzi minaccia di salpare immediatamente verso la patria [T6] Inutilmente Fenice lrsquoantico precettore di Achille cerca di ammorbidire la determinazione del Pelide richiamando la vicenda dellrsquoeroe Meleagro [T7] Gli inviati riferiscono ad Agamennone la risposta di Achille egli torneragrave a combattere solo quando Ettore saragrave arrivato fino alle navi dei Mirmidoni Canto X Nella stessa notte si effettua una missione segreta nel corso della quale Odisseo e Diomede dapprima catturano la spia troiana Dolone (che Ettore aveva inviato alle navi achee promettendogli come ricompensa i cavalli di Achille) poi uccidono il re trace Reso appena arrivato presso i Troiani e ne rubano i magnifici cavalli Giagrave gli antichi ritenevano questo canto unrsquoaggiunta post-omerica e questi dubbi trovano riscontro in lati eccentrici della narrazione e nellrsquoimpiego di un linguaggio che spesso appare svincolato dal corrente repertorio formulare Canto XI Si apre una nuova giornata di battaglia (la cui narrazione si protrarragrave fino al canto XVIII) che ruota intorno allrsquoἀριστεία di Agamennone Quando lrsquoAtride viene ferito gli Achei ripiegano Diomede resta anchrsquoegli ferito Odisseo e Aiace evitano a stento la massa dei nemici Nestore salva sul suo carro Macaone Achille che dalla poppa della nave osserva la battaglia vuol sapere chi egrave condotto via da Nestore e manda Patroclo che viene accolto molto benevolmente e con cui Nestore intrattiene un lungo discorso egli dice di deplorare il comportamento di Achille e con atteggiamento consono alla sua condizione di anziano si dilunga nel raccontare le proprie gesta giovanili Egli esorta quindi Patroclo a far leva sulla sua amicizia per convincere Achille a riprendere il combattimento o - almeno - a concedere a Patroclo le sue armi per incutere timore nei Troiani Eccitato dalle parole del vecchio Patroclo si avvia verso la nave di Achille ma incontra Euripilo ferito che gli chiede aiuto ed egli impietositosi lo accompagna alla tenda e cura la ferita Canto XII Divisi in cinque contingenti i Troiani danno lrsquoassalto al muro eretto a difesa del campo acheo Sul campo di battaglia si manifesta un prodigio unrsquoaquila in cielo con un grosso serpente fra le zampe che riesce a ferire lrsquouccello e a sfuggire Polidamante che interpreta il segno come un presagio funesto consiglia di tornare indietro ma Ettore egrave di altro avviso Sarpedone e Glauco sferrano un attacco contro il muro e - pur rimanendo feriti - riescono ad aprire una breccia La battaglia infuria con esito incerto fincheacute Ettore con un macigno sfonda una delle porte consentendo ai Troiani di entrare in massa nel campo acheo mentre i Greci fuggono verso il mare Canto XIII Zeus distoglie lo sguardo dalla battaglia nella convinzione che nessuno fra gli dei avrebbe osato violare il divieto di intervenire ne approfitta invece Poseidone favorevole ai Greci Assunto lrsquoaspetto dellrsquoindovino Calcante il dio infonde nuovo vigore nei due Aiaci
Letteratura greca [1]
17
spronandoli al combattimento Gli Achei riconoscono lrsquointervento divino e riprendono fiducia I combattimenti si susseguono violentissimi Nella resistenza si distingue il re cretese Idomeneo Polidamante consiglia una seconda volta di interrompere la battaglia e accenna allrsquoimminente intervento di Achille Ettore non ascolta lrsquoammonimento e riprende lrsquoassalto Il canto si chiude con un suo scambio di insulti con Aiace Telamonio Canto XIV Mentre Diomede Odisseo e Agamennone tornano feriti allrsquoaccampamento Era per distogliere Zeus dalla battaglia e consentire a Poseidone di favorire gli Achei indossa la cintura magica di Afrodite e sollecita il consorte a un convegno amoroso sullrsquoIda dopo lrsquoamplesso Zeus cade in un sonno profondo e Hypnos (il Sonno) annuncia a Posidone che potragrave aiutare senza rischi gli Achei Ettore colpito con una pietra da Aiace resta a lungo in stato di incoscienza e i Troiani vengono respinti Canto XV Zeus si risveglia avvedendosi dellrsquoinganno subito e costringe Era a mandargli Iride e Apollo la prima allontaneragrave Posidone dal campo di battaglia Apollo inciteragrave Ettore a far retrocedere gli Achei fino alle navi dei Mirmidoni Riprende lrsquooffensiva troiana Apollo stesso abbatte il muro e scuotendo lrsquoegida atterrisce gli Achei Patroclo corre da Achille mentre i Troiani giagrave sono sul punto di appiccare il fuoco alle navi Canto XVI Patroclo in lacrime supplica Achille di intervenire o di mandare lui stesso al suo posto [T8] Achille gli consegna le proprie armi e gli fa promettere che non si avventureragrave oltre la zona delle navi Ma Patroclo trascinato dal suo stesso impeto oltrepassa il limite prescrittogli da Achille Abbatte Sarpedone figlio di Zeus attorno al cui cadavere infuria la lotta fincheacute Apollo lo sottrae alla mischia e Hypnos e Thanatos (il demone della morte) lo trasportano in Licia sua patria Patroclo continua lrsquoassalto alla testa dei Mirmidoni fin sotto le mura di Troia ma poco prima del tramonto al quarto assalto Apollo stesso assunto lrsquoaspetto di Asio lo percuote fra le spalle allora Euforbo lo colpisce con lrsquoasta ed Ettore lo trafigge Canto XVII Euforbo viene ucciso da Menelao ma Ettore riesce a catturare le armi di Achille indossate da Patroclo Vigorosamente sostenuti da Aiace gli Achei difendono il cadavere Una densa nebbia scende sui combattenti Zeus infonde nuovo ardimento nei cavalli di Achille piangenti per la fine di Patroclo [T9] Atena e Apollo arroventano la lotta attorno alla salma In seguito alla preghiera di Aiace Zeus dissolve la nebbia Menelao manda Antiloco figlio di Nestore a informare Achille della morte di Patroclo la cui salma viene intanto trascinata fuori della battaglia da Menelao e Merione mentre i due Aiaci offrono la necessaria copertura contro la furia incalzante dei nemici Canto XVIII Lo scoppio di selvaggio dolore a cui si abbandona Achille allrsquoudire della morte di Patroclo provoca lrsquoaccorrere dal mare di Tetide insieme con le Nereidi La madre gli promette di procurargli nuove armi Poicheacute la salma di Patroclo egrave tuttora contesa Achille fa la sua apparizione sul fossato e lancia un grido che atterrisce i nemici Efesto su preghiera di Tetide foggia le nuove armi fra cui un magnifico scudo su cui appaiono effigiati in bande concentriche gli aspetti salienti dellrsquoesistenza umana Canto XIX Il mattino seguente Tetide porta le armi al figlio e con lrsquoambrosia preserva la salma di Patroclo dalla decomposizione Achille convoca unrsquoassemblea dellrsquoesercito e rinuncia alla sua collera Agamennone lamenta di essere stato ldquoaccecatordquo da Zeus e promette doni
Letteratura greca [1]
18
riparatori [T10] Achille si lascia convincere a stento ad attendere che i soldati abbiano mangiato Poi gli armati si radunano e anche Achille si arma Il suo cavallo Xanto gli predice la prossima morte [T11] Canto XX Zeus consente agli degravei di partecipare alla nuova battaglia Enea scontratosi con Achille egrave tratto in salvo da Posidone Achille infuria come un incendio in una selva Canto XXI Achille colma di cadaveri il fiume Scamandro e cattura dodici giovani troiani che intende offrire in sacrificio a Patroclo non risparmia neppure Licaone figlio di Priamo che lo supplica con accenti di grande intensitagrave ma altrettanto intensa nella consapevolezza di un destino imminente egrave la pur spietata replica del Pelide [T12] Lo Scamandro solleva le proprie onde ma le fiamme di Efesto inaridiscono il terreno e domano la corrente Gli degravei si azzuffano Atena raggiunge Ares con una pietra Era rintuzza la furia di Artemide Infine tutti tornano sullrsquoOlimpo Apollo assunto lrsquoaspetto di Agenore respinge Achille percheacute i Troiani possano rifugiarsi allrsquointerno delle mura Canto XXII Il solo Ettore resta fuori nella pianura Invano Priamo ed Ecuba lo pregano di rientrare Mentre Achille si avvicina Ettore decide di affrontarlo ma quando quello gli egrave da presso col bronzo che gli lampeggia intorno laquosimile al raggio del fuoco ardente o del sole che sorgeraquo egrave afferrato dal panico e comincia a fuggire compiendo tre giri intorno alle mura Zeus pesa sulla bilancia i destini (le κῆρες) dei due eroi e quello di Ettore affonda in basso Allora Apollo lo abbandona e Atena apparsa a Ettore sotto le spoglie di suo fratello Deifobo gli si avvicina promettendogli aiuto e invece riporta ad Achille la lancia che gli era caduta fuori bersaglio Il colpo di risposta di Ettore rimbalza sullo scudo di Achille Ettore urla a Deifobo di passargli la sua lancia ma il falso Deifobo egrave scomparso ed Ettore comprende di trovarsi sullrsquoorlo dellrsquoabisso [T13] Achille gli trapassa la gola ed Ettore lo supplica di non oltraggiare la sua salma in risposta riceve la minaccia che finiragrave in pasto ai cani Achille trascina il cadavere alle navi attaccato al carro Priamo Ecuba e Andromaca si abbandonano al cordoglio a cui fanno eco le donne troiane Canto XXIII Viene preparato il banchetto funebre in onore di Patroclo la cui ombra nel corso della notte appare ad Achille chiedendo la sepoltura del corpo Il mattino seguente si appresta il rogo fra le offerte votive ci sono anche dodici giovani troiani Il giorno successivo si raccolgono le ossa di Patroclo Seguono i ludi funebri gare coi carri e con lrsquoarco duello in armi etc Canto XXIV Ogni giorno Achille trascina il cadavere di Ettore attorno alla tomba dellrsquoamico ma lo spettacolo offende gli degravei e al dodicesimo giorno Zeus decide di mandare Tetide percheacute induca suo figlio a restituire la salma di Ettore Iride viene inviata presso Priamo percheacute gli consigli di recarsi nel cuore della notte con un carro da trasporto e un copioso riscatto scortato da Ermes alla tenda di Achille Questi accoglie il vecchio con rispetto riconoscendo in lui lrsquoimmagine del padre lontano e si piega alla sua supplica [T14] Per volontagrave degli degravei il cadavere non egrave stato aggredito dalla putrefazione composto sul pianale del carro viene ricondotto dal padre a Troia Qui le lamentazioni rituali srsquoinnalzano dal gruppo delle donne (Andromaca Ecuba Elena) Si stipula una tregua di dodici giorni Per nove giorni i Troiani raccolgono legname poi anche il rogo di Ettore arde e si erige un tumulo
Letteratura greca [1]
19
Struttura e caratteri dellʼopera Poema di trama relativamente organica (soprattutto a partire dal canto XVI tutti gli avvenimenti tranne pochi episodi isolati ruotano attorno ai due principali antagonisti Ettore uccide Patroclo per vendicare Sarpedone e Achille uccide Ettore per vendicare Patroclo) pur se non privo di piugrave o meno cospicue incongruenze spiegabili in primo luogo con la lunga e complessa genesi orale dellrsquoopera lrsquoIliade lascia emergere in mezzo alle centinaia di nomi e alle intricate vicende alcuni caratteri delineati nella loro individualitagrave e innanzi tutto quelli di Achille e di Ettore accomunati dalla medesima coscienza di un destino di morte che sono pronti ad affrontare Appunto una tale attitudine a rappresentare i laquocaratteriraquo (ἤθη) dei suoi personaggi egrave un altro titolo di merito che Aristotele ascrive ad Omero (Poetica 1460a9-11)
dopo aver brevemente proemiato subito introduce un uomo una donna o un altro personaggio nessuno privo di caratterizzazione ma dotato di un carattere
Fondamentale per la struttura del poema egrave la novitagrave della prospettiva Possiamo presumere che i cosiddetti poemi ciclici22 mirassero a conservare lrsquoangolatura che era stata propria delle versioni pre-omeriche della saga troiana sigrave che puograve riuscire significativo il confronto fra lrsquoesordio della Piccola Iliade (dove muovendo da grandi entitagrave ndash la cittagrave il paese due popoli la guerra ndash viene lanciato secondo lrsquoespressione di J Latacz come laquouno sguardo dallrsquoesternoraquo)
Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην εὔπωλον ἧς πέρι πολλὰ πάθον Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος Canto Ilio e la terra dei Dardani dai bei puledri per la quale molti dolori patirono i Danai servitori di Ares
con lo laquosguardo internoraquo che caratterizza lrsquoinizio dellrsquoIliade
Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν ἡρώων αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν οἰωνοῖσί τε δαῖτα Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς Canta o dea di Achille figlio di Peleo la collera maledetta che pene innumerevoli inflisse agli Achei e molte scagliograve allrsquoAde vite possenti di eroi e ne faceva prede per i cani e pasto per gli uccelli e si avverava il volere di Zeus da quando primamente si separarono venuti a contesa LrsquoAtride sovrano di eroi e Achille magnifico
Argomento non egrave dunque come doveva avvenire nella tradizione del canto epico un evento complesso da inquadrare con un grandangolo onnicomprensivo e neppure come saragrave nellrsquoOdissea un personaggio colto nella multiforme varietagrave delle sue peregrinazioni egrave invece una reazione emotiva (lrsquoira di Achille) con le sue conseguenze (le innumerevoli morti degli Achei) Narrare di questa ira significa per il poeta cominciare da un punto preciso (laquoda quandoraquo) ossia dal momento della contesa e della separazione fra i due massimi eroi greci Agamennone il primo per potere (laquosovrano di eroiraquo) e Achille il primo per nobiltagrave e forza (δῖος) E sintomatica della bipolaritagrave del mondo epico in quanto mondo di degravei e di eroi egrave la sincronia per cui il taglio della narrazione coincide col decorso del laquovolere di Zeusraquo (Διὸς βουλή) forse da identificare con la promessa del dio a Tetide (rievocata piugrave oltre in questo
22 V cap II laquoLa tradizione omericaraquo
Letteratura greca [1]
20
stesso canto ai vv 518-527) di vendicare lrsquoaffronto subito da Achille o piugrave in generale con il corso degli eventi in quanto tutto come per definizione laquogiace sulle ginocchia di Zeusraquo Opera indubbiamente allrsquointerno del poema unrsquoidea formativa un progetto di qui un insieme monumentale unificato anche da una serie di corrispondenze a distanza fra cui particolare significato acquistano quelle fra primo e ultimo canto Nel canto I il vecchio Crise va come supplice presso Agamennone portando doni e supplicando la restituzione della figlia e Agamennone lo respinge aspramente minacciandolo di far ricorso alla violenza se dovesse tornare nel canto XXIV il vecchio Priamo va come supplice presso Achille portando doni e supplicando la restituzione del corpo del figlio Achille ha una prima reazione irosa (esordisce al v 560 con laquoSmetti di irritarmi vecchioraquo) ma poi accoglie la supplica E al di lagrave delle corrispondenze nelle linee dellrsquoazione si colgono fra principio e fine del poema alcuni importanti echi verbali in particolare fra XXIV 501 s
τοῦ νῦν εἵνεχ᾽ ἱκάνω νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενος παρὰ σεῖο φέρω δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα per lui [Ettore] vengo ora alle navi degli Achei per riscattarlo da te e ti porto compenso infinito
e I 12 s
ὁ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενός τε θυγάτρα φέρων δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα costui [Crise] venne alle navi rapide degli Achei per riscattare la figlia portando compenso infinito
fra XXIV 555-557
λῦσον ἵν᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδωmiddot σὺ δὲ δέξαι ἄποινα πολλά τά τοι φέρομενmiddot σὺ δὲ τῶνδrsquo ἀπόναιο καὶ ἔλθοις σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν restituiscimelo percheacute lo possa vedere con gli occhi e accogli il riscatto copioso che portiamo e tu possa goderne e tornare alla tua terra patria
e I 18-20
Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν εὖ δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκέσθαιmiddot παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην τὰ δ᾽ ἄποινα δέχεσθαι Atridi e voi altri Achei dai forti schinieri a voi concedano gli degravei che hanno le case in Olimpo di distruggere la cittagrave di Priamo e tornare facilmente in patria ma restituitemi la figlia e accettate il riscatto
fra XXIV 560 μηκέτι νῦν μ᾽ ἐρέθιζε (laquosmetti di irritarmiraquo) e I 32 μή μ᾽ ἐρέθιζε (laquonon mi irritareraquo) fra XXIV 568-570
τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς μή σε γέρον οὐδrsquo αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω καὶ ἱκέτην περ ἐόντα Διὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμάς Ora perciograve fra i dolori non mi eccitare lrsquoanimo ancora di piugrave bada o vecchio che non ti lasci neppure nella tenda
Letteratura greca [1]
21
bencheacute supplice e violi gli ordini di Zeus e I 26-28
μή σε γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω ἢ νῦν δηθύνοντ᾽ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο Mai te o vecchio io colga presso le concave navi ora a indugiare o piugrave tardi a tornare che piugrave non dovesse giovarti lo scettro e la benda del dio
(e infine XXIV 571 ὣς ἔφατ ἔδεισεν δ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ laquocosigrave diceva e il vecchio tremograve e obbediva alle paroleraquo ripete esattamente I 33) In effetti lrsquoepisodio terminale del poema col superamento dellrsquoira ad opera della pietagrave e del senso di unrsquoesistenza invasa dal dolore si propone come il rovesciamento consapevole dellrsquoepisodio iniziale che era apparso caratterizzato dalla cancellazione della pietagrave e del diritto dei supplici in nome della forza Al rifiuto iniziale del donoriscatto si oppone lrsquoaccettazione finale in consonanza con un principio-guida che opera nel poema secondo linee che alla fine si riunificano Agamennone restituisce Criseide al padre ma si appropria del dono fatto dagli altri Achei ad Achille (Briseide) Achille respinge i doni fatti da Agamennone per indurlo a riconciliarsi con lui ma dopo aver contestato nel IX canto la nozione che la vita umana possa essere barattata con una massa di beni torna alla lotta non in cambio di qualche premio da conquistare ma per vendicare lrsquouccisione dellrsquoamico Patroclo e tanto nella lotta sul campo di battaglia quanto nellrsquoinfierire sul cadavere di Ettore si abbandona a un furore cosigrave smisurato e patologico che puograve essere superato solo con lrsquoaccettare i doni di Priamo non tuttavia per il loro valore drsquouso ma percheacute in Priamo Achille riconosce lrsquoombra del padre lontano Cosigrave lrsquoIliade appare attraversata da un impulso fondamentale che muove dallrsquoideologia del dono e dalla conseguente centralitagrave assegnata allrsquoonore (τιμή) come ldquoprezzordquo che qualifica il valore del guerriero ma supera questo piano di valutazione dei rapporti umani attraverso la loro riformulazione nei termini di un umanesimo esistenziale che ha come punti di riferimento lrsquoidentitagrave universale dei condizionamenti oggettivi (la vecchiaia la malattia la morte) e i legami che uniscono padre e figlio compagno e compagno vivi e morti (il cordoglio finale di Andromaca Ecuba ed Elena sulla salma di Ettore) Entro questo orizzonte progressivamente allargato la guerra le lotte lo scontro mortale finiscono col rappresentare solo un momento e un aspetto dellrsquoesistenza graditi tanto agli degravei che vi assistono come spettatori interessati quanto agli uditori che riascoltano le antiche gesta eppure non tali da appiattire il poema in una prospettiva guerresca conclusa in se stessa Molto del fascino delle battaglie e delle ἀριστεῖαι dellrsquoIliade sta nella presenza recondita di un occhio che sa guardare al di lagrave di esse (e al di lagrave della stessa distinzione fra Greci e Troiani vincitori e vinti) e che puograve anche attraverso le similitudini lasciare irrompere il mondo della natura o del lavoro umano nel mezzo delle battaglie LʼOdissea LrsquoOdissea (Ὀδύσσεια) consta di circa 12100 esametri divisi anchrsquoessi in 24 libri e indicati con le lettere minuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquoargomento egrave costituito dalle avventure di Odisseo dalla distruzione di Troia al ritorno alla patria Itaca esposte secondo un ordine che entrando subito nel vivo degli avvenimenti (lrsquoinizio del poema mostra Odisseo nellrsquoisola di Calipso) rievoca poi i fatti giagrave trascorsi e li ricongiunge infine a partire dal libro XV (con lrsquoarrivo di Telemaco alla capanna di Eumeo dove giagrave si trova Odisseo) in unrsquoazione unitaria La trama del poema i cui avvenimenti sono concentrati cronologicamente nello spazio di 40 giorni (ma sono narrati solo gli avvenimenti di 16 giorni e 8 notti) si articola in tre parti la laquoTelemachiaraquo (canti I-IV) il laquoRitorno di Odisseoraquo (canti V-XIII) e la laquoVendetta di Odisseoraquo (canti XIV-XXIV)
Letteratura greca [1]
22
Canto I Tutti gli eroi superstiti sono ormai tornati da Troia alle loro case tranne Odisseo che pur desideroso di tornare egrave trattenuto dalla ninfa Calipso nellrsquoisola di Ogigia Gli degravei hanno pietagrave di lui tranne Posidone irato per lrsquoaccecamento del figlio il ciclope Polifemo Ma un consiglio degli degravei assente Posidone (che si egrave recato presso gli Etiopi) delibera il ritorno dellrsquoeroe si decide che Ermes andragrave subito da Calipso mentre Atena si avvia verso Itaca sotto lrsquoaspetto del signore dei Tafi Mente per incoraggiare il figlio di Odisseo Telemaco a tener testa ai pretendenti della madre i laquoprociraquo (i quali aspirano al regno tramite le nozze con Penelope) e per indurlo a intraprendere un viaggio in cerca di notizie sul padre Canto IΙ Telemaco segue il consiglio della dea e il giorno seguente nellrsquoassemblea popolare chiede una nave per andare in cerca del padre ma la sua richiesta non viene discussa e Leocrito scioglie lrsquoassemblea Grazie ad Atena che ora ha assunto le sembianze di Mentore (antico amico di Odisseo) Telemaco riesce tuttavia a trovare una nave con cui salpa nel corso della notte allrsquoinsaputa sia della madre che dei proci Canto IΙΙ Telemaco e MentoreAtena arrivano a Pilo e sul lido trovano Nestore che sta offrendo un sacrificio a Posidone Il vecchio eroe accoglie ospitalmente Telemaco e gli comunica molte notizie sul ritorno di altri Achei ma nessuna su Odisseo Alla sera Atena scompare in forma di aquila e il mattino seguente Telemaco salpa insieme con Pisistrato (figlio di Nestore) alla volta di Sparta dove arriva la sera del giorno successivo Canto IV A Sparta Menelao sta festeggiando il doppio matrimonio del figlio e della figlia Il giorno seguente Telemaco chiede del padre Menelao gli racconta il proprio ritorno durante il quale aveva incontrato Proteo il vecchio nume marino che gli aveva riferito come Odisseo fosse trattenuto nellrsquoisola di Calipso Intanto a Itaca i proci preparano insidie meditando di uccidere Telemaco al suo ritorno Penelope ne viene a conoscenza ma Atena le appare in sogno per confortarla Canto V Dopo un secondo concilio degli degravei (in effetti un ldquodoppionerdquo di quello del I canto) Zeus manda finalmente Ermes presso Calipso con lrsquoordine di lasciar partire Odisseo La ninfa aiuta lrsquoeroe a costruirsi una zattera Al diciottesimo giorno di navigazione Odisseo egrave in vista dellrsquoisola dei Feaci Scheria quando Posidone di ritorno dal suo soggiorno presso gli Etiopi lo vede e suscita una tempesta che distrugge la zattera Ma la dea marina Ino Leucotea impietositasi gli porge il proprio velo sostenuto dal quale lrsquoeroe giunge a nuoto alla riva di Scheria dove si abbandona esausto addormentandosi Canto VI In seguito a un sogno inviatole da Atena Nausicaa la figlia del re dei Feaci Alcinoo si reca nei pressi della spiaggia a lavare le vesti insieme con le ancelle Odisseo risvegliatosi atterrisce le fanciulle che fuggono tutte allrsquoinfuori di Nausicaa Lrsquoeroe supplica la giovane di porgerle aiuto ed ella lo fa rivestire e lo accompagna fino al bosco di Atena poco prima della cittagrave esortandolo a presentarsi a suo padre Canto VII Protetto dalla nebbia di cui Atena lo ha avvolto Odisseo entra nel palazzo abbraccia le ginocchia della regina Arete e la caligine scompare poi viene accolto con onore da Alcinoo Arete chiede a Odisseo donde provenga e chi gli abbia donato gli abiti (a lei ben noti) che indossa Lrsquoeroe inizia a raccontare le disavventure che gli sono occorse dopo la
Letteratura greca [1]
23
partenza dallrsquoisola di Calipso Alcinoo gli promette di farlo ricondurre a Itaca il giorno seguente Canto VIII Ma lrsquoindomani Alcinoo fa apprestare un banchetto durante il quale lrsquoaedo Demodoco canta della contesa insorta un giorno fra Achille e Odisseo Lrsquoeroe si copre il volto per nascondere le lacrime allora Alcinoo interrompe il canto e organizza una serie di gare nel corso delle quali Odisseo primeggia Poi Demodoco al margine di unrsquoarea per la danza dove si esibiscono i ballerini feaci canta gli amori di Ares e Afrodite e la vendetta di Efesto (che incatena i due amanti) La sera al ritorno nel palazzo Demodoco racconta la storia del Cavallo di legno Odisseo scoppia nuovamente in lacrime e Alcinoo gli chiede di rivelare il suo nome Canto IX Odisseo dichiara il proprio nome e dagrave inizio al racconto della propria storia a partire dalla caduta di Troia distruzione di Ismaro e perdite subite ad opera dei Ciconi sbarco presso i Lotofagi (che si nutrono di un cibo misterioso che fa dimenticare il ritorno) dopo una terribile tempesta scatenatasi durante il tentativo di doppiare il capo Malea arrivo allrsquoisola antistante quella dei Ciclopi dove Odisseo si trasferisce con una sola nave esplorazione dellrsquoisola perdita di alcuni compagni allrsquointerno della caverna del gigante monocolo accecamento del mostro e fuga Canto X Odisseo giunge allrsquoisola di Eolo signore dei venti che lo accoglie benevolmente e gli consegna alla partenza tutti i venti chiusi in un otre ma poi lo respinge con durezza quando ritorna presso di lui percheacute i compagni (sospettando che nellrsquootre siano racchiuse cospicue ricchezze) hanno sciolto i venti e da essi si egrave sprigionato un uragano che li ha risospinti sullrsquoisola Ripreso il mare Odisseo egrave trasportato fino ai Lestrigoni antropofagi il cui attacco priva lrsquoeroe di tutte le altre navi tranne la propria Con questa fugge fino allrsquoisola (Eea) della maga Circe Dopo che Circe ha trasformato in porci un gruppo di compagni mandati innanzi ad esplorare lrsquoisola Odisseo ha la meglio sulla maga (a cui impone di restituire forma umana ai compagni) grazie allrsquoerba moly fornitagli da Ermes Resta un anno presso Circe che al momento della partenza gli consiglia di recarsi al paese dei morti per interrogare il vate Tiresia Canto XI Approdato alla terra dei Cimmeri (che vivono immersi in una nebbia perenne sulla riva dellrsquoOceano) e scavata una fossa Odisseo sacrifica ai morti e immola una vittima speciale a Tiresia Le anime accorrono dapprima Elpenore caduto per caso giugrave dal tetto della casa di Circe (Odisseo gli promette sepoltura) poi la madre Anticlea (che gli racconta di esser morta di dolore per la sua assenza) quindi Tiresia che gli vaticina le sue vicende future fino alla morte (questa lo coglieragrave dopo una lunga vita in un paese straniero che non conosce neacute il sale neacute il remo) Da un certo punto in poi il poeta dimentica il presupposto per cui Odisseo aveva scavato una fossa alla quale i morti accorrevano per bere il sangue delle vittime e bevendolo riacquistavano per breve tempo una piena consapevolezza immagina invece che Odisseo sia allrsquointerno dellrsquoAde In questa sezione rientrano la descrizione di Aiace sdegnato di Minosse di Orione dei grandi peccatori di Eracle Poi Odisseo fa ritorno a Eea e ricevuti i consigli di Circe si imbarca per il ritorno in patria Canto XII Scampato alle Sirene che invano lo attirano col canto (si egrave fatto legare allrsquoalbero della nave i compagni che remano hanno le orecchie turate con la cera) passa tra Cariddi e Scilla (che gli rapisce sei uomini) ed egrave costretto dai compagni ad approdare in contrasto con le prescrizioni di Circe allrsquoisola Trinachia dove pascolano le greggi del Sole I
Letteratura greca [1]
24
compagni spronati da Euriloco se ne cibano nonostante il divieto dellrsquoeroe Il Sole sdegnato ottiene da Zeus che la nave sia colpita dal fulmine Tutti i compagni periscono ma Odisseo che ripassa tra Scilla e Cariddi si salva miracolosamente da questrsquoultima aggrappandosi a un fico selvatico fincheacute il gorgo restituisce i rottami della nave infine arriva remando con le mani allrsquoisola di Ogigia Canto XIII Terminato il racconto lrsquoeroe riceve doni dai Feaci e la notte seguente egrave ricondotto a Itaca e deposto addormentato sulla spiaggia presso un antro sacro alle Ninfe Al risveglio per la nebbia non riconosce la sua terra fincheacute Atena in veste di giovane pastore lo rassicura e poi rivelatasi gli dagrave istruzioni su come far strage dei proci e lo trasforma in un vecchio mendico Canto XIV Odisseo si reca allo stazzo del suo porcaio Eumeo che pur non riconoscendolo lo accoglie ospitalmente rifocillandolo e offrendogli un mantello per ripararsi dal gelo notturno Canto XV A questo punto la laquoTelemachiaraquo si riannoda allrsquoazione principale Telemaco che si trova ancora a Sparta viene indotto da Atena a tornare a Itaca sulla via del ritorno a Pilo accoglie a bordo lrsquoindovino Teoclimeno e grazie allrsquoaiuto della dea sfugge alle insidie dei proci sbarca a Itaca e si reca anchrsquoegli presso Eumeo Canto XVI Questi va da Penelope ad annunciargli il ritorno del figlio Intanto Odisseo rimosso lrsquoincantesimo si svela nel suo vero aspetto a Telemaco e con lui progetta la vendetta sui proci (che intanto tramano una nuova insidia ai danni di Telemaco) Eumeo torna al suo stazzo Canto XVII Il mattino seguente Telemaco si reca in cittagrave seguito in un secondo tempo da Eumeo e Odisseo (che ha riassunto lrsquoaspetto di mendico) Davanti al palazzo Odisseo egrave riconosciuto dal cane Argo Entra e va mendicando tra i proci Antinoo lo colpisce alla spalla destra con uno sgabello Canto XVIII Odisseo si batte al pugilato col mendicante Iro Penelope scesa nella sala prospetta ai proci lrsquoeventualitagrave di un nuovo matrimonio Odisseo egrave insultato dalla schiava Melanto e schiva uno sgabello scagliato da Eurinomo Canto XIX Insieme con Telemaco lrsquoeroe allontana le armi dalla sala poi conversa con Penelope che gli racconta un sogno e gli espone il suo piano per sedare le contese tra i proci concedendosi sposa a colui che riusciragrave a tendere lrsquoarco di Odisseo la prova avverragrave il giorno seguente al novilunio Durante il colloquio la fida schiava Euriclea lava i piedi di Odisseo e riconosciutolo da unrsquoantica cicatrice sta per rivelarne lrsquoidentitagrave ma lrsquoeroe la costringe a tacere Canto XX Al mattino Euriclea e le ancelle fanno i preparativi per il banchetto Giungono Eumeo Melanzio e il mandriano Filezio Un presagio mandato da Zeus dissuade i proci dal progetto di uccidere Telemaco Durante il banchetto Teoclimeno predice la loro imminente rovina
Letteratura greca [1]
25
Canto XXI Penelope conduce lrsquoarco nella sala dopo che parecchi fra i proci e lo stesso Telemaco hanno tentato invano di tenderne la corda Odisseo chiede di partecipare alla prova tende lrsquoarco senza fatica e riesce a far passare la freccia attraverso gli anelli di dodici scuri predisposte da Telemaco Canto XXII Poi scaglia le frecce sui proci e si rivela nella sua identitagrave Nella lotta che segue Telemaco Eumeo e Filezio aiutano il padrone contro i proci (appoggiati dal capraio Melanzio) Tutti i proci restano uccisi le ancelle infedeli sono impiccate Melanzio viene mutilato e ucciso soltanto lrsquoaedo Femio e lrsquoaraldo Medonte sono risparmiati Canto XXIII Nuovo colloquio fra Odisseo e Penelope che durante lrsquoeccidio dormiva ed egrave stata svegliata da Euriclea Penelope esita ancora a riconoscere il marito e non si arrende alla veritagrave fincheacute Odisseo non le descrive la posizione e la struttura del letto coniugale Canto XXIV Ermes conduce allrsquoAde le ombre dei proci Odisseo fa visita al padre Laerte nella masseria dove quello vive nello squallore e nellrsquoemarginazione e si fa riconoscere Intanto il padre di Antinoo incita gli Itacesi alla rivolta e il poema si conclude con lo scontro di Odisseo e dei suoi contro i concittadini lrsquoeroe ha la meglio e Zeus scagliato il fulmine pone fine alla battaglia Atena sotto lrsquoaspetto di Mentore stabilisce fra i contendenti un patto per il futuro36
Struttura e caratteri dellʼopera Giagrave la prima parola del proemio (ἄνδρα) non menziona come tema dellrsquoopera un determinato episodio della vita del protagonista ma il protagonista stesso (I 1-10)
Ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα πολύτροπον ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεmiddot πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περmiddot αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο νήπιοι οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιονmiddot αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ τῶν ἁμόθεν γε θεά θύγατερ Διός εἰπὲ καὶ ἡμῖν Dellrsquouomo multiforme a me racconta o Musa che molto errograve dopo che di Troia la sacra rocca distrusse di molti uomini vide le cittagrave riconobbe il pensiero e molti per il mare patigrave dolori nellrsquoanimo per salvare la sua vita e il ritorno dei compagni Eppure non li salvograve i compagni per quanto bramasse per la loro stessa follia si persero gli stolti i buoi del Sole Iperione mangiarono e quello rapigrave ad essi il digrave del ritorno Di questo da un punto qualsiasi narra anche a noi o dea figlia di Zeus
Storie favolose di naviganti racconti imperniati sul ritorno dei guerrieri achei che avevano combattuto a Troia e il particolare rientro in patria di Odisseo figlio di Laerte erano forse giagrave stati connessi e intrecciati nella precedente tradizione epica sigrave che il presente cantore poteva
Letteratura greca [1]
26
metter mano alla vicenda partendo (v 10) laquoda un punto qualsiasiraquo (ἁμόθεν) una notazione che certo presuppone la convenzione propria dellrsquoesordio tradizionale di un canto epico comparabile con i giagrave ricordati ἐξ οὗ (laquoda quandoraquo) di Iliade I 4 ed ἔνθεν (laquoda doveraquo) di Odissea VIII 500 Senoncheacute rispetto a queste indicazioni di tipo puntuale il tratto costituito dalla dimensione casuale quasi arbitraria inerente ad ἁμόθεν proprio mentre dichiara lrsquoassenza di un determinato piano compositivo implica in realtagrave che il racconto non si svolgeragrave per filo e per segno secondo lrsquoordine noto a poeta e uditori non si snoderagrave κατὰ κόσμον (laquoper ordineraquo) come il canto di Demodoco (VIII 489) ma seguiragrave un andamento originale Il ldquopunto qualsiasirdquo incipitario non rappresenta una scelta della Musa (figura dellrsquoarchivio tematico che conserva le laquovieraquo dellrsquoepica) bensigrave di questo cantore che ha deciso di far incominciare la narrazione in medias res e ha in serbo la sorpresa di far succedere al concilio degli degravei (che decide lrsquoinvio di Ermes presso Calipso) non lrsquoazione testeacute programmata (azione che viene differita con un ritardo che a piugrave riprese ha scandalizzato i lettori a principio del V canto) ma la partenza di Atena alla volta di Itaca e lrsquoavvio della laquoTelemachiaraquo Le due diverse vicende proposte a principio del poema quella di Telemaco e quella di Odisseo procedono infatti in parallelo coprendo un analogo lasso di tempo Piugrave oltre la decisione di trasformare la sequenza narrativa che va dalla partenza di Odisseo da Troia fino al suo arrivo nella terra dei Feaci in una rievocazione fatta dallrsquoeroe in prima persona al cospetto di Alcinoo e dei Feaci (la sezione detta degli ἀπόλογοι laquoraccontiraquo) crea una struttura ad anello che parte dal presente e ad esso fa ritorno dopo aver ricostruito le premesse della condizione attuale del protagonista Col canto XIII Odisseo egrave riportato dai Feaci a Itaca e questo permette la saldatura fra le vicende sue e quelle di Telemaco sia pure col differimento dellrsquoincontro e del riconoscimento fra padre e figlio fino al canto XVI Far scorrere in parallelo sequenze distinte organizzare programmi narrativi a corta e a lunga gittata tendere o allentare ad arte il ritmo della narrazione non si tratta davvero di procedimenti che potessero configurarsi come tradizionali dellrsquoarte epica quanto piuttosto di un momento sperimentale di una ricerca di soluzioni nuove al termine di una lunga e ormai consolidata sedimentazione di percorsi compiuti allrsquointerno di un determinato repertorio tematico unrsquoaudacia inventiva una πολυτροπίη degne del protagonista del poema che inevitabilmente comportavano rischi molteplici di incoerenze dissonanze occasionali avarie della macchina epica e che tuttavia erano destinate a conseguire un risultato assolutamente convincente allrsquoorecchio di chi si abbandonasse al fascino del racconto senza lrsquourgenza propria di altre etagrave e di altre mentalitagrave di puntare il dito sui singoli dettagli o le singole sfasature
PER SAPERNE DI PIUrsquo Difficoltagrave e incongruenze della narrazione omerica Forti della possibilitagrave di un controllo su un testo scritto che possiamo percorrere in avanti e a ritroso secondo ritmi di nostra scelta a noi non riesce difficile cogliere alcune delle difficoltagrave organizzative incontrate nella composizione del poema In proposito per ricordare un caso che saragrave allrsquoorigine delle discussioni di orientamento ldquoanaliticordquo intorno allrsquoOdissea possiamo leggere il discorso che Atena prese le sembianze di Mente re dei Tafi rivolge a Telemaco nel I canto (vv 253-305) Ah infelice ti manca molto davvero lrsquoassente Odisseo che getti le mani addosso ai pretendenti sfrontati Percheacute se ora tornato stesse sulla soglia 255 con una scure lo scudo e due lance cosigrave come io per la prima volta lo vidi in casa nostra che beveva e godeva di ritorno da Efira da Ilo di Mermero (andograve anche ligrave Odisseo con la nave veloce 260 in cerca del veleno omicida per averne da ungere le frecce di bronzo ma quello non glielo diede percheacute temeva gli dei che vivono eterni
Letteratura greca [1]
27
glielo diede invece mio padre percheacute lrsquoamava moltissimo) se stesse Odisseo tra i pretendenti cosigrave 265 essi avrebbero tutti rapida morte e nozze amare Ma sulle ginocchia degli dei questo giace se una volta tornato faragrave o no vendetta nella sua casa te invece io esorto a riflettere come cacciare i pretendenti da casa 270 Ebbene ora ascolta e alle mie parole darsquo retta Domattina chiamati gli eroi Achei a consiglio rivolgi a tutti un discorso e siano testimoni gli dei Ai pretendenti comanda drsquoandarsene per i fatti loro e tua madre se lrsquoanimo la spinge alle nozze 275 ritorni a casa del padre molto potente Prepareranno essi le nozze e disporranno i doni nuziali moltissimi quanti gli pare che debbano andare alla figlia A te darograve un saggio consiglio se vuoi ascoltarlo armata una nave con venti remi la migliore che crsquoegrave 280 Varsquo a domandare del padre partito da tempo se mai te ne parli un mortale o sentissi da Zeus la voce che divulga la fama tra gli uomini Anzitutto varsquo a Pilo e interroga il chiaro Nestore di ligrave poi varsquo a Sparta dal biondo Menelao 285 degli Achei vestiti di bronzo egli egrave tornato per ultimo Se senti dire qualcosa sulla vita e il ritorno del padre per quanto stremato potresti sopportare un altro anno se invece senti dire che egrave morto e non vive allora tornato nella cara terra patria 290 ergigli un tumulo e offrigli funebri offerte moltissime quanto conviene e darsquo tua madre a un marito E poi dopo aver compiuto e fatto ogni cosa allora medita nella mente e nellrsquoanimo come tu possa uccidere nelle tue case 295 i pretendenti con lrsquoinganno affrontandoli non devi piugrave avere i modi di un bimbo percheacute ormai non sei tale Non senti lrsquoillustre Oreste quale gloria ha acquistato fra tutti gli uomini percheacute uccise lrsquoassassino del padre Egisto esperto di inganni che gli uccise il nobile padre 300 Anche tu caro infatti molto bello e grande ti vedo sii valoroso percheacute ti lodi anche qualcuno dei posteri Ma io tornerograve adesso alla nave veloce dai compagni che forse impazienti mi aspettano Tu devi pensarci da te dammi retta 305
[Tr di GA Privitera] Le stranezze non mancano davvero e cosigrave sono state messe a fuoco da Stephanie West nel suo commento23 1 Atena sa evidentemente molto piugrave di quanto uno come Mente avrebbe potuto sapere in particolare ella sa che i proci ignoreranno lrsquoinvito di Telemaco a lasciare la sua casa e fatto piugrave importante che gli degravei tra breve ricondurranno in patria Odisseo A queste osservazioni si puograve replicare con la stessa West che laquosi sono esagerate difficoltagrave e
23 Omero Odissea I cit 219 ss
Letteratura greca [1]
28
incongruenze alle quali un pubblico di ascoltatori (o anche un lettore moderatamente attento) probabilmente non farebbe casoraquo 2 Il progetto di una pubblica denuncia dei proci dinanzi agli degravei e agli uomini ai vv 273-274 egrave ciograve che Atena sembra prefiggersi nel promuovere lrsquoassemblea degli Itacesi (assemblea che effettivamente avragrave luogo a principio del canto II) drsquoaltra parte le successive istruzioni di AtenaMente ai vv 295 s (medita come uccidere i pretendenti) presuppongono che di quella richiesta da formulare nel corso dellrsquoassembla essi non terranno alcun conto Anche a questa osservazione si puograve rispondere che laquoegrave ragionevole attendersi che Telemaco condivida la previsione di un esito negativo della sua iniziativaraquo e si puograve aggiungere che pure in caso di insuccesso il ricorso allrsquoassemblea potrebbe ottenere almeno il risultato di screditare i pretendenti presso la comunitagrave itacese legittimando un successivo ricorso alla violenza (e si tratta di una legittimazione di cui anche lrsquoultimo canto mostreragrave lrsquoesigenza) 3 Dopo che Telemaco aveva detto che la madre non intendeva risposarsi (vv 249-250) AtenaMente si esprime ai vv 275-278 come se Penelope desiderasse proprio nuove nozze e inoltre sarebbe assurdo che il padre di Penelope cominciasse a contrattare un secondo matrimonio prima del ritorno di Telemaco dal suo viaggio e che mettesse mano a preparativi che rischierebbero di essere annullati qualche tempo dopo con inevitabile imbarazzo se Telemaco venisse a sapere che Odisseo egrave ancora vivo In piugrave lrsquoandamento sintattico di questi versi presenta un anacoluto durissimo per cui a principio del v 275 lrsquoaccusativo μητέρα egrave seguito da un ἂψ ἴτω (laquovada indietroraquo laquotorniraquo) che richiederebbe come soggetto un nominativo μήτηρ Come hanno reagito i lettori di Omero Nellrsquoantichitagrave un grammatico rimasto anonimo cambiava come attesta uno scolio μητέρ᾽ in μήτηρ nel secolo XVIII Richard Bentley modificava ἴτω in ἴμεν (infinito eolico di εἶμι laquovadoraquo) nel XIX un altro grande della filologia europea Gottfried Hermann risolveva piugrave drasticamente la questione eliminando il complesso dei vv 275-278 e la stessa West mostra simpatia per tale proposta supponendo laquounrsquoaggiunta posteriore modellata sul corrispondente passo del libro IIraquo (dove i vv 196 s sono identici ai vv 277 s e il v 195 copre lo stesso contenuto dei vv 275 s) Si tratta di procedimenti adeguati ai dati di fatto Migliorano davvero il testo che ci egrave stato tramandato In realtagrave ambedue le ldquocorrezionirdquo appena ricordate (di μήτερ᾽ e di ἴτω) ottengono un risultato tanto lineare che egrave davvero difficile pensare che lrsquoanacoluto avrebbe potuto invadere tutta la tradizione se non fosse stato originario e quanto allrsquoespunzione dei vv 275-278 essa indubbiamente peggiorerebbe il ritmo del discorso determinando lrsquoavvicinamento fra i due versi (v 271 e v 279) molto simili fra loro che aprono le due sequenze occupate dai consigli di Mente E allora La via piugrave saggia egrave senzrsquoaltro quella di tenerci qui come quasi sempre di fronte al testo omerico contraddizioni e anacoluti riconoscendo in essi lrsquoeffetto dellrsquoattivitagrave di un cantore che pur sulla base di una traccia largamente memorizzata restava pur sempre legato a quella prassi orale per cui composizione ed esecuzione tendevano a coincidere E lrsquoanacoluto si spiega bene se cerchiamo di immedesimarci nel procedimento seguito dal poeta Egli ha affidato ad Atena un certo flusso argomentativo per cui la dea deve dar consigli a Telemaco sui suoi rapporti coi proci e con la madre e cosigrave colloca in fine di v 274 un ἄνωχθι (laquoordinaraquo) destinato a reggere gli accusativi simmetricamente dislocati in principio di verso (vv 274 e 275) μνηστῆρας e μητέρα Senoncheacute giunto a questa seconda parte dellrsquoargomentazione egli si avvede quanto sarebbe illogico che Telemaco sollecitasse la madre a nuove nozze di qui lrsquoimprovviso cambio di costruzione che svincola al prezzo di una sensibile slogatura sintattica lrsquoipotesi delle nuove nozze dallrsquoordine impartito a Telemaco e la prospetta invece come un desiderio eventuale della stessa Penelope Il poeta ha un progetto ben meditato brani e sequenze piugrave volte sperimentati ed egrave col supporto di questi materiali giagrave elaborati che egli si fa strada attraverso le insidie della
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
13
LrsquoIliade (Ἰλιάς) consta di circa 15690 esametri divisi secondo una partizione che potrebbe risalire al primo editore alessandrino (Zenodoto di Efeso) in 24 libri indicati con le lettere maiuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquounitagrave strutturale di parecchi canti che spesso finiscono col tramonto o iniziano con lrsquoalba e la coincidenza fra alcuni dei titoli attribuiti a ciascun canto nelle edizioni alessandrine e quelli che si rintracciano in autori precedenti (ad es Tucidide [I 10 4] cita il ldquoCatalogo delle navirdquo cioegrave il canto II) provano che non si trattograve di una divisione arbitraria bensigrave fondata almeno in certa misura sulle abitudini dei rapsodi Tema dellrsquoopera non egrave lrsquointero assedio decennale di Troia da parte dei Greci (di norma detti Achei o Danai o Argivi) provocato dal rapimento di Elena ad opera di Paride ma una porzione assai limitata del conflitto una sequenza narrativa che copre la durata di 51 giorni e si colloca verso la fine del nono anno di guerra lrsquoira di Achille contro lrsquoAtride Agamennone il suo ritiro dalla guerra e le relative conseguenze la fine dellrsquoira lrsquouccisione e i funerali di Ettore Fu proprio questa delimitazione tematica a consentire la realizzazione di quellrsquounitagrave e compiutezza dellrsquoazione che giagrave Aristotele individuava come uno dei pregi essenziali dellrsquoopera di Omero rispetto agli altri poemi epici arcaici (Poetica 1459a-b)20
anche in questo Omero deve apparire mirabile in confronto agli altri per non aver tentato di rappresentare intera la guerra anche se essa aveva un principio e una fine il racconto sarebbe risultato troppo grande e non abbracciabile con uno sguardo oppure pur misurato nella grandezza intricato per la varietagrave Ricavatane invece una parte ha fatto uso di molti episodi per esempio con il ldquoCatalogo delle navirdquo e con altri episodi fa procedere in lungo il poema Gli altri invece come lrsquoautore delle Ciprie o della Piccola Iliade compongono unrsquoazione multipla su unrsquounica persona o un unico tempo Di conseguenza mentre dallrsquoIliade e dallrsquoOdissea si ricava unrsquounica tragedia o soltanto due da ciascuna dalle Ciprie parecchie
[Tr di D Lanza]21
Canto I Lrsquoazione si apre sul campo degli Achei devastato dalle frecce scagliate da Apollo [T1] il dio ha scatenato una pestilenza percheacute Agamennone ha rifiutato il riscatto offerto dal sacerdote Crise per la liberazione della figlia Criseide divenuta schiava dellrsquoAtride Ai guerrieri convocati in assemblea lrsquoindovino Calcante rivela che la sola via di scampo egrave la restituzione di Criseide al padre Agamennone acconsente ma solo a patto che gli venga data in cambio Briseide la schiava che Achille tiene nella sua tenda come premio personale (γέρας) ricevuto dagli altri guerrieri Achille non puograve opporsi alla prevaricazione dellrsquoAtride ma non egrave disposto a subire passivamente lrsquooltraggio e insulta Agamennone anzi egrave giagrave pronto a estrarre la spada dal fodero per farsi giustizia quando viene trattenuto da Atena apparsa allrsquoimprovviso allora si ritira nella tenda giurando che non combatteragrave piugrave [T2] Quindi invoca la madre Tetide che dopo essere apparsa al figlio sulla riva del mare intercede presso Zeus e ottiene la promessa che i Greci non vinceranno la guerra e non espugneranno Troia fincheacute Achille non riceveragrave soddisfazione per lrsquooffesa subita Ma il piano di Zeus non resta celato ad Era che ingelosita provoca una lite nel corso del banchetto degli dei tuttavia la visione di Efesto zoppicante che funge da coppiere suscita lrsquoilaritagrave dei numi e riporta la serenitagrave Canto II Quella stessa notte Zeus manda ad Agamennone un sogno ingannatore per incitarlo ad attaccare Troia LrsquoAtride riferisce il sogno agli anziani e comanda lrsquoadunata dellrsquoesercito
20 Cfr anche 1462b ταῦτα τὰ ποιήματα συνέστηκεν ὡς ἐνδέχεται ἄριστα καὶ ὅτι μάλιστα μιᾶς πράξεως μίμησις (laquoQuesti poemi sono composti come meglio non si puograve e son il piugrave possibile imitazione di unrsquounica azioneraquo) 21 Aristotele Poetica Milano Rizzoli 19902
Letteratura greca [1]
14
con lrsquoidea stravagante di saggiare lrsquoumore delle truppe proponendo il ritorno in patria Gli uomini incitati da Tersite corrono alle navi pronti a salpare ma vengono bloccati da Odisseo e da Nestore Egrave significativo che Tersite lrsquoanti-eroe riecheggi le accuse di Achille ad Agamennone sottolineando gli onori di cui questi gode e prenda le parti di Achille [T3] Per tutta la seconda parte del libro lrsquoazione viene interrotta per far posto alla grandiosa uscita in armi dellrsquoesercito acheo dal recinto delle navi un quadro scintillante ornato da una catena di sei similitudini concatenate introdotte per illustrare il fulgore delle armi il rombo dei passi umani e degli zoccoli precipitosi lrsquoaspetto della schiera achea e la maestria dei condottieri Un ldquoCatalogo delle navirdquo contiene lrsquoelenco circostanziato delle genti greche che hanno preso parte allrsquoassedio ed egrave seguito da un catalogo piugrave breve e piugrave arido degli alleati dei Troiani accorsi in difesa di Ilio Canto III Lrsquoatteso scontro tra gli schieramenti appena passati in rassegna non ha luogo ParideAlessandro ottiene infatti una tregua per sfidare Menelao Iride la messaggera degli degravei spinge Elena ad accorrere alle mura presso le porte Scee per assistere al preannunciato duello di ligrave Priamo e gli altri anziani di Troia osservano la pianura Su richiesta del vecchio sovrano (una richiesta che sarebbe stata piugrave ldquoverosimilerdquo al primo anno di guerra) Elena nomina i piugrave prestigiosi campioni achei [T4] Nel duello che segue Paride si trova ben presto a mal partito contro Menelao ma Afrodite lo sottrae ai colpi del nemico avvolgendolo in una fitta nebbia e lo riporta nelle sue stanze dove dopo aver assunto lrsquoaspetto di una vecchia filatrice ordina a Elena di giacere con lui Elena si ribella ma la dea non transige Mentre Paride ed Elena si uniscono nellrsquoamplesso Menelao furibondo cerca fra la folla il nemico che sia i Greci che i Troiani sarebbero lieti di consegnargli pur di porre fine alla guerra Agamennone rivendicando la vittoria di Menelao pretende dai Troiani la restituzione di Elena e delle sue ricchezze noncheacute il pagamento di una forte ammenda Canto IV La tregua stipulata dopo la scomparsa di Paride viene infranta dallrsquoarciere Pandaro che sollecitato da Atena (scesa tra le schiere troiane su ordine di Zeus) ferisce con una freccia Menelao questi viene prontamente guarito dal medico Macaone figlio di Asclepio Agamennone passa fra le schiere incitandole a combattere incontra vari capi intenti a dare istruzioni ai propri uomini Solo Ulisse e Menesteo si tengono in disparte ricevendo i rimproveri di Agamennone ai quali Ulisse reagisce con indignazione Gli Achei muovono contro i Troiani con grande ordine e disciplina mentre i Troiani e i loro alleati schiamazzano come barbari Ha inizio la battaglia vera e propria nella quale lrsquoattenzione egrave focalizzata sui duelli individuali Ad assistere e rincuorare i Troiani compare Apollo sulla rocca di Troia mentre Atena infonde coraggio nei Greci Il canto si chiude sullrsquoinfuriare della battaglia la cui descrizione riprenderagrave nel canto successivo Canto V Balza in primo piano Diomede di cui viene presentata lrsquoἀριστεία lrsquoeroe laquoglorioso e chiaroraquo fa strage di nemici imperversando furiosamente fra le schiere troiane Nel pieno del combattimento viene ferito da una freccia scagliata da Pandaro il quale mena gran vanto del colpo andato a segno Diomede ottenuta unrsquoimmediata guarigione grazie allrsquointervento di Atena muove allora contro il nemico che nel frattempo era stato accolto sul carro di Enea Pandaro scaglia la sua lancia contro Diomede ma lo scudo di questi regge il colpo Diomede colpisce a sua volta uccidendo il nemico Enea scende dal cocchio per proteggere il cadavere di Pandaro dagli Achei che vorrebbero farne razzia ma Diomede lo colpisce con un grande masso fratturandogli il femore Enea viene salvato dallrsquointervento di Afrodite che lo avvolge nel suo manto mentre Diomede arriva addirittura a ferire al polso la dea che fugge sullrsquoOlimpo a farsi confortare dalla madre Dione Il figlio di Tideo attacca anche Apollo che aveva sottratto Enea alla sua furia ma
Letteratura greca [1]
15
egrave fermato dal grido di ammonimento del dio Incitati e aiutati da Ares ora i Troiani avanzano con impeto Intervengono Era e Atena e questrsquoultima assume il ruolo di auriga di Diomede Col suo aiuto questi ferisce al ventre Ares che fugge sullrsquoOlimpo Anche le dee vi fanno ritorno Canto VI Il canto VI egrave una naturale continuazione del V (tanto che Erodoto citeragrave come dallrsquoἀριστεία di Diomede un brano della prima parte del VI canto) La battaglia infuria nella pianura ma il furore di Diomede si stempera su una nota di cortesia quando lrsquoeroe dopo aver sfidato Glauco di Licia scopre di avere con lrsquoavversario antichi rapporti di ospitalitagrave I due si scambiano le armature (a detrimento di Glauco a cui laquoZeus Cronide levograve il senno cheacute scambiograve con Diomede Tidide armi drsquooro con armi di bronzo cento buoi con nove buoiraquo [vv 234-6]) Frattanto Ettore su invito dellrsquoindovino Eleno rientra in cittagrave dove le donne devono cercare di ottenere con offerte e voti il favore di Atena e incontra dapprima la madre Ecuba poi Paride (che intende ricondurre alla battaglia) vorrebbe salutare anche la moglie ma non la trova in casa bensigrave alle porte Scee dove Andromaca era accorsa piena drsquoangoscia insieme col figlioletto e con la nutrice Nel colloquio che segue ella lo implora di non esporre al pericolo se stessa e il figlio La replica di Ettore egrave esemplare per capire la prospettiva del poema e le motivazioni dellrsquoagire dei personaggi dominanti se Achille e gli eroi achei in genere cercano onore e gloria a questa motivazione (che pure non egrave assente) Ettore antepone lrsquoαἰδώς il senso di laquovergognaraquo e di responsabilitagrave nei confronti della comunitagrave e del nucleo familiare di cui egrave il difensore Poi si volta per prendere tra le braccia Astianatte ma lrsquoelmo lucente e il cimiero ondeggiante impauriscono il piccolo che si rifugia in seno alla nutrice Alla fine del canto Paride si incontra con Ettore e i due si avviano verso il campo di battaglia [T5] Canto VII A principio del canto VII Atena e Apollo si accordano per indurre Ettore a lanciare una sfida agli Achei per un duello Il sorteggio designa Aiace come campione greco Nello scontro Ettore lancia per primo lrsquoasta che penetra ma senza trapassarlo nello scudo di Aiace greve e massiccio (compaginato con sette strati di pelle bovina simile a una torre) Aiace di rimando lacera lo scudo e il pettorale della corazza ma non riesce a squarciare le carni del nemico percheacute Ettore si piega di lato Allora i due brandiscono di nuovo le aste poi ricorrono alle pietre Alla fine gli araldi arrestano il combattimento con la giustificazione che laquola notte giagrave viene ed egrave bene obbedire alla notteraquo (v 282) Su proposta di Nestore gli Achei decidono per il giorno seguente di seppellire i morti e di scavare una grande trincea difesa da un bastione sul margine del loro accampamento Respingono lrsquoofferta di pace dei Troiani (che prevederebbe la riconsegna dei tesori sottratti da Paride a Sparta) Il mattino seguente i morti vengono cremati e durante la giornata si erige il muro di protezione Canto VIII Nellrsquoassemblea degli degravei Zeus vieta ai numi di appoggiare lrsquouna o lrsquoaltra parte in conflitto Al mattino il combattimento riprende e a mezzogiorno Zeus pone i destini dei due popoli sulla bilancia che piega a favore dei Troiani Sul campo di battaglia Diomede salva Nestore Lrsquoazione di Ettore egrave travolgente fincheacute Zeus contravvenendo alla sua intenzione di favorire i Troiani accoglie la preghiera di Agamennone per risollevare il morale degli Achei che organizzano la difesa delle navi Nel corso degli scontri si segnala lrsquoarciere Teucro che colpisce i nemici muovendosi in sincronia con Aiace Telamonio che lo protegge con lo scudo Incitato da Agamennone egli prova a colpire anche Ettore ma soccombe colpito con una pietra A questa vista Era e Atena corrono ad armarsi per intervenire a favore degli Achei ma vengono distolte dalle minacce di Zeus che manifesta la propria intenzione di favorire i Troiani fino a quando i Greci non saranno ridotti alla disperazione tanto da scongiurare Achille percheacute ritorni Il sopraggiungere della notte
Letteratura greca [1]
16
interrompe i combattimenti Ettore galvanizzato dai successi ottenuti in quel giorno si illude che la vittoria sia a portata di mano e prospetta ai suoi una prossima ritirata degli Achei Il canto si chiude con il banchetto dei Troiani che banchettano nella pianura esaltati dalla speranza di vittoria Canto IX Agamennone affranto propone di fare ciograve che nel canto II aveva suggerito soltanto per mettere alla prova lrsquoesercito interrompere la guerra e tornare in patria Diomede si oppone e Nestore in un consiglio dei capi propone di tentare la riconciliazione con Achille Si invia alla tenda di Achille unrsquoambasceria (composta da Aiace Odisseo e Fenice antico pedagogo di Achille) per offrire doni ricchissimi Achille non cede anzi minaccia di salpare immediatamente verso la patria [T6] Inutilmente Fenice lrsquoantico precettore di Achille cerca di ammorbidire la determinazione del Pelide richiamando la vicenda dellrsquoeroe Meleagro [T7] Gli inviati riferiscono ad Agamennone la risposta di Achille egli torneragrave a combattere solo quando Ettore saragrave arrivato fino alle navi dei Mirmidoni Canto X Nella stessa notte si effettua una missione segreta nel corso della quale Odisseo e Diomede dapprima catturano la spia troiana Dolone (che Ettore aveva inviato alle navi achee promettendogli come ricompensa i cavalli di Achille) poi uccidono il re trace Reso appena arrivato presso i Troiani e ne rubano i magnifici cavalli Giagrave gli antichi ritenevano questo canto unrsquoaggiunta post-omerica e questi dubbi trovano riscontro in lati eccentrici della narrazione e nellrsquoimpiego di un linguaggio che spesso appare svincolato dal corrente repertorio formulare Canto XI Si apre una nuova giornata di battaglia (la cui narrazione si protrarragrave fino al canto XVIII) che ruota intorno allrsquoἀριστεία di Agamennone Quando lrsquoAtride viene ferito gli Achei ripiegano Diomede resta anchrsquoegli ferito Odisseo e Aiace evitano a stento la massa dei nemici Nestore salva sul suo carro Macaone Achille che dalla poppa della nave osserva la battaglia vuol sapere chi egrave condotto via da Nestore e manda Patroclo che viene accolto molto benevolmente e con cui Nestore intrattiene un lungo discorso egli dice di deplorare il comportamento di Achille e con atteggiamento consono alla sua condizione di anziano si dilunga nel raccontare le proprie gesta giovanili Egli esorta quindi Patroclo a far leva sulla sua amicizia per convincere Achille a riprendere il combattimento o - almeno - a concedere a Patroclo le sue armi per incutere timore nei Troiani Eccitato dalle parole del vecchio Patroclo si avvia verso la nave di Achille ma incontra Euripilo ferito che gli chiede aiuto ed egli impietositosi lo accompagna alla tenda e cura la ferita Canto XII Divisi in cinque contingenti i Troiani danno lrsquoassalto al muro eretto a difesa del campo acheo Sul campo di battaglia si manifesta un prodigio unrsquoaquila in cielo con un grosso serpente fra le zampe che riesce a ferire lrsquouccello e a sfuggire Polidamante che interpreta il segno come un presagio funesto consiglia di tornare indietro ma Ettore egrave di altro avviso Sarpedone e Glauco sferrano un attacco contro il muro e - pur rimanendo feriti - riescono ad aprire una breccia La battaglia infuria con esito incerto fincheacute Ettore con un macigno sfonda una delle porte consentendo ai Troiani di entrare in massa nel campo acheo mentre i Greci fuggono verso il mare Canto XIII Zeus distoglie lo sguardo dalla battaglia nella convinzione che nessuno fra gli dei avrebbe osato violare il divieto di intervenire ne approfitta invece Poseidone favorevole ai Greci Assunto lrsquoaspetto dellrsquoindovino Calcante il dio infonde nuovo vigore nei due Aiaci
Letteratura greca [1]
17
spronandoli al combattimento Gli Achei riconoscono lrsquointervento divino e riprendono fiducia I combattimenti si susseguono violentissimi Nella resistenza si distingue il re cretese Idomeneo Polidamante consiglia una seconda volta di interrompere la battaglia e accenna allrsquoimminente intervento di Achille Ettore non ascolta lrsquoammonimento e riprende lrsquoassalto Il canto si chiude con un suo scambio di insulti con Aiace Telamonio Canto XIV Mentre Diomede Odisseo e Agamennone tornano feriti allrsquoaccampamento Era per distogliere Zeus dalla battaglia e consentire a Poseidone di favorire gli Achei indossa la cintura magica di Afrodite e sollecita il consorte a un convegno amoroso sullrsquoIda dopo lrsquoamplesso Zeus cade in un sonno profondo e Hypnos (il Sonno) annuncia a Posidone che potragrave aiutare senza rischi gli Achei Ettore colpito con una pietra da Aiace resta a lungo in stato di incoscienza e i Troiani vengono respinti Canto XV Zeus si risveglia avvedendosi dellrsquoinganno subito e costringe Era a mandargli Iride e Apollo la prima allontaneragrave Posidone dal campo di battaglia Apollo inciteragrave Ettore a far retrocedere gli Achei fino alle navi dei Mirmidoni Riprende lrsquooffensiva troiana Apollo stesso abbatte il muro e scuotendo lrsquoegida atterrisce gli Achei Patroclo corre da Achille mentre i Troiani giagrave sono sul punto di appiccare il fuoco alle navi Canto XVI Patroclo in lacrime supplica Achille di intervenire o di mandare lui stesso al suo posto [T8] Achille gli consegna le proprie armi e gli fa promettere che non si avventureragrave oltre la zona delle navi Ma Patroclo trascinato dal suo stesso impeto oltrepassa il limite prescrittogli da Achille Abbatte Sarpedone figlio di Zeus attorno al cui cadavere infuria la lotta fincheacute Apollo lo sottrae alla mischia e Hypnos e Thanatos (il demone della morte) lo trasportano in Licia sua patria Patroclo continua lrsquoassalto alla testa dei Mirmidoni fin sotto le mura di Troia ma poco prima del tramonto al quarto assalto Apollo stesso assunto lrsquoaspetto di Asio lo percuote fra le spalle allora Euforbo lo colpisce con lrsquoasta ed Ettore lo trafigge Canto XVII Euforbo viene ucciso da Menelao ma Ettore riesce a catturare le armi di Achille indossate da Patroclo Vigorosamente sostenuti da Aiace gli Achei difendono il cadavere Una densa nebbia scende sui combattenti Zeus infonde nuovo ardimento nei cavalli di Achille piangenti per la fine di Patroclo [T9] Atena e Apollo arroventano la lotta attorno alla salma In seguito alla preghiera di Aiace Zeus dissolve la nebbia Menelao manda Antiloco figlio di Nestore a informare Achille della morte di Patroclo la cui salma viene intanto trascinata fuori della battaglia da Menelao e Merione mentre i due Aiaci offrono la necessaria copertura contro la furia incalzante dei nemici Canto XVIII Lo scoppio di selvaggio dolore a cui si abbandona Achille allrsquoudire della morte di Patroclo provoca lrsquoaccorrere dal mare di Tetide insieme con le Nereidi La madre gli promette di procurargli nuove armi Poicheacute la salma di Patroclo egrave tuttora contesa Achille fa la sua apparizione sul fossato e lancia un grido che atterrisce i nemici Efesto su preghiera di Tetide foggia le nuove armi fra cui un magnifico scudo su cui appaiono effigiati in bande concentriche gli aspetti salienti dellrsquoesistenza umana Canto XIX Il mattino seguente Tetide porta le armi al figlio e con lrsquoambrosia preserva la salma di Patroclo dalla decomposizione Achille convoca unrsquoassemblea dellrsquoesercito e rinuncia alla sua collera Agamennone lamenta di essere stato ldquoaccecatordquo da Zeus e promette doni
Letteratura greca [1]
18
riparatori [T10] Achille si lascia convincere a stento ad attendere che i soldati abbiano mangiato Poi gli armati si radunano e anche Achille si arma Il suo cavallo Xanto gli predice la prossima morte [T11] Canto XX Zeus consente agli degravei di partecipare alla nuova battaglia Enea scontratosi con Achille egrave tratto in salvo da Posidone Achille infuria come un incendio in una selva Canto XXI Achille colma di cadaveri il fiume Scamandro e cattura dodici giovani troiani che intende offrire in sacrificio a Patroclo non risparmia neppure Licaone figlio di Priamo che lo supplica con accenti di grande intensitagrave ma altrettanto intensa nella consapevolezza di un destino imminente egrave la pur spietata replica del Pelide [T12] Lo Scamandro solleva le proprie onde ma le fiamme di Efesto inaridiscono il terreno e domano la corrente Gli degravei si azzuffano Atena raggiunge Ares con una pietra Era rintuzza la furia di Artemide Infine tutti tornano sullrsquoOlimpo Apollo assunto lrsquoaspetto di Agenore respinge Achille percheacute i Troiani possano rifugiarsi allrsquointerno delle mura Canto XXII Il solo Ettore resta fuori nella pianura Invano Priamo ed Ecuba lo pregano di rientrare Mentre Achille si avvicina Ettore decide di affrontarlo ma quando quello gli egrave da presso col bronzo che gli lampeggia intorno laquosimile al raggio del fuoco ardente o del sole che sorgeraquo egrave afferrato dal panico e comincia a fuggire compiendo tre giri intorno alle mura Zeus pesa sulla bilancia i destini (le κῆρες) dei due eroi e quello di Ettore affonda in basso Allora Apollo lo abbandona e Atena apparsa a Ettore sotto le spoglie di suo fratello Deifobo gli si avvicina promettendogli aiuto e invece riporta ad Achille la lancia che gli era caduta fuori bersaglio Il colpo di risposta di Ettore rimbalza sullo scudo di Achille Ettore urla a Deifobo di passargli la sua lancia ma il falso Deifobo egrave scomparso ed Ettore comprende di trovarsi sullrsquoorlo dellrsquoabisso [T13] Achille gli trapassa la gola ed Ettore lo supplica di non oltraggiare la sua salma in risposta riceve la minaccia che finiragrave in pasto ai cani Achille trascina il cadavere alle navi attaccato al carro Priamo Ecuba e Andromaca si abbandonano al cordoglio a cui fanno eco le donne troiane Canto XXIII Viene preparato il banchetto funebre in onore di Patroclo la cui ombra nel corso della notte appare ad Achille chiedendo la sepoltura del corpo Il mattino seguente si appresta il rogo fra le offerte votive ci sono anche dodici giovani troiani Il giorno successivo si raccolgono le ossa di Patroclo Seguono i ludi funebri gare coi carri e con lrsquoarco duello in armi etc Canto XXIV Ogni giorno Achille trascina il cadavere di Ettore attorno alla tomba dellrsquoamico ma lo spettacolo offende gli degravei e al dodicesimo giorno Zeus decide di mandare Tetide percheacute induca suo figlio a restituire la salma di Ettore Iride viene inviata presso Priamo percheacute gli consigli di recarsi nel cuore della notte con un carro da trasporto e un copioso riscatto scortato da Ermes alla tenda di Achille Questi accoglie il vecchio con rispetto riconoscendo in lui lrsquoimmagine del padre lontano e si piega alla sua supplica [T14] Per volontagrave degli degravei il cadavere non egrave stato aggredito dalla putrefazione composto sul pianale del carro viene ricondotto dal padre a Troia Qui le lamentazioni rituali srsquoinnalzano dal gruppo delle donne (Andromaca Ecuba Elena) Si stipula una tregua di dodici giorni Per nove giorni i Troiani raccolgono legname poi anche il rogo di Ettore arde e si erige un tumulo
Letteratura greca [1]
19
Struttura e caratteri dellʼopera Poema di trama relativamente organica (soprattutto a partire dal canto XVI tutti gli avvenimenti tranne pochi episodi isolati ruotano attorno ai due principali antagonisti Ettore uccide Patroclo per vendicare Sarpedone e Achille uccide Ettore per vendicare Patroclo) pur se non privo di piugrave o meno cospicue incongruenze spiegabili in primo luogo con la lunga e complessa genesi orale dellrsquoopera lrsquoIliade lascia emergere in mezzo alle centinaia di nomi e alle intricate vicende alcuni caratteri delineati nella loro individualitagrave e innanzi tutto quelli di Achille e di Ettore accomunati dalla medesima coscienza di un destino di morte che sono pronti ad affrontare Appunto una tale attitudine a rappresentare i laquocaratteriraquo (ἤθη) dei suoi personaggi egrave un altro titolo di merito che Aristotele ascrive ad Omero (Poetica 1460a9-11)
dopo aver brevemente proemiato subito introduce un uomo una donna o un altro personaggio nessuno privo di caratterizzazione ma dotato di un carattere
Fondamentale per la struttura del poema egrave la novitagrave della prospettiva Possiamo presumere che i cosiddetti poemi ciclici22 mirassero a conservare lrsquoangolatura che era stata propria delle versioni pre-omeriche della saga troiana sigrave che puograve riuscire significativo il confronto fra lrsquoesordio della Piccola Iliade (dove muovendo da grandi entitagrave ndash la cittagrave il paese due popoli la guerra ndash viene lanciato secondo lrsquoespressione di J Latacz come laquouno sguardo dallrsquoesternoraquo)
Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην εὔπωλον ἧς πέρι πολλὰ πάθον Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος Canto Ilio e la terra dei Dardani dai bei puledri per la quale molti dolori patirono i Danai servitori di Ares
con lo laquosguardo internoraquo che caratterizza lrsquoinizio dellrsquoIliade
Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν ἡρώων αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν οἰωνοῖσί τε δαῖτα Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς Canta o dea di Achille figlio di Peleo la collera maledetta che pene innumerevoli inflisse agli Achei e molte scagliograve allrsquoAde vite possenti di eroi e ne faceva prede per i cani e pasto per gli uccelli e si avverava il volere di Zeus da quando primamente si separarono venuti a contesa LrsquoAtride sovrano di eroi e Achille magnifico
Argomento non egrave dunque come doveva avvenire nella tradizione del canto epico un evento complesso da inquadrare con un grandangolo onnicomprensivo e neppure come saragrave nellrsquoOdissea un personaggio colto nella multiforme varietagrave delle sue peregrinazioni egrave invece una reazione emotiva (lrsquoira di Achille) con le sue conseguenze (le innumerevoli morti degli Achei) Narrare di questa ira significa per il poeta cominciare da un punto preciso (laquoda quandoraquo) ossia dal momento della contesa e della separazione fra i due massimi eroi greci Agamennone il primo per potere (laquosovrano di eroiraquo) e Achille il primo per nobiltagrave e forza (δῖος) E sintomatica della bipolaritagrave del mondo epico in quanto mondo di degravei e di eroi egrave la sincronia per cui il taglio della narrazione coincide col decorso del laquovolere di Zeusraquo (Διὸς βουλή) forse da identificare con la promessa del dio a Tetide (rievocata piugrave oltre in questo
22 V cap II laquoLa tradizione omericaraquo
Letteratura greca [1]
20
stesso canto ai vv 518-527) di vendicare lrsquoaffronto subito da Achille o piugrave in generale con il corso degli eventi in quanto tutto come per definizione laquogiace sulle ginocchia di Zeusraquo Opera indubbiamente allrsquointerno del poema unrsquoidea formativa un progetto di qui un insieme monumentale unificato anche da una serie di corrispondenze a distanza fra cui particolare significato acquistano quelle fra primo e ultimo canto Nel canto I il vecchio Crise va come supplice presso Agamennone portando doni e supplicando la restituzione della figlia e Agamennone lo respinge aspramente minacciandolo di far ricorso alla violenza se dovesse tornare nel canto XXIV il vecchio Priamo va come supplice presso Achille portando doni e supplicando la restituzione del corpo del figlio Achille ha una prima reazione irosa (esordisce al v 560 con laquoSmetti di irritarmi vecchioraquo) ma poi accoglie la supplica E al di lagrave delle corrispondenze nelle linee dellrsquoazione si colgono fra principio e fine del poema alcuni importanti echi verbali in particolare fra XXIV 501 s
τοῦ νῦν εἵνεχ᾽ ἱκάνω νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενος παρὰ σεῖο φέρω δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα per lui [Ettore] vengo ora alle navi degli Achei per riscattarlo da te e ti porto compenso infinito
e I 12 s
ὁ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενός τε θυγάτρα φέρων δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα costui [Crise] venne alle navi rapide degli Achei per riscattare la figlia portando compenso infinito
fra XXIV 555-557
λῦσον ἵν᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδωmiddot σὺ δὲ δέξαι ἄποινα πολλά τά τοι φέρομενmiddot σὺ δὲ τῶνδrsquo ἀπόναιο καὶ ἔλθοις σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν restituiscimelo percheacute lo possa vedere con gli occhi e accogli il riscatto copioso che portiamo e tu possa goderne e tornare alla tua terra patria
e I 18-20
Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν εὖ δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκέσθαιmiddot παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην τὰ δ᾽ ἄποινα δέχεσθαι Atridi e voi altri Achei dai forti schinieri a voi concedano gli degravei che hanno le case in Olimpo di distruggere la cittagrave di Priamo e tornare facilmente in patria ma restituitemi la figlia e accettate il riscatto
fra XXIV 560 μηκέτι νῦν μ᾽ ἐρέθιζε (laquosmetti di irritarmiraquo) e I 32 μή μ᾽ ἐρέθιζε (laquonon mi irritareraquo) fra XXIV 568-570
τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς μή σε γέρον οὐδrsquo αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω καὶ ἱκέτην περ ἐόντα Διὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμάς Ora perciograve fra i dolori non mi eccitare lrsquoanimo ancora di piugrave bada o vecchio che non ti lasci neppure nella tenda
Letteratura greca [1]
21
bencheacute supplice e violi gli ordini di Zeus e I 26-28
μή σε γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω ἢ νῦν δηθύνοντ᾽ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο Mai te o vecchio io colga presso le concave navi ora a indugiare o piugrave tardi a tornare che piugrave non dovesse giovarti lo scettro e la benda del dio
(e infine XXIV 571 ὣς ἔφατ ἔδεισεν δ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ laquocosigrave diceva e il vecchio tremograve e obbediva alle paroleraquo ripete esattamente I 33) In effetti lrsquoepisodio terminale del poema col superamento dellrsquoira ad opera della pietagrave e del senso di unrsquoesistenza invasa dal dolore si propone come il rovesciamento consapevole dellrsquoepisodio iniziale che era apparso caratterizzato dalla cancellazione della pietagrave e del diritto dei supplici in nome della forza Al rifiuto iniziale del donoriscatto si oppone lrsquoaccettazione finale in consonanza con un principio-guida che opera nel poema secondo linee che alla fine si riunificano Agamennone restituisce Criseide al padre ma si appropria del dono fatto dagli altri Achei ad Achille (Briseide) Achille respinge i doni fatti da Agamennone per indurlo a riconciliarsi con lui ma dopo aver contestato nel IX canto la nozione che la vita umana possa essere barattata con una massa di beni torna alla lotta non in cambio di qualche premio da conquistare ma per vendicare lrsquouccisione dellrsquoamico Patroclo e tanto nella lotta sul campo di battaglia quanto nellrsquoinfierire sul cadavere di Ettore si abbandona a un furore cosigrave smisurato e patologico che puograve essere superato solo con lrsquoaccettare i doni di Priamo non tuttavia per il loro valore drsquouso ma percheacute in Priamo Achille riconosce lrsquoombra del padre lontano Cosigrave lrsquoIliade appare attraversata da un impulso fondamentale che muove dallrsquoideologia del dono e dalla conseguente centralitagrave assegnata allrsquoonore (τιμή) come ldquoprezzordquo che qualifica il valore del guerriero ma supera questo piano di valutazione dei rapporti umani attraverso la loro riformulazione nei termini di un umanesimo esistenziale che ha come punti di riferimento lrsquoidentitagrave universale dei condizionamenti oggettivi (la vecchiaia la malattia la morte) e i legami che uniscono padre e figlio compagno e compagno vivi e morti (il cordoglio finale di Andromaca Ecuba ed Elena sulla salma di Ettore) Entro questo orizzonte progressivamente allargato la guerra le lotte lo scontro mortale finiscono col rappresentare solo un momento e un aspetto dellrsquoesistenza graditi tanto agli degravei che vi assistono come spettatori interessati quanto agli uditori che riascoltano le antiche gesta eppure non tali da appiattire il poema in una prospettiva guerresca conclusa in se stessa Molto del fascino delle battaglie e delle ἀριστεῖαι dellrsquoIliade sta nella presenza recondita di un occhio che sa guardare al di lagrave di esse (e al di lagrave della stessa distinzione fra Greci e Troiani vincitori e vinti) e che puograve anche attraverso le similitudini lasciare irrompere il mondo della natura o del lavoro umano nel mezzo delle battaglie LʼOdissea LrsquoOdissea (Ὀδύσσεια) consta di circa 12100 esametri divisi anchrsquoessi in 24 libri e indicati con le lettere minuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquoargomento egrave costituito dalle avventure di Odisseo dalla distruzione di Troia al ritorno alla patria Itaca esposte secondo un ordine che entrando subito nel vivo degli avvenimenti (lrsquoinizio del poema mostra Odisseo nellrsquoisola di Calipso) rievoca poi i fatti giagrave trascorsi e li ricongiunge infine a partire dal libro XV (con lrsquoarrivo di Telemaco alla capanna di Eumeo dove giagrave si trova Odisseo) in unrsquoazione unitaria La trama del poema i cui avvenimenti sono concentrati cronologicamente nello spazio di 40 giorni (ma sono narrati solo gli avvenimenti di 16 giorni e 8 notti) si articola in tre parti la laquoTelemachiaraquo (canti I-IV) il laquoRitorno di Odisseoraquo (canti V-XIII) e la laquoVendetta di Odisseoraquo (canti XIV-XXIV)
Letteratura greca [1]
22
Canto I Tutti gli eroi superstiti sono ormai tornati da Troia alle loro case tranne Odisseo che pur desideroso di tornare egrave trattenuto dalla ninfa Calipso nellrsquoisola di Ogigia Gli degravei hanno pietagrave di lui tranne Posidone irato per lrsquoaccecamento del figlio il ciclope Polifemo Ma un consiglio degli degravei assente Posidone (che si egrave recato presso gli Etiopi) delibera il ritorno dellrsquoeroe si decide che Ermes andragrave subito da Calipso mentre Atena si avvia verso Itaca sotto lrsquoaspetto del signore dei Tafi Mente per incoraggiare il figlio di Odisseo Telemaco a tener testa ai pretendenti della madre i laquoprociraquo (i quali aspirano al regno tramite le nozze con Penelope) e per indurlo a intraprendere un viaggio in cerca di notizie sul padre Canto IΙ Telemaco segue il consiglio della dea e il giorno seguente nellrsquoassemblea popolare chiede una nave per andare in cerca del padre ma la sua richiesta non viene discussa e Leocrito scioglie lrsquoassemblea Grazie ad Atena che ora ha assunto le sembianze di Mentore (antico amico di Odisseo) Telemaco riesce tuttavia a trovare una nave con cui salpa nel corso della notte allrsquoinsaputa sia della madre che dei proci Canto IΙΙ Telemaco e MentoreAtena arrivano a Pilo e sul lido trovano Nestore che sta offrendo un sacrificio a Posidone Il vecchio eroe accoglie ospitalmente Telemaco e gli comunica molte notizie sul ritorno di altri Achei ma nessuna su Odisseo Alla sera Atena scompare in forma di aquila e il mattino seguente Telemaco salpa insieme con Pisistrato (figlio di Nestore) alla volta di Sparta dove arriva la sera del giorno successivo Canto IV A Sparta Menelao sta festeggiando il doppio matrimonio del figlio e della figlia Il giorno seguente Telemaco chiede del padre Menelao gli racconta il proprio ritorno durante il quale aveva incontrato Proteo il vecchio nume marino che gli aveva riferito come Odisseo fosse trattenuto nellrsquoisola di Calipso Intanto a Itaca i proci preparano insidie meditando di uccidere Telemaco al suo ritorno Penelope ne viene a conoscenza ma Atena le appare in sogno per confortarla Canto V Dopo un secondo concilio degli degravei (in effetti un ldquodoppionerdquo di quello del I canto) Zeus manda finalmente Ermes presso Calipso con lrsquoordine di lasciar partire Odisseo La ninfa aiuta lrsquoeroe a costruirsi una zattera Al diciottesimo giorno di navigazione Odisseo egrave in vista dellrsquoisola dei Feaci Scheria quando Posidone di ritorno dal suo soggiorno presso gli Etiopi lo vede e suscita una tempesta che distrugge la zattera Ma la dea marina Ino Leucotea impietositasi gli porge il proprio velo sostenuto dal quale lrsquoeroe giunge a nuoto alla riva di Scheria dove si abbandona esausto addormentandosi Canto VI In seguito a un sogno inviatole da Atena Nausicaa la figlia del re dei Feaci Alcinoo si reca nei pressi della spiaggia a lavare le vesti insieme con le ancelle Odisseo risvegliatosi atterrisce le fanciulle che fuggono tutte allrsquoinfuori di Nausicaa Lrsquoeroe supplica la giovane di porgerle aiuto ed ella lo fa rivestire e lo accompagna fino al bosco di Atena poco prima della cittagrave esortandolo a presentarsi a suo padre Canto VII Protetto dalla nebbia di cui Atena lo ha avvolto Odisseo entra nel palazzo abbraccia le ginocchia della regina Arete e la caligine scompare poi viene accolto con onore da Alcinoo Arete chiede a Odisseo donde provenga e chi gli abbia donato gli abiti (a lei ben noti) che indossa Lrsquoeroe inizia a raccontare le disavventure che gli sono occorse dopo la
Letteratura greca [1]
23
partenza dallrsquoisola di Calipso Alcinoo gli promette di farlo ricondurre a Itaca il giorno seguente Canto VIII Ma lrsquoindomani Alcinoo fa apprestare un banchetto durante il quale lrsquoaedo Demodoco canta della contesa insorta un giorno fra Achille e Odisseo Lrsquoeroe si copre il volto per nascondere le lacrime allora Alcinoo interrompe il canto e organizza una serie di gare nel corso delle quali Odisseo primeggia Poi Demodoco al margine di unrsquoarea per la danza dove si esibiscono i ballerini feaci canta gli amori di Ares e Afrodite e la vendetta di Efesto (che incatena i due amanti) La sera al ritorno nel palazzo Demodoco racconta la storia del Cavallo di legno Odisseo scoppia nuovamente in lacrime e Alcinoo gli chiede di rivelare il suo nome Canto IX Odisseo dichiara il proprio nome e dagrave inizio al racconto della propria storia a partire dalla caduta di Troia distruzione di Ismaro e perdite subite ad opera dei Ciconi sbarco presso i Lotofagi (che si nutrono di un cibo misterioso che fa dimenticare il ritorno) dopo una terribile tempesta scatenatasi durante il tentativo di doppiare il capo Malea arrivo allrsquoisola antistante quella dei Ciclopi dove Odisseo si trasferisce con una sola nave esplorazione dellrsquoisola perdita di alcuni compagni allrsquointerno della caverna del gigante monocolo accecamento del mostro e fuga Canto X Odisseo giunge allrsquoisola di Eolo signore dei venti che lo accoglie benevolmente e gli consegna alla partenza tutti i venti chiusi in un otre ma poi lo respinge con durezza quando ritorna presso di lui percheacute i compagni (sospettando che nellrsquootre siano racchiuse cospicue ricchezze) hanno sciolto i venti e da essi si egrave sprigionato un uragano che li ha risospinti sullrsquoisola Ripreso il mare Odisseo egrave trasportato fino ai Lestrigoni antropofagi il cui attacco priva lrsquoeroe di tutte le altre navi tranne la propria Con questa fugge fino allrsquoisola (Eea) della maga Circe Dopo che Circe ha trasformato in porci un gruppo di compagni mandati innanzi ad esplorare lrsquoisola Odisseo ha la meglio sulla maga (a cui impone di restituire forma umana ai compagni) grazie allrsquoerba moly fornitagli da Ermes Resta un anno presso Circe che al momento della partenza gli consiglia di recarsi al paese dei morti per interrogare il vate Tiresia Canto XI Approdato alla terra dei Cimmeri (che vivono immersi in una nebbia perenne sulla riva dellrsquoOceano) e scavata una fossa Odisseo sacrifica ai morti e immola una vittima speciale a Tiresia Le anime accorrono dapprima Elpenore caduto per caso giugrave dal tetto della casa di Circe (Odisseo gli promette sepoltura) poi la madre Anticlea (che gli racconta di esser morta di dolore per la sua assenza) quindi Tiresia che gli vaticina le sue vicende future fino alla morte (questa lo coglieragrave dopo una lunga vita in un paese straniero che non conosce neacute il sale neacute il remo) Da un certo punto in poi il poeta dimentica il presupposto per cui Odisseo aveva scavato una fossa alla quale i morti accorrevano per bere il sangue delle vittime e bevendolo riacquistavano per breve tempo una piena consapevolezza immagina invece che Odisseo sia allrsquointerno dellrsquoAde In questa sezione rientrano la descrizione di Aiace sdegnato di Minosse di Orione dei grandi peccatori di Eracle Poi Odisseo fa ritorno a Eea e ricevuti i consigli di Circe si imbarca per il ritorno in patria Canto XII Scampato alle Sirene che invano lo attirano col canto (si egrave fatto legare allrsquoalbero della nave i compagni che remano hanno le orecchie turate con la cera) passa tra Cariddi e Scilla (che gli rapisce sei uomini) ed egrave costretto dai compagni ad approdare in contrasto con le prescrizioni di Circe allrsquoisola Trinachia dove pascolano le greggi del Sole I
Letteratura greca [1]
24
compagni spronati da Euriloco se ne cibano nonostante il divieto dellrsquoeroe Il Sole sdegnato ottiene da Zeus che la nave sia colpita dal fulmine Tutti i compagni periscono ma Odisseo che ripassa tra Scilla e Cariddi si salva miracolosamente da questrsquoultima aggrappandosi a un fico selvatico fincheacute il gorgo restituisce i rottami della nave infine arriva remando con le mani allrsquoisola di Ogigia Canto XIII Terminato il racconto lrsquoeroe riceve doni dai Feaci e la notte seguente egrave ricondotto a Itaca e deposto addormentato sulla spiaggia presso un antro sacro alle Ninfe Al risveglio per la nebbia non riconosce la sua terra fincheacute Atena in veste di giovane pastore lo rassicura e poi rivelatasi gli dagrave istruzioni su come far strage dei proci e lo trasforma in un vecchio mendico Canto XIV Odisseo si reca allo stazzo del suo porcaio Eumeo che pur non riconoscendolo lo accoglie ospitalmente rifocillandolo e offrendogli un mantello per ripararsi dal gelo notturno Canto XV A questo punto la laquoTelemachiaraquo si riannoda allrsquoazione principale Telemaco che si trova ancora a Sparta viene indotto da Atena a tornare a Itaca sulla via del ritorno a Pilo accoglie a bordo lrsquoindovino Teoclimeno e grazie allrsquoaiuto della dea sfugge alle insidie dei proci sbarca a Itaca e si reca anchrsquoegli presso Eumeo Canto XVI Questi va da Penelope ad annunciargli il ritorno del figlio Intanto Odisseo rimosso lrsquoincantesimo si svela nel suo vero aspetto a Telemaco e con lui progetta la vendetta sui proci (che intanto tramano una nuova insidia ai danni di Telemaco) Eumeo torna al suo stazzo Canto XVII Il mattino seguente Telemaco si reca in cittagrave seguito in un secondo tempo da Eumeo e Odisseo (che ha riassunto lrsquoaspetto di mendico) Davanti al palazzo Odisseo egrave riconosciuto dal cane Argo Entra e va mendicando tra i proci Antinoo lo colpisce alla spalla destra con uno sgabello Canto XVIII Odisseo si batte al pugilato col mendicante Iro Penelope scesa nella sala prospetta ai proci lrsquoeventualitagrave di un nuovo matrimonio Odisseo egrave insultato dalla schiava Melanto e schiva uno sgabello scagliato da Eurinomo Canto XIX Insieme con Telemaco lrsquoeroe allontana le armi dalla sala poi conversa con Penelope che gli racconta un sogno e gli espone il suo piano per sedare le contese tra i proci concedendosi sposa a colui che riusciragrave a tendere lrsquoarco di Odisseo la prova avverragrave il giorno seguente al novilunio Durante il colloquio la fida schiava Euriclea lava i piedi di Odisseo e riconosciutolo da unrsquoantica cicatrice sta per rivelarne lrsquoidentitagrave ma lrsquoeroe la costringe a tacere Canto XX Al mattino Euriclea e le ancelle fanno i preparativi per il banchetto Giungono Eumeo Melanzio e il mandriano Filezio Un presagio mandato da Zeus dissuade i proci dal progetto di uccidere Telemaco Durante il banchetto Teoclimeno predice la loro imminente rovina
Letteratura greca [1]
25
Canto XXI Penelope conduce lrsquoarco nella sala dopo che parecchi fra i proci e lo stesso Telemaco hanno tentato invano di tenderne la corda Odisseo chiede di partecipare alla prova tende lrsquoarco senza fatica e riesce a far passare la freccia attraverso gli anelli di dodici scuri predisposte da Telemaco Canto XXII Poi scaglia le frecce sui proci e si rivela nella sua identitagrave Nella lotta che segue Telemaco Eumeo e Filezio aiutano il padrone contro i proci (appoggiati dal capraio Melanzio) Tutti i proci restano uccisi le ancelle infedeli sono impiccate Melanzio viene mutilato e ucciso soltanto lrsquoaedo Femio e lrsquoaraldo Medonte sono risparmiati Canto XXIII Nuovo colloquio fra Odisseo e Penelope che durante lrsquoeccidio dormiva ed egrave stata svegliata da Euriclea Penelope esita ancora a riconoscere il marito e non si arrende alla veritagrave fincheacute Odisseo non le descrive la posizione e la struttura del letto coniugale Canto XXIV Ermes conduce allrsquoAde le ombre dei proci Odisseo fa visita al padre Laerte nella masseria dove quello vive nello squallore e nellrsquoemarginazione e si fa riconoscere Intanto il padre di Antinoo incita gli Itacesi alla rivolta e il poema si conclude con lo scontro di Odisseo e dei suoi contro i concittadini lrsquoeroe ha la meglio e Zeus scagliato il fulmine pone fine alla battaglia Atena sotto lrsquoaspetto di Mentore stabilisce fra i contendenti un patto per il futuro36
Struttura e caratteri dellʼopera Giagrave la prima parola del proemio (ἄνδρα) non menziona come tema dellrsquoopera un determinato episodio della vita del protagonista ma il protagonista stesso (I 1-10)
Ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα πολύτροπον ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεmiddot πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περmiddot αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο νήπιοι οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιονmiddot αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ τῶν ἁμόθεν γε θεά θύγατερ Διός εἰπὲ καὶ ἡμῖν Dellrsquouomo multiforme a me racconta o Musa che molto errograve dopo che di Troia la sacra rocca distrusse di molti uomini vide le cittagrave riconobbe il pensiero e molti per il mare patigrave dolori nellrsquoanimo per salvare la sua vita e il ritorno dei compagni Eppure non li salvograve i compagni per quanto bramasse per la loro stessa follia si persero gli stolti i buoi del Sole Iperione mangiarono e quello rapigrave ad essi il digrave del ritorno Di questo da un punto qualsiasi narra anche a noi o dea figlia di Zeus
Storie favolose di naviganti racconti imperniati sul ritorno dei guerrieri achei che avevano combattuto a Troia e il particolare rientro in patria di Odisseo figlio di Laerte erano forse giagrave stati connessi e intrecciati nella precedente tradizione epica sigrave che il presente cantore poteva
Letteratura greca [1]
26
metter mano alla vicenda partendo (v 10) laquoda un punto qualsiasiraquo (ἁμόθεν) una notazione che certo presuppone la convenzione propria dellrsquoesordio tradizionale di un canto epico comparabile con i giagrave ricordati ἐξ οὗ (laquoda quandoraquo) di Iliade I 4 ed ἔνθεν (laquoda doveraquo) di Odissea VIII 500 Senoncheacute rispetto a queste indicazioni di tipo puntuale il tratto costituito dalla dimensione casuale quasi arbitraria inerente ad ἁμόθεν proprio mentre dichiara lrsquoassenza di un determinato piano compositivo implica in realtagrave che il racconto non si svolgeragrave per filo e per segno secondo lrsquoordine noto a poeta e uditori non si snoderagrave κατὰ κόσμον (laquoper ordineraquo) come il canto di Demodoco (VIII 489) ma seguiragrave un andamento originale Il ldquopunto qualsiasirdquo incipitario non rappresenta una scelta della Musa (figura dellrsquoarchivio tematico che conserva le laquovieraquo dellrsquoepica) bensigrave di questo cantore che ha deciso di far incominciare la narrazione in medias res e ha in serbo la sorpresa di far succedere al concilio degli degravei (che decide lrsquoinvio di Ermes presso Calipso) non lrsquoazione testeacute programmata (azione che viene differita con un ritardo che a piugrave riprese ha scandalizzato i lettori a principio del V canto) ma la partenza di Atena alla volta di Itaca e lrsquoavvio della laquoTelemachiaraquo Le due diverse vicende proposte a principio del poema quella di Telemaco e quella di Odisseo procedono infatti in parallelo coprendo un analogo lasso di tempo Piugrave oltre la decisione di trasformare la sequenza narrativa che va dalla partenza di Odisseo da Troia fino al suo arrivo nella terra dei Feaci in una rievocazione fatta dallrsquoeroe in prima persona al cospetto di Alcinoo e dei Feaci (la sezione detta degli ἀπόλογοι laquoraccontiraquo) crea una struttura ad anello che parte dal presente e ad esso fa ritorno dopo aver ricostruito le premesse della condizione attuale del protagonista Col canto XIII Odisseo egrave riportato dai Feaci a Itaca e questo permette la saldatura fra le vicende sue e quelle di Telemaco sia pure col differimento dellrsquoincontro e del riconoscimento fra padre e figlio fino al canto XVI Far scorrere in parallelo sequenze distinte organizzare programmi narrativi a corta e a lunga gittata tendere o allentare ad arte il ritmo della narrazione non si tratta davvero di procedimenti che potessero configurarsi come tradizionali dellrsquoarte epica quanto piuttosto di un momento sperimentale di una ricerca di soluzioni nuove al termine di una lunga e ormai consolidata sedimentazione di percorsi compiuti allrsquointerno di un determinato repertorio tematico unrsquoaudacia inventiva una πολυτροπίη degne del protagonista del poema che inevitabilmente comportavano rischi molteplici di incoerenze dissonanze occasionali avarie della macchina epica e che tuttavia erano destinate a conseguire un risultato assolutamente convincente allrsquoorecchio di chi si abbandonasse al fascino del racconto senza lrsquourgenza propria di altre etagrave e di altre mentalitagrave di puntare il dito sui singoli dettagli o le singole sfasature
PER SAPERNE DI PIUrsquo Difficoltagrave e incongruenze della narrazione omerica Forti della possibilitagrave di un controllo su un testo scritto che possiamo percorrere in avanti e a ritroso secondo ritmi di nostra scelta a noi non riesce difficile cogliere alcune delle difficoltagrave organizzative incontrate nella composizione del poema In proposito per ricordare un caso che saragrave allrsquoorigine delle discussioni di orientamento ldquoanaliticordquo intorno allrsquoOdissea possiamo leggere il discorso che Atena prese le sembianze di Mente re dei Tafi rivolge a Telemaco nel I canto (vv 253-305) Ah infelice ti manca molto davvero lrsquoassente Odisseo che getti le mani addosso ai pretendenti sfrontati Percheacute se ora tornato stesse sulla soglia 255 con una scure lo scudo e due lance cosigrave come io per la prima volta lo vidi in casa nostra che beveva e godeva di ritorno da Efira da Ilo di Mermero (andograve anche ligrave Odisseo con la nave veloce 260 in cerca del veleno omicida per averne da ungere le frecce di bronzo ma quello non glielo diede percheacute temeva gli dei che vivono eterni
Letteratura greca [1]
27
glielo diede invece mio padre percheacute lrsquoamava moltissimo) se stesse Odisseo tra i pretendenti cosigrave 265 essi avrebbero tutti rapida morte e nozze amare Ma sulle ginocchia degli dei questo giace se una volta tornato faragrave o no vendetta nella sua casa te invece io esorto a riflettere come cacciare i pretendenti da casa 270 Ebbene ora ascolta e alle mie parole darsquo retta Domattina chiamati gli eroi Achei a consiglio rivolgi a tutti un discorso e siano testimoni gli dei Ai pretendenti comanda drsquoandarsene per i fatti loro e tua madre se lrsquoanimo la spinge alle nozze 275 ritorni a casa del padre molto potente Prepareranno essi le nozze e disporranno i doni nuziali moltissimi quanti gli pare che debbano andare alla figlia A te darograve un saggio consiglio se vuoi ascoltarlo armata una nave con venti remi la migliore che crsquoegrave 280 Varsquo a domandare del padre partito da tempo se mai te ne parli un mortale o sentissi da Zeus la voce che divulga la fama tra gli uomini Anzitutto varsquo a Pilo e interroga il chiaro Nestore di ligrave poi varsquo a Sparta dal biondo Menelao 285 degli Achei vestiti di bronzo egli egrave tornato per ultimo Se senti dire qualcosa sulla vita e il ritorno del padre per quanto stremato potresti sopportare un altro anno se invece senti dire che egrave morto e non vive allora tornato nella cara terra patria 290 ergigli un tumulo e offrigli funebri offerte moltissime quanto conviene e darsquo tua madre a un marito E poi dopo aver compiuto e fatto ogni cosa allora medita nella mente e nellrsquoanimo come tu possa uccidere nelle tue case 295 i pretendenti con lrsquoinganno affrontandoli non devi piugrave avere i modi di un bimbo percheacute ormai non sei tale Non senti lrsquoillustre Oreste quale gloria ha acquistato fra tutti gli uomini percheacute uccise lrsquoassassino del padre Egisto esperto di inganni che gli uccise il nobile padre 300 Anche tu caro infatti molto bello e grande ti vedo sii valoroso percheacute ti lodi anche qualcuno dei posteri Ma io tornerograve adesso alla nave veloce dai compagni che forse impazienti mi aspettano Tu devi pensarci da te dammi retta 305
[Tr di GA Privitera] Le stranezze non mancano davvero e cosigrave sono state messe a fuoco da Stephanie West nel suo commento23 1 Atena sa evidentemente molto piugrave di quanto uno come Mente avrebbe potuto sapere in particolare ella sa che i proci ignoreranno lrsquoinvito di Telemaco a lasciare la sua casa e fatto piugrave importante che gli degravei tra breve ricondurranno in patria Odisseo A queste osservazioni si puograve replicare con la stessa West che laquosi sono esagerate difficoltagrave e
23 Omero Odissea I cit 219 ss
Letteratura greca [1]
28
incongruenze alle quali un pubblico di ascoltatori (o anche un lettore moderatamente attento) probabilmente non farebbe casoraquo 2 Il progetto di una pubblica denuncia dei proci dinanzi agli degravei e agli uomini ai vv 273-274 egrave ciograve che Atena sembra prefiggersi nel promuovere lrsquoassemblea degli Itacesi (assemblea che effettivamente avragrave luogo a principio del canto II) drsquoaltra parte le successive istruzioni di AtenaMente ai vv 295 s (medita come uccidere i pretendenti) presuppongono che di quella richiesta da formulare nel corso dellrsquoassembla essi non terranno alcun conto Anche a questa osservazione si puograve rispondere che laquoegrave ragionevole attendersi che Telemaco condivida la previsione di un esito negativo della sua iniziativaraquo e si puograve aggiungere che pure in caso di insuccesso il ricorso allrsquoassemblea potrebbe ottenere almeno il risultato di screditare i pretendenti presso la comunitagrave itacese legittimando un successivo ricorso alla violenza (e si tratta di una legittimazione di cui anche lrsquoultimo canto mostreragrave lrsquoesigenza) 3 Dopo che Telemaco aveva detto che la madre non intendeva risposarsi (vv 249-250) AtenaMente si esprime ai vv 275-278 come se Penelope desiderasse proprio nuove nozze e inoltre sarebbe assurdo che il padre di Penelope cominciasse a contrattare un secondo matrimonio prima del ritorno di Telemaco dal suo viaggio e che mettesse mano a preparativi che rischierebbero di essere annullati qualche tempo dopo con inevitabile imbarazzo se Telemaco venisse a sapere che Odisseo egrave ancora vivo In piugrave lrsquoandamento sintattico di questi versi presenta un anacoluto durissimo per cui a principio del v 275 lrsquoaccusativo μητέρα egrave seguito da un ἂψ ἴτω (laquovada indietroraquo laquotorniraquo) che richiederebbe come soggetto un nominativo μήτηρ Come hanno reagito i lettori di Omero Nellrsquoantichitagrave un grammatico rimasto anonimo cambiava come attesta uno scolio μητέρ᾽ in μήτηρ nel secolo XVIII Richard Bentley modificava ἴτω in ἴμεν (infinito eolico di εἶμι laquovadoraquo) nel XIX un altro grande della filologia europea Gottfried Hermann risolveva piugrave drasticamente la questione eliminando il complesso dei vv 275-278 e la stessa West mostra simpatia per tale proposta supponendo laquounrsquoaggiunta posteriore modellata sul corrispondente passo del libro IIraquo (dove i vv 196 s sono identici ai vv 277 s e il v 195 copre lo stesso contenuto dei vv 275 s) Si tratta di procedimenti adeguati ai dati di fatto Migliorano davvero il testo che ci egrave stato tramandato In realtagrave ambedue le ldquocorrezionirdquo appena ricordate (di μήτερ᾽ e di ἴτω) ottengono un risultato tanto lineare che egrave davvero difficile pensare che lrsquoanacoluto avrebbe potuto invadere tutta la tradizione se non fosse stato originario e quanto allrsquoespunzione dei vv 275-278 essa indubbiamente peggiorerebbe il ritmo del discorso determinando lrsquoavvicinamento fra i due versi (v 271 e v 279) molto simili fra loro che aprono le due sequenze occupate dai consigli di Mente E allora La via piugrave saggia egrave senzrsquoaltro quella di tenerci qui come quasi sempre di fronte al testo omerico contraddizioni e anacoluti riconoscendo in essi lrsquoeffetto dellrsquoattivitagrave di un cantore che pur sulla base di una traccia largamente memorizzata restava pur sempre legato a quella prassi orale per cui composizione ed esecuzione tendevano a coincidere E lrsquoanacoluto si spiega bene se cerchiamo di immedesimarci nel procedimento seguito dal poeta Egli ha affidato ad Atena un certo flusso argomentativo per cui la dea deve dar consigli a Telemaco sui suoi rapporti coi proci e con la madre e cosigrave colloca in fine di v 274 un ἄνωχθι (laquoordinaraquo) destinato a reggere gli accusativi simmetricamente dislocati in principio di verso (vv 274 e 275) μνηστῆρας e μητέρα Senoncheacute giunto a questa seconda parte dellrsquoargomentazione egli si avvede quanto sarebbe illogico che Telemaco sollecitasse la madre a nuove nozze di qui lrsquoimprovviso cambio di costruzione che svincola al prezzo di una sensibile slogatura sintattica lrsquoipotesi delle nuove nozze dallrsquoordine impartito a Telemaco e la prospetta invece come un desiderio eventuale della stessa Penelope Il poeta ha un progetto ben meditato brani e sequenze piugrave volte sperimentati ed egrave col supporto di questi materiali giagrave elaborati che egli si fa strada attraverso le insidie della
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
14
con lrsquoidea stravagante di saggiare lrsquoumore delle truppe proponendo il ritorno in patria Gli uomini incitati da Tersite corrono alle navi pronti a salpare ma vengono bloccati da Odisseo e da Nestore Egrave significativo che Tersite lrsquoanti-eroe riecheggi le accuse di Achille ad Agamennone sottolineando gli onori di cui questi gode e prenda le parti di Achille [T3] Per tutta la seconda parte del libro lrsquoazione viene interrotta per far posto alla grandiosa uscita in armi dellrsquoesercito acheo dal recinto delle navi un quadro scintillante ornato da una catena di sei similitudini concatenate introdotte per illustrare il fulgore delle armi il rombo dei passi umani e degli zoccoli precipitosi lrsquoaspetto della schiera achea e la maestria dei condottieri Un ldquoCatalogo delle navirdquo contiene lrsquoelenco circostanziato delle genti greche che hanno preso parte allrsquoassedio ed egrave seguito da un catalogo piugrave breve e piugrave arido degli alleati dei Troiani accorsi in difesa di Ilio Canto III Lrsquoatteso scontro tra gli schieramenti appena passati in rassegna non ha luogo ParideAlessandro ottiene infatti una tregua per sfidare Menelao Iride la messaggera degli degravei spinge Elena ad accorrere alle mura presso le porte Scee per assistere al preannunciato duello di ligrave Priamo e gli altri anziani di Troia osservano la pianura Su richiesta del vecchio sovrano (una richiesta che sarebbe stata piugrave ldquoverosimilerdquo al primo anno di guerra) Elena nomina i piugrave prestigiosi campioni achei [T4] Nel duello che segue Paride si trova ben presto a mal partito contro Menelao ma Afrodite lo sottrae ai colpi del nemico avvolgendolo in una fitta nebbia e lo riporta nelle sue stanze dove dopo aver assunto lrsquoaspetto di una vecchia filatrice ordina a Elena di giacere con lui Elena si ribella ma la dea non transige Mentre Paride ed Elena si uniscono nellrsquoamplesso Menelao furibondo cerca fra la folla il nemico che sia i Greci che i Troiani sarebbero lieti di consegnargli pur di porre fine alla guerra Agamennone rivendicando la vittoria di Menelao pretende dai Troiani la restituzione di Elena e delle sue ricchezze noncheacute il pagamento di una forte ammenda Canto IV La tregua stipulata dopo la scomparsa di Paride viene infranta dallrsquoarciere Pandaro che sollecitato da Atena (scesa tra le schiere troiane su ordine di Zeus) ferisce con una freccia Menelao questi viene prontamente guarito dal medico Macaone figlio di Asclepio Agamennone passa fra le schiere incitandole a combattere incontra vari capi intenti a dare istruzioni ai propri uomini Solo Ulisse e Menesteo si tengono in disparte ricevendo i rimproveri di Agamennone ai quali Ulisse reagisce con indignazione Gli Achei muovono contro i Troiani con grande ordine e disciplina mentre i Troiani e i loro alleati schiamazzano come barbari Ha inizio la battaglia vera e propria nella quale lrsquoattenzione egrave focalizzata sui duelli individuali Ad assistere e rincuorare i Troiani compare Apollo sulla rocca di Troia mentre Atena infonde coraggio nei Greci Il canto si chiude sullrsquoinfuriare della battaglia la cui descrizione riprenderagrave nel canto successivo Canto V Balza in primo piano Diomede di cui viene presentata lrsquoἀριστεία lrsquoeroe laquoglorioso e chiaroraquo fa strage di nemici imperversando furiosamente fra le schiere troiane Nel pieno del combattimento viene ferito da una freccia scagliata da Pandaro il quale mena gran vanto del colpo andato a segno Diomede ottenuta unrsquoimmediata guarigione grazie allrsquointervento di Atena muove allora contro il nemico che nel frattempo era stato accolto sul carro di Enea Pandaro scaglia la sua lancia contro Diomede ma lo scudo di questi regge il colpo Diomede colpisce a sua volta uccidendo il nemico Enea scende dal cocchio per proteggere il cadavere di Pandaro dagli Achei che vorrebbero farne razzia ma Diomede lo colpisce con un grande masso fratturandogli il femore Enea viene salvato dallrsquointervento di Afrodite che lo avvolge nel suo manto mentre Diomede arriva addirittura a ferire al polso la dea che fugge sullrsquoOlimpo a farsi confortare dalla madre Dione Il figlio di Tideo attacca anche Apollo che aveva sottratto Enea alla sua furia ma
Letteratura greca [1]
15
egrave fermato dal grido di ammonimento del dio Incitati e aiutati da Ares ora i Troiani avanzano con impeto Intervengono Era e Atena e questrsquoultima assume il ruolo di auriga di Diomede Col suo aiuto questi ferisce al ventre Ares che fugge sullrsquoOlimpo Anche le dee vi fanno ritorno Canto VI Il canto VI egrave una naturale continuazione del V (tanto che Erodoto citeragrave come dallrsquoἀριστεία di Diomede un brano della prima parte del VI canto) La battaglia infuria nella pianura ma il furore di Diomede si stempera su una nota di cortesia quando lrsquoeroe dopo aver sfidato Glauco di Licia scopre di avere con lrsquoavversario antichi rapporti di ospitalitagrave I due si scambiano le armature (a detrimento di Glauco a cui laquoZeus Cronide levograve il senno cheacute scambiograve con Diomede Tidide armi drsquooro con armi di bronzo cento buoi con nove buoiraquo [vv 234-6]) Frattanto Ettore su invito dellrsquoindovino Eleno rientra in cittagrave dove le donne devono cercare di ottenere con offerte e voti il favore di Atena e incontra dapprima la madre Ecuba poi Paride (che intende ricondurre alla battaglia) vorrebbe salutare anche la moglie ma non la trova in casa bensigrave alle porte Scee dove Andromaca era accorsa piena drsquoangoscia insieme col figlioletto e con la nutrice Nel colloquio che segue ella lo implora di non esporre al pericolo se stessa e il figlio La replica di Ettore egrave esemplare per capire la prospettiva del poema e le motivazioni dellrsquoagire dei personaggi dominanti se Achille e gli eroi achei in genere cercano onore e gloria a questa motivazione (che pure non egrave assente) Ettore antepone lrsquoαἰδώς il senso di laquovergognaraquo e di responsabilitagrave nei confronti della comunitagrave e del nucleo familiare di cui egrave il difensore Poi si volta per prendere tra le braccia Astianatte ma lrsquoelmo lucente e il cimiero ondeggiante impauriscono il piccolo che si rifugia in seno alla nutrice Alla fine del canto Paride si incontra con Ettore e i due si avviano verso il campo di battaglia [T5] Canto VII A principio del canto VII Atena e Apollo si accordano per indurre Ettore a lanciare una sfida agli Achei per un duello Il sorteggio designa Aiace come campione greco Nello scontro Ettore lancia per primo lrsquoasta che penetra ma senza trapassarlo nello scudo di Aiace greve e massiccio (compaginato con sette strati di pelle bovina simile a una torre) Aiace di rimando lacera lo scudo e il pettorale della corazza ma non riesce a squarciare le carni del nemico percheacute Ettore si piega di lato Allora i due brandiscono di nuovo le aste poi ricorrono alle pietre Alla fine gli araldi arrestano il combattimento con la giustificazione che laquola notte giagrave viene ed egrave bene obbedire alla notteraquo (v 282) Su proposta di Nestore gli Achei decidono per il giorno seguente di seppellire i morti e di scavare una grande trincea difesa da un bastione sul margine del loro accampamento Respingono lrsquoofferta di pace dei Troiani (che prevederebbe la riconsegna dei tesori sottratti da Paride a Sparta) Il mattino seguente i morti vengono cremati e durante la giornata si erige il muro di protezione Canto VIII Nellrsquoassemblea degli degravei Zeus vieta ai numi di appoggiare lrsquouna o lrsquoaltra parte in conflitto Al mattino il combattimento riprende e a mezzogiorno Zeus pone i destini dei due popoli sulla bilancia che piega a favore dei Troiani Sul campo di battaglia Diomede salva Nestore Lrsquoazione di Ettore egrave travolgente fincheacute Zeus contravvenendo alla sua intenzione di favorire i Troiani accoglie la preghiera di Agamennone per risollevare il morale degli Achei che organizzano la difesa delle navi Nel corso degli scontri si segnala lrsquoarciere Teucro che colpisce i nemici muovendosi in sincronia con Aiace Telamonio che lo protegge con lo scudo Incitato da Agamennone egli prova a colpire anche Ettore ma soccombe colpito con una pietra A questa vista Era e Atena corrono ad armarsi per intervenire a favore degli Achei ma vengono distolte dalle minacce di Zeus che manifesta la propria intenzione di favorire i Troiani fino a quando i Greci non saranno ridotti alla disperazione tanto da scongiurare Achille percheacute ritorni Il sopraggiungere della notte
Letteratura greca [1]
16
interrompe i combattimenti Ettore galvanizzato dai successi ottenuti in quel giorno si illude che la vittoria sia a portata di mano e prospetta ai suoi una prossima ritirata degli Achei Il canto si chiude con il banchetto dei Troiani che banchettano nella pianura esaltati dalla speranza di vittoria Canto IX Agamennone affranto propone di fare ciograve che nel canto II aveva suggerito soltanto per mettere alla prova lrsquoesercito interrompere la guerra e tornare in patria Diomede si oppone e Nestore in un consiglio dei capi propone di tentare la riconciliazione con Achille Si invia alla tenda di Achille unrsquoambasceria (composta da Aiace Odisseo e Fenice antico pedagogo di Achille) per offrire doni ricchissimi Achille non cede anzi minaccia di salpare immediatamente verso la patria [T6] Inutilmente Fenice lrsquoantico precettore di Achille cerca di ammorbidire la determinazione del Pelide richiamando la vicenda dellrsquoeroe Meleagro [T7] Gli inviati riferiscono ad Agamennone la risposta di Achille egli torneragrave a combattere solo quando Ettore saragrave arrivato fino alle navi dei Mirmidoni Canto X Nella stessa notte si effettua una missione segreta nel corso della quale Odisseo e Diomede dapprima catturano la spia troiana Dolone (che Ettore aveva inviato alle navi achee promettendogli come ricompensa i cavalli di Achille) poi uccidono il re trace Reso appena arrivato presso i Troiani e ne rubano i magnifici cavalli Giagrave gli antichi ritenevano questo canto unrsquoaggiunta post-omerica e questi dubbi trovano riscontro in lati eccentrici della narrazione e nellrsquoimpiego di un linguaggio che spesso appare svincolato dal corrente repertorio formulare Canto XI Si apre una nuova giornata di battaglia (la cui narrazione si protrarragrave fino al canto XVIII) che ruota intorno allrsquoἀριστεία di Agamennone Quando lrsquoAtride viene ferito gli Achei ripiegano Diomede resta anchrsquoegli ferito Odisseo e Aiace evitano a stento la massa dei nemici Nestore salva sul suo carro Macaone Achille che dalla poppa della nave osserva la battaglia vuol sapere chi egrave condotto via da Nestore e manda Patroclo che viene accolto molto benevolmente e con cui Nestore intrattiene un lungo discorso egli dice di deplorare il comportamento di Achille e con atteggiamento consono alla sua condizione di anziano si dilunga nel raccontare le proprie gesta giovanili Egli esorta quindi Patroclo a far leva sulla sua amicizia per convincere Achille a riprendere il combattimento o - almeno - a concedere a Patroclo le sue armi per incutere timore nei Troiani Eccitato dalle parole del vecchio Patroclo si avvia verso la nave di Achille ma incontra Euripilo ferito che gli chiede aiuto ed egli impietositosi lo accompagna alla tenda e cura la ferita Canto XII Divisi in cinque contingenti i Troiani danno lrsquoassalto al muro eretto a difesa del campo acheo Sul campo di battaglia si manifesta un prodigio unrsquoaquila in cielo con un grosso serpente fra le zampe che riesce a ferire lrsquouccello e a sfuggire Polidamante che interpreta il segno come un presagio funesto consiglia di tornare indietro ma Ettore egrave di altro avviso Sarpedone e Glauco sferrano un attacco contro il muro e - pur rimanendo feriti - riescono ad aprire una breccia La battaglia infuria con esito incerto fincheacute Ettore con un macigno sfonda una delle porte consentendo ai Troiani di entrare in massa nel campo acheo mentre i Greci fuggono verso il mare Canto XIII Zeus distoglie lo sguardo dalla battaglia nella convinzione che nessuno fra gli dei avrebbe osato violare il divieto di intervenire ne approfitta invece Poseidone favorevole ai Greci Assunto lrsquoaspetto dellrsquoindovino Calcante il dio infonde nuovo vigore nei due Aiaci
Letteratura greca [1]
17
spronandoli al combattimento Gli Achei riconoscono lrsquointervento divino e riprendono fiducia I combattimenti si susseguono violentissimi Nella resistenza si distingue il re cretese Idomeneo Polidamante consiglia una seconda volta di interrompere la battaglia e accenna allrsquoimminente intervento di Achille Ettore non ascolta lrsquoammonimento e riprende lrsquoassalto Il canto si chiude con un suo scambio di insulti con Aiace Telamonio Canto XIV Mentre Diomede Odisseo e Agamennone tornano feriti allrsquoaccampamento Era per distogliere Zeus dalla battaglia e consentire a Poseidone di favorire gli Achei indossa la cintura magica di Afrodite e sollecita il consorte a un convegno amoroso sullrsquoIda dopo lrsquoamplesso Zeus cade in un sonno profondo e Hypnos (il Sonno) annuncia a Posidone che potragrave aiutare senza rischi gli Achei Ettore colpito con una pietra da Aiace resta a lungo in stato di incoscienza e i Troiani vengono respinti Canto XV Zeus si risveglia avvedendosi dellrsquoinganno subito e costringe Era a mandargli Iride e Apollo la prima allontaneragrave Posidone dal campo di battaglia Apollo inciteragrave Ettore a far retrocedere gli Achei fino alle navi dei Mirmidoni Riprende lrsquooffensiva troiana Apollo stesso abbatte il muro e scuotendo lrsquoegida atterrisce gli Achei Patroclo corre da Achille mentre i Troiani giagrave sono sul punto di appiccare il fuoco alle navi Canto XVI Patroclo in lacrime supplica Achille di intervenire o di mandare lui stesso al suo posto [T8] Achille gli consegna le proprie armi e gli fa promettere che non si avventureragrave oltre la zona delle navi Ma Patroclo trascinato dal suo stesso impeto oltrepassa il limite prescrittogli da Achille Abbatte Sarpedone figlio di Zeus attorno al cui cadavere infuria la lotta fincheacute Apollo lo sottrae alla mischia e Hypnos e Thanatos (il demone della morte) lo trasportano in Licia sua patria Patroclo continua lrsquoassalto alla testa dei Mirmidoni fin sotto le mura di Troia ma poco prima del tramonto al quarto assalto Apollo stesso assunto lrsquoaspetto di Asio lo percuote fra le spalle allora Euforbo lo colpisce con lrsquoasta ed Ettore lo trafigge Canto XVII Euforbo viene ucciso da Menelao ma Ettore riesce a catturare le armi di Achille indossate da Patroclo Vigorosamente sostenuti da Aiace gli Achei difendono il cadavere Una densa nebbia scende sui combattenti Zeus infonde nuovo ardimento nei cavalli di Achille piangenti per la fine di Patroclo [T9] Atena e Apollo arroventano la lotta attorno alla salma In seguito alla preghiera di Aiace Zeus dissolve la nebbia Menelao manda Antiloco figlio di Nestore a informare Achille della morte di Patroclo la cui salma viene intanto trascinata fuori della battaglia da Menelao e Merione mentre i due Aiaci offrono la necessaria copertura contro la furia incalzante dei nemici Canto XVIII Lo scoppio di selvaggio dolore a cui si abbandona Achille allrsquoudire della morte di Patroclo provoca lrsquoaccorrere dal mare di Tetide insieme con le Nereidi La madre gli promette di procurargli nuove armi Poicheacute la salma di Patroclo egrave tuttora contesa Achille fa la sua apparizione sul fossato e lancia un grido che atterrisce i nemici Efesto su preghiera di Tetide foggia le nuove armi fra cui un magnifico scudo su cui appaiono effigiati in bande concentriche gli aspetti salienti dellrsquoesistenza umana Canto XIX Il mattino seguente Tetide porta le armi al figlio e con lrsquoambrosia preserva la salma di Patroclo dalla decomposizione Achille convoca unrsquoassemblea dellrsquoesercito e rinuncia alla sua collera Agamennone lamenta di essere stato ldquoaccecatordquo da Zeus e promette doni
Letteratura greca [1]
18
riparatori [T10] Achille si lascia convincere a stento ad attendere che i soldati abbiano mangiato Poi gli armati si radunano e anche Achille si arma Il suo cavallo Xanto gli predice la prossima morte [T11] Canto XX Zeus consente agli degravei di partecipare alla nuova battaglia Enea scontratosi con Achille egrave tratto in salvo da Posidone Achille infuria come un incendio in una selva Canto XXI Achille colma di cadaveri il fiume Scamandro e cattura dodici giovani troiani che intende offrire in sacrificio a Patroclo non risparmia neppure Licaone figlio di Priamo che lo supplica con accenti di grande intensitagrave ma altrettanto intensa nella consapevolezza di un destino imminente egrave la pur spietata replica del Pelide [T12] Lo Scamandro solleva le proprie onde ma le fiamme di Efesto inaridiscono il terreno e domano la corrente Gli degravei si azzuffano Atena raggiunge Ares con una pietra Era rintuzza la furia di Artemide Infine tutti tornano sullrsquoOlimpo Apollo assunto lrsquoaspetto di Agenore respinge Achille percheacute i Troiani possano rifugiarsi allrsquointerno delle mura Canto XXII Il solo Ettore resta fuori nella pianura Invano Priamo ed Ecuba lo pregano di rientrare Mentre Achille si avvicina Ettore decide di affrontarlo ma quando quello gli egrave da presso col bronzo che gli lampeggia intorno laquosimile al raggio del fuoco ardente o del sole che sorgeraquo egrave afferrato dal panico e comincia a fuggire compiendo tre giri intorno alle mura Zeus pesa sulla bilancia i destini (le κῆρες) dei due eroi e quello di Ettore affonda in basso Allora Apollo lo abbandona e Atena apparsa a Ettore sotto le spoglie di suo fratello Deifobo gli si avvicina promettendogli aiuto e invece riporta ad Achille la lancia che gli era caduta fuori bersaglio Il colpo di risposta di Ettore rimbalza sullo scudo di Achille Ettore urla a Deifobo di passargli la sua lancia ma il falso Deifobo egrave scomparso ed Ettore comprende di trovarsi sullrsquoorlo dellrsquoabisso [T13] Achille gli trapassa la gola ed Ettore lo supplica di non oltraggiare la sua salma in risposta riceve la minaccia che finiragrave in pasto ai cani Achille trascina il cadavere alle navi attaccato al carro Priamo Ecuba e Andromaca si abbandonano al cordoglio a cui fanno eco le donne troiane Canto XXIII Viene preparato il banchetto funebre in onore di Patroclo la cui ombra nel corso della notte appare ad Achille chiedendo la sepoltura del corpo Il mattino seguente si appresta il rogo fra le offerte votive ci sono anche dodici giovani troiani Il giorno successivo si raccolgono le ossa di Patroclo Seguono i ludi funebri gare coi carri e con lrsquoarco duello in armi etc Canto XXIV Ogni giorno Achille trascina il cadavere di Ettore attorno alla tomba dellrsquoamico ma lo spettacolo offende gli degravei e al dodicesimo giorno Zeus decide di mandare Tetide percheacute induca suo figlio a restituire la salma di Ettore Iride viene inviata presso Priamo percheacute gli consigli di recarsi nel cuore della notte con un carro da trasporto e un copioso riscatto scortato da Ermes alla tenda di Achille Questi accoglie il vecchio con rispetto riconoscendo in lui lrsquoimmagine del padre lontano e si piega alla sua supplica [T14] Per volontagrave degli degravei il cadavere non egrave stato aggredito dalla putrefazione composto sul pianale del carro viene ricondotto dal padre a Troia Qui le lamentazioni rituali srsquoinnalzano dal gruppo delle donne (Andromaca Ecuba Elena) Si stipula una tregua di dodici giorni Per nove giorni i Troiani raccolgono legname poi anche il rogo di Ettore arde e si erige un tumulo
Letteratura greca [1]
19
Struttura e caratteri dellʼopera Poema di trama relativamente organica (soprattutto a partire dal canto XVI tutti gli avvenimenti tranne pochi episodi isolati ruotano attorno ai due principali antagonisti Ettore uccide Patroclo per vendicare Sarpedone e Achille uccide Ettore per vendicare Patroclo) pur se non privo di piugrave o meno cospicue incongruenze spiegabili in primo luogo con la lunga e complessa genesi orale dellrsquoopera lrsquoIliade lascia emergere in mezzo alle centinaia di nomi e alle intricate vicende alcuni caratteri delineati nella loro individualitagrave e innanzi tutto quelli di Achille e di Ettore accomunati dalla medesima coscienza di un destino di morte che sono pronti ad affrontare Appunto una tale attitudine a rappresentare i laquocaratteriraquo (ἤθη) dei suoi personaggi egrave un altro titolo di merito che Aristotele ascrive ad Omero (Poetica 1460a9-11)
dopo aver brevemente proemiato subito introduce un uomo una donna o un altro personaggio nessuno privo di caratterizzazione ma dotato di un carattere
Fondamentale per la struttura del poema egrave la novitagrave della prospettiva Possiamo presumere che i cosiddetti poemi ciclici22 mirassero a conservare lrsquoangolatura che era stata propria delle versioni pre-omeriche della saga troiana sigrave che puograve riuscire significativo il confronto fra lrsquoesordio della Piccola Iliade (dove muovendo da grandi entitagrave ndash la cittagrave il paese due popoli la guerra ndash viene lanciato secondo lrsquoespressione di J Latacz come laquouno sguardo dallrsquoesternoraquo)
Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην εὔπωλον ἧς πέρι πολλὰ πάθον Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος Canto Ilio e la terra dei Dardani dai bei puledri per la quale molti dolori patirono i Danai servitori di Ares
con lo laquosguardo internoraquo che caratterizza lrsquoinizio dellrsquoIliade
Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν ἡρώων αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν οἰωνοῖσί τε δαῖτα Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς Canta o dea di Achille figlio di Peleo la collera maledetta che pene innumerevoli inflisse agli Achei e molte scagliograve allrsquoAde vite possenti di eroi e ne faceva prede per i cani e pasto per gli uccelli e si avverava il volere di Zeus da quando primamente si separarono venuti a contesa LrsquoAtride sovrano di eroi e Achille magnifico
Argomento non egrave dunque come doveva avvenire nella tradizione del canto epico un evento complesso da inquadrare con un grandangolo onnicomprensivo e neppure come saragrave nellrsquoOdissea un personaggio colto nella multiforme varietagrave delle sue peregrinazioni egrave invece una reazione emotiva (lrsquoira di Achille) con le sue conseguenze (le innumerevoli morti degli Achei) Narrare di questa ira significa per il poeta cominciare da un punto preciso (laquoda quandoraquo) ossia dal momento della contesa e della separazione fra i due massimi eroi greci Agamennone il primo per potere (laquosovrano di eroiraquo) e Achille il primo per nobiltagrave e forza (δῖος) E sintomatica della bipolaritagrave del mondo epico in quanto mondo di degravei e di eroi egrave la sincronia per cui il taglio della narrazione coincide col decorso del laquovolere di Zeusraquo (Διὸς βουλή) forse da identificare con la promessa del dio a Tetide (rievocata piugrave oltre in questo
22 V cap II laquoLa tradizione omericaraquo
Letteratura greca [1]
20
stesso canto ai vv 518-527) di vendicare lrsquoaffronto subito da Achille o piugrave in generale con il corso degli eventi in quanto tutto come per definizione laquogiace sulle ginocchia di Zeusraquo Opera indubbiamente allrsquointerno del poema unrsquoidea formativa un progetto di qui un insieme monumentale unificato anche da una serie di corrispondenze a distanza fra cui particolare significato acquistano quelle fra primo e ultimo canto Nel canto I il vecchio Crise va come supplice presso Agamennone portando doni e supplicando la restituzione della figlia e Agamennone lo respinge aspramente minacciandolo di far ricorso alla violenza se dovesse tornare nel canto XXIV il vecchio Priamo va come supplice presso Achille portando doni e supplicando la restituzione del corpo del figlio Achille ha una prima reazione irosa (esordisce al v 560 con laquoSmetti di irritarmi vecchioraquo) ma poi accoglie la supplica E al di lagrave delle corrispondenze nelle linee dellrsquoazione si colgono fra principio e fine del poema alcuni importanti echi verbali in particolare fra XXIV 501 s
τοῦ νῦν εἵνεχ᾽ ἱκάνω νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενος παρὰ σεῖο φέρω δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα per lui [Ettore] vengo ora alle navi degli Achei per riscattarlo da te e ti porto compenso infinito
e I 12 s
ὁ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενός τε θυγάτρα φέρων δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα costui [Crise] venne alle navi rapide degli Achei per riscattare la figlia portando compenso infinito
fra XXIV 555-557
λῦσον ἵν᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδωmiddot σὺ δὲ δέξαι ἄποινα πολλά τά τοι φέρομενmiddot σὺ δὲ τῶνδrsquo ἀπόναιο καὶ ἔλθοις σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν restituiscimelo percheacute lo possa vedere con gli occhi e accogli il riscatto copioso che portiamo e tu possa goderne e tornare alla tua terra patria
e I 18-20
Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν εὖ δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκέσθαιmiddot παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην τὰ δ᾽ ἄποινα δέχεσθαι Atridi e voi altri Achei dai forti schinieri a voi concedano gli degravei che hanno le case in Olimpo di distruggere la cittagrave di Priamo e tornare facilmente in patria ma restituitemi la figlia e accettate il riscatto
fra XXIV 560 μηκέτι νῦν μ᾽ ἐρέθιζε (laquosmetti di irritarmiraquo) e I 32 μή μ᾽ ἐρέθιζε (laquonon mi irritareraquo) fra XXIV 568-570
τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς μή σε γέρον οὐδrsquo αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω καὶ ἱκέτην περ ἐόντα Διὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμάς Ora perciograve fra i dolori non mi eccitare lrsquoanimo ancora di piugrave bada o vecchio che non ti lasci neppure nella tenda
Letteratura greca [1]
21
bencheacute supplice e violi gli ordini di Zeus e I 26-28
μή σε γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω ἢ νῦν δηθύνοντ᾽ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο Mai te o vecchio io colga presso le concave navi ora a indugiare o piugrave tardi a tornare che piugrave non dovesse giovarti lo scettro e la benda del dio
(e infine XXIV 571 ὣς ἔφατ ἔδεισεν δ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ laquocosigrave diceva e il vecchio tremograve e obbediva alle paroleraquo ripete esattamente I 33) In effetti lrsquoepisodio terminale del poema col superamento dellrsquoira ad opera della pietagrave e del senso di unrsquoesistenza invasa dal dolore si propone come il rovesciamento consapevole dellrsquoepisodio iniziale che era apparso caratterizzato dalla cancellazione della pietagrave e del diritto dei supplici in nome della forza Al rifiuto iniziale del donoriscatto si oppone lrsquoaccettazione finale in consonanza con un principio-guida che opera nel poema secondo linee che alla fine si riunificano Agamennone restituisce Criseide al padre ma si appropria del dono fatto dagli altri Achei ad Achille (Briseide) Achille respinge i doni fatti da Agamennone per indurlo a riconciliarsi con lui ma dopo aver contestato nel IX canto la nozione che la vita umana possa essere barattata con una massa di beni torna alla lotta non in cambio di qualche premio da conquistare ma per vendicare lrsquouccisione dellrsquoamico Patroclo e tanto nella lotta sul campo di battaglia quanto nellrsquoinfierire sul cadavere di Ettore si abbandona a un furore cosigrave smisurato e patologico che puograve essere superato solo con lrsquoaccettare i doni di Priamo non tuttavia per il loro valore drsquouso ma percheacute in Priamo Achille riconosce lrsquoombra del padre lontano Cosigrave lrsquoIliade appare attraversata da un impulso fondamentale che muove dallrsquoideologia del dono e dalla conseguente centralitagrave assegnata allrsquoonore (τιμή) come ldquoprezzordquo che qualifica il valore del guerriero ma supera questo piano di valutazione dei rapporti umani attraverso la loro riformulazione nei termini di un umanesimo esistenziale che ha come punti di riferimento lrsquoidentitagrave universale dei condizionamenti oggettivi (la vecchiaia la malattia la morte) e i legami che uniscono padre e figlio compagno e compagno vivi e morti (il cordoglio finale di Andromaca Ecuba ed Elena sulla salma di Ettore) Entro questo orizzonte progressivamente allargato la guerra le lotte lo scontro mortale finiscono col rappresentare solo un momento e un aspetto dellrsquoesistenza graditi tanto agli degravei che vi assistono come spettatori interessati quanto agli uditori che riascoltano le antiche gesta eppure non tali da appiattire il poema in una prospettiva guerresca conclusa in se stessa Molto del fascino delle battaglie e delle ἀριστεῖαι dellrsquoIliade sta nella presenza recondita di un occhio che sa guardare al di lagrave di esse (e al di lagrave della stessa distinzione fra Greci e Troiani vincitori e vinti) e che puograve anche attraverso le similitudini lasciare irrompere il mondo della natura o del lavoro umano nel mezzo delle battaglie LʼOdissea LrsquoOdissea (Ὀδύσσεια) consta di circa 12100 esametri divisi anchrsquoessi in 24 libri e indicati con le lettere minuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquoargomento egrave costituito dalle avventure di Odisseo dalla distruzione di Troia al ritorno alla patria Itaca esposte secondo un ordine che entrando subito nel vivo degli avvenimenti (lrsquoinizio del poema mostra Odisseo nellrsquoisola di Calipso) rievoca poi i fatti giagrave trascorsi e li ricongiunge infine a partire dal libro XV (con lrsquoarrivo di Telemaco alla capanna di Eumeo dove giagrave si trova Odisseo) in unrsquoazione unitaria La trama del poema i cui avvenimenti sono concentrati cronologicamente nello spazio di 40 giorni (ma sono narrati solo gli avvenimenti di 16 giorni e 8 notti) si articola in tre parti la laquoTelemachiaraquo (canti I-IV) il laquoRitorno di Odisseoraquo (canti V-XIII) e la laquoVendetta di Odisseoraquo (canti XIV-XXIV)
Letteratura greca [1]
22
Canto I Tutti gli eroi superstiti sono ormai tornati da Troia alle loro case tranne Odisseo che pur desideroso di tornare egrave trattenuto dalla ninfa Calipso nellrsquoisola di Ogigia Gli degravei hanno pietagrave di lui tranne Posidone irato per lrsquoaccecamento del figlio il ciclope Polifemo Ma un consiglio degli degravei assente Posidone (che si egrave recato presso gli Etiopi) delibera il ritorno dellrsquoeroe si decide che Ermes andragrave subito da Calipso mentre Atena si avvia verso Itaca sotto lrsquoaspetto del signore dei Tafi Mente per incoraggiare il figlio di Odisseo Telemaco a tener testa ai pretendenti della madre i laquoprociraquo (i quali aspirano al regno tramite le nozze con Penelope) e per indurlo a intraprendere un viaggio in cerca di notizie sul padre Canto IΙ Telemaco segue il consiglio della dea e il giorno seguente nellrsquoassemblea popolare chiede una nave per andare in cerca del padre ma la sua richiesta non viene discussa e Leocrito scioglie lrsquoassemblea Grazie ad Atena che ora ha assunto le sembianze di Mentore (antico amico di Odisseo) Telemaco riesce tuttavia a trovare una nave con cui salpa nel corso della notte allrsquoinsaputa sia della madre che dei proci Canto IΙΙ Telemaco e MentoreAtena arrivano a Pilo e sul lido trovano Nestore che sta offrendo un sacrificio a Posidone Il vecchio eroe accoglie ospitalmente Telemaco e gli comunica molte notizie sul ritorno di altri Achei ma nessuna su Odisseo Alla sera Atena scompare in forma di aquila e il mattino seguente Telemaco salpa insieme con Pisistrato (figlio di Nestore) alla volta di Sparta dove arriva la sera del giorno successivo Canto IV A Sparta Menelao sta festeggiando il doppio matrimonio del figlio e della figlia Il giorno seguente Telemaco chiede del padre Menelao gli racconta il proprio ritorno durante il quale aveva incontrato Proteo il vecchio nume marino che gli aveva riferito come Odisseo fosse trattenuto nellrsquoisola di Calipso Intanto a Itaca i proci preparano insidie meditando di uccidere Telemaco al suo ritorno Penelope ne viene a conoscenza ma Atena le appare in sogno per confortarla Canto V Dopo un secondo concilio degli degravei (in effetti un ldquodoppionerdquo di quello del I canto) Zeus manda finalmente Ermes presso Calipso con lrsquoordine di lasciar partire Odisseo La ninfa aiuta lrsquoeroe a costruirsi una zattera Al diciottesimo giorno di navigazione Odisseo egrave in vista dellrsquoisola dei Feaci Scheria quando Posidone di ritorno dal suo soggiorno presso gli Etiopi lo vede e suscita una tempesta che distrugge la zattera Ma la dea marina Ino Leucotea impietositasi gli porge il proprio velo sostenuto dal quale lrsquoeroe giunge a nuoto alla riva di Scheria dove si abbandona esausto addormentandosi Canto VI In seguito a un sogno inviatole da Atena Nausicaa la figlia del re dei Feaci Alcinoo si reca nei pressi della spiaggia a lavare le vesti insieme con le ancelle Odisseo risvegliatosi atterrisce le fanciulle che fuggono tutte allrsquoinfuori di Nausicaa Lrsquoeroe supplica la giovane di porgerle aiuto ed ella lo fa rivestire e lo accompagna fino al bosco di Atena poco prima della cittagrave esortandolo a presentarsi a suo padre Canto VII Protetto dalla nebbia di cui Atena lo ha avvolto Odisseo entra nel palazzo abbraccia le ginocchia della regina Arete e la caligine scompare poi viene accolto con onore da Alcinoo Arete chiede a Odisseo donde provenga e chi gli abbia donato gli abiti (a lei ben noti) che indossa Lrsquoeroe inizia a raccontare le disavventure che gli sono occorse dopo la
Letteratura greca [1]
23
partenza dallrsquoisola di Calipso Alcinoo gli promette di farlo ricondurre a Itaca il giorno seguente Canto VIII Ma lrsquoindomani Alcinoo fa apprestare un banchetto durante il quale lrsquoaedo Demodoco canta della contesa insorta un giorno fra Achille e Odisseo Lrsquoeroe si copre il volto per nascondere le lacrime allora Alcinoo interrompe il canto e organizza una serie di gare nel corso delle quali Odisseo primeggia Poi Demodoco al margine di unrsquoarea per la danza dove si esibiscono i ballerini feaci canta gli amori di Ares e Afrodite e la vendetta di Efesto (che incatena i due amanti) La sera al ritorno nel palazzo Demodoco racconta la storia del Cavallo di legno Odisseo scoppia nuovamente in lacrime e Alcinoo gli chiede di rivelare il suo nome Canto IX Odisseo dichiara il proprio nome e dagrave inizio al racconto della propria storia a partire dalla caduta di Troia distruzione di Ismaro e perdite subite ad opera dei Ciconi sbarco presso i Lotofagi (che si nutrono di un cibo misterioso che fa dimenticare il ritorno) dopo una terribile tempesta scatenatasi durante il tentativo di doppiare il capo Malea arrivo allrsquoisola antistante quella dei Ciclopi dove Odisseo si trasferisce con una sola nave esplorazione dellrsquoisola perdita di alcuni compagni allrsquointerno della caverna del gigante monocolo accecamento del mostro e fuga Canto X Odisseo giunge allrsquoisola di Eolo signore dei venti che lo accoglie benevolmente e gli consegna alla partenza tutti i venti chiusi in un otre ma poi lo respinge con durezza quando ritorna presso di lui percheacute i compagni (sospettando che nellrsquootre siano racchiuse cospicue ricchezze) hanno sciolto i venti e da essi si egrave sprigionato un uragano che li ha risospinti sullrsquoisola Ripreso il mare Odisseo egrave trasportato fino ai Lestrigoni antropofagi il cui attacco priva lrsquoeroe di tutte le altre navi tranne la propria Con questa fugge fino allrsquoisola (Eea) della maga Circe Dopo che Circe ha trasformato in porci un gruppo di compagni mandati innanzi ad esplorare lrsquoisola Odisseo ha la meglio sulla maga (a cui impone di restituire forma umana ai compagni) grazie allrsquoerba moly fornitagli da Ermes Resta un anno presso Circe che al momento della partenza gli consiglia di recarsi al paese dei morti per interrogare il vate Tiresia Canto XI Approdato alla terra dei Cimmeri (che vivono immersi in una nebbia perenne sulla riva dellrsquoOceano) e scavata una fossa Odisseo sacrifica ai morti e immola una vittima speciale a Tiresia Le anime accorrono dapprima Elpenore caduto per caso giugrave dal tetto della casa di Circe (Odisseo gli promette sepoltura) poi la madre Anticlea (che gli racconta di esser morta di dolore per la sua assenza) quindi Tiresia che gli vaticina le sue vicende future fino alla morte (questa lo coglieragrave dopo una lunga vita in un paese straniero che non conosce neacute il sale neacute il remo) Da un certo punto in poi il poeta dimentica il presupposto per cui Odisseo aveva scavato una fossa alla quale i morti accorrevano per bere il sangue delle vittime e bevendolo riacquistavano per breve tempo una piena consapevolezza immagina invece che Odisseo sia allrsquointerno dellrsquoAde In questa sezione rientrano la descrizione di Aiace sdegnato di Minosse di Orione dei grandi peccatori di Eracle Poi Odisseo fa ritorno a Eea e ricevuti i consigli di Circe si imbarca per il ritorno in patria Canto XII Scampato alle Sirene che invano lo attirano col canto (si egrave fatto legare allrsquoalbero della nave i compagni che remano hanno le orecchie turate con la cera) passa tra Cariddi e Scilla (che gli rapisce sei uomini) ed egrave costretto dai compagni ad approdare in contrasto con le prescrizioni di Circe allrsquoisola Trinachia dove pascolano le greggi del Sole I
Letteratura greca [1]
24
compagni spronati da Euriloco se ne cibano nonostante il divieto dellrsquoeroe Il Sole sdegnato ottiene da Zeus che la nave sia colpita dal fulmine Tutti i compagni periscono ma Odisseo che ripassa tra Scilla e Cariddi si salva miracolosamente da questrsquoultima aggrappandosi a un fico selvatico fincheacute il gorgo restituisce i rottami della nave infine arriva remando con le mani allrsquoisola di Ogigia Canto XIII Terminato il racconto lrsquoeroe riceve doni dai Feaci e la notte seguente egrave ricondotto a Itaca e deposto addormentato sulla spiaggia presso un antro sacro alle Ninfe Al risveglio per la nebbia non riconosce la sua terra fincheacute Atena in veste di giovane pastore lo rassicura e poi rivelatasi gli dagrave istruzioni su come far strage dei proci e lo trasforma in un vecchio mendico Canto XIV Odisseo si reca allo stazzo del suo porcaio Eumeo che pur non riconoscendolo lo accoglie ospitalmente rifocillandolo e offrendogli un mantello per ripararsi dal gelo notturno Canto XV A questo punto la laquoTelemachiaraquo si riannoda allrsquoazione principale Telemaco che si trova ancora a Sparta viene indotto da Atena a tornare a Itaca sulla via del ritorno a Pilo accoglie a bordo lrsquoindovino Teoclimeno e grazie allrsquoaiuto della dea sfugge alle insidie dei proci sbarca a Itaca e si reca anchrsquoegli presso Eumeo Canto XVI Questi va da Penelope ad annunciargli il ritorno del figlio Intanto Odisseo rimosso lrsquoincantesimo si svela nel suo vero aspetto a Telemaco e con lui progetta la vendetta sui proci (che intanto tramano una nuova insidia ai danni di Telemaco) Eumeo torna al suo stazzo Canto XVII Il mattino seguente Telemaco si reca in cittagrave seguito in un secondo tempo da Eumeo e Odisseo (che ha riassunto lrsquoaspetto di mendico) Davanti al palazzo Odisseo egrave riconosciuto dal cane Argo Entra e va mendicando tra i proci Antinoo lo colpisce alla spalla destra con uno sgabello Canto XVIII Odisseo si batte al pugilato col mendicante Iro Penelope scesa nella sala prospetta ai proci lrsquoeventualitagrave di un nuovo matrimonio Odisseo egrave insultato dalla schiava Melanto e schiva uno sgabello scagliato da Eurinomo Canto XIX Insieme con Telemaco lrsquoeroe allontana le armi dalla sala poi conversa con Penelope che gli racconta un sogno e gli espone il suo piano per sedare le contese tra i proci concedendosi sposa a colui che riusciragrave a tendere lrsquoarco di Odisseo la prova avverragrave il giorno seguente al novilunio Durante il colloquio la fida schiava Euriclea lava i piedi di Odisseo e riconosciutolo da unrsquoantica cicatrice sta per rivelarne lrsquoidentitagrave ma lrsquoeroe la costringe a tacere Canto XX Al mattino Euriclea e le ancelle fanno i preparativi per il banchetto Giungono Eumeo Melanzio e il mandriano Filezio Un presagio mandato da Zeus dissuade i proci dal progetto di uccidere Telemaco Durante il banchetto Teoclimeno predice la loro imminente rovina
Letteratura greca [1]
25
Canto XXI Penelope conduce lrsquoarco nella sala dopo che parecchi fra i proci e lo stesso Telemaco hanno tentato invano di tenderne la corda Odisseo chiede di partecipare alla prova tende lrsquoarco senza fatica e riesce a far passare la freccia attraverso gli anelli di dodici scuri predisposte da Telemaco Canto XXII Poi scaglia le frecce sui proci e si rivela nella sua identitagrave Nella lotta che segue Telemaco Eumeo e Filezio aiutano il padrone contro i proci (appoggiati dal capraio Melanzio) Tutti i proci restano uccisi le ancelle infedeli sono impiccate Melanzio viene mutilato e ucciso soltanto lrsquoaedo Femio e lrsquoaraldo Medonte sono risparmiati Canto XXIII Nuovo colloquio fra Odisseo e Penelope che durante lrsquoeccidio dormiva ed egrave stata svegliata da Euriclea Penelope esita ancora a riconoscere il marito e non si arrende alla veritagrave fincheacute Odisseo non le descrive la posizione e la struttura del letto coniugale Canto XXIV Ermes conduce allrsquoAde le ombre dei proci Odisseo fa visita al padre Laerte nella masseria dove quello vive nello squallore e nellrsquoemarginazione e si fa riconoscere Intanto il padre di Antinoo incita gli Itacesi alla rivolta e il poema si conclude con lo scontro di Odisseo e dei suoi contro i concittadini lrsquoeroe ha la meglio e Zeus scagliato il fulmine pone fine alla battaglia Atena sotto lrsquoaspetto di Mentore stabilisce fra i contendenti un patto per il futuro36
Struttura e caratteri dellʼopera Giagrave la prima parola del proemio (ἄνδρα) non menziona come tema dellrsquoopera un determinato episodio della vita del protagonista ma il protagonista stesso (I 1-10)
Ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα πολύτροπον ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεmiddot πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περmiddot αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο νήπιοι οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιονmiddot αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ τῶν ἁμόθεν γε θεά θύγατερ Διός εἰπὲ καὶ ἡμῖν Dellrsquouomo multiforme a me racconta o Musa che molto errograve dopo che di Troia la sacra rocca distrusse di molti uomini vide le cittagrave riconobbe il pensiero e molti per il mare patigrave dolori nellrsquoanimo per salvare la sua vita e il ritorno dei compagni Eppure non li salvograve i compagni per quanto bramasse per la loro stessa follia si persero gli stolti i buoi del Sole Iperione mangiarono e quello rapigrave ad essi il digrave del ritorno Di questo da un punto qualsiasi narra anche a noi o dea figlia di Zeus
Storie favolose di naviganti racconti imperniati sul ritorno dei guerrieri achei che avevano combattuto a Troia e il particolare rientro in patria di Odisseo figlio di Laerte erano forse giagrave stati connessi e intrecciati nella precedente tradizione epica sigrave che il presente cantore poteva
Letteratura greca [1]
26
metter mano alla vicenda partendo (v 10) laquoda un punto qualsiasiraquo (ἁμόθεν) una notazione che certo presuppone la convenzione propria dellrsquoesordio tradizionale di un canto epico comparabile con i giagrave ricordati ἐξ οὗ (laquoda quandoraquo) di Iliade I 4 ed ἔνθεν (laquoda doveraquo) di Odissea VIII 500 Senoncheacute rispetto a queste indicazioni di tipo puntuale il tratto costituito dalla dimensione casuale quasi arbitraria inerente ad ἁμόθεν proprio mentre dichiara lrsquoassenza di un determinato piano compositivo implica in realtagrave che il racconto non si svolgeragrave per filo e per segno secondo lrsquoordine noto a poeta e uditori non si snoderagrave κατὰ κόσμον (laquoper ordineraquo) come il canto di Demodoco (VIII 489) ma seguiragrave un andamento originale Il ldquopunto qualsiasirdquo incipitario non rappresenta una scelta della Musa (figura dellrsquoarchivio tematico che conserva le laquovieraquo dellrsquoepica) bensigrave di questo cantore che ha deciso di far incominciare la narrazione in medias res e ha in serbo la sorpresa di far succedere al concilio degli degravei (che decide lrsquoinvio di Ermes presso Calipso) non lrsquoazione testeacute programmata (azione che viene differita con un ritardo che a piugrave riprese ha scandalizzato i lettori a principio del V canto) ma la partenza di Atena alla volta di Itaca e lrsquoavvio della laquoTelemachiaraquo Le due diverse vicende proposte a principio del poema quella di Telemaco e quella di Odisseo procedono infatti in parallelo coprendo un analogo lasso di tempo Piugrave oltre la decisione di trasformare la sequenza narrativa che va dalla partenza di Odisseo da Troia fino al suo arrivo nella terra dei Feaci in una rievocazione fatta dallrsquoeroe in prima persona al cospetto di Alcinoo e dei Feaci (la sezione detta degli ἀπόλογοι laquoraccontiraquo) crea una struttura ad anello che parte dal presente e ad esso fa ritorno dopo aver ricostruito le premesse della condizione attuale del protagonista Col canto XIII Odisseo egrave riportato dai Feaci a Itaca e questo permette la saldatura fra le vicende sue e quelle di Telemaco sia pure col differimento dellrsquoincontro e del riconoscimento fra padre e figlio fino al canto XVI Far scorrere in parallelo sequenze distinte organizzare programmi narrativi a corta e a lunga gittata tendere o allentare ad arte il ritmo della narrazione non si tratta davvero di procedimenti che potessero configurarsi come tradizionali dellrsquoarte epica quanto piuttosto di un momento sperimentale di una ricerca di soluzioni nuove al termine di una lunga e ormai consolidata sedimentazione di percorsi compiuti allrsquointerno di un determinato repertorio tematico unrsquoaudacia inventiva una πολυτροπίη degne del protagonista del poema che inevitabilmente comportavano rischi molteplici di incoerenze dissonanze occasionali avarie della macchina epica e che tuttavia erano destinate a conseguire un risultato assolutamente convincente allrsquoorecchio di chi si abbandonasse al fascino del racconto senza lrsquourgenza propria di altre etagrave e di altre mentalitagrave di puntare il dito sui singoli dettagli o le singole sfasature
PER SAPERNE DI PIUrsquo Difficoltagrave e incongruenze della narrazione omerica Forti della possibilitagrave di un controllo su un testo scritto che possiamo percorrere in avanti e a ritroso secondo ritmi di nostra scelta a noi non riesce difficile cogliere alcune delle difficoltagrave organizzative incontrate nella composizione del poema In proposito per ricordare un caso che saragrave allrsquoorigine delle discussioni di orientamento ldquoanaliticordquo intorno allrsquoOdissea possiamo leggere il discorso che Atena prese le sembianze di Mente re dei Tafi rivolge a Telemaco nel I canto (vv 253-305) Ah infelice ti manca molto davvero lrsquoassente Odisseo che getti le mani addosso ai pretendenti sfrontati Percheacute se ora tornato stesse sulla soglia 255 con una scure lo scudo e due lance cosigrave come io per la prima volta lo vidi in casa nostra che beveva e godeva di ritorno da Efira da Ilo di Mermero (andograve anche ligrave Odisseo con la nave veloce 260 in cerca del veleno omicida per averne da ungere le frecce di bronzo ma quello non glielo diede percheacute temeva gli dei che vivono eterni
Letteratura greca [1]
27
glielo diede invece mio padre percheacute lrsquoamava moltissimo) se stesse Odisseo tra i pretendenti cosigrave 265 essi avrebbero tutti rapida morte e nozze amare Ma sulle ginocchia degli dei questo giace se una volta tornato faragrave o no vendetta nella sua casa te invece io esorto a riflettere come cacciare i pretendenti da casa 270 Ebbene ora ascolta e alle mie parole darsquo retta Domattina chiamati gli eroi Achei a consiglio rivolgi a tutti un discorso e siano testimoni gli dei Ai pretendenti comanda drsquoandarsene per i fatti loro e tua madre se lrsquoanimo la spinge alle nozze 275 ritorni a casa del padre molto potente Prepareranno essi le nozze e disporranno i doni nuziali moltissimi quanti gli pare che debbano andare alla figlia A te darograve un saggio consiglio se vuoi ascoltarlo armata una nave con venti remi la migliore che crsquoegrave 280 Varsquo a domandare del padre partito da tempo se mai te ne parli un mortale o sentissi da Zeus la voce che divulga la fama tra gli uomini Anzitutto varsquo a Pilo e interroga il chiaro Nestore di ligrave poi varsquo a Sparta dal biondo Menelao 285 degli Achei vestiti di bronzo egli egrave tornato per ultimo Se senti dire qualcosa sulla vita e il ritorno del padre per quanto stremato potresti sopportare un altro anno se invece senti dire che egrave morto e non vive allora tornato nella cara terra patria 290 ergigli un tumulo e offrigli funebri offerte moltissime quanto conviene e darsquo tua madre a un marito E poi dopo aver compiuto e fatto ogni cosa allora medita nella mente e nellrsquoanimo come tu possa uccidere nelle tue case 295 i pretendenti con lrsquoinganno affrontandoli non devi piugrave avere i modi di un bimbo percheacute ormai non sei tale Non senti lrsquoillustre Oreste quale gloria ha acquistato fra tutti gli uomini percheacute uccise lrsquoassassino del padre Egisto esperto di inganni che gli uccise il nobile padre 300 Anche tu caro infatti molto bello e grande ti vedo sii valoroso percheacute ti lodi anche qualcuno dei posteri Ma io tornerograve adesso alla nave veloce dai compagni che forse impazienti mi aspettano Tu devi pensarci da te dammi retta 305
[Tr di GA Privitera] Le stranezze non mancano davvero e cosigrave sono state messe a fuoco da Stephanie West nel suo commento23 1 Atena sa evidentemente molto piugrave di quanto uno come Mente avrebbe potuto sapere in particolare ella sa che i proci ignoreranno lrsquoinvito di Telemaco a lasciare la sua casa e fatto piugrave importante che gli degravei tra breve ricondurranno in patria Odisseo A queste osservazioni si puograve replicare con la stessa West che laquosi sono esagerate difficoltagrave e
23 Omero Odissea I cit 219 ss
Letteratura greca [1]
28
incongruenze alle quali un pubblico di ascoltatori (o anche un lettore moderatamente attento) probabilmente non farebbe casoraquo 2 Il progetto di una pubblica denuncia dei proci dinanzi agli degravei e agli uomini ai vv 273-274 egrave ciograve che Atena sembra prefiggersi nel promuovere lrsquoassemblea degli Itacesi (assemblea che effettivamente avragrave luogo a principio del canto II) drsquoaltra parte le successive istruzioni di AtenaMente ai vv 295 s (medita come uccidere i pretendenti) presuppongono che di quella richiesta da formulare nel corso dellrsquoassembla essi non terranno alcun conto Anche a questa osservazione si puograve rispondere che laquoegrave ragionevole attendersi che Telemaco condivida la previsione di un esito negativo della sua iniziativaraquo e si puograve aggiungere che pure in caso di insuccesso il ricorso allrsquoassemblea potrebbe ottenere almeno il risultato di screditare i pretendenti presso la comunitagrave itacese legittimando un successivo ricorso alla violenza (e si tratta di una legittimazione di cui anche lrsquoultimo canto mostreragrave lrsquoesigenza) 3 Dopo che Telemaco aveva detto che la madre non intendeva risposarsi (vv 249-250) AtenaMente si esprime ai vv 275-278 come se Penelope desiderasse proprio nuove nozze e inoltre sarebbe assurdo che il padre di Penelope cominciasse a contrattare un secondo matrimonio prima del ritorno di Telemaco dal suo viaggio e che mettesse mano a preparativi che rischierebbero di essere annullati qualche tempo dopo con inevitabile imbarazzo se Telemaco venisse a sapere che Odisseo egrave ancora vivo In piugrave lrsquoandamento sintattico di questi versi presenta un anacoluto durissimo per cui a principio del v 275 lrsquoaccusativo μητέρα egrave seguito da un ἂψ ἴτω (laquovada indietroraquo laquotorniraquo) che richiederebbe come soggetto un nominativo μήτηρ Come hanno reagito i lettori di Omero Nellrsquoantichitagrave un grammatico rimasto anonimo cambiava come attesta uno scolio μητέρ᾽ in μήτηρ nel secolo XVIII Richard Bentley modificava ἴτω in ἴμεν (infinito eolico di εἶμι laquovadoraquo) nel XIX un altro grande della filologia europea Gottfried Hermann risolveva piugrave drasticamente la questione eliminando il complesso dei vv 275-278 e la stessa West mostra simpatia per tale proposta supponendo laquounrsquoaggiunta posteriore modellata sul corrispondente passo del libro IIraquo (dove i vv 196 s sono identici ai vv 277 s e il v 195 copre lo stesso contenuto dei vv 275 s) Si tratta di procedimenti adeguati ai dati di fatto Migliorano davvero il testo che ci egrave stato tramandato In realtagrave ambedue le ldquocorrezionirdquo appena ricordate (di μήτερ᾽ e di ἴτω) ottengono un risultato tanto lineare che egrave davvero difficile pensare che lrsquoanacoluto avrebbe potuto invadere tutta la tradizione se non fosse stato originario e quanto allrsquoespunzione dei vv 275-278 essa indubbiamente peggiorerebbe il ritmo del discorso determinando lrsquoavvicinamento fra i due versi (v 271 e v 279) molto simili fra loro che aprono le due sequenze occupate dai consigli di Mente E allora La via piugrave saggia egrave senzrsquoaltro quella di tenerci qui come quasi sempre di fronte al testo omerico contraddizioni e anacoluti riconoscendo in essi lrsquoeffetto dellrsquoattivitagrave di un cantore che pur sulla base di una traccia largamente memorizzata restava pur sempre legato a quella prassi orale per cui composizione ed esecuzione tendevano a coincidere E lrsquoanacoluto si spiega bene se cerchiamo di immedesimarci nel procedimento seguito dal poeta Egli ha affidato ad Atena un certo flusso argomentativo per cui la dea deve dar consigli a Telemaco sui suoi rapporti coi proci e con la madre e cosigrave colloca in fine di v 274 un ἄνωχθι (laquoordinaraquo) destinato a reggere gli accusativi simmetricamente dislocati in principio di verso (vv 274 e 275) μνηστῆρας e μητέρα Senoncheacute giunto a questa seconda parte dellrsquoargomentazione egli si avvede quanto sarebbe illogico che Telemaco sollecitasse la madre a nuove nozze di qui lrsquoimprovviso cambio di costruzione che svincola al prezzo di una sensibile slogatura sintattica lrsquoipotesi delle nuove nozze dallrsquoordine impartito a Telemaco e la prospetta invece come un desiderio eventuale della stessa Penelope Il poeta ha un progetto ben meditato brani e sequenze piugrave volte sperimentati ed egrave col supporto di questi materiali giagrave elaborati che egli si fa strada attraverso le insidie della
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
15
egrave fermato dal grido di ammonimento del dio Incitati e aiutati da Ares ora i Troiani avanzano con impeto Intervengono Era e Atena e questrsquoultima assume il ruolo di auriga di Diomede Col suo aiuto questi ferisce al ventre Ares che fugge sullrsquoOlimpo Anche le dee vi fanno ritorno Canto VI Il canto VI egrave una naturale continuazione del V (tanto che Erodoto citeragrave come dallrsquoἀριστεία di Diomede un brano della prima parte del VI canto) La battaglia infuria nella pianura ma il furore di Diomede si stempera su una nota di cortesia quando lrsquoeroe dopo aver sfidato Glauco di Licia scopre di avere con lrsquoavversario antichi rapporti di ospitalitagrave I due si scambiano le armature (a detrimento di Glauco a cui laquoZeus Cronide levograve il senno cheacute scambiograve con Diomede Tidide armi drsquooro con armi di bronzo cento buoi con nove buoiraquo [vv 234-6]) Frattanto Ettore su invito dellrsquoindovino Eleno rientra in cittagrave dove le donne devono cercare di ottenere con offerte e voti il favore di Atena e incontra dapprima la madre Ecuba poi Paride (che intende ricondurre alla battaglia) vorrebbe salutare anche la moglie ma non la trova in casa bensigrave alle porte Scee dove Andromaca era accorsa piena drsquoangoscia insieme col figlioletto e con la nutrice Nel colloquio che segue ella lo implora di non esporre al pericolo se stessa e il figlio La replica di Ettore egrave esemplare per capire la prospettiva del poema e le motivazioni dellrsquoagire dei personaggi dominanti se Achille e gli eroi achei in genere cercano onore e gloria a questa motivazione (che pure non egrave assente) Ettore antepone lrsquoαἰδώς il senso di laquovergognaraquo e di responsabilitagrave nei confronti della comunitagrave e del nucleo familiare di cui egrave il difensore Poi si volta per prendere tra le braccia Astianatte ma lrsquoelmo lucente e il cimiero ondeggiante impauriscono il piccolo che si rifugia in seno alla nutrice Alla fine del canto Paride si incontra con Ettore e i due si avviano verso il campo di battaglia [T5] Canto VII A principio del canto VII Atena e Apollo si accordano per indurre Ettore a lanciare una sfida agli Achei per un duello Il sorteggio designa Aiace come campione greco Nello scontro Ettore lancia per primo lrsquoasta che penetra ma senza trapassarlo nello scudo di Aiace greve e massiccio (compaginato con sette strati di pelle bovina simile a una torre) Aiace di rimando lacera lo scudo e il pettorale della corazza ma non riesce a squarciare le carni del nemico percheacute Ettore si piega di lato Allora i due brandiscono di nuovo le aste poi ricorrono alle pietre Alla fine gli araldi arrestano il combattimento con la giustificazione che laquola notte giagrave viene ed egrave bene obbedire alla notteraquo (v 282) Su proposta di Nestore gli Achei decidono per il giorno seguente di seppellire i morti e di scavare una grande trincea difesa da un bastione sul margine del loro accampamento Respingono lrsquoofferta di pace dei Troiani (che prevederebbe la riconsegna dei tesori sottratti da Paride a Sparta) Il mattino seguente i morti vengono cremati e durante la giornata si erige il muro di protezione Canto VIII Nellrsquoassemblea degli degravei Zeus vieta ai numi di appoggiare lrsquouna o lrsquoaltra parte in conflitto Al mattino il combattimento riprende e a mezzogiorno Zeus pone i destini dei due popoli sulla bilancia che piega a favore dei Troiani Sul campo di battaglia Diomede salva Nestore Lrsquoazione di Ettore egrave travolgente fincheacute Zeus contravvenendo alla sua intenzione di favorire i Troiani accoglie la preghiera di Agamennone per risollevare il morale degli Achei che organizzano la difesa delle navi Nel corso degli scontri si segnala lrsquoarciere Teucro che colpisce i nemici muovendosi in sincronia con Aiace Telamonio che lo protegge con lo scudo Incitato da Agamennone egli prova a colpire anche Ettore ma soccombe colpito con una pietra A questa vista Era e Atena corrono ad armarsi per intervenire a favore degli Achei ma vengono distolte dalle minacce di Zeus che manifesta la propria intenzione di favorire i Troiani fino a quando i Greci non saranno ridotti alla disperazione tanto da scongiurare Achille percheacute ritorni Il sopraggiungere della notte
Letteratura greca [1]
16
interrompe i combattimenti Ettore galvanizzato dai successi ottenuti in quel giorno si illude che la vittoria sia a portata di mano e prospetta ai suoi una prossima ritirata degli Achei Il canto si chiude con il banchetto dei Troiani che banchettano nella pianura esaltati dalla speranza di vittoria Canto IX Agamennone affranto propone di fare ciograve che nel canto II aveva suggerito soltanto per mettere alla prova lrsquoesercito interrompere la guerra e tornare in patria Diomede si oppone e Nestore in un consiglio dei capi propone di tentare la riconciliazione con Achille Si invia alla tenda di Achille unrsquoambasceria (composta da Aiace Odisseo e Fenice antico pedagogo di Achille) per offrire doni ricchissimi Achille non cede anzi minaccia di salpare immediatamente verso la patria [T6] Inutilmente Fenice lrsquoantico precettore di Achille cerca di ammorbidire la determinazione del Pelide richiamando la vicenda dellrsquoeroe Meleagro [T7] Gli inviati riferiscono ad Agamennone la risposta di Achille egli torneragrave a combattere solo quando Ettore saragrave arrivato fino alle navi dei Mirmidoni Canto X Nella stessa notte si effettua una missione segreta nel corso della quale Odisseo e Diomede dapprima catturano la spia troiana Dolone (che Ettore aveva inviato alle navi achee promettendogli come ricompensa i cavalli di Achille) poi uccidono il re trace Reso appena arrivato presso i Troiani e ne rubano i magnifici cavalli Giagrave gli antichi ritenevano questo canto unrsquoaggiunta post-omerica e questi dubbi trovano riscontro in lati eccentrici della narrazione e nellrsquoimpiego di un linguaggio che spesso appare svincolato dal corrente repertorio formulare Canto XI Si apre una nuova giornata di battaglia (la cui narrazione si protrarragrave fino al canto XVIII) che ruota intorno allrsquoἀριστεία di Agamennone Quando lrsquoAtride viene ferito gli Achei ripiegano Diomede resta anchrsquoegli ferito Odisseo e Aiace evitano a stento la massa dei nemici Nestore salva sul suo carro Macaone Achille che dalla poppa della nave osserva la battaglia vuol sapere chi egrave condotto via da Nestore e manda Patroclo che viene accolto molto benevolmente e con cui Nestore intrattiene un lungo discorso egli dice di deplorare il comportamento di Achille e con atteggiamento consono alla sua condizione di anziano si dilunga nel raccontare le proprie gesta giovanili Egli esorta quindi Patroclo a far leva sulla sua amicizia per convincere Achille a riprendere il combattimento o - almeno - a concedere a Patroclo le sue armi per incutere timore nei Troiani Eccitato dalle parole del vecchio Patroclo si avvia verso la nave di Achille ma incontra Euripilo ferito che gli chiede aiuto ed egli impietositosi lo accompagna alla tenda e cura la ferita Canto XII Divisi in cinque contingenti i Troiani danno lrsquoassalto al muro eretto a difesa del campo acheo Sul campo di battaglia si manifesta un prodigio unrsquoaquila in cielo con un grosso serpente fra le zampe che riesce a ferire lrsquouccello e a sfuggire Polidamante che interpreta il segno come un presagio funesto consiglia di tornare indietro ma Ettore egrave di altro avviso Sarpedone e Glauco sferrano un attacco contro il muro e - pur rimanendo feriti - riescono ad aprire una breccia La battaglia infuria con esito incerto fincheacute Ettore con un macigno sfonda una delle porte consentendo ai Troiani di entrare in massa nel campo acheo mentre i Greci fuggono verso il mare Canto XIII Zeus distoglie lo sguardo dalla battaglia nella convinzione che nessuno fra gli dei avrebbe osato violare il divieto di intervenire ne approfitta invece Poseidone favorevole ai Greci Assunto lrsquoaspetto dellrsquoindovino Calcante il dio infonde nuovo vigore nei due Aiaci
Letteratura greca [1]
17
spronandoli al combattimento Gli Achei riconoscono lrsquointervento divino e riprendono fiducia I combattimenti si susseguono violentissimi Nella resistenza si distingue il re cretese Idomeneo Polidamante consiglia una seconda volta di interrompere la battaglia e accenna allrsquoimminente intervento di Achille Ettore non ascolta lrsquoammonimento e riprende lrsquoassalto Il canto si chiude con un suo scambio di insulti con Aiace Telamonio Canto XIV Mentre Diomede Odisseo e Agamennone tornano feriti allrsquoaccampamento Era per distogliere Zeus dalla battaglia e consentire a Poseidone di favorire gli Achei indossa la cintura magica di Afrodite e sollecita il consorte a un convegno amoroso sullrsquoIda dopo lrsquoamplesso Zeus cade in un sonno profondo e Hypnos (il Sonno) annuncia a Posidone che potragrave aiutare senza rischi gli Achei Ettore colpito con una pietra da Aiace resta a lungo in stato di incoscienza e i Troiani vengono respinti Canto XV Zeus si risveglia avvedendosi dellrsquoinganno subito e costringe Era a mandargli Iride e Apollo la prima allontaneragrave Posidone dal campo di battaglia Apollo inciteragrave Ettore a far retrocedere gli Achei fino alle navi dei Mirmidoni Riprende lrsquooffensiva troiana Apollo stesso abbatte il muro e scuotendo lrsquoegida atterrisce gli Achei Patroclo corre da Achille mentre i Troiani giagrave sono sul punto di appiccare il fuoco alle navi Canto XVI Patroclo in lacrime supplica Achille di intervenire o di mandare lui stesso al suo posto [T8] Achille gli consegna le proprie armi e gli fa promettere che non si avventureragrave oltre la zona delle navi Ma Patroclo trascinato dal suo stesso impeto oltrepassa il limite prescrittogli da Achille Abbatte Sarpedone figlio di Zeus attorno al cui cadavere infuria la lotta fincheacute Apollo lo sottrae alla mischia e Hypnos e Thanatos (il demone della morte) lo trasportano in Licia sua patria Patroclo continua lrsquoassalto alla testa dei Mirmidoni fin sotto le mura di Troia ma poco prima del tramonto al quarto assalto Apollo stesso assunto lrsquoaspetto di Asio lo percuote fra le spalle allora Euforbo lo colpisce con lrsquoasta ed Ettore lo trafigge Canto XVII Euforbo viene ucciso da Menelao ma Ettore riesce a catturare le armi di Achille indossate da Patroclo Vigorosamente sostenuti da Aiace gli Achei difendono il cadavere Una densa nebbia scende sui combattenti Zeus infonde nuovo ardimento nei cavalli di Achille piangenti per la fine di Patroclo [T9] Atena e Apollo arroventano la lotta attorno alla salma In seguito alla preghiera di Aiace Zeus dissolve la nebbia Menelao manda Antiloco figlio di Nestore a informare Achille della morte di Patroclo la cui salma viene intanto trascinata fuori della battaglia da Menelao e Merione mentre i due Aiaci offrono la necessaria copertura contro la furia incalzante dei nemici Canto XVIII Lo scoppio di selvaggio dolore a cui si abbandona Achille allrsquoudire della morte di Patroclo provoca lrsquoaccorrere dal mare di Tetide insieme con le Nereidi La madre gli promette di procurargli nuove armi Poicheacute la salma di Patroclo egrave tuttora contesa Achille fa la sua apparizione sul fossato e lancia un grido che atterrisce i nemici Efesto su preghiera di Tetide foggia le nuove armi fra cui un magnifico scudo su cui appaiono effigiati in bande concentriche gli aspetti salienti dellrsquoesistenza umana Canto XIX Il mattino seguente Tetide porta le armi al figlio e con lrsquoambrosia preserva la salma di Patroclo dalla decomposizione Achille convoca unrsquoassemblea dellrsquoesercito e rinuncia alla sua collera Agamennone lamenta di essere stato ldquoaccecatordquo da Zeus e promette doni
Letteratura greca [1]
18
riparatori [T10] Achille si lascia convincere a stento ad attendere che i soldati abbiano mangiato Poi gli armati si radunano e anche Achille si arma Il suo cavallo Xanto gli predice la prossima morte [T11] Canto XX Zeus consente agli degravei di partecipare alla nuova battaglia Enea scontratosi con Achille egrave tratto in salvo da Posidone Achille infuria come un incendio in una selva Canto XXI Achille colma di cadaveri il fiume Scamandro e cattura dodici giovani troiani che intende offrire in sacrificio a Patroclo non risparmia neppure Licaone figlio di Priamo che lo supplica con accenti di grande intensitagrave ma altrettanto intensa nella consapevolezza di un destino imminente egrave la pur spietata replica del Pelide [T12] Lo Scamandro solleva le proprie onde ma le fiamme di Efesto inaridiscono il terreno e domano la corrente Gli degravei si azzuffano Atena raggiunge Ares con una pietra Era rintuzza la furia di Artemide Infine tutti tornano sullrsquoOlimpo Apollo assunto lrsquoaspetto di Agenore respinge Achille percheacute i Troiani possano rifugiarsi allrsquointerno delle mura Canto XXII Il solo Ettore resta fuori nella pianura Invano Priamo ed Ecuba lo pregano di rientrare Mentre Achille si avvicina Ettore decide di affrontarlo ma quando quello gli egrave da presso col bronzo che gli lampeggia intorno laquosimile al raggio del fuoco ardente o del sole che sorgeraquo egrave afferrato dal panico e comincia a fuggire compiendo tre giri intorno alle mura Zeus pesa sulla bilancia i destini (le κῆρες) dei due eroi e quello di Ettore affonda in basso Allora Apollo lo abbandona e Atena apparsa a Ettore sotto le spoglie di suo fratello Deifobo gli si avvicina promettendogli aiuto e invece riporta ad Achille la lancia che gli era caduta fuori bersaglio Il colpo di risposta di Ettore rimbalza sullo scudo di Achille Ettore urla a Deifobo di passargli la sua lancia ma il falso Deifobo egrave scomparso ed Ettore comprende di trovarsi sullrsquoorlo dellrsquoabisso [T13] Achille gli trapassa la gola ed Ettore lo supplica di non oltraggiare la sua salma in risposta riceve la minaccia che finiragrave in pasto ai cani Achille trascina il cadavere alle navi attaccato al carro Priamo Ecuba e Andromaca si abbandonano al cordoglio a cui fanno eco le donne troiane Canto XXIII Viene preparato il banchetto funebre in onore di Patroclo la cui ombra nel corso della notte appare ad Achille chiedendo la sepoltura del corpo Il mattino seguente si appresta il rogo fra le offerte votive ci sono anche dodici giovani troiani Il giorno successivo si raccolgono le ossa di Patroclo Seguono i ludi funebri gare coi carri e con lrsquoarco duello in armi etc Canto XXIV Ogni giorno Achille trascina il cadavere di Ettore attorno alla tomba dellrsquoamico ma lo spettacolo offende gli degravei e al dodicesimo giorno Zeus decide di mandare Tetide percheacute induca suo figlio a restituire la salma di Ettore Iride viene inviata presso Priamo percheacute gli consigli di recarsi nel cuore della notte con un carro da trasporto e un copioso riscatto scortato da Ermes alla tenda di Achille Questi accoglie il vecchio con rispetto riconoscendo in lui lrsquoimmagine del padre lontano e si piega alla sua supplica [T14] Per volontagrave degli degravei il cadavere non egrave stato aggredito dalla putrefazione composto sul pianale del carro viene ricondotto dal padre a Troia Qui le lamentazioni rituali srsquoinnalzano dal gruppo delle donne (Andromaca Ecuba Elena) Si stipula una tregua di dodici giorni Per nove giorni i Troiani raccolgono legname poi anche il rogo di Ettore arde e si erige un tumulo
Letteratura greca [1]
19
Struttura e caratteri dellʼopera Poema di trama relativamente organica (soprattutto a partire dal canto XVI tutti gli avvenimenti tranne pochi episodi isolati ruotano attorno ai due principali antagonisti Ettore uccide Patroclo per vendicare Sarpedone e Achille uccide Ettore per vendicare Patroclo) pur se non privo di piugrave o meno cospicue incongruenze spiegabili in primo luogo con la lunga e complessa genesi orale dellrsquoopera lrsquoIliade lascia emergere in mezzo alle centinaia di nomi e alle intricate vicende alcuni caratteri delineati nella loro individualitagrave e innanzi tutto quelli di Achille e di Ettore accomunati dalla medesima coscienza di un destino di morte che sono pronti ad affrontare Appunto una tale attitudine a rappresentare i laquocaratteriraquo (ἤθη) dei suoi personaggi egrave un altro titolo di merito che Aristotele ascrive ad Omero (Poetica 1460a9-11)
dopo aver brevemente proemiato subito introduce un uomo una donna o un altro personaggio nessuno privo di caratterizzazione ma dotato di un carattere
Fondamentale per la struttura del poema egrave la novitagrave della prospettiva Possiamo presumere che i cosiddetti poemi ciclici22 mirassero a conservare lrsquoangolatura che era stata propria delle versioni pre-omeriche della saga troiana sigrave che puograve riuscire significativo il confronto fra lrsquoesordio della Piccola Iliade (dove muovendo da grandi entitagrave ndash la cittagrave il paese due popoli la guerra ndash viene lanciato secondo lrsquoespressione di J Latacz come laquouno sguardo dallrsquoesternoraquo)
Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην εὔπωλον ἧς πέρι πολλὰ πάθον Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος Canto Ilio e la terra dei Dardani dai bei puledri per la quale molti dolori patirono i Danai servitori di Ares
con lo laquosguardo internoraquo che caratterizza lrsquoinizio dellrsquoIliade
Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν ἡρώων αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν οἰωνοῖσί τε δαῖτα Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς Canta o dea di Achille figlio di Peleo la collera maledetta che pene innumerevoli inflisse agli Achei e molte scagliograve allrsquoAde vite possenti di eroi e ne faceva prede per i cani e pasto per gli uccelli e si avverava il volere di Zeus da quando primamente si separarono venuti a contesa LrsquoAtride sovrano di eroi e Achille magnifico
Argomento non egrave dunque come doveva avvenire nella tradizione del canto epico un evento complesso da inquadrare con un grandangolo onnicomprensivo e neppure come saragrave nellrsquoOdissea un personaggio colto nella multiforme varietagrave delle sue peregrinazioni egrave invece una reazione emotiva (lrsquoira di Achille) con le sue conseguenze (le innumerevoli morti degli Achei) Narrare di questa ira significa per il poeta cominciare da un punto preciso (laquoda quandoraquo) ossia dal momento della contesa e della separazione fra i due massimi eroi greci Agamennone il primo per potere (laquosovrano di eroiraquo) e Achille il primo per nobiltagrave e forza (δῖος) E sintomatica della bipolaritagrave del mondo epico in quanto mondo di degravei e di eroi egrave la sincronia per cui il taglio della narrazione coincide col decorso del laquovolere di Zeusraquo (Διὸς βουλή) forse da identificare con la promessa del dio a Tetide (rievocata piugrave oltre in questo
22 V cap II laquoLa tradizione omericaraquo
Letteratura greca [1]
20
stesso canto ai vv 518-527) di vendicare lrsquoaffronto subito da Achille o piugrave in generale con il corso degli eventi in quanto tutto come per definizione laquogiace sulle ginocchia di Zeusraquo Opera indubbiamente allrsquointerno del poema unrsquoidea formativa un progetto di qui un insieme monumentale unificato anche da una serie di corrispondenze a distanza fra cui particolare significato acquistano quelle fra primo e ultimo canto Nel canto I il vecchio Crise va come supplice presso Agamennone portando doni e supplicando la restituzione della figlia e Agamennone lo respinge aspramente minacciandolo di far ricorso alla violenza se dovesse tornare nel canto XXIV il vecchio Priamo va come supplice presso Achille portando doni e supplicando la restituzione del corpo del figlio Achille ha una prima reazione irosa (esordisce al v 560 con laquoSmetti di irritarmi vecchioraquo) ma poi accoglie la supplica E al di lagrave delle corrispondenze nelle linee dellrsquoazione si colgono fra principio e fine del poema alcuni importanti echi verbali in particolare fra XXIV 501 s
τοῦ νῦν εἵνεχ᾽ ἱκάνω νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενος παρὰ σεῖο φέρω δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα per lui [Ettore] vengo ora alle navi degli Achei per riscattarlo da te e ti porto compenso infinito
e I 12 s
ὁ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενός τε θυγάτρα φέρων δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα costui [Crise] venne alle navi rapide degli Achei per riscattare la figlia portando compenso infinito
fra XXIV 555-557
λῦσον ἵν᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδωmiddot σὺ δὲ δέξαι ἄποινα πολλά τά τοι φέρομενmiddot σὺ δὲ τῶνδrsquo ἀπόναιο καὶ ἔλθοις σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν restituiscimelo percheacute lo possa vedere con gli occhi e accogli il riscatto copioso che portiamo e tu possa goderne e tornare alla tua terra patria
e I 18-20
Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν εὖ δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκέσθαιmiddot παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην τὰ δ᾽ ἄποινα δέχεσθαι Atridi e voi altri Achei dai forti schinieri a voi concedano gli degravei che hanno le case in Olimpo di distruggere la cittagrave di Priamo e tornare facilmente in patria ma restituitemi la figlia e accettate il riscatto
fra XXIV 560 μηκέτι νῦν μ᾽ ἐρέθιζε (laquosmetti di irritarmiraquo) e I 32 μή μ᾽ ἐρέθιζε (laquonon mi irritareraquo) fra XXIV 568-570
τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς μή σε γέρον οὐδrsquo αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω καὶ ἱκέτην περ ἐόντα Διὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμάς Ora perciograve fra i dolori non mi eccitare lrsquoanimo ancora di piugrave bada o vecchio che non ti lasci neppure nella tenda
Letteratura greca [1]
21
bencheacute supplice e violi gli ordini di Zeus e I 26-28
μή σε γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω ἢ νῦν δηθύνοντ᾽ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο Mai te o vecchio io colga presso le concave navi ora a indugiare o piugrave tardi a tornare che piugrave non dovesse giovarti lo scettro e la benda del dio
(e infine XXIV 571 ὣς ἔφατ ἔδεισεν δ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ laquocosigrave diceva e il vecchio tremograve e obbediva alle paroleraquo ripete esattamente I 33) In effetti lrsquoepisodio terminale del poema col superamento dellrsquoira ad opera della pietagrave e del senso di unrsquoesistenza invasa dal dolore si propone come il rovesciamento consapevole dellrsquoepisodio iniziale che era apparso caratterizzato dalla cancellazione della pietagrave e del diritto dei supplici in nome della forza Al rifiuto iniziale del donoriscatto si oppone lrsquoaccettazione finale in consonanza con un principio-guida che opera nel poema secondo linee che alla fine si riunificano Agamennone restituisce Criseide al padre ma si appropria del dono fatto dagli altri Achei ad Achille (Briseide) Achille respinge i doni fatti da Agamennone per indurlo a riconciliarsi con lui ma dopo aver contestato nel IX canto la nozione che la vita umana possa essere barattata con una massa di beni torna alla lotta non in cambio di qualche premio da conquistare ma per vendicare lrsquouccisione dellrsquoamico Patroclo e tanto nella lotta sul campo di battaglia quanto nellrsquoinfierire sul cadavere di Ettore si abbandona a un furore cosigrave smisurato e patologico che puograve essere superato solo con lrsquoaccettare i doni di Priamo non tuttavia per il loro valore drsquouso ma percheacute in Priamo Achille riconosce lrsquoombra del padre lontano Cosigrave lrsquoIliade appare attraversata da un impulso fondamentale che muove dallrsquoideologia del dono e dalla conseguente centralitagrave assegnata allrsquoonore (τιμή) come ldquoprezzordquo che qualifica il valore del guerriero ma supera questo piano di valutazione dei rapporti umani attraverso la loro riformulazione nei termini di un umanesimo esistenziale che ha come punti di riferimento lrsquoidentitagrave universale dei condizionamenti oggettivi (la vecchiaia la malattia la morte) e i legami che uniscono padre e figlio compagno e compagno vivi e morti (il cordoglio finale di Andromaca Ecuba ed Elena sulla salma di Ettore) Entro questo orizzonte progressivamente allargato la guerra le lotte lo scontro mortale finiscono col rappresentare solo un momento e un aspetto dellrsquoesistenza graditi tanto agli degravei che vi assistono come spettatori interessati quanto agli uditori che riascoltano le antiche gesta eppure non tali da appiattire il poema in una prospettiva guerresca conclusa in se stessa Molto del fascino delle battaglie e delle ἀριστεῖαι dellrsquoIliade sta nella presenza recondita di un occhio che sa guardare al di lagrave di esse (e al di lagrave della stessa distinzione fra Greci e Troiani vincitori e vinti) e che puograve anche attraverso le similitudini lasciare irrompere il mondo della natura o del lavoro umano nel mezzo delle battaglie LʼOdissea LrsquoOdissea (Ὀδύσσεια) consta di circa 12100 esametri divisi anchrsquoessi in 24 libri e indicati con le lettere minuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquoargomento egrave costituito dalle avventure di Odisseo dalla distruzione di Troia al ritorno alla patria Itaca esposte secondo un ordine che entrando subito nel vivo degli avvenimenti (lrsquoinizio del poema mostra Odisseo nellrsquoisola di Calipso) rievoca poi i fatti giagrave trascorsi e li ricongiunge infine a partire dal libro XV (con lrsquoarrivo di Telemaco alla capanna di Eumeo dove giagrave si trova Odisseo) in unrsquoazione unitaria La trama del poema i cui avvenimenti sono concentrati cronologicamente nello spazio di 40 giorni (ma sono narrati solo gli avvenimenti di 16 giorni e 8 notti) si articola in tre parti la laquoTelemachiaraquo (canti I-IV) il laquoRitorno di Odisseoraquo (canti V-XIII) e la laquoVendetta di Odisseoraquo (canti XIV-XXIV)
Letteratura greca [1]
22
Canto I Tutti gli eroi superstiti sono ormai tornati da Troia alle loro case tranne Odisseo che pur desideroso di tornare egrave trattenuto dalla ninfa Calipso nellrsquoisola di Ogigia Gli degravei hanno pietagrave di lui tranne Posidone irato per lrsquoaccecamento del figlio il ciclope Polifemo Ma un consiglio degli degravei assente Posidone (che si egrave recato presso gli Etiopi) delibera il ritorno dellrsquoeroe si decide che Ermes andragrave subito da Calipso mentre Atena si avvia verso Itaca sotto lrsquoaspetto del signore dei Tafi Mente per incoraggiare il figlio di Odisseo Telemaco a tener testa ai pretendenti della madre i laquoprociraquo (i quali aspirano al regno tramite le nozze con Penelope) e per indurlo a intraprendere un viaggio in cerca di notizie sul padre Canto IΙ Telemaco segue il consiglio della dea e il giorno seguente nellrsquoassemblea popolare chiede una nave per andare in cerca del padre ma la sua richiesta non viene discussa e Leocrito scioglie lrsquoassemblea Grazie ad Atena che ora ha assunto le sembianze di Mentore (antico amico di Odisseo) Telemaco riesce tuttavia a trovare una nave con cui salpa nel corso della notte allrsquoinsaputa sia della madre che dei proci Canto IΙΙ Telemaco e MentoreAtena arrivano a Pilo e sul lido trovano Nestore che sta offrendo un sacrificio a Posidone Il vecchio eroe accoglie ospitalmente Telemaco e gli comunica molte notizie sul ritorno di altri Achei ma nessuna su Odisseo Alla sera Atena scompare in forma di aquila e il mattino seguente Telemaco salpa insieme con Pisistrato (figlio di Nestore) alla volta di Sparta dove arriva la sera del giorno successivo Canto IV A Sparta Menelao sta festeggiando il doppio matrimonio del figlio e della figlia Il giorno seguente Telemaco chiede del padre Menelao gli racconta il proprio ritorno durante il quale aveva incontrato Proteo il vecchio nume marino che gli aveva riferito come Odisseo fosse trattenuto nellrsquoisola di Calipso Intanto a Itaca i proci preparano insidie meditando di uccidere Telemaco al suo ritorno Penelope ne viene a conoscenza ma Atena le appare in sogno per confortarla Canto V Dopo un secondo concilio degli degravei (in effetti un ldquodoppionerdquo di quello del I canto) Zeus manda finalmente Ermes presso Calipso con lrsquoordine di lasciar partire Odisseo La ninfa aiuta lrsquoeroe a costruirsi una zattera Al diciottesimo giorno di navigazione Odisseo egrave in vista dellrsquoisola dei Feaci Scheria quando Posidone di ritorno dal suo soggiorno presso gli Etiopi lo vede e suscita una tempesta che distrugge la zattera Ma la dea marina Ino Leucotea impietositasi gli porge il proprio velo sostenuto dal quale lrsquoeroe giunge a nuoto alla riva di Scheria dove si abbandona esausto addormentandosi Canto VI In seguito a un sogno inviatole da Atena Nausicaa la figlia del re dei Feaci Alcinoo si reca nei pressi della spiaggia a lavare le vesti insieme con le ancelle Odisseo risvegliatosi atterrisce le fanciulle che fuggono tutte allrsquoinfuori di Nausicaa Lrsquoeroe supplica la giovane di porgerle aiuto ed ella lo fa rivestire e lo accompagna fino al bosco di Atena poco prima della cittagrave esortandolo a presentarsi a suo padre Canto VII Protetto dalla nebbia di cui Atena lo ha avvolto Odisseo entra nel palazzo abbraccia le ginocchia della regina Arete e la caligine scompare poi viene accolto con onore da Alcinoo Arete chiede a Odisseo donde provenga e chi gli abbia donato gli abiti (a lei ben noti) che indossa Lrsquoeroe inizia a raccontare le disavventure che gli sono occorse dopo la
Letteratura greca [1]
23
partenza dallrsquoisola di Calipso Alcinoo gli promette di farlo ricondurre a Itaca il giorno seguente Canto VIII Ma lrsquoindomani Alcinoo fa apprestare un banchetto durante il quale lrsquoaedo Demodoco canta della contesa insorta un giorno fra Achille e Odisseo Lrsquoeroe si copre il volto per nascondere le lacrime allora Alcinoo interrompe il canto e organizza una serie di gare nel corso delle quali Odisseo primeggia Poi Demodoco al margine di unrsquoarea per la danza dove si esibiscono i ballerini feaci canta gli amori di Ares e Afrodite e la vendetta di Efesto (che incatena i due amanti) La sera al ritorno nel palazzo Demodoco racconta la storia del Cavallo di legno Odisseo scoppia nuovamente in lacrime e Alcinoo gli chiede di rivelare il suo nome Canto IX Odisseo dichiara il proprio nome e dagrave inizio al racconto della propria storia a partire dalla caduta di Troia distruzione di Ismaro e perdite subite ad opera dei Ciconi sbarco presso i Lotofagi (che si nutrono di un cibo misterioso che fa dimenticare il ritorno) dopo una terribile tempesta scatenatasi durante il tentativo di doppiare il capo Malea arrivo allrsquoisola antistante quella dei Ciclopi dove Odisseo si trasferisce con una sola nave esplorazione dellrsquoisola perdita di alcuni compagni allrsquointerno della caverna del gigante monocolo accecamento del mostro e fuga Canto X Odisseo giunge allrsquoisola di Eolo signore dei venti che lo accoglie benevolmente e gli consegna alla partenza tutti i venti chiusi in un otre ma poi lo respinge con durezza quando ritorna presso di lui percheacute i compagni (sospettando che nellrsquootre siano racchiuse cospicue ricchezze) hanno sciolto i venti e da essi si egrave sprigionato un uragano che li ha risospinti sullrsquoisola Ripreso il mare Odisseo egrave trasportato fino ai Lestrigoni antropofagi il cui attacco priva lrsquoeroe di tutte le altre navi tranne la propria Con questa fugge fino allrsquoisola (Eea) della maga Circe Dopo che Circe ha trasformato in porci un gruppo di compagni mandati innanzi ad esplorare lrsquoisola Odisseo ha la meglio sulla maga (a cui impone di restituire forma umana ai compagni) grazie allrsquoerba moly fornitagli da Ermes Resta un anno presso Circe che al momento della partenza gli consiglia di recarsi al paese dei morti per interrogare il vate Tiresia Canto XI Approdato alla terra dei Cimmeri (che vivono immersi in una nebbia perenne sulla riva dellrsquoOceano) e scavata una fossa Odisseo sacrifica ai morti e immola una vittima speciale a Tiresia Le anime accorrono dapprima Elpenore caduto per caso giugrave dal tetto della casa di Circe (Odisseo gli promette sepoltura) poi la madre Anticlea (che gli racconta di esser morta di dolore per la sua assenza) quindi Tiresia che gli vaticina le sue vicende future fino alla morte (questa lo coglieragrave dopo una lunga vita in un paese straniero che non conosce neacute il sale neacute il remo) Da un certo punto in poi il poeta dimentica il presupposto per cui Odisseo aveva scavato una fossa alla quale i morti accorrevano per bere il sangue delle vittime e bevendolo riacquistavano per breve tempo una piena consapevolezza immagina invece che Odisseo sia allrsquointerno dellrsquoAde In questa sezione rientrano la descrizione di Aiace sdegnato di Minosse di Orione dei grandi peccatori di Eracle Poi Odisseo fa ritorno a Eea e ricevuti i consigli di Circe si imbarca per il ritorno in patria Canto XII Scampato alle Sirene che invano lo attirano col canto (si egrave fatto legare allrsquoalbero della nave i compagni che remano hanno le orecchie turate con la cera) passa tra Cariddi e Scilla (che gli rapisce sei uomini) ed egrave costretto dai compagni ad approdare in contrasto con le prescrizioni di Circe allrsquoisola Trinachia dove pascolano le greggi del Sole I
Letteratura greca [1]
24
compagni spronati da Euriloco se ne cibano nonostante il divieto dellrsquoeroe Il Sole sdegnato ottiene da Zeus che la nave sia colpita dal fulmine Tutti i compagni periscono ma Odisseo che ripassa tra Scilla e Cariddi si salva miracolosamente da questrsquoultima aggrappandosi a un fico selvatico fincheacute il gorgo restituisce i rottami della nave infine arriva remando con le mani allrsquoisola di Ogigia Canto XIII Terminato il racconto lrsquoeroe riceve doni dai Feaci e la notte seguente egrave ricondotto a Itaca e deposto addormentato sulla spiaggia presso un antro sacro alle Ninfe Al risveglio per la nebbia non riconosce la sua terra fincheacute Atena in veste di giovane pastore lo rassicura e poi rivelatasi gli dagrave istruzioni su come far strage dei proci e lo trasforma in un vecchio mendico Canto XIV Odisseo si reca allo stazzo del suo porcaio Eumeo che pur non riconoscendolo lo accoglie ospitalmente rifocillandolo e offrendogli un mantello per ripararsi dal gelo notturno Canto XV A questo punto la laquoTelemachiaraquo si riannoda allrsquoazione principale Telemaco che si trova ancora a Sparta viene indotto da Atena a tornare a Itaca sulla via del ritorno a Pilo accoglie a bordo lrsquoindovino Teoclimeno e grazie allrsquoaiuto della dea sfugge alle insidie dei proci sbarca a Itaca e si reca anchrsquoegli presso Eumeo Canto XVI Questi va da Penelope ad annunciargli il ritorno del figlio Intanto Odisseo rimosso lrsquoincantesimo si svela nel suo vero aspetto a Telemaco e con lui progetta la vendetta sui proci (che intanto tramano una nuova insidia ai danni di Telemaco) Eumeo torna al suo stazzo Canto XVII Il mattino seguente Telemaco si reca in cittagrave seguito in un secondo tempo da Eumeo e Odisseo (che ha riassunto lrsquoaspetto di mendico) Davanti al palazzo Odisseo egrave riconosciuto dal cane Argo Entra e va mendicando tra i proci Antinoo lo colpisce alla spalla destra con uno sgabello Canto XVIII Odisseo si batte al pugilato col mendicante Iro Penelope scesa nella sala prospetta ai proci lrsquoeventualitagrave di un nuovo matrimonio Odisseo egrave insultato dalla schiava Melanto e schiva uno sgabello scagliato da Eurinomo Canto XIX Insieme con Telemaco lrsquoeroe allontana le armi dalla sala poi conversa con Penelope che gli racconta un sogno e gli espone il suo piano per sedare le contese tra i proci concedendosi sposa a colui che riusciragrave a tendere lrsquoarco di Odisseo la prova avverragrave il giorno seguente al novilunio Durante il colloquio la fida schiava Euriclea lava i piedi di Odisseo e riconosciutolo da unrsquoantica cicatrice sta per rivelarne lrsquoidentitagrave ma lrsquoeroe la costringe a tacere Canto XX Al mattino Euriclea e le ancelle fanno i preparativi per il banchetto Giungono Eumeo Melanzio e il mandriano Filezio Un presagio mandato da Zeus dissuade i proci dal progetto di uccidere Telemaco Durante il banchetto Teoclimeno predice la loro imminente rovina
Letteratura greca [1]
25
Canto XXI Penelope conduce lrsquoarco nella sala dopo che parecchi fra i proci e lo stesso Telemaco hanno tentato invano di tenderne la corda Odisseo chiede di partecipare alla prova tende lrsquoarco senza fatica e riesce a far passare la freccia attraverso gli anelli di dodici scuri predisposte da Telemaco Canto XXII Poi scaglia le frecce sui proci e si rivela nella sua identitagrave Nella lotta che segue Telemaco Eumeo e Filezio aiutano il padrone contro i proci (appoggiati dal capraio Melanzio) Tutti i proci restano uccisi le ancelle infedeli sono impiccate Melanzio viene mutilato e ucciso soltanto lrsquoaedo Femio e lrsquoaraldo Medonte sono risparmiati Canto XXIII Nuovo colloquio fra Odisseo e Penelope che durante lrsquoeccidio dormiva ed egrave stata svegliata da Euriclea Penelope esita ancora a riconoscere il marito e non si arrende alla veritagrave fincheacute Odisseo non le descrive la posizione e la struttura del letto coniugale Canto XXIV Ermes conduce allrsquoAde le ombre dei proci Odisseo fa visita al padre Laerte nella masseria dove quello vive nello squallore e nellrsquoemarginazione e si fa riconoscere Intanto il padre di Antinoo incita gli Itacesi alla rivolta e il poema si conclude con lo scontro di Odisseo e dei suoi contro i concittadini lrsquoeroe ha la meglio e Zeus scagliato il fulmine pone fine alla battaglia Atena sotto lrsquoaspetto di Mentore stabilisce fra i contendenti un patto per il futuro36
Struttura e caratteri dellʼopera Giagrave la prima parola del proemio (ἄνδρα) non menziona come tema dellrsquoopera un determinato episodio della vita del protagonista ma il protagonista stesso (I 1-10)
Ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα πολύτροπον ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεmiddot πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περmiddot αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο νήπιοι οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιονmiddot αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ τῶν ἁμόθεν γε θεά θύγατερ Διός εἰπὲ καὶ ἡμῖν Dellrsquouomo multiforme a me racconta o Musa che molto errograve dopo che di Troia la sacra rocca distrusse di molti uomini vide le cittagrave riconobbe il pensiero e molti per il mare patigrave dolori nellrsquoanimo per salvare la sua vita e il ritorno dei compagni Eppure non li salvograve i compagni per quanto bramasse per la loro stessa follia si persero gli stolti i buoi del Sole Iperione mangiarono e quello rapigrave ad essi il digrave del ritorno Di questo da un punto qualsiasi narra anche a noi o dea figlia di Zeus
Storie favolose di naviganti racconti imperniati sul ritorno dei guerrieri achei che avevano combattuto a Troia e il particolare rientro in patria di Odisseo figlio di Laerte erano forse giagrave stati connessi e intrecciati nella precedente tradizione epica sigrave che il presente cantore poteva
Letteratura greca [1]
26
metter mano alla vicenda partendo (v 10) laquoda un punto qualsiasiraquo (ἁμόθεν) una notazione che certo presuppone la convenzione propria dellrsquoesordio tradizionale di un canto epico comparabile con i giagrave ricordati ἐξ οὗ (laquoda quandoraquo) di Iliade I 4 ed ἔνθεν (laquoda doveraquo) di Odissea VIII 500 Senoncheacute rispetto a queste indicazioni di tipo puntuale il tratto costituito dalla dimensione casuale quasi arbitraria inerente ad ἁμόθεν proprio mentre dichiara lrsquoassenza di un determinato piano compositivo implica in realtagrave che il racconto non si svolgeragrave per filo e per segno secondo lrsquoordine noto a poeta e uditori non si snoderagrave κατὰ κόσμον (laquoper ordineraquo) come il canto di Demodoco (VIII 489) ma seguiragrave un andamento originale Il ldquopunto qualsiasirdquo incipitario non rappresenta una scelta della Musa (figura dellrsquoarchivio tematico che conserva le laquovieraquo dellrsquoepica) bensigrave di questo cantore che ha deciso di far incominciare la narrazione in medias res e ha in serbo la sorpresa di far succedere al concilio degli degravei (che decide lrsquoinvio di Ermes presso Calipso) non lrsquoazione testeacute programmata (azione che viene differita con un ritardo che a piugrave riprese ha scandalizzato i lettori a principio del V canto) ma la partenza di Atena alla volta di Itaca e lrsquoavvio della laquoTelemachiaraquo Le due diverse vicende proposte a principio del poema quella di Telemaco e quella di Odisseo procedono infatti in parallelo coprendo un analogo lasso di tempo Piugrave oltre la decisione di trasformare la sequenza narrativa che va dalla partenza di Odisseo da Troia fino al suo arrivo nella terra dei Feaci in una rievocazione fatta dallrsquoeroe in prima persona al cospetto di Alcinoo e dei Feaci (la sezione detta degli ἀπόλογοι laquoraccontiraquo) crea una struttura ad anello che parte dal presente e ad esso fa ritorno dopo aver ricostruito le premesse della condizione attuale del protagonista Col canto XIII Odisseo egrave riportato dai Feaci a Itaca e questo permette la saldatura fra le vicende sue e quelle di Telemaco sia pure col differimento dellrsquoincontro e del riconoscimento fra padre e figlio fino al canto XVI Far scorrere in parallelo sequenze distinte organizzare programmi narrativi a corta e a lunga gittata tendere o allentare ad arte il ritmo della narrazione non si tratta davvero di procedimenti che potessero configurarsi come tradizionali dellrsquoarte epica quanto piuttosto di un momento sperimentale di una ricerca di soluzioni nuove al termine di una lunga e ormai consolidata sedimentazione di percorsi compiuti allrsquointerno di un determinato repertorio tematico unrsquoaudacia inventiva una πολυτροπίη degne del protagonista del poema che inevitabilmente comportavano rischi molteplici di incoerenze dissonanze occasionali avarie della macchina epica e che tuttavia erano destinate a conseguire un risultato assolutamente convincente allrsquoorecchio di chi si abbandonasse al fascino del racconto senza lrsquourgenza propria di altre etagrave e di altre mentalitagrave di puntare il dito sui singoli dettagli o le singole sfasature
PER SAPERNE DI PIUrsquo Difficoltagrave e incongruenze della narrazione omerica Forti della possibilitagrave di un controllo su un testo scritto che possiamo percorrere in avanti e a ritroso secondo ritmi di nostra scelta a noi non riesce difficile cogliere alcune delle difficoltagrave organizzative incontrate nella composizione del poema In proposito per ricordare un caso che saragrave allrsquoorigine delle discussioni di orientamento ldquoanaliticordquo intorno allrsquoOdissea possiamo leggere il discorso che Atena prese le sembianze di Mente re dei Tafi rivolge a Telemaco nel I canto (vv 253-305) Ah infelice ti manca molto davvero lrsquoassente Odisseo che getti le mani addosso ai pretendenti sfrontati Percheacute se ora tornato stesse sulla soglia 255 con una scure lo scudo e due lance cosigrave come io per la prima volta lo vidi in casa nostra che beveva e godeva di ritorno da Efira da Ilo di Mermero (andograve anche ligrave Odisseo con la nave veloce 260 in cerca del veleno omicida per averne da ungere le frecce di bronzo ma quello non glielo diede percheacute temeva gli dei che vivono eterni
Letteratura greca [1]
27
glielo diede invece mio padre percheacute lrsquoamava moltissimo) se stesse Odisseo tra i pretendenti cosigrave 265 essi avrebbero tutti rapida morte e nozze amare Ma sulle ginocchia degli dei questo giace se una volta tornato faragrave o no vendetta nella sua casa te invece io esorto a riflettere come cacciare i pretendenti da casa 270 Ebbene ora ascolta e alle mie parole darsquo retta Domattina chiamati gli eroi Achei a consiglio rivolgi a tutti un discorso e siano testimoni gli dei Ai pretendenti comanda drsquoandarsene per i fatti loro e tua madre se lrsquoanimo la spinge alle nozze 275 ritorni a casa del padre molto potente Prepareranno essi le nozze e disporranno i doni nuziali moltissimi quanti gli pare che debbano andare alla figlia A te darograve un saggio consiglio se vuoi ascoltarlo armata una nave con venti remi la migliore che crsquoegrave 280 Varsquo a domandare del padre partito da tempo se mai te ne parli un mortale o sentissi da Zeus la voce che divulga la fama tra gli uomini Anzitutto varsquo a Pilo e interroga il chiaro Nestore di ligrave poi varsquo a Sparta dal biondo Menelao 285 degli Achei vestiti di bronzo egli egrave tornato per ultimo Se senti dire qualcosa sulla vita e il ritorno del padre per quanto stremato potresti sopportare un altro anno se invece senti dire che egrave morto e non vive allora tornato nella cara terra patria 290 ergigli un tumulo e offrigli funebri offerte moltissime quanto conviene e darsquo tua madre a un marito E poi dopo aver compiuto e fatto ogni cosa allora medita nella mente e nellrsquoanimo come tu possa uccidere nelle tue case 295 i pretendenti con lrsquoinganno affrontandoli non devi piugrave avere i modi di un bimbo percheacute ormai non sei tale Non senti lrsquoillustre Oreste quale gloria ha acquistato fra tutti gli uomini percheacute uccise lrsquoassassino del padre Egisto esperto di inganni che gli uccise il nobile padre 300 Anche tu caro infatti molto bello e grande ti vedo sii valoroso percheacute ti lodi anche qualcuno dei posteri Ma io tornerograve adesso alla nave veloce dai compagni che forse impazienti mi aspettano Tu devi pensarci da te dammi retta 305
[Tr di GA Privitera] Le stranezze non mancano davvero e cosigrave sono state messe a fuoco da Stephanie West nel suo commento23 1 Atena sa evidentemente molto piugrave di quanto uno come Mente avrebbe potuto sapere in particolare ella sa che i proci ignoreranno lrsquoinvito di Telemaco a lasciare la sua casa e fatto piugrave importante che gli degravei tra breve ricondurranno in patria Odisseo A queste osservazioni si puograve replicare con la stessa West che laquosi sono esagerate difficoltagrave e
23 Omero Odissea I cit 219 ss
Letteratura greca [1]
28
incongruenze alle quali un pubblico di ascoltatori (o anche un lettore moderatamente attento) probabilmente non farebbe casoraquo 2 Il progetto di una pubblica denuncia dei proci dinanzi agli degravei e agli uomini ai vv 273-274 egrave ciograve che Atena sembra prefiggersi nel promuovere lrsquoassemblea degli Itacesi (assemblea che effettivamente avragrave luogo a principio del canto II) drsquoaltra parte le successive istruzioni di AtenaMente ai vv 295 s (medita come uccidere i pretendenti) presuppongono che di quella richiesta da formulare nel corso dellrsquoassembla essi non terranno alcun conto Anche a questa osservazione si puograve rispondere che laquoegrave ragionevole attendersi che Telemaco condivida la previsione di un esito negativo della sua iniziativaraquo e si puograve aggiungere che pure in caso di insuccesso il ricorso allrsquoassemblea potrebbe ottenere almeno il risultato di screditare i pretendenti presso la comunitagrave itacese legittimando un successivo ricorso alla violenza (e si tratta di una legittimazione di cui anche lrsquoultimo canto mostreragrave lrsquoesigenza) 3 Dopo che Telemaco aveva detto che la madre non intendeva risposarsi (vv 249-250) AtenaMente si esprime ai vv 275-278 come se Penelope desiderasse proprio nuove nozze e inoltre sarebbe assurdo che il padre di Penelope cominciasse a contrattare un secondo matrimonio prima del ritorno di Telemaco dal suo viaggio e che mettesse mano a preparativi che rischierebbero di essere annullati qualche tempo dopo con inevitabile imbarazzo se Telemaco venisse a sapere che Odisseo egrave ancora vivo In piugrave lrsquoandamento sintattico di questi versi presenta un anacoluto durissimo per cui a principio del v 275 lrsquoaccusativo μητέρα egrave seguito da un ἂψ ἴτω (laquovada indietroraquo laquotorniraquo) che richiederebbe come soggetto un nominativo μήτηρ Come hanno reagito i lettori di Omero Nellrsquoantichitagrave un grammatico rimasto anonimo cambiava come attesta uno scolio μητέρ᾽ in μήτηρ nel secolo XVIII Richard Bentley modificava ἴτω in ἴμεν (infinito eolico di εἶμι laquovadoraquo) nel XIX un altro grande della filologia europea Gottfried Hermann risolveva piugrave drasticamente la questione eliminando il complesso dei vv 275-278 e la stessa West mostra simpatia per tale proposta supponendo laquounrsquoaggiunta posteriore modellata sul corrispondente passo del libro IIraquo (dove i vv 196 s sono identici ai vv 277 s e il v 195 copre lo stesso contenuto dei vv 275 s) Si tratta di procedimenti adeguati ai dati di fatto Migliorano davvero il testo che ci egrave stato tramandato In realtagrave ambedue le ldquocorrezionirdquo appena ricordate (di μήτερ᾽ e di ἴτω) ottengono un risultato tanto lineare che egrave davvero difficile pensare che lrsquoanacoluto avrebbe potuto invadere tutta la tradizione se non fosse stato originario e quanto allrsquoespunzione dei vv 275-278 essa indubbiamente peggiorerebbe il ritmo del discorso determinando lrsquoavvicinamento fra i due versi (v 271 e v 279) molto simili fra loro che aprono le due sequenze occupate dai consigli di Mente E allora La via piugrave saggia egrave senzrsquoaltro quella di tenerci qui come quasi sempre di fronte al testo omerico contraddizioni e anacoluti riconoscendo in essi lrsquoeffetto dellrsquoattivitagrave di un cantore che pur sulla base di una traccia largamente memorizzata restava pur sempre legato a quella prassi orale per cui composizione ed esecuzione tendevano a coincidere E lrsquoanacoluto si spiega bene se cerchiamo di immedesimarci nel procedimento seguito dal poeta Egli ha affidato ad Atena un certo flusso argomentativo per cui la dea deve dar consigli a Telemaco sui suoi rapporti coi proci e con la madre e cosigrave colloca in fine di v 274 un ἄνωχθι (laquoordinaraquo) destinato a reggere gli accusativi simmetricamente dislocati in principio di verso (vv 274 e 275) μνηστῆρας e μητέρα Senoncheacute giunto a questa seconda parte dellrsquoargomentazione egli si avvede quanto sarebbe illogico che Telemaco sollecitasse la madre a nuove nozze di qui lrsquoimprovviso cambio di costruzione che svincola al prezzo di una sensibile slogatura sintattica lrsquoipotesi delle nuove nozze dallrsquoordine impartito a Telemaco e la prospetta invece come un desiderio eventuale della stessa Penelope Il poeta ha un progetto ben meditato brani e sequenze piugrave volte sperimentati ed egrave col supporto di questi materiali giagrave elaborati che egli si fa strada attraverso le insidie della
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
16
interrompe i combattimenti Ettore galvanizzato dai successi ottenuti in quel giorno si illude che la vittoria sia a portata di mano e prospetta ai suoi una prossima ritirata degli Achei Il canto si chiude con il banchetto dei Troiani che banchettano nella pianura esaltati dalla speranza di vittoria Canto IX Agamennone affranto propone di fare ciograve che nel canto II aveva suggerito soltanto per mettere alla prova lrsquoesercito interrompere la guerra e tornare in patria Diomede si oppone e Nestore in un consiglio dei capi propone di tentare la riconciliazione con Achille Si invia alla tenda di Achille unrsquoambasceria (composta da Aiace Odisseo e Fenice antico pedagogo di Achille) per offrire doni ricchissimi Achille non cede anzi minaccia di salpare immediatamente verso la patria [T6] Inutilmente Fenice lrsquoantico precettore di Achille cerca di ammorbidire la determinazione del Pelide richiamando la vicenda dellrsquoeroe Meleagro [T7] Gli inviati riferiscono ad Agamennone la risposta di Achille egli torneragrave a combattere solo quando Ettore saragrave arrivato fino alle navi dei Mirmidoni Canto X Nella stessa notte si effettua una missione segreta nel corso della quale Odisseo e Diomede dapprima catturano la spia troiana Dolone (che Ettore aveva inviato alle navi achee promettendogli come ricompensa i cavalli di Achille) poi uccidono il re trace Reso appena arrivato presso i Troiani e ne rubano i magnifici cavalli Giagrave gli antichi ritenevano questo canto unrsquoaggiunta post-omerica e questi dubbi trovano riscontro in lati eccentrici della narrazione e nellrsquoimpiego di un linguaggio che spesso appare svincolato dal corrente repertorio formulare Canto XI Si apre una nuova giornata di battaglia (la cui narrazione si protrarragrave fino al canto XVIII) che ruota intorno allrsquoἀριστεία di Agamennone Quando lrsquoAtride viene ferito gli Achei ripiegano Diomede resta anchrsquoegli ferito Odisseo e Aiace evitano a stento la massa dei nemici Nestore salva sul suo carro Macaone Achille che dalla poppa della nave osserva la battaglia vuol sapere chi egrave condotto via da Nestore e manda Patroclo che viene accolto molto benevolmente e con cui Nestore intrattiene un lungo discorso egli dice di deplorare il comportamento di Achille e con atteggiamento consono alla sua condizione di anziano si dilunga nel raccontare le proprie gesta giovanili Egli esorta quindi Patroclo a far leva sulla sua amicizia per convincere Achille a riprendere il combattimento o - almeno - a concedere a Patroclo le sue armi per incutere timore nei Troiani Eccitato dalle parole del vecchio Patroclo si avvia verso la nave di Achille ma incontra Euripilo ferito che gli chiede aiuto ed egli impietositosi lo accompagna alla tenda e cura la ferita Canto XII Divisi in cinque contingenti i Troiani danno lrsquoassalto al muro eretto a difesa del campo acheo Sul campo di battaglia si manifesta un prodigio unrsquoaquila in cielo con un grosso serpente fra le zampe che riesce a ferire lrsquouccello e a sfuggire Polidamante che interpreta il segno come un presagio funesto consiglia di tornare indietro ma Ettore egrave di altro avviso Sarpedone e Glauco sferrano un attacco contro il muro e - pur rimanendo feriti - riescono ad aprire una breccia La battaglia infuria con esito incerto fincheacute Ettore con un macigno sfonda una delle porte consentendo ai Troiani di entrare in massa nel campo acheo mentre i Greci fuggono verso il mare Canto XIII Zeus distoglie lo sguardo dalla battaglia nella convinzione che nessuno fra gli dei avrebbe osato violare il divieto di intervenire ne approfitta invece Poseidone favorevole ai Greci Assunto lrsquoaspetto dellrsquoindovino Calcante il dio infonde nuovo vigore nei due Aiaci
Letteratura greca [1]
17
spronandoli al combattimento Gli Achei riconoscono lrsquointervento divino e riprendono fiducia I combattimenti si susseguono violentissimi Nella resistenza si distingue il re cretese Idomeneo Polidamante consiglia una seconda volta di interrompere la battaglia e accenna allrsquoimminente intervento di Achille Ettore non ascolta lrsquoammonimento e riprende lrsquoassalto Il canto si chiude con un suo scambio di insulti con Aiace Telamonio Canto XIV Mentre Diomede Odisseo e Agamennone tornano feriti allrsquoaccampamento Era per distogliere Zeus dalla battaglia e consentire a Poseidone di favorire gli Achei indossa la cintura magica di Afrodite e sollecita il consorte a un convegno amoroso sullrsquoIda dopo lrsquoamplesso Zeus cade in un sonno profondo e Hypnos (il Sonno) annuncia a Posidone che potragrave aiutare senza rischi gli Achei Ettore colpito con una pietra da Aiace resta a lungo in stato di incoscienza e i Troiani vengono respinti Canto XV Zeus si risveglia avvedendosi dellrsquoinganno subito e costringe Era a mandargli Iride e Apollo la prima allontaneragrave Posidone dal campo di battaglia Apollo inciteragrave Ettore a far retrocedere gli Achei fino alle navi dei Mirmidoni Riprende lrsquooffensiva troiana Apollo stesso abbatte il muro e scuotendo lrsquoegida atterrisce gli Achei Patroclo corre da Achille mentre i Troiani giagrave sono sul punto di appiccare il fuoco alle navi Canto XVI Patroclo in lacrime supplica Achille di intervenire o di mandare lui stesso al suo posto [T8] Achille gli consegna le proprie armi e gli fa promettere che non si avventureragrave oltre la zona delle navi Ma Patroclo trascinato dal suo stesso impeto oltrepassa il limite prescrittogli da Achille Abbatte Sarpedone figlio di Zeus attorno al cui cadavere infuria la lotta fincheacute Apollo lo sottrae alla mischia e Hypnos e Thanatos (il demone della morte) lo trasportano in Licia sua patria Patroclo continua lrsquoassalto alla testa dei Mirmidoni fin sotto le mura di Troia ma poco prima del tramonto al quarto assalto Apollo stesso assunto lrsquoaspetto di Asio lo percuote fra le spalle allora Euforbo lo colpisce con lrsquoasta ed Ettore lo trafigge Canto XVII Euforbo viene ucciso da Menelao ma Ettore riesce a catturare le armi di Achille indossate da Patroclo Vigorosamente sostenuti da Aiace gli Achei difendono il cadavere Una densa nebbia scende sui combattenti Zeus infonde nuovo ardimento nei cavalli di Achille piangenti per la fine di Patroclo [T9] Atena e Apollo arroventano la lotta attorno alla salma In seguito alla preghiera di Aiace Zeus dissolve la nebbia Menelao manda Antiloco figlio di Nestore a informare Achille della morte di Patroclo la cui salma viene intanto trascinata fuori della battaglia da Menelao e Merione mentre i due Aiaci offrono la necessaria copertura contro la furia incalzante dei nemici Canto XVIII Lo scoppio di selvaggio dolore a cui si abbandona Achille allrsquoudire della morte di Patroclo provoca lrsquoaccorrere dal mare di Tetide insieme con le Nereidi La madre gli promette di procurargli nuove armi Poicheacute la salma di Patroclo egrave tuttora contesa Achille fa la sua apparizione sul fossato e lancia un grido che atterrisce i nemici Efesto su preghiera di Tetide foggia le nuove armi fra cui un magnifico scudo su cui appaiono effigiati in bande concentriche gli aspetti salienti dellrsquoesistenza umana Canto XIX Il mattino seguente Tetide porta le armi al figlio e con lrsquoambrosia preserva la salma di Patroclo dalla decomposizione Achille convoca unrsquoassemblea dellrsquoesercito e rinuncia alla sua collera Agamennone lamenta di essere stato ldquoaccecatordquo da Zeus e promette doni
Letteratura greca [1]
18
riparatori [T10] Achille si lascia convincere a stento ad attendere che i soldati abbiano mangiato Poi gli armati si radunano e anche Achille si arma Il suo cavallo Xanto gli predice la prossima morte [T11] Canto XX Zeus consente agli degravei di partecipare alla nuova battaglia Enea scontratosi con Achille egrave tratto in salvo da Posidone Achille infuria come un incendio in una selva Canto XXI Achille colma di cadaveri il fiume Scamandro e cattura dodici giovani troiani che intende offrire in sacrificio a Patroclo non risparmia neppure Licaone figlio di Priamo che lo supplica con accenti di grande intensitagrave ma altrettanto intensa nella consapevolezza di un destino imminente egrave la pur spietata replica del Pelide [T12] Lo Scamandro solleva le proprie onde ma le fiamme di Efesto inaridiscono il terreno e domano la corrente Gli degravei si azzuffano Atena raggiunge Ares con una pietra Era rintuzza la furia di Artemide Infine tutti tornano sullrsquoOlimpo Apollo assunto lrsquoaspetto di Agenore respinge Achille percheacute i Troiani possano rifugiarsi allrsquointerno delle mura Canto XXII Il solo Ettore resta fuori nella pianura Invano Priamo ed Ecuba lo pregano di rientrare Mentre Achille si avvicina Ettore decide di affrontarlo ma quando quello gli egrave da presso col bronzo che gli lampeggia intorno laquosimile al raggio del fuoco ardente o del sole che sorgeraquo egrave afferrato dal panico e comincia a fuggire compiendo tre giri intorno alle mura Zeus pesa sulla bilancia i destini (le κῆρες) dei due eroi e quello di Ettore affonda in basso Allora Apollo lo abbandona e Atena apparsa a Ettore sotto le spoglie di suo fratello Deifobo gli si avvicina promettendogli aiuto e invece riporta ad Achille la lancia che gli era caduta fuori bersaglio Il colpo di risposta di Ettore rimbalza sullo scudo di Achille Ettore urla a Deifobo di passargli la sua lancia ma il falso Deifobo egrave scomparso ed Ettore comprende di trovarsi sullrsquoorlo dellrsquoabisso [T13] Achille gli trapassa la gola ed Ettore lo supplica di non oltraggiare la sua salma in risposta riceve la minaccia che finiragrave in pasto ai cani Achille trascina il cadavere alle navi attaccato al carro Priamo Ecuba e Andromaca si abbandonano al cordoglio a cui fanno eco le donne troiane Canto XXIII Viene preparato il banchetto funebre in onore di Patroclo la cui ombra nel corso della notte appare ad Achille chiedendo la sepoltura del corpo Il mattino seguente si appresta il rogo fra le offerte votive ci sono anche dodici giovani troiani Il giorno successivo si raccolgono le ossa di Patroclo Seguono i ludi funebri gare coi carri e con lrsquoarco duello in armi etc Canto XXIV Ogni giorno Achille trascina il cadavere di Ettore attorno alla tomba dellrsquoamico ma lo spettacolo offende gli degravei e al dodicesimo giorno Zeus decide di mandare Tetide percheacute induca suo figlio a restituire la salma di Ettore Iride viene inviata presso Priamo percheacute gli consigli di recarsi nel cuore della notte con un carro da trasporto e un copioso riscatto scortato da Ermes alla tenda di Achille Questi accoglie il vecchio con rispetto riconoscendo in lui lrsquoimmagine del padre lontano e si piega alla sua supplica [T14] Per volontagrave degli degravei il cadavere non egrave stato aggredito dalla putrefazione composto sul pianale del carro viene ricondotto dal padre a Troia Qui le lamentazioni rituali srsquoinnalzano dal gruppo delle donne (Andromaca Ecuba Elena) Si stipula una tregua di dodici giorni Per nove giorni i Troiani raccolgono legname poi anche il rogo di Ettore arde e si erige un tumulo
Letteratura greca [1]
19
Struttura e caratteri dellʼopera Poema di trama relativamente organica (soprattutto a partire dal canto XVI tutti gli avvenimenti tranne pochi episodi isolati ruotano attorno ai due principali antagonisti Ettore uccide Patroclo per vendicare Sarpedone e Achille uccide Ettore per vendicare Patroclo) pur se non privo di piugrave o meno cospicue incongruenze spiegabili in primo luogo con la lunga e complessa genesi orale dellrsquoopera lrsquoIliade lascia emergere in mezzo alle centinaia di nomi e alle intricate vicende alcuni caratteri delineati nella loro individualitagrave e innanzi tutto quelli di Achille e di Ettore accomunati dalla medesima coscienza di un destino di morte che sono pronti ad affrontare Appunto una tale attitudine a rappresentare i laquocaratteriraquo (ἤθη) dei suoi personaggi egrave un altro titolo di merito che Aristotele ascrive ad Omero (Poetica 1460a9-11)
dopo aver brevemente proemiato subito introduce un uomo una donna o un altro personaggio nessuno privo di caratterizzazione ma dotato di un carattere
Fondamentale per la struttura del poema egrave la novitagrave della prospettiva Possiamo presumere che i cosiddetti poemi ciclici22 mirassero a conservare lrsquoangolatura che era stata propria delle versioni pre-omeriche della saga troiana sigrave che puograve riuscire significativo il confronto fra lrsquoesordio della Piccola Iliade (dove muovendo da grandi entitagrave ndash la cittagrave il paese due popoli la guerra ndash viene lanciato secondo lrsquoespressione di J Latacz come laquouno sguardo dallrsquoesternoraquo)
Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην εὔπωλον ἧς πέρι πολλὰ πάθον Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος Canto Ilio e la terra dei Dardani dai bei puledri per la quale molti dolori patirono i Danai servitori di Ares
con lo laquosguardo internoraquo che caratterizza lrsquoinizio dellrsquoIliade
Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν ἡρώων αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν οἰωνοῖσί τε δαῖτα Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς Canta o dea di Achille figlio di Peleo la collera maledetta che pene innumerevoli inflisse agli Achei e molte scagliograve allrsquoAde vite possenti di eroi e ne faceva prede per i cani e pasto per gli uccelli e si avverava il volere di Zeus da quando primamente si separarono venuti a contesa LrsquoAtride sovrano di eroi e Achille magnifico
Argomento non egrave dunque come doveva avvenire nella tradizione del canto epico un evento complesso da inquadrare con un grandangolo onnicomprensivo e neppure come saragrave nellrsquoOdissea un personaggio colto nella multiforme varietagrave delle sue peregrinazioni egrave invece una reazione emotiva (lrsquoira di Achille) con le sue conseguenze (le innumerevoli morti degli Achei) Narrare di questa ira significa per il poeta cominciare da un punto preciso (laquoda quandoraquo) ossia dal momento della contesa e della separazione fra i due massimi eroi greci Agamennone il primo per potere (laquosovrano di eroiraquo) e Achille il primo per nobiltagrave e forza (δῖος) E sintomatica della bipolaritagrave del mondo epico in quanto mondo di degravei e di eroi egrave la sincronia per cui il taglio della narrazione coincide col decorso del laquovolere di Zeusraquo (Διὸς βουλή) forse da identificare con la promessa del dio a Tetide (rievocata piugrave oltre in questo
22 V cap II laquoLa tradizione omericaraquo
Letteratura greca [1]
20
stesso canto ai vv 518-527) di vendicare lrsquoaffronto subito da Achille o piugrave in generale con il corso degli eventi in quanto tutto come per definizione laquogiace sulle ginocchia di Zeusraquo Opera indubbiamente allrsquointerno del poema unrsquoidea formativa un progetto di qui un insieme monumentale unificato anche da una serie di corrispondenze a distanza fra cui particolare significato acquistano quelle fra primo e ultimo canto Nel canto I il vecchio Crise va come supplice presso Agamennone portando doni e supplicando la restituzione della figlia e Agamennone lo respinge aspramente minacciandolo di far ricorso alla violenza se dovesse tornare nel canto XXIV il vecchio Priamo va come supplice presso Achille portando doni e supplicando la restituzione del corpo del figlio Achille ha una prima reazione irosa (esordisce al v 560 con laquoSmetti di irritarmi vecchioraquo) ma poi accoglie la supplica E al di lagrave delle corrispondenze nelle linee dellrsquoazione si colgono fra principio e fine del poema alcuni importanti echi verbali in particolare fra XXIV 501 s
τοῦ νῦν εἵνεχ᾽ ἱκάνω νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενος παρὰ σεῖο φέρω δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα per lui [Ettore] vengo ora alle navi degli Achei per riscattarlo da te e ti porto compenso infinito
e I 12 s
ὁ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενός τε θυγάτρα φέρων δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα costui [Crise] venne alle navi rapide degli Achei per riscattare la figlia portando compenso infinito
fra XXIV 555-557
λῦσον ἵν᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδωmiddot σὺ δὲ δέξαι ἄποινα πολλά τά τοι φέρομενmiddot σὺ δὲ τῶνδrsquo ἀπόναιο καὶ ἔλθοις σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν restituiscimelo percheacute lo possa vedere con gli occhi e accogli il riscatto copioso che portiamo e tu possa goderne e tornare alla tua terra patria
e I 18-20
Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν εὖ δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκέσθαιmiddot παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην τὰ δ᾽ ἄποινα δέχεσθαι Atridi e voi altri Achei dai forti schinieri a voi concedano gli degravei che hanno le case in Olimpo di distruggere la cittagrave di Priamo e tornare facilmente in patria ma restituitemi la figlia e accettate il riscatto
fra XXIV 560 μηκέτι νῦν μ᾽ ἐρέθιζε (laquosmetti di irritarmiraquo) e I 32 μή μ᾽ ἐρέθιζε (laquonon mi irritareraquo) fra XXIV 568-570
τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς μή σε γέρον οὐδrsquo αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω καὶ ἱκέτην περ ἐόντα Διὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμάς Ora perciograve fra i dolori non mi eccitare lrsquoanimo ancora di piugrave bada o vecchio che non ti lasci neppure nella tenda
Letteratura greca [1]
21
bencheacute supplice e violi gli ordini di Zeus e I 26-28
μή σε γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω ἢ νῦν δηθύνοντ᾽ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο Mai te o vecchio io colga presso le concave navi ora a indugiare o piugrave tardi a tornare che piugrave non dovesse giovarti lo scettro e la benda del dio
(e infine XXIV 571 ὣς ἔφατ ἔδεισεν δ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ laquocosigrave diceva e il vecchio tremograve e obbediva alle paroleraquo ripete esattamente I 33) In effetti lrsquoepisodio terminale del poema col superamento dellrsquoira ad opera della pietagrave e del senso di unrsquoesistenza invasa dal dolore si propone come il rovesciamento consapevole dellrsquoepisodio iniziale che era apparso caratterizzato dalla cancellazione della pietagrave e del diritto dei supplici in nome della forza Al rifiuto iniziale del donoriscatto si oppone lrsquoaccettazione finale in consonanza con un principio-guida che opera nel poema secondo linee che alla fine si riunificano Agamennone restituisce Criseide al padre ma si appropria del dono fatto dagli altri Achei ad Achille (Briseide) Achille respinge i doni fatti da Agamennone per indurlo a riconciliarsi con lui ma dopo aver contestato nel IX canto la nozione che la vita umana possa essere barattata con una massa di beni torna alla lotta non in cambio di qualche premio da conquistare ma per vendicare lrsquouccisione dellrsquoamico Patroclo e tanto nella lotta sul campo di battaglia quanto nellrsquoinfierire sul cadavere di Ettore si abbandona a un furore cosigrave smisurato e patologico che puograve essere superato solo con lrsquoaccettare i doni di Priamo non tuttavia per il loro valore drsquouso ma percheacute in Priamo Achille riconosce lrsquoombra del padre lontano Cosigrave lrsquoIliade appare attraversata da un impulso fondamentale che muove dallrsquoideologia del dono e dalla conseguente centralitagrave assegnata allrsquoonore (τιμή) come ldquoprezzordquo che qualifica il valore del guerriero ma supera questo piano di valutazione dei rapporti umani attraverso la loro riformulazione nei termini di un umanesimo esistenziale che ha come punti di riferimento lrsquoidentitagrave universale dei condizionamenti oggettivi (la vecchiaia la malattia la morte) e i legami che uniscono padre e figlio compagno e compagno vivi e morti (il cordoglio finale di Andromaca Ecuba ed Elena sulla salma di Ettore) Entro questo orizzonte progressivamente allargato la guerra le lotte lo scontro mortale finiscono col rappresentare solo un momento e un aspetto dellrsquoesistenza graditi tanto agli degravei che vi assistono come spettatori interessati quanto agli uditori che riascoltano le antiche gesta eppure non tali da appiattire il poema in una prospettiva guerresca conclusa in se stessa Molto del fascino delle battaglie e delle ἀριστεῖαι dellrsquoIliade sta nella presenza recondita di un occhio che sa guardare al di lagrave di esse (e al di lagrave della stessa distinzione fra Greci e Troiani vincitori e vinti) e che puograve anche attraverso le similitudini lasciare irrompere il mondo della natura o del lavoro umano nel mezzo delle battaglie LʼOdissea LrsquoOdissea (Ὀδύσσεια) consta di circa 12100 esametri divisi anchrsquoessi in 24 libri e indicati con le lettere minuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquoargomento egrave costituito dalle avventure di Odisseo dalla distruzione di Troia al ritorno alla patria Itaca esposte secondo un ordine che entrando subito nel vivo degli avvenimenti (lrsquoinizio del poema mostra Odisseo nellrsquoisola di Calipso) rievoca poi i fatti giagrave trascorsi e li ricongiunge infine a partire dal libro XV (con lrsquoarrivo di Telemaco alla capanna di Eumeo dove giagrave si trova Odisseo) in unrsquoazione unitaria La trama del poema i cui avvenimenti sono concentrati cronologicamente nello spazio di 40 giorni (ma sono narrati solo gli avvenimenti di 16 giorni e 8 notti) si articola in tre parti la laquoTelemachiaraquo (canti I-IV) il laquoRitorno di Odisseoraquo (canti V-XIII) e la laquoVendetta di Odisseoraquo (canti XIV-XXIV)
Letteratura greca [1]
22
Canto I Tutti gli eroi superstiti sono ormai tornati da Troia alle loro case tranne Odisseo che pur desideroso di tornare egrave trattenuto dalla ninfa Calipso nellrsquoisola di Ogigia Gli degravei hanno pietagrave di lui tranne Posidone irato per lrsquoaccecamento del figlio il ciclope Polifemo Ma un consiglio degli degravei assente Posidone (che si egrave recato presso gli Etiopi) delibera il ritorno dellrsquoeroe si decide che Ermes andragrave subito da Calipso mentre Atena si avvia verso Itaca sotto lrsquoaspetto del signore dei Tafi Mente per incoraggiare il figlio di Odisseo Telemaco a tener testa ai pretendenti della madre i laquoprociraquo (i quali aspirano al regno tramite le nozze con Penelope) e per indurlo a intraprendere un viaggio in cerca di notizie sul padre Canto IΙ Telemaco segue il consiglio della dea e il giorno seguente nellrsquoassemblea popolare chiede una nave per andare in cerca del padre ma la sua richiesta non viene discussa e Leocrito scioglie lrsquoassemblea Grazie ad Atena che ora ha assunto le sembianze di Mentore (antico amico di Odisseo) Telemaco riesce tuttavia a trovare una nave con cui salpa nel corso della notte allrsquoinsaputa sia della madre che dei proci Canto IΙΙ Telemaco e MentoreAtena arrivano a Pilo e sul lido trovano Nestore che sta offrendo un sacrificio a Posidone Il vecchio eroe accoglie ospitalmente Telemaco e gli comunica molte notizie sul ritorno di altri Achei ma nessuna su Odisseo Alla sera Atena scompare in forma di aquila e il mattino seguente Telemaco salpa insieme con Pisistrato (figlio di Nestore) alla volta di Sparta dove arriva la sera del giorno successivo Canto IV A Sparta Menelao sta festeggiando il doppio matrimonio del figlio e della figlia Il giorno seguente Telemaco chiede del padre Menelao gli racconta il proprio ritorno durante il quale aveva incontrato Proteo il vecchio nume marino che gli aveva riferito come Odisseo fosse trattenuto nellrsquoisola di Calipso Intanto a Itaca i proci preparano insidie meditando di uccidere Telemaco al suo ritorno Penelope ne viene a conoscenza ma Atena le appare in sogno per confortarla Canto V Dopo un secondo concilio degli degravei (in effetti un ldquodoppionerdquo di quello del I canto) Zeus manda finalmente Ermes presso Calipso con lrsquoordine di lasciar partire Odisseo La ninfa aiuta lrsquoeroe a costruirsi una zattera Al diciottesimo giorno di navigazione Odisseo egrave in vista dellrsquoisola dei Feaci Scheria quando Posidone di ritorno dal suo soggiorno presso gli Etiopi lo vede e suscita una tempesta che distrugge la zattera Ma la dea marina Ino Leucotea impietositasi gli porge il proprio velo sostenuto dal quale lrsquoeroe giunge a nuoto alla riva di Scheria dove si abbandona esausto addormentandosi Canto VI In seguito a un sogno inviatole da Atena Nausicaa la figlia del re dei Feaci Alcinoo si reca nei pressi della spiaggia a lavare le vesti insieme con le ancelle Odisseo risvegliatosi atterrisce le fanciulle che fuggono tutte allrsquoinfuori di Nausicaa Lrsquoeroe supplica la giovane di porgerle aiuto ed ella lo fa rivestire e lo accompagna fino al bosco di Atena poco prima della cittagrave esortandolo a presentarsi a suo padre Canto VII Protetto dalla nebbia di cui Atena lo ha avvolto Odisseo entra nel palazzo abbraccia le ginocchia della regina Arete e la caligine scompare poi viene accolto con onore da Alcinoo Arete chiede a Odisseo donde provenga e chi gli abbia donato gli abiti (a lei ben noti) che indossa Lrsquoeroe inizia a raccontare le disavventure che gli sono occorse dopo la
Letteratura greca [1]
23
partenza dallrsquoisola di Calipso Alcinoo gli promette di farlo ricondurre a Itaca il giorno seguente Canto VIII Ma lrsquoindomani Alcinoo fa apprestare un banchetto durante il quale lrsquoaedo Demodoco canta della contesa insorta un giorno fra Achille e Odisseo Lrsquoeroe si copre il volto per nascondere le lacrime allora Alcinoo interrompe il canto e organizza una serie di gare nel corso delle quali Odisseo primeggia Poi Demodoco al margine di unrsquoarea per la danza dove si esibiscono i ballerini feaci canta gli amori di Ares e Afrodite e la vendetta di Efesto (che incatena i due amanti) La sera al ritorno nel palazzo Demodoco racconta la storia del Cavallo di legno Odisseo scoppia nuovamente in lacrime e Alcinoo gli chiede di rivelare il suo nome Canto IX Odisseo dichiara il proprio nome e dagrave inizio al racconto della propria storia a partire dalla caduta di Troia distruzione di Ismaro e perdite subite ad opera dei Ciconi sbarco presso i Lotofagi (che si nutrono di un cibo misterioso che fa dimenticare il ritorno) dopo una terribile tempesta scatenatasi durante il tentativo di doppiare il capo Malea arrivo allrsquoisola antistante quella dei Ciclopi dove Odisseo si trasferisce con una sola nave esplorazione dellrsquoisola perdita di alcuni compagni allrsquointerno della caverna del gigante monocolo accecamento del mostro e fuga Canto X Odisseo giunge allrsquoisola di Eolo signore dei venti che lo accoglie benevolmente e gli consegna alla partenza tutti i venti chiusi in un otre ma poi lo respinge con durezza quando ritorna presso di lui percheacute i compagni (sospettando che nellrsquootre siano racchiuse cospicue ricchezze) hanno sciolto i venti e da essi si egrave sprigionato un uragano che li ha risospinti sullrsquoisola Ripreso il mare Odisseo egrave trasportato fino ai Lestrigoni antropofagi il cui attacco priva lrsquoeroe di tutte le altre navi tranne la propria Con questa fugge fino allrsquoisola (Eea) della maga Circe Dopo che Circe ha trasformato in porci un gruppo di compagni mandati innanzi ad esplorare lrsquoisola Odisseo ha la meglio sulla maga (a cui impone di restituire forma umana ai compagni) grazie allrsquoerba moly fornitagli da Ermes Resta un anno presso Circe che al momento della partenza gli consiglia di recarsi al paese dei morti per interrogare il vate Tiresia Canto XI Approdato alla terra dei Cimmeri (che vivono immersi in una nebbia perenne sulla riva dellrsquoOceano) e scavata una fossa Odisseo sacrifica ai morti e immola una vittima speciale a Tiresia Le anime accorrono dapprima Elpenore caduto per caso giugrave dal tetto della casa di Circe (Odisseo gli promette sepoltura) poi la madre Anticlea (che gli racconta di esser morta di dolore per la sua assenza) quindi Tiresia che gli vaticina le sue vicende future fino alla morte (questa lo coglieragrave dopo una lunga vita in un paese straniero che non conosce neacute il sale neacute il remo) Da un certo punto in poi il poeta dimentica il presupposto per cui Odisseo aveva scavato una fossa alla quale i morti accorrevano per bere il sangue delle vittime e bevendolo riacquistavano per breve tempo una piena consapevolezza immagina invece che Odisseo sia allrsquointerno dellrsquoAde In questa sezione rientrano la descrizione di Aiace sdegnato di Minosse di Orione dei grandi peccatori di Eracle Poi Odisseo fa ritorno a Eea e ricevuti i consigli di Circe si imbarca per il ritorno in patria Canto XII Scampato alle Sirene che invano lo attirano col canto (si egrave fatto legare allrsquoalbero della nave i compagni che remano hanno le orecchie turate con la cera) passa tra Cariddi e Scilla (che gli rapisce sei uomini) ed egrave costretto dai compagni ad approdare in contrasto con le prescrizioni di Circe allrsquoisola Trinachia dove pascolano le greggi del Sole I
Letteratura greca [1]
24
compagni spronati da Euriloco se ne cibano nonostante il divieto dellrsquoeroe Il Sole sdegnato ottiene da Zeus che la nave sia colpita dal fulmine Tutti i compagni periscono ma Odisseo che ripassa tra Scilla e Cariddi si salva miracolosamente da questrsquoultima aggrappandosi a un fico selvatico fincheacute il gorgo restituisce i rottami della nave infine arriva remando con le mani allrsquoisola di Ogigia Canto XIII Terminato il racconto lrsquoeroe riceve doni dai Feaci e la notte seguente egrave ricondotto a Itaca e deposto addormentato sulla spiaggia presso un antro sacro alle Ninfe Al risveglio per la nebbia non riconosce la sua terra fincheacute Atena in veste di giovane pastore lo rassicura e poi rivelatasi gli dagrave istruzioni su come far strage dei proci e lo trasforma in un vecchio mendico Canto XIV Odisseo si reca allo stazzo del suo porcaio Eumeo che pur non riconoscendolo lo accoglie ospitalmente rifocillandolo e offrendogli un mantello per ripararsi dal gelo notturno Canto XV A questo punto la laquoTelemachiaraquo si riannoda allrsquoazione principale Telemaco che si trova ancora a Sparta viene indotto da Atena a tornare a Itaca sulla via del ritorno a Pilo accoglie a bordo lrsquoindovino Teoclimeno e grazie allrsquoaiuto della dea sfugge alle insidie dei proci sbarca a Itaca e si reca anchrsquoegli presso Eumeo Canto XVI Questi va da Penelope ad annunciargli il ritorno del figlio Intanto Odisseo rimosso lrsquoincantesimo si svela nel suo vero aspetto a Telemaco e con lui progetta la vendetta sui proci (che intanto tramano una nuova insidia ai danni di Telemaco) Eumeo torna al suo stazzo Canto XVII Il mattino seguente Telemaco si reca in cittagrave seguito in un secondo tempo da Eumeo e Odisseo (che ha riassunto lrsquoaspetto di mendico) Davanti al palazzo Odisseo egrave riconosciuto dal cane Argo Entra e va mendicando tra i proci Antinoo lo colpisce alla spalla destra con uno sgabello Canto XVIII Odisseo si batte al pugilato col mendicante Iro Penelope scesa nella sala prospetta ai proci lrsquoeventualitagrave di un nuovo matrimonio Odisseo egrave insultato dalla schiava Melanto e schiva uno sgabello scagliato da Eurinomo Canto XIX Insieme con Telemaco lrsquoeroe allontana le armi dalla sala poi conversa con Penelope che gli racconta un sogno e gli espone il suo piano per sedare le contese tra i proci concedendosi sposa a colui che riusciragrave a tendere lrsquoarco di Odisseo la prova avverragrave il giorno seguente al novilunio Durante il colloquio la fida schiava Euriclea lava i piedi di Odisseo e riconosciutolo da unrsquoantica cicatrice sta per rivelarne lrsquoidentitagrave ma lrsquoeroe la costringe a tacere Canto XX Al mattino Euriclea e le ancelle fanno i preparativi per il banchetto Giungono Eumeo Melanzio e il mandriano Filezio Un presagio mandato da Zeus dissuade i proci dal progetto di uccidere Telemaco Durante il banchetto Teoclimeno predice la loro imminente rovina
Letteratura greca [1]
25
Canto XXI Penelope conduce lrsquoarco nella sala dopo che parecchi fra i proci e lo stesso Telemaco hanno tentato invano di tenderne la corda Odisseo chiede di partecipare alla prova tende lrsquoarco senza fatica e riesce a far passare la freccia attraverso gli anelli di dodici scuri predisposte da Telemaco Canto XXII Poi scaglia le frecce sui proci e si rivela nella sua identitagrave Nella lotta che segue Telemaco Eumeo e Filezio aiutano il padrone contro i proci (appoggiati dal capraio Melanzio) Tutti i proci restano uccisi le ancelle infedeli sono impiccate Melanzio viene mutilato e ucciso soltanto lrsquoaedo Femio e lrsquoaraldo Medonte sono risparmiati Canto XXIII Nuovo colloquio fra Odisseo e Penelope che durante lrsquoeccidio dormiva ed egrave stata svegliata da Euriclea Penelope esita ancora a riconoscere il marito e non si arrende alla veritagrave fincheacute Odisseo non le descrive la posizione e la struttura del letto coniugale Canto XXIV Ermes conduce allrsquoAde le ombre dei proci Odisseo fa visita al padre Laerte nella masseria dove quello vive nello squallore e nellrsquoemarginazione e si fa riconoscere Intanto il padre di Antinoo incita gli Itacesi alla rivolta e il poema si conclude con lo scontro di Odisseo e dei suoi contro i concittadini lrsquoeroe ha la meglio e Zeus scagliato il fulmine pone fine alla battaglia Atena sotto lrsquoaspetto di Mentore stabilisce fra i contendenti un patto per il futuro36
Struttura e caratteri dellʼopera Giagrave la prima parola del proemio (ἄνδρα) non menziona come tema dellrsquoopera un determinato episodio della vita del protagonista ma il protagonista stesso (I 1-10)
Ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα πολύτροπον ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεmiddot πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περmiddot αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο νήπιοι οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιονmiddot αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ τῶν ἁμόθεν γε θεά θύγατερ Διός εἰπὲ καὶ ἡμῖν Dellrsquouomo multiforme a me racconta o Musa che molto errograve dopo che di Troia la sacra rocca distrusse di molti uomini vide le cittagrave riconobbe il pensiero e molti per il mare patigrave dolori nellrsquoanimo per salvare la sua vita e il ritorno dei compagni Eppure non li salvograve i compagni per quanto bramasse per la loro stessa follia si persero gli stolti i buoi del Sole Iperione mangiarono e quello rapigrave ad essi il digrave del ritorno Di questo da un punto qualsiasi narra anche a noi o dea figlia di Zeus
Storie favolose di naviganti racconti imperniati sul ritorno dei guerrieri achei che avevano combattuto a Troia e il particolare rientro in patria di Odisseo figlio di Laerte erano forse giagrave stati connessi e intrecciati nella precedente tradizione epica sigrave che il presente cantore poteva
Letteratura greca [1]
26
metter mano alla vicenda partendo (v 10) laquoda un punto qualsiasiraquo (ἁμόθεν) una notazione che certo presuppone la convenzione propria dellrsquoesordio tradizionale di un canto epico comparabile con i giagrave ricordati ἐξ οὗ (laquoda quandoraquo) di Iliade I 4 ed ἔνθεν (laquoda doveraquo) di Odissea VIII 500 Senoncheacute rispetto a queste indicazioni di tipo puntuale il tratto costituito dalla dimensione casuale quasi arbitraria inerente ad ἁμόθεν proprio mentre dichiara lrsquoassenza di un determinato piano compositivo implica in realtagrave che il racconto non si svolgeragrave per filo e per segno secondo lrsquoordine noto a poeta e uditori non si snoderagrave κατὰ κόσμον (laquoper ordineraquo) come il canto di Demodoco (VIII 489) ma seguiragrave un andamento originale Il ldquopunto qualsiasirdquo incipitario non rappresenta una scelta della Musa (figura dellrsquoarchivio tematico che conserva le laquovieraquo dellrsquoepica) bensigrave di questo cantore che ha deciso di far incominciare la narrazione in medias res e ha in serbo la sorpresa di far succedere al concilio degli degravei (che decide lrsquoinvio di Ermes presso Calipso) non lrsquoazione testeacute programmata (azione che viene differita con un ritardo che a piugrave riprese ha scandalizzato i lettori a principio del V canto) ma la partenza di Atena alla volta di Itaca e lrsquoavvio della laquoTelemachiaraquo Le due diverse vicende proposte a principio del poema quella di Telemaco e quella di Odisseo procedono infatti in parallelo coprendo un analogo lasso di tempo Piugrave oltre la decisione di trasformare la sequenza narrativa che va dalla partenza di Odisseo da Troia fino al suo arrivo nella terra dei Feaci in una rievocazione fatta dallrsquoeroe in prima persona al cospetto di Alcinoo e dei Feaci (la sezione detta degli ἀπόλογοι laquoraccontiraquo) crea una struttura ad anello che parte dal presente e ad esso fa ritorno dopo aver ricostruito le premesse della condizione attuale del protagonista Col canto XIII Odisseo egrave riportato dai Feaci a Itaca e questo permette la saldatura fra le vicende sue e quelle di Telemaco sia pure col differimento dellrsquoincontro e del riconoscimento fra padre e figlio fino al canto XVI Far scorrere in parallelo sequenze distinte organizzare programmi narrativi a corta e a lunga gittata tendere o allentare ad arte il ritmo della narrazione non si tratta davvero di procedimenti che potessero configurarsi come tradizionali dellrsquoarte epica quanto piuttosto di un momento sperimentale di una ricerca di soluzioni nuove al termine di una lunga e ormai consolidata sedimentazione di percorsi compiuti allrsquointerno di un determinato repertorio tematico unrsquoaudacia inventiva una πολυτροπίη degne del protagonista del poema che inevitabilmente comportavano rischi molteplici di incoerenze dissonanze occasionali avarie della macchina epica e che tuttavia erano destinate a conseguire un risultato assolutamente convincente allrsquoorecchio di chi si abbandonasse al fascino del racconto senza lrsquourgenza propria di altre etagrave e di altre mentalitagrave di puntare il dito sui singoli dettagli o le singole sfasature
PER SAPERNE DI PIUrsquo Difficoltagrave e incongruenze della narrazione omerica Forti della possibilitagrave di un controllo su un testo scritto che possiamo percorrere in avanti e a ritroso secondo ritmi di nostra scelta a noi non riesce difficile cogliere alcune delle difficoltagrave organizzative incontrate nella composizione del poema In proposito per ricordare un caso che saragrave allrsquoorigine delle discussioni di orientamento ldquoanaliticordquo intorno allrsquoOdissea possiamo leggere il discorso che Atena prese le sembianze di Mente re dei Tafi rivolge a Telemaco nel I canto (vv 253-305) Ah infelice ti manca molto davvero lrsquoassente Odisseo che getti le mani addosso ai pretendenti sfrontati Percheacute se ora tornato stesse sulla soglia 255 con una scure lo scudo e due lance cosigrave come io per la prima volta lo vidi in casa nostra che beveva e godeva di ritorno da Efira da Ilo di Mermero (andograve anche ligrave Odisseo con la nave veloce 260 in cerca del veleno omicida per averne da ungere le frecce di bronzo ma quello non glielo diede percheacute temeva gli dei che vivono eterni
Letteratura greca [1]
27
glielo diede invece mio padre percheacute lrsquoamava moltissimo) se stesse Odisseo tra i pretendenti cosigrave 265 essi avrebbero tutti rapida morte e nozze amare Ma sulle ginocchia degli dei questo giace se una volta tornato faragrave o no vendetta nella sua casa te invece io esorto a riflettere come cacciare i pretendenti da casa 270 Ebbene ora ascolta e alle mie parole darsquo retta Domattina chiamati gli eroi Achei a consiglio rivolgi a tutti un discorso e siano testimoni gli dei Ai pretendenti comanda drsquoandarsene per i fatti loro e tua madre se lrsquoanimo la spinge alle nozze 275 ritorni a casa del padre molto potente Prepareranno essi le nozze e disporranno i doni nuziali moltissimi quanti gli pare che debbano andare alla figlia A te darograve un saggio consiglio se vuoi ascoltarlo armata una nave con venti remi la migliore che crsquoegrave 280 Varsquo a domandare del padre partito da tempo se mai te ne parli un mortale o sentissi da Zeus la voce che divulga la fama tra gli uomini Anzitutto varsquo a Pilo e interroga il chiaro Nestore di ligrave poi varsquo a Sparta dal biondo Menelao 285 degli Achei vestiti di bronzo egli egrave tornato per ultimo Se senti dire qualcosa sulla vita e il ritorno del padre per quanto stremato potresti sopportare un altro anno se invece senti dire che egrave morto e non vive allora tornato nella cara terra patria 290 ergigli un tumulo e offrigli funebri offerte moltissime quanto conviene e darsquo tua madre a un marito E poi dopo aver compiuto e fatto ogni cosa allora medita nella mente e nellrsquoanimo come tu possa uccidere nelle tue case 295 i pretendenti con lrsquoinganno affrontandoli non devi piugrave avere i modi di un bimbo percheacute ormai non sei tale Non senti lrsquoillustre Oreste quale gloria ha acquistato fra tutti gli uomini percheacute uccise lrsquoassassino del padre Egisto esperto di inganni che gli uccise il nobile padre 300 Anche tu caro infatti molto bello e grande ti vedo sii valoroso percheacute ti lodi anche qualcuno dei posteri Ma io tornerograve adesso alla nave veloce dai compagni che forse impazienti mi aspettano Tu devi pensarci da te dammi retta 305
[Tr di GA Privitera] Le stranezze non mancano davvero e cosigrave sono state messe a fuoco da Stephanie West nel suo commento23 1 Atena sa evidentemente molto piugrave di quanto uno come Mente avrebbe potuto sapere in particolare ella sa che i proci ignoreranno lrsquoinvito di Telemaco a lasciare la sua casa e fatto piugrave importante che gli degravei tra breve ricondurranno in patria Odisseo A queste osservazioni si puograve replicare con la stessa West che laquosi sono esagerate difficoltagrave e
23 Omero Odissea I cit 219 ss
Letteratura greca [1]
28
incongruenze alle quali un pubblico di ascoltatori (o anche un lettore moderatamente attento) probabilmente non farebbe casoraquo 2 Il progetto di una pubblica denuncia dei proci dinanzi agli degravei e agli uomini ai vv 273-274 egrave ciograve che Atena sembra prefiggersi nel promuovere lrsquoassemblea degli Itacesi (assemblea che effettivamente avragrave luogo a principio del canto II) drsquoaltra parte le successive istruzioni di AtenaMente ai vv 295 s (medita come uccidere i pretendenti) presuppongono che di quella richiesta da formulare nel corso dellrsquoassembla essi non terranno alcun conto Anche a questa osservazione si puograve rispondere che laquoegrave ragionevole attendersi che Telemaco condivida la previsione di un esito negativo della sua iniziativaraquo e si puograve aggiungere che pure in caso di insuccesso il ricorso allrsquoassemblea potrebbe ottenere almeno il risultato di screditare i pretendenti presso la comunitagrave itacese legittimando un successivo ricorso alla violenza (e si tratta di una legittimazione di cui anche lrsquoultimo canto mostreragrave lrsquoesigenza) 3 Dopo che Telemaco aveva detto che la madre non intendeva risposarsi (vv 249-250) AtenaMente si esprime ai vv 275-278 come se Penelope desiderasse proprio nuove nozze e inoltre sarebbe assurdo che il padre di Penelope cominciasse a contrattare un secondo matrimonio prima del ritorno di Telemaco dal suo viaggio e che mettesse mano a preparativi che rischierebbero di essere annullati qualche tempo dopo con inevitabile imbarazzo se Telemaco venisse a sapere che Odisseo egrave ancora vivo In piugrave lrsquoandamento sintattico di questi versi presenta un anacoluto durissimo per cui a principio del v 275 lrsquoaccusativo μητέρα egrave seguito da un ἂψ ἴτω (laquovada indietroraquo laquotorniraquo) che richiederebbe come soggetto un nominativo μήτηρ Come hanno reagito i lettori di Omero Nellrsquoantichitagrave un grammatico rimasto anonimo cambiava come attesta uno scolio μητέρ᾽ in μήτηρ nel secolo XVIII Richard Bentley modificava ἴτω in ἴμεν (infinito eolico di εἶμι laquovadoraquo) nel XIX un altro grande della filologia europea Gottfried Hermann risolveva piugrave drasticamente la questione eliminando il complesso dei vv 275-278 e la stessa West mostra simpatia per tale proposta supponendo laquounrsquoaggiunta posteriore modellata sul corrispondente passo del libro IIraquo (dove i vv 196 s sono identici ai vv 277 s e il v 195 copre lo stesso contenuto dei vv 275 s) Si tratta di procedimenti adeguati ai dati di fatto Migliorano davvero il testo che ci egrave stato tramandato In realtagrave ambedue le ldquocorrezionirdquo appena ricordate (di μήτερ᾽ e di ἴτω) ottengono un risultato tanto lineare che egrave davvero difficile pensare che lrsquoanacoluto avrebbe potuto invadere tutta la tradizione se non fosse stato originario e quanto allrsquoespunzione dei vv 275-278 essa indubbiamente peggiorerebbe il ritmo del discorso determinando lrsquoavvicinamento fra i due versi (v 271 e v 279) molto simili fra loro che aprono le due sequenze occupate dai consigli di Mente E allora La via piugrave saggia egrave senzrsquoaltro quella di tenerci qui come quasi sempre di fronte al testo omerico contraddizioni e anacoluti riconoscendo in essi lrsquoeffetto dellrsquoattivitagrave di un cantore che pur sulla base di una traccia largamente memorizzata restava pur sempre legato a quella prassi orale per cui composizione ed esecuzione tendevano a coincidere E lrsquoanacoluto si spiega bene se cerchiamo di immedesimarci nel procedimento seguito dal poeta Egli ha affidato ad Atena un certo flusso argomentativo per cui la dea deve dar consigli a Telemaco sui suoi rapporti coi proci e con la madre e cosigrave colloca in fine di v 274 un ἄνωχθι (laquoordinaraquo) destinato a reggere gli accusativi simmetricamente dislocati in principio di verso (vv 274 e 275) μνηστῆρας e μητέρα Senoncheacute giunto a questa seconda parte dellrsquoargomentazione egli si avvede quanto sarebbe illogico che Telemaco sollecitasse la madre a nuove nozze di qui lrsquoimprovviso cambio di costruzione che svincola al prezzo di una sensibile slogatura sintattica lrsquoipotesi delle nuove nozze dallrsquoordine impartito a Telemaco e la prospetta invece come un desiderio eventuale della stessa Penelope Il poeta ha un progetto ben meditato brani e sequenze piugrave volte sperimentati ed egrave col supporto di questi materiali giagrave elaborati che egli si fa strada attraverso le insidie della
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
17
spronandoli al combattimento Gli Achei riconoscono lrsquointervento divino e riprendono fiducia I combattimenti si susseguono violentissimi Nella resistenza si distingue il re cretese Idomeneo Polidamante consiglia una seconda volta di interrompere la battaglia e accenna allrsquoimminente intervento di Achille Ettore non ascolta lrsquoammonimento e riprende lrsquoassalto Il canto si chiude con un suo scambio di insulti con Aiace Telamonio Canto XIV Mentre Diomede Odisseo e Agamennone tornano feriti allrsquoaccampamento Era per distogliere Zeus dalla battaglia e consentire a Poseidone di favorire gli Achei indossa la cintura magica di Afrodite e sollecita il consorte a un convegno amoroso sullrsquoIda dopo lrsquoamplesso Zeus cade in un sonno profondo e Hypnos (il Sonno) annuncia a Posidone che potragrave aiutare senza rischi gli Achei Ettore colpito con una pietra da Aiace resta a lungo in stato di incoscienza e i Troiani vengono respinti Canto XV Zeus si risveglia avvedendosi dellrsquoinganno subito e costringe Era a mandargli Iride e Apollo la prima allontaneragrave Posidone dal campo di battaglia Apollo inciteragrave Ettore a far retrocedere gli Achei fino alle navi dei Mirmidoni Riprende lrsquooffensiva troiana Apollo stesso abbatte il muro e scuotendo lrsquoegida atterrisce gli Achei Patroclo corre da Achille mentre i Troiani giagrave sono sul punto di appiccare il fuoco alle navi Canto XVI Patroclo in lacrime supplica Achille di intervenire o di mandare lui stesso al suo posto [T8] Achille gli consegna le proprie armi e gli fa promettere che non si avventureragrave oltre la zona delle navi Ma Patroclo trascinato dal suo stesso impeto oltrepassa il limite prescrittogli da Achille Abbatte Sarpedone figlio di Zeus attorno al cui cadavere infuria la lotta fincheacute Apollo lo sottrae alla mischia e Hypnos e Thanatos (il demone della morte) lo trasportano in Licia sua patria Patroclo continua lrsquoassalto alla testa dei Mirmidoni fin sotto le mura di Troia ma poco prima del tramonto al quarto assalto Apollo stesso assunto lrsquoaspetto di Asio lo percuote fra le spalle allora Euforbo lo colpisce con lrsquoasta ed Ettore lo trafigge Canto XVII Euforbo viene ucciso da Menelao ma Ettore riesce a catturare le armi di Achille indossate da Patroclo Vigorosamente sostenuti da Aiace gli Achei difendono il cadavere Una densa nebbia scende sui combattenti Zeus infonde nuovo ardimento nei cavalli di Achille piangenti per la fine di Patroclo [T9] Atena e Apollo arroventano la lotta attorno alla salma In seguito alla preghiera di Aiace Zeus dissolve la nebbia Menelao manda Antiloco figlio di Nestore a informare Achille della morte di Patroclo la cui salma viene intanto trascinata fuori della battaglia da Menelao e Merione mentre i due Aiaci offrono la necessaria copertura contro la furia incalzante dei nemici Canto XVIII Lo scoppio di selvaggio dolore a cui si abbandona Achille allrsquoudire della morte di Patroclo provoca lrsquoaccorrere dal mare di Tetide insieme con le Nereidi La madre gli promette di procurargli nuove armi Poicheacute la salma di Patroclo egrave tuttora contesa Achille fa la sua apparizione sul fossato e lancia un grido che atterrisce i nemici Efesto su preghiera di Tetide foggia le nuove armi fra cui un magnifico scudo su cui appaiono effigiati in bande concentriche gli aspetti salienti dellrsquoesistenza umana Canto XIX Il mattino seguente Tetide porta le armi al figlio e con lrsquoambrosia preserva la salma di Patroclo dalla decomposizione Achille convoca unrsquoassemblea dellrsquoesercito e rinuncia alla sua collera Agamennone lamenta di essere stato ldquoaccecatordquo da Zeus e promette doni
Letteratura greca [1]
18
riparatori [T10] Achille si lascia convincere a stento ad attendere che i soldati abbiano mangiato Poi gli armati si radunano e anche Achille si arma Il suo cavallo Xanto gli predice la prossima morte [T11] Canto XX Zeus consente agli degravei di partecipare alla nuova battaglia Enea scontratosi con Achille egrave tratto in salvo da Posidone Achille infuria come un incendio in una selva Canto XXI Achille colma di cadaveri il fiume Scamandro e cattura dodici giovani troiani che intende offrire in sacrificio a Patroclo non risparmia neppure Licaone figlio di Priamo che lo supplica con accenti di grande intensitagrave ma altrettanto intensa nella consapevolezza di un destino imminente egrave la pur spietata replica del Pelide [T12] Lo Scamandro solleva le proprie onde ma le fiamme di Efesto inaridiscono il terreno e domano la corrente Gli degravei si azzuffano Atena raggiunge Ares con una pietra Era rintuzza la furia di Artemide Infine tutti tornano sullrsquoOlimpo Apollo assunto lrsquoaspetto di Agenore respinge Achille percheacute i Troiani possano rifugiarsi allrsquointerno delle mura Canto XXII Il solo Ettore resta fuori nella pianura Invano Priamo ed Ecuba lo pregano di rientrare Mentre Achille si avvicina Ettore decide di affrontarlo ma quando quello gli egrave da presso col bronzo che gli lampeggia intorno laquosimile al raggio del fuoco ardente o del sole che sorgeraquo egrave afferrato dal panico e comincia a fuggire compiendo tre giri intorno alle mura Zeus pesa sulla bilancia i destini (le κῆρες) dei due eroi e quello di Ettore affonda in basso Allora Apollo lo abbandona e Atena apparsa a Ettore sotto le spoglie di suo fratello Deifobo gli si avvicina promettendogli aiuto e invece riporta ad Achille la lancia che gli era caduta fuori bersaglio Il colpo di risposta di Ettore rimbalza sullo scudo di Achille Ettore urla a Deifobo di passargli la sua lancia ma il falso Deifobo egrave scomparso ed Ettore comprende di trovarsi sullrsquoorlo dellrsquoabisso [T13] Achille gli trapassa la gola ed Ettore lo supplica di non oltraggiare la sua salma in risposta riceve la minaccia che finiragrave in pasto ai cani Achille trascina il cadavere alle navi attaccato al carro Priamo Ecuba e Andromaca si abbandonano al cordoglio a cui fanno eco le donne troiane Canto XXIII Viene preparato il banchetto funebre in onore di Patroclo la cui ombra nel corso della notte appare ad Achille chiedendo la sepoltura del corpo Il mattino seguente si appresta il rogo fra le offerte votive ci sono anche dodici giovani troiani Il giorno successivo si raccolgono le ossa di Patroclo Seguono i ludi funebri gare coi carri e con lrsquoarco duello in armi etc Canto XXIV Ogni giorno Achille trascina il cadavere di Ettore attorno alla tomba dellrsquoamico ma lo spettacolo offende gli degravei e al dodicesimo giorno Zeus decide di mandare Tetide percheacute induca suo figlio a restituire la salma di Ettore Iride viene inviata presso Priamo percheacute gli consigli di recarsi nel cuore della notte con un carro da trasporto e un copioso riscatto scortato da Ermes alla tenda di Achille Questi accoglie il vecchio con rispetto riconoscendo in lui lrsquoimmagine del padre lontano e si piega alla sua supplica [T14] Per volontagrave degli degravei il cadavere non egrave stato aggredito dalla putrefazione composto sul pianale del carro viene ricondotto dal padre a Troia Qui le lamentazioni rituali srsquoinnalzano dal gruppo delle donne (Andromaca Ecuba Elena) Si stipula una tregua di dodici giorni Per nove giorni i Troiani raccolgono legname poi anche il rogo di Ettore arde e si erige un tumulo
Letteratura greca [1]
19
Struttura e caratteri dellʼopera Poema di trama relativamente organica (soprattutto a partire dal canto XVI tutti gli avvenimenti tranne pochi episodi isolati ruotano attorno ai due principali antagonisti Ettore uccide Patroclo per vendicare Sarpedone e Achille uccide Ettore per vendicare Patroclo) pur se non privo di piugrave o meno cospicue incongruenze spiegabili in primo luogo con la lunga e complessa genesi orale dellrsquoopera lrsquoIliade lascia emergere in mezzo alle centinaia di nomi e alle intricate vicende alcuni caratteri delineati nella loro individualitagrave e innanzi tutto quelli di Achille e di Ettore accomunati dalla medesima coscienza di un destino di morte che sono pronti ad affrontare Appunto una tale attitudine a rappresentare i laquocaratteriraquo (ἤθη) dei suoi personaggi egrave un altro titolo di merito che Aristotele ascrive ad Omero (Poetica 1460a9-11)
dopo aver brevemente proemiato subito introduce un uomo una donna o un altro personaggio nessuno privo di caratterizzazione ma dotato di un carattere
Fondamentale per la struttura del poema egrave la novitagrave della prospettiva Possiamo presumere che i cosiddetti poemi ciclici22 mirassero a conservare lrsquoangolatura che era stata propria delle versioni pre-omeriche della saga troiana sigrave che puograve riuscire significativo il confronto fra lrsquoesordio della Piccola Iliade (dove muovendo da grandi entitagrave ndash la cittagrave il paese due popoli la guerra ndash viene lanciato secondo lrsquoespressione di J Latacz come laquouno sguardo dallrsquoesternoraquo)
Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην εὔπωλον ἧς πέρι πολλὰ πάθον Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος Canto Ilio e la terra dei Dardani dai bei puledri per la quale molti dolori patirono i Danai servitori di Ares
con lo laquosguardo internoraquo che caratterizza lrsquoinizio dellrsquoIliade
Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν ἡρώων αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν οἰωνοῖσί τε δαῖτα Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς Canta o dea di Achille figlio di Peleo la collera maledetta che pene innumerevoli inflisse agli Achei e molte scagliograve allrsquoAde vite possenti di eroi e ne faceva prede per i cani e pasto per gli uccelli e si avverava il volere di Zeus da quando primamente si separarono venuti a contesa LrsquoAtride sovrano di eroi e Achille magnifico
Argomento non egrave dunque come doveva avvenire nella tradizione del canto epico un evento complesso da inquadrare con un grandangolo onnicomprensivo e neppure come saragrave nellrsquoOdissea un personaggio colto nella multiforme varietagrave delle sue peregrinazioni egrave invece una reazione emotiva (lrsquoira di Achille) con le sue conseguenze (le innumerevoli morti degli Achei) Narrare di questa ira significa per il poeta cominciare da un punto preciso (laquoda quandoraquo) ossia dal momento della contesa e della separazione fra i due massimi eroi greci Agamennone il primo per potere (laquosovrano di eroiraquo) e Achille il primo per nobiltagrave e forza (δῖος) E sintomatica della bipolaritagrave del mondo epico in quanto mondo di degravei e di eroi egrave la sincronia per cui il taglio della narrazione coincide col decorso del laquovolere di Zeusraquo (Διὸς βουλή) forse da identificare con la promessa del dio a Tetide (rievocata piugrave oltre in questo
22 V cap II laquoLa tradizione omericaraquo
Letteratura greca [1]
20
stesso canto ai vv 518-527) di vendicare lrsquoaffronto subito da Achille o piugrave in generale con il corso degli eventi in quanto tutto come per definizione laquogiace sulle ginocchia di Zeusraquo Opera indubbiamente allrsquointerno del poema unrsquoidea formativa un progetto di qui un insieme monumentale unificato anche da una serie di corrispondenze a distanza fra cui particolare significato acquistano quelle fra primo e ultimo canto Nel canto I il vecchio Crise va come supplice presso Agamennone portando doni e supplicando la restituzione della figlia e Agamennone lo respinge aspramente minacciandolo di far ricorso alla violenza se dovesse tornare nel canto XXIV il vecchio Priamo va come supplice presso Achille portando doni e supplicando la restituzione del corpo del figlio Achille ha una prima reazione irosa (esordisce al v 560 con laquoSmetti di irritarmi vecchioraquo) ma poi accoglie la supplica E al di lagrave delle corrispondenze nelle linee dellrsquoazione si colgono fra principio e fine del poema alcuni importanti echi verbali in particolare fra XXIV 501 s
τοῦ νῦν εἵνεχ᾽ ἱκάνω νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενος παρὰ σεῖο φέρω δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα per lui [Ettore] vengo ora alle navi degli Achei per riscattarlo da te e ti porto compenso infinito
e I 12 s
ὁ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενός τε θυγάτρα φέρων δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα costui [Crise] venne alle navi rapide degli Achei per riscattare la figlia portando compenso infinito
fra XXIV 555-557
λῦσον ἵν᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδωmiddot σὺ δὲ δέξαι ἄποινα πολλά τά τοι φέρομενmiddot σὺ δὲ τῶνδrsquo ἀπόναιο καὶ ἔλθοις σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν restituiscimelo percheacute lo possa vedere con gli occhi e accogli il riscatto copioso che portiamo e tu possa goderne e tornare alla tua terra patria
e I 18-20
Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν εὖ δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκέσθαιmiddot παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην τὰ δ᾽ ἄποινα δέχεσθαι Atridi e voi altri Achei dai forti schinieri a voi concedano gli degravei che hanno le case in Olimpo di distruggere la cittagrave di Priamo e tornare facilmente in patria ma restituitemi la figlia e accettate il riscatto
fra XXIV 560 μηκέτι νῦν μ᾽ ἐρέθιζε (laquosmetti di irritarmiraquo) e I 32 μή μ᾽ ἐρέθιζε (laquonon mi irritareraquo) fra XXIV 568-570
τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς μή σε γέρον οὐδrsquo αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω καὶ ἱκέτην περ ἐόντα Διὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμάς Ora perciograve fra i dolori non mi eccitare lrsquoanimo ancora di piugrave bada o vecchio che non ti lasci neppure nella tenda
Letteratura greca [1]
21
bencheacute supplice e violi gli ordini di Zeus e I 26-28
μή σε γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω ἢ νῦν δηθύνοντ᾽ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο Mai te o vecchio io colga presso le concave navi ora a indugiare o piugrave tardi a tornare che piugrave non dovesse giovarti lo scettro e la benda del dio
(e infine XXIV 571 ὣς ἔφατ ἔδεισεν δ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ laquocosigrave diceva e il vecchio tremograve e obbediva alle paroleraquo ripete esattamente I 33) In effetti lrsquoepisodio terminale del poema col superamento dellrsquoira ad opera della pietagrave e del senso di unrsquoesistenza invasa dal dolore si propone come il rovesciamento consapevole dellrsquoepisodio iniziale che era apparso caratterizzato dalla cancellazione della pietagrave e del diritto dei supplici in nome della forza Al rifiuto iniziale del donoriscatto si oppone lrsquoaccettazione finale in consonanza con un principio-guida che opera nel poema secondo linee che alla fine si riunificano Agamennone restituisce Criseide al padre ma si appropria del dono fatto dagli altri Achei ad Achille (Briseide) Achille respinge i doni fatti da Agamennone per indurlo a riconciliarsi con lui ma dopo aver contestato nel IX canto la nozione che la vita umana possa essere barattata con una massa di beni torna alla lotta non in cambio di qualche premio da conquistare ma per vendicare lrsquouccisione dellrsquoamico Patroclo e tanto nella lotta sul campo di battaglia quanto nellrsquoinfierire sul cadavere di Ettore si abbandona a un furore cosigrave smisurato e patologico che puograve essere superato solo con lrsquoaccettare i doni di Priamo non tuttavia per il loro valore drsquouso ma percheacute in Priamo Achille riconosce lrsquoombra del padre lontano Cosigrave lrsquoIliade appare attraversata da un impulso fondamentale che muove dallrsquoideologia del dono e dalla conseguente centralitagrave assegnata allrsquoonore (τιμή) come ldquoprezzordquo che qualifica il valore del guerriero ma supera questo piano di valutazione dei rapporti umani attraverso la loro riformulazione nei termini di un umanesimo esistenziale che ha come punti di riferimento lrsquoidentitagrave universale dei condizionamenti oggettivi (la vecchiaia la malattia la morte) e i legami che uniscono padre e figlio compagno e compagno vivi e morti (il cordoglio finale di Andromaca Ecuba ed Elena sulla salma di Ettore) Entro questo orizzonte progressivamente allargato la guerra le lotte lo scontro mortale finiscono col rappresentare solo un momento e un aspetto dellrsquoesistenza graditi tanto agli degravei che vi assistono come spettatori interessati quanto agli uditori che riascoltano le antiche gesta eppure non tali da appiattire il poema in una prospettiva guerresca conclusa in se stessa Molto del fascino delle battaglie e delle ἀριστεῖαι dellrsquoIliade sta nella presenza recondita di un occhio che sa guardare al di lagrave di esse (e al di lagrave della stessa distinzione fra Greci e Troiani vincitori e vinti) e che puograve anche attraverso le similitudini lasciare irrompere il mondo della natura o del lavoro umano nel mezzo delle battaglie LʼOdissea LrsquoOdissea (Ὀδύσσεια) consta di circa 12100 esametri divisi anchrsquoessi in 24 libri e indicati con le lettere minuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquoargomento egrave costituito dalle avventure di Odisseo dalla distruzione di Troia al ritorno alla patria Itaca esposte secondo un ordine che entrando subito nel vivo degli avvenimenti (lrsquoinizio del poema mostra Odisseo nellrsquoisola di Calipso) rievoca poi i fatti giagrave trascorsi e li ricongiunge infine a partire dal libro XV (con lrsquoarrivo di Telemaco alla capanna di Eumeo dove giagrave si trova Odisseo) in unrsquoazione unitaria La trama del poema i cui avvenimenti sono concentrati cronologicamente nello spazio di 40 giorni (ma sono narrati solo gli avvenimenti di 16 giorni e 8 notti) si articola in tre parti la laquoTelemachiaraquo (canti I-IV) il laquoRitorno di Odisseoraquo (canti V-XIII) e la laquoVendetta di Odisseoraquo (canti XIV-XXIV)
Letteratura greca [1]
22
Canto I Tutti gli eroi superstiti sono ormai tornati da Troia alle loro case tranne Odisseo che pur desideroso di tornare egrave trattenuto dalla ninfa Calipso nellrsquoisola di Ogigia Gli degravei hanno pietagrave di lui tranne Posidone irato per lrsquoaccecamento del figlio il ciclope Polifemo Ma un consiglio degli degravei assente Posidone (che si egrave recato presso gli Etiopi) delibera il ritorno dellrsquoeroe si decide che Ermes andragrave subito da Calipso mentre Atena si avvia verso Itaca sotto lrsquoaspetto del signore dei Tafi Mente per incoraggiare il figlio di Odisseo Telemaco a tener testa ai pretendenti della madre i laquoprociraquo (i quali aspirano al regno tramite le nozze con Penelope) e per indurlo a intraprendere un viaggio in cerca di notizie sul padre Canto IΙ Telemaco segue il consiglio della dea e il giorno seguente nellrsquoassemblea popolare chiede una nave per andare in cerca del padre ma la sua richiesta non viene discussa e Leocrito scioglie lrsquoassemblea Grazie ad Atena che ora ha assunto le sembianze di Mentore (antico amico di Odisseo) Telemaco riesce tuttavia a trovare una nave con cui salpa nel corso della notte allrsquoinsaputa sia della madre che dei proci Canto IΙΙ Telemaco e MentoreAtena arrivano a Pilo e sul lido trovano Nestore che sta offrendo un sacrificio a Posidone Il vecchio eroe accoglie ospitalmente Telemaco e gli comunica molte notizie sul ritorno di altri Achei ma nessuna su Odisseo Alla sera Atena scompare in forma di aquila e il mattino seguente Telemaco salpa insieme con Pisistrato (figlio di Nestore) alla volta di Sparta dove arriva la sera del giorno successivo Canto IV A Sparta Menelao sta festeggiando il doppio matrimonio del figlio e della figlia Il giorno seguente Telemaco chiede del padre Menelao gli racconta il proprio ritorno durante il quale aveva incontrato Proteo il vecchio nume marino che gli aveva riferito come Odisseo fosse trattenuto nellrsquoisola di Calipso Intanto a Itaca i proci preparano insidie meditando di uccidere Telemaco al suo ritorno Penelope ne viene a conoscenza ma Atena le appare in sogno per confortarla Canto V Dopo un secondo concilio degli degravei (in effetti un ldquodoppionerdquo di quello del I canto) Zeus manda finalmente Ermes presso Calipso con lrsquoordine di lasciar partire Odisseo La ninfa aiuta lrsquoeroe a costruirsi una zattera Al diciottesimo giorno di navigazione Odisseo egrave in vista dellrsquoisola dei Feaci Scheria quando Posidone di ritorno dal suo soggiorno presso gli Etiopi lo vede e suscita una tempesta che distrugge la zattera Ma la dea marina Ino Leucotea impietositasi gli porge il proprio velo sostenuto dal quale lrsquoeroe giunge a nuoto alla riva di Scheria dove si abbandona esausto addormentandosi Canto VI In seguito a un sogno inviatole da Atena Nausicaa la figlia del re dei Feaci Alcinoo si reca nei pressi della spiaggia a lavare le vesti insieme con le ancelle Odisseo risvegliatosi atterrisce le fanciulle che fuggono tutte allrsquoinfuori di Nausicaa Lrsquoeroe supplica la giovane di porgerle aiuto ed ella lo fa rivestire e lo accompagna fino al bosco di Atena poco prima della cittagrave esortandolo a presentarsi a suo padre Canto VII Protetto dalla nebbia di cui Atena lo ha avvolto Odisseo entra nel palazzo abbraccia le ginocchia della regina Arete e la caligine scompare poi viene accolto con onore da Alcinoo Arete chiede a Odisseo donde provenga e chi gli abbia donato gli abiti (a lei ben noti) che indossa Lrsquoeroe inizia a raccontare le disavventure che gli sono occorse dopo la
Letteratura greca [1]
23
partenza dallrsquoisola di Calipso Alcinoo gli promette di farlo ricondurre a Itaca il giorno seguente Canto VIII Ma lrsquoindomani Alcinoo fa apprestare un banchetto durante il quale lrsquoaedo Demodoco canta della contesa insorta un giorno fra Achille e Odisseo Lrsquoeroe si copre il volto per nascondere le lacrime allora Alcinoo interrompe il canto e organizza una serie di gare nel corso delle quali Odisseo primeggia Poi Demodoco al margine di unrsquoarea per la danza dove si esibiscono i ballerini feaci canta gli amori di Ares e Afrodite e la vendetta di Efesto (che incatena i due amanti) La sera al ritorno nel palazzo Demodoco racconta la storia del Cavallo di legno Odisseo scoppia nuovamente in lacrime e Alcinoo gli chiede di rivelare il suo nome Canto IX Odisseo dichiara il proprio nome e dagrave inizio al racconto della propria storia a partire dalla caduta di Troia distruzione di Ismaro e perdite subite ad opera dei Ciconi sbarco presso i Lotofagi (che si nutrono di un cibo misterioso che fa dimenticare il ritorno) dopo una terribile tempesta scatenatasi durante il tentativo di doppiare il capo Malea arrivo allrsquoisola antistante quella dei Ciclopi dove Odisseo si trasferisce con una sola nave esplorazione dellrsquoisola perdita di alcuni compagni allrsquointerno della caverna del gigante monocolo accecamento del mostro e fuga Canto X Odisseo giunge allrsquoisola di Eolo signore dei venti che lo accoglie benevolmente e gli consegna alla partenza tutti i venti chiusi in un otre ma poi lo respinge con durezza quando ritorna presso di lui percheacute i compagni (sospettando che nellrsquootre siano racchiuse cospicue ricchezze) hanno sciolto i venti e da essi si egrave sprigionato un uragano che li ha risospinti sullrsquoisola Ripreso il mare Odisseo egrave trasportato fino ai Lestrigoni antropofagi il cui attacco priva lrsquoeroe di tutte le altre navi tranne la propria Con questa fugge fino allrsquoisola (Eea) della maga Circe Dopo che Circe ha trasformato in porci un gruppo di compagni mandati innanzi ad esplorare lrsquoisola Odisseo ha la meglio sulla maga (a cui impone di restituire forma umana ai compagni) grazie allrsquoerba moly fornitagli da Ermes Resta un anno presso Circe che al momento della partenza gli consiglia di recarsi al paese dei morti per interrogare il vate Tiresia Canto XI Approdato alla terra dei Cimmeri (che vivono immersi in una nebbia perenne sulla riva dellrsquoOceano) e scavata una fossa Odisseo sacrifica ai morti e immola una vittima speciale a Tiresia Le anime accorrono dapprima Elpenore caduto per caso giugrave dal tetto della casa di Circe (Odisseo gli promette sepoltura) poi la madre Anticlea (che gli racconta di esser morta di dolore per la sua assenza) quindi Tiresia che gli vaticina le sue vicende future fino alla morte (questa lo coglieragrave dopo una lunga vita in un paese straniero che non conosce neacute il sale neacute il remo) Da un certo punto in poi il poeta dimentica il presupposto per cui Odisseo aveva scavato una fossa alla quale i morti accorrevano per bere il sangue delle vittime e bevendolo riacquistavano per breve tempo una piena consapevolezza immagina invece che Odisseo sia allrsquointerno dellrsquoAde In questa sezione rientrano la descrizione di Aiace sdegnato di Minosse di Orione dei grandi peccatori di Eracle Poi Odisseo fa ritorno a Eea e ricevuti i consigli di Circe si imbarca per il ritorno in patria Canto XII Scampato alle Sirene che invano lo attirano col canto (si egrave fatto legare allrsquoalbero della nave i compagni che remano hanno le orecchie turate con la cera) passa tra Cariddi e Scilla (che gli rapisce sei uomini) ed egrave costretto dai compagni ad approdare in contrasto con le prescrizioni di Circe allrsquoisola Trinachia dove pascolano le greggi del Sole I
Letteratura greca [1]
24
compagni spronati da Euriloco se ne cibano nonostante il divieto dellrsquoeroe Il Sole sdegnato ottiene da Zeus che la nave sia colpita dal fulmine Tutti i compagni periscono ma Odisseo che ripassa tra Scilla e Cariddi si salva miracolosamente da questrsquoultima aggrappandosi a un fico selvatico fincheacute il gorgo restituisce i rottami della nave infine arriva remando con le mani allrsquoisola di Ogigia Canto XIII Terminato il racconto lrsquoeroe riceve doni dai Feaci e la notte seguente egrave ricondotto a Itaca e deposto addormentato sulla spiaggia presso un antro sacro alle Ninfe Al risveglio per la nebbia non riconosce la sua terra fincheacute Atena in veste di giovane pastore lo rassicura e poi rivelatasi gli dagrave istruzioni su come far strage dei proci e lo trasforma in un vecchio mendico Canto XIV Odisseo si reca allo stazzo del suo porcaio Eumeo che pur non riconoscendolo lo accoglie ospitalmente rifocillandolo e offrendogli un mantello per ripararsi dal gelo notturno Canto XV A questo punto la laquoTelemachiaraquo si riannoda allrsquoazione principale Telemaco che si trova ancora a Sparta viene indotto da Atena a tornare a Itaca sulla via del ritorno a Pilo accoglie a bordo lrsquoindovino Teoclimeno e grazie allrsquoaiuto della dea sfugge alle insidie dei proci sbarca a Itaca e si reca anchrsquoegli presso Eumeo Canto XVI Questi va da Penelope ad annunciargli il ritorno del figlio Intanto Odisseo rimosso lrsquoincantesimo si svela nel suo vero aspetto a Telemaco e con lui progetta la vendetta sui proci (che intanto tramano una nuova insidia ai danni di Telemaco) Eumeo torna al suo stazzo Canto XVII Il mattino seguente Telemaco si reca in cittagrave seguito in un secondo tempo da Eumeo e Odisseo (che ha riassunto lrsquoaspetto di mendico) Davanti al palazzo Odisseo egrave riconosciuto dal cane Argo Entra e va mendicando tra i proci Antinoo lo colpisce alla spalla destra con uno sgabello Canto XVIII Odisseo si batte al pugilato col mendicante Iro Penelope scesa nella sala prospetta ai proci lrsquoeventualitagrave di un nuovo matrimonio Odisseo egrave insultato dalla schiava Melanto e schiva uno sgabello scagliato da Eurinomo Canto XIX Insieme con Telemaco lrsquoeroe allontana le armi dalla sala poi conversa con Penelope che gli racconta un sogno e gli espone il suo piano per sedare le contese tra i proci concedendosi sposa a colui che riusciragrave a tendere lrsquoarco di Odisseo la prova avverragrave il giorno seguente al novilunio Durante il colloquio la fida schiava Euriclea lava i piedi di Odisseo e riconosciutolo da unrsquoantica cicatrice sta per rivelarne lrsquoidentitagrave ma lrsquoeroe la costringe a tacere Canto XX Al mattino Euriclea e le ancelle fanno i preparativi per il banchetto Giungono Eumeo Melanzio e il mandriano Filezio Un presagio mandato da Zeus dissuade i proci dal progetto di uccidere Telemaco Durante il banchetto Teoclimeno predice la loro imminente rovina
Letteratura greca [1]
25
Canto XXI Penelope conduce lrsquoarco nella sala dopo che parecchi fra i proci e lo stesso Telemaco hanno tentato invano di tenderne la corda Odisseo chiede di partecipare alla prova tende lrsquoarco senza fatica e riesce a far passare la freccia attraverso gli anelli di dodici scuri predisposte da Telemaco Canto XXII Poi scaglia le frecce sui proci e si rivela nella sua identitagrave Nella lotta che segue Telemaco Eumeo e Filezio aiutano il padrone contro i proci (appoggiati dal capraio Melanzio) Tutti i proci restano uccisi le ancelle infedeli sono impiccate Melanzio viene mutilato e ucciso soltanto lrsquoaedo Femio e lrsquoaraldo Medonte sono risparmiati Canto XXIII Nuovo colloquio fra Odisseo e Penelope che durante lrsquoeccidio dormiva ed egrave stata svegliata da Euriclea Penelope esita ancora a riconoscere il marito e non si arrende alla veritagrave fincheacute Odisseo non le descrive la posizione e la struttura del letto coniugale Canto XXIV Ermes conduce allrsquoAde le ombre dei proci Odisseo fa visita al padre Laerte nella masseria dove quello vive nello squallore e nellrsquoemarginazione e si fa riconoscere Intanto il padre di Antinoo incita gli Itacesi alla rivolta e il poema si conclude con lo scontro di Odisseo e dei suoi contro i concittadini lrsquoeroe ha la meglio e Zeus scagliato il fulmine pone fine alla battaglia Atena sotto lrsquoaspetto di Mentore stabilisce fra i contendenti un patto per il futuro36
Struttura e caratteri dellʼopera Giagrave la prima parola del proemio (ἄνδρα) non menziona come tema dellrsquoopera un determinato episodio della vita del protagonista ma il protagonista stesso (I 1-10)
Ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα πολύτροπον ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεmiddot πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περmiddot αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο νήπιοι οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιονmiddot αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ τῶν ἁμόθεν γε θεά θύγατερ Διός εἰπὲ καὶ ἡμῖν Dellrsquouomo multiforme a me racconta o Musa che molto errograve dopo che di Troia la sacra rocca distrusse di molti uomini vide le cittagrave riconobbe il pensiero e molti per il mare patigrave dolori nellrsquoanimo per salvare la sua vita e il ritorno dei compagni Eppure non li salvograve i compagni per quanto bramasse per la loro stessa follia si persero gli stolti i buoi del Sole Iperione mangiarono e quello rapigrave ad essi il digrave del ritorno Di questo da un punto qualsiasi narra anche a noi o dea figlia di Zeus
Storie favolose di naviganti racconti imperniati sul ritorno dei guerrieri achei che avevano combattuto a Troia e il particolare rientro in patria di Odisseo figlio di Laerte erano forse giagrave stati connessi e intrecciati nella precedente tradizione epica sigrave che il presente cantore poteva
Letteratura greca [1]
26
metter mano alla vicenda partendo (v 10) laquoda un punto qualsiasiraquo (ἁμόθεν) una notazione che certo presuppone la convenzione propria dellrsquoesordio tradizionale di un canto epico comparabile con i giagrave ricordati ἐξ οὗ (laquoda quandoraquo) di Iliade I 4 ed ἔνθεν (laquoda doveraquo) di Odissea VIII 500 Senoncheacute rispetto a queste indicazioni di tipo puntuale il tratto costituito dalla dimensione casuale quasi arbitraria inerente ad ἁμόθεν proprio mentre dichiara lrsquoassenza di un determinato piano compositivo implica in realtagrave che il racconto non si svolgeragrave per filo e per segno secondo lrsquoordine noto a poeta e uditori non si snoderagrave κατὰ κόσμον (laquoper ordineraquo) come il canto di Demodoco (VIII 489) ma seguiragrave un andamento originale Il ldquopunto qualsiasirdquo incipitario non rappresenta una scelta della Musa (figura dellrsquoarchivio tematico che conserva le laquovieraquo dellrsquoepica) bensigrave di questo cantore che ha deciso di far incominciare la narrazione in medias res e ha in serbo la sorpresa di far succedere al concilio degli degravei (che decide lrsquoinvio di Ermes presso Calipso) non lrsquoazione testeacute programmata (azione che viene differita con un ritardo che a piugrave riprese ha scandalizzato i lettori a principio del V canto) ma la partenza di Atena alla volta di Itaca e lrsquoavvio della laquoTelemachiaraquo Le due diverse vicende proposte a principio del poema quella di Telemaco e quella di Odisseo procedono infatti in parallelo coprendo un analogo lasso di tempo Piugrave oltre la decisione di trasformare la sequenza narrativa che va dalla partenza di Odisseo da Troia fino al suo arrivo nella terra dei Feaci in una rievocazione fatta dallrsquoeroe in prima persona al cospetto di Alcinoo e dei Feaci (la sezione detta degli ἀπόλογοι laquoraccontiraquo) crea una struttura ad anello che parte dal presente e ad esso fa ritorno dopo aver ricostruito le premesse della condizione attuale del protagonista Col canto XIII Odisseo egrave riportato dai Feaci a Itaca e questo permette la saldatura fra le vicende sue e quelle di Telemaco sia pure col differimento dellrsquoincontro e del riconoscimento fra padre e figlio fino al canto XVI Far scorrere in parallelo sequenze distinte organizzare programmi narrativi a corta e a lunga gittata tendere o allentare ad arte il ritmo della narrazione non si tratta davvero di procedimenti che potessero configurarsi come tradizionali dellrsquoarte epica quanto piuttosto di un momento sperimentale di una ricerca di soluzioni nuove al termine di una lunga e ormai consolidata sedimentazione di percorsi compiuti allrsquointerno di un determinato repertorio tematico unrsquoaudacia inventiva una πολυτροπίη degne del protagonista del poema che inevitabilmente comportavano rischi molteplici di incoerenze dissonanze occasionali avarie della macchina epica e che tuttavia erano destinate a conseguire un risultato assolutamente convincente allrsquoorecchio di chi si abbandonasse al fascino del racconto senza lrsquourgenza propria di altre etagrave e di altre mentalitagrave di puntare il dito sui singoli dettagli o le singole sfasature
PER SAPERNE DI PIUrsquo Difficoltagrave e incongruenze della narrazione omerica Forti della possibilitagrave di un controllo su un testo scritto che possiamo percorrere in avanti e a ritroso secondo ritmi di nostra scelta a noi non riesce difficile cogliere alcune delle difficoltagrave organizzative incontrate nella composizione del poema In proposito per ricordare un caso che saragrave allrsquoorigine delle discussioni di orientamento ldquoanaliticordquo intorno allrsquoOdissea possiamo leggere il discorso che Atena prese le sembianze di Mente re dei Tafi rivolge a Telemaco nel I canto (vv 253-305) Ah infelice ti manca molto davvero lrsquoassente Odisseo che getti le mani addosso ai pretendenti sfrontati Percheacute se ora tornato stesse sulla soglia 255 con una scure lo scudo e due lance cosigrave come io per la prima volta lo vidi in casa nostra che beveva e godeva di ritorno da Efira da Ilo di Mermero (andograve anche ligrave Odisseo con la nave veloce 260 in cerca del veleno omicida per averne da ungere le frecce di bronzo ma quello non glielo diede percheacute temeva gli dei che vivono eterni
Letteratura greca [1]
27
glielo diede invece mio padre percheacute lrsquoamava moltissimo) se stesse Odisseo tra i pretendenti cosigrave 265 essi avrebbero tutti rapida morte e nozze amare Ma sulle ginocchia degli dei questo giace se una volta tornato faragrave o no vendetta nella sua casa te invece io esorto a riflettere come cacciare i pretendenti da casa 270 Ebbene ora ascolta e alle mie parole darsquo retta Domattina chiamati gli eroi Achei a consiglio rivolgi a tutti un discorso e siano testimoni gli dei Ai pretendenti comanda drsquoandarsene per i fatti loro e tua madre se lrsquoanimo la spinge alle nozze 275 ritorni a casa del padre molto potente Prepareranno essi le nozze e disporranno i doni nuziali moltissimi quanti gli pare che debbano andare alla figlia A te darograve un saggio consiglio se vuoi ascoltarlo armata una nave con venti remi la migliore che crsquoegrave 280 Varsquo a domandare del padre partito da tempo se mai te ne parli un mortale o sentissi da Zeus la voce che divulga la fama tra gli uomini Anzitutto varsquo a Pilo e interroga il chiaro Nestore di ligrave poi varsquo a Sparta dal biondo Menelao 285 degli Achei vestiti di bronzo egli egrave tornato per ultimo Se senti dire qualcosa sulla vita e il ritorno del padre per quanto stremato potresti sopportare un altro anno se invece senti dire che egrave morto e non vive allora tornato nella cara terra patria 290 ergigli un tumulo e offrigli funebri offerte moltissime quanto conviene e darsquo tua madre a un marito E poi dopo aver compiuto e fatto ogni cosa allora medita nella mente e nellrsquoanimo come tu possa uccidere nelle tue case 295 i pretendenti con lrsquoinganno affrontandoli non devi piugrave avere i modi di un bimbo percheacute ormai non sei tale Non senti lrsquoillustre Oreste quale gloria ha acquistato fra tutti gli uomini percheacute uccise lrsquoassassino del padre Egisto esperto di inganni che gli uccise il nobile padre 300 Anche tu caro infatti molto bello e grande ti vedo sii valoroso percheacute ti lodi anche qualcuno dei posteri Ma io tornerograve adesso alla nave veloce dai compagni che forse impazienti mi aspettano Tu devi pensarci da te dammi retta 305
[Tr di GA Privitera] Le stranezze non mancano davvero e cosigrave sono state messe a fuoco da Stephanie West nel suo commento23 1 Atena sa evidentemente molto piugrave di quanto uno come Mente avrebbe potuto sapere in particolare ella sa che i proci ignoreranno lrsquoinvito di Telemaco a lasciare la sua casa e fatto piugrave importante che gli degravei tra breve ricondurranno in patria Odisseo A queste osservazioni si puograve replicare con la stessa West che laquosi sono esagerate difficoltagrave e
23 Omero Odissea I cit 219 ss
Letteratura greca [1]
28
incongruenze alle quali un pubblico di ascoltatori (o anche un lettore moderatamente attento) probabilmente non farebbe casoraquo 2 Il progetto di una pubblica denuncia dei proci dinanzi agli degravei e agli uomini ai vv 273-274 egrave ciograve che Atena sembra prefiggersi nel promuovere lrsquoassemblea degli Itacesi (assemblea che effettivamente avragrave luogo a principio del canto II) drsquoaltra parte le successive istruzioni di AtenaMente ai vv 295 s (medita come uccidere i pretendenti) presuppongono che di quella richiesta da formulare nel corso dellrsquoassembla essi non terranno alcun conto Anche a questa osservazione si puograve rispondere che laquoegrave ragionevole attendersi che Telemaco condivida la previsione di un esito negativo della sua iniziativaraquo e si puograve aggiungere che pure in caso di insuccesso il ricorso allrsquoassemblea potrebbe ottenere almeno il risultato di screditare i pretendenti presso la comunitagrave itacese legittimando un successivo ricorso alla violenza (e si tratta di una legittimazione di cui anche lrsquoultimo canto mostreragrave lrsquoesigenza) 3 Dopo che Telemaco aveva detto che la madre non intendeva risposarsi (vv 249-250) AtenaMente si esprime ai vv 275-278 come se Penelope desiderasse proprio nuove nozze e inoltre sarebbe assurdo che il padre di Penelope cominciasse a contrattare un secondo matrimonio prima del ritorno di Telemaco dal suo viaggio e che mettesse mano a preparativi che rischierebbero di essere annullati qualche tempo dopo con inevitabile imbarazzo se Telemaco venisse a sapere che Odisseo egrave ancora vivo In piugrave lrsquoandamento sintattico di questi versi presenta un anacoluto durissimo per cui a principio del v 275 lrsquoaccusativo μητέρα egrave seguito da un ἂψ ἴτω (laquovada indietroraquo laquotorniraquo) che richiederebbe come soggetto un nominativo μήτηρ Come hanno reagito i lettori di Omero Nellrsquoantichitagrave un grammatico rimasto anonimo cambiava come attesta uno scolio μητέρ᾽ in μήτηρ nel secolo XVIII Richard Bentley modificava ἴτω in ἴμεν (infinito eolico di εἶμι laquovadoraquo) nel XIX un altro grande della filologia europea Gottfried Hermann risolveva piugrave drasticamente la questione eliminando il complesso dei vv 275-278 e la stessa West mostra simpatia per tale proposta supponendo laquounrsquoaggiunta posteriore modellata sul corrispondente passo del libro IIraquo (dove i vv 196 s sono identici ai vv 277 s e il v 195 copre lo stesso contenuto dei vv 275 s) Si tratta di procedimenti adeguati ai dati di fatto Migliorano davvero il testo che ci egrave stato tramandato In realtagrave ambedue le ldquocorrezionirdquo appena ricordate (di μήτερ᾽ e di ἴτω) ottengono un risultato tanto lineare che egrave davvero difficile pensare che lrsquoanacoluto avrebbe potuto invadere tutta la tradizione se non fosse stato originario e quanto allrsquoespunzione dei vv 275-278 essa indubbiamente peggiorerebbe il ritmo del discorso determinando lrsquoavvicinamento fra i due versi (v 271 e v 279) molto simili fra loro che aprono le due sequenze occupate dai consigli di Mente E allora La via piugrave saggia egrave senzrsquoaltro quella di tenerci qui come quasi sempre di fronte al testo omerico contraddizioni e anacoluti riconoscendo in essi lrsquoeffetto dellrsquoattivitagrave di un cantore che pur sulla base di una traccia largamente memorizzata restava pur sempre legato a quella prassi orale per cui composizione ed esecuzione tendevano a coincidere E lrsquoanacoluto si spiega bene se cerchiamo di immedesimarci nel procedimento seguito dal poeta Egli ha affidato ad Atena un certo flusso argomentativo per cui la dea deve dar consigli a Telemaco sui suoi rapporti coi proci e con la madre e cosigrave colloca in fine di v 274 un ἄνωχθι (laquoordinaraquo) destinato a reggere gli accusativi simmetricamente dislocati in principio di verso (vv 274 e 275) μνηστῆρας e μητέρα Senoncheacute giunto a questa seconda parte dellrsquoargomentazione egli si avvede quanto sarebbe illogico che Telemaco sollecitasse la madre a nuove nozze di qui lrsquoimprovviso cambio di costruzione che svincola al prezzo di una sensibile slogatura sintattica lrsquoipotesi delle nuove nozze dallrsquoordine impartito a Telemaco e la prospetta invece come un desiderio eventuale della stessa Penelope Il poeta ha un progetto ben meditato brani e sequenze piugrave volte sperimentati ed egrave col supporto di questi materiali giagrave elaborati che egli si fa strada attraverso le insidie della
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
18
riparatori [T10] Achille si lascia convincere a stento ad attendere che i soldati abbiano mangiato Poi gli armati si radunano e anche Achille si arma Il suo cavallo Xanto gli predice la prossima morte [T11] Canto XX Zeus consente agli degravei di partecipare alla nuova battaglia Enea scontratosi con Achille egrave tratto in salvo da Posidone Achille infuria come un incendio in una selva Canto XXI Achille colma di cadaveri il fiume Scamandro e cattura dodici giovani troiani che intende offrire in sacrificio a Patroclo non risparmia neppure Licaone figlio di Priamo che lo supplica con accenti di grande intensitagrave ma altrettanto intensa nella consapevolezza di un destino imminente egrave la pur spietata replica del Pelide [T12] Lo Scamandro solleva le proprie onde ma le fiamme di Efesto inaridiscono il terreno e domano la corrente Gli degravei si azzuffano Atena raggiunge Ares con una pietra Era rintuzza la furia di Artemide Infine tutti tornano sullrsquoOlimpo Apollo assunto lrsquoaspetto di Agenore respinge Achille percheacute i Troiani possano rifugiarsi allrsquointerno delle mura Canto XXII Il solo Ettore resta fuori nella pianura Invano Priamo ed Ecuba lo pregano di rientrare Mentre Achille si avvicina Ettore decide di affrontarlo ma quando quello gli egrave da presso col bronzo che gli lampeggia intorno laquosimile al raggio del fuoco ardente o del sole che sorgeraquo egrave afferrato dal panico e comincia a fuggire compiendo tre giri intorno alle mura Zeus pesa sulla bilancia i destini (le κῆρες) dei due eroi e quello di Ettore affonda in basso Allora Apollo lo abbandona e Atena apparsa a Ettore sotto le spoglie di suo fratello Deifobo gli si avvicina promettendogli aiuto e invece riporta ad Achille la lancia che gli era caduta fuori bersaglio Il colpo di risposta di Ettore rimbalza sullo scudo di Achille Ettore urla a Deifobo di passargli la sua lancia ma il falso Deifobo egrave scomparso ed Ettore comprende di trovarsi sullrsquoorlo dellrsquoabisso [T13] Achille gli trapassa la gola ed Ettore lo supplica di non oltraggiare la sua salma in risposta riceve la minaccia che finiragrave in pasto ai cani Achille trascina il cadavere alle navi attaccato al carro Priamo Ecuba e Andromaca si abbandonano al cordoglio a cui fanno eco le donne troiane Canto XXIII Viene preparato il banchetto funebre in onore di Patroclo la cui ombra nel corso della notte appare ad Achille chiedendo la sepoltura del corpo Il mattino seguente si appresta il rogo fra le offerte votive ci sono anche dodici giovani troiani Il giorno successivo si raccolgono le ossa di Patroclo Seguono i ludi funebri gare coi carri e con lrsquoarco duello in armi etc Canto XXIV Ogni giorno Achille trascina il cadavere di Ettore attorno alla tomba dellrsquoamico ma lo spettacolo offende gli degravei e al dodicesimo giorno Zeus decide di mandare Tetide percheacute induca suo figlio a restituire la salma di Ettore Iride viene inviata presso Priamo percheacute gli consigli di recarsi nel cuore della notte con un carro da trasporto e un copioso riscatto scortato da Ermes alla tenda di Achille Questi accoglie il vecchio con rispetto riconoscendo in lui lrsquoimmagine del padre lontano e si piega alla sua supplica [T14] Per volontagrave degli degravei il cadavere non egrave stato aggredito dalla putrefazione composto sul pianale del carro viene ricondotto dal padre a Troia Qui le lamentazioni rituali srsquoinnalzano dal gruppo delle donne (Andromaca Ecuba Elena) Si stipula una tregua di dodici giorni Per nove giorni i Troiani raccolgono legname poi anche il rogo di Ettore arde e si erige un tumulo
Letteratura greca [1]
19
Struttura e caratteri dellʼopera Poema di trama relativamente organica (soprattutto a partire dal canto XVI tutti gli avvenimenti tranne pochi episodi isolati ruotano attorno ai due principali antagonisti Ettore uccide Patroclo per vendicare Sarpedone e Achille uccide Ettore per vendicare Patroclo) pur se non privo di piugrave o meno cospicue incongruenze spiegabili in primo luogo con la lunga e complessa genesi orale dellrsquoopera lrsquoIliade lascia emergere in mezzo alle centinaia di nomi e alle intricate vicende alcuni caratteri delineati nella loro individualitagrave e innanzi tutto quelli di Achille e di Ettore accomunati dalla medesima coscienza di un destino di morte che sono pronti ad affrontare Appunto una tale attitudine a rappresentare i laquocaratteriraquo (ἤθη) dei suoi personaggi egrave un altro titolo di merito che Aristotele ascrive ad Omero (Poetica 1460a9-11)
dopo aver brevemente proemiato subito introduce un uomo una donna o un altro personaggio nessuno privo di caratterizzazione ma dotato di un carattere
Fondamentale per la struttura del poema egrave la novitagrave della prospettiva Possiamo presumere che i cosiddetti poemi ciclici22 mirassero a conservare lrsquoangolatura che era stata propria delle versioni pre-omeriche della saga troiana sigrave che puograve riuscire significativo il confronto fra lrsquoesordio della Piccola Iliade (dove muovendo da grandi entitagrave ndash la cittagrave il paese due popoli la guerra ndash viene lanciato secondo lrsquoespressione di J Latacz come laquouno sguardo dallrsquoesternoraquo)
Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην εὔπωλον ἧς πέρι πολλὰ πάθον Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος Canto Ilio e la terra dei Dardani dai bei puledri per la quale molti dolori patirono i Danai servitori di Ares
con lo laquosguardo internoraquo che caratterizza lrsquoinizio dellrsquoIliade
Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν ἡρώων αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν οἰωνοῖσί τε δαῖτα Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς Canta o dea di Achille figlio di Peleo la collera maledetta che pene innumerevoli inflisse agli Achei e molte scagliograve allrsquoAde vite possenti di eroi e ne faceva prede per i cani e pasto per gli uccelli e si avverava il volere di Zeus da quando primamente si separarono venuti a contesa LrsquoAtride sovrano di eroi e Achille magnifico
Argomento non egrave dunque come doveva avvenire nella tradizione del canto epico un evento complesso da inquadrare con un grandangolo onnicomprensivo e neppure come saragrave nellrsquoOdissea un personaggio colto nella multiforme varietagrave delle sue peregrinazioni egrave invece una reazione emotiva (lrsquoira di Achille) con le sue conseguenze (le innumerevoli morti degli Achei) Narrare di questa ira significa per il poeta cominciare da un punto preciso (laquoda quandoraquo) ossia dal momento della contesa e della separazione fra i due massimi eroi greci Agamennone il primo per potere (laquosovrano di eroiraquo) e Achille il primo per nobiltagrave e forza (δῖος) E sintomatica della bipolaritagrave del mondo epico in quanto mondo di degravei e di eroi egrave la sincronia per cui il taglio della narrazione coincide col decorso del laquovolere di Zeusraquo (Διὸς βουλή) forse da identificare con la promessa del dio a Tetide (rievocata piugrave oltre in questo
22 V cap II laquoLa tradizione omericaraquo
Letteratura greca [1]
20
stesso canto ai vv 518-527) di vendicare lrsquoaffronto subito da Achille o piugrave in generale con il corso degli eventi in quanto tutto come per definizione laquogiace sulle ginocchia di Zeusraquo Opera indubbiamente allrsquointerno del poema unrsquoidea formativa un progetto di qui un insieme monumentale unificato anche da una serie di corrispondenze a distanza fra cui particolare significato acquistano quelle fra primo e ultimo canto Nel canto I il vecchio Crise va come supplice presso Agamennone portando doni e supplicando la restituzione della figlia e Agamennone lo respinge aspramente minacciandolo di far ricorso alla violenza se dovesse tornare nel canto XXIV il vecchio Priamo va come supplice presso Achille portando doni e supplicando la restituzione del corpo del figlio Achille ha una prima reazione irosa (esordisce al v 560 con laquoSmetti di irritarmi vecchioraquo) ma poi accoglie la supplica E al di lagrave delle corrispondenze nelle linee dellrsquoazione si colgono fra principio e fine del poema alcuni importanti echi verbali in particolare fra XXIV 501 s
τοῦ νῦν εἵνεχ᾽ ἱκάνω νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενος παρὰ σεῖο φέρω δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα per lui [Ettore] vengo ora alle navi degli Achei per riscattarlo da te e ti porto compenso infinito
e I 12 s
ὁ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενός τε θυγάτρα φέρων δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα costui [Crise] venne alle navi rapide degli Achei per riscattare la figlia portando compenso infinito
fra XXIV 555-557
λῦσον ἵν᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδωmiddot σὺ δὲ δέξαι ἄποινα πολλά τά τοι φέρομενmiddot σὺ δὲ τῶνδrsquo ἀπόναιο καὶ ἔλθοις σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν restituiscimelo percheacute lo possa vedere con gli occhi e accogli il riscatto copioso che portiamo e tu possa goderne e tornare alla tua terra patria
e I 18-20
Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν εὖ δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκέσθαιmiddot παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην τὰ δ᾽ ἄποινα δέχεσθαι Atridi e voi altri Achei dai forti schinieri a voi concedano gli degravei che hanno le case in Olimpo di distruggere la cittagrave di Priamo e tornare facilmente in patria ma restituitemi la figlia e accettate il riscatto
fra XXIV 560 μηκέτι νῦν μ᾽ ἐρέθιζε (laquosmetti di irritarmiraquo) e I 32 μή μ᾽ ἐρέθιζε (laquonon mi irritareraquo) fra XXIV 568-570
τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς μή σε γέρον οὐδrsquo αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω καὶ ἱκέτην περ ἐόντα Διὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμάς Ora perciograve fra i dolori non mi eccitare lrsquoanimo ancora di piugrave bada o vecchio che non ti lasci neppure nella tenda
Letteratura greca [1]
21
bencheacute supplice e violi gli ordini di Zeus e I 26-28
μή σε γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω ἢ νῦν δηθύνοντ᾽ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο Mai te o vecchio io colga presso le concave navi ora a indugiare o piugrave tardi a tornare che piugrave non dovesse giovarti lo scettro e la benda del dio
(e infine XXIV 571 ὣς ἔφατ ἔδεισεν δ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ laquocosigrave diceva e il vecchio tremograve e obbediva alle paroleraquo ripete esattamente I 33) In effetti lrsquoepisodio terminale del poema col superamento dellrsquoira ad opera della pietagrave e del senso di unrsquoesistenza invasa dal dolore si propone come il rovesciamento consapevole dellrsquoepisodio iniziale che era apparso caratterizzato dalla cancellazione della pietagrave e del diritto dei supplici in nome della forza Al rifiuto iniziale del donoriscatto si oppone lrsquoaccettazione finale in consonanza con un principio-guida che opera nel poema secondo linee che alla fine si riunificano Agamennone restituisce Criseide al padre ma si appropria del dono fatto dagli altri Achei ad Achille (Briseide) Achille respinge i doni fatti da Agamennone per indurlo a riconciliarsi con lui ma dopo aver contestato nel IX canto la nozione che la vita umana possa essere barattata con una massa di beni torna alla lotta non in cambio di qualche premio da conquistare ma per vendicare lrsquouccisione dellrsquoamico Patroclo e tanto nella lotta sul campo di battaglia quanto nellrsquoinfierire sul cadavere di Ettore si abbandona a un furore cosigrave smisurato e patologico che puograve essere superato solo con lrsquoaccettare i doni di Priamo non tuttavia per il loro valore drsquouso ma percheacute in Priamo Achille riconosce lrsquoombra del padre lontano Cosigrave lrsquoIliade appare attraversata da un impulso fondamentale che muove dallrsquoideologia del dono e dalla conseguente centralitagrave assegnata allrsquoonore (τιμή) come ldquoprezzordquo che qualifica il valore del guerriero ma supera questo piano di valutazione dei rapporti umani attraverso la loro riformulazione nei termini di un umanesimo esistenziale che ha come punti di riferimento lrsquoidentitagrave universale dei condizionamenti oggettivi (la vecchiaia la malattia la morte) e i legami che uniscono padre e figlio compagno e compagno vivi e morti (il cordoglio finale di Andromaca Ecuba ed Elena sulla salma di Ettore) Entro questo orizzonte progressivamente allargato la guerra le lotte lo scontro mortale finiscono col rappresentare solo un momento e un aspetto dellrsquoesistenza graditi tanto agli degravei che vi assistono come spettatori interessati quanto agli uditori che riascoltano le antiche gesta eppure non tali da appiattire il poema in una prospettiva guerresca conclusa in se stessa Molto del fascino delle battaglie e delle ἀριστεῖαι dellrsquoIliade sta nella presenza recondita di un occhio che sa guardare al di lagrave di esse (e al di lagrave della stessa distinzione fra Greci e Troiani vincitori e vinti) e che puograve anche attraverso le similitudini lasciare irrompere il mondo della natura o del lavoro umano nel mezzo delle battaglie LʼOdissea LrsquoOdissea (Ὀδύσσεια) consta di circa 12100 esametri divisi anchrsquoessi in 24 libri e indicati con le lettere minuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquoargomento egrave costituito dalle avventure di Odisseo dalla distruzione di Troia al ritorno alla patria Itaca esposte secondo un ordine che entrando subito nel vivo degli avvenimenti (lrsquoinizio del poema mostra Odisseo nellrsquoisola di Calipso) rievoca poi i fatti giagrave trascorsi e li ricongiunge infine a partire dal libro XV (con lrsquoarrivo di Telemaco alla capanna di Eumeo dove giagrave si trova Odisseo) in unrsquoazione unitaria La trama del poema i cui avvenimenti sono concentrati cronologicamente nello spazio di 40 giorni (ma sono narrati solo gli avvenimenti di 16 giorni e 8 notti) si articola in tre parti la laquoTelemachiaraquo (canti I-IV) il laquoRitorno di Odisseoraquo (canti V-XIII) e la laquoVendetta di Odisseoraquo (canti XIV-XXIV)
Letteratura greca [1]
22
Canto I Tutti gli eroi superstiti sono ormai tornati da Troia alle loro case tranne Odisseo che pur desideroso di tornare egrave trattenuto dalla ninfa Calipso nellrsquoisola di Ogigia Gli degravei hanno pietagrave di lui tranne Posidone irato per lrsquoaccecamento del figlio il ciclope Polifemo Ma un consiglio degli degravei assente Posidone (che si egrave recato presso gli Etiopi) delibera il ritorno dellrsquoeroe si decide che Ermes andragrave subito da Calipso mentre Atena si avvia verso Itaca sotto lrsquoaspetto del signore dei Tafi Mente per incoraggiare il figlio di Odisseo Telemaco a tener testa ai pretendenti della madre i laquoprociraquo (i quali aspirano al regno tramite le nozze con Penelope) e per indurlo a intraprendere un viaggio in cerca di notizie sul padre Canto IΙ Telemaco segue il consiglio della dea e il giorno seguente nellrsquoassemblea popolare chiede una nave per andare in cerca del padre ma la sua richiesta non viene discussa e Leocrito scioglie lrsquoassemblea Grazie ad Atena che ora ha assunto le sembianze di Mentore (antico amico di Odisseo) Telemaco riesce tuttavia a trovare una nave con cui salpa nel corso della notte allrsquoinsaputa sia della madre che dei proci Canto IΙΙ Telemaco e MentoreAtena arrivano a Pilo e sul lido trovano Nestore che sta offrendo un sacrificio a Posidone Il vecchio eroe accoglie ospitalmente Telemaco e gli comunica molte notizie sul ritorno di altri Achei ma nessuna su Odisseo Alla sera Atena scompare in forma di aquila e il mattino seguente Telemaco salpa insieme con Pisistrato (figlio di Nestore) alla volta di Sparta dove arriva la sera del giorno successivo Canto IV A Sparta Menelao sta festeggiando il doppio matrimonio del figlio e della figlia Il giorno seguente Telemaco chiede del padre Menelao gli racconta il proprio ritorno durante il quale aveva incontrato Proteo il vecchio nume marino che gli aveva riferito come Odisseo fosse trattenuto nellrsquoisola di Calipso Intanto a Itaca i proci preparano insidie meditando di uccidere Telemaco al suo ritorno Penelope ne viene a conoscenza ma Atena le appare in sogno per confortarla Canto V Dopo un secondo concilio degli degravei (in effetti un ldquodoppionerdquo di quello del I canto) Zeus manda finalmente Ermes presso Calipso con lrsquoordine di lasciar partire Odisseo La ninfa aiuta lrsquoeroe a costruirsi una zattera Al diciottesimo giorno di navigazione Odisseo egrave in vista dellrsquoisola dei Feaci Scheria quando Posidone di ritorno dal suo soggiorno presso gli Etiopi lo vede e suscita una tempesta che distrugge la zattera Ma la dea marina Ino Leucotea impietositasi gli porge il proprio velo sostenuto dal quale lrsquoeroe giunge a nuoto alla riva di Scheria dove si abbandona esausto addormentandosi Canto VI In seguito a un sogno inviatole da Atena Nausicaa la figlia del re dei Feaci Alcinoo si reca nei pressi della spiaggia a lavare le vesti insieme con le ancelle Odisseo risvegliatosi atterrisce le fanciulle che fuggono tutte allrsquoinfuori di Nausicaa Lrsquoeroe supplica la giovane di porgerle aiuto ed ella lo fa rivestire e lo accompagna fino al bosco di Atena poco prima della cittagrave esortandolo a presentarsi a suo padre Canto VII Protetto dalla nebbia di cui Atena lo ha avvolto Odisseo entra nel palazzo abbraccia le ginocchia della regina Arete e la caligine scompare poi viene accolto con onore da Alcinoo Arete chiede a Odisseo donde provenga e chi gli abbia donato gli abiti (a lei ben noti) che indossa Lrsquoeroe inizia a raccontare le disavventure che gli sono occorse dopo la
Letteratura greca [1]
23
partenza dallrsquoisola di Calipso Alcinoo gli promette di farlo ricondurre a Itaca il giorno seguente Canto VIII Ma lrsquoindomani Alcinoo fa apprestare un banchetto durante il quale lrsquoaedo Demodoco canta della contesa insorta un giorno fra Achille e Odisseo Lrsquoeroe si copre il volto per nascondere le lacrime allora Alcinoo interrompe il canto e organizza una serie di gare nel corso delle quali Odisseo primeggia Poi Demodoco al margine di unrsquoarea per la danza dove si esibiscono i ballerini feaci canta gli amori di Ares e Afrodite e la vendetta di Efesto (che incatena i due amanti) La sera al ritorno nel palazzo Demodoco racconta la storia del Cavallo di legno Odisseo scoppia nuovamente in lacrime e Alcinoo gli chiede di rivelare il suo nome Canto IX Odisseo dichiara il proprio nome e dagrave inizio al racconto della propria storia a partire dalla caduta di Troia distruzione di Ismaro e perdite subite ad opera dei Ciconi sbarco presso i Lotofagi (che si nutrono di un cibo misterioso che fa dimenticare il ritorno) dopo una terribile tempesta scatenatasi durante il tentativo di doppiare il capo Malea arrivo allrsquoisola antistante quella dei Ciclopi dove Odisseo si trasferisce con una sola nave esplorazione dellrsquoisola perdita di alcuni compagni allrsquointerno della caverna del gigante monocolo accecamento del mostro e fuga Canto X Odisseo giunge allrsquoisola di Eolo signore dei venti che lo accoglie benevolmente e gli consegna alla partenza tutti i venti chiusi in un otre ma poi lo respinge con durezza quando ritorna presso di lui percheacute i compagni (sospettando che nellrsquootre siano racchiuse cospicue ricchezze) hanno sciolto i venti e da essi si egrave sprigionato un uragano che li ha risospinti sullrsquoisola Ripreso il mare Odisseo egrave trasportato fino ai Lestrigoni antropofagi il cui attacco priva lrsquoeroe di tutte le altre navi tranne la propria Con questa fugge fino allrsquoisola (Eea) della maga Circe Dopo che Circe ha trasformato in porci un gruppo di compagni mandati innanzi ad esplorare lrsquoisola Odisseo ha la meglio sulla maga (a cui impone di restituire forma umana ai compagni) grazie allrsquoerba moly fornitagli da Ermes Resta un anno presso Circe che al momento della partenza gli consiglia di recarsi al paese dei morti per interrogare il vate Tiresia Canto XI Approdato alla terra dei Cimmeri (che vivono immersi in una nebbia perenne sulla riva dellrsquoOceano) e scavata una fossa Odisseo sacrifica ai morti e immola una vittima speciale a Tiresia Le anime accorrono dapprima Elpenore caduto per caso giugrave dal tetto della casa di Circe (Odisseo gli promette sepoltura) poi la madre Anticlea (che gli racconta di esser morta di dolore per la sua assenza) quindi Tiresia che gli vaticina le sue vicende future fino alla morte (questa lo coglieragrave dopo una lunga vita in un paese straniero che non conosce neacute il sale neacute il remo) Da un certo punto in poi il poeta dimentica il presupposto per cui Odisseo aveva scavato una fossa alla quale i morti accorrevano per bere il sangue delle vittime e bevendolo riacquistavano per breve tempo una piena consapevolezza immagina invece che Odisseo sia allrsquointerno dellrsquoAde In questa sezione rientrano la descrizione di Aiace sdegnato di Minosse di Orione dei grandi peccatori di Eracle Poi Odisseo fa ritorno a Eea e ricevuti i consigli di Circe si imbarca per il ritorno in patria Canto XII Scampato alle Sirene che invano lo attirano col canto (si egrave fatto legare allrsquoalbero della nave i compagni che remano hanno le orecchie turate con la cera) passa tra Cariddi e Scilla (che gli rapisce sei uomini) ed egrave costretto dai compagni ad approdare in contrasto con le prescrizioni di Circe allrsquoisola Trinachia dove pascolano le greggi del Sole I
Letteratura greca [1]
24
compagni spronati da Euriloco se ne cibano nonostante il divieto dellrsquoeroe Il Sole sdegnato ottiene da Zeus che la nave sia colpita dal fulmine Tutti i compagni periscono ma Odisseo che ripassa tra Scilla e Cariddi si salva miracolosamente da questrsquoultima aggrappandosi a un fico selvatico fincheacute il gorgo restituisce i rottami della nave infine arriva remando con le mani allrsquoisola di Ogigia Canto XIII Terminato il racconto lrsquoeroe riceve doni dai Feaci e la notte seguente egrave ricondotto a Itaca e deposto addormentato sulla spiaggia presso un antro sacro alle Ninfe Al risveglio per la nebbia non riconosce la sua terra fincheacute Atena in veste di giovane pastore lo rassicura e poi rivelatasi gli dagrave istruzioni su come far strage dei proci e lo trasforma in un vecchio mendico Canto XIV Odisseo si reca allo stazzo del suo porcaio Eumeo che pur non riconoscendolo lo accoglie ospitalmente rifocillandolo e offrendogli un mantello per ripararsi dal gelo notturno Canto XV A questo punto la laquoTelemachiaraquo si riannoda allrsquoazione principale Telemaco che si trova ancora a Sparta viene indotto da Atena a tornare a Itaca sulla via del ritorno a Pilo accoglie a bordo lrsquoindovino Teoclimeno e grazie allrsquoaiuto della dea sfugge alle insidie dei proci sbarca a Itaca e si reca anchrsquoegli presso Eumeo Canto XVI Questi va da Penelope ad annunciargli il ritorno del figlio Intanto Odisseo rimosso lrsquoincantesimo si svela nel suo vero aspetto a Telemaco e con lui progetta la vendetta sui proci (che intanto tramano una nuova insidia ai danni di Telemaco) Eumeo torna al suo stazzo Canto XVII Il mattino seguente Telemaco si reca in cittagrave seguito in un secondo tempo da Eumeo e Odisseo (che ha riassunto lrsquoaspetto di mendico) Davanti al palazzo Odisseo egrave riconosciuto dal cane Argo Entra e va mendicando tra i proci Antinoo lo colpisce alla spalla destra con uno sgabello Canto XVIII Odisseo si batte al pugilato col mendicante Iro Penelope scesa nella sala prospetta ai proci lrsquoeventualitagrave di un nuovo matrimonio Odisseo egrave insultato dalla schiava Melanto e schiva uno sgabello scagliato da Eurinomo Canto XIX Insieme con Telemaco lrsquoeroe allontana le armi dalla sala poi conversa con Penelope che gli racconta un sogno e gli espone il suo piano per sedare le contese tra i proci concedendosi sposa a colui che riusciragrave a tendere lrsquoarco di Odisseo la prova avverragrave il giorno seguente al novilunio Durante il colloquio la fida schiava Euriclea lava i piedi di Odisseo e riconosciutolo da unrsquoantica cicatrice sta per rivelarne lrsquoidentitagrave ma lrsquoeroe la costringe a tacere Canto XX Al mattino Euriclea e le ancelle fanno i preparativi per il banchetto Giungono Eumeo Melanzio e il mandriano Filezio Un presagio mandato da Zeus dissuade i proci dal progetto di uccidere Telemaco Durante il banchetto Teoclimeno predice la loro imminente rovina
Letteratura greca [1]
25
Canto XXI Penelope conduce lrsquoarco nella sala dopo che parecchi fra i proci e lo stesso Telemaco hanno tentato invano di tenderne la corda Odisseo chiede di partecipare alla prova tende lrsquoarco senza fatica e riesce a far passare la freccia attraverso gli anelli di dodici scuri predisposte da Telemaco Canto XXII Poi scaglia le frecce sui proci e si rivela nella sua identitagrave Nella lotta che segue Telemaco Eumeo e Filezio aiutano il padrone contro i proci (appoggiati dal capraio Melanzio) Tutti i proci restano uccisi le ancelle infedeli sono impiccate Melanzio viene mutilato e ucciso soltanto lrsquoaedo Femio e lrsquoaraldo Medonte sono risparmiati Canto XXIII Nuovo colloquio fra Odisseo e Penelope che durante lrsquoeccidio dormiva ed egrave stata svegliata da Euriclea Penelope esita ancora a riconoscere il marito e non si arrende alla veritagrave fincheacute Odisseo non le descrive la posizione e la struttura del letto coniugale Canto XXIV Ermes conduce allrsquoAde le ombre dei proci Odisseo fa visita al padre Laerte nella masseria dove quello vive nello squallore e nellrsquoemarginazione e si fa riconoscere Intanto il padre di Antinoo incita gli Itacesi alla rivolta e il poema si conclude con lo scontro di Odisseo e dei suoi contro i concittadini lrsquoeroe ha la meglio e Zeus scagliato il fulmine pone fine alla battaglia Atena sotto lrsquoaspetto di Mentore stabilisce fra i contendenti un patto per il futuro36
Struttura e caratteri dellʼopera Giagrave la prima parola del proemio (ἄνδρα) non menziona come tema dellrsquoopera un determinato episodio della vita del protagonista ma il protagonista stesso (I 1-10)
Ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα πολύτροπον ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεmiddot πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περmiddot αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο νήπιοι οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιονmiddot αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ τῶν ἁμόθεν γε θεά θύγατερ Διός εἰπὲ καὶ ἡμῖν Dellrsquouomo multiforme a me racconta o Musa che molto errograve dopo che di Troia la sacra rocca distrusse di molti uomini vide le cittagrave riconobbe il pensiero e molti per il mare patigrave dolori nellrsquoanimo per salvare la sua vita e il ritorno dei compagni Eppure non li salvograve i compagni per quanto bramasse per la loro stessa follia si persero gli stolti i buoi del Sole Iperione mangiarono e quello rapigrave ad essi il digrave del ritorno Di questo da un punto qualsiasi narra anche a noi o dea figlia di Zeus
Storie favolose di naviganti racconti imperniati sul ritorno dei guerrieri achei che avevano combattuto a Troia e il particolare rientro in patria di Odisseo figlio di Laerte erano forse giagrave stati connessi e intrecciati nella precedente tradizione epica sigrave che il presente cantore poteva
Letteratura greca [1]
26
metter mano alla vicenda partendo (v 10) laquoda un punto qualsiasiraquo (ἁμόθεν) una notazione che certo presuppone la convenzione propria dellrsquoesordio tradizionale di un canto epico comparabile con i giagrave ricordati ἐξ οὗ (laquoda quandoraquo) di Iliade I 4 ed ἔνθεν (laquoda doveraquo) di Odissea VIII 500 Senoncheacute rispetto a queste indicazioni di tipo puntuale il tratto costituito dalla dimensione casuale quasi arbitraria inerente ad ἁμόθεν proprio mentre dichiara lrsquoassenza di un determinato piano compositivo implica in realtagrave che il racconto non si svolgeragrave per filo e per segno secondo lrsquoordine noto a poeta e uditori non si snoderagrave κατὰ κόσμον (laquoper ordineraquo) come il canto di Demodoco (VIII 489) ma seguiragrave un andamento originale Il ldquopunto qualsiasirdquo incipitario non rappresenta una scelta della Musa (figura dellrsquoarchivio tematico che conserva le laquovieraquo dellrsquoepica) bensigrave di questo cantore che ha deciso di far incominciare la narrazione in medias res e ha in serbo la sorpresa di far succedere al concilio degli degravei (che decide lrsquoinvio di Ermes presso Calipso) non lrsquoazione testeacute programmata (azione che viene differita con un ritardo che a piugrave riprese ha scandalizzato i lettori a principio del V canto) ma la partenza di Atena alla volta di Itaca e lrsquoavvio della laquoTelemachiaraquo Le due diverse vicende proposte a principio del poema quella di Telemaco e quella di Odisseo procedono infatti in parallelo coprendo un analogo lasso di tempo Piugrave oltre la decisione di trasformare la sequenza narrativa che va dalla partenza di Odisseo da Troia fino al suo arrivo nella terra dei Feaci in una rievocazione fatta dallrsquoeroe in prima persona al cospetto di Alcinoo e dei Feaci (la sezione detta degli ἀπόλογοι laquoraccontiraquo) crea una struttura ad anello che parte dal presente e ad esso fa ritorno dopo aver ricostruito le premesse della condizione attuale del protagonista Col canto XIII Odisseo egrave riportato dai Feaci a Itaca e questo permette la saldatura fra le vicende sue e quelle di Telemaco sia pure col differimento dellrsquoincontro e del riconoscimento fra padre e figlio fino al canto XVI Far scorrere in parallelo sequenze distinte organizzare programmi narrativi a corta e a lunga gittata tendere o allentare ad arte il ritmo della narrazione non si tratta davvero di procedimenti che potessero configurarsi come tradizionali dellrsquoarte epica quanto piuttosto di un momento sperimentale di una ricerca di soluzioni nuove al termine di una lunga e ormai consolidata sedimentazione di percorsi compiuti allrsquointerno di un determinato repertorio tematico unrsquoaudacia inventiva una πολυτροπίη degne del protagonista del poema che inevitabilmente comportavano rischi molteplici di incoerenze dissonanze occasionali avarie della macchina epica e che tuttavia erano destinate a conseguire un risultato assolutamente convincente allrsquoorecchio di chi si abbandonasse al fascino del racconto senza lrsquourgenza propria di altre etagrave e di altre mentalitagrave di puntare il dito sui singoli dettagli o le singole sfasature
PER SAPERNE DI PIUrsquo Difficoltagrave e incongruenze della narrazione omerica Forti della possibilitagrave di un controllo su un testo scritto che possiamo percorrere in avanti e a ritroso secondo ritmi di nostra scelta a noi non riesce difficile cogliere alcune delle difficoltagrave organizzative incontrate nella composizione del poema In proposito per ricordare un caso che saragrave allrsquoorigine delle discussioni di orientamento ldquoanaliticordquo intorno allrsquoOdissea possiamo leggere il discorso che Atena prese le sembianze di Mente re dei Tafi rivolge a Telemaco nel I canto (vv 253-305) Ah infelice ti manca molto davvero lrsquoassente Odisseo che getti le mani addosso ai pretendenti sfrontati Percheacute se ora tornato stesse sulla soglia 255 con una scure lo scudo e due lance cosigrave come io per la prima volta lo vidi in casa nostra che beveva e godeva di ritorno da Efira da Ilo di Mermero (andograve anche ligrave Odisseo con la nave veloce 260 in cerca del veleno omicida per averne da ungere le frecce di bronzo ma quello non glielo diede percheacute temeva gli dei che vivono eterni
Letteratura greca [1]
27
glielo diede invece mio padre percheacute lrsquoamava moltissimo) se stesse Odisseo tra i pretendenti cosigrave 265 essi avrebbero tutti rapida morte e nozze amare Ma sulle ginocchia degli dei questo giace se una volta tornato faragrave o no vendetta nella sua casa te invece io esorto a riflettere come cacciare i pretendenti da casa 270 Ebbene ora ascolta e alle mie parole darsquo retta Domattina chiamati gli eroi Achei a consiglio rivolgi a tutti un discorso e siano testimoni gli dei Ai pretendenti comanda drsquoandarsene per i fatti loro e tua madre se lrsquoanimo la spinge alle nozze 275 ritorni a casa del padre molto potente Prepareranno essi le nozze e disporranno i doni nuziali moltissimi quanti gli pare che debbano andare alla figlia A te darograve un saggio consiglio se vuoi ascoltarlo armata una nave con venti remi la migliore che crsquoegrave 280 Varsquo a domandare del padre partito da tempo se mai te ne parli un mortale o sentissi da Zeus la voce che divulga la fama tra gli uomini Anzitutto varsquo a Pilo e interroga il chiaro Nestore di ligrave poi varsquo a Sparta dal biondo Menelao 285 degli Achei vestiti di bronzo egli egrave tornato per ultimo Se senti dire qualcosa sulla vita e il ritorno del padre per quanto stremato potresti sopportare un altro anno se invece senti dire che egrave morto e non vive allora tornato nella cara terra patria 290 ergigli un tumulo e offrigli funebri offerte moltissime quanto conviene e darsquo tua madre a un marito E poi dopo aver compiuto e fatto ogni cosa allora medita nella mente e nellrsquoanimo come tu possa uccidere nelle tue case 295 i pretendenti con lrsquoinganno affrontandoli non devi piugrave avere i modi di un bimbo percheacute ormai non sei tale Non senti lrsquoillustre Oreste quale gloria ha acquistato fra tutti gli uomini percheacute uccise lrsquoassassino del padre Egisto esperto di inganni che gli uccise il nobile padre 300 Anche tu caro infatti molto bello e grande ti vedo sii valoroso percheacute ti lodi anche qualcuno dei posteri Ma io tornerograve adesso alla nave veloce dai compagni che forse impazienti mi aspettano Tu devi pensarci da te dammi retta 305
[Tr di GA Privitera] Le stranezze non mancano davvero e cosigrave sono state messe a fuoco da Stephanie West nel suo commento23 1 Atena sa evidentemente molto piugrave di quanto uno come Mente avrebbe potuto sapere in particolare ella sa che i proci ignoreranno lrsquoinvito di Telemaco a lasciare la sua casa e fatto piugrave importante che gli degravei tra breve ricondurranno in patria Odisseo A queste osservazioni si puograve replicare con la stessa West che laquosi sono esagerate difficoltagrave e
23 Omero Odissea I cit 219 ss
Letteratura greca [1]
28
incongruenze alle quali un pubblico di ascoltatori (o anche un lettore moderatamente attento) probabilmente non farebbe casoraquo 2 Il progetto di una pubblica denuncia dei proci dinanzi agli degravei e agli uomini ai vv 273-274 egrave ciograve che Atena sembra prefiggersi nel promuovere lrsquoassemblea degli Itacesi (assemblea che effettivamente avragrave luogo a principio del canto II) drsquoaltra parte le successive istruzioni di AtenaMente ai vv 295 s (medita come uccidere i pretendenti) presuppongono che di quella richiesta da formulare nel corso dellrsquoassembla essi non terranno alcun conto Anche a questa osservazione si puograve rispondere che laquoegrave ragionevole attendersi che Telemaco condivida la previsione di un esito negativo della sua iniziativaraquo e si puograve aggiungere che pure in caso di insuccesso il ricorso allrsquoassemblea potrebbe ottenere almeno il risultato di screditare i pretendenti presso la comunitagrave itacese legittimando un successivo ricorso alla violenza (e si tratta di una legittimazione di cui anche lrsquoultimo canto mostreragrave lrsquoesigenza) 3 Dopo che Telemaco aveva detto che la madre non intendeva risposarsi (vv 249-250) AtenaMente si esprime ai vv 275-278 come se Penelope desiderasse proprio nuove nozze e inoltre sarebbe assurdo che il padre di Penelope cominciasse a contrattare un secondo matrimonio prima del ritorno di Telemaco dal suo viaggio e che mettesse mano a preparativi che rischierebbero di essere annullati qualche tempo dopo con inevitabile imbarazzo se Telemaco venisse a sapere che Odisseo egrave ancora vivo In piugrave lrsquoandamento sintattico di questi versi presenta un anacoluto durissimo per cui a principio del v 275 lrsquoaccusativo μητέρα egrave seguito da un ἂψ ἴτω (laquovada indietroraquo laquotorniraquo) che richiederebbe come soggetto un nominativo μήτηρ Come hanno reagito i lettori di Omero Nellrsquoantichitagrave un grammatico rimasto anonimo cambiava come attesta uno scolio μητέρ᾽ in μήτηρ nel secolo XVIII Richard Bentley modificava ἴτω in ἴμεν (infinito eolico di εἶμι laquovadoraquo) nel XIX un altro grande della filologia europea Gottfried Hermann risolveva piugrave drasticamente la questione eliminando il complesso dei vv 275-278 e la stessa West mostra simpatia per tale proposta supponendo laquounrsquoaggiunta posteriore modellata sul corrispondente passo del libro IIraquo (dove i vv 196 s sono identici ai vv 277 s e il v 195 copre lo stesso contenuto dei vv 275 s) Si tratta di procedimenti adeguati ai dati di fatto Migliorano davvero il testo che ci egrave stato tramandato In realtagrave ambedue le ldquocorrezionirdquo appena ricordate (di μήτερ᾽ e di ἴτω) ottengono un risultato tanto lineare che egrave davvero difficile pensare che lrsquoanacoluto avrebbe potuto invadere tutta la tradizione se non fosse stato originario e quanto allrsquoespunzione dei vv 275-278 essa indubbiamente peggiorerebbe il ritmo del discorso determinando lrsquoavvicinamento fra i due versi (v 271 e v 279) molto simili fra loro che aprono le due sequenze occupate dai consigli di Mente E allora La via piugrave saggia egrave senzrsquoaltro quella di tenerci qui come quasi sempre di fronte al testo omerico contraddizioni e anacoluti riconoscendo in essi lrsquoeffetto dellrsquoattivitagrave di un cantore che pur sulla base di una traccia largamente memorizzata restava pur sempre legato a quella prassi orale per cui composizione ed esecuzione tendevano a coincidere E lrsquoanacoluto si spiega bene se cerchiamo di immedesimarci nel procedimento seguito dal poeta Egli ha affidato ad Atena un certo flusso argomentativo per cui la dea deve dar consigli a Telemaco sui suoi rapporti coi proci e con la madre e cosigrave colloca in fine di v 274 un ἄνωχθι (laquoordinaraquo) destinato a reggere gli accusativi simmetricamente dislocati in principio di verso (vv 274 e 275) μνηστῆρας e μητέρα Senoncheacute giunto a questa seconda parte dellrsquoargomentazione egli si avvede quanto sarebbe illogico che Telemaco sollecitasse la madre a nuove nozze di qui lrsquoimprovviso cambio di costruzione che svincola al prezzo di una sensibile slogatura sintattica lrsquoipotesi delle nuove nozze dallrsquoordine impartito a Telemaco e la prospetta invece come un desiderio eventuale della stessa Penelope Il poeta ha un progetto ben meditato brani e sequenze piugrave volte sperimentati ed egrave col supporto di questi materiali giagrave elaborati che egli si fa strada attraverso le insidie della
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
19
Struttura e caratteri dellʼopera Poema di trama relativamente organica (soprattutto a partire dal canto XVI tutti gli avvenimenti tranne pochi episodi isolati ruotano attorno ai due principali antagonisti Ettore uccide Patroclo per vendicare Sarpedone e Achille uccide Ettore per vendicare Patroclo) pur se non privo di piugrave o meno cospicue incongruenze spiegabili in primo luogo con la lunga e complessa genesi orale dellrsquoopera lrsquoIliade lascia emergere in mezzo alle centinaia di nomi e alle intricate vicende alcuni caratteri delineati nella loro individualitagrave e innanzi tutto quelli di Achille e di Ettore accomunati dalla medesima coscienza di un destino di morte che sono pronti ad affrontare Appunto una tale attitudine a rappresentare i laquocaratteriraquo (ἤθη) dei suoi personaggi egrave un altro titolo di merito che Aristotele ascrive ad Omero (Poetica 1460a9-11)
dopo aver brevemente proemiato subito introduce un uomo una donna o un altro personaggio nessuno privo di caratterizzazione ma dotato di un carattere
Fondamentale per la struttura del poema egrave la novitagrave della prospettiva Possiamo presumere che i cosiddetti poemi ciclici22 mirassero a conservare lrsquoangolatura che era stata propria delle versioni pre-omeriche della saga troiana sigrave che puograve riuscire significativo il confronto fra lrsquoesordio della Piccola Iliade (dove muovendo da grandi entitagrave ndash la cittagrave il paese due popoli la guerra ndash viene lanciato secondo lrsquoespressione di J Latacz come laquouno sguardo dallrsquoesternoraquo)
Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην εὔπωλον ἧς πέρι πολλὰ πάθον Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος Canto Ilio e la terra dei Dardani dai bei puledri per la quale molti dolori patirono i Danai servitori di Ares
con lo laquosguardo internoraquo che caratterizza lrsquoinizio dellrsquoIliade
Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν ἡρώων αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν οἰωνοῖσί τε δαῖτα Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς Canta o dea di Achille figlio di Peleo la collera maledetta che pene innumerevoli inflisse agli Achei e molte scagliograve allrsquoAde vite possenti di eroi e ne faceva prede per i cani e pasto per gli uccelli e si avverava il volere di Zeus da quando primamente si separarono venuti a contesa LrsquoAtride sovrano di eroi e Achille magnifico
Argomento non egrave dunque come doveva avvenire nella tradizione del canto epico un evento complesso da inquadrare con un grandangolo onnicomprensivo e neppure come saragrave nellrsquoOdissea un personaggio colto nella multiforme varietagrave delle sue peregrinazioni egrave invece una reazione emotiva (lrsquoira di Achille) con le sue conseguenze (le innumerevoli morti degli Achei) Narrare di questa ira significa per il poeta cominciare da un punto preciso (laquoda quandoraquo) ossia dal momento della contesa e della separazione fra i due massimi eroi greci Agamennone il primo per potere (laquosovrano di eroiraquo) e Achille il primo per nobiltagrave e forza (δῖος) E sintomatica della bipolaritagrave del mondo epico in quanto mondo di degravei e di eroi egrave la sincronia per cui il taglio della narrazione coincide col decorso del laquovolere di Zeusraquo (Διὸς βουλή) forse da identificare con la promessa del dio a Tetide (rievocata piugrave oltre in questo
22 V cap II laquoLa tradizione omericaraquo
Letteratura greca [1]
20
stesso canto ai vv 518-527) di vendicare lrsquoaffronto subito da Achille o piugrave in generale con il corso degli eventi in quanto tutto come per definizione laquogiace sulle ginocchia di Zeusraquo Opera indubbiamente allrsquointerno del poema unrsquoidea formativa un progetto di qui un insieme monumentale unificato anche da una serie di corrispondenze a distanza fra cui particolare significato acquistano quelle fra primo e ultimo canto Nel canto I il vecchio Crise va come supplice presso Agamennone portando doni e supplicando la restituzione della figlia e Agamennone lo respinge aspramente minacciandolo di far ricorso alla violenza se dovesse tornare nel canto XXIV il vecchio Priamo va come supplice presso Achille portando doni e supplicando la restituzione del corpo del figlio Achille ha una prima reazione irosa (esordisce al v 560 con laquoSmetti di irritarmi vecchioraquo) ma poi accoglie la supplica E al di lagrave delle corrispondenze nelle linee dellrsquoazione si colgono fra principio e fine del poema alcuni importanti echi verbali in particolare fra XXIV 501 s
τοῦ νῦν εἵνεχ᾽ ἱκάνω νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενος παρὰ σεῖο φέρω δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα per lui [Ettore] vengo ora alle navi degli Achei per riscattarlo da te e ti porto compenso infinito
e I 12 s
ὁ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενός τε θυγάτρα φέρων δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα costui [Crise] venne alle navi rapide degli Achei per riscattare la figlia portando compenso infinito
fra XXIV 555-557
λῦσον ἵν᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδωmiddot σὺ δὲ δέξαι ἄποινα πολλά τά τοι φέρομενmiddot σὺ δὲ τῶνδrsquo ἀπόναιο καὶ ἔλθοις σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν restituiscimelo percheacute lo possa vedere con gli occhi e accogli il riscatto copioso che portiamo e tu possa goderne e tornare alla tua terra patria
e I 18-20
Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν εὖ δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκέσθαιmiddot παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην τὰ δ᾽ ἄποινα δέχεσθαι Atridi e voi altri Achei dai forti schinieri a voi concedano gli degravei che hanno le case in Olimpo di distruggere la cittagrave di Priamo e tornare facilmente in patria ma restituitemi la figlia e accettate il riscatto
fra XXIV 560 μηκέτι νῦν μ᾽ ἐρέθιζε (laquosmetti di irritarmiraquo) e I 32 μή μ᾽ ἐρέθιζε (laquonon mi irritareraquo) fra XXIV 568-570
τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς μή σε γέρον οὐδrsquo αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω καὶ ἱκέτην περ ἐόντα Διὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμάς Ora perciograve fra i dolori non mi eccitare lrsquoanimo ancora di piugrave bada o vecchio che non ti lasci neppure nella tenda
Letteratura greca [1]
21
bencheacute supplice e violi gli ordini di Zeus e I 26-28
μή σε γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω ἢ νῦν δηθύνοντ᾽ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο Mai te o vecchio io colga presso le concave navi ora a indugiare o piugrave tardi a tornare che piugrave non dovesse giovarti lo scettro e la benda del dio
(e infine XXIV 571 ὣς ἔφατ ἔδεισεν δ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ laquocosigrave diceva e il vecchio tremograve e obbediva alle paroleraquo ripete esattamente I 33) In effetti lrsquoepisodio terminale del poema col superamento dellrsquoira ad opera della pietagrave e del senso di unrsquoesistenza invasa dal dolore si propone come il rovesciamento consapevole dellrsquoepisodio iniziale che era apparso caratterizzato dalla cancellazione della pietagrave e del diritto dei supplici in nome della forza Al rifiuto iniziale del donoriscatto si oppone lrsquoaccettazione finale in consonanza con un principio-guida che opera nel poema secondo linee che alla fine si riunificano Agamennone restituisce Criseide al padre ma si appropria del dono fatto dagli altri Achei ad Achille (Briseide) Achille respinge i doni fatti da Agamennone per indurlo a riconciliarsi con lui ma dopo aver contestato nel IX canto la nozione che la vita umana possa essere barattata con una massa di beni torna alla lotta non in cambio di qualche premio da conquistare ma per vendicare lrsquouccisione dellrsquoamico Patroclo e tanto nella lotta sul campo di battaglia quanto nellrsquoinfierire sul cadavere di Ettore si abbandona a un furore cosigrave smisurato e patologico che puograve essere superato solo con lrsquoaccettare i doni di Priamo non tuttavia per il loro valore drsquouso ma percheacute in Priamo Achille riconosce lrsquoombra del padre lontano Cosigrave lrsquoIliade appare attraversata da un impulso fondamentale che muove dallrsquoideologia del dono e dalla conseguente centralitagrave assegnata allrsquoonore (τιμή) come ldquoprezzordquo che qualifica il valore del guerriero ma supera questo piano di valutazione dei rapporti umani attraverso la loro riformulazione nei termini di un umanesimo esistenziale che ha come punti di riferimento lrsquoidentitagrave universale dei condizionamenti oggettivi (la vecchiaia la malattia la morte) e i legami che uniscono padre e figlio compagno e compagno vivi e morti (il cordoglio finale di Andromaca Ecuba ed Elena sulla salma di Ettore) Entro questo orizzonte progressivamente allargato la guerra le lotte lo scontro mortale finiscono col rappresentare solo un momento e un aspetto dellrsquoesistenza graditi tanto agli degravei che vi assistono come spettatori interessati quanto agli uditori che riascoltano le antiche gesta eppure non tali da appiattire il poema in una prospettiva guerresca conclusa in se stessa Molto del fascino delle battaglie e delle ἀριστεῖαι dellrsquoIliade sta nella presenza recondita di un occhio che sa guardare al di lagrave di esse (e al di lagrave della stessa distinzione fra Greci e Troiani vincitori e vinti) e che puograve anche attraverso le similitudini lasciare irrompere il mondo della natura o del lavoro umano nel mezzo delle battaglie LʼOdissea LrsquoOdissea (Ὀδύσσεια) consta di circa 12100 esametri divisi anchrsquoessi in 24 libri e indicati con le lettere minuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquoargomento egrave costituito dalle avventure di Odisseo dalla distruzione di Troia al ritorno alla patria Itaca esposte secondo un ordine che entrando subito nel vivo degli avvenimenti (lrsquoinizio del poema mostra Odisseo nellrsquoisola di Calipso) rievoca poi i fatti giagrave trascorsi e li ricongiunge infine a partire dal libro XV (con lrsquoarrivo di Telemaco alla capanna di Eumeo dove giagrave si trova Odisseo) in unrsquoazione unitaria La trama del poema i cui avvenimenti sono concentrati cronologicamente nello spazio di 40 giorni (ma sono narrati solo gli avvenimenti di 16 giorni e 8 notti) si articola in tre parti la laquoTelemachiaraquo (canti I-IV) il laquoRitorno di Odisseoraquo (canti V-XIII) e la laquoVendetta di Odisseoraquo (canti XIV-XXIV)
Letteratura greca [1]
22
Canto I Tutti gli eroi superstiti sono ormai tornati da Troia alle loro case tranne Odisseo che pur desideroso di tornare egrave trattenuto dalla ninfa Calipso nellrsquoisola di Ogigia Gli degravei hanno pietagrave di lui tranne Posidone irato per lrsquoaccecamento del figlio il ciclope Polifemo Ma un consiglio degli degravei assente Posidone (che si egrave recato presso gli Etiopi) delibera il ritorno dellrsquoeroe si decide che Ermes andragrave subito da Calipso mentre Atena si avvia verso Itaca sotto lrsquoaspetto del signore dei Tafi Mente per incoraggiare il figlio di Odisseo Telemaco a tener testa ai pretendenti della madre i laquoprociraquo (i quali aspirano al regno tramite le nozze con Penelope) e per indurlo a intraprendere un viaggio in cerca di notizie sul padre Canto IΙ Telemaco segue il consiglio della dea e il giorno seguente nellrsquoassemblea popolare chiede una nave per andare in cerca del padre ma la sua richiesta non viene discussa e Leocrito scioglie lrsquoassemblea Grazie ad Atena che ora ha assunto le sembianze di Mentore (antico amico di Odisseo) Telemaco riesce tuttavia a trovare una nave con cui salpa nel corso della notte allrsquoinsaputa sia della madre che dei proci Canto IΙΙ Telemaco e MentoreAtena arrivano a Pilo e sul lido trovano Nestore che sta offrendo un sacrificio a Posidone Il vecchio eroe accoglie ospitalmente Telemaco e gli comunica molte notizie sul ritorno di altri Achei ma nessuna su Odisseo Alla sera Atena scompare in forma di aquila e il mattino seguente Telemaco salpa insieme con Pisistrato (figlio di Nestore) alla volta di Sparta dove arriva la sera del giorno successivo Canto IV A Sparta Menelao sta festeggiando il doppio matrimonio del figlio e della figlia Il giorno seguente Telemaco chiede del padre Menelao gli racconta il proprio ritorno durante il quale aveva incontrato Proteo il vecchio nume marino che gli aveva riferito come Odisseo fosse trattenuto nellrsquoisola di Calipso Intanto a Itaca i proci preparano insidie meditando di uccidere Telemaco al suo ritorno Penelope ne viene a conoscenza ma Atena le appare in sogno per confortarla Canto V Dopo un secondo concilio degli degravei (in effetti un ldquodoppionerdquo di quello del I canto) Zeus manda finalmente Ermes presso Calipso con lrsquoordine di lasciar partire Odisseo La ninfa aiuta lrsquoeroe a costruirsi una zattera Al diciottesimo giorno di navigazione Odisseo egrave in vista dellrsquoisola dei Feaci Scheria quando Posidone di ritorno dal suo soggiorno presso gli Etiopi lo vede e suscita una tempesta che distrugge la zattera Ma la dea marina Ino Leucotea impietositasi gli porge il proprio velo sostenuto dal quale lrsquoeroe giunge a nuoto alla riva di Scheria dove si abbandona esausto addormentandosi Canto VI In seguito a un sogno inviatole da Atena Nausicaa la figlia del re dei Feaci Alcinoo si reca nei pressi della spiaggia a lavare le vesti insieme con le ancelle Odisseo risvegliatosi atterrisce le fanciulle che fuggono tutte allrsquoinfuori di Nausicaa Lrsquoeroe supplica la giovane di porgerle aiuto ed ella lo fa rivestire e lo accompagna fino al bosco di Atena poco prima della cittagrave esortandolo a presentarsi a suo padre Canto VII Protetto dalla nebbia di cui Atena lo ha avvolto Odisseo entra nel palazzo abbraccia le ginocchia della regina Arete e la caligine scompare poi viene accolto con onore da Alcinoo Arete chiede a Odisseo donde provenga e chi gli abbia donato gli abiti (a lei ben noti) che indossa Lrsquoeroe inizia a raccontare le disavventure che gli sono occorse dopo la
Letteratura greca [1]
23
partenza dallrsquoisola di Calipso Alcinoo gli promette di farlo ricondurre a Itaca il giorno seguente Canto VIII Ma lrsquoindomani Alcinoo fa apprestare un banchetto durante il quale lrsquoaedo Demodoco canta della contesa insorta un giorno fra Achille e Odisseo Lrsquoeroe si copre il volto per nascondere le lacrime allora Alcinoo interrompe il canto e organizza una serie di gare nel corso delle quali Odisseo primeggia Poi Demodoco al margine di unrsquoarea per la danza dove si esibiscono i ballerini feaci canta gli amori di Ares e Afrodite e la vendetta di Efesto (che incatena i due amanti) La sera al ritorno nel palazzo Demodoco racconta la storia del Cavallo di legno Odisseo scoppia nuovamente in lacrime e Alcinoo gli chiede di rivelare il suo nome Canto IX Odisseo dichiara il proprio nome e dagrave inizio al racconto della propria storia a partire dalla caduta di Troia distruzione di Ismaro e perdite subite ad opera dei Ciconi sbarco presso i Lotofagi (che si nutrono di un cibo misterioso che fa dimenticare il ritorno) dopo una terribile tempesta scatenatasi durante il tentativo di doppiare il capo Malea arrivo allrsquoisola antistante quella dei Ciclopi dove Odisseo si trasferisce con una sola nave esplorazione dellrsquoisola perdita di alcuni compagni allrsquointerno della caverna del gigante monocolo accecamento del mostro e fuga Canto X Odisseo giunge allrsquoisola di Eolo signore dei venti che lo accoglie benevolmente e gli consegna alla partenza tutti i venti chiusi in un otre ma poi lo respinge con durezza quando ritorna presso di lui percheacute i compagni (sospettando che nellrsquootre siano racchiuse cospicue ricchezze) hanno sciolto i venti e da essi si egrave sprigionato un uragano che li ha risospinti sullrsquoisola Ripreso il mare Odisseo egrave trasportato fino ai Lestrigoni antropofagi il cui attacco priva lrsquoeroe di tutte le altre navi tranne la propria Con questa fugge fino allrsquoisola (Eea) della maga Circe Dopo che Circe ha trasformato in porci un gruppo di compagni mandati innanzi ad esplorare lrsquoisola Odisseo ha la meglio sulla maga (a cui impone di restituire forma umana ai compagni) grazie allrsquoerba moly fornitagli da Ermes Resta un anno presso Circe che al momento della partenza gli consiglia di recarsi al paese dei morti per interrogare il vate Tiresia Canto XI Approdato alla terra dei Cimmeri (che vivono immersi in una nebbia perenne sulla riva dellrsquoOceano) e scavata una fossa Odisseo sacrifica ai morti e immola una vittima speciale a Tiresia Le anime accorrono dapprima Elpenore caduto per caso giugrave dal tetto della casa di Circe (Odisseo gli promette sepoltura) poi la madre Anticlea (che gli racconta di esser morta di dolore per la sua assenza) quindi Tiresia che gli vaticina le sue vicende future fino alla morte (questa lo coglieragrave dopo una lunga vita in un paese straniero che non conosce neacute il sale neacute il remo) Da un certo punto in poi il poeta dimentica il presupposto per cui Odisseo aveva scavato una fossa alla quale i morti accorrevano per bere il sangue delle vittime e bevendolo riacquistavano per breve tempo una piena consapevolezza immagina invece che Odisseo sia allrsquointerno dellrsquoAde In questa sezione rientrano la descrizione di Aiace sdegnato di Minosse di Orione dei grandi peccatori di Eracle Poi Odisseo fa ritorno a Eea e ricevuti i consigli di Circe si imbarca per il ritorno in patria Canto XII Scampato alle Sirene che invano lo attirano col canto (si egrave fatto legare allrsquoalbero della nave i compagni che remano hanno le orecchie turate con la cera) passa tra Cariddi e Scilla (che gli rapisce sei uomini) ed egrave costretto dai compagni ad approdare in contrasto con le prescrizioni di Circe allrsquoisola Trinachia dove pascolano le greggi del Sole I
Letteratura greca [1]
24
compagni spronati da Euriloco se ne cibano nonostante il divieto dellrsquoeroe Il Sole sdegnato ottiene da Zeus che la nave sia colpita dal fulmine Tutti i compagni periscono ma Odisseo che ripassa tra Scilla e Cariddi si salva miracolosamente da questrsquoultima aggrappandosi a un fico selvatico fincheacute il gorgo restituisce i rottami della nave infine arriva remando con le mani allrsquoisola di Ogigia Canto XIII Terminato il racconto lrsquoeroe riceve doni dai Feaci e la notte seguente egrave ricondotto a Itaca e deposto addormentato sulla spiaggia presso un antro sacro alle Ninfe Al risveglio per la nebbia non riconosce la sua terra fincheacute Atena in veste di giovane pastore lo rassicura e poi rivelatasi gli dagrave istruzioni su come far strage dei proci e lo trasforma in un vecchio mendico Canto XIV Odisseo si reca allo stazzo del suo porcaio Eumeo che pur non riconoscendolo lo accoglie ospitalmente rifocillandolo e offrendogli un mantello per ripararsi dal gelo notturno Canto XV A questo punto la laquoTelemachiaraquo si riannoda allrsquoazione principale Telemaco che si trova ancora a Sparta viene indotto da Atena a tornare a Itaca sulla via del ritorno a Pilo accoglie a bordo lrsquoindovino Teoclimeno e grazie allrsquoaiuto della dea sfugge alle insidie dei proci sbarca a Itaca e si reca anchrsquoegli presso Eumeo Canto XVI Questi va da Penelope ad annunciargli il ritorno del figlio Intanto Odisseo rimosso lrsquoincantesimo si svela nel suo vero aspetto a Telemaco e con lui progetta la vendetta sui proci (che intanto tramano una nuova insidia ai danni di Telemaco) Eumeo torna al suo stazzo Canto XVII Il mattino seguente Telemaco si reca in cittagrave seguito in un secondo tempo da Eumeo e Odisseo (che ha riassunto lrsquoaspetto di mendico) Davanti al palazzo Odisseo egrave riconosciuto dal cane Argo Entra e va mendicando tra i proci Antinoo lo colpisce alla spalla destra con uno sgabello Canto XVIII Odisseo si batte al pugilato col mendicante Iro Penelope scesa nella sala prospetta ai proci lrsquoeventualitagrave di un nuovo matrimonio Odisseo egrave insultato dalla schiava Melanto e schiva uno sgabello scagliato da Eurinomo Canto XIX Insieme con Telemaco lrsquoeroe allontana le armi dalla sala poi conversa con Penelope che gli racconta un sogno e gli espone il suo piano per sedare le contese tra i proci concedendosi sposa a colui che riusciragrave a tendere lrsquoarco di Odisseo la prova avverragrave il giorno seguente al novilunio Durante il colloquio la fida schiava Euriclea lava i piedi di Odisseo e riconosciutolo da unrsquoantica cicatrice sta per rivelarne lrsquoidentitagrave ma lrsquoeroe la costringe a tacere Canto XX Al mattino Euriclea e le ancelle fanno i preparativi per il banchetto Giungono Eumeo Melanzio e il mandriano Filezio Un presagio mandato da Zeus dissuade i proci dal progetto di uccidere Telemaco Durante il banchetto Teoclimeno predice la loro imminente rovina
Letteratura greca [1]
25
Canto XXI Penelope conduce lrsquoarco nella sala dopo che parecchi fra i proci e lo stesso Telemaco hanno tentato invano di tenderne la corda Odisseo chiede di partecipare alla prova tende lrsquoarco senza fatica e riesce a far passare la freccia attraverso gli anelli di dodici scuri predisposte da Telemaco Canto XXII Poi scaglia le frecce sui proci e si rivela nella sua identitagrave Nella lotta che segue Telemaco Eumeo e Filezio aiutano il padrone contro i proci (appoggiati dal capraio Melanzio) Tutti i proci restano uccisi le ancelle infedeli sono impiccate Melanzio viene mutilato e ucciso soltanto lrsquoaedo Femio e lrsquoaraldo Medonte sono risparmiati Canto XXIII Nuovo colloquio fra Odisseo e Penelope che durante lrsquoeccidio dormiva ed egrave stata svegliata da Euriclea Penelope esita ancora a riconoscere il marito e non si arrende alla veritagrave fincheacute Odisseo non le descrive la posizione e la struttura del letto coniugale Canto XXIV Ermes conduce allrsquoAde le ombre dei proci Odisseo fa visita al padre Laerte nella masseria dove quello vive nello squallore e nellrsquoemarginazione e si fa riconoscere Intanto il padre di Antinoo incita gli Itacesi alla rivolta e il poema si conclude con lo scontro di Odisseo e dei suoi contro i concittadini lrsquoeroe ha la meglio e Zeus scagliato il fulmine pone fine alla battaglia Atena sotto lrsquoaspetto di Mentore stabilisce fra i contendenti un patto per il futuro36
Struttura e caratteri dellʼopera Giagrave la prima parola del proemio (ἄνδρα) non menziona come tema dellrsquoopera un determinato episodio della vita del protagonista ma il protagonista stesso (I 1-10)
Ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα πολύτροπον ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεmiddot πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περmiddot αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο νήπιοι οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιονmiddot αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ τῶν ἁμόθεν γε θεά θύγατερ Διός εἰπὲ καὶ ἡμῖν Dellrsquouomo multiforme a me racconta o Musa che molto errograve dopo che di Troia la sacra rocca distrusse di molti uomini vide le cittagrave riconobbe il pensiero e molti per il mare patigrave dolori nellrsquoanimo per salvare la sua vita e il ritorno dei compagni Eppure non li salvograve i compagni per quanto bramasse per la loro stessa follia si persero gli stolti i buoi del Sole Iperione mangiarono e quello rapigrave ad essi il digrave del ritorno Di questo da un punto qualsiasi narra anche a noi o dea figlia di Zeus
Storie favolose di naviganti racconti imperniati sul ritorno dei guerrieri achei che avevano combattuto a Troia e il particolare rientro in patria di Odisseo figlio di Laerte erano forse giagrave stati connessi e intrecciati nella precedente tradizione epica sigrave che il presente cantore poteva
Letteratura greca [1]
26
metter mano alla vicenda partendo (v 10) laquoda un punto qualsiasiraquo (ἁμόθεν) una notazione che certo presuppone la convenzione propria dellrsquoesordio tradizionale di un canto epico comparabile con i giagrave ricordati ἐξ οὗ (laquoda quandoraquo) di Iliade I 4 ed ἔνθεν (laquoda doveraquo) di Odissea VIII 500 Senoncheacute rispetto a queste indicazioni di tipo puntuale il tratto costituito dalla dimensione casuale quasi arbitraria inerente ad ἁμόθεν proprio mentre dichiara lrsquoassenza di un determinato piano compositivo implica in realtagrave che il racconto non si svolgeragrave per filo e per segno secondo lrsquoordine noto a poeta e uditori non si snoderagrave κατὰ κόσμον (laquoper ordineraquo) come il canto di Demodoco (VIII 489) ma seguiragrave un andamento originale Il ldquopunto qualsiasirdquo incipitario non rappresenta una scelta della Musa (figura dellrsquoarchivio tematico che conserva le laquovieraquo dellrsquoepica) bensigrave di questo cantore che ha deciso di far incominciare la narrazione in medias res e ha in serbo la sorpresa di far succedere al concilio degli degravei (che decide lrsquoinvio di Ermes presso Calipso) non lrsquoazione testeacute programmata (azione che viene differita con un ritardo che a piugrave riprese ha scandalizzato i lettori a principio del V canto) ma la partenza di Atena alla volta di Itaca e lrsquoavvio della laquoTelemachiaraquo Le due diverse vicende proposte a principio del poema quella di Telemaco e quella di Odisseo procedono infatti in parallelo coprendo un analogo lasso di tempo Piugrave oltre la decisione di trasformare la sequenza narrativa che va dalla partenza di Odisseo da Troia fino al suo arrivo nella terra dei Feaci in una rievocazione fatta dallrsquoeroe in prima persona al cospetto di Alcinoo e dei Feaci (la sezione detta degli ἀπόλογοι laquoraccontiraquo) crea una struttura ad anello che parte dal presente e ad esso fa ritorno dopo aver ricostruito le premesse della condizione attuale del protagonista Col canto XIII Odisseo egrave riportato dai Feaci a Itaca e questo permette la saldatura fra le vicende sue e quelle di Telemaco sia pure col differimento dellrsquoincontro e del riconoscimento fra padre e figlio fino al canto XVI Far scorrere in parallelo sequenze distinte organizzare programmi narrativi a corta e a lunga gittata tendere o allentare ad arte il ritmo della narrazione non si tratta davvero di procedimenti che potessero configurarsi come tradizionali dellrsquoarte epica quanto piuttosto di un momento sperimentale di una ricerca di soluzioni nuove al termine di una lunga e ormai consolidata sedimentazione di percorsi compiuti allrsquointerno di un determinato repertorio tematico unrsquoaudacia inventiva una πολυτροπίη degne del protagonista del poema che inevitabilmente comportavano rischi molteplici di incoerenze dissonanze occasionali avarie della macchina epica e che tuttavia erano destinate a conseguire un risultato assolutamente convincente allrsquoorecchio di chi si abbandonasse al fascino del racconto senza lrsquourgenza propria di altre etagrave e di altre mentalitagrave di puntare il dito sui singoli dettagli o le singole sfasature
PER SAPERNE DI PIUrsquo Difficoltagrave e incongruenze della narrazione omerica Forti della possibilitagrave di un controllo su un testo scritto che possiamo percorrere in avanti e a ritroso secondo ritmi di nostra scelta a noi non riesce difficile cogliere alcune delle difficoltagrave organizzative incontrate nella composizione del poema In proposito per ricordare un caso che saragrave allrsquoorigine delle discussioni di orientamento ldquoanaliticordquo intorno allrsquoOdissea possiamo leggere il discorso che Atena prese le sembianze di Mente re dei Tafi rivolge a Telemaco nel I canto (vv 253-305) Ah infelice ti manca molto davvero lrsquoassente Odisseo che getti le mani addosso ai pretendenti sfrontati Percheacute se ora tornato stesse sulla soglia 255 con una scure lo scudo e due lance cosigrave come io per la prima volta lo vidi in casa nostra che beveva e godeva di ritorno da Efira da Ilo di Mermero (andograve anche ligrave Odisseo con la nave veloce 260 in cerca del veleno omicida per averne da ungere le frecce di bronzo ma quello non glielo diede percheacute temeva gli dei che vivono eterni
Letteratura greca [1]
27
glielo diede invece mio padre percheacute lrsquoamava moltissimo) se stesse Odisseo tra i pretendenti cosigrave 265 essi avrebbero tutti rapida morte e nozze amare Ma sulle ginocchia degli dei questo giace se una volta tornato faragrave o no vendetta nella sua casa te invece io esorto a riflettere come cacciare i pretendenti da casa 270 Ebbene ora ascolta e alle mie parole darsquo retta Domattina chiamati gli eroi Achei a consiglio rivolgi a tutti un discorso e siano testimoni gli dei Ai pretendenti comanda drsquoandarsene per i fatti loro e tua madre se lrsquoanimo la spinge alle nozze 275 ritorni a casa del padre molto potente Prepareranno essi le nozze e disporranno i doni nuziali moltissimi quanti gli pare che debbano andare alla figlia A te darograve un saggio consiglio se vuoi ascoltarlo armata una nave con venti remi la migliore che crsquoegrave 280 Varsquo a domandare del padre partito da tempo se mai te ne parli un mortale o sentissi da Zeus la voce che divulga la fama tra gli uomini Anzitutto varsquo a Pilo e interroga il chiaro Nestore di ligrave poi varsquo a Sparta dal biondo Menelao 285 degli Achei vestiti di bronzo egli egrave tornato per ultimo Se senti dire qualcosa sulla vita e il ritorno del padre per quanto stremato potresti sopportare un altro anno se invece senti dire che egrave morto e non vive allora tornato nella cara terra patria 290 ergigli un tumulo e offrigli funebri offerte moltissime quanto conviene e darsquo tua madre a un marito E poi dopo aver compiuto e fatto ogni cosa allora medita nella mente e nellrsquoanimo come tu possa uccidere nelle tue case 295 i pretendenti con lrsquoinganno affrontandoli non devi piugrave avere i modi di un bimbo percheacute ormai non sei tale Non senti lrsquoillustre Oreste quale gloria ha acquistato fra tutti gli uomini percheacute uccise lrsquoassassino del padre Egisto esperto di inganni che gli uccise il nobile padre 300 Anche tu caro infatti molto bello e grande ti vedo sii valoroso percheacute ti lodi anche qualcuno dei posteri Ma io tornerograve adesso alla nave veloce dai compagni che forse impazienti mi aspettano Tu devi pensarci da te dammi retta 305
[Tr di GA Privitera] Le stranezze non mancano davvero e cosigrave sono state messe a fuoco da Stephanie West nel suo commento23 1 Atena sa evidentemente molto piugrave di quanto uno come Mente avrebbe potuto sapere in particolare ella sa che i proci ignoreranno lrsquoinvito di Telemaco a lasciare la sua casa e fatto piugrave importante che gli degravei tra breve ricondurranno in patria Odisseo A queste osservazioni si puograve replicare con la stessa West che laquosi sono esagerate difficoltagrave e
23 Omero Odissea I cit 219 ss
Letteratura greca [1]
28
incongruenze alle quali un pubblico di ascoltatori (o anche un lettore moderatamente attento) probabilmente non farebbe casoraquo 2 Il progetto di una pubblica denuncia dei proci dinanzi agli degravei e agli uomini ai vv 273-274 egrave ciograve che Atena sembra prefiggersi nel promuovere lrsquoassemblea degli Itacesi (assemblea che effettivamente avragrave luogo a principio del canto II) drsquoaltra parte le successive istruzioni di AtenaMente ai vv 295 s (medita come uccidere i pretendenti) presuppongono che di quella richiesta da formulare nel corso dellrsquoassembla essi non terranno alcun conto Anche a questa osservazione si puograve rispondere che laquoegrave ragionevole attendersi che Telemaco condivida la previsione di un esito negativo della sua iniziativaraquo e si puograve aggiungere che pure in caso di insuccesso il ricorso allrsquoassemblea potrebbe ottenere almeno il risultato di screditare i pretendenti presso la comunitagrave itacese legittimando un successivo ricorso alla violenza (e si tratta di una legittimazione di cui anche lrsquoultimo canto mostreragrave lrsquoesigenza) 3 Dopo che Telemaco aveva detto che la madre non intendeva risposarsi (vv 249-250) AtenaMente si esprime ai vv 275-278 come se Penelope desiderasse proprio nuove nozze e inoltre sarebbe assurdo che il padre di Penelope cominciasse a contrattare un secondo matrimonio prima del ritorno di Telemaco dal suo viaggio e che mettesse mano a preparativi che rischierebbero di essere annullati qualche tempo dopo con inevitabile imbarazzo se Telemaco venisse a sapere che Odisseo egrave ancora vivo In piugrave lrsquoandamento sintattico di questi versi presenta un anacoluto durissimo per cui a principio del v 275 lrsquoaccusativo μητέρα egrave seguito da un ἂψ ἴτω (laquovada indietroraquo laquotorniraquo) che richiederebbe come soggetto un nominativo μήτηρ Come hanno reagito i lettori di Omero Nellrsquoantichitagrave un grammatico rimasto anonimo cambiava come attesta uno scolio μητέρ᾽ in μήτηρ nel secolo XVIII Richard Bentley modificava ἴτω in ἴμεν (infinito eolico di εἶμι laquovadoraquo) nel XIX un altro grande della filologia europea Gottfried Hermann risolveva piugrave drasticamente la questione eliminando il complesso dei vv 275-278 e la stessa West mostra simpatia per tale proposta supponendo laquounrsquoaggiunta posteriore modellata sul corrispondente passo del libro IIraquo (dove i vv 196 s sono identici ai vv 277 s e il v 195 copre lo stesso contenuto dei vv 275 s) Si tratta di procedimenti adeguati ai dati di fatto Migliorano davvero il testo che ci egrave stato tramandato In realtagrave ambedue le ldquocorrezionirdquo appena ricordate (di μήτερ᾽ e di ἴτω) ottengono un risultato tanto lineare che egrave davvero difficile pensare che lrsquoanacoluto avrebbe potuto invadere tutta la tradizione se non fosse stato originario e quanto allrsquoespunzione dei vv 275-278 essa indubbiamente peggiorerebbe il ritmo del discorso determinando lrsquoavvicinamento fra i due versi (v 271 e v 279) molto simili fra loro che aprono le due sequenze occupate dai consigli di Mente E allora La via piugrave saggia egrave senzrsquoaltro quella di tenerci qui come quasi sempre di fronte al testo omerico contraddizioni e anacoluti riconoscendo in essi lrsquoeffetto dellrsquoattivitagrave di un cantore che pur sulla base di una traccia largamente memorizzata restava pur sempre legato a quella prassi orale per cui composizione ed esecuzione tendevano a coincidere E lrsquoanacoluto si spiega bene se cerchiamo di immedesimarci nel procedimento seguito dal poeta Egli ha affidato ad Atena un certo flusso argomentativo per cui la dea deve dar consigli a Telemaco sui suoi rapporti coi proci e con la madre e cosigrave colloca in fine di v 274 un ἄνωχθι (laquoordinaraquo) destinato a reggere gli accusativi simmetricamente dislocati in principio di verso (vv 274 e 275) μνηστῆρας e μητέρα Senoncheacute giunto a questa seconda parte dellrsquoargomentazione egli si avvede quanto sarebbe illogico che Telemaco sollecitasse la madre a nuove nozze di qui lrsquoimprovviso cambio di costruzione che svincola al prezzo di una sensibile slogatura sintattica lrsquoipotesi delle nuove nozze dallrsquoordine impartito a Telemaco e la prospetta invece come un desiderio eventuale della stessa Penelope Il poeta ha un progetto ben meditato brani e sequenze piugrave volte sperimentati ed egrave col supporto di questi materiali giagrave elaborati che egli si fa strada attraverso le insidie della
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
20
stesso canto ai vv 518-527) di vendicare lrsquoaffronto subito da Achille o piugrave in generale con il corso degli eventi in quanto tutto come per definizione laquogiace sulle ginocchia di Zeusraquo Opera indubbiamente allrsquointerno del poema unrsquoidea formativa un progetto di qui un insieme monumentale unificato anche da una serie di corrispondenze a distanza fra cui particolare significato acquistano quelle fra primo e ultimo canto Nel canto I il vecchio Crise va come supplice presso Agamennone portando doni e supplicando la restituzione della figlia e Agamennone lo respinge aspramente minacciandolo di far ricorso alla violenza se dovesse tornare nel canto XXIV il vecchio Priamo va come supplice presso Achille portando doni e supplicando la restituzione del corpo del figlio Achille ha una prima reazione irosa (esordisce al v 560 con laquoSmetti di irritarmi vecchioraquo) ma poi accoglie la supplica E al di lagrave delle corrispondenze nelle linee dellrsquoazione si colgono fra principio e fine del poema alcuni importanti echi verbali in particolare fra XXIV 501 s
τοῦ νῦν εἵνεχ᾽ ἱκάνω νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενος παρὰ σεῖο φέρω δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα per lui [Ettore] vengo ora alle navi degli Achei per riscattarlo da te e ti porto compenso infinito
e I 12 s
ὁ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενός τε θυγάτρα φέρων δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα costui [Crise] venne alle navi rapide degli Achei per riscattare la figlia portando compenso infinito
fra XXIV 555-557
λῦσον ἵν᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἴδωmiddot σὺ δὲ δέξαι ἄποινα πολλά τά τοι φέρομενmiddot σὺ δὲ τῶνδrsquo ἀπόναιο καὶ ἔλθοις σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν restituiscimelo percheacute lo possa vedere con gli occhi e accogli il riscatto copioso che portiamo e tu possa goderne e tornare alla tua terra patria
e I 18-20
Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν εὖ δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκέσθαιmiddot παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην τὰ δ᾽ ἄποινα δέχεσθαι Atridi e voi altri Achei dai forti schinieri a voi concedano gli degravei che hanno le case in Olimpo di distruggere la cittagrave di Priamo e tornare facilmente in patria ma restituitemi la figlia e accettate il riscatto
fra XXIV 560 μηκέτι νῦν μ᾽ ἐρέθιζε (laquosmetti di irritarmiraquo) e I 32 μή μ᾽ ἐρέθιζε (laquonon mi irritareraquo) fra XXIV 568-570
τὼ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς μή σε γέρον οὐδrsquo αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω καὶ ἱκέτην περ ἐόντα Διὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμάς Ora perciograve fra i dolori non mi eccitare lrsquoanimo ancora di piugrave bada o vecchio che non ti lasci neppure nella tenda
Letteratura greca [1]
21
bencheacute supplice e violi gli ordini di Zeus e I 26-28
μή σε γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω ἢ νῦν δηθύνοντ᾽ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο Mai te o vecchio io colga presso le concave navi ora a indugiare o piugrave tardi a tornare che piugrave non dovesse giovarti lo scettro e la benda del dio
(e infine XXIV 571 ὣς ἔφατ ἔδεισεν δ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ laquocosigrave diceva e il vecchio tremograve e obbediva alle paroleraquo ripete esattamente I 33) In effetti lrsquoepisodio terminale del poema col superamento dellrsquoira ad opera della pietagrave e del senso di unrsquoesistenza invasa dal dolore si propone come il rovesciamento consapevole dellrsquoepisodio iniziale che era apparso caratterizzato dalla cancellazione della pietagrave e del diritto dei supplici in nome della forza Al rifiuto iniziale del donoriscatto si oppone lrsquoaccettazione finale in consonanza con un principio-guida che opera nel poema secondo linee che alla fine si riunificano Agamennone restituisce Criseide al padre ma si appropria del dono fatto dagli altri Achei ad Achille (Briseide) Achille respinge i doni fatti da Agamennone per indurlo a riconciliarsi con lui ma dopo aver contestato nel IX canto la nozione che la vita umana possa essere barattata con una massa di beni torna alla lotta non in cambio di qualche premio da conquistare ma per vendicare lrsquouccisione dellrsquoamico Patroclo e tanto nella lotta sul campo di battaglia quanto nellrsquoinfierire sul cadavere di Ettore si abbandona a un furore cosigrave smisurato e patologico che puograve essere superato solo con lrsquoaccettare i doni di Priamo non tuttavia per il loro valore drsquouso ma percheacute in Priamo Achille riconosce lrsquoombra del padre lontano Cosigrave lrsquoIliade appare attraversata da un impulso fondamentale che muove dallrsquoideologia del dono e dalla conseguente centralitagrave assegnata allrsquoonore (τιμή) come ldquoprezzordquo che qualifica il valore del guerriero ma supera questo piano di valutazione dei rapporti umani attraverso la loro riformulazione nei termini di un umanesimo esistenziale che ha come punti di riferimento lrsquoidentitagrave universale dei condizionamenti oggettivi (la vecchiaia la malattia la morte) e i legami che uniscono padre e figlio compagno e compagno vivi e morti (il cordoglio finale di Andromaca Ecuba ed Elena sulla salma di Ettore) Entro questo orizzonte progressivamente allargato la guerra le lotte lo scontro mortale finiscono col rappresentare solo un momento e un aspetto dellrsquoesistenza graditi tanto agli degravei che vi assistono come spettatori interessati quanto agli uditori che riascoltano le antiche gesta eppure non tali da appiattire il poema in una prospettiva guerresca conclusa in se stessa Molto del fascino delle battaglie e delle ἀριστεῖαι dellrsquoIliade sta nella presenza recondita di un occhio che sa guardare al di lagrave di esse (e al di lagrave della stessa distinzione fra Greci e Troiani vincitori e vinti) e che puograve anche attraverso le similitudini lasciare irrompere il mondo della natura o del lavoro umano nel mezzo delle battaglie LʼOdissea LrsquoOdissea (Ὀδύσσεια) consta di circa 12100 esametri divisi anchrsquoessi in 24 libri e indicati con le lettere minuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquoargomento egrave costituito dalle avventure di Odisseo dalla distruzione di Troia al ritorno alla patria Itaca esposte secondo un ordine che entrando subito nel vivo degli avvenimenti (lrsquoinizio del poema mostra Odisseo nellrsquoisola di Calipso) rievoca poi i fatti giagrave trascorsi e li ricongiunge infine a partire dal libro XV (con lrsquoarrivo di Telemaco alla capanna di Eumeo dove giagrave si trova Odisseo) in unrsquoazione unitaria La trama del poema i cui avvenimenti sono concentrati cronologicamente nello spazio di 40 giorni (ma sono narrati solo gli avvenimenti di 16 giorni e 8 notti) si articola in tre parti la laquoTelemachiaraquo (canti I-IV) il laquoRitorno di Odisseoraquo (canti V-XIII) e la laquoVendetta di Odisseoraquo (canti XIV-XXIV)
Letteratura greca [1]
22
Canto I Tutti gli eroi superstiti sono ormai tornati da Troia alle loro case tranne Odisseo che pur desideroso di tornare egrave trattenuto dalla ninfa Calipso nellrsquoisola di Ogigia Gli degravei hanno pietagrave di lui tranne Posidone irato per lrsquoaccecamento del figlio il ciclope Polifemo Ma un consiglio degli degravei assente Posidone (che si egrave recato presso gli Etiopi) delibera il ritorno dellrsquoeroe si decide che Ermes andragrave subito da Calipso mentre Atena si avvia verso Itaca sotto lrsquoaspetto del signore dei Tafi Mente per incoraggiare il figlio di Odisseo Telemaco a tener testa ai pretendenti della madre i laquoprociraquo (i quali aspirano al regno tramite le nozze con Penelope) e per indurlo a intraprendere un viaggio in cerca di notizie sul padre Canto IΙ Telemaco segue il consiglio della dea e il giorno seguente nellrsquoassemblea popolare chiede una nave per andare in cerca del padre ma la sua richiesta non viene discussa e Leocrito scioglie lrsquoassemblea Grazie ad Atena che ora ha assunto le sembianze di Mentore (antico amico di Odisseo) Telemaco riesce tuttavia a trovare una nave con cui salpa nel corso della notte allrsquoinsaputa sia della madre che dei proci Canto IΙΙ Telemaco e MentoreAtena arrivano a Pilo e sul lido trovano Nestore che sta offrendo un sacrificio a Posidone Il vecchio eroe accoglie ospitalmente Telemaco e gli comunica molte notizie sul ritorno di altri Achei ma nessuna su Odisseo Alla sera Atena scompare in forma di aquila e il mattino seguente Telemaco salpa insieme con Pisistrato (figlio di Nestore) alla volta di Sparta dove arriva la sera del giorno successivo Canto IV A Sparta Menelao sta festeggiando il doppio matrimonio del figlio e della figlia Il giorno seguente Telemaco chiede del padre Menelao gli racconta il proprio ritorno durante il quale aveva incontrato Proteo il vecchio nume marino che gli aveva riferito come Odisseo fosse trattenuto nellrsquoisola di Calipso Intanto a Itaca i proci preparano insidie meditando di uccidere Telemaco al suo ritorno Penelope ne viene a conoscenza ma Atena le appare in sogno per confortarla Canto V Dopo un secondo concilio degli degravei (in effetti un ldquodoppionerdquo di quello del I canto) Zeus manda finalmente Ermes presso Calipso con lrsquoordine di lasciar partire Odisseo La ninfa aiuta lrsquoeroe a costruirsi una zattera Al diciottesimo giorno di navigazione Odisseo egrave in vista dellrsquoisola dei Feaci Scheria quando Posidone di ritorno dal suo soggiorno presso gli Etiopi lo vede e suscita una tempesta che distrugge la zattera Ma la dea marina Ino Leucotea impietositasi gli porge il proprio velo sostenuto dal quale lrsquoeroe giunge a nuoto alla riva di Scheria dove si abbandona esausto addormentandosi Canto VI In seguito a un sogno inviatole da Atena Nausicaa la figlia del re dei Feaci Alcinoo si reca nei pressi della spiaggia a lavare le vesti insieme con le ancelle Odisseo risvegliatosi atterrisce le fanciulle che fuggono tutte allrsquoinfuori di Nausicaa Lrsquoeroe supplica la giovane di porgerle aiuto ed ella lo fa rivestire e lo accompagna fino al bosco di Atena poco prima della cittagrave esortandolo a presentarsi a suo padre Canto VII Protetto dalla nebbia di cui Atena lo ha avvolto Odisseo entra nel palazzo abbraccia le ginocchia della regina Arete e la caligine scompare poi viene accolto con onore da Alcinoo Arete chiede a Odisseo donde provenga e chi gli abbia donato gli abiti (a lei ben noti) che indossa Lrsquoeroe inizia a raccontare le disavventure che gli sono occorse dopo la
Letteratura greca [1]
23
partenza dallrsquoisola di Calipso Alcinoo gli promette di farlo ricondurre a Itaca il giorno seguente Canto VIII Ma lrsquoindomani Alcinoo fa apprestare un banchetto durante il quale lrsquoaedo Demodoco canta della contesa insorta un giorno fra Achille e Odisseo Lrsquoeroe si copre il volto per nascondere le lacrime allora Alcinoo interrompe il canto e organizza una serie di gare nel corso delle quali Odisseo primeggia Poi Demodoco al margine di unrsquoarea per la danza dove si esibiscono i ballerini feaci canta gli amori di Ares e Afrodite e la vendetta di Efesto (che incatena i due amanti) La sera al ritorno nel palazzo Demodoco racconta la storia del Cavallo di legno Odisseo scoppia nuovamente in lacrime e Alcinoo gli chiede di rivelare il suo nome Canto IX Odisseo dichiara il proprio nome e dagrave inizio al racconto della propria storia a partire dalla caduta di Troia distruzione di Ismaro e perdite subite ad opera dei Ciconi sbarco presso i Lotofagi (che si nutrono di un cibo misterioso che fa dimenticare il ritorno) dopo una terribile tempesta scatenatasi durante il tentativo di doppiare il capo Malea arrivo allrsquoisola antistante quella dei Ciclopi dove Odisseo si trasferisce con una sola nave esplorazione dellrsquoisola perdita di alcuni compagni allrsquointerno della caverna del gigante monocolo accecamento del mostro e fuga Canto X Odisseo giunge allrsquoisola di Eolo signore dei venti che lo accoglie benevolmente e gli consegna alla partenza tutti i venti chiusi in un otre ma poi lo respinge con durezza quando ritorna presso di lui percheacute i compagni (sospettando che nellrsquootre siano racchiuse cospicue ricchezze) hanno sciolto i venti e da essi si egrave sprigionato un uragano che li ha risospinti sullrsquoisola Ripreso il mare Odisseo egrave trasportato fino ai Lestrigoni antropofagi il cui attacco priva lrsquoeroe di tutte le altre navi tranne la propria Con questa fugge fino allrsquoisola (Eea) della maga Circe Dopo che Circe ha trasformato in porci un gruppo di compagni mandati innanzi ad esplorare lrsquoisola Odisseo ha la meglio sulla maga (a cui impone di restituire forma umana ai compagni) grazie allrsquoerba moly fornitagli da Ermes Resta un anno presso Circe che al momento della partenza gli consiglia di recarsi al paese dei morti per interrogare il vate Tiresia Canto XI Approdato alla terra dei Cimmeri (che vivono immersi in una nebbia perenne sulla riva dellrsquoOceano) e scavata una fossa Odisseo sacrifica ai morti e immola una vittima speciale a Tiresia Le anime accorrono dapprima Elpenore caduto per caso giugrave dal tetto della casa di Circe (Odisseo gli promette sepoltura) poi la madre Anticlea (che gli racconta di esser morta di dolore per la sua assenza) quindi Tiresia che gli vaticina le sue vicende future fino alla morte (questa lo coglieragrave dopo una lunga vita in un paese straniero che non conosce neacute il sale neacute il remo) Da un certo punto in poi il poeta dimentica il presupposto per cui Odisseo aveva scavato una fossa alla quale i morti accorrevano per bere il sangue delle vittime e bevendolo riacquistavano per breve tempo una piena consapevolezza immagina invece che Odisseo sia allrsquointerno dellrsquoAde In questa sezione rientrano la descrizione di Aiace sdegnato di Minosse di Orione dei grandi peccatori di Eracle Poi Odisseo fa ritorno a Eea e ricevuti i consigli di Circe si imbarca per il ritorno in patria Canto XII Scampato alle Sirene che invano lo attirano col canto (si egrave fatto legare allrsquoalbero della nave i compagni che remano hanno le orecchie turate con la cera) passa tra Cariddi e Scilla (che gli rapisce sei uomini) ed egrave costretto dai compagni ad approdare in contrasto con le prescrizioni di Circe allrsquoisola Trinachia dove pascolano le greggi del Sole I
Letteratura greca [1]
24
compagni spronati da Euriloco se ne cibano nonostante il divieto dellrsquoeroe Il Sole sdegnato ottiene da Zeus che la nave sia colpita dal fulmine Tutti i compagni periscono ma Odisseo che ripassa tra Scilla e Cariddi si salva miracolosamente da questrsquoultima aggrappandosi a un fico selvatico fincheacute il gorgo restituisce i rottami della nave infine arriva remando con le mani allrsquoisola di Ogigia Canto XIII Terminato il racconto lrsquoeroe riceve doni dai Feaci e la notte seguente egrave ricondotto a Itaca e deposto addormentato sulla spiaggia presso un antro sacro alle Ninfe Al risveglio per la nebbia non riconosce la sua terra fincheacute Atena in veste di giovane pastore lo rassicura e poi rivelatasi gli dagrave istruzioni su come far strage dei proci e lo trasforma in un vecchio mendico Canto XIV Odisseo si reca allo stazzo del suo porcaio Eumeo che pur non riconoscendolo lo accoglie ospitalmente rifocillandolo e offrendogli un mantello per ripararsi dal gelo notturno Canto XV A questo punto la laquoTelemachiaraquo si riannoda allrsquoazione principale Telemaco che si trova ancora a Sparta viene indotto da Atena a tornare a Itaca sulla via del ritorno a Pilo accoglie a bordo lrsquoindovino Teoclimeno e grazie allrsquoaiuto della dea sfugge alle insidie dei proci sbarca a Itaca e si reca anchrsquoegli presso Eumeo Canto XVI Questi va da Penelope ad annunciargli il ritorno del figlio Intanto Odisseo rimosso lrsquoincantesimo si svela nel suo vero aspetto a Telemaco e con lui progetta la vendetta sui proci (che intanto tramano una nuova insidia ai danni di Telemaco) Eumeo torna al suo stazzo Canto XVII Il mattino seguente Telemaco si reca in cittagrave seguito in un secondo tempo da Eumeo e Odisseo (che ha riassunto lrsquoaspetto di mendico) Davanti al palazzo Odisseo egrave riconosciuto dal cane Argo Entra e va mendicando tra i proci Antinoo lo colpisce alla spalla destra con uno sgabello Canto XVIII Odisseo si batte al pugilato col mendicante Iro Penelope scesa nella sala prospetta ai proci lrsquoeventualitagrave di un nuovo matrimonio Odisseo egrave insultato dalla schiava Melanto e schiva uno sgabello scagliato da Eurinomo Canto XIX Insieme con Telemaco lrsquoeroe allontana le armi dalla sala poi conversa con Penelope che gli racconta un sogno e gli espone il suo piano per sedare le contese tra i proci concedendosi sposa a colui che riusciragrave a tendere lrsquoarco di Odisseo la prova avverragrave il giorno seguente al novilunio Durante il colloquio la fida schiava Euriclea lava i piedi di Odisseo e riconosciutolo da unrsquoantica cicatrice sta per rivelarne lrsquoidentitagrave ma lrsquoeroe la costringe a tacere Canto XX Al mattino Euriclea e le ancelle fanno i preparativi per il banchetto Giungono Eumeo Melanzio e il mandriano Filezio Un presagio mandato da Zeus dissuade i proci dal progetto di uccidere Telemaco Durante il banchetto Teoclimeno predice la loro imminente rovina
Letteratura greca [1]
25
Canto XXI Penelope conduce lrsquoarco nella sala dopo che parecchi fra i proci e lo stesso Telemaco hanno tentato invano di tenderne la corda Odisseo chiede di partecipare alla prova tende lrsquoarco senza fatica e riesce a far passare la freccia attraverso gli anelli di dodici scuri predisposte da Telemaco Canto XXII Poi scaglia le frecce sui proci e si rivela nella sua identitagrave Nella lotta che segue Telemaco Eumeo e Filezio aiutano il padrone contro i proci (appoggiati dal capraio Melanzio) Tutti i proci restano uccisi le ancelle infedeli sono impiccate Melanzio viene mutilato e ucciso soltanto lrsquoaedo Femio e lrsquoaraldo Medonte sono risparmiati Canto XXIII Nuovo colloquio fra Odisseo e Penelope che durante lrsquoeccidio dormiva ed egrave stata svegliata da Euriclea Penelope esita ancora a riconoscere il marito e non si arrende alla veritagrave fincheacute Odisseo non le descrive la posizione e la struttura del letto coniugale Canto XXIV Ermes conduce allrsquoAde le ombre dei proci Odisseo fa visita al padre Laerte nella masseria dove quello vive nello squallore e nellrsquoemarginazione e si fa riconoscere Intanto il padre di Antinoo incita gli Itacesi alla rivolta e il poema si conclude con lo scontro di Odisseo e dei suoi contro i concittadini lrsquoeroe ha la meglio e Zeus scagliato il fulmine pone fine alla battaglia Atena sotto lrsquoaspetto di Mentore stabilisce fra i contendenti un patto per il futuro36
Struttura e caratteri dellʼopera Giagrave la prima parola del proemio (ἄνδρα) non menziona come tema dellrsquoopera un determinato episodio della vita del protagonista ma il protagonista stesso (I 1-10)
Ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα πολύτροπον ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεmiddot πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περmiddot αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο νήπιοι οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιονmiddot αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ τῶν ἁμόθεν γε θεά θύγατερ Διός εἰπὲ καὶ ἡμῖν Dellrsquouomo multiforme a me racconta o Musa che molto errograve dopo che di Troia la sacra rocca distrusse di molti uomini vide le cittagrave riconobbe il pensiero e molti per il mare patigrave dolori nellrsquoanimo per salvare la sua vita e il ritorno dei compagni Eppure non li salvograve i compagni per quanto bramasse per la loro stessa follia si persero gli stolti i buoi del Sole Iperione mangiarono e quello rapigrave ad essi il digrave del ritorno Di questo da un punto qualsiasi narra anche a noi o dea figlia di Zeus
Storie favolose di naviganti racconti imperniati sul ritorno dei guerrieri achei che avevano combattuto a Troia e il particolare rientro in patria di Odisseo figlio di Laerte erano forse giagrave stati connessi e intrecciati nella precedente tradizione epica sigrave che il presente cantore poteva
Letteratura greca [1]
26
metter mano alla vicenda partendo (v 10) laquoda un punto qualsiasiraquo (ἁμόθεν) una notazione che certo presuppone la convenzione propria dellrsquoesordio tradizionale di un canto epico comparabile con i giagrave ricordati ἐξ οὗ (laquoda quandoraquo) di Iliade I 4 ed ἔνθεν (laquoda doveraquo) di Odissea VIII 500 Senoncheacute rispetto a queste indicazioni di tipo puntuale il tratto costituito dalla dimensione casuale quasi arbitraria inerente ad ἁμόθεν proprio mentre dichiara lrsquoassenza di un determinato piano compositivo implica in realtagrave che il racconto non si svolgeragrave per filo e per segno secondo lrsquoordine noto a poeta e uditori non si snoderagrave κατὰ κόσμον (laquoper ordineraquo) come il canto di Demodoco (VIII 489) ma seguiragrave un andamento originale Il ldquopunto qualsiasirdquo incipitario non rappresenta una scelta della Musa (figura dellrsquoarchivio tematico che conserva le laquovieraquo dellrsquoepica) bensigrave di questo cantore che ha deciso di far incominciare la narrazione in medias res e ha in serbo la sorpresa di far succedere al concilio degli degravei (che decide lrsquoinvio di Ermes presso Calipso) non lrsquoazione testeacute programmata (azione che viene differita con un ritardo che a piugrave riprese ha scandalizzato i lettori a principio del V canto) ma la partenza di Atena alla volta di Itaca e lrsquoavvio della laquoTelemachiaraquo Le due diverse vicende proposte a principio del poema quella di Telemaco e quella di Odisseo procedono infatti in parallelo coprendo un analogo lasso di tempo Piugrave oltre la decisione di trasformare la sequenza narrativa che va dalla partenza di Odisseo da Troia fino al suo arrivo nella terra dei Feaci in una rievocazione fatta dallrsquoeroe in prima persona al cospetto di Alcinoo e dei Feaci (la sezione detta degli ἀπόλογοι laquoraccontiraquo) crea una struttura ad anello che parte dal presente e ad esso fa ritorno dopo aver ricostruito le premesse della condizione attuale del protagonista Col canto XIII Odisseo egrave riportato dai Feaci a Itaca e questo permette la saldatura fra le vicende sue e quelle di Telemaco sia pure col differimento dellrsquoincontro e del riconoscimento fra padre e figlio fino al canto XVI Far scorrere in parallelo sequenze distinte organizzare programmi narrativi a corta e a lunga gittata tendere o allentare ad arte il ritmo della narrazione non si tratta davvero di procedimenti che potessero configurarsi come tradizionali dellrsquoarte epica quanto piuttosto di un momento sperimentale di una ricerca di soluzioni nuove al termine di una lunga e ormai consolidata sedimentazione di percorsi compiuti allrsquointerno di un determinato repertorio tematico unrsquoaudacia inventiva una πολυτροπίη degne del protagonista del poema che inevitabilmente comportavano rischi molteplici di incoerenze dissonanze occasionali avarie della macchina epica e che tuttavia erano destinate a conseguire un risultato assolutamente convincente allrsquoorecchio di chi si abbandonasse al fascino del racconto senza lrsquourgenza propria di altre etagrave e di altre mentalitagrave di puntare il dito sui singoli dettagli o le singole sfasature
PER SAPERNE DI PIUrsquo Difficoltagrave e incongruenze della narrazione omerica Forti della possibilitagrave di un controllo su un testo scritto che possiamo percorrere in avanti e a ritroso secondo ritmi di nostra scelta a noi non riesce difficile cogliere alcune delle difficoltagrave organizzative incontrate nella composizione del poema In proposito per ricordare un caso che saragrave allrsquoorigine delle discussioni di orientamento ldquoanaliticordquo intorno allrsquoOdissea possiamo leggere il discorso che Atena prese le sembianze di Mente re dei Tafi rivolge a Telemaco nel I canto (vv 253-305) Ah infelice ti manca molto davvero lrsquoassente Odisseo che getti le mani addosso ai pretendenti sfrontati Percheacute se ora tornato stesse sulla soglia 255 con una scure lo scudo e due lance cosigrave come io per la prima volta lo vidi in casa nostra che beveva e godeva di ritorno da Efira da Ilo di Mermero (andograve anche ligrave Odisseo con la nave veloce 260 in cerca del veleno omicida per averne da ungere le frecce di bronzo ma quello non glielo diede percheacute temeva gli dei che vivono eterni
Letteratura greca [1]
27
glielo diede invece mio padre percheacute lrsquoamava moltissimo) se stesse Odisseo tra i pretendenti cosigrave 265 essi avrebbero tutti rapida morte e nozze amare Ma sulle ginocchia degli dei questo giace se una volta tornato faragrave o no vendetta nella sua casa te invece io esorto a riflettere come cacciare i pretendenti da casa 270 Ebbene ora ascolta e alle mie parole darsquo retta Domattina chiamati gli eroi Achei a consiglio rivolgi a tutti un discorso e siano testimoni gli dei Ai pretendenti comanda drsquoandarsene per i fatti loro e tua madre se lrsquoanimo la spinge alle nozze 275 ritorni a casa del padre molto potente Prepareranno essi le nozze e disporranno i doni nuziali moltissimi quanti gli pare che debbano andare alla figlia A te darograve un saggio consiglio se vuoi ascoltarlo armata una nave con venti remi la migliore che crsquoegrave 280 Varsquo a domandare del padre partito da tempo se mai te ne parli un mortale o sentissi da Zeus la voce che divulga la fama tra gli uomini Anzitutto varsquo a Pilo e interroga il chiaro Nestore di ligrave poi varsquo a Sparta dal biondo Menelao 285 degli Achei vestiti di bronzo egli egrave tornato per ultimo Se senti dire qualcosa sulla vita e il ritorno del padre per quanto stremato potresti sopportare un altro anno se invece senti dire che egrave morto e non vive allora tornato nella cara terra patria 290 ergigli un tumulo e offrigli funebri offerte moltissime quanto conviene e darsquo tua madre a un marito E poi dopo aver compiuto e fatto ogni cosa allora medita nella mente e nellrsquoanimo come tu possa uccidere nelle tue case 295 i pretendenti con lrsquoinganno affrontandoli non devi piugrave avere i modi di un bimbo percheacute ormai non sei tale Non senti lrsquoillustre Oreste quale gloria ha acquistato fra tutti gli uomini percheacute uccise lrsquoassassino del padre Egisto esperto di inganni che gli uccise il nobile padre 300 Anche tu caro infatti molto bello e grande ti vedo sii valoroso percheacute ti lodi anche qualcuno dei posteri Ma io tornerograve adesso alla nave veloce dai compagni che forse impazienti mi aspettano Tu devi pensarci da te dammi retta 305
[Tr di GA Privitera] Le stranezze non mancano davvero e cosigrave sono state messe a fuoco da Stephanie West nel suo commento23 1 Atena sa evidentemente molto piugrave di quanto uno come Mente avrebbe potuto sapere in particolare ella sa che i proci ignoreranno lrsquoinvito di Telemaco a lasciare la sua casa e fatto piugrave importante che gli degravei tra breve ricondurranno in patria Odisseo A queste osservazioni si puograve replicare con la stessa West che laquosi sono esagerate difficoltagrave e
23 Omero Odissea I cit 219 ss
Letteratura greca [1]
28
incongruenze alle quali un pubblico di ascoltatori (o anche un lettore moderatamente attento) probabilmente non farebbe casoraquo 2 Il progetto di una pubblica denuncia dei proci dinanzi agli degravei e agli uomini ai vv 273-274 egrave ciograve che Atena sembra prefiggersi nel promuovere lrsquoassemblea degli Itacesi (assemblea che effettivamente avragrave luogo a principio del canto II) drsquoaltra parte le successive istruzioni di AtenaMente ai vv 295 s (medita come uccidere i pretendenti) presuppongono che di quella richiesta da formulare nel corso dellrsquoassembla essi non terranno alcun conto Anche a questa osservazione si puograve rispondere che laquoegrave ragionevole attendersi che Telemaco condivida la previsione di un esito negativo della sua iniziativaraquo e si puograve aggiungere che pure in caso di insuccesso il ricorso allrsquoassemblea potrebbe ottenere almeno il risultato di screditare i pretendenti presso la comunitagrave itacese legittimando un successivo ricorso alla violenza (e si tratta di una legittimazione di cui anche lrsquoultimo canto mostreragrave lrsquoesigenza) 3 Dopo che Telemaco aveva detto che la madre non intendeva risposarsi (vv 249-250) AtenaMente si esprime ai vv 275-278 come se Penelope desiderasse proprio nuove nozze e inoltre sarebbe assurdo che il padre di Penelope cominciasse a contrattare un secondo matrimonio prima del ritorno di Telemaco dal suo viaggio e che mettesse mano a preparativi che rischierebbero di essere annullati qualche tempo dopo con inevitabile imbarazzo se Telemaco venisse a sapere che Odisseo egrave ancora vivo In piugrave lrsquoandamento sintattico di questi versi presenta un anacoluto durissimo per cui a principio del v 275 lrsquoaccusativo μητέρα egrave seguito da un ἂψ ἴτω (laquovada indietroraquo laquotorniraquo) che richiederebbe come soggetto un nominativo μήτηρ Come hanno reagito i lettori di Omero Nellrsquoantichitagrave un grammatico rimasto anonimo cambiava come attesta uno scolio μητέρ᾽ in μήτηρ nel secolo XVIII Richard Bentley modificava ἴτω in ἴμεν (infinito eolico di εἶμι laquovadoraquo) nel XIX un altro grande della filologia europea Gottfried Hermann risolveva piugrave drasticamente la questione eliminando il complesso dei vv 275-278 e la stessa West mostra simpatia per tale proposta supponendo laquounrsquoaggiunta posteriore modellata sul corrispondente passo del libro IIraquo (dove i vv 196 s sono identici ai vv 277 s e il v 195 copre lo stesso contenuto dei vv 275 s) Si tratta di procedimenti adeguati ai dati di fatto Migliorano davvero il testo che ci egrave stato tramandato In realtagrave ambedue le ldquocorrezionirdquo appena ricordate (di μήτερ᾽ e di ἴτω) ottengono un risultato tanto lineare che egrave davvero difficile pensare che lrsquoanacoluto avrebbe potuto invadere tutta la tradizione se non fosse stato originario e quanto allrsquoespunzione dei vv 275-278 essa indubbiamente peggiorerebbe il ritmo del discorso determinando lrsquoavvicinamento fra i due versi (v 271 e v 279) molto simili fra loro che aprono le due sequenze occupate dai consigli di Mente E allora La via piugrave saggia egrave senzrsquoaltro quella di tenerci qui come quasi sempre di fronte al testo omerico contraddizioni e anacoluti riconoscendo in essi lrsquoeffetto dellrsquoattivitagrave di un cantore che pur sulla base di una traccia largamente memorizzata restava pur sempre legato a quella prassi orale per cui composizione ed esecuzione tendevano a coincidere E lrsquoanacoluto si spiega bene se cerchiamo di immedesimarci nel procedimento seguito dal poeta Egli ha affidato ad Atena un certo flusso argomentativo per cui la dea deve dar consigli a Telemaco sui suoi rapporti coi proci e con la madre e cosigrave colloca in fine di v 274 un ἄνωχθι (laquoordinaraquo) destinato a reggere gli accusativi simmetricamente dislocati in principio di verso (vv 274 e 275) μνηστῆρας e μητέρα Senoncheacute giunto a questa seconda parte dellrsquoargomentazione egli si avvede quanto sarebbe illogico che Telemaco sollecitasse la madre a nuove nozze di qui lrsquoimprovviso cambio di costruzione che svincola al prezzo di una sensibile slogatura sintattica lrsquoipotesi delle nuove nozze dallrsquoordine impartito a Telemaco e la prospetta invece come un desiderio eventuale della stessa Penelope Il poeta ha un progetto ben meditato brani e sequenze piugrave volte sperimentati ed egrave col supporto di questi materiali giagrave elaborati che egli si fa strada attraverso le insidie della
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
21
bencheacute supplice e violi gli ordini di Zeus e I 26-28
μή σε γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω ἢ νῦν δηθύνοντ᾽ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο Mai te o vecchio io colga presso le concave navi ora a indugiare o piugrave tardi a tornare che piugrave non dovesse giovarti lo scettro e la benda del dio
(e infine XXIV 571 ὣς ἔφατ ἔδεισεν δ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ laquocosigrave diceva e il vecchio tremograve e obbediva alle paroleraquo ripete esattamente I 33) In effetti lrsquoepisodio terminale del poema col superamento dellrsquoira ad opera della pietagrave e del senso di unrsquoesistenza invasa dal dolore si propone come il rovesciamento consapevole dellrsquoepisodio iniziale che era apparso caratterizzato dalla cancellazione della pietagrave e del diritto dei supplici in nome della forza Al rifiuto iniziale del donoriscatto si oppone lrsquoaccettazione finale in consonanza con un principio-guida che opera nel poema secondo linee che alla fine si riunificano Agamennone restituisce Criseide al padre ma si appropria del dono fatto dagli altri Achei ad Achille (Briseide) Achille respinge i doni fatti da Agamennone per indurlo a riconciliarsi con lui ma dopo aver contestato nel IX canto la nozione che la vita umana possa essere barattata con una massa di beni torna alla lotta non in cambio di qualche premio da conquistare ma per vendicare lrsquouccisione dellrsquoamico Patroclo e tanto nella lotta sul campo di battaglia quanto nellrsquoinfierire sul cadavere di Ettore si abbandona a un furore cosigrave smisurato e patologico che puograve essere superato solo con lrsquoaccettare i doni di Priamo non tuttavia per il loro valore drsquouso ma percheacute in Priamo Achille riconosce lrsquoombra del padre lontano Cosigrave lrsquoIliade appare attraversata da un impulso fondamentale che muove dallrsquoideologia del dono e dalla conseguente centralitagrave assegnata allrsquoonore (τιμή) come ldquoprezzordquo che qualifica il valore del guerriero ma supera questo piano di valutazione dei rapporti umani attraverso la loro riformulazione nei termini di un umanesimo esistenziale che ha come punti di riferimento lrsquoidentitagrave universale dei condizionamenti oggettivi (la vecchiaia la malattia la morte) e i legami che uniscono padre e figlio compagno e compagno vivi e morti (il cordoglio finale di Andromaca Ecuba ed Elena sulla salma di Ettore) Entro questo orizzonte progressivamente allargato la guerra le lotte lo scontro mortale finiscono col rappresentare solo un momento e un aspetto dellrsquoesistenza graditi tanto agli degravei che vi assistono come spettatori interessati quanto agli uditori che riascoltano le antiche gesta eppure non tali da appiattire il poema in una prospettiva guerresca conclusa in se stessa Molto del fascino delle battaglie e delle ἀριστεῖαι dellrsquoIliade sta nella presenza recondita di un occhio che sa guardare al di lagrave di esse (e al di lagrave della stessa distinzione fra Greci e Troiani vincitori e vinti) e che puograve anche attraverso le similitudini lasciare irrompere il mondo della natura o del lavoro umano nel mezzo delle battaglie LʼOdissea LrsquoOdissea (Ὀδύσσεια) consta di circa 12100 esametri divisi anchrsquoessi in 24 libri e indicati con le lettere minuscole dellrsquoalfabeto greco Lrsquoargomento egrave costituito dalle avventure di Odisseo dalla distruzione di Troia al ritorno alla patria Itaca esposte secondo un ordine che entrando subito nel vivo degli avvenimenti (lrsquoinizio del poema mostra Odisseo nellrsquoisola di Calipso) rievoca poi i fatti giagrave trascorsi e li ricongiunge infine a partire dal libro XV (con lrsquoarrivo di Telemaco alla capanna di Eumeo dove giagrave si trova Odisseo) in unrsquoazione unitaria La trama del poema i cui avvenimenti sono concentrati cronologicamente nello spazio di 40 giorni (ma sono narrati solo gli avvenimenti di 16 giorni e 8 notti) si articola in tre parti la laquoTelemachiaraquo (canti I-IV) il laquoRitorno di Odisseoraquo (canti V-XIII) e la laquoVendetta di Odisseoraquo (canti XIV-XXIV)
Letteratura greca [1]
22
Canto I Tutti gli eroi superstiti sono ormai tornati da Troia alle loro case tranne Odisseo che pur desideroso di tornare egrave trattenuto dalla ninfa Calipso nellrsquoisola di Ogigia Gli degravei hanno pietagrave di lui tranne Posidone irato per lrsquoaccecamento del figlio il ciclope Polifemo Ma un consiglio degli degravei assente Posidone (che si egrave recato presso gli Etiopi) delibera il ritorno dellrsquoeroe si decide che Ermes andragrave subito da Calipso mentre Atena si avvia verso Itaca sotto lrsquoaspetto del signore dei Tafi Mente per incoraggiare il figlio di Odisseo Telemaco a tener testa ai pretendenti della madre i laquoprociraquo (i quali aspirano al regno tramite le nozze con Penelope) e per indurlo a intraprendere un viaggio in cerca di notizie sul padre Canto IΙ Telemaco segue il consiglio della dea e il giorno seguente nellrsquoassemblea popolare chiede una nave per andare in cerca del padre ma la sua richiesta non viene discussa e Leocrito scioglie lrsquoassemblea Grazie ad Atena che ora ha assunto le sembianze di Mentore (antico amico di Odisseo) Telemaco riesce tuttavia a trovare una nave con cui salpa nel corso della notte allrsquoinsaputa sia della madre che dei proci Canto IΙΙ Telemaco e MentoreAtena arrivano a Pilo e sul lido trovano Nestore che sta offrendo un sacrificio a Posidone Il vecchio eroe accoglie ospitalmente Telemaco e gli comunica molte notizie sul ritorno di altri Achei ma nessuna su Odisseo Alla sera Atena scompare in forma di aquila e il mattino seguente Telemaco salpa insieme con Pisistrato (figlio di Nestore) alla volta di Sparta dove arriva la sera del giorno successivo Canto IV A Sparta Menelao sta festeggiando il doppio matrimonio del figlio e della figlia Il giorno seguente Telemaco chiede del padre Menelao gli racconta il proprio ritorno durante il quale aveva incontrato Proteo il vecchio nume marino che gli aveva riferito come Odisseo fosse trattenuto nellrsquoisola di Calipso Intanto a Itaca i proci preparano insidie meditando di uccidere Telemaco al suo ritorno Penelope ne viene a conoscenza ma Atena le appare in sogno per confortarla Canto V Dopo un secondo concilio degli degravei (in effetti un ldquodoppionerdquo di quello del I canto) Zeus manda finalmente Ermes presso Calipso con lrsquoordine di lasciar partire Odisseo La ninfa aiuta lrsquoeroe a costruirsi una zattera Al diciottesimo giorno di navigazione Odisseo egrave in vista dellrsquoisola dei Feaci Scheria quando Posidone di ritorno dal suo soggiorno presso gli Etiopi lo vede e suscita una tempesta che distrugge la zattera Ma la dea marina Ino Leucotea impietositasi gli porge il proprio velo sostenuto dal quale lrsquoeroe giunge a nuoto alla riva di Scheria dove si abbandona esausto addormentandosi Canto VI In seguito a un sogno inviatole da Atena Nausicaa la figlia del re dei Feaci Alcinoo si reca nei pressi della spiaggia a lavare le vesti insieme con le ancelle Odisseo risvegliatosi atterrisce le fanciulle che fuggono tutte allrsquoinfuori di Nausicaa Lrsquoeroe supplica la giovane di porgerle aiuto ed ella lo fa rivestire e lo accompagna fino al bosco di Atena poco prima della cittagrave esortandolo a presentarsi a suo padre Canto VII Protetto dalla nebbia di cui Atena lo ha avvolto Odisseo entra nel palazzo abbraccia le ginocchia della regina Arete e la caligine scompare poi viene accolto con onore da Alcinoo Arete chiede a Odisseo donde provenga e chi gli abbia donato gli abiti (a lei ben noti) che indossa Lrsquoeroe inizia a raccontare le disavventure che gli sono occorse dopo la
Letteratura greca [1]
23
partenza dallrsquoisola di Calipso Alcinoo gli promette di farlo ricondurre a Itaca il giorno seguente Canto VIII Ma lrsquoindomani Alcinoo fa apprestare un banchetto durante il quale lrsquoaedo Demodoco canta della contesa insorta un giorno fra Achille e Odisseo Lrsquoeroe si copre il volto per nascondere le lacrime allora Alcinoo interrompe il canto e organizza una serie di gare nel corso delle quali Odisseo primeggia Poi Demodoco al margine di unrsquoarea per la danza dove si esibiscono i ballerini feaci canta gli amori di Ares e Afrodite e la vendetta di Efesto (che incatena i due amanti) La sera al ritorno nel palazzo Demodoco racconta la storia del Cavallo di legno Odisseo scoppia nuovamente in lacrime e Alcinoo gli chiede di rivelare il suo nome Canto IX Odisseo dichiara il proprio nome e dagrave inizio al racconto della propria storia a partire dalla caduta di Troia distruzione di Ismaro e perdite subite ad opera dei Ciconi sbarco presso i Lotofagi (che si nutrono di un cibo misterioso che fa dimenticare il ritorno) dopo una terribile tempesta scatenatasi durante il tentativo di doppiare il capo Malea arrivo allrsquoisola antistante quella dei Ciclopi dove Odisseo si trasferisce con una sola nave esplorazione dellrsquoisola perdita di alcuni compagni allrsquointerno della caverna del gigante monocolo accecamento del mostro e fuga Canto X Odisseo giunge allrsquoisola di Eolo signore dei venti che lo accoglie benevolmente e gli consegna alla partenza tutti i venti chiusi in un otre ma poi lo respinge con durezza quando ritorna presso di lui percheacute i compagni (sospettando che nellrsquootre siano racchiuse cospicue ricchezze) hanno sciolto i venti e da essi si egrave sprigionato un uragano che li ha risospinti sullrsquoisola Ripreso il mare Odisseo egrave trasportato fino ai Lestrigoni antropofagi il cui attacco priva lrsquoeroe di tutte le altre navi tranne la propria Con questa fugge fino allrsquoisola (Eea) della maga Circe Dopo che Circe ha trasformato in porci un gruppo di compagni mandati innanzi ad esplorare lrsquoisola Odisseo ha la meglio sulla maga (a cui impone di restituire forma umana ai compagni) grazie allrsquoerba moly fornitagli da Ermes Resta un anno presso Circe che al momento della partenza gli consiglia di recarsi al paese dei morti per interrogare il vate Tiresia Canto XI Approdato alla terra dei Cimmeri (che vivono immersi in una nebbia perenne sulla riva dellrsquoOceano) e scavata una fossa Odisseo sacrifica ai morti e immola una vittima speciale a Tiresia Le anime accorrono dapprima Elpenore caduto per caso giugrave dal tetto della casa di Circe (Odisseo gli promette sepoltura) poi la madre Anticlea (che gli racconta di esser morta di dolore per la sua assenza) quindi Tiresia che gli vaticina le sue vicende future fino alla morte (questa lo coglieragrave dopo una lunga vita in un paese straniero che non conosce neacute il sale neacute il remo) Da un certo punto in poi il poeta dimentica il presupposto per cui Odisseo aveva scavato una fossa alla quale i morti accorrevano per bere il sangue delle vittime e bevendolo riacquistavano per breve tempo una piena consapevolezza immagina invece che Odisseo sia allrsquointerno dellrsquoAde In questa sezione rientrano la descrizione di Aiace sdegnato di Minosse di Orione dei grandi peccatori di Eracle Poi Odisseo fa ritorno a Eea e ricevuti i consigli di Circe si imbarca per il ritorno in patria Canto XII Scampato alle Sirene che invano lo attirano col canto (si egrave fatto legare allrsquoalbero della nave i compagni che remano hanno le orecchie turate con la cera) passa tra Cariddi e Scilla (che gli rapisce sei uomini) ed egrave costretto dai compagni ad approdare in contrasto con le prescrizioni di Circe allrsquoisola Trinachia dove pascolano le greggi del Sole I
Letteratura greca [1]
24
compagni spronati da Euriloco se ne cibano nonostante il divieto dellrsquoeroe Il Sole sdegnato ottiene da Zeus che la nave sia colpita dal fulmine Tutti i compagni periscono ma Odisseo che ripassa tra Scilla e Cariddi si salva miracolosamente da questrsquoultima aggrappandosi a un fico selvatico fincheacute il gorgo restituisce i rottami della nave infine arriva remando con le mani allrsquoisola di Ogigia Canto XIII Terminato il racconto lrsquoeroe riceve doni dai Feaci e la notte seguente egrave ricondotto a Itaca e deposto addormentato sulla spiaggia presso un antro sacro alle Ninfe Al risveglio per la nebbia non riconosce la sua terra fincheacute Atena in veste di giovane pastore lo rassicura e poi rivelatasi gli dagrave istruzioni su come far strage dei proci e lo trasforma in un vecchio mendico Canto XIV Odisseo si reca allo stazzo del suo porcaio Eumeo che pur non riconoscendolo lo accoglie ospitalmente rifocillandolo e offrendogli un mantello per ripararsi dal gelo notturno Canto XV A questo punto la laquoTelemachiaraquo si riannoda allrsquoazione principale Telemaco che si trova ancora a Sparta viene indotto da Atena a tornare a Itaca sulla via del ritorno a Pilo accoglie a bordo lrsquoindovino Teoclimeno e grazie allrsquoaiuto della dea sfugge alle insidie dei proci sbarca a Itaca e si reca anchrsquoegli presso Eumeo Canto XVI Questi va da Penelope ad annunciargli il ritorno del figlio Intanto Odisseo rimosso lrsquoincantesimo si svela nel suo vero aspetto a Telemaco e con lui progetta la vendetta sui proci (che intanto tramano una nuova insidia ai danni di Telemaco) Eumeo torna al suo stazzo Canto XVII Il mattino seguente Telemaco si reca in cittagrave seguito in un secondo tempo da Eumeo e Odisseo (che ha riassunto lrsquoaspetto di mendico) Davanti al palazzo Odisseo egrave riconosciuto dal cane Argo Entra e va mendicando tra i proci Antinoo lo colpisce alla spalla destra con uno sgabello Canto XVIII Odisseo si batte al pugilato col mendicante Iro Penelope scesa nella sala prospetta ai proci lrsquoeventualitagrave di un nuovo matrimonio Odisseo egrave insultato dalla schiava Melanto e schiva uno sgabello scagliato da Eurinomo Canto XIX Insieme con Telemaco lrsquoeroe allontana le armi dalla sala poi conversa con Penelope che gli racconta un sogno e gli espone il suo piano per sedare le contese tra i proci concedendosi sposa a colui che riusciragrave a tendere lrsquoarco di Odisseo la prova avverragrave il giorno seguente al novilunio Durante il colloquio la fida schiava Euriclea lava i piedi di Odisseo e riconosciutolo da unrsquoantica cicatrice sta per rivelarne lrsquoidentitagrave ma lrsquoeroe la costringe a tacere Canto XX Al mattino Euriclea e le ancelle fanno i preparativi per il banchetto Giungono Eumeo Melanzio e il mandriano Filezio Un presagio mandato da Zeus dissuade i proci dal progetto di uccidere Telemaco Durante il banchetto Teoclimeno predice la loro imminente rovina
Letteratura greca [1]
25
Canto XXI Penelope conduce lrsquoarco nella sala dopo che parecchi fra i proci e lo stesso Telemaco hanno tentato invano di tenderne la corda Odisseo chiede di partecipare alla prova tende lrsquoarco senza fatica e riesce a far passare la freccia attraverso gli anelli di dodici scuri predisposte da Telemaco Canto XXII Poi scaglia le frecce sui proci e si rivela nella sua identitagrave Nella lotta che segue Telemaco Eumeo e Filezio aiutano il padrone contro i proci (appoggiati dal capraio Melanzio) Tutti i proci restano uccisi le ancelle infedeli sono impiccate Melanzio viene mutilato e ucciso soltanto lrsquoaedo Femio e lrsquoaraldo Medonte sono risparmiati Canto XXIII Nuovo colloquio fra Odisseo e Penelope che durante lrsquoeccidio dormiva ed egrave stata svegliata da Euriclea Penelope esita ancora a riconoscere il marito e non si arrende alla veritagrave fincheacute Odisseo non le descrive la posizione e la struttura del letto coniugale Canto XXIV Ermes conduce allrsquoAde le ombre dei proci Odisseo fa visita al padre Laerte nella masseria dove quello vive nello squallore e nellrsquoemarginazione e si fa riconoscere Intanto il padre di Antinoo incita gli Itacesi alla rivolta e il poema si conclude con lo scontro di Odisseo e dei suoi contro i concittadini lrsquoeroe ha la meglio e Zeus scagliato il fulmine pone fine alla battaglia Atena sotto lrsquoaspetto di Mentore stabilisce fra i contendenti un patto per il futuro36
Struttura e caratteri dellʼopera Giagrave la prima parola del proemio (ἄνδρα) non menziona come tema dellrsquoopera un determinato episodio della vita del protagonista ma il protagonista stesso (I 1-10)
Ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα πολύτροπον ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεmiddot πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περmiddot αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο νήπιοι οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιονmiddot αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ τῶν ἁμόθεν γε θεά θύγατερ Διός εἰπὲ καὶ ἡμῖν Dellrsquouomo multiforme a me racconta o Musa che molto errograve dopo che di Troia la sacra rocca distrusse di molti uomini vide le cittagrave riconobbe il pensiero e molti per il mare patigrave dolori nellrsquoanimo per salvare la sua vita e il ritorno dei compagni Eppure non li salvograve i compagni per quanto bramasse per la loro stessa follia si persero gli stolti i buoi del Sole Iperione mangiarono e quello rapigrave ad essi il digrave del ritorno Di questo da un punto qualsiasi narra anche a noi o dea figlia di Zeus
Storie favolose di naviganti racconti imperniati sul ritorno dei guerrieri achei che avevano combattuto a Troia e il particolare rientro in patria di Odisseo figlio di Laerte erano forse giagrave stati connessi e intrecciati nella precedente tradizione epica sigrave che il presente cantore poteva
Letteratura greca [1]
26
metter mano alla vicenda partendo (v 10) laquoda un punto qualsiasiraquo (ἁμόθεν) una notazione che certo presuppone la convenzione propria dellrsquoesordio tradizionale di un canto epico comparabile con i giagrave ricordati ἐξ οὗ (laquoda quandoraquo) di Iliade I 4 ed ἔνθεν (laquoda doveraquo) di Odissea VIII 500 Senoncheacute rispetto a queste indicazioni di tipo puntuale il tratto costituito dalla dimensione casuale quasi arbitraria inerente ad ἁμόθεν proprio mentre dichiara lrsquoassenza di un determinato piano compositivo implica in realtagrave che il racconto non si svolgeragrave per filo e per segno secondo lrsquoordine noto a poeta e uditori non si snoderagrave κατὰ κόσμον (laquoper ordineraquo) come il canto di Demodoco (VIII 489) ma seguiragrave un andamento originale Il ldquopunto qualsiasirdquo incipitario non rappresenta una scelta della Musa (figura dellrsquoarchivio tematico che conserva le laquovieraquo dellrsquoepica) bensigrave di questo cantore che ha deciso di far incominciare la narrazione in medias res e ha in serbo la sorpresa di far succedere al concilio degli degravei (che decide lrsquoinvio di Ermes presso Calipso) non lrsquoazione testeacute programmata (azione che viene differita con un ritardo che a piugrave riprese ha scandalizzato i lettori a principio del V canto) ma la partenza di Atena alla volta di Itaca e lrsquoavvio della laquoTelemachiaraquo Le due diverse vicende proposte a principio del poema quella di Telemaco e quella di Odisseo procedono infatti in parallelo coprendo un analogo lasso di tempo Piugrave oltre la decisione di trasformare la sequenza narrativa che va dalla partenza di Odisseo da Troia fino al suo arrivo nella terra dei Feaci in una rievocazione fatta dallrsquoeroe in prima persona al cospetto di Alcinoo e dei Feaci (la sezione detta degli ἀπόλογοι laquoraccontiraquo) crea una struttura ad anello che parte dal presente e ad esso fa ritorno dopo aver ricostruito le premesse della condizione attuale del protagonista Col canto XIII Odisseo egrave riportato dai Feaci a Itaca e questo permette la saldatura fra le vicende sue e quelle di Telemaco sia pure col differimento dellrsquoincontro e del riconoscimento fra padre e figlio fino al canto XVI Far scorrere in parallelo sequenze distinte organizzare programmi narrativi a corta e a lunga gittata tendere o allentare ad arte il ritmo della narrazione non si tratta davvero di procedimenti che potessero configurarsi come tradizionali dellrsquoarte epica quanto piuttosto di un momento sperimentale di una ricerca di soluzioni nuove al termine di una lunga e ormai consolidata sedimentazione di percorsi compiuti allrsquointerno di un determinato repertorio tematico unrsquoaudacia inventiva una πολυτροπίη degne del protagonista del poema che inevitabilmente comportavano rischi molteplici di incoerenze dissonanze occasionali avarie della macchina epica e che tuttavia erano destinate a conseguire un risultato assolutamente convincente allrsquoorecchio di chi si abbandonasse al fascino del racconto senza lrsquourgenza propria di altre etagrave e di altre mentalitagrave di puntare il dito sui singoli dettagli o le singole sfasature
PER SAPERNE DI PIUrsquo Difficoltagrave e incongruenze della narrazione omerica Forti della possibilitagrave di un controllo su un testo scritto che possiamo percorrere in avanti e a ritroso secondo ritmi di nostra scelta a noi non riesce difficile cogliere alcune delle difficoltagrave organizzative incontrate nella composizione del poema In proposito per ricordare un caso che saragrave allrsquoorigine delle discussioni di orientamento ldquoanaliticordquo intorno allrsquoOdissea possiamo leggere il discorso che Atena prese le sembianze di Mente re dei Tafi rivolge a Telemaco nel I canto (vv 253-305) Ah infelice ti manca molto davvero lrsquoassente Odisseo che getti le mani addosso ai pretendenti sfrontati Percheacute se ora tornato stesse sulla soglia 255 con una scure lo scudo e due lance cosigrave come io per la prima volta lo vidi in casa nostra che beveva e godeva di ritorno da Efira da Ilo di Mermero (andograve anche ligrave Odisseo con la nave veloce 260 in cerca del veleno omicida per averne da ungere le frecce di bronzo ma quello non glielo diede percheacute temeva gli dei che vivono eterni
Letteratura greca [1]
27
glielo diede invece mio padre percheacute lrsquoamava moltissimo) se stesse Odisseo tra i pretendenti cosigrave 265 essi avrebbero tutti rapida morte e nozze amare Ma sulle ginocchia degli dei questo giace se una volta tornato faragrave o no vendetta nella sua casa te invece io esorto a riflettere come cacciare i pretendenti da casa 270 Ebbene ora ascolta e alle mie parole darsquo retta Domattina chiamati gli eroi Achei a consiglio rivolgi a tutti un discorso e siano testimoni gli dei Ai pretendenti comanda drsquoandarsene per i fatti loro e tua madre se lrsquoanimo la spinge alle nozze 275 ritorni a casa del padre molto potente Prepareranno essi le nozze e disporranno i doni nuziali moltissimi quanti gli pare che debbano andare alla figlia A te darograve un saggio consiglio se vuoi ascoltarlo armata una nave con venti remi la migliore che crsquoegrave 280 Varsquo a domandare del padre partito da tempo se mai te ne parli un mortale o sentissi da Zeus la voce che divulga la fama tra gli uomini Anzitutto varsquo a Pilo e interroga il chiaro Nestore di ligrave poi varsquo a Sparta dal biondo Menelao 285 degli Achei vestiti di bronzo egli egrave tornato per ultimo Se senti dire qualcosa sulla vita e il ritorno del padre per quanto stremato potresti sopportare un altro anno se invece senti dire che egrave morto e non vive allora tornato nella cara terra patria 290 ergigli un tumulo e offrigli funebri offerte moltissime quanto conviene e darsquo tua madre a un marito E poi dopo aver compiuto e fatto ogni cosa allora medita nella mente e nellrsquoanimo come tu possa uccidere nelle tue case 295 i pretendenti con lrsquoinganno affrontandoli non devi piugrave avere i modi di un bimbo percheacute ormai non sei tale Non senti lrsquoillustre Oreste quale gloria ha acquistato fra tutti gli uomini percheacute uccise lrsquoassassino del padre Egisto esperto di inganni che gli uccise il nobile padre 300 Anche tu caro infatti molto bello e grande ti vedo sii valoroso percheacute ti lodi anche qualcuno dei posteri Ma io tornerograve adesso alla nave veloce dai compagni che forse impazienti mi aspettano Tu devi pensarci da te dammi retta 305
[Tr di GA Privitera] Le stranezze non mancano davvero e cosigrave sono state messe a fuoco da Stephanie West nel suo commento23 1 Atena sa evidentemente molto piugrave di quanto uno come Mente avrebbe potuto sapere in particolare ella sa che i proci ignoreranno lrsquoinvito di Telemaco a lasciare la sua casa e fatto piugrave importante che gli degravei tra breve ricondurranno in patria Odisseo A queste osservazioni si puograve replicare con la stessa West che laquosi sono esagerate difficoltagrave e
23 Omero Odissea I cit 219 ss
Letteratura greca [1]
28
incongruenze alle quali un pubblico di ascoltatori (o anche un lettore moderatamente attento) probabilmente non farebbe casoraquo 2 Il progetto di una pubblica denuncia dei proci dinanzi agli degravei e agli uomini ai vv 273-274 egrave ciograve che Atena sembra prefiggersi nel promuovere lrsquoassemblea degli Itacesi (assemblea che effettivamente avragrave luogo a principio del canto II) drsquoaltra parte le successive istruzioni di AtenaMente ai vv 295 s (medita come uccidere i pretendenti) presuppongono che di quella richiesta da formulare nel corso dellrsquoassembla essi non terranno alcun conto Anche a questa osservazione si puograve rispondere che laquoegrave ragionevole attendersi che Telemaco condivida la previsione di un esito negativo della sua iniziativaraquo e si puograve aggiungere che pure in caso di insuccesso il ricorso allrsquoassemblea potrebbe ottenere almeno il risultato di screditare i pretendenti presso la comunitagrave itacese legittimando un successivo ricorso alla violenza (e si tratta di una legittimazione di cui anche lrsquoultimo canto mostreragrave lrsquoesigenza) 3 Dopo che Telemaco aveva detto che la madre non intendeva risposarsi (vv 249-250) AtenaMente si esprime ai vv 275-278 come se Penelope desiderasse proprio nuove nozze e inoltre sarebbe assurdo che il padre di Penelope cominciasse a contrattare un secondo matrimonio prima del ritorno di Telemaco dal suo viaggio e che mettesse mano a preparativi che rischierebbero di essere annullati qualche tempo dopo con inevitabile imbarazzo se Telemaco venisse a sapere che Odisseo egrave ancora vivo In piugrave lrsquoandamento sintattico di questi versi presenta un anacoluto durissimo per cui a principio del v 275 lrsquoaccusativo μητέρα egrave seguito da un ἂψ ἴτω (laquovada indietroraquo laquotorniraquo) che richiederebbe come soggetto un nominativo μήτηρ Come hanno reagito i lettori di Omero Nellrsquoantichitagrave un grammatico rimasto anonimo cambiava come attesta uno scolio μητέρ᾽ in μήτηρ nel secolo XVIII Richard Bentley modificava ἴτω in ἴμεν (infinito eolico di εἶμι laquovadoraquo) nel XIX un altro grande della filologia europea Gottfried Hermann risolveva piugrave drasticamente la questione eliminando il complesso dei vv 275-278 e la stessa West mostra simpatia per tale proposta supponendo laquounrsquoaggiunta posteriore modellata sul corrispondente passo del libro IIraquo (dove i vv 196 s sono identici ai vv 277 s e il v 195 copre lo stesso contenuto dei vv 275 s) Si tratta di procedimenti adeguati ai dati di fatto Migliorano davvero il testo che ci egrave stato tramandato In realtagrave ambedue le ldquocorrezionirdquo appena ricordate (di μήτερ᾽ e di ἴτω) ottengono un risultato tanto lineare che egrave davvero difficile pensare che lrsquoanacoluto avrebbe potuto invadere tutta la tradizione se non fosse stato originario e quanto allrsquoespunzione dei vv 275-278 essa indubbiamente peggiorerebbe il ritmo del discorso determinando lrsquoavvicinamento fra i due versi (v 271 e v 279) molto simili fra loro che aprono le due sequenze occupate dai consigli di Mente E allora La via piugrave saggia egrave senzrsquoaltro quella di tenerci qui come quasi sempre di fronte al testo omerico contraddizioni e anacoluti riconoscendo in essi lrsquoeffetto dellrsquoattivitagrave di un cantore che pur sulla base di una traccia largamente memorizzata restava pur sempre legato a quella prassi orale per cui composizione ed esecuzione tendevano a coincidere E lrsquoanacoluto si spiega bene se cerchiamo di immedesimarci nel procedimento seguito dal poeta Egli ha affidato ad Atena un certo flusso argomentativo per cui la dea deve dar consigli a Telemaco sui suoi rapporti coi proci e con la madre e cosigrave colloca in fine di v 274 un ἄνωχθι (laquoordinaraquo) destinato a reggere gli accusativi simmetricamente dislocati in principio di verso (vv 274 e 275) μνηστῆρας e μητέρα Senoncheacute giunto a questa seconda parte dellrsquoargomentazione egli si avvede quanto sarebbe illogico che Telemaco sollecitasse la madre a nuove nozze di qui lrsquoimprovviso cambio di costruzione che svincola al prezzo di una sensibile slogatura sintattica lrsquoipotesi delle nuove nozze dallrsquoordine impartito a Telemaco e la prospetta invece come un desiderio eventuale della stessa Penelope Il poeta ha un progetto ben meditato brani e sequenze piugrave volte sperimentati ed egrave col supporto di questi materiali giagrave elaborati che egli si fa strada attraverso le insidie della
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
22
Canto I Tutti gli eroi superstiti sono ormai tornati da Troia alle loro case tranne Odisseo che pur desideroso di tornare egrave trattenuto dalla ninfa Calipso nellrsquoisola di Ogigia Gli degravei hanno pietagrave di lui tranne Posidone irato per lrsquoaccecamento del figlio il ciclope Polifemo Ma un consiglio degli degravei assente Posidone (che si egrave recato presso gli Etiopi) delibera il ritorno dellrsquoeroe si decide che Ermes andragrave subito da Calipso mentre Atena si avvia verso Itaca sotto lrsquoaspetto del signore dei Tafi Mente per incoraggiare il figlio di Odisseo Telemaco a tener testa ai pretendenti della madre i laquoprociraquo (i quali aspirano al regno tramite le nozze con Penelope) e per indurlo a intraprendere un viaggio in cerca di notizie sul padre Canto IΙ Telemaco segue il consiglio della dea e il giorno seguente nellrsquoassemblea popolare chiede una nave per andare in cerca del padre ma la sua richiesta non viene discussa e Leocrito scioglie lrsquoassemblea Grazie ad Atena che ora ha assunto le sembianze di Mentore (antico amico di Odisseo) Telemaco riesce tuttavia a trovare una nave con cui salpa nel corso della notte allrsquoinsaputa sia della madre che dei proci Canto IΙΙ Telemaco e MentoreAtena arrivano a Pilo e sul lido trovano Nestore che sta offrendo un sacrificio a Posidone Il vecchio eroe accoglie ospitalmente Telemaco e gli comunica molte notizie sul ritorno di altri Achei ma nessuna su Odisseo Alla sera Atena scompare in forma di aquila e il mattino seguente Telemaco salpa insieme con Pisistrato (figlio di Nestore) alla volta di Sparta dove arriva la sera del giorno successivo Canto IV A Sparta Menelao sta festeggiando il doppio matrimonio del figlio e della figlia Il giorno seguente Telemaco chiede del padre Menelao gli racconta il proprio ritorno durante il quale aveva incontrato Proteo il vecchio nume marino che gli aveva riferito come Odisseo fosse trattenuto nellrsquoisola di Calipso Intanto a Itaca i proci preparano insidie meditando di uccidere Telemaco al suo ritorno Penelope ne viene a conoscenza ma Atena le appare in sogno per confortarla Canto V Dopo un secondo concilio degli degravei (in effetti un ldquodoppionerdquo di quello del I canto) Zeus manda finalmente Ermes presso Calipso con lrsquoordine di lasciar partire Odisseo La ninfa aiuta lrsquoeroe a costruirsi una zattera Al diciottesimo giorno di navigazione Odisseo egrave in vista dellrsquoisola dei Feaci Scheria quando Posidone di ritorno dal suo soggiorno presso gli Etiopi lo vede e suscita una tempesta che distrugge la zattera Ma la dea marina Ino Leucotea impietositasi gli porge il proprio velo sostenuto dal quale lrsquoeroe giunge a nuoto alla riva di Scheria dove si abbandona esausto addormentandosi Canto VI In seguito a un sogno inviatole da Atena Nausicaa la figlia del re dei Feaci Alcinoo si reca nei pressi della spiaggia a lavare le vesti insieme con le ancelle Odisseo risvegliatosi atterrisce le fanciulle che fuggono tutte allrsquoinfuori di Nausicaa Lrsquoeroe supplica la giovane di porgerle aiuto ed ella lo fa rivestire e lo accompagna fino al bosco di Atena poco prima della cittagrave esortandolo a presentarsi a suo padre Canto VII Protetto dalla nebbia di cui Atena lo ha avvolto Odisseo entra nel palazzo abbraccia le ginocchia della regina Arete e la caligine scompare poi viene accolto con onore da Alcinoo Arete chiede a Odisseo donde provenga e chi gli abbia donato gli abiti (a lei ben noti) che indossa Lrsquoeroe inizia a raccontare le disavventure che gli sono occorse dopo la
Letteratura greca [1]
23
partenza dallrsquoisola di Calipso Alcinoo gli promette di farlo ricondurre a Itaca il giorno seguente Canto VIII Ma lrsquoindomani Alcinoo fa apprestare un banchetto durante il quale lrsquoaedo Demodoco canta della contesa insorta un giorno fra Achille e Odisseo Lrsquoeroe si copre il volto per nascondere le lacrime allora Alcinoo interrompe il canto e organizza una serie di gare nel corso delle quali Odisseo primeggia Poi Demodoco al margine di unrsquoarea per la danza dove si esibiscono i ballerini feaci canta gli amori di Ares e Afrodite e la vendetta di Efesto (che incatena i due amanti) La sera al ritorno nel palazzo Demodoco racconta la storia del Cavallo di legno Odisseo scoppia nuovamente in lacrime e Alcinoo gli chiede di rivelare il suo nome Canto IX Odisseo dichiara il proprio nome e dagrave inizio al racconto della propria storia a partire dalla caduta di Troia distruzione di Ismaro e perdite subite ad opera dei Ciconi sbarco presso i Lotofagi (che si nutrono di un cibo misterioso che fa dimenticare il ritorno) dopo una terribile tempesta scatenatasi durante il tentativo di doppiare il capo Malea arrivo allrsquoisola antistante quella dei Ciclopi dove Odisseo si trasferisce con una sola nave esplorazione dellrsquoisola perdita di alcuni compagni allrsquointerno della caverna del gigante monocolo accecamento del mostro e fuga Canto X Odisseo giunge allrsquoisola di Eolo signore dei venti che lo accoglie benevolmente e gli consegna alla partenza tutti i venti chiusi in un otre ma poi lo respinge con durezza quando ritorna presso di lui percheacute i compagni (sospettando che nellrsquootre siano racchiuse cospicue ricchezze) hanno sciolto i venti e da essi si egrave sprigionato un uragano che li ha risospinti sullrsquoisola Ripreso il mare Odisseo egrave trasportato fino ai Lestrigoni antropofagi il cui attacco priva lrsquoeroe di tutte le altre navi tranne la propria Con questa fugge fino allrsquoisola (Eea) della maga Circe Dopo che Circe ha trasformato in porci un gruppo di compagni mandati innanzi ad esplorare lrsquoisola Odisseo ha la meglio sulla maga (a cui impone di restituire forma umana ai compagni) grazie allrsquoerba moly fornitagli da Ermes Resta un anno presso Circe che al momento della partenza gli consiglia di recarsi al paese dei morti per interrogare il vate Tiresia Canto XI Approdato alla terra dei Cimmeri (che vivono immersi in una nebbia perenne sulla riva dellrsquoOceano) e scavata una fossa Odisseo sacrifica ai morti e immola una vittima speciale a Tiresia Le anime accorrono dapprima Elpenore caduto per caso giugrave dal tetto della casa di Circe (Odisseo gli promette sepoltura) poi la madre Anticlea (che gli racconta di esser morta di dolore per la sua assenza) quindi Tiresia che gli vaticina le sue vicende future fino alla morte (questa lo coglieragrave dopo una lunga vita in un paese straniero che non conosce neacute il sale neacute il remo) Da un certo punto in poi il poeta dimentica il presupposto per cui Odisseo aveva scavato una fossa alla quale i morti accorrevano per bere il sangue delle vittime e bevendolo riacquistavano per breve tempo una piena consapevolezza immagina invece che Odisseo sia allrsquointerno dellrsquoAde In questa sezione rientrano la descrizione di Aiace sdegnato di Minosse di Orione dei grandi peccatori di Eracle Poi Odisseo fa ritorno a Eea e ricevuti i consigli di Circe si imbarca per il ritorno in patria Canto XII Scampato alle Sirene che invano lo attirano col canto (si egrave fatto legare allrsquoalbero della nave i compagni che remano hanno le orecchie turate con la cera) passa tra Cariddi e Scilla (che gli rapisce sei uomini) ed egrave costretto dai compagni ad approdare in contrasto con le prescrizioni di Circe allrsquoisola Trinachia dove pascolano le greggi del Sole I
Letteratura greca [1]
24
compagni spronati da Euriloco se ne cibano nonostante il divieto dellrsquoeroe Il Sole sdegnato ottiene da Zeus che la nave sia colpita dal fulmine Tutti i compagni periscono ma Odisseo che ripassa tra Scilla e Cariddi si salva miracolosamente da questrsquoultima aggrappandosi a un fico selvatico fincheacute il gorgo restituisce i rottami della nave infine arriva remando con le mani allrsquoisola di Ogigia Canto XIII Terminato il racconto lrsquoeroe riceve doni dai Feaci e la notte seguente egrave ricondotto a Itaca e deposto addormentato sulla spiaggia presso un antro sacro alle Ninfe Al risveglio per la nebbia non riconosce la sua terra fincheacute Atena in veste di giovane pastore lo rassicura e poi rivelatasi gli dagrave istruzioni su come far strage dei proci e lo trasforma in un vecchio mendico Canto XIV Odisseo si reca allo stazzo del suo porcaio Eumeo che pur non riconoscendolo lo accoglie ospitalmente rifocillandolo e offrendogli un mantello per ripararsi dal gelo notturno Canto XV A questo punto la laquoTelemachiaraquo si riannoda allrsquoazione principale Telemaco che si trova ancora a Sparta viene indotto da Atena a tornare a Itaca sulla via del ritorno a Pilo accoglie a bordo lrsquoindovino Teoclimeno e grazie allrsquoaiuto della dea sfugge alle insidie dei proci sbarca a Itaca e si reca anchrsquoegli presso Eumeo Canto XVI Questi va da Penelope ad annunciargli il ritorno del figlio Intanto Odisseo rimosso lrsquoincantesimo si svela nel suo vero aspetto a Telemaco e con lui progetta la vendetta sui proci (che intanto tramano una nuova insidia ai danni di Telemaco) Eumeo torna al suo stazzo Canto XVII Il mattino seguente Telemaco si reca in cittagrave seguito in un secondo tempo da Eumeo e Odisseo (che ha riassunto lrsquoaspetto di mendico) Davanti al palazzo Odisseo egrave riconosciuto dal cane Argo Entra e va mendicando tra i proci Antinoo lo colpisce alla spalla destra con uno sgabello Canto XVIII Odisseo si batte al pugilato col mendicante Iro Penelope scesa nella sala prospetta ai proci lrsquoeventualitagrave di un nuovo matrimonio Odisseo egrave insultato dalla schiava Melanto e schiva uno sgabello scagliato da Eurinomo Canto XIX Insieme con Telemaco lrsquoeroe allontana le armi dalla sala poi conversa con Penelope che gli racconta un sogno e gli espone il suo piano per sedare le contese tra i proci concedendosi sposa a colui che riusciragrave a tendere lrsquoarco di Odisseo la prova avverragrave il giorno seguente al novilunio Durante il colloquio la fida schiava Euriclea lava i piedi di Odisseo e riconosciutolo da unrsquoantica cicatrice sta per rivelarne lrsquoidentitagrave ma lrsquoeroe la costringe a tacere Canto XX Al mattino Euriclea e le ancelle fanno i preparativi per il banchetto Giungono Eumeo Melanzio e il mandriano Filezio Un presagio mandato da Zeus dissuade i proci dal progetto di uccidere Telemaco Durante il banchetto Teoclimeno predice la loro imminente rovina
Letteratura greca [1]
25
Canto XXI Penelope conduce lrsquoarco nella sala dopo che parecchi fra i proci e lo stesso Telemaco hanno tentato invano di tenderne la corda Odisseo chiede di partecipare alla prova tende lrsquoarco senza fatica e riesce a far passare la freccia attraverso gli anelli di dodici scuri predisposte da Telemaco Canto XXII Poi scaglia le frecce sui proci e si rivela nella sua identitagrave Nella lotta che segue Telemaco Eumeo e Filezio aiutano il padrone contro i proci (appoggiati dal capraio Melanzio) Tutti i proci restano uccisi le ancelle infedeli sono impiccate Melanzio viene mutilato e ucciso soltanto lrsquoaedo Femio e lrsquoaraldo Medonte sono risparmiati Canto XXIII Nuovo colloquio fra Odisseo e Penelope che durante lrsquoeccidio dormiva ed egrave stata svegliata da Euriclea Penelope esita ancora a riconoscere il marito e non si arrende alla veritagrave fincheacute Odisseo non le descrive la posizione e la struttura del letto coniugale Canto XXIV Ermes conduce allrsquoAde le ombre dei proci Odisseo fa visita al padre Laerte nella masseria dove quello vive nello squallore e nellrsquoemarginazione e si fa riconoscere Intanto il padre di Antinoo incita gli Itacesi alla rivolta e il poema si conclude con lo scontro di Odisseo e dei suoi contro i concittadini lrsquoeroe ha la meglio e Zeus scagliato il fulmine pone fine alla battaglia Atena sotto lrsquoaspetto di Mentore stabilisce fra i contendenti un patto per il futuro36
Struttura e caratteri dellʼopera Giagrave la prima parola del proemio (ἄνδρα) non menziona come tema dellrsquoopera un determinato episodio della vita del protagonista ma il protagonista stesso (I 1-10)
Ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα πολύτροπον ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεmiddot πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περmiddot αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο νήπιοι οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιονmiddot αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ τῶν ἁμόθεν γε θεά θύγατερ Διός εἰπὲ καὶ ἡμῖν Dellrsquouomo multiforme a me racconta o Musa che molto errograve dopo che di Troia la sacra rocca distrusse di molti uomini vide le cittagrave riconobbe il pensiero e molti per il mare patigrave dolori nellrsquoanimo per salvare la sua vita e il ritorno dei compagni Eppure non li salvograve i compagni per quanto bramasse per la loro stessa follia si persero gli stolti i buoi del Sole Iperione mangiarono e quello rapigrave ad essi il digrave del ritorno Di questo da un punto qualsiasi narra anche a noi o dea figlia di Zeus
Storie favolose di naviganti racconti imperniati sul ritorno dei guerrieri achei che avevano combattuto a Troia e il particolare rientro in patria di Odisseo figlio di Laerte erano forse giagrave stati connessi e intrecciati nella precedente tradizione epica sigrave che il presente cantore poteva
Letteratura greca [1]
26
metter mano alla vicenda partendo (v 10) laquoda un punto qualsiasiraquo (ἁμόθεν) una notazione che certo presuppone la convenzione propria dellrsquoesordio tradizionale di un canto epico comparabile con i giagrave ricordati ἐξ οὗ (laquoda quandoraquo) di Iliade I 4 ed ἔνθεν (laquoda doveraquo) di Odissea VIII 500 Senoncheacute rispetto a queste indicazioni di tipo puntuale il tratto costituito dalla dimensione casuale quasi arbitraria inerente ad ἁμόθεν proprio mentre dichiara lrsquoassenza di un determinato piano compositivo implica in realtagrave che il racconto non si svolgeragrave per filo e per segno secondo lrsquoordine noto a poeta e uditori non si snoderagrave κατὰ κόσμον (laquoper ordineraquo) come il canto di Demodoco (VIII 489) ma seguiragrave un andamento originale Il ldquopunto qualsiasirdquo incipitario non rappresenta una scelta della Musa (figura dellrsquoarchivio tematico che conserva le laquovieraquo dellrsquoepica) bensigrave di questo cantore che ha deciso di far incominciare la narrazione in medias res e ha in serbo la sorpresa di far succedere al concilio degli degravei (che decide lrsquoinvio di Ermes presso Calipso) non lrsquoazione testeacute programmata (azione che viene differita con un ritardo che a piugrave riprese ha scandalizzato i lettori a principio del V canto) ma la partenza di Atena alla volta di Itaca e lrsquoavvio della laquoTelemachiaraquo Le due diverse vicende proposte a principio del poema quella di Telemaco e quella di Odisseo procedono infatti in parallelo coprendo un analogo lasso di tempo Piugrave oltre la decisione di trasformare la sequenza narrativa che va dalla partenza di Odisseo da Troia fino al suo arrivo nella terra dei Feaci in una rievocazione fatta dallrsquoeroe in prima persona al cospetto di Alcinoo e dei Feaci (la sezione detta degli ἀπόλογοι laquoraccontiraquo) crea una struttura ad anello che parte dal presente e ad esso fa ritorno dopo aver ricostruito le premesse della condizione attuale del protagonista Col canto XIII Odisseo egrave riportato dai Feaci a Itaca e questo permette la saldatura fra le vicende sue e quelle di Telemaco sia pure col differimento dellrsquoincontro e del riconoscimento fra padre e figlio fino al canto XVI Far scorrere in parallelo sequenze distinte organizzare programmi narrativi a corta e a lunga gittata tendere o allentare ad arte il ritmo della narrazione non si tratta davvero di procedimenti che potessero configurarsi come tradizionali dellrsquoarte epica quanto piuttosto di un momento sperimentale di una ricerca di soluzioni nuove al termine di una lunga e ormai consolidata sedimentazione di percorsi compiuti allrsquointerno di un determinato repertorio tematico unrsquoaudacia inventiva una πολυτροπίη degne del protagonista del poema che inevitabilmente comportavano rischi molteplici di incoerenze dissonanze occasionali avarie della macchina epica e che tuttavia erano destinate a conseguire un risultato assolutamente convincente allrsquoorecchio di chi si abbandonasse al fascino del racconto senza lrsquourgenza propria di altre etagrave e di altre mentalitagrave di puntare il dito sui singoli dettagli o le singole sfasature
PER SAPERNE DI PIUrsquo Difficoltagrave e incongruenze della narrazione omerica Forti della possibilitagrave di un controllo su un testo scritto che possiamo percorrere in avanti e a ritroso secondo ritmi di nostra scelta a noi non riesce difficile cogliere alcune delle difficoltagrave organizzative incontrate nella composizione del poema In proposito per ricordare un caso che saragrave allrsquoorigine delle discussioni di orientamento ldquoanaliticordquo intorno allrsquoOdissea possiamo leggere il discorso che Atena prese le sembianze di Mente re dei Tafi rivolge a Telemaco nel I canto (vv 253-305) Ah infelice ti manca molto davvero lrsquoassente Odisseo che getti le mani addosso ai pretendenti sfrontati Percheacute se ora tornato stesse sulla soglia 255 con una scure lo scudo e due lance cosigrave come io per la prima volta lo vidi in casa nostra che beveva e godeva di ritorno da Efira da Ilo di Mermero (andograve anche ligrave Odisseo con la nave veloce 260 in cerca del veleno omicida per averne da ungere le frecce di bronzo ma quello non glielo diede percheacute temeva gli dei che vivono eterni
Letteratura greca [1]
27
glielo diede invece mio padre percheacute lrsquoamava moltissimo) se stesse Odisseo tra i pretendenti cosigrave 265 essi avrebbero tutti rapida morte e nozze amare Ma sulle ginocchia degli dei questo giace se una volta tornato faragrave o no vendetta nella sua casa te invece io esorto a riflettere come cacciare i pretendenti da casa 270 Ebbene ora ascolta e alle mie parole darsquo retta Domattina chiamati gli eroi Achei a consiglio rivolgi a tutti un discorso e siano testimoni gli dei Ai pretendenti comanda drsquoandarsene per i fatti loro e tua madre se lrsquoanimo la spinge alle nozze 275 ritorni a casa del padre molto potente Prepareranno essi le nozze e disporranno i doni nuziali moltissimi quanti gli pare che debbano andare alla figlia A te darograve un saggio consiglio se vuoi ascoltarlo armata una nave con venti remi la migliore che crsquoegrave 280 Varsquo a domandare del padre partito da tempo se mai te ne parli un mortale o sentissi da Zeus la voce che divulga la fama tra gli uomini Anzitutto varsquo a Pilo e interroga il chiaro Nestore di ligrave poi varsquo a Sparta dal biondo Menelao 285 degli Achei vestiti di bronzo egli egrave tornato per ultimo Se senti dire qualcosa sulla vita e il ritorno del padre per quanto stremato potresti sopportare un altro anno se invece senti dire che egrave morto e non vive allora tornato nella cara terra patria 290 ergigli un tumulo e offrigli funebri offerte moltissime quanto conviene e darsquo tua madre a un marito E poi dopo aver compiuto e fatto ogni cosa allora medita nella mente e nellrsquoanimo come tu possa uccidere nelle tue case 295 i pretendenti con lrsquoinganno affrontandoli non devi piugrave avere i modi di un bimbo percheacute ormai non sei tale Non senti lrsquoillustre Oreste quale gloria ha acquistato fra tutti gli uomini percheacute uccise lrsquoassassino del padre Egisto esperto di inganni che gli uccise il nobile padre 300 Anche tu caro infatti molto bello e grande ti vedo sii valoroso percheacute ti lodi anche qualcuno dei posteri Ma io tornerograve adesso alla nave veloce dai compagni che forse impazienti mi aspettano Tu devi pensarci da te dammi retta 305
[Tr di GA Privitera] Le stranezze non mancano davvero e cosigrave sono state messe a fuoco da Stephanie West nel suo commento23 1 Atena sa evidentemente molto piugrave di quanto uno come Mente avrebbe potuto sapere in particolare ella sa che i proci ignoreranno lrsquoinvito di Telemaco a lasciare la sua casa e fatto piugrave importante che gli degravei tra breve ricondurranno in patria Odisseo A queste osservazioni si puograve replicare con la stessa West che laquosi sono esagerate difficoltagrave e
23 Omero Odissea I cit 219 ss
Letteratura greca [1]
28
incongruenze alle quali un pubblico di ascoltatori (o anche un lettore moderatamente attento) probabilmente non farebbe casoraquo 2 Il progetto di una pubblica denuncia dei proci dinanzi agli degravei e agli uomini ai vv 273-274 egrave ciograve che Atena sembra prefiggersi nel promuovere lrsquoassemblea degli Itacesi (assemblea che effettivamente avragrave luogo a principio del canto II) drsquoaltra parte le successive istruzioni di AtenaMente ai vv 295 s (medita come uccidere i pretendenti) presuppongono che di quella richiesta da formulare nel corso dellrsquoassembla essi non terranno alcun conto Anche a questa osservazione si puograve rispondere che laquoegrave ragionevole attendersi che Telemaco condivida la previsione di un esito negativo della sua iniziativaraquo e si puograve aggiungere che pure in caso di insuccesso il ricorso allrsquoassemblea potrebbe ottenere almeno il risultato di screditare i pretendenti presso la comunitagrave itacese legittimando un successivo ricorso alla violenza (e si tratta di una legittimazione di cui anche lrsquoultimo canto mostreragrave lrsquoesigenza) 3 Dopo che Telemaco aveva detto che la madre non intendeva risposarsi (vv 249-250) AtenaMente si esprime ai vv 275-278 come se Penelope desiderasse proprio nuove nozze e inoltre sarebbe assurdo che il padre di Penelope cominciasse a contrattare un secondo matrimonio prima del ritorno di Telemaco dal suo viaggio e che mettesse mano a preparativi che rischierebbero di essere annullati qualche tempo dopo con inevitabile imbarazzo se Telemaco venisse a sapere che Odisseo egrave ancora vivo In piugrave lrsquoandamento sintattico di questi versi presenta un anacoluto durissimo per cui a principio del v 275 lrsquoaccusativo μητέρα egrave seguito da un ἂψ ἴτω (laquovada indietroraquo laquotorniraquo) che richiederebbe come soggetto un nominativo μήτηρ Come hanno reagito i lettori di Omero Nellrsquoantichitagrave un grammatico rimasto anonimo cambiava come attesta uno scolio μητέρ᾽ in μήτηρ nel secolo XVIII Richard Bentley modificava ἴτω in ἴμεν (infinito eolico di εἶμι laquovadoraquo) nel XIX un altro grande della filologia europea Gottfried Hermann risolveva piugrave drasticamente la questione eliminando il complesso dei vv 275-278 e la stessa West mostra simpatia per tale proposta supponendo laquounrsquoaggiunta posteriore modellata sul corrispondente passo del libro IIraquo (dove i vv 196 s sono identici ai vv 277 s e il v 195 copre lo stesso contenuto dei vv 275 s) Si tratta di procedimenti adeguati ai dati di fatto Migliorano davvero il testo che ci egrave stato tramandato In realtagrave ambedue le ldquocorrezionirdquo appena ricordate (di μήτερ᾽ e di ἴτω) ottengono un risultato tanto lineare che egrave davvero difficile pensare che lrsquoanacoluto avrebbe potuto invadere tutta la tradizione se non fosse stato originario e quanto allrsquoespunzione dei vv 275-278 essa indubbiamente peggiorerebbe il ritmo del discorso determinando lrsquoavvicinamento fra i due versi (v 271 e v 279) molto simili fra loro che aprono le due sequenze occupate dai consigli di Mente E allora La via piugrave saggia egrave senzrsquoaltro quella di tenerci qui come quasi sempre di fronte al testo omerico contraddizioni e anacoluti riconoscendo in essi lrsquoeffetto dellrsquoattivitagrave di un cantore che pur sulla base di una traccia largamente memorizzata restava pur sempre legato a quella prassi orale per cui composizione ed esecuzione tendevano a coincidere E lrsquoanacoluto si spiega bene se cerchiamo di immedesimarci nel procedimento seguito dal poeta Egli ha affidato ad Atena un certo flusso argomentativo per cui la dea deve dar consigli a Telemaco sui suoi rapporti coi proci e con la madre e cosigrave colloca in fine di v 274 un ἄνωχθι (laquoordinaraquo) destinato a reggere gli accusativi simmetricamente dislocati in principio di verso (vv 274 e 275) μνηστῆρας e μητέρα Senoncheacute giunto a questa seconda parte dellrsquoargomentazione egli si avvede quanto sarebbe illogico che Telemaco sollecitasse la madre a nuove nozze di qui lrsquoimprovviso cambio di costruzione che svincola al prezzo di una sensibile slogatura sintattica lrsquoipotesi delle nuove nozze dallrsquoordine impartito a Telemaco e la prospetta invece come un desiderio eventuale della stessa Penelope Il poeta ha un progetto ben meditato brani e sequenze piugrave volte sperimentati ed egrave col supporto di questi materiali giagrave elaborati che egli si fa strada attraverso le insidie della
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
23
partenza dallrsquoisola di Calipso Alcinoo gli promette di farlo ricondurre a Itaca il giorno seguente Canto VIII Ma lrsquoindomani Alcinoo fa apprestare un banchetto durante il quale lrsquoaedo Demodoco canta della contesa insorta un giorno fra Achille e Odisseo Lrsquoeroe si copre il volto per nascondere le lacrime allora Alcinoo interrompe il canto e organizza una serie di gare nel corso delle quali Odisseo primeggia Poi Demodoco al margine di unrsquoarea per la danza dove si esibiscono i ballerini feaci canta gli amori di Ares e Afrodite e la vendetta di Efesto (che incatena i due amanti) La sera al ritorno nel palazzo Demodoco racconta la storia del Cavallo di legno Odisseo scoppia nuovamente in lacrime e Alcinoo gli chiede di rivelare il suo nome Canto IX Odisseo dichiara il proprio nome e dagrave inizio al racconto della propria storia a partire dalla caduta di Troia distruzione di Ismaro e perdite subite ad opera dei Ciconi sbarco presso i Lotofagi (che si nutrono di un cibo misterioso che fa dimenticare il ritorno) dopo una terribile tempesta scatenatasi durante il tentativo di doppiare il capo Malea arrivo allrsquoisola antistante quella dei Ciclopi dove Odisseo si trasferisce con una sola nave esplorazione dellrsquoisola perdita di alcuni compagni allrsquointerno della caverna del gigante monocolo accecamento del mostro e fuga Canto X Odisseo giunge allrsquoisola di Eolo signore dei venti che lo accoglie benevolmente e gli consegna alla partenza tutti i venti chiusi in un otre ma poi lo respinge con durezza quando ritorna presso di lui percheacute i compagni (sospettando che nellrsquootre siano racchiuse cospicue ricchezze) hanno sciolto i venti e da essi si egrave sprigionato un uragano che li ha risospinti sullrsquoisola Ripreso il mare Odisseo egrave trasportato fino ai Lestrigoni antropofagi il cui attacco priva lrsquoeroe di tutte le altre navi tranne la propria Con questa fugge fino allrsquoisola (Eea) della maga Circe Dopo che Circe ha trasformato in porci un gruppo di compagni mandati innanzi ad esplorare lrsquoisola Odisseo ha la meglio sulla maga (a cui impone di restituire forma umana ai compagni) grazie allrsquoerba moly fornitagli da Ermes Resta un anno presso Circe che al momento della partenza gli consiglia di recarsi al paese dei morti per interrogare il vate Tiresia Canto XI Approdato alla terra dei Cimmeri (che vivono immersi in una nebbia perenne sulla riva dellrsquoOceano) e scavata una fossa Odisseo sacrifica ai morti e immola una vittima speciale a Tiresia Le anime accorrono dapprima Elpenore caduto per caso giugrave dal tetto della casa di Circe (Odisseo gli promette sepoltura) poi la madre Anticlea (che gli racconta di esser morta di dolore per la sua assenza) quindi Tiresia che gli vaticina le sue vicende future fino alla morte (questa lo coglieragrave dopo una lunga vita in un paese straniero che non conosce neacute il sale neacute il remo) Da un certo punto in poi il poeta dimentica il presupposto per cui Odisseo aveva scavato una fossa alla quale i morti accorrevano per bere il sangue delle vittime e bevendolo riacquistavano per breve tempo una piena consapevolezza immagina invece che Odisseo sia allrsquointerno dellrsquoAde In questa sezione rientrano la descrizione di Aiace sdegnato di Minosse di Orione dei grandi peccatori di Eracle Poi Odisseo fa ritorno a Eea e ricevuti i consigli di Circe si imbarca per il ritorno in patria Canto XII Scampato alle Sirene che invano lo attirano col canto (si egrave fatto legare allrsquoalbero della nave i compagni che remano hanno le orecchie turate con la cera) passa tra Cariddi e Scilla (che gli rapisce sei uomini) ed egrave costretto dai compagni ad approdare in contrasto con le prescrizioni di Circe allrsquoisola Trinachia dove pascolano le greggi del Sole I
Letteratura greca [1]
24
compagni spronati da Euriloco se ne cibano nonostante il divieto dellrsquoeroe Il Sole sdegnato ottiene da Zeus che la nave sia colpita dal fulmine Tutti i compagni periscono ma Odisseo che ripassa tra Scilla e Cariddi si salva miracolosamente da questrsquoultima aggrappandosi a un fico selvatico fincheacute il gorgo restituisce i rottami della nave infine arriva remando con le mani allrsquoisola di Ogigia Canto XIII Terminato il racconto lrsquoeroe riceve doni dai Feaci e la notte seguente egrave ricondotto a Itaca e deposto addormentato sulla spiaggia presso un antro sacro alle Ninfe Al risveglio per la nebbia non riconosce la sua terra fincheacute Atena in veste di giovane pastore lo rassicura e poi rivelatasi gli dagrave istruzioni su come far strage dei proci e lo trasforma in un vecchio mendico Canto XIV Odisseo si reca allo stazzo del suo porcaio Eumeo che pur non riconoscendolo lo accoglie ospitalmente rifocillandolo e offrendogli un mantello per ripararsi dal gelo notturno Canto XV A questo punto la laquoTelemachiaraquo si riannoda allrsquoazione principale Telemaco che si trova ancora a Sparta viene indotto da Atena a tornare a Itaca sulla via del ritorno a Pilo accoglie a bordo lrsquoindovino Teoclimeno e grazie allrsquoaiuto della dea sfugge alle insidie dei proci sbarca a Itaca e si reca anchrsquoegli presso Eumeo Canto XVI Questi va da Penelope ad annunciargli il ritorno del figlio Intanto Odisseo rimosso lrsquoincantesimo si svela nel suo vero aspetto a Telemaco e con lui progetta la vendetta sui proci (che intanto tramano una nuova insidia ai danni di Telemaco) Eumeo torna al suo stazzo Canto XVII Il mattino seguente Telemaco si reca in cittagrave seguito in un secondo tempo da Eumeo e Odisseo (che ha riassunto lrsquoaspetto di mendico) Davanti al palazzo Odisseo egrave riconosciuto dal cane Argo Entra e va mendicando tra i proci Antinoo lo colpisce alla spalla destra con uno sgabello Canto XVIII Odisseo si batte al pugilato col mendicante Iro Penelope scesa nella sala prospetta ai proci lrsquoeventualitagrave di un nuovo matrimonio Odisseo egrave insultato dalla schiava Melanto e schiva uno sgabello scagliato da Eurinomo Canto XIX Insieme con Telemaco lrsquoeroe allontana le armi dalla sala poi conversa con Penelope che gli racconta un sogno e gli espone il suo piano per sedare le contese tra i proci concedendosi sposa a colui che riusciragrave a tendere lrsquoarco di Odisseo la prova avverragrave il giorno seguente al novilunio Durante il colloquio la fida schiava Euriclea lava i piedi di Odisseo e riconosciutolo da unrsquoantica cicatrice sta per rivelarne lrsquoidentitagrave ma lrsquoeroe la costringe a tacere Canto XX Al mattino Euriclea e le ancelle fanno i preparativi per il banchetto Giungono Eumeo Melanzio e il mandriano Filezio Un presagio mandato da Zeus dissuade i proci dal progetto di uccidere Telemaco Durante il banchetto Teoclimeno predice la loro imminente rovina
Letteratura greca [1]
25
Canto XXI Penelope conduce lrsquoarco nella sala dopo che parecchi fra i proci e lo stesso Telemaco hanno tentato invano di tenderne la corda Odisseo chiede di partecipare alla prova tende lrsquoarco senza fatica e riesce a far passare la freccia attraverso gli anelli di dodici scuri predisposte da Telemaco Canto XXII Poi scaglia le frecce sui proci e si rivela nella sua identitagrave Nella lotta che segue Telemaco Eumeo e Filezio aiutano il padrone contro i proci (appoggiati dal capraio Melanzio) Tutti i proci restano uccisi le ancelle infedeli sono impiccate Melanzio viene mutilato e ucciso soltanto lrsquoaedo Femio e lrsquoaraldo Medonte sono risparmiati Canto XXIII Nuovo colloquio fra Odisseo e Penelope che durante lrsquoeccidio dormiva ed egrave stata svegliata da Euriclea Penelope esita ancora a riconoscere il marito e non si arrende alla veritagrave fincheacute Odisseo non le descrive la posizione e la struttura del letto coniugale Canto XXIV Ermes conduce allrsquoAde le ombre dei proci Odisseo fa visita al padre Laerte nella masseria dove quello vive nello squallore e nellrsquoemarginazione e si fa riconoscere Intanto il padre di Antinoo incita gli Itacesi alla rivolta e il poema si conclude con lo scontro di Odisseo e dei suoi contro i concittadini lrsquoeroe ha la meglio e Zeus scagliato il fulmine pone fine alla battaglia Atena sotto lrsquoaspetto di Mentore stabilisce fra i contendenti un patto per il futuro36
Struttura e caratteri dellʼopera Giagrave la prima parola del proemio (ἄνδρα) non menziona come tema dellrsquoopera un determinato episodio della vita del protagonista ma il protagonista stesso (I 1-10)
Ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα πολύτροπον ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεmiddot πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περmiddot αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο νήπιοι οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιονmiddot αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ τῶν ἁμόθεν γε θεά θύγατερ Διός εἰπὲ καὶ ἡμῖν Dellrsquouomo multiforme a me racconta o Musa che molto errograve dopo che di Troia la sacra rocca distrusse di molti uomini vide le cittagrave riconobbe il pensiero e molti per il mare patigrave dolori nellrsquoanimo per salvare la sua vita e il ritorno dei compagni Eppure non li salvograve i compagni per quanto bramasse per la loro stessa follia si persero gli stolti i buoi del Sole Iperione mangiarono e quello rapigrave ad essi il digrave del ritorno Di questo da un punto qualsiasi narra anche a noi o dea figlia di Zeus
Storie favolose di naviganti racconti imperniati sul ritorno dei guerrieri achei che avevano combattuto a Troia e il particolare rientro in patria di Odisseo figlio di Laerte erano forse giagrave stati connessi e intrecciati nella precedente tradizione epica sigrave che il presente cantore poteva
Letteratura greca [1]
26
metter mano alla vicenda partendo (v 10) laquoda un punto qualsiasiraquo (ἁμόθεν) una notazione che certo presuppone la convenzione propria dellrsquoesordio tradizionale di un canto epico comparabile con i giagrave ricordati ἐξ οὗ (laquoda quandoraquo) di Iliade I 4 ed ἔνθεν (laquoda doveraquo) di Odissea VIII 500 Senoncheacute rispetto a queste indicazioni di tipo puntuale il tratto costituito dalla dimensione casuale quasi arbitraria inerente ad ἁμόθεν proprio mentre dichiara lrsquoassenza di un determinato piano compositivo implica in realtagrave che il racconto non si svolgeragrave per filo e per segno secondo lrsquoordine noto a poeta e uditori non si snoderagrave κατὰ κόσμον (laquoper ordineraquo) come il canto di Demodoco (VIII 489) ma seguiragrave un andamento originale Il ldquopunto qualsiasirdquo incipitario non rappresenta una scelta della Musa (figura dellrsquoarchivio tematico che conserva le laquovieraquo dellrsquoepica) bensigrave di questo cantore che ha deciso di far incominciare la narrazione in medias res e ha in serbo la sorpresa di far succedere al concilio degli degravei (che decide lrsquoinvio di Ermes presso Calipso) non lrsquoazione testeacute programmata (azione che viene differita con un ritardo che a piugrave riprese ha scandalizzato i lettori a principio del V canto) ma la partenza di Atena alla volta di Itaca e lrsquoavvio della laquoTelemachiaraquo Le due diverse vicende proposte a principio del poema quella di Telemaco e quella di Odisseo procedono infatti in parallelo coprendo un analogo lasso di tempo Piugrave oltre la decisione di trasformare la sequenza narrativa che va dalla partenza di Odisseo da Troia fino al suo arrivo nella terra dei Feaci in una rievocazione fatta dallrsquoeroe in prima persona al cospetto di Alcinoo e dei Feaci (la sezione detta degli ἀπόλογοι laquoraccontiraquo) crea una struttura ad anello che parte dal presente e ad esso fa ritorno dopo aver ricostruito le premesse della condizione attuale del protagonista Col canto XIII Odisseo egrave riportato dai Feaci a Itaca e questo permette la saldatura fra le vicende sue e quelle di Telemaco sia pure col differimento dellrsquoincontro e del riconoscimento fra padre e figlio fino al canto XVI Far scorrere in parallelo sequenze distinte organizzare programmi narrativi a corta e a lunga gittata tendere o allentare ad arte il ritmo della narrazione non si tratta davvero di procedimenti che potessero configurarsi come tradizionali dellrsquoarte epica quanto piuttosto di un momento sperimentale di una ricerca di soluzioni nuove al termine di una lunga e ormai consolidata sedimentazione di percorsi compiuti allrsquointerno di un determinato repertorio tematico unrsquoaudacia inventiva una πολυτροπίη degne del protagonista del poema che inevitabilmente comportavano rischi molteplici di incoerenze dissonanze occasionali avarie della macchina epica e che tuttavia erano destinate a conseguire un risultato assolutamente convincente allrsquoorecchio di chi si abbandonasse al fascino del racconto senza lrsquourgenza propria di altre etagrave e di altre mentalitagrave di puntare il dito sui singoli dettagli o le singole sfasature
PER SAPERNE DI PIUrsquo Difficoltagrave e incongruenze della narrazione omerica Forti della possibilitagrave di un controllo su un testo scritto che possiamo percorrere in avanti e a ritroso secondo ritmi di nostra scelta a noi non riesce difficile cogliere alcune delle difficoltagrave organizzative incontrate nella composizione del poema In proposito per ricordare un caso che saragrave allrsquoorigine delle discussioni di orientamento ldquoanaliticordquo intorno allrsquoOdissea possiamo leggere il discorso che Atena prese le sembianze di Mente re dei Tafi rivolge a Telemaco nel I canto (vv 253-305) Ah infelice ti manca molto davvero lrsquoassente Odisseo che getti le mani addosso ai pretendenti sfrontati Percheacute se ora tornato stesse sulla soglia 255 con una scure lo scudo e due lance cosigrave come io per la prima volta lo vidi in casa nostra che beveva e godeva di ritorno da Efira da Ilo di Mermero (andograve anche ligrave Odisseo con la nave veloce 260 in cerca del veleno omicida per averne da ungere le frecce di bronzo ma quello non glielo diede percheacute temeva gli dei che vivono eterni
Letteratura greca [1]
27
glielo diede invece mio padre percheacute lrsquoamava moltissimo) se stesse Odisseo tra i pretendenti cosigrave 265 essi avrebbero tutti rapida morte e nozze amare Ma sulle ginocchia degli dei questo giace se una volta tornato faragrave o no vendetta nella sua casa te invece io esorto a riflettere come cacciare i pretendenti da casa 270 Ebbene ora ascolta e alle mie parole darsquo retta Domattina chiamati gli eroi Achei a consiglio rivolgi a tutti un discorso e siano testimoni gli dei Ai pretendenti comanda drsquoandarsene per i fatti loro e tua madre se lrsquoanimo la spinge alle nozze 275 ritorni a casa del padre molto potente Prepareranno essi le nozze e disporranno i doni nuziali moltissimi quanti gli pare che debbano andare alla figlia A te darograve un saggio consiglio se vuoi ascoltarlo armata una nave con venti remi la migliore che crsquoegrave 280 Varsquo a domandare del padre partito da tempo se mai te ne parli un mortale o sentissi da Zeus la voce che divulga la fama tra gli uomini Anzitutto varsquo a Pilo e interroga il chiaro Nestore di ligrave poi varsquo a Sparta dal biondo Menelao 285 degli Achei vestiti di bronzo egli egrave tornato per ultimo Se senti dire qualcosa sulla vita e il ritorno del padre per quanto stremato potresti sopportare un altro anno se invece senti dire che egrave morto e non vive allora tornato nella cara terra patria 290 ergigli un tumulo e offrigli funebri offerte moltissime quanto conviene e darsquo tua madre a un marito E poi dopo aver compiuto e fatto ogni cosa allora medita nella mente e nellrsquoanimo come tu possa uccidere nelle tue case 295 i pretendenti con lrsquoinganno affrontandoli non devi piugrave avere i modi di un bimbo percheacute ormai non sei tale Non senti lrsquoillustre Oreste quale gloria ha acquistato fra tutti gli uomini percheacute uccise lrsquoassassino del padre Egisto esperto di inganni che gli uccise il nobile padre 300 Anche tu caro infatti molto bello e grande ti vedo sii valoroso percheacute ti lodi anche qualcuno dei posteri Ma io tornerograve adesso alla nave veloce dai compagni che forse impazienti mi aspettano Tu devi pensarci da te dammi retta 305
[Tr di GA Privitera] Le stranezze non mancano davvero e cosigrave sono state messe a fuoco da Stephanie West nel suo commento23 1 Atena sa evidentemente molto piugrave di quanto uno come Mente avrebbe potuto sapere in particolare ella sa che i proci ignoreranno lrsquoinvito di Telemaco a lasciare la sua casa e fatto piugrave importante che gli degravei tra breve ricondurranno in patria Odisseo A queste osservazioni si puograve replicare con la stessa West che laquosi sono esagerate difficoltagrave e
23 Omero Odissea I cit 219 ss
Letteratura greca [1]
28
incongruenze alle quali un pubblico di ascoltatori (o anche un lettore moderatamente attento) probabilmente non farebbe casoraquo 2 Il progetto di una pubblica denuncia dei proci dinanzi agli degravei e agli uomini ai vv 273-274 egrave ciograve che Atena sembra prefiggersi nel promuovere lrsquoassemblea degli Itacesi (assemblea che effettivamente avragrave luogo a principio del canto II) drsquoaltra parte le successive istruzioni di AtenaMente ai vv 295 s (medita come uccidere i pretendenti) presuppongono che di quella richiesta da formulare nel corso dellrsquoassembla essi non terranno alcun conto Anche a questa osservazione si puograve rispondere che laquoegrave ragionevole attendersi che Telemaco condivida la previsione di un esito negativo della sua iniziativaraquo e si puograve aggiungere che pure in caso di insuccesso il ricorso allrsquoassemblea potrebbe ottenere almeno il risultato di screditare i pretendenti presso la comunitagrave itacese legittimando un successivo ricorso alla violenza (e si tratta di una legittimazione di cui anche lrsquoultimo canto mostreragrave lrsquoesigenza) 3 Dopo che Telemaco aveva detto che la madre non intendeva risposarsi (vv 249-250) AtenaMente si esprime ai vv 275-278 come se Penelope desiderasse proprio nuove nozze e inoltre sarebbe assurdo che il padre di Penelope cominciasse a contrattare un secondo matrimonio prima del ritorno di Telemaco dal suo viaggio e che mettesse mano a preparativi che rischierebbero di essere annullati qualche tempo dopo con inevitabile imbarazzo se Telemaco venisse a sapere che Odisseo egrave ancora vivo In piugrave lrsquoandamento sintattico di questi versi presenta un anacoluto durissimo per cui a principio del v 275 lrsquoaccusativo μητέρα egrave seguito da un ἂψ ἴτω (laquovada indietroraquo laquotorniraquo) che richiederebbe come soggetto un nominativo μήτηρ Come hanno reagito i lettori di Omero Nellrsquoantichitagrave un grammatico rimasto anonimo cambiava come attesta uno scolio μητέρ᾽ in μήτηρ nel secolo XVIII Richard Bentley modificava ἴτω in ἴμεν (infinito eolico di εἶμι laquovadoraquo) nel XIX un altro grande della filologia europea Gottfried Hermann risolveva piugrave drasticamente la questione eliminando il complesso dei vv 275-278 e la stessa West mostra simpatia per tale proposta supponendo laquounrsquoaggiunta posteriore modellata sul corrispondente passo del libro IIraquo (dove i vv 196 s sono identici ai vv 277 s e il v 195 copre lo stesso contenuto dei vv 275 s) Si tratta di procedimenti adeguati ai dati di fatto Migliorano davvero il testo che ci egrave stato tramandato In realtagrave ambedue le ldquocorrezionirdquo appena ricordate (di μήτερ᾽ e di ἴτω) ottengono un risultato tanto lineare che egrave davvero difficile pensare che lrsquoanacoluto avrebbe potuto invadere tutta la tradizione se non fosse stato originario e quanto allrsquoespunzione dei vv 275-278 essa indubbiamente peggiorerebbe il ritmo del discorso determinando lrsquoavvicinamento fra i due versi (v 271 e v 279) molto simili fra loro che aprono le due sequenze occupate dai consigli di Mente E allora La via piugrave saggia egrave senzrsquoaltro quella di tenerci qui come quasi sempre di fronte al testo omerico contraddizioni e anacoluti riconoscendo in essi lrsquoeffetto dellrsquoattivitagrave di un cantore che pur sulla base di una traccia largamente memorizzata restava pur sempre legato a quella prassi orale per cui composizione ed esecuzione tendevano a coincidere E lrsquoanacoluto si spiega bene se cerchiamo di immedesimarci nel procedimento seguito dal poeta Egli ha affidato ad Atena un certo flusso argomentativo per cui la dea deve dar consigli a Telemaco sui suoi rapporti coi proci e con la madre e cosigrave colloca in fine di v 274 un ἄνωχθι (laquoordinaraquo) destinato a reggere gli accusativi simmetricamente dislocati in principio di verso (vv 274 e 275) μνηστῆρας e μητέρα Senoncheacute giunto a questa seconda parte dellrsquoargomentazione egli si avvede quanto sarebbe illogico che Telemaco sollecitasse la madre a nuove nozze di qui lrsquoimprovviso cambio di costruzione che svincola al prezzo di una sensibile slogatura sintattica lrsquoipotesi delle nuove nozze dallrsquoordine impartito a Telemaco e la prospetta invece come un desiderio eventuale della stessa Penelope Il poeta ha un progetto ben meditato brani e sequenze piugrave volte sperimentati ed egrave col supporto di questi materiali giagrave elaborati che egli si fa strada attraverso le insidie della
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
24
compagni spronati da Euriloco se ne cibano nonostante il divieto dellrsquoeroe Il Sole sdegnato ottiene da Zeus che la nave sia colpita dal fulmine Tutti i compagni periscono ma Odisseo che ripassa tra Scilla e Cariddi si salva miracolosamente da questrsquoultima aggrappandosi a un fico selvatico fincheacute il gorgo restituisce i rottami della nave infine arriva remando con le mani allrsquoisola di Ogigia Canto XIII Terminato il racconto lrsquoeroe riceve doni dai Feaci e la notte seguente egrave ricondotto a Itaca e deposto addormentato sulla spiaggia presso un antro sacro alle Ninfe Al risveglio per la nebbia non riconosce la sua terra fincheacute Atena in veste di giovane pastore lo rassicura e poi rivelatasi gli dagrave istruzioni su come far strage dei proci e lo trasforma in un vecchio mendico Canto XIV Odisseo si reca allo stazzo del suo porcaio Eumeo che pur non riconoscendolo lo accoglie ospitalmente rifocillandolo e offrendogli un mantello per ripararsi dal gelo notturno Canto XV A questo punto la laquoTelemachiaraquo si riannoda allrsquoazione principale Telemaco che si trova ancora a Sparta viene indotto da Atena a tornare a Itaca sulla via del ritorno a Pilo accoglie a bordo lrsquoindovino Teoclimeno e grazie allrsquoaiuto della dea sfugge alle insidie dei proci sbarca a Itaca e si reca anchrsquoegli presso Eumeo Canto XVI Questi va da Penelope ad annunciargli il ritorno del figlio Intanto Odisseo rimosso lrsquoincantesimo si svela nel suo vero aspetto a Telemaco e con lui progetta la vendetta sui proci (che intanto tramano una nuova insidia ai danni di Telemaco) Eumeo torna al suo stazzo Canto XVII Il mattino seguente Telemaco si reca in cittagrave seguito in un secondo tempo da Eumeo e Odisseo (che ha riassunto lrsquoaspetto di mendico) Davanti al palazzo Odisseo egrave riconosciuto dal cane Argo Entra e va mendicando tra i proci Antinoo lo colpisce alla spalla destra con uno sgabello Canto XVIII Odisseo si batte al pugilato col mendicante Iro Penelope scesa nella sala prospetta ai proci lrsquoeventualitagrave di un nuovo matrimonio Odisseo egrave insultato dalla schiava Melanto e schiva uno sgabello scagliato da Eurinomo Canto XIX Insieme con Telemaco lrsquoeroe allontana le armi dalla sala poi conversa con Penelope che gli racconta un sogno e gli espone il suo piano per sedare le contese tra i proci concedendosi sposa a colui che riusciragrave a tendere lrsquoarco di Odisseo la prova avverragrave il giorno seguente al novilunio Durante il colloquio la fida schiava Euriclea lava i piedi di Odisseo e riconosciutolo da unrsquoantica cicatrice sta per rivelarne lrsquoidentitagrave ma lrsquoeroe la costringe a tacere Canto XX Al mattino Euriclea e le ancelle fanno i preparativi per il banchetto Giungono Eumeo Melanzio e il mandriano Filezio Un presagio mandato da Zeus dissuade i proci dal progetto di uccidere Telemaco Durante il banchetto Teoclimeno predice la loro imminente rovina
Letteratura greca [1]
25
Canto XXI Penelope conduce lrsquoarco nella sala dopo che parecchi fra i proci e lo stesso Telemaco hanno tentato invano di tenderne la corda Odisseo chiede di partecipare alla prova tende lrsquoarco senza fatica e riesce a far passare la freccia attraverso gli anelli di dodici scuri predisposte da Telemaco Canto XXII Poi scaglia le frecce sui proci e si rivela nella sua identitagrave Nella lotta che segue Telemaco Eumeo e Filezio aiutano il padrone contro i proci (appoggiati dal capraio Melanzio) Tutti i proci restano uccisi le ancelle infedeli sono impiccate Melanzio viene mutilato e ucciso soltanto lrsquoaedo Femio e lrsquoaraldo Medonte sono risparmiati Canto XXIII Nuovo colloquio fra Odisseo e Penelope che durante lrsquoeccidio dormiva ed egrave stata svegliata da Euriclea Penelope esita ancora a riconoscere il marito e non si arrende alla veritagrave fincheacute Odisseo non le descrive la posizione e la struttura del letto coniugale Canto XXIV Ermes conduce allrsquoAde le ombre dei proci Odisseo fa visita al padre Laerte nella masseria dove quello vive nello squallore e nellrsquoemarginazione e si fa riconoscere Intanto il padre di Antinoo incita gli Itacesi alla rivolta e il poema si conclude con lo scontro di Odisseo e dei suoi contro i concittadini lrsquoeroe ha la meglio e Zeus scagliato il fulmine pone fine alla battaglia Atena sotto lrsquoaspetto di Mentore stabilisce fra i contendenti un patto per il futuro36
Struttura e caratteri dellʼopera Giagrave la prima parola del proemio (ἄνδρα) non menziona come tema dellrsquoopera un determinato episodio della vita del protagonista ma il protagonista stesso (I 1-10)
Ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα πολύτροπον ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεmiddot πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περmiddot αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο νήπιοι οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιονmiddot αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ τῶν ἁμόθεν γε θεά θύγατερ Διός εἰπὲ καὶ ἡμῖν Dellrsquouomo multiforme a me racconta o Musa che molto errograve dopo che di Troia la sacra rocca distrusse di molti uomini vide le cittagrave riconobbe il pensiero e molti per il mare patigrave dolori nellrsquoanimo per salvare la sua vita e il ritorno dei compagni Eppure non li salvograve i compagni per quanto bramasse per la loro stessa follia si persero gli stolti i buoi del Sole Iperione mangiarono e quello rapigrave ad essi il digrave del ritorno Di questo da un punto qualsiasi narra anche a noi o dea figlia di Zeus
Storie favolose di naviganti racconti imperniati sul ritorno dei guerrieri achei che avevano combattuto a Troia e il particolare rientro in patria di Odisseo figlio di Laerte erano forse giagrave stati connessi e intrecciati nella precedente tradizione epica sigrave che il presente cantore poteva
Letteratura greca [1]
26
metter mano alla vicenda partendo (v 10) laquoda un punto qualsiasiraquo (ἁμόθεν) una notazione che certo presuppone la convenzione propria dellrsquoesordio tradizionale di un canto epico comparabile con i giagrave ricordati ἐξ οὗ (laquoda quandoraquo) di Iliade I 4 ed ἔνθεν (laquoda doveraquo) di Odissea VIII 500 Senoncheacute rispetto a queste indicazioni di tipo puntuale il tratto costituito dalla dimensione casuale quasi arbitraria inerente ad ἁμόθεν proprio mentre dichiara lrsquoassenza di un determinato piano compositivo implica in realtagrave che il racconto non si svolgeragrave per filo e per segno secondo lrsquoordine noto a poeta e uditori non si snoderagrave κατὰ κόσμον (laquoper ordineraquo) come il canto di Demodoco (VIII 489) ma seguiragrave un andamento originale Il ldquopunto qualsiasirdquo incipitario non rappresenta una scelta della Musa (figura dellrsquoarchivio tematico che conserva le laquovieraquo dellrsquoepica) bensigrave di questo cantore che ha deciso di far incominciare la narrazione in medias res e ha in serbo la sorpresa di far succedere al concilio degli degravei (che decide lrsquoinvio di Ermes presso Calipso) non lrsquoazione testeacute programmata (azione che viene differita con un ritardo che a piugrave riprese ha scandalizzato i lettori a principio del V canto) ma la partenza di Atena alla volta di Itaca e lrsquoavvio della laquoTelemachiaraquo Le due diverse vicende proposte a principio del poema quella di Telemaco e quella di Odisseo procedono infatti in parallelo coprendo un analogo lasso di tempo Piugrave oltre la decisione di trasformare la sequenza narrativa che va dalla partenza di Odisseo da Troia fino al suo arrivo nella terra dei Feaci in una rievocazione fatta dallrsquoeroe in prima persona al cospetto di Alcinoo e dei Feaci (la sezione detta degli ἀπόλογοι laquoraccontiraquo) crea una struttura ad anello che parte dal presente e ad esso fa ritorno dopo aver ricostruito le premesse della condizione attuale del protagonista Col canto XIII Odisseo egrave riportato dai Feaci a Itaca e questo permette la saldatura fra le vicende sue e quelle di Telemaco sia pure col differimento dellrsquoincontro e del riconoscimento fra padre e figlio fino al canto XVI Far scorrere in parallelo sequenze distinte organizzare programmi narrativi a corta e a lunga gittata tendere o allentare ad arte il ritmo della narrazione non si tratta davvero di procedimenti che potessero configurarsi come tradizionali dellrsquoarte epica quanto piuttosto di un momento sperimentale di una ricerca di soluzioni nuove al termine di una lunga e ormai consolidata sedimentazione di percorsi compiuti allrsquointerno di un determinato repertorio tematico unrsquoaudacia inventiva una πολυτροπίη degne del protagonista del poema che inevitabilmente comportavano rischi molteplici di incoerenze dissonanze occasionali avarie della macchina epica e che tuttavia erano destinate a conseguire un risultato assolutamente convincente allrsquoorecchio di chi si abbandonasse al fascino del racconto senza lrsquourgenza propria di altre etagrave e di altre mentalitagrave di puntare il dito sui singoli dettagli o le singole sfasature
PER SAPERNE DI PIUrsquo Difficoltagrave e incongruenze della narrazione omerica Forti della possibilitagrave di un controllo su un testo scritto che possiamo percorrere in avanti e a ritroso secondo ritmi di nostra scelta a noi non riesce difficile cogliere alcune delle difficoltagrave organizzative incontrate nella composizione del poema In proposito per ricordare un caso che saragrave allrsquoorigine delle discussioni di orientamento ldquoanaliticordquo intorno allrsquoOdissea possiamo leggere il discorso che Atena prese le sembianze di Mente re dei Tafi rivolge a Telemaco nel I canto (vv 253-305) Ah infelice ti manca molto davvero lrsquoassente Odisseo che getti le mani addosso ai pretendenti sfrontati Percheacute se ora tornato stesse sulla soglia 255 con una scure lo scudo e due lance cosigrave come io per la prima volta lo vidi in casa nostra che beveva e godeva di ritorno da Efira da Ilo di Mermero (andograve anche ligrave Odisseo con la nave veloce 260 in cerca del veleno omicida per averne da ungere le frecce di bronzo ma quello non glielo diede percheacute temeva gli dei che vivono eterni
Letteratura greca [1]
27
glielo diede invece mio padre percheacute lrsquoamava moltissimo) se stesse Odisseo tra i pretendenti cosigrave 265 essi avrebbero tutti rapida morte e nozze amare Ma sulle ginocchia degli dei questo giace se una volta tornato faragrave o no vendetta nella sua casa te invece io esorto a riflettere come cacciare i pretendenti da casa 270 Ebbene ora ascolta e alle mie parole darsquo retta Domattina chiamati gli eroi Achei a consiglio rivolgi a tutti un discorso e siano testimoni gli dei Ai pretendenti comanda drsquoandarsene per i fatti loro e tua madre se lrsquoanimo la spinge alle nozze 275 ritorni a casa del padre molto potente Prepareranno essi le nozze e disporranno i doni nuziali moltissimi quanti gli pare che debbano andare alla figlia A te darograve un saggio consiglio se vuoi ascoltarlo armata una nave con venti remi la migliore che crsquoegrave 280 Varsquo a domandare del padre partito da tempo se mai te ne parli un mortale o sentissi da Zeus la voce che divulga la fama tra gli uomini Anzitutto varsquo a Pilo e interroga il chiaro Nestore di ligrave poi varsquo a Sparta dal biondo Menelao 285 degli Achei vestiti di bronzo egli egrave tornato per ultimo Se senti dire qualcosa sulla vita e il ritorno del padre per quanto stremato potresti sopportare un altro anno se invece senti dire che egrave morto e non vive allora tornato nella cara terra patria 290 ergigli un tumulo e offrigli funebri offerte moltissime quanto conviene e darsquo tua madre a un marito E poi dopo aver compiuto e fatto ogni cosa allora medita nella mente e nellrsquoanimo come tu possa uccidere nelle tue case 295 i pretendenti con lrsquoinganno affrontandoli non devi piugrave avere i modi di un bimbo percheacute ormai non sei tale Non senti lrsquoillustre Oreste quale gloria ha acquistato fra tutti gli uomini percheacute uccise lrsquoassassino del padre Egisto esperto di inganni che gli uccise il nobile padre 300 Anche tu caro infatti molto bello e grande ti vedo sii valoroso percheacute ti lodi anche qualcuno dei posteri Ma io tornerograve adesso alla nave veloce dai compagni che forse impazienti mi aspettano Tu devi pensarci da te dammi retta 305
[Tr di GA Privitera] Le stranezze non mancano davvero e cosigrave sono state messe a fuoco da Stephanie West nel suo commento23 1 Atena sa evidentemente molto piugrave di quanto uno come Mente avrebbe potuto sapere in particolare ella sa che i proci ignoreranno lrsquoinvito di Telemaco a lasciare la sua casa e fatto piugrave importante che gli degravei tra breve ricondurranno in patria Odisseo A queste osservazioni si puograve replicare con la stessa West che laquosi sono esagerate difficoltagrave e
23 Omero Odissea I cit 219 ss
Letteratura greca [1]
28
incongruenze alle quali un pubblico di ascoltatori (o anche un lettore moderatamente attento) probabilmente non farebbe casoraquo 2 Il progetto di una pubblica denuncia dei proci dinanzi agli degravei e agli uomini ai vv 273-274 egrave ciograve che Atena sembra prefiggersi nel promuovere lrsquoassemblea degli Itacesi (assemblea che effettivamente avragrave luogo a principio del canto II) drsquoaltra parte le successive istruzioni di AtenaMente ai vv 295 s (medita come uccidere i pretendenti) presuppongono che di quella richiesta da formulare nel corso dellrsquoassembla essi non terranno alcun conto Anche a questa osservazione si puograve rispondere che laquoegrave ragionevole attendersi che Telemaco condivida la previsione di un esito negativo della sua iniziativaraquo e si puograve aggiungere che pure in caso di insuccesso il ricorso allrsquoassemblea potrebbe ottenere almeno il risultato di screditare i pretendenti presso la comunitagrave itacese legittimando un successivo ricorso alla violenza (e si tratta di una legittimazione di cui anche lrsquoultimo canto mostreragrave lrsquoesigenza) 3 Dopo che Telemaco aveva detto che la madre non intendeva risposarsi (vv 249-250) AtenaMente si esprime ai vv 275-278 come se Penelope desiderasse proprio nuove nozze e inoltre sarebbe assurdo che il padre di Penelope cominciasse a contrattare un secondo matrimonio prima del ritorno di Telemaco dal suo viaggio e che mettesse mano a preparativi che rischierebbero di essere annullati qualche tempo dopo con inevitabile imbarazzo se Telemaco venisse a sapere che Odisseo egrave ancora vivo In piugrave lrsquoandamento sintattico di questi versi presenta un anacoluto durissimo per cui a principio del v 275 lrsquoaccusativo μητέρα egrave seguito da un ἂψ ἴτω (laquovada indietroraquo laquotorniraquo) che richiederebbe come soggetto un nominativo μήτηρ Come hanno reagito i lettori di Omero Nellrsquoantichitagrave un grammatico rimasto anonimo cambiava come attesta uno scolio μητέρ᾽ in μήτηρ nel secolo XVIII Richard Bentley modificava ἴτω in ἴμεν (infinito eolico di εἶμι laquovadoraquo) nel XIX un altro grande della filologia europea Gottfried Hermann risolveva piugrave drasticamente la questione eliminando il complesso dei vv 275-278 e la stessa West mostra simpatia per tale proposta supponendo laquounrsquoaggiunta posteriore modellata sul corrispondente passo del libro IIraquo (dove i vv 196 s sono identici ai vv 277 s e il v 195 copre lo stesso contenuto dei vv 275 s) Si tratta di procedimenti adeguati ai dati di fatto Migliorano davvero il testo che ci egrave stato tramandato In realtagrave ambedue le ldquocorrezionirdquo appena ricordate (di μήτερ᾽ e di ἴτω) ottengono un risultato tanto lineare che egrave davvero difficile pensare che lrsquoanacoluto avrebbe potuto invadere tutta la tradizione se non fosse stato originario e quanto allrsquoespunzione dei vv 275-278 essa indubbiamente peggiorerebbe il ritmo del discorso determinando lrsquoavvicinamento fra i due versi (v 271 e v 279) molto simili fra loro che aprono le due sequenze occupate dai consigli di Mente E allora La via piugrave saggia egrave senzrsquoaltro quella di tenerci qui come quasi sempre di fronte al testo omerico contraddizioni e anacoluti riconoscendo in essi lrsquoeffetto dellrsquoattivitagrave di un cantore che pur sulla base di una traccia largamente memorizzata restava pur sempre legato a quella prassi orale per cui composizione ed esecuzione tendevano a coincidere E lrsquoanacoluto si spiega bene se cerchiamo di immedesimarci nel procedimento seguito dal poeta Egli ha affidato ad Atena un certo flusso argomentativo per cui la dea deve dar consigli a Telemaco sui suoi rapporti coi proci e con la madre e cosigrave colloca in fine di v 274 un ἄνωχθι (laquoordinaraquo) destinato a reggere gli accusativi simmetricamente dislocati in principio di verso (vv 274 e 275) μνηστῆρας e μητέρα Senoncheacute giunto a questa seconda parte dellrsquoargomentazione egli si avvede quanto sarebbe illogico che Telemaco sollecitasse la madre a nuove nozze di qui lrsquoimprovviso cambio di costruzione che svincola al prezzo di una sensibile slogatura sintattica lrsquoipotesi delle nuove nozze dallrsquoordine impartito a Telemaco e la prospetta invece come un desiderio eventuale della stessa Penelope Il poeta ha un progetto ben meditato brani e sequenze piugrave volte sperimentati ed egrave col supporto di questi materiali giagrave elaborati che egli si fa strada attraverso le insidie della
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
25
Canto XXI Penelope conduce lrsquoarco nella sala dopo che parecchi fra i proci e lo stesso Telemaco hanno tentato invano di tenderne la corda Odisseo chiede di partecipare alla prova tende lrsquoarco senza fatica e riesce a far passare la freccia attraverso gli anelli di dodici scuri predisposte da Telemaco Canto XXII Poi scaglia le frecce sui proci e si rivela nella sua identitagrave Nella lotta che segue Telemaco Eumeo e Filezio aiutano il padrone contro i proci (appoggiati dal capraio Melanzio) Tutti i proci restano uccisi le ancelle infedeli sono impiccate Melanzio viene mutilato e ucciso soltanto lrsquoaedo Femio e lrsquoaraldo Medonte sono risparmiati Canto XXIII Nuovo colloquio fra Odisseo e Penelope che durante lrsquoeccidio dormiva ed egrave stata svegliata da Euriclea Penelope esita ancora a riconoscere il marito e non si arrende alla veritagrave fincheacute Odisseo non le descrive la posizione e la struttura del letto coniugale Canto XXIV Ermes conduce allrsquoAde le ombre dei proci Odisseo fa visita al padre Laerte nella masseria dove quello vive nello squallore e nellrsquoemarginazione e si fa riconoscere Intanto il padre di Antinoo incita gli Itacesi alla rivolta e il poema si conclude con lo scontro di Odisseo e dei suoi contro i concittadini lrsquoeroe ha la meglio e Zeus scagliato il fulmine pone fine alla battaglia Atena sotto lrsquoaspetto di Mentore stabilisce fra i contendenti un patto per il futuro36
Struttura e caratteri dellʼopera Giagrave la prima parola del proemio (ἄνδρα) non menziona come tema dellrsquoopera un determinato episodio della vita del protagonista ma il protagonista stesso (I 1-10)
Ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα πολύτροπον ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεmiddot πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο ἱέμενός περmiddot αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο νήπιοι οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιονmiddot αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ τῶν ἁμόθεν γε θεά θύγατερ Διός εἰπὲ καὶ ἡμῖν Dellrsquouomo multiforme a me racconta o Musa che molto errograve dopo che di Troia la sacra rocca distrusse di molti uomini vide le cittagrave riconobbe il pensiero e molti per il mare patigrave dolori nellrsquoanimo per salvare la sua vita e il ritorno dei compagni Eppure non li salvograve i compagni per quanto bramasse per la loro stessa follia si persero gli stolti i buoi del Sole Iperione mangiarono e quello rapigrave ad essi il digrave del ritorno Di questo da un punto qualsiasi narra anche a noi o dea figlia di Zeus
Storie favolose di naviganti racconti imperniati sul ritorno dei guerrieri achei che avevano combattuto a Troia e il particolare rientro in patria di Odisseo figlio di Laerte erano forse giagrave stati connessi e intrecciati nella precedente tradizione epica sigrave che il presente cantore poteva
Letteratura greca [1]
26
metter mano alla vicenda partendo (v 10) laquoda un punto qualsiasiraquo (ἁμόθεν) una notazione che certo presuppone la convenzione propria dellrsquoesordio tradizionale di un canto epico comparabile con i giagrave ricordati ἐξ οὗ (laquoda quandoraquo) di Iliade I 4 ed ἔνθεν (laquoda doveraquo) di Odissea VIII 500 Senoncheacute rispetto a queste indicazioni di tipo puntuale il tratto costituito dalla dimensione casuale quasi arbitraria inerente ad ἁμόθεν proprio mentre dichiara lrsquoassenza di un determinato piano compositivo implica in realtagrave che il racconto non si svolgeragrave per filo e per segno secondo lrsquoordine noto a poeta e uditori non si snoderagrave κατὰ κόσμον (laquoper ordineraquo) come il canto di Demodoco (VIII 489) ma seguiragrave un andamento originale Il ldquopunto qualsiasirdquo incipitario non rappresenta una scelta della Musa (figura dellrsquoarchivio tematico che conserva le laquovieraquo dellrsquoepica) bensigrave di questo cantore che ha deciso di far incominciare la narrazione in medias res e ha in serbo la sorpresa di far succedere al concilio degli degravei (che decide lrsquoinvio di Ermes presso Calipso) non lrsquoazione testeacute programmata (azione che viene differita con un ritardo che a piugrave riprese ha scandalizzato i lettori a principio del V canto) ma la partenza di Atena alla volta di Itaca e lrsquoavvio della laquoTelemachiaraquo Le due diverse vicende proposte a principio del poema quella di Telemaco e quella di Odisseo procedono infatti in parallelo coprendo un analogo lasso di tempo Piugrave oltre la decisione di trasformare la sequenza narrativa che va dalla partenza di Odisseo da Troia fino al suo arrivo nella terra dei Feaci in una rievocazione fatta dallrsquoeroe in prima persona al cospetto di Alcinoo e dei Feaci (la sezione detta degli ἀπόλογοι laquoraccontiraquo) crea una struttura ad anello che parte dal presente e ad esso fa ritorno dopo aver ricostruito le premesse della condizione attuale del protagonista Col canto XIII Odisseo egrave riportato dai Feaci a Itaca e questo permette la saldatura fra le vicende sue e quelle di Telemaco sia pure col differimento dellrsquoincontro e del riconoscimento fra padre e figlio fino al canto XVI Far scorrere in parallelo sequenze distinte organizzare programmi narrativi a corta e a lunga gittata tendere o allentare ad arte il ritmo della narrazione non si tratta davvero di procedimenti che potessero configurarsi come tradizionali dellrsquoarte epica quanto piuttosto di un momento sperimentale di una ricerca di soluzioni nuove al termine di una lunga e ormai consolidata sedimentazione di percorsi compiuti allrsquointerno di un determinato repertorio tematico unrsquoaudacia inventiva una πολυτροπίη degne del protagonista del poema che inevitabilmente comportavano rischi molteplici di incoerenze dissonanze occasionali avarie della macchina epica e che tuttavia erano destinate a conseguire un risultato assolutamente convincente allrsquoorecchio di chi si abbandonasse al fascino del racconto senza lrsquourgenza propria di altre etagrave e di altre mentalitagrave di puntare il dito sui singoli dettagli o le singole sfasature
PER SAPERNE DI PIUrsquo Difficoltagrave e incongruenze della narrazione omerica Forti della possibilitagrave di un controllo su un testo scritto che possiamo percorrere in avanti e a ritroso secondo ritmi di nostra scelta a noi non riesce difficile cogliere alcune delle difficoltagrave organizzative incontrate nella composizione del poema In proposito per ricordare un caso che saragrave allrsquoorigine delle discussioni di orientamento ldquoanaliticordquo intorno allrsquoOdissea possiamo leggere il discorso che Atena prese le sembianze di Mente re dei Tafi rivolge a Telemaco nel I canto (vv 253-305) Ah infelice ti manca molto davvero lrsquoassente Odisseo che getti le mani addosso ai pretendenti sfrontati Percheacute se ora tornato stesse sulla soglia 255 con una scure lo scudo e due lance cosigrave come io per la prima volta lo vidi in casa nostra che beveva e godeva di ritorno da Efira da Ilo di Mermero (andograve anche ligrave Odisseo con la nave veloce 260 in cerca del veleno omicida per averne da ungere le frecce di bronzo ma quello non glielo diede percheacute temeva gli dei che vivono eterni
Letteratura greca [1]
27
glielo diede invece mio padre percheacute lrsquoamava moltissimo) se stesse Odisseo tra i pretendenti cosigrave 265 essi avrebbero tutti rapida morte e nozze amare Ma sulle ginocchia degli dei questo giace se una volta tornato faragrave o no vendetta nella sua casa te invece io esorto a riflettere come cacciare i pretendenti da casa 270 Ebbene ora ascolta e alle mie parole darsquo retta Domattina chiamati gli eroi Achei a consiglio rivolgi a tutti un discorso e siano testimoni gli dei Ai pretendenti comanda drsquoandarsene per i fatti loro e tua madre se lrsquoanimo la spinge alle nozze 275 ritorni a casa del padre molto potente Prepareranno essi le nozze e disporranno i doni nuziali moltissimi quanti gli pare che debbano andare alla figlia A te darograve un saggio consiglio se vuoi ascoltarlo armata una nave con venti remi la migliore che crsquoegrave 280 Varsquo a domandare del padre partito da tempo se mai te ne parli un mortale o sentissi da Zeus la voce che divulga la fama tra gli uomini Anzitutto varsquo a Pilo e interroga il chiaro Nestore di ligrave poi varsquo a Sparta dal biondo Menelao 285 degli Achei vestiti di bronzo egli egrave tornato per ultimo Se senti dire qualcosa sulla vita e il ritorno del padre per quanto stremato potresti sopportare un altro anno se invece senti dire che egrave morto e non vive allora tornato nella cara terra patria 290 ergigli un tumulo e offrigli funebri offerte moltissime quanto conviene e darsquo tua madre a un marito E poi dopo aver compiuto e fatto ogni cosa allora medita nella mente e nellrsquoanimo come tu possa uccidere nelle tue case 295 i pretendenti con lrsquoinganno affrontandoli non devi piugrave avere i modi di un bimbo percheacute ormai non sei tale Non senti lrsquoillustre Oreste quale gloria ha acquistato fra tutti gli uomini percheacute uccise lrsquoassassino del padre Egisto esperto di inganni che gli uccise il nobile padre 300 Anche tu caro infatti molto bello e grande ti vedo sii valoroso percheacute ti lodi anche qualcuno dei posteri Ma io tornerograve adesso alla nave veloce dai compagni che forse impazienti mi aspettano Tu devi pensarci da te dammi retta 305
[Tr di GA Privitera] Le stranezze non mancano davvero e cosigrave sono state messe a fuoco da Stephanie West nel suo commento23 1 Atena sa evidentemente molto piugrave di quanto uno come Mente avrebbe potuto sapere in particolare ella sa che i proci ignoreranno lrsquoinvito di Telemaco a lasciare la sua casa e fatto piugrave importante che gli degravei tra breve ricondurranno in patria Odisseo A queste osservazioni si puograve replicare con la stessa West che laquosi sono esagerate difficoltagrave e
23 Omero Odissea I cit 219 ss
Letteratura greca [1]
28
incongruenze alle quali un pubblico di ascoltatori (o anche un lettore moderatamente attento) probabilmente non farebbe casoraquo 2 Il progetto di una pubblica denuncia dei proci dinanzi agli degravei e agli uomini ai vv 273-274 egrave ciograve che Atena sembra prefiggersi nel promuovere lrsquoassemblea degli Itacesi (assemblea che effettivamente avragrave luogo a principio del canto II) drsquoaltra parte le successive istruzioni di AtenaMente ai vv 295 s (medita come uccidere i pretendenti) presuppongono che di quella richiesta da formulare nel corso dellrsquoassembla essi non terranno alcun conto Anche a questa osservazione si puograve rispondere che laquoegrave ragionevole attendersi che Telemaco condivida la previsione di un esito negativo della sua iniziativaraquo e si puograve aggiungere che pure in caso di insuccesso il ricorso allrsquoassemblea potrebbe ottenere almeno il risultato di screditare i pretendenti presso la comunitagrave itacese legittimando un successivo ricorso alla violenza (e si tratta di una legittimazione di cui anche lrsquoultimo canto mostreragrave lrsquoesigenza) 3 Dopo che Telemaco aveva detto che la madre non intendeva risposarsi (vv 249-250) AtenaMente si esprime ai vv 275-278 come se Penelope desiderasse proprio nuove nozze e inoltre sarebbe assurdo che il padre di Penelope cominciasse a contrattare un secondo matrimonio prima del ritorno di Telemaco dal suo viaggio e che mettesse mano a preparativi che rischierebbero di essere annullati qualche tempo dopo con inevitabile imbarazzo se Telemaco venisse a sapere che Odisseo egrave ancora vivo In piugrave lrsquoandamento sintattico di questi versi presenta un anacoluto durissimo per cui a principio del v 275 lrsquoaccusativo μητέρα egrave seguito da un ἂψ ἴτω (laquovada indietroraquo laquotorniraquo) che richiederebbe come soggetto un nominativo μήτηρ Come hanno reagito i lettori di Omero Nellrsquoantichitagrave un grammatico rimasto anonimo cambiava come attesta uno scolio μητέρ᾽ in μήτηρ nel secolo XVIII Richard Bentley modificava ἴτω in ἴμεν (infinito eolico di εἶμι laquovadoraquo) nel XIX un altro grande della filologia europea Gottfried Hermann risolveva piugrave drasticamente la questione eliminando il complesso dei vv 275-278 e la stessa West mostra simpatia per tale proposta supponendo laquounrsquoaggiunta posteriore modellata sul corrispondente passo del libro IIraquo (dove i vv 196 s sono identici ai vv 277 s e il v 195 copre lo stesso contenuto dei vv 275 s) Si tratta di procedimenti adeguati ai dati di fatto Migliorano davvero il testo che ci egrave stato tramandato In realtagrave ambedue le ldquocorrezionirdquo appena ricordate (di μήτερ᾽ e di ἴτω) ottengono un risultato tanto lineare che egrave davvero difficile pensare che lrsquoanacoluto avrebbe potuto invadere tutta la tradizione se non fosse stato originario e quanto allrsquoespunzione dei vv 275-278 essa indubbiamente peggiorerebbe il ritmo del discorso determinando lrsquoavvicinamento fra i due versi (v 271 e v 279) molto simili fra loro che aprono le due sequenze occupate dai consigli di Mente E allora La via piugrave saggia egrave senzrsquoaltro quella di tenerci qui come quasi sempre di fronte al testo omerico contraddizioni e anacoluti riconoscendo in essi lrsquoeffetto dellrsquoattivitagrave di un cantore che pur sulla base di una traccia largamente memorizzata restava pur sempre legato a quella prassi orale per cui composizione ed esecuzione tendevano a coincidere E lrsquoanacoluto si spiega bene se cerchiamo di immedesimarci nel procedimento seguito dal poeta Egli ha affidato ad Atena un certo flusso argomentativo per cui la dea deve dar consigli a Telemaco sui suoi rapporti coi proci e con la madre e cosigrave colloca in fine di v 274 un ἄνωχθι (laquoordinaraquo) destinato a reggere gli accusativi simmetricamente dislocati in principio di verso (vv 274 e 275) μνηστῆρας e μητέρα Senoncheacute giunto a questa seconda parte dellrsquoargomentazione egli si avvede quanto sarebbe illogico che Telemaco sollecitasse la madre a nuove nozze di qui lrsquoimprovviso cambio di costruzione che svincola al prezzo di una sensibile slogatura sintattica lrsquoipotesi delle nuove nozze dallrsquoordine impartito a Telemaco e la prospetta invece come un desiderio eventuale della stessa Penelope Il poeta ha un progetto ben meditato brani e sequenze piugrave volte sperimentati ed egrave col supporto di questi materiali giagrave elaborati che egli si fa strada attraverso le insidie della
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
26
metter mano alla vicenda partendo (v 10) laquoda un punto qualsiasiraquo (ἁμόθεν) una notazione che certo presuppone la convenzione propria dellrsquoesordio tradizionale di un canto epico comparabile con i giagrave ricordati ἐξ οὗ (laquoda quandoraquo) di Iliade I 4 ed ἔνθεν (laquoda doveraquo) di Odissea VIII 500 Senoncheacute rispetto a queste indicazioni di tipo puntuale il tratto costituito dalla dimensione casuale quasi arbitraria inerente ad ἁμόθεν proprio mentre dichiara lrsquoassenza di un determinato piano compositivo implica in realtagrave che il racconto non si svolgeragrave per filo e per segno secondo lrsquoordine noto a poeta e uditori non si snoderagrave κατὰ κόσμον (laquoper ordineraquo) come il canto di Demodoco (VIII 489) ma seguiragrave un andamento originale Il ldquopunto qualsiasirdquo incipitario non rappresenta una scelta della Musa (figura dellrsquoarchivio tematico che conserva le laquovieraquo dellrsquoepica) bensigrave di questo cantore che ha deciso di far incominciare la narrazione in medias res e ha in serbo la sorpresa di far succedere al concilio degli degravei (che decide lrsquoinvio di Ermes presso Calipso) non lrsquoazione testeacute programmata (azione che viene differita con un ritardo che a piugrave riprese ha scandalizzato i lettori a principio del V canto) ma la partenza di Atena alla volta di Itaca e lrsquoavvio della laquoTelemachiaraquo Le due diverse vicende proposte a principio del poema quella di Telemaco e quella di Odisseo procedono infatti in parallelo coprendo un analogo lasso di tempo Piugrave oltre la decisione di trasformare la sequenza narrativa che va dalla partenza di Odisseo da Troia fino al suo arrivo nella terra dei Feaci in una rievocazione fatta dallrsquoeroe in prima persona al cospetto di Alcinoo e dei Feaci (la sezione detta degli ἀπόλογοι laquoraccontiraquo) crea una struttura ad anello che parte dal presente e ad esso fa ritorno dopo aver ricostruito le premesse della condizione attuale del protagonista Col canto XIII Odisseo egrave riportato dai Feaci a Itaca e questo permette la saldatura fra le vicende sue e quelle di Telemaco sia pure col differimento dellrsquoincontro e del riconoscimento fra padre e figlio fino al canto XVI Far scorrere in parallelo sequenze distinte organizzare programmi narrativi a corta e a lunga gittata tendere o allentare ad arte il ritmo della narrazione non si tratta davvero di procedimenti che potessero configurarsi come tradizionali dellrsquoarte epica quanto piuttosto di un momento sperimentale di una ricerca di soluzioni nuove al termine di una lunga e ormai consolidata sedimentazione di percorsi compiuti allrsquointerno di un determinato repertorio tematico unrsquoaudacia inventiva una πολυτροπίη degne del protagonista del poema che inevitabilmente comportavano rischi molteplici di incoerenze dissonanze occasionali avarie della macchina epica e che tuttavia erano destinate a conseguire un risultato assolutamente convincente allrsquoorecchio di chi si abbandonasse al fascino del racconto senza lrsquourgenza propria di altre etagrave e di altre mentalitagrave di puntare il dito sui singoli dettagli o le singole sfasature
PER SAPERNE DI PIUrsquo Difficoltagrave e incongruenze della narrazione omerica Forti della possibilitagrave di un controllo su un testo scritto che possiamo percorrere in avanti e a ritroso secondo ritmi di nostra scelta a noi non riesce difficile cogliere alcune delle difficoltagrave organizzative incontrate nella composizione del poema In proposito per ricordare un caso che saragrave allrsquoorigine delle discussioni di orientamento ldquoanaliticordquo intorno allrsquoOdissea possiamo leggere il discorso che Atena prese le sembianze di Mente re dei Tafi rivolge a Telemaco nel I canto (vv 253-305) Ah infelice ti manca molto davvero lrsquoassente Odisseo che getti le mani addosso ai pretendenti sfrontati Percheacute se ora tornato stesse sulla soglia 255 con una scure lo scudo e due lance cosigrave come io per la prima volta lo vidi in casa nostra che beveva e godeva di ritorno da Efira da Ilo di Mermero (andograve anche ligrave Odisseo con la nave veloce 260 in cerca del veleno omicida per averne da ungere le frecce di bronzo ma quello non glielo diede percheacute temeva gli dei che vivono eterni
Letteratura greca [1]
27
glielo diede invece mio padre percheacute lrsquoamava moltissimo) se stesse Odisseo tra i pretendenti cosigrave 265 essi avrebbero tutti rapida morte e nozze amare Ma sulle ginocchia degli dei questo giace se una volta tornato faragrave o no vendetta nella sua casa te invece io esorto a riflettere come cacciare i pretendenti da casa 270 Ebbene ora ascolta e alle mie parole darsquo retta Domattina chiamati gli eroi Achei a consiglio rivolgi a tutti un discorso e siano testimoni gli dei Ai pretendenti comanda drsquoandarsene per i fatti loro e tua madre se lrsquoanimo la spinge alle nozze 275 ritorni a casa del padre molto potente Prepareranno essi le nozze e disporranno i doni nuziali moltissimi quanti gli pare che debbano andare alla figlia A te darograve un saggio consiglio se vuoi ascoltarlo armata una nave con venti remi la migliore che crsquoegrave 280 Varsquo a domandare del padre partito da tempo se mai te ne parli un mortale o sentissi da Zeus la voce che divulga la fama tra gli uomini Anzitutto varsquo a Pilo e interroga il chiaro Nestore di ligrave poi varsquo a Sparta dal biondo Menelao 285 degli Achei vestiti di bronzo egli egrave tornato per ultimo Se senti dire qualcosa sulla vita e il ritorno del padre per quanto stremato potresti sopportare un altro anno se invece senti dire che egrave morto e non vive allora tornato nella cara terra patria 290 ergigli un tumulo e offrigli funebri offerte moltissime quanto conviene e darsquo tua madre a un marito E poi dopo aver compiuto e fatto ogni cosa allora medita nella mente e nellrsquoanimo come tu possa uccidere nelle tue case 295 i pretendenti con lrsquoinganno affrontandoli non devi piugrave avere i modi di un bimbo percheacute ormai non sei tale Non senti lrsquoillustre Oreste quale gloria ha acquistato fra tutti gli uomini percheacute uccise lrsquoassassino del padre Egisto esperto di inganni che gli uccise il nobile padre 300 Anche tu caro infatti molto bello e grande ti vedo sii valoroso percheacute ti lodi anche qualcuno dei posteri Ma io tornerograve adesso alla nave veloce dai compagni che forse impazienti mi aspettano Tu devi pensarci da te dammi retta 305
[Tr di GA Privitera] Le stranezze non mancano davvero e cosigrave sono state messe a fuoco da Stephanie West nel suo commento23 1 Atena sa evidentemente molto piugrave di quanto uno come Mente avrebbe potuto sapere in particolare ella sa che i proci ignoreranno lrsquoinvito di Telemaco a lasciare la sua casa e fatto piugrave importante che gli degravei tra breve ricondurranno in patria Odisseo A queste osservazioni si puograve replicare con la stessa West che laquosi sono esagerate difficoltagrave e
23 Omero Odissea I cit 219 ss
Letteratura greca [1]
28
incongruenze alle quali un pubblico di ascoltatori (o anche un lettore moderatamente attento) probabilmente non farebbe casoraquo 2 Il progetto di una pubblica denuncia dei proci dinanzi agli degravei e agli uomini ai vv 273-274 egrave ciograve che Atena sembra prefiggersi nel promuovere lrsquoassemblea degli Itacesi (assemblea che effettivamente avragrave luogo a principio del canto II) drsquoaltra parte le successive istruzioni di AtenaMente ai vv 295 s (medita come uccidere i pretendenti) presuppongono che di quella richiesta da formulare nel corso dellrsquoassembla essi non terranno alcun conto Anche a questa osservazione si puograve rispondere che laquoegrave ragionevole attendersi che Telemaco condivida la previsione di un esito negativo della sua iniziativaraquo e si puograve aggiungere che pure in caso di insuccesso il ricorso allrsquoassemblea potrebbe ottenere almeno il risultato di screditare i pretendenti presso la comunitagrave itacese legittimando un successivo ricorso alla violenza (e si tratta di una legittimazione di cui anche lrsquoultimo canto mostreragrave lrsquoesigenza) 3 Dopo che Telemaco aveva detto che la madre non intendeva risposarsi (vv 249-250) AtenaMente si esprime ai vv 275-278 come se Penelope desiderasse proprio nuove nozze e inoltre sarebbe assurdo che il padre di Penelope cominciasse a contrattare un secondo matrimonio prima del ritorno di Telemaco dal suo viaggio e che mettesse mano a preparativi che rischierebbero di essere annullati qualche tempo dopo con inevitabile imbarazzo se Telemaco venisse a sapere che Odisseo egrave ancora vivo In piugrave lrsquoandamento sintattico di questi versi presenta un anacoluto durissimo per cui a principio del v 275 lrsquoaccusativo μητέρα egrave seguito da un ἂψ ἴτω (laquovada indietroraquo laquotorniraquo) che richiederebbe come soggetto un nominativo μήτηρ Come hanno reagito i lettori di Omero Nellrsquoantichitagrave un grammatico rimasto anonimo cambiava come attesta uno scolio μητέρ᾽ in μήτηρ nel secolo XVIII Richard Bentley modificava ἴτω in ἴμεν (infinito eolico di εἶμι laquovadoraquo) nel XIX un altro grande della filologia europea Gottfried Hermann risolveva piugrave drasticamente la questione eliminando il complesso dei vv 275-278 e la stessa West mostra simpatia per tale proposta supponendo laquounrsquoaggiunta posteriore modellata sul corrispondente passo del libro IIraquo (dove i vv 196 s sono identici ai vv 277 s e il v 195 copre lo stesso contenuto dei vv 275 s) Si tratta di procedimenti adeguati ai dati di fatto Migliorano davvero il testo che ci egrave stato tramandato In realtagrave ambedue le ldquocorrezionirdquo appena ricordate (di μήτερ᾽ e di ἴτω) ottengono un risultato tanto lineare che egrave davvero difficile pensare che lrsquoanacoluto avrebbe potuto invadere tutta la tradizione se non fosse stato originario e quanto allrsquoespunzione dei vv 275-278 essa indubbiamente peggiorerebbe il ritmo del discorso determinando lrsquoavvicinamento fra i due versi (v 271 e v 279) molto simili fra loro che aprono le due sequenze occupate dai consigli di Mente E allora La via piugrave saggia egrave senzrsquoaltro quella di tenerci qui come quasi sempre di fronte al testo omerico contraddizioni e anacoluti riconoscendo in essi lrsquoeffetto dellrsquoattivitagrave di un cantore che pur sulla base di una traccia largamente memorizzata restava pur sempre legato a quella prassi orale per cui composizione ed esecuzione tendevano a coincidere E lrsquoanacoluto si spiega bene se cerchiamo di immedesimarci nel procedimento seguito dal poeta Egli ha affidato ad Atena un certo flusso argomentativo per cui la dea deve dar consigli a Telemaco sui suoi rapporti coi proci e con la madre e cosigrave colloca in fine di v 274 un ἄνωχθι (laquoordinaraquo) destinato a reggere gli accusativi simmetricamente dislocati in principio di verso (vv 274 e 275) μνηστῆρας e μητέρα Senoncheacute giunto a questa seconda parte dellrsquoargomentazione egli si avvede quanto sarebbe illogico che Telemaco sollecitasse la madre a nuove nozze di qui lrsquoimprovviso cambio di costruzione che svincola al prezzo di una sensibile slogatura sintattica lrsquoipotesi delle nuove nozze dallrsquoordine impartito a Telemaco e la prospetta invece come un desiderio eventuale della stessa Penelope Il poeta ha un progetto ben meditato brani e sequenze piugrave volte sperimentati ed egrave col supporto di questi materiali giagrave elaborati che egli si fa strada attraverso le insidie della
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
27
glielo diede invece mio padre percheacute lrsquoamava moltissimo) se stesse Odisseo tra i pretendenti cosigrave 265 essi avrebbero tutti rapida morte e nozze amare Ma sulle ginocchia degli dei questo giace se una volta tornato faragrave o no vendetta nella sua casa te invece io esorto a riflettere come cacciare i pretendenti da casa 270 Ebbene ora ascolta e alle mie parole darsquo retta Domattina chiamati gli eroi Achei a consiglio rivolgi a tutti un discorso e siano testimoni gli dei Ai pretendenti comanda drsquoandarsene per i fatti loro e tua madre se lrsquoanimo la spinge alle nozze 275 ritorni a casa del padre molto potente Prepareranno essi le nozze e disporranno i doni nuziali moltissimi quanti gli pare che debbano andare alla figlia A te darograve un saggio consiglio se vuoi ascoltarlo armata una nave con venti remi la migliore che crsquoegrave 280 Varsquo a domandare del padre partito da tempo se mai te ne parli un mortale o sentissi da Zeus la voce che divulga la fama tra gli uomini Anzitutto varsquo a Pilo e interroga il chiaro Nestore di ligrave poi varsquo a Sparta dal biondo Menelao 285 degli Achei vestiti di bronzo egli egrave tornato per ultimo Se senti dire qualcosa sulla vita e il ritorno del padre per quanto stremato potresti sopportare un altro anno se invece senti dire che egrave morto e non vive allora tornato nella cara terra patria 290 ergigli un tumulo e offrigli funebri offerte moltissime quanto conviene e darsquo tua madre a un marito E poi dopo aver compiuto e fatto ogni cosa allora medita nella mente e nellrsquoanimo come tu possa uccidere nelle tue case 295 i pretendenti con lrsquoinganno affrontandoli non devi piugrave avere i modi di un bimbo percheacute ormai non sei tale Non senti lrsquoillustre Oreste quale gloria ha acquistato fra tutti gli uomini percheacute uccise lrsquoassassino del padre Egisto esperto di inganni che gli uccise il nobile padre 300 Anche tu caro infatti molto bello e grande ti vedo sii valoroso percheacute ti lodi anche qualcuno dei posteri Ma io tornerograve adesso alla nave veloce dai compagni che forse impazienti mi aspettano Tu devi pensarci da te dammi retta 305
[Tr di GA Privitera] Le stranezze non mancano davvero e cosigrave sono state messe a fuoco da Stephanie West nel suo commento23 1 Atena sa evidentemente molto piugrave di quanto uno come Mente avrebbe potuto sapere in particolare ella sa che i proci ignoreranno lrsquoinvito di Telemaco a lasciare la sua casa e fatto piugrave importante che gli degravei tra breve ricondurranno in patria Odisseo A queste osservazioni si puograve replicare con la stessa West che laquosi sono esagerate difficoltagrave e
23 Omero Odissea I cit 219 ss
Letteratura greca [1]
28
incongruenze alle quali un pubblico di ascoltatori (o anche un lettore moderatamente attento) probabilmente non farebbe casoraquo 2 Il progetto di una pubblica denuncia dei proci dinanzi agli degravei e agli uomini ai vv 273-274 egrave ciograve che Atena sembra prefiggersi nel promuovere lrsquoassemblea degli Itacesi (assemblea che effettivamente avragrave luogo a principio del canto II) drsquoaltra parte le successive istruzioni di AtenaMente ai vv 295 s (medita come uccidere i pretendenti) presuppongono che di quella richiesta da formulare nel corso dellrsquoassembla essi non terranno alcun conto Anche a questa osservazione si puograve rispondere che laquoegrave ragionevole attendersi che Telemaco condivida la previsione di un esito negativo della sua iniziativaraquo e si puograve aggiungere che pure in caso di insuccesso il ricorso allrsquoassemblea potrebbe ottenere almeno il risultato di screditare i pretendenti presso la comunitagrave itacese legittimando un successivo ricorso alla violenza (e si tratta di una legittimazione di cui anche lrsquoultimo canto mostreragrave lrsquoesigenza) 3 Dopo che Telemaco aveva detto che la madre non intendeva risposarsi (vv 249-250) AtenaMente si esprime ai vv 275-278 come se Penelope desiderasse proprio nuove nozze e inoltre sarebbe assurdo che il padre di Penelope cominciasse a contrattare un secondo matrimonio prima del ritorno di Telemaco dal suo viaggio e che mettesse mano a preparativi che rischierebbero di essere annullati qualche tempo dopo con inevitabile imbarazzo se Telemaco venisse a sapere che Odisseo egrave ancora vivo In piugrave lrsquoandamento sintattico di questi versi presenta un anacoluto durissimo per cui a principio del v 275 lrsquoaccusativo μητέρα egrave seguito da un ἂψ ἴτω (laquovada indietroraquo laquotorniraquo) che richiederebbe come soggetto un nominativo μήτηρ Come hanno reagito i lettori di Omero Nellrsquoantichitagrave un grammatico rimasto anonimo cambiava come attesta uno scolio μητέρ᾽ in μήτηρ nel secolo XVIII Richard Bentley modificava ἴτω in ἴμεν (infinito eolico di εἶμι laquovadoraquo) nel XIX un altro grande della filologia europea Gottfried Hermann risolveva piugrave drasticamente la questione eliminando il complesso dei vv 275-278 e la stessa West mostra simpatia per tale proposta supponendo laquounrsquoaggiunta posteriore modellata sul corrispondente passo del libro IIraquo (dove i vv 196 s sono identici ai vv 277 s e il v 195 copre lo stesso contenuto dei vv 275 s) Si tratta di procedimenti adeguati ai dati di fatto Migliorano davvero il testo che ci egrave stato tramandato In realtagrave ambedue le ldquocorrezionirdquo appena ricordate (di μήτερ᾽ e di ἴτω) ottengono un risultato tanto lineare che egrave davvero difficile pensare che lrsquoanacoluto avrebbe potuto invadere tutta la tradizione se non fosse stato originario e quanto allrsquoespunzione dei vv 275-278 essa indubbiamente peggiorerebbe il ritmo del discorso determinando lrsquoavvicinamento fra i due versi (v 271 e v 279) molto simili fra loro che aprono le due sequenze occupate dai consigli di Mente E allora La via piugrave saggia egrave senzrsquoaltro quella di tenerci qui come quasi sempre di fronte al testo omerico contraddizioni e anacoluti riconoscendo in essi lrsquoeffetto dellrsquoattivitagrave di un cantore che pur sulla base di una traccia largamente memorizzata restava pur sempre legato a quella prassi orale per cui composizione ed esecuzione tendevano a coincidere E lrsquoanacoluto si spiega bene se cerchiamo di immedesimarci nel procedimento seguito dal poeta Egli ha affidato ad Atena un certo flusso argomentativo per cui la dea deve dar consigli a Telemaco sui suoi rapporti coi proci e con la madre e cosigrave colloca in fine di v 274 un ἄνωχθι (laquoordinaraquo) destinato a reggere gli accusativi simmetricamente dislocati in principio di verso (vv 274 e 275) μνηστῆρας e μητέρα Senoncheacute giunto a questa seconda parte dellrsquoargomentazione egli si avvede quanto sarebbe illogico che Telemaco sollecitasse la madre a nuove nozze di qui lrsquoimprovviso cambio di costruzione che svincola al prezzo di una sensibile slogatura sintattica lrsquoipotesi delle nuove nozze dallrsquoordine impartito a Telemaco e la prospetta invece come un desiderio eventuale della stessa Penelope Il poeta ha un progetto ben meditato brani e sequenze piugrave volte sperimentati ed egrave col supporto di questi materiali giagrave elaborati che egli si fa strada attraverso le insidie della
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
28
incongruenze alle quali un pubblico di ascoltatori (o anche un lettore moderatamente attento) probabilmente non farebbe casoraquo 2 Il progetto di una pubblica denuncia dei proci dinanzi agli degravei e agli uomini ai vv 273-274 egrave ciograve che Atena sembra prefiggersi nel promuovere lrsquoassemblea degli Itacesi (assemblea che effettivamente avragrave luogo a principio del canto II) drsquoaltra parte le successive istruzioni di AtenaMente ai vv 295 s (medita come uccidere i pretendenti) presuppongono che di quella richiesta da formulare nel corso dellrsquoassembla essi non terranno alcun conto Anche a questa osservazione si puograve rispondere che laquoegrave ragionevole attendersi che Telemaco condivida la previsione di un esito negativo della sua iniziativaraquo e si puograve aggiungere che pure in caso di insuccesso il ricorso allrsquoassemblea potrebbe ottenere almeno il risultato di screditare i pretendenti presso la comunitagrave itacese legittimando un successivo ricorso alla violenza (e si tratta di una legittimazione di cui anche lrsquoultimo canto mostreragrave lrsquoesigenza) 3 Dopo che Telemaco aveva detto che la madre non intendeva risposarsi (vv 249-250) AtenaMente si esprime ai vv 275-278 come se Penelope desiderasse proprio nuove nozze e inoltre sarebbe assurdo che il padre di Penelope cominciasse a contrattare un secondo matrimonio prima del ritorno di Telemaco dal suo viaggio e che mettesse mano a preparativi che rischierebbero di essere annullati qualche tempo dopo con inevitabile imbarazzo se Telemaco venisse a sapere che Odisseo egrave ancora vivo In piugrave lrsquoandamento sintattico di questi versi presenta un anacoluto durissimo per cui a principio del v 275 lrsquoaccusativo μητέρα egrave seguito da un ἂψ ἴτω (laquovada indietroraquo laquotorniraquo) che richiederebbe come soggetto un nominativo μήτηρ Come hanno reagito i lettori di Omero Nellrsquoantichitagrave un grammatico rimasto anonimo cambiava come attesta uno scolio μητέρ᾽ in μήτηρ nel secolo XVIII Richard Bentley modificava ἴτω in ἴμεν (infinito eolico di εἶμι laquovadoraquo) nel XIX un altro grande della filologia europea Gottfried Hermann risolveva piugrave drasticamente la questione eliminando il complesso dei vv 275-278 e la stessa West mostra simpatia per tale proposta supponendo laquounrsquoaggiunta posteriore modellata sul corrispondente passo del libro IIraquo (dove i vv 196 s sono identici ai vv 277 s e il v 195 copre lo stesso contenuto dei vv 275 s) Si tratta di procedimenti adeguati ai dati di fatto Migliorano davvero il testo che ci egrave stato tramandato In realtagrave ambedue le ldquocorrezionirdquo appena ricordate (di μήτερ᾽ e di ἴτω) ottengono un risultato tanto lineare che egrave davvero difficile pensare che lrsquoanacoluto avrebbe potuto invadere tutta la tradizione se non fosse stato originario e quanto allrsquoespunzione dei vv 275-278 essa indubbiamente peggiorerebbe il ritmo del discorso determinando lrsquoavvicinamento fra i due versi (v 271 e v 279) molto simili fra loro che aprono le due sequenze occupate dai consigli di Mente E allora La via piugrave saggia egrave senzrsquoaltro quella di tenerci qui come quasi sempre di fronte al testo omerico contraddizioni e anacoluti riconoscendo in essi lrsquoeffetto dellrsquoattivitagrave di un cantore che pur sulla base di una traccia largamente memorizzata restava pur sempre legato a quella prassi orale per cui composizione ed esecuzione tendevano a coincidere E lrsquoanacoluto si spiega bene se cerchiamo di immedesimarci nel procedimento seguito dal poeta Egli ha affidato ad Atena un certo flusso argomentativo per cui la dea deve dar consigli a Telemaco sui suoi rapporti coi proci e con la madre e cosigrave colloca in fine di v 274 un ἄνωχθι (laquoordinaraquo) destinato a reggere gli accusativi simmetricamente dislocati in principio di verso (vv 274 e 275) μνηστῆρας e μητέρα Senoncheacute giunto a questa seconda parte dellrsquoargomentazione egli si avvede quanto sarebbe illogico che Telemaco sollecitasse la madre a nuove nozze di qui lrsquoimprovviso cambio di costruzione che svincola al prezzo di una sensibile slogatura sintattica lrsquoipotesi delle nuove nozze dallrsquoordine impartito a Telemaco e la prospetta invece come un desiderio eventuale della stessa Penelope Il poeta ha un progetto ben meditato brani e sequenze piugrave volte sperimentati ed egrave col supporto di questi materiali giagrave elaborati che egli si fa strada attraverso le insidie della
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
29
singola espressione o del singolo modulo argomentativo e non egrave che un esempio reso celebre dalle dispute analitiche di una situazione che pervade la totalitagrave di entrambi i poemi
Il fatto che lrsquoOdissea partecipi della dimensione orale dellrsquoIliade e che i problemi affrontati dai cantori che nel corso del tempo elaborarono la traccia narrativa del poema e la dizione dei singoli episodi appartengano alla medesima cultura dei cantori a cui dobbiamo la formazione e la sedimentazione della materia iliadica (tanto che alcune sezioni dellrsquoIliade sono state non impropriamente definite per stile e tematica laquoodissiacheraquo) non toglie che siano individuabili fra i due poemi divergenze significative Alcune di queste possono dipendere dalla diversitagrave del tema volta a volta toccato come nel caso del lessico e delle formule relativi alla navigazione o alla vita di palazzo ma questo sicuramente non vale per alcune formule esclusivamente odissiache come κακὰ βυσσοδομεύων (laquocovando malvagitagraveraquo) τετληότι θυμῷ (laquocon animo pazienteraquo) μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι (laquochiedere e domandareraquo) κατεκλάσθη φίλον ἦτορ (laquosi spezzograve il suo cuoreraquo) δύσετό τ᾽ ἠέλιος σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί (laquotramontograve il sole e si oscuravano tutte le vieraquo) E lrsquoaraldo divino nellrsquoIliade egrave Ermes nellrsquoOdissea (ma anche nel canto XXIV dellrsquoIliade appunto uno dei brani definibili anche per altri aspetti come laquoodissiaciraquo) Iride e piugrave in generale nellrsquoOdissea le divinitagrave mostrano di preoccuparsi in modo nuovo del problema della giustizia allrsquointerno del mondo degli uomini non a caso proprio al principio del poema troviamo una serie di considerazioni di Zeus (I 28-47) sulla cattiva abitudine dei mortali di attribuire agli degravei la radice di quei mali che gli uomini in realtagrave subiscono percheacute agiscono ὑπὲρ μόρον al di lagrave della misura e del lecito Soprattutto nellrsquoOdissea non egrave piugrave in primo piano la ricerca della τιμή e del κλέος laquoora la basilare questione egrave la sopravvivenza politica ed economica dellrsquouomo singolo piuttosto che lrsquourto armato fra le masse coi suoi corollari di eroismo sotto gli occhi della comunitagrave conquiste di prede sbandierata fedeltagrave ai soci drsquoarme e al gruppo tribale E nellrsquoOdissea emergono altri temi che si differenziano dallrsquoIliade e che egrave difficile considerare come del tutto appartenenti a una visione nostalgicamente eroica della vita i temi dellrsquoamore e del rispetto fra uomo e donna di devozione da parte di un figlio di una moglie di un gruppo di servi drsquoospitalitagrave nelle sue forme meno viziate drsquoostentazione di equo compenso per la colpa infine drsquouna ripartizione fra responsabilitagrave divina e umana nel caso di avversitagrave e malasorte Nessuno di questi temi passa nellrsquoIliade sotto totale silenzio ma nessuno vi assurge a motivo dominante [] NellrsquoOdissea lrsquoeroe vede ampliarsi la sua gamma di valori da onore coraggio amore di primato e di vistosi possessi fino a comprendere sopportazione capacitagrave di chinare il capo intrigante astuzia disposizione al travestimento umile i comprimari da guerrieri di seconda fila diventano esseri stregoneschi mostri dallrsquounico occhio mandriani ancelle i luoghi drsquoazione svariano dal campo navale dai terreni di scontri e dalla cittagrave assediata alle roccaforti del Peloponneso alle campagne di Itaca alle terre del prodigio percorse da Odisseo e questrsquoampliarsi dei motivi egrave un grande scrigno per azioni e sentimenti sempre nuovi e variraquo24 Antropologia e teologia Le relazioni umane
24 GS Kirk Omero in AAVV La letteratura greca della Cambridge University (1985) I Mondadori Milano 1989 135-144 Dedurre da queste e consimili considerazioni se i due poemi siano da attribuire allo stesso o a diversi cantori egrave come vedremo questione antica che sfugge a qualsiasi verifica stringente si tratta in altri termini di decidere se dare maggior peso alle convergenze o alle divergenze allʼinterno della poesia ldquoomericardquo o in altri termini ancora di una scommessa che puograve essere giocata solo in termini di intuizione o tuttʼal piugrave di ldquosenso dello stilerdquo Un argomento non privo di suggestione avanzato da NJ Richardson nel suo commentario (1993) ai canti XXI-XXIV dellʼIliade egrave il carattere marcatamente ldquoodissiacordquo proprio dellʼultimo canto dellʼIliade quasi che esso fosse composto al tempo in cui ldquoOmerordquo (o davvero Omero) giagrave si cimentava in prove dellʼOdissea
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
30
Uno dei tratti piugrave specifici individuato da Bruno Snell25 della rappresentazione omerica dellrsquouomo egrave dato dal fatto che nellrsquoambito di questo linguaggio le nozioni astratte non appaiono ancora sviluppate mentre esiste una variegata abbondanza di definizioni relative ad atti connessi alle nostre percezioni Ad es non esiste un verbo che indichi in astratto la nozione generale del laquovedereraquo bensigrave una serie di verbi ndash ὁρᾶν ἰδεῖν λεύσσειν ἀθρεῖν θεᾶσθαι σκέπτεσθαι ὄσσεσθαι δενδίλλειν δέρκεσθαι παπταίνειν ndash che denotano ognuno modi particolari di vedere (ad es δέρκεσθαι egrave il lampeggiare dello sguardo παπταίνειν il guardarsi intorno con sguardo circospetto o con apprensione cercando qualcosa) Analogamente non crsquoegrave un vocabolo generale per laquocorporaquo (σῶμα significa solo il corpo del defunto il laquocadavereraquo) ma compaiono sostantivi che indicano la laquofiguraraquo o laquocorporaturaraquo (δέμας) i muscoli in movimento (μέλεα) le articolazioni (γυῖα) la superficie o lrsquoinvolucro del corpo (χρώς) neacute vi egrave un sostantivo corrispondente ad laquoanimaraquo ψυχή egrave lrsquoanima solo come qualcosa che dagrave laquoanimazioneraquo allrsquouomo tenendolo in vita (infatti lo abbandona al momento della morte) θυμός egrave lrsquoorgano che suscita le emozioni νόος la funzione che genera le immagini Quanto alle motivazioni che determinano lrsquoagire dei personaggi omerici ER Dodds 26riprendendo la distinzione di matrice antropologica fra shame culture (laquociviltagrave di vergognaraquo) e guilt culture (laquociviltagrave di colparaquo) mise in luce come i personaggi omerici si sentano condizionati non tanto da sentimenti introiettati nella sfera dellrsquoio individuale (colpa rimorso coscienza) quanto dai risvolti pubblici sociali delle loro azioni in primo luogo dal senso dellrsquoonore (τιμή) e dallo scrupolo verso gli altri (αἰδώς) Perciograve essi tendono ad attribuire la responsabilitagrave delle proprie azioni a un agente esterno che puograve essere un dio o un demone o la Moira (la laquoparteraquo di destino assegnata a ciascun uomo) o ἄτη lrsquoaccecamento che travia la mente Esemplari in questo senso le considerazioni di Agamennone in Iliade XIX 83-94
Io dunque al Pelide mi rivolgerograve ma voi altri comprendetemi o Argivi capite bene la parola ciascuno Spesso questo discorso mi facevan gli Argivi 85 e mi biasimavano pure non io son colpevole ma Zeus e la Moira e lrsquoErinni che nella nebbia cammina essi nellrsquoassemblea gettarono contro di me stolto errore quel giorno che tolsi il suo dono ad Achille Ma che potevo fare I numi tutto compiscono 90 Ate egrave la figlia maggiore di Zeus che tutti fa errare funesta essa ha piedi molli perciograve non sul suolo si muove ma tra le teste degli uomini avanza danneggiando gli umani un dopo lrsquoaltro li impania
[Tr di R Calzecchi Onesti] Lo scontro intorno alla rocca di Ilio non egrave presentato nei poemi come contrasto fra etnie o culture In effetti i Troiani nellrsquoIliade non si connotano come ldquostranierirdquo bensigrave mostrano strutture politiche e sociali non distinguibili da quelle degli Achei e lo stesso vale quasi sempre per edifici vesti agricoltura cibo suppellettili armi (e anche la poligamia di Priamo non differisce nella sostanza dalla procreazione di figli illegittimi in ambito greco) Inoltre Achei e Troiani condividono gli stessi degravei e le stesse pratiche cultuali Atena favorisce gli Achei ma ha il suo tempio a Troia Apollo favorisce i Troiani ma egrave altresigrave il patrono dellrsquoindovino greco Calcante Quanto al linguaggio proprio la definizione dei Cari nel laquoCatalogoraquo (Iliade II 867) come βαρβαρώφονοι implica che un tale epiteto non sarebbe stato riferibile ai Troiani o alla maggior parte degli altri alleati Fra i popoli stranieri sono invece ricordati nellrsquoIliade Fenici Egizi Traci Misi e altri gruppi piugrave periferici evocati come esseri meravigliosi Posidone guardando dallrsquoIda verso il nord scorge (XIII 5 s) gli Ἱππημολγοί (laquoMungitori di cavalliraquo) e gli Abicirc (Ἄβιοι laquoPrivi di violenzaraquo) e in entrambi i poemi udiamo degli Etiopi che abitano nel piugrave lontano Oriente e nel piugrave lontano
25 La cultura greca e le origini del pensiero europeo (19482) Torino Einaudi 19632 19-47 26 I Greci e lʼirrazionale (1951) Firenze La Nuova Italia 19732 1-31
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
31
Occidente e hanno il volto bruno per la prossimitagrave del sole godendo del privilegio di visite divine (invece i Pigmei abitano nellrsquoestremo sud e combattono con le gru) Sia Achei che Troiani agiscono secondo comportamenti la cui descrizione assolve anche a una funzione prescrittiva Lrsquoesecuzione di un sacrificio o di un rito funebre la vestizione di un guerriero le fasi di un duello un atto di supplica lo svolgimento di unrsquoambasceria la costruzione di un naviglio rappresentano altrettanti esempi di quelle che W Arend ha denominato laquoscene tipicheraquo situazioni competenze atti che vengono enunciati secondo moduli tendenzialmente standardizzati la cui riproposizione trasmette e sanziona le consuetudini sociali comportamentali tecnologiche del gruppo umano che le condivide e che nella loro attualizzazione ritrova la propria specifica identitagrave
PER SAPERNE DI PIUrsquo Esempi di laquoscene tipicheraquo Nel saggio tuttora fondamentale dal titolo Die typischen Scenen bei Homer Walter Arend ha offerto un esteso campionario di quelle che lrsquoautore definisce appunto laquoscene tipicheraquo momenti comunitari ldquofortirdquo e ritualizzati che scandiscono in maniera significativa la vita della comunitagrave e costituiscono un patrimonio comportamentale condiviso dal poeta e dal suo pubblico La battaglia la vestizione del guerriero lo svolgimento dellrsquoassemblea il banchetto lrsquoambasceria la supplica il sacrificio ecc vengono descritti con pressocheacute assoluta fedeltagrave di particolari in sequenze narrative che si ripetono in modo costante in una fissitagrave descrittiva nella quale si puograve riconoscere la stilizzazione di un vero e proprio codice di comportamento
Probante esempio sono le scene di sacrificio scandite secondo una sequela di momenti e di gesti che ritornano piugrave volte nel corso dei poemi riportiamo il passo di Iliade II 402-33
1 Verso introduttivo presentazione della vittima offerta in sacrificio e invito della comunitagrave
Agamennone capo drsquoeserciti immolograve un bue grasso di cinque anni al potentissimo figlio di Crono e invitograve i capi i principi di tutti i Greci
2 Tutti si dispongono attorno alla vittima e prendono i chicchi drsquoorzo per primi Nestore e il re Idomeneo poi i due Aiaci e il figlio di Tideo per sesto Odisseo pari a Zeus per saggezza Venne da seacute Menelao possente nel grido di guerra giaccheacute capiva in cuore le pene di suo fratello Si misero attorno al bue e presero i chicchi drsquoorzo
3 Preghiera di Agamennone a nome dei presenti e tra di loro pregograve il potente Agamennone
4 Formula di preghiera codificata secondo la tradizione
laquoZeus gloriosissimo abitatore del cielo signore delle nuvole nere Farsquo che il sole non scenda e cali la tenebra prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e lrsquoabbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi dentiraquo
5 La divinitagrave esaudisce o non esaudisce la preghiera
Cosiacute disse ma non lo esaudigrave ancora il figlio di Crono accettograve i sacrifici ma gli inflisse fatiche terribili
6 Conclusa la preghiera vengono gettati i chicchi drsquoorzo
Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
32
7 Uccisione delle vittime e preparazione delle carni che vengono arrostite sugli spiedi
tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo
8 Preparazione delle viscere
Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiate le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco
9 Tutti mangiano a sazietagrave
Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito
Questo schema rituale tipico egrave passibile di lievi variazioni con lrsquoinserzione di elementi secondari che arricchiscono di volta in volta il quadro della rappresentazione Si confronti ad esempio il passo seguente (Iliade 1 447-475) che descrive il sacrificio di ringraziamento di Crise nel momento in cui gli viene restituita la figlia Si individuino gli elementi comuni ai due passi e si individuino le differenze
Cosigrave dicendo la mise nelle sue mani e Crise accolse la figlia con gioia poi subito collocarono attorno Allrsquoaltare la sacra ecatombe in onore del dio si lavarono le mani e presero i chicchi drsquoorzo Tra loro Crise pregograve levando alte la mani laquoAscoltami dio dallrsquoarco drsquoargento tu che proteggi Crisa e la sacra Cilla e sei il signore di Tenedo giagrave prima hai esaudito la mia preghiera e mi hai onorato colpendo lrsquoesercito greco Ora di nuovo adempi il mio desiderio allontana dai Greci la terribile pesteraquo Cosiacute disse pregando e Febo Apollo lrsquoudiva Dopo avere pregato e gettato i chicchi drsquoorzo tirarono indietro le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono estrassero le cosce le ricoprirono drsquoadipe ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne il vecchio le bruciava sulle cataste e versava vino lucente i giovani accanto tenevano in mano gli spiedi Quandrsquoebbero arso le cosce e mangiato le viscere fecero a pezzi le parti restanti le infilarono sugli spiedi e con ogni cura le arrostirono poi tolsero il tutto dal fuoco Cosiacute compiuto il lavoro e preparato il banchetto mangiarono e non mancograve ad alcuno il cibo imbandito Quandrsquoebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere i giovani colmarono fino allrsquoorlo i crateri di vino lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti per libare Tutto il giorno i Greci placarono il dio con il canto intonando un peana bellissimo in onore del dio arciere che si rallegrava ad udirli
[Tr di G Paduano] Per avere un quadro piugrave completo si possono confrontare ancora i seguenti passi Iliade VII 312-324 XXIV 621-634 Odissea III 421-474 XII 353-365 XIV 415-431
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
33
Uomini e dei Il pantheon omerico (con Zeus in posizione di dio supremo spesso affannato a ridurre allrsquoordine gli inquieti coabitatori dellrsquoOlimpo) sembra riflettere piugrave che la realtagrave sociologica rappresentata nei poemi lrsquoassetto degli strati superiori della societagrave micenea retta da un ἄναξ attorniato da funzionari che detenevano il potere in singoli distretti Drsquoaltra parte questo pantheon mostra al proprio interno un coacervo di tendenze mal riconducibili a un insieme unitario vi convivono tratti di estremo arcaismo (ad es la raffigurazione teriomorfica della divinitagrave) e di accentuata ldquomodernitagraverdquo come una spiccata tendenza antropomorfica che puograve contemplare accenti di sottile ironia (come nel ferimento di Afrodite al polso da parte di Diomede nel V canto dellrsquoIliade) o addirittura (come nella cosiddetta laquoBattaglia degli degraveiraquo) di irridente comicitagrave in un ldquocontrocantordquo leggero o pungente alle tragiche necessitagrave della condizione mortale E queste divinitagrave talora si avvicinano a un livello di onnipotenza e di preveggenza quasi assolute che le rende capaci di determinare il corso degli eventi talora appaiono condizionate e limitate da un potere piugrave vago e piugrave astratto da qualcosa che assomiglia a un fato superiore senza ridursi del tutto ad esso un equilibrio instabile una fluttuazione di punti di vista che ben si evince ad esempio nellrsquoepisodio che vede il padre degli uomini e degli degravei assistere allo scontro tra suo figlio Sarpedone (avuto da Laodamia) e Patroclo (Iliade XVI 431-461)
Gemette vedendoli il figlio di Crono pensiero complesso e parlograve ad Era la sua sposa e sorella laquoOhimegrave che il mio Sarpedone il piugrave caro fra gli uomini egrave fato che muoia per mano di Patroclo Meneziade E il cuore nel petto sconvolto medita due pensieri 435 o vivo lontano dalla triste battaglia lo rapisco e lo porto nel grasso paese di Licia o subito sotto il braccio del Meneziade lo atterroraquo E gli rispose Era augusta grandi occhi laquoTerribile Cronide che parola hai detto 440 Uomo mortale da tempo dovuto al destino vorresti strappare alla morte lugubre gemito Farsquo ma non tutti ti loderemo noi degravei E ti dirograve unrsquoaltra cosa tu mettila nella tua mente se alla sua casa vivo Sarpedone rimandi 445 bada che qualcun altro dei numi beati non voglia salvare il figlio dalla mischia brutale cheacute molti lottano intorno alla gran rocca di Priamo figli di numi immortali cui ispirerai sdegno tremendo Ma se ti egrave caro se il tuo cuore lo piange 450 lascialo dunque nella mischia violenta sotto le mani di Patroclo Meneziade perire e appena il respiro lrsquoabbia lasciato e la vita manda la Morte a prenderlo e il Sonno soave che la contrada dellrsquoampia Licia raggiungano 455 e lagrave lrsquoonoreranno i fratelli e i compagni di tomba e stele questo egrave lrsquoonore dei mortiraquo Disse cosigrave fu persuaso il padre dei numi e degli uomini e gocce sanguigne sopra la terra versograve onorando il suo figlio che Patroclo gli doveva 460 uccidere in Troia fertile zolla lontano dalla patria
[Tr di R Calzecchi Onesti] Sia Zeus che Era discutono muovendo dal preliminare riconoscimento di una μοῖρα (v 434) o di unrsquoαἶσα (v 441) che si pongono entrambe come laquoparteraquo della vita che egrave stata assegnata ab antiquo (πάλαι 441) al singolo uomo da un potere oscuro e indefinito Ma la tensione scatta precisamente percheacute lrsquoattuazione di questa laquoparteraquo secondo il disegno previsto puograve essere messa in dubbio da Zeus e considerata come il polo di un dilemma che contempla al polo
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
34
opposto la sottrazione di Sarpedone alla morte Neacute Era contesta questa impostazione del caso che investe il grande guerriero licio ciograve che ella sottolinea egrave che lrsquointerferenza divina nel ldquodestinordquo di un uomo provocherebbe uno squilibrio nellrsquoassetto dellrsquouniverso divino incitando altri numi a salvare dalla battaglia i propri figli Cosigrave il ldquodestinordquo tende a configurarsi come il corso ldquonaturalerdquo o ldquonormalerdquo delle cose il cui turbamento egrave pur sempre possibile ma si prospetta come disdicevole e soprattutto pericoloso per le buone relazioni allrsquointerno di una societagrave che al pari di quella umana fa della tutela e del rispetto delle prerogative individuali la condizione della sua fragile concordia Piugrave in generale la relazione fra uomini e degravei non appare riducibile a un quadro unitario ma coinvolge una serie di antinomie fra le quali spiccano secondo la diagnosi di Albin Lesky27 le seguenti 1 prossimitagravedistanza gli uomini possono riconoscere gli degravei grazie a una diretta epifania del nume (Achille riconosce Atena nel I canto dellrsquoIliade e lo stesso fa Diomede nel V) o piugrave spesso attraverso segni o messaggi e gli degravei conversano coi mortali li proteggono li assistono in battaglia e possono addirittura esser feriti da questi Ma la barriera che separa i due mondi puograve essere drsquoimprovviso ribadita come impenetrabile laquoRifletti e torna indietro La stirpe degli uomini non egrave mai uguale a quella degli degraveiraquo grida Apollo a Diomede (Iliade V 440 s) ed laquoegrave insensato per gli degravei ndash osserva Efesto (Iliade I 573) ndash litigare a causa dei mortaliraquo 2 favorecrudeltagrave un atteggiamento di favore come quello di Afrodite nei confronti di Elena puograve ad un tratto tramutarsi in imperiosa crudeltagrave cosigrave nel III canto dellrsquoIliade la dea in sembianza di vecchia filatrice impone con parole sferzanti alla sua riluttante protetta di rientrare nel talamo di Paride (vv 389-420) 3 arbitriodiritto generalmente gli degravei omerici dimostrano soprattutto nellrsquoIliade un atteggiamento amorale neacute talora rifuggono da atti di astuzia o di violenza ma in Iliade XVI 384 ss si parla della tempesta suscitata da Zeus contro gli uomini che pronunciano sentenze ingiuste in Odissea I 32-43 Zeus lamenta che gli uomini attribuiscano agli degravei il male di cui essi stessi sono responsabili e nello stesso poema stranieri e mendicanti appaiono collocati sotto la protezione di Zeus La peculiaritagrave dellʼeroe Gli eroi omerici si distinguono per la loro prossimitagrave agli degravei e per la loro grande forza fisica dai comuni mortali che vivono nel presente in cui si colloca il narratore Molti eroi hanno genitori o avi divini e ricevono visite dagli degravei La loro forza egrave tale che possono sollevare massi che nemmeno due uomini del presente potrebbero alzare (Iliade ΧΙΙ 445-449)
Ed Ettore prese e portograve via un pietrone che stava 445 davanti alla porta largo di sotto ma sopra acuminato nemmeno due uomini i piugrave robusti del popolo facilmente lrsquoavrebbero alzato sul carro da terra per quello che sono gli uomini oggi lui lo palleggiava senza fatica anche da solo
[Tr di G Cerri] Piugrave volte viene enfatizzata la loro forza sovrumana (Iliade V 302-4 per Diomede XII 378-86 per Aiace XX 287 per Achille) ma non senza cospicue differenze interne visto che di Achille si sottolinea in relazione al problema di sollevare la spranga che chiude la sua tenda che era tre volte piugrave forte degli altri Achei (Iliade ΧΧΙV 453-456)
la porta era chiusa da una sola spranga di abete per metterla su occorrevano tre Achei e tre per sollevarla la sbarra pesante 455 ma Achille poteva maneggiarla anche da solo
27 Storia della letteratura greca (1957) I Il Saggiatore Milano 1962 92-100
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
35
Questi eroi ambiscono allrsquoonore e alla gloria e per raggiungere lrsquoobiettivo sono pronti a ricorrere alla rissa e alla violenza La τιμή ha il suo correlativo tangibile nel possesso di beni (case terre greggi metalli preziosi servi etc) ma denota nel contempo uno status sociale Il κλέος egrave la fama acquisita di cui il guerriero va fiero e che sancisce il suo ruolo di spicco allrsquointerno del gruppo I valori e le prospettive che formano lrsquoimmagine che il guerriero ha di seacute e ispirano la sua linea drsquoazione derivano in primo luogo dal giudizio della comunitagrave dal senso di vergogna che egli proverebbe se non si dimostrasse allrsquoaltezza del proprio ruolo perdere la faccia egrave insopportabile lrsquoidentitagrave individuale tende a ridursi a identitagrave sociale Il senso di colpa (guilt) che lievita in societagrave piugrave complesse non si egrave ancora sviluppato come autonoma categoria interiore Ecco allora che Ettore nel famoso incontro con Andromaca prima di tornare sul campo di battaglia pur dichiarandosi sensibile allrsquoappello della moglie a non scendere in campo aperto dichiara che ciograve che lo spinge alla lotta egrave in prima istanza la αἰδώς il senso di vergogna che proverebbe di fronte ai concittadini se si comportasse da vile (Iliade VI 441-446)
Donna anche a me sta a cuore ciograve che dici ma terribilmente ho vergogna dei Troiani e delle Troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla guerra neacute me lo permette il mio animo poicheacute ho imparato a essere forte sempre e a combattere in prima fila fra i Troiani 445 per conquistare grande gloria a mio padre e a me stesso
Pertanto la laquovirtugraveraquo (ἀρετή) dei guerrieri omerici ha una dimensione eminentemente pubblica e si misura dallrsquoammontare di onore (τιμή) che il gruppo conferisce al singolo e che trova tangibile espressione nel γέρας (laquoprivilegioraquo) la parte di bottino assegnata a un guerriero al momento della spartizione (cfr I 127 e 162 XI 703-705) Le qualitagrave che possono conferire onore sono varie aspetto fisico forza coraggio ricchezza potere senno E cosigrave anche se tutti i principi achei hanno il rango di ἀριστῆες laquoi miglioriraquo e di βασιλῆες (il vocabolo βασιλεύς giagrave attestato in miceneo nella forma qa-si-re-u in relazione a funzionari locali viene reso convenzionalmente con laquoreraquo meglio laquoprinciperaquo o laquocaporaquo) e pertanto portano lo lsquoscettrorsquo - il bastone che simboleggia lrsquoesercizio del potere - Achille si distingue per forza e per nascita Agamennone eccelle percheacute domina su molti Nestore e Odisseo spiccano per accortezza Come dice Nestore ad Achille (Iliade I 278-281) laquose tu sei forte ed egrave una dea la madre che ti ha generato Agamennone egrave piugrave potente percheacute domina su gente piugrave numerosaraquo Belli forti valorosi i guerrieri omerici non sono tuttavia immuni dalla paura Questa puograve essere superata grazie alla forza interiore o a un sovrappiugrave di energia infusa dalla divinitagrave ma senza il rischio del terrore e della fuga non ci sarebbe azione eroica (lsquoaristiarsquo o lsquoandroctasiarsquo) La paura puograve essere individuale o collettiva (panico generalizzato) per la prima si pensi ad esempio in relazione a Paride a Iliade III 33-37
Come uno che ha visto un serpente fa un balzo allrsquoindietro nella gola drsquoun monte e il tremore gli prende le membra sui suoi passi ritorna il pallore gli invade le guance 35 cosigrave di nuovo nel gruppo dei Troiani animosi Srsquoinfilograve Alessandro simile a un dio temendo il figlio di Atreo
[Tr di G Cerri] Per la seconda si veda Iliade V 862-863
Tremore afferrograve le Troiani e Achei per la paura tanto potente fu lrsquourlo di Ares mai sazio di guerra
o XXII 1-3
Cosigrave i Troiani in cittagrave terrorizzati come cerbiatti asciugavano il sudore e bevevano placando la sete
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
36
appoggiati ai bastioni Il codice eroico Ersquo Sarpedone a formulare nel modo piugrave articolato il principio secondo cui la gloria conquistata in battaglia egrave un dovere del principe nei confronti della sua gente e nel contempo la sola forma di immortalitagrave a cui un uomo possa aspirare (Iliade XII 320-328)
laquoGlauco percheacute in Licia ci riveriscono 310 dandoci il posto drsquoonore carne e coppe ripiene e tutti ci considerano come degravei e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto ricco di piantagioni drsquoalberi e di terreni coltivi Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila 315 e affrontare la battaglia bruciante percheacute i Lici dalle forti corazze possano dire ldquoNon erano privi di gloria i nostri re che governano la Licia e mangiano grasse pecore e bevono vino scelto soave ma hanno grande vigore 320 percheacute combattono in prima fila tra i Licirdquo Mio caro se noi fuggendo da questa battaglia dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia io non vorrei combattere in prima fila e non ti spingerei alla guerra gloriosa 315 ma attorno a noi stanno sempre in gran numero le dee della morte che noi mortali non possiamo evitare Andiamo o noi daremo gloria al nemico o lui a noiraquo
[Tr di G Paduano] Sarpedone e Glauco sono a capo dei contingenti dei Lici alleati dei Troiani e nel loro paese godono di manifestazioni di onore nei conviti e nella concessione di terre pregiate primato sociale che rappresenta il corrispettivo del comportamento eroico in guerra quello sintetizzato nella formula piugrave efficace da Nestore in XI 784 e proprio da Glauco in VI 208
αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων essere sempre il migliore e mostrarsi superiore agli altri
La questione omerica Giagrave i grammatici alessandrini coglievano contraddizioni interne nei poemi e le loro osservazioni si possono considerare le premesse da cui in etagrave moderna si egrave sviluppata la cosiddetta laquoquestione omericaraquo Fra tali contraddizioni lrsquoesempio forse piugrave strabiliante egrave quello di un guerriero che muore e risuscita (Pilemene cfr Iliade V 576 con XIII 658) Analogo egrave un problema numerico che si pone alla lettura del IX canto dellrsquoIliade sono inviati tre eroi (Fenice Odisseo Aiace) ma da un certo momento in poi le forme verbali che designano lrsquoambasceria sono in duale (Fenice sembra scomparso salvo ricomparire piugrave tardi e pronunciare un importante discorso) E difficoltagrave irrisolvibili pone la prospettazione del muro degli Achei in Iliade XII un muro la cui esistenza sembra a tratti presupposta a tratti ignorata cosigrave come ci resta incomprensibile in termini logici o strategici percheacute mai Ettore in Iliade VI 72 ss proprio in un frangente di grave difficoltagrave per i suoi senta il bisogno di lasciare allrsquoimprovviso il campo di battaglia per recarsi dalla madre Ecuba e raccomandarle un sacrificio in onore di Atena O ancora un caso meno frequentemente citato ma significativo al v 30 del canto XVII dellrsquoOdissea si dice che quando Telemaco giunse dalla stalla di Eumeo al proprio palazzo varcograve una soglia di pietra (ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν) ma quando poco dopo vi arriva Odisseo
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
37
si afferma invece che egli si sedette su una soglia di frassino (v 339 ἷζε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ)28 Fra III e II secolo aC due grammatici Xenone ed Ellanico basandosi sulle discrepanze fra i due poemi negarono a Omero la paternitagrave dellrsquoOdissea e furono perciograve definiti χωρίζοντες (laquoseparatoriraquo o laquoseparatistiraquo) Contro di essi Aristarco di Samotracia scrisse il trattato Contro il paradosso di Xenone Nel I secolo dC Lrsquoautore del trattato Sul Sublime ricorreragrave invece alla soluzione di assegnare lrsquoIliade alla giovinezza e lrsquoOdissea alla senilitagrave di Omero (9 12-14)
[12] Egrave infatti chiaro per vari motivi che egli compose questrsquoopera per seconda ma in particolare percheacute egli introduce in aggiunta nellrsquoOdissea come episodi resti delle sciagure dellrsquoIliade e percheacute ndash per Zeus ndash rende qui agli eroi i lamenti e i compianti funebri come noti da gran tempo LrsquoOdissea infatti non egrave altro che un epilogo dellrsquoIliade [Odissea III 109-111] Ligrave giace il bellicoso Aiace ligrave Achille ligrave Patroclo consigliere pari agli dei e ligrave il mio caro figlio [13] Per lo stesso motivo penso egli concepigrave il complesso dellrsquoIliade scritta quando il suo spirito era allrsquoacme drammatico e veemente e quello dellrsquoOdissea per lo piugrave narrativo cosa tipica della vecchiaia Perciograve nellrsquoOdissea si potrebbe paragonare Omero al sole che tramonta del quale anche senza lrsquointensitagrave permane la grandezza Qui infatti egli non mantiene piugrave una tensione pari a quella degli eccezionali canti dellrsquoIliade e neppure quei vertici sublimi tutti alla stessa altezza che non hanno mai un cedimento neacute un simile prorompere di passioni una sullrsquoaltra neacute la rapiditagrave di trapassi e la naturalezza e lrsquoaddensamento di immagini prese dal vero ma come lrsquooceano si ritira in se stesso e si fa terra intorno ai suoi confini appaiono ormai riflussi di grandezza e uno smarrirsi in vicende favolose e incredibili 14 Dicendo questo ho ben presenti le tempeste dellrsquoOdissea lrsquoepisodio del Ciclope e alcuni altri (ma sigrave egrave una vecchiaia quella che descrivo ma la vecchiaia drsquoOmero) senoncheacute in tutti quanti nessuno eccettuato il tono favolistico domina lrsquoazione
[Tr di CM Mazzucchi]44 Per secoli non si tornograve sullrsquoargomento salvo per istituire in etagrave imperiale una sorta di gara fra Omero e Virgilio appunto in essa affonda le radici quella querelle des anciens et des modernes che fu accesa da Charles Perrault nel 1687 e che era stata anticipata dalle Congetture accademiche o dissertazione sullrsquoIliade composte e lette in pubblico nel 1664 (ma pubblicate postume nel 1715) da Franccedilois Heacutedelin abate drsquoAubignac egli sosteneva che Omero era un personaggio immaginario e lrsquoIliade una maldestra ricucitura di canti (definiti laquopiccole tragedieraquo) composti oralmente in epoche diverse Indipendentemente dal drsquoAubignac Giovan Battista Vico nel III libro della seconda edizione dei Principii di scienza nuova drsquointorno alla comune natura delle nazioni (1730) intraprendeva la laquodiscoverta del vero Omeroraquo anche per Vico Omero non sarebbe mai esistito ma i poemi a lui attribuiti sarebbero lrsquoopera collettiva del popolo greco il prodotto di unrsquoetagrave ancora animata dal senso del mito e dal vigore della fantasia lrsquoidea simbolica degli antichissimi Greci laquoin quanto essi narravano cantando la loro storiaraquo
28 A lungo si egrave cercato di risolvere la contraddizione ricorrendo a una varietagrave di schemi architettonici o dichiarando interpolati i versi che contengono il riferimento alla soglia di frassino Piugrave pertinente sembra lrsquoannotazione di J Russo nel suo commento ai canti XVII-XX (Omero Odissea V Mondadori Milano 1985 178 s) laquoμελίνου οὐδοῦ egrave una variante metrica di λάϊνον οὐδόν (kkl ll per lkk lk) esattamente come per es Hera egrave di solito ldquodalle bianche bracciardquo oppure ldquodagli occhi di giovencardquo (λευκώλενος o βοῶπις) per ragioni di convenienza metrica piuttosto che per esigenze descrittiveraquo
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
38
In due capitoli intitolati Sulla scrittura e Se sia verosimile che Omero sapesse scrivere del Saggio sulle origini delle lingue (1762) Jean-Jacques Rousseau rivendicava anche in relazione a Omero la nozione di un linguaggio ldquonaturalerdquo o ldquoselvaggiordquo rispetto al quale la scrittura rappresenterebbe lo strumento di un progressivo asservimento della passione e della fantasia Qualche decennio piugrave tardi lrsquoinglese Robert Wood ribadigrave in unrsquoopera dal titolo Un saggio sul genio originario di Omero (1769 17752) che la trasmissione dei poemi dovette avvenire oralmente cosigrave come orale ne era stata la composizione Ma la questione omerica entrograve propriamente nel dominio della filologia solo con i Prolegomena ad Homerum (1795) di Friedrich August Wolf il primo tentativo di ricostruire come premessa a unrsquoedizione critica dei poemi una storia del testo di Omero dalle origini al II secolo aC (cioegrave fino al costituirsi della laquovulgataraquo molto simile al testo omerico trasmesso dalla tradizione manoscritta medievale) Per la storia piugrave antica Wolf insistette sullrsquoassenza di scrittura al tempo della primitiva composizione dei canti omerici sulla trasmissione orale del testo e sul ruolo che per la trascrizione e ricucitura dei canti originari dovette esercitare la cosiddetta laquorecensione pisistraticaraquo cioegrave unrsquoopera di fissazione del testo avvenuta nel VI secolo aC in Atene alla corte di Pisistrato In Wolf si trovava abbozzata anche quella teoria dei canti separati (Liedertheorie) o nuclei originari che fu poi ripresa e sviluppata durante il secolo XIX anche ricorrendo al confronto con la Canzone dei Nibelunghi soprattutto da Karl Lachmann (1793-1851) dopo aver individuato venti canti primitivi allrsquointerno appunto del Nibelungenlied il Lachmann riconobbe nellrsquoIliade da 16 a 18 laquorapsodieraquo Una teoria opposta a quella dei canti separati venne formulata da Gottfried Hermann (1772-1848) che riconobbe il fondo originario dellrsquoIliade in una Urilias (laquoIliade originariaraquo) in sostanza unrsquoAchilleide intorno a cui si sarebbero aggregate per ampliamenti successivi le altre parti (laquoteoria dellrsquoallargamentoraquo) similmente nucleo dellrsquoOdissea sarebbe stato un canto sul ritorno del protagonista Una terza ipotesi di tipo conciliativo nata in relazione allrsquoOdissea e poi estesa allrsquoIliade sottolineograve la distinzione fra singoli canti e laquopiccole composizioniraquo (Kleinepen) Iliade e Odissea sarebbero sorte dallrsquoagglutinazione non di singoli canti bensigrave di brevi poemetti artificiosamente adattati lrsquouno allrsquoaltro Il piugrave illustre rappresentante di questa tendenza Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) il cui saggio LrsquoIliade e Omero egrave del 1916 accettava la tesi di Lachmann sui nuclei originari ma affermava che intorno allrsquoVIII secolo aC in ambiente ionico un poeta (forse di nome Omero) avrebbe unificato i Kleinepen in un epos monumentale (Grossepos) al quale si sarebbero poi aggiunti altri canti In ogni caso i rappresentanti di tutte queste linee di ricerca concordavano nel prefiggersi di laquoenucleareraquo (in greco ἀναλύειν donde il nome di critici laquoanaliticiraquo) i diversi poeti e i diversi laquostratiraquo (una metafora di evidente matrice archeologica) che si dovrebbero presupporre al di sotto del testo omerico cosigrave come ci egrave stato tramandato dalla tradizione manoscritta medievale La corrente degli laquounitariraquo che era rimasta a lungo ai margini degli studi omerici prese a reagire ndash soprattutto con gli Studi sullrsquoIliade (1938) di Wolfgang Schadewaldt e poi con una serie di indagini di Karl Reinhardt culminate nel volume postumo LrsquoIliade e il suo poeta (1961) ndash mettendo in evidenza la complessa architettura dei poemi i nessi fra le singole parti le anticipazioni e i ritardi nella strategia del racconto la costruzione di episodi come parti di un tutto insomma fornendo le prime letture dei poemi in termini di strutture narrative consapevolmente perseguite (ma sullrsquoOdissea la posizione di Schadewaldt restava parzialmente analitica) Nei decenni successivi la corrente unitaria ha spesso imboccato una nuova direzione anche sfruttando le osservazioni della vecchia analisi con la corrente detta della laquoneo-analisiraquo (promossa specialmente dalle Ricerche omeriche di JTh Kakridis [1949]) essa cerca di ricostruire grazie soprattutto al confronto con le opere del cosiddetto Ciclo i precedenti dei poemi ricostruendo ldquofontirdquo giagrave compiute e fissate che Omero o comunque i poeti dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea avrebbero utilizzato e rimodellato (elaborando in particolare il tema dellrsquoira di
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
39
Achille sul modello della storia di Meleagro e il tema delle peregrinazioni di Odisseo sul modello della saga degli Argonauti) Per lrsquoOdissea la proposta di teorie analitiche ha un avvio assai piugrave tardivo anche se giagrave nel 1832 Gottfried Hermann considerava la laquoTelemachiaraquo come unrsquoaggiunta posteriore Per incontrare il primo tentativo organico bisogna attendere la seconda metagrave del secolo XIX con LrsquoOdissea omerica e la sua genesi (1859) di Adolf Kirchhoff (1826-1908) che ricondusse la genesi del poema alla cucitura di quattro ldquorapsodierdquo preesistenti La prospettiva oralista Sul versante della comparazione un energico impulso alla riconsiderazione di alcuni tratti generali della poesia epica venne a partire dal 1928 da una serie di studi compiuti da Milman Parry (1902-1935) e da una campagna condotta dallo stesso Parry e da Albert B Lord in territorio serbo e croato fra il 1933 e il 1935 con la raccolta di un ingente materiale documentario ndash 12500 registrazioni a Novi Pazar e in altri siti29 ndash che attestava come i cantori popolari serbi e croati fossero tuttora in grado di improvvisare canti eroici di estensione comparabile ai poemi omerici ricorrendo a un patrimonio formulare tramandato mnemonicamente Essi si esibivano in pubblico accompagnandosi con uno strumento a corda (la gusla una sorta di violino donde il nome di laquoguslariraquo) che serviva loro a scandire il ritmo su cui cantare in decasillabi le imprese degli eroi del loro paese conoscendo solo attraverso la tradizione orale i costumi del tempo in cui i loro canti erano ambientati Il confronto successivamente operato da Lord a distanza di quasi ventrsquoanni su un medesimo componimento eseguito dallo stesso interprete mostrograve non solo che i canti tendono a modificarsi nelle singole espressioni ma che interi episodi si allargano o si abbreviano o comunque subiscono alterazioni significative della loro struttura narrativa Egrave opera dei due studiosi americani lrsquoelaborazione di una teoria dellrsquooralitagrave basata sulle nozioni di formularitagrave (il cantore procede nel suo percorso utilizzando ldquogruppi di parolerdquo cristallizzati le formule di cui abbiamo giagrave trattato) e di tradizionalitagrave (nocciolo generativo del poetare per formule egrave il ldquotemardquo cioegrave una certa situazione o scena o una certa sequenza narrativa che puograve essere ripetuta con limitate variazioni oppure modificata arricchita condensata in relazione alla struttura dellrsquoepisodio o allrsquooccasione per la quale il canto viene eseguito) In certa misura preceduto dalle ricerche di E Ellendt H Duumlntzer e K Witte nella scoperta del legame fra lingua omerica e struttura dellrsquoesametro Milman Parry studiograve dapprima le formule composte dallrsquoabbinamento fra i nomi di degravei e di eroi e i loro epiteti Definita la formula come laquounrsquoespressione30 regolarmente impiegata nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenzialeraquo Parry intendeva mostrare che allrsquointerno della dizione epica le formule nomeepiteto costituiscono un sistema coerente che si costruisce in strettissima interdipendenza con le articolazioni del verso (e specialmente con la clausola di esso) per lrsquoinconsapevole cooperazione degli aedi immersi nella tradizione orale Parry morigrave allrsquoimprovviso verso la fine del 1935 al ritorno dalla campagna condotta a Novi Pazar Dopo una lunga pausa la problematica da lui elaborata fu ripresa da A Hoekstra e da JB Hainsworth Hoekstra cercograve di tracciare unrsquoevoluzione dello stile formulare prendendo come punti di riferimento quali indizi di recenzioritagrave i fenomeni della metatesi quantitativa (ad es ηοεω) della caduta del digamma iniziale e del ricorso al ν efelcistico per evitare lo iato Hainsworth studiograve lrsquouso dinamico delle formule (la loro ldquoflessibilitagraverdquo) osservando come allrsquointerno del verso esse si spostino si modifichino si smembrino o si espandano in relazione alle necessitagrave espressive e ai condizionamenti del metro (ad es μέγα ἔργον e κακὰ πολλά si presentano nei poemi in tutte e quattro le posizioni metricamente possibili)
29 Cfr AB Lord Serbo-Croatian Heroic Songs I Cambridge 1954 Le registrazioni sono conservate presso lrsquoUniversitagrave di Harvard 30 Ma ad laquoespressioneraquo Parry preferigrave in seguito laquogruppo di paroleraquo
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
40
Piugrave di recente si egrave cercato di precisare anche un altro aspetto dellrsquooralitagrave quello della composizione estemporanea e della sua applicabilitagrave al metodo di lavoro di Omero Da un lato si egrave ribadito che allrsquointerno della ldquoletteraturardquo orale ogni testo egrave strettamente dipendente dallrsquooccasione della recita cosiccheacute non esiste composizione separata dallrsquoatto dellrsquoesecuzione bensigrave la composizione e la trasmissione di un poema o di un canto avvengono attraverso una sorta di laquoricostruzione generativaraquo (J Goody) ossia di una riappropriazione creativa di ciograve che dei canti tradizionali il cantore ha memorizzato per contro Ruth Finnegan31 ha mostrato che talora la poesia orale viene composta prima dellrsquoesecuzione (per cui lrsquoesecuzione risulta subordinata alla scrupolosa memorizzazione di un testo prefissato) Nelle isole Gilbert ad esempio il poeta che deve comporre un canto si isola in un luogo appartato esegue una serie di rituali e poi si procura la collaborazione di un gruppo di amici che porta con seacute nella Casa del canto percheacute lo aiutino a mettere a punto il componimento rimasto di nuovo solo riflette sui consigli ricevuti e infine istruisce un coro e questi coreuti memorizzano le parole della canzone frase per frase e apprendono i passi di danza sotto la guida di un esperto infine il canto viene eseguito in una determinata occasione festiva con meticoloso rispetto del testo giagrave composto ci troviamo cosigrave di fronte a quella che Lord aveva definito con un paradosso una laquocomposizione scritta senza scritturaraquo Occorre perciograve non identificare a priori oralitagrave ed estemporaneitagrave ma tener conto che la composizione orale sopra un ritmo inventato per lrsquooccasione puograve esigere una fase di premeditazione e di memorizzazione interne Senoncheacute proprio la restrizione delle esecuzioni condotte su un testo compiutamente memorizzato a casi che richiedono lrsquoinvenzione di un nuovo ritmo parrebbe confermare la pratica del comporre improvvisando in rapporto a una performance condotta invece su un ritmo precostituito e ripetuto come egrave quella della poesia esametrica Questa improvvisazione naturalmente non nasce dal nulla ma si elabora sfruttando moduli giagrave pronti sia sul piano della dizione (formule nessi formulari collocazioni preferenziali di parole e sintagmi allrsquointerno del verso) sia su quello piugrave ampio delle sequenze di motivi (le laquoscene tipicheraquo studiate da W Arend a cui giagrave abbiamo accennato vestizione di armi banchetto partenza cerimonia funebre scontri fra i combattenti etc) e dei temi (le situazioni scelte ad argomento delle singole unitagrave narrative) Si egrave riproposto allora anche il problema se Omero componesse con lrsquoausilio della scrittura Contro la reiterata obiezione secondo cui poemi di tale complessitagrave e perfezione non potrebbero essere stati composti senza ricorso alla scrittura si egrave osservato che un complesso di indizi favoriscono lrsquoipotesi oralistica anche in relazione ad Omero R Janko (1982) sulla linea di Parry ha posto come decisiva la compresenza di tre fattori complessi sistemi fomulari che dispiegano estensione ed economia una bassa frequenza di enjambement necessari32 irregolaritagrave metriche dovute al gioco delle formule Nessuno di essi appare decisivo ma anche alla statistica vanno riconosciuti i suoi diritti Un tratto che sembra essere caratteristico allrsquointerno dei poemi omerici di un comporre tuttora orale sembra inoltre offerto dal largo e pervasivo dispiegarsi della tecnica della ripetizione interna (di parole di nessi ma anche di singoli gruppi fonici) cosigrave come tipicamente orale sembra essere il ricorrere di ldquoincidentirdquo seguiti da unrsquoauto-correzione operata a breve distanza33 Comunque sia se il problema di quando per la prima volta fu usata la scrittura in relazione al canto epico (cosigrave omerico come esiodeo) non puograve che restare irrisolta data la carenza di prove dirimenti sembra ragionevole ipotizzare che nel momento in cui fu originariamente impiegata essa dovette rappresentare non tanto un ausilio alla composizione quanto uno strumento per ldquoregistrarerdquo ciograve che continuava a essere meditato e comunicato con le tecniche dellrsquoarte orale 31 La fine di Gutenberg Studi sulla tecnologia della comunicazione (1988) Sansoni Firenze 1990 108-120 32 Si intende per enjambement laquonecessarioraquo (periodic) quello che investe la struttura sintattica della frase per enjambement laquonon necessarioraquo (unperiodic) quello che si limita a porre al di lagrave della fine di verso elementi non decisivi sul piano sintattico quali aggettivi o avverbi 33 Questi fenomeni sono discussi in laquoTesti e non testi il ritmo dellrsquoiterazioneraquo e in laquoI rischi del cantoraquo di F Ferrari Oralitagrave ed espressione cit 11-34 e 35-50
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
41
La lingua omerica La lingua dei poemi omerici che egrave in sostanza quella in cui furono affidati alla scrittura verso la fine dellrsquoVIII secolo aC e che si conserveragrave in larga misura nella tradizione epica successiva egrave un amalgama artificiale una laquolingua drsquoarteraquo (Kunstsprache) basata su elementi dialettali disparati Innanzi tutto coesistono allrsquointerno di un tessuto a base prevalentemente ionica numerosi eolismi fra i quali sono in particolare da ricordare
bull lrsquoesito labiale della labiovelare iniziale indoeuropea πίσυρες per τέσσαρες laquoquattroraquo bull lrsquoesito in ροορ della r sonante indo-europea ἤμβροτον per ἥμαρτον (su ἤμβροτον
si basa anche la forma isolata ἀβροτάξομεν aoristo congiuntivo a vocale breve di un inattestato ἀβροτάζω in Iliade X 65)
bull i pronomi personali ἄμμες ἄμμε ἄμμι(ν) per lo ionico ἡμεῖς ἡμέας (attico ἡμᾶς) ἡμῖν e ὔμμες ὔμμε ὔμμι(ν) per lo ionico ὑμεῖς ὑμέας (attico ὑμᾶς) ὑμῖν
bull lrsquoesito in -εσσι dei dativi plurali della III declinazione πόδεσσι per ποσσί o ποσί χείρεσσι per χερσί πάντεσσι per πᾶσι
bull participi perfetti attivi con la desinenza caratteristica del presente (-ων -οντος) κεκλήγοντες per κεκληγότες
bull gli infiniti in -μεναι -μεν (soprattutto per i verbi atematici) δόμεναι o δόμεν per δοῦναι ἔμμεναι o ἔμμεν per εἶναι ἀγέμεναι o ἀγέμεν per ἄγειν ἐλθέμεναι o ἐλθέμεν per ἐλθεῖν
bull la forma apocopata di alcune preposizioni πάρ per παρά κάτ per κατά bull Lrsquouso della particella modale κε(ν) in concorrenza con ἄν bull il pronome di II persona τύνε (cfr beotico τούν) = σύ (attestato cinque volte
nellrsquoIliade mai nellrsquoOdissea) Le forme eoliche possono essere ricondotte al contatto fra gli Ioni della costa anatolica e gli insediamenti eolici che in essa si trovavano Infatti lo ionico si impose solo gradualmente in buona parte della costa settentrionale dellrsquoAsia minore ad es laquoalcune particolaritagrave eoliche del linguaggio di Chio () indicano che il processo di ionizzazione di Chio non era ancora compiuto allrsquoinizio dellrsquoepoca storica se lrsquoeolico traspare ancora dalle iscrizioni doveva sopravvivere piugrave largamente nellrsquouso comuneraquo (A Meillet) La nuova fioritura del canto epico avrebbe ricevuto fra IX e VIII secolo aC una nuova forma linguistica ionica ad opera di aedi ionici pur conservando molto dellrsquoantica lingua a base eolica anche per lrsquoinerzia conservativa della tradizione orale Una diversa ipotesi vuole invece che lrsquoepos sia sorto in una zona di confine fra territori ionici ed eolici del Peloponneso settentrionale prima dellrsquoinvasione dorica e dunque riflettesse una lingua ibrida eolo-ionica che per un certo periodo sarebbe stata effettivamente parlata in quelle zone Contro questa ipotesi milita il fatto che quasi tutte le forme eoliche appaiono strettamente vincolate al metro e non potrebbero essere sostituite con forme dialettali ioniche senza intervenire sul contesto dellrsquointero verso (ad es il dativo plurale lsquolungorsquo eolico στήθεσσι non poteva essere sostituito con lo ionico στήθεσι la particella modale κε(ν) con ἄν etc) mentre le forme ioniche appaiono generalmente sostituibili con forme eoliche (ad es lrsquoinfinito ἰέναι con lrsquoeolico ἴμεναι πείρατα con lrsquoeolico πέρρατα) E una poesia narrativa eolica in un metro affine allrsquoesametro (il cosiddetto lsquopentametrorsquo in realtagrave un gliconeo con doppia espansione
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
42
dattilica x x - - - - - - - - - - - =) egrave positivamente attestata in alcuni carmi di Saffo come il fr 44 Voigt (racconto delle nozze fra Ettore e Andromaca) Fra i tratti dello ionico presenti in Omero e nellrsquoepica arcaica che subiranno unrsquoevoluzione in attico vanno ricordati
bull la chiusura della vocale a lunga in η anche quando preceduta da ε ι ρ (ionico βίη πέτρη attico βία πέτρα)
bull lrsquoassenza di metatesi fra η e ο donde i genitivi in -ηος (o -εος) dei sostantivi con tema uscente in -ew (ionico πόληος o πόλεος ma anche πόλιος sulla base di un tema alternativo in -j attico πόλεως ionico βασιλῆος o βασιλέος attico βασιλέως) e ionico νηός laquotempioraquo rispetto ad attico νεώς ionico νηός (o νεός) laquodella naveraquo rispetto ad attico νεώς
bull la conservazione dei gruppi consonantici -ρσ- e -σσ- (ionico ἄρσην attico ἄρρην ionico θάρσος attico θάρρος ionico γλῶσσα attico γλῶττα)
bull lrsquoallungamento di compenso per la caduta del digamma dopo ν ρ λ (da xenwos ionico ξεῖνος attico ξένος)
bull la minore estensione della contrazione (ad es ionico βασιλῆες ἱππῆες attico βασιλεῖς ἱππεῖς ionico ποδώκεες attico ποδώκεις ionico τείχεος τείχεα attico τείχους τείχη ionico ἡμέων ἡμέας ὑμέων ὑμέας attico ἡμῶν ἡμᾶς ὑμῶν ὑμᾶς ionico φιλέω φιλέεις φιλέει ἐφίλεον ἐφίλεε φιλέων φιλέουσα etc attico φιλῶ φιλεῖς φιλεῖ ἐφίλουν ἐφίλει φιλῶν φιλοῦσα etc ionico ἔρχεαι ἔσεαι βούλεαι κήδεαι attico ἔρχῃ ἔσῃ βούλῃ κήδῃ)
bull la contrazione di εο in ευ rispetto ad attico ου (ionico θάρσευς ἐμεῦ attico θάρσους ἐμοῦ)
bull i genitivi in -έων della I declinazione (ἀγορέων βουλέων κεφαλέων) in concorrenza con le forme lsquoacheersquo in -άων (attico -ῶν)
bull i dativi plurali lsquolunghirsquo -οισι -ῃσι (attico -οις -αις) Accanto allo ionico e allrsquoeolico egrave stata poi sottolineata nella lingua omerica soprattutto a partire dalla decifrazione della Lineare B la persistenza di elementi del greco meridionale miceneo (egrave lrsquo laquoelemento acheoraquo di Ruijgh 1957) in particolare
bull πτ iniziale in luogo di π (πτόλις per πόλις) bull la desinenza -αο -αων per i genitivi della I declinazione (Ἀτρεΐδαο Πριαμίδαο
θεάων μελαινάων) e -οιο (πλούτοιο δίφροιο) per quelli della II bull il suffisso locativo-strumentale -φι(ν) (miceneo pi cfr lat ti-bi) ἀγέλεφι κεφαλῆφι
ναῦφι ὄρεσφι στήθεσφι bull la forma enclitica μιν per lrsquoaccusativo singolare del pronome personale di III persona bull una serie di vocaboli che trovano riscontro nellrsquoarcadico-cipriota (il gruppo che mantiene
i piugrave saldi legami con il miceneo) fra cui αἶσα ἄναξ δατέομαι δέπας δῶμα ἦμαρ (cfr Ruijgh 1957 pp 111-167)
Nella lingua omerica troviamo infine alcuni atticismi che probabilmente non vanno ascritti al processo di formazione e trasmissione piugrave antica dei poemi ma subentrarono quando a partire dal VI secolo aC lrsquoepica omerica si diffuse largamente anche in Attica ad es ἧντrsquo di Iliade III 153 κεῖντο di Iliade ΧΧΙ 426 e ἐπέκειντο di Odissea VI 19 dovettero sostituire rispettivamente le forme ioniche ἕατrsquo κέατο e ἐπεκέατο (con sinizesi di εα)
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
43
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
La trasmissione del testo omerico
La storia del testo omerico si caratterizza per molteplici varianti che si sono originate almeno in parte come effetto dellrsquoattivitagrave di rapsodi a cui era estraneo lo scrupolo di riprodurre fedelmente un determinato modello Inoltre Iliade e Odissea furono sempre troppo lette e studiate anche in etagrave bizantina percheacute la tradizione potesse ricominciare da quel punto che per molti autori antichi egrave rappresentato da un archetipo medievale In effetti laquola tradizione bizantina risale questa volta recta via a esemplari antichi recta via almeno in questo senso che non vi egrave stato un unico nodo stradale un unico bacino di raccoglimento nel quale le lezioni antiche siano confluite dal quale i codici medievali si siano di nuovo diramatiraquo (Pasquali) I poemi furono oggetto di cure intense e reiterate ad opera dei filologi di Alessandria drsquoEgitto a partire dallrsquoinizio del III secolo aC ma giagrave nella seconda metagrave del VI nellrsquoAtene dei Pisistratidi la loro recitazione era divenuta parte integrante del programma delle Panatenee I numerosi manoscritti medievali e umanistici ci hanno consegnato un tessuto verbale che nonostante le divergenze dovute sia a varianti testuali che alla presenza o assenza di un nutrito numero di versi mostra un assetto ndash ciograve che si usa denominare la laquovulgataraquo ndash che corrisponde abbastanza fedelmente al modo come Omero fu letto allrsquoincirca dal 150 aC alla fine del mondo antico Ma accanto a questa laquovulgataraquo disponiamo di testimonianze frammentarie ma cospicue offerte da papiri di etagrave tolemaica da citazioni di scrittori attici del IV secolo aC e da scoli trascritti in margine ai manoscritti medievali (soprattutto quelli contenuti nel codice A il Venetus 454) da cui si ricavano indicazioni importanti su aspetti del testo coevi o anteriori allrsquoetagrave alessandrina Giagrave verso la fine del VI secolo aC Teagene di Reggio aveva introdotto il metodo allegorico per difendere Omero da censure come quelle sollevate da Senofane in merito alla rappresentazione antropomorfica e amorale degli degravei ma la prima lsquoedizionersquo di cui ci resti memoria egrave fra V e IV secolo aC quella del poeta Antimaco di Colofone Drsquoaltra parte Antimaco in assenza di un commento non poteva motivare i suoi giudizi poteva solo accogliere (per tradizione o per congettura) o non accogliere una certa lezione Anche se giagrave Protagora poteacute discettare sullrsquouso a suo avviso scorretto dellrsquoimperativo invece dellrsquoottativo nellrsquoapostrofe del poeta alla Musa a principio dellrsquoIliade (80 A 29 D-K) e se Aristotele e i suoi allievi del Liceo si occuparono con impegno di esegesi omerica come vediamo dai Problemi omerici (fr 142-179 Rose) e dal cap 25 della Poetica una sistematica attivitagrave filologica si avvia solo con i grammatici di Alessandria Zenodoto di Efeso divenuto direttore della Biblioteca di Alessandria intorno al 290 aC fu secondo la Suda lrsquoautore della prima recensione (διόρθωσις) del testo omerico e introdusse il primo segno diacritico ndash lrsquoobelo (laquospiedoraquo) un tratto orizzontale sul margine sinistro accanto al verso incriminato ndash per segnalare versi che egli non ometteva ma lsquoatetizzavarsquo cioegrave lasciava nel testo pur giudicandoli di sospetta autenticitagrave Senoncheacute Zenodoto non redasse un commentario e perciograve non conosciamo le ragioni delle sue scelte Aristofane di Bisanzio direttore della Biblioteca a partire dal 195 circa fino alla morte (circa 180) offrigrave un testo piugrave conservativo di quello di Zenodoto e aggiunse nuovi segni critici (lrsquoasterisco per contrassegnare i versi ripetuti da un altro passo dove sembravano piugrave al loro posto il sigma e lrsquoantisigma per marcare due versi consecutivi di identico contenuto e intercambiabili) Aristarco di Samotracia divenuto direttore della Biblioteca qualche tempo dopo il 180 e morto nel 145 introdusse il commento perpetuo (ὑπόμνημα) mentre alla sua scuola la Vita di Omero pseudo-plutarchea (2 4) attribuisce la divisione dei poemi in 24 libri ciascuno (questa divisione appare attestata nei papiri solo a partire dal 50 circa aC egrave stato sostenuto ma senza argomenti stringenti che la divisione risale a Zenodoto se non a epoca pre-alessandrina) Ai segni diacritici giagrave usati da Aristofane aggiunse la dipleacute (gt) per segnalare le sue scelte contrarie a quelle di editori diversi da Zenodoto e la dipleacute periestigmeacutene cioegrave lo stesso segno sormontato in alto e in basso da un punto per segnalare i dissensi da Zenodoto e in luogo di sigma e antisigma adottograve lrsquoantisigma e la stigmeacute (punto) Secondo la ricostruzione piugrave verosimile del suo percorso filologico Aristarco redasse dapprima un commento al testo stabilito da Aristofane poi una propria recensione poi ancora un commento destinato ad accompagnarlo infine i suoi allievi avrebbero costituito un nuovo testo che incorporava le sue scelte piugrave recenti Lo stesso Aristarco raccolse e collazionograve numerose copie ripartendole in due categorie
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
44
a) le laquopiugrave elegantiraquo di origine dotta da un lato quelle κατ᾽ ἄνδρα e cioegrave dei grammatici alessandrini suoi predecessori (ma egrave ricordata anche unrsquoedizione di Cratete di Pergamo) e di poeti come Antimaco e Riano dallrsquoaltro quelle πολιτικαί (laquocittadineraquo) e cioegrave le copie provenienti da Chio Argo Creta Cipro Marsiglia Sinope etc b) le laquomeno curateraquo o laquoinferioriraquo o laquovolgariraquo (probabilmente anche le edizioni denominate κοιναί o κοινότερα laquo(piugrave) comuniraquo e quella detta κοινή laquovulgataraquo facevano parte di questa seconda categoria) Gli esemplari laquopiugrave elegantiraquo per quanto possiamo verificare sulla base delle lezioni a noi note abbondavano di varianti inferiori (poste a testo o in margine o anche nellrsquointerlineo) mentre le copie laquovolgariraquo (compresa la koineacute) erano normalmente di qualitagrave superiore in quanto conservavano peculiaritagrave che oggi siamo in grado di spiegare su base linguistica o grazie allrsquoapprofondimento dei meccanismi dellrsquoepica orale ed erano altresigrave piugrave consonanti (pur se non coincidenti) con la stabilizzazione del testo che si sarebbe realizzata in etagrave tardo-antica e medievale Riscontriamo drsquoaltra parte dalla testimonianza dei papiri di epoca tolemaica che numerosi testi ellenistici contenevano versi in piugrave tratti generalmente da altre parti dei poemi e frequenti varianti Di fronte ad essi Aristarco dovette procedere ripudiando tutto ciograve che si proponesse come lsquoeccentricorsquo I suoi commenti spaziavano dalla censura sullrsquouso infelice di una formula allrsquointerpretazione della paradosis dalla discussione di questioni ortografiche alla congettura Per le proposte di atetesi in particolare Aristarco era incline a ritenere spuria ogni sequenza che apparisse ridondante o tale da rispecchiare ai suoi occhi moduli espressivi e orientamenti del gusto tipici dei poeti epici piugrave recenti Anche per lui come per Zenodoto la questione di fondo egrave in quale misura le sue lezioni si basassero sulla tradizione ellenistica a sua disposizione o su congetture personali o altrui Non egrave dirimente il fatto che talvolta egli accettasse lezioni che sono completamente assenti nella tradizione medievale dato che gli esemplari ellenistici dovevano offrire lezioni che la tradizione medievale non ha recepito come provano citazioni platoniche non spiegabili come errori di memoria Drsquoaltra parte se le lezioni peculiari ad Aristarco rappresentavano in buona misura il frutto di congetture fatte da lui o da suoi predecessori e contemporanei si comprende assai meglio come esse non riuscissero a influenzare in profonditagrave la tradizione testuale successiva (non tutte le lezioni attestate per Aristarco sono passate nella tradizione medievale e di esse solo una modesta percentuale egrave attestata in tutti o nella maggior parte dei nostri manoscritti a quanto egrave stato calcolato rispettivamente 80 e 160 su 874) mentre sarebbe difficile immaginare che lezioni circolanti in etagrave ellenistica con lrsquoavallo del piugrave accreditato filologo di Alessandria non lasciassero traccia nei manoscritti medievali La ben piugrave alta coincidenza fra Aristarco e la vulgata medievale nel numero dei versi si spiega col fatto che egli dovette muovere da un testo base scelto fra quelli meno eccentrici (o costruito sulla base di esemplari di questo tipo) limitandosi a segnalare le sue proposte di atetesi con i segni diacritici Che tali testi non mancassero egrave provato sia da quei papiri del IIIII secolo aC che diversamente dalla maggior parte degli altri papiri tolemaici non presentano affatto o presentano in misura minima versi in piugrave rispetto alla vulgata medievale sia dalle citazioni omeriche di Platone tanto ricche di lezioni peculiari quanto non lontane nel gioco di compensazione fra lsquoaggiuntersquo e lsquoomissionirsquo dal nostro numero di versi (sul versante opposto gli esemplari ellenistici infarciti di versi aggiuntivi trovano un antecedente in altri scrittori attici ad es nella citazione di Iliade XXIII 77-91 fatta da Eschine Contro Timarco 149) Quando si trattava di omettere uno o piugrave versi e non semplicemente di proporne lrsquoatetesi Aristarco dovette operare quasi esclusivamente su base documentaria attento a snidare le lsquointerpolazioni per concordanzarsquo infiltratesi in una parte della tradizione e caratteristiche di molti papiri tolemaici In sostanza non dovette essere tanto la tradizione ellenistica a subire lrsquoinflusso delle scelte di Aristarco quanto Aristarco a seguire allrsquointerno degli esemplari a lui noti il filone tradizionale meno marcato da interpolazioni rapsodiche La graduale scomparsa di papiri lsquoeccentricirsquo a partire dalla metagrave del II secolo aC fu probabilmente condizionata dal declino dellrsquoattivitagrave dei rapsodi piugrave che dallrsquoinflusso degli esemplari di origine dotta
I rapsodi A sua volta la buona qualitagrave della tradizione testuale ellenistica destinata a sfociare nella tradizione medievale in che relazione si pone con le origini del testo omerico Per quanto la dizione omerica appaia imbevuta di oralitagrave - formularitagrave scene tipiche procedimenti narrativi incidenti e contraddizioni - lrsquoIliade e lrsquoOdissea se confrontate con
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
45
testi che hanno attraversato fasi di oralitagrave o di semi-oralitagrave (dal Poema di Gilgamesh al Mahabharata dal Digenes Akrites al Nibelungenlied e alla Chanson de Roland) non offrono redazioni alternative Fin dallrsquoetagrave classica non sappiamo di altra redazione se non di quella rappresentata dalla nostra tradizione Tutti i nostri manoscritti rinviano a unrsquounica origine e nulla ci fa pensare che a parte le aggiunte e le ornamentazioni dei rapsodi sia mai esistita piugrave di unrsquoIliade o di unrsquoOdissea lsquooriginariersquo Secondo alcuni la vulgata ellenistica avrebbe unrsquoorigine ateniese appunto la redazione ateniese avrebbe acquistato unrsquoautoritagrave tale da impedire lrsquoemergere di altre versioni o da screditare ogni variante narrativa eventualmente affiorante (West 1981 una trascrizione dei poemi per la prima volta in Atene ha ipotizzato Kirk 1962 ma in un secondo tempo la sua posizione egrave piugrave sfumata) Vi egrave in effetti un blocco di testimonianze legato alla presenza dei poemi nellrsquoAtene della tirannide pisistratica degli ultimi decenni del VI secolo aC Secondo lsquoPlatonersquo Ipparco 228b Ipparco figlio di Pisistrato istituigrave regolari recitazioni dei poemi omerici durante le Panatenee (che erano state fondate o rifondate da Pisistrato nel 566555 aC) imponendo ai rapsodi di recitare i singoli episodi in successione lrsquouno dopo lrsquoaltro (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς)raquo (uno storico megarese del IV secolo aC di nome Dieuchida FGrHist 485 F 6 attribuisce invece il provvedimento a Solone mentre lrsquooratore Licurgo Contro Leocrate 102 accenna genericamente rivolgendosi agli Ateniesi ai laquovostri padriraquo) A tale scopo Ipparco avrebbe laquoimportatoraquo (ἐκόμισεν) in Attica un esemplare completo dei poemi ciograve che sembra presupporre lrsquoesistenza nella Ionia di un testo canonico monopolizzato dai rapsodi tale da poter essere trasportato come un oggetto (il verbo κομίζω egrave lo stesso usato subito dopo [228c] per il trasferimento ad Atene su una nave del poeta Anacreonte) Drsquoaltra parte lrsquoabito di cantare in suc cessione non sembra essere stato unrsquoinvenzione ateniese percheacute trova un riscontro implicito giagrave nellrsquoIliade (IX 189-91) dove Patroclo aspetta il suo turno per riprendere il canto nel punto in cui Achille lo ha lasciato laquo(Achille) cantava imprese di eroi e Patroclo di fronte a lui sedeva in silenzio aspettando (δέγμενος) che Achille interrompesse il suo cantoraquo Come ha osservato Nagy in questa immagine omerica di Patroclo che aspetta il suo turno per cantare troviamo abbozzata la prassi della catena rapsodica (per δέγμενος cfr Aristofane Vespe 1222 τὰ σκόλι᾽ ὅπως δέξει καλῶς laquocosigrave che tu sappia riprendere con arte le canzoni simposialiraquo) Unrsquoaltra serie di testimonianze fra cui lrsquoepigramma anonimo conservato in Antologia Palatina XI 442 3 s suggerisce invece che Pisistrato raccogliesse singoli canti dalla viva voce dei rapsodi dato che i poemi si erano ormai dispersi ed erano tramandati in laquoparti staccateraquo σποράδην (ma nella versione della storia riportata da Cicerone De oratore III 34 lrsquooperazione viene interpretata come la raccolta di una serie di rotoli capace di consentire la ricostruzione dellrsquoinsieme primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur ut nunc habemus) E uno scolio a Dionisio Trace (Grammatici Graeci III 179) presume di sapere che il tiranno remunerograve secondo un compenso prefissato tutti coloro che fossero in grado di recitare versi omerici mentre lo scolio a Pindaro Nemea 2 1c ricorda sulla base di un erudito del III secolo aC (Ippostrato FGrHist 568 F 5) che un tempo i rapsodi i quali in origine erano i discendenti diretti di Omero (gli laquoOmeridiraquo) recitavano negli agoni ciascuno la parte che preferiva e che fra questi si erano distinti Cineto di Chio e i suoi adepti i quali sarebbero stati anche i primi a introdurre la recitazione dei poemi omerici a Siracusa fra il 504 e il 501 aC_ Giuseppe Flavio (Contro Apione 1 12) registra poi la tradizione secondo cui neppure Omero avrebbe affidato alla scrittura i suoi poemi tanto che essi tramandati mnemonicamente solo in seguito sarebbero stati ricomposti (συντεθῆναι) da canti separati e verso la metagrave del XII secolo lrsquoerudito bizantino Tzetzes Anecdota Graeca (ed Cramer) 1 6 aggiunge che Pisistrato in vista della nuova redazione dei poemi avrebbe creato una commissione di dotti Infine Pisistrato stesso o Solone avrebbero promosso lrsquointerpolazione di versi filoateniesi laquoAlcuni sostengono ndash riferisce Strabone (IX 1 10) ndash che sia stato Pisistrato altri Solone a interpolare nel Catalogo delle navi subito dopo il verso ldquoAiace conduceva da Salamina dodici navirdquo [II 557] lrsquoaltro ldquole schierograve lagrave dove erano piazzate le falangi ateniesirdquo [II 558] per far testimoniare al poeta che lrsquoisola apparteneva agli Ateniesi fin dal principio Ma i filologi non accettano la tradizioneraquo Ma il punto egrave che la lsquoregola panatenaicarsquo ebbe evidentemente lo scopo di impedire che i rapsodi recitassero troppo spesso (e manipolassero) gli episodi piugrave popolari Sia lrsquointroduzione della regola che gli aneddoti sulle interpolazioni rsquopolitichersquo presuppongono lrsquoesistenza di un testo giagrave stabilizzato nella Ionia Per altro verso Plutarco (Vita di Licurgo 4) sulla scia di notizie fornite da Aristotele nella perduta Costituzione degli Spartani (fr 611 Rose) pur ripetendo la tradizione secondo cui i
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
46
poemi sarebbero stati tramandati in modo sparso afferma che fu lo spartano Licurgo colui che li laquoraccolseraquo (συνήγαγεν) per portarli (κομιῶν) nel Peloponneso dopo esserseli procurati dai Creofilei una confraternita di rapsodi samii (nella tradizione biografica Creofilo era stato colui che a Cos aveva ospitato Omero e al quale il poeta aveva donato la Presa di Ecalia) Se la lsquoregola panatenaicarsquo sembra un dato storicamente attendibile ma riguarda non piugrave che lrsquointroduzione della recitazione in serie dei poemi in Atene lrsquoidea di una redazione pisistratica su larga scala egrave certamente unrsquoinvenzione erudita modellata sulle consuetudini delle biblioteche ellenistiche ma sconosciuta agli stessi studiosi alessandrini che avrebbero sicuramente menzionato una cosigrave antica recensione se ne avessero avuto in qualche modo notizia In effetti anche a non tener conto della fantomatica redazione pisistratica non abbiamo alcun serio indizio neppure di un effetto profondo esercitato dagli esemplari ateniesi sulla trasmissione del testo omerico Che gli studiosi alessandrini fra le edizioni lsquopolitichersquo utilizzate non ricordino alcun esemplare ateniese egrave il segno dello scarso rilievo delle copie attiche piuttosto che come pure si egrave pensato la prova di un prestigio cosigrave alto da rendere superfluo un esplicito richiamo ade esse Se i rapsodi fincheacute la dimensione della recita rimase un fenomeno intensamente praticato e apprezzato continuarono ad ampliare e manipolare il testo dei poemi e se i grammatici cercarono di correggerlo elaborando regole e schemi il corso maggiore della tradizione e il relativo commercio librario rimasero in larga misura indifferenti alle ridondanze degli uni e al raziocinio degli altri Una tale resistenza dovette dipendere dalla precoce dimensione panellenica acquisita dai poemi conosciuti e imitati in vaste aree del mondo greco giagrave prima delle Panatenee del VI secolo aC e ben presto divenuti il cardine dellrsquoinsegnamento elementare e il primo referente culturale dei Greci
La prima registrazione scritta Oltre allrsquoassenza di varianti narrative un altro indizio a favore della cristallizzazione del testo omerico molto prima del tempo dei Pisistratidi egrave dato dallrsquoaspetto linguistico La lingua artificiale o Kunstsprache che egrave il lsquodialettorsquo omerico (vedi sopra p xxx) ci egrave stata trasmessa in uno stadio che sembra anteriore allo sviluppo lsquosub-epicorsquo rappresentato da Esiodo dai poemi del Ciclo e dai cosiddetti Inni omerici In particolare le trasformazioni fonetiche del dialetto ionico che dovettero verificarsi intorno alla prima metagrave dellrsquoVIII secolo col mancato rispetto del digamma con la metatesi quantitativa e col ricorso al ν efelcistico intaccarono non tanto il sistema formulare quanto le zone non formulari della dizione (cfr Janko 1982 che prende in considerazione anche i genitivi singolari della II declinazione in -ου invece che in -οιο -οο i dativi plurali lsquobrevirsquo in -οις ed -ῃς invece che in -οισι ed -ῃσι lrsquoaffermarsi di Διός a scapito di Ζηνός) Del resto anche considerando la totalitagrave del testo i tratti innovativi appaiono disseminati in una misura inferiore a quanto avverragrave a partire da Esiodo ad es il digamma antevocalico conserva il suo effetto prosodico nellrsquo84 dei casi nellrsquoIliade nellrsquo83 nellrsquoOdissea nel 66 nella Teogonia nel 62 negli Erga e nel 54 nellrsquoInno a Demetra Crsquoegrave poi da considerare che se il testo non fosse stato precocemente affidato alla scrittura mal si spiegherebbe la permanenza al suo interno di incidenti compositivi Non sono veri incidenti lsquoscandalirsquo come quello di Pilemene che viene ucciso in Iliade V 576 e ricompare vivo in Iliade XIII 643 Come ha osservato Di Benedetto la distanza fra i due passi legittimerebbe la contraddizione anche in un testo lentamente costruito con lrsquoausilio della scrittura se egrave vero che lrsquoAriosto fa uccidere Agricalte in Orlando furioso XVI 81 5 e poi lo ripresenta vivo in XL 73 6 Sono invece veri incidenti quelli che risultano irriducibili a una spiegazione plausibile nellrsquoambito degli usi linguistici e compositivi di Omero e che intervengono nellrsquoarco di una stessa scena o di uno stesso episodio o fra episodi fra loro strettamente correlati talvolta provocando unrsquoautocorrezione o un cambiamento di direzione del flusso narrativo da parte del poeta (sui termini del fenomeno cfr Ferrari 1986 pp 35-50 e 2000) In realtagrave proprio i segni di autentica oralitagrave incapsulati nel testo omerico denunciano la trascrizione dellrsquoIliade e dellrsquoOdissea in un tempo non lontano dalla prima introduzione della scrittura allo scopo di conservare testi poetici e dunque dalla metagrave dellrsquoVIII secolo aC Se cosigrave non fosse stato se cioegrave i poemi fossero stati trascritti dopo secoli di uso della scrittura sarebbe molto difficile immaginare che simili incidenti non venissero corretti nel corso delle reiterate riprese rapsodiche
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura
Letteratura greca [1]
47
Come poteacute essere realizzata una cosigrave poderosa opera di trascrizione resta un enigma Comunque sia le difficoltagrave inerenti al materiale scrittorio ndash il papiro si diffuse in Grecia solo quando con Psammetico I (663-609 aC) lrsquoEgitto aprigrave le sue frontiere agli insediamenti commerciali greci ndash non sono insormontabili Esportazioni egizie di papiro in Fenicia sono attestate giagrave per il 1050 aC circa e pertanto laquoritenere che i mercanti greci di Al Mina recependo lrsquoalfabeto abbiano ostinatamente tralasciato di rifornirsi di materia scrittoria (oltre al cuoio anche il papiro) contraddice ogni criterio di verosimiglianzaraquo (Latacz) E Omero stesso in Iliade VI 168 s menziona una tavoletta pieghevole (ἐν πίνακι πυκτῷ) verosimilmente lignea con la superficie interna spalmata di cera_ ed Erodoto (V 58 3) ricorda che anticamente gli Ioni scrivevano su cuoio ricavato da pelli di capra o di pecora (διφθέρῃσι αἰγέῃσί τε καὶ οἰέῃσι) La scrittura egrave oggi documentata a partire dal 770 circa aC periodo a cui risale lrsquoΕΥΟΙΝ (il grido bacchico attestato altrove nella forma εὐοῖ o εὐάν) graffito su un vaso di produzione locale rinvenuto nella necropoli etrusca di Gabii mentre del 740730 egrave il graffito ateniese su una oinochoe del Dipylon che riproduce lrsquoesametro
ὃς νῦν ὀρχηστῶν πάντων ἀταλώτατα παίζῃ Chi fra tutti i ballerini danzeragrave con piugrave eleganza
e del 730720 lrsquoiscrizione retrograda su una kotyle di Pitecusa (Ischia) che menziona la coppa di Nestore e che appare disposta su tre righe di cui la seconda e la terza rappresentano sequenze esametriche (ma una piugrave antica iscrizione di Ischia di cui resta la sequenza ]ΜΙΜΑΛΟΝ | ] ΟΣ ΕΜΙ risale al 740 circa Quanto alla modalitagrave della trascrizione lrsquoipotesi di Lord secondo cui Iliade e Odissea avrebbero assunto forma scritta come laquotesti orali dettatiraquo egrave forse quella che meglio puograve dar conto sia delle tracce di autentica oralitagrave incapsulate nei poemi sia della precoce cristallizzazione del testo Giagrave gli antichi del resto avevano immaginato secondo la testimonianza della Vita Herodotea sect 15 s che a Focea un certo Testoride avesse trascritto i brani che Omero andava recitando nei ritrovi cittadini Ci si egrave anche interrogati sulle motivazioni capaci di determinare lrsquoimpulso a una cosigrave ambiziosa operazione Si egrave immaginato che chi promosse una tale iniziativa fosse a conoscenza dellrsquoepica scritta orientale e fosse fornito di tempo e risorse e dunque si muovesse nellrsquoambito di corti principesche o aristocratiche aperte a significativi contatti commerciali (Janko) Ma forse il primo impulso fu lo stesso che avrebbe in seguito determinato lrsquointroduzione della lsquoregola panatenaicarsquo e cioegrave la necessitagrave di collegare gli interventi dei singoli cantori lungo la traccia di una stessa storia Se come ricordavamo la prassi della recitazione in serie sembra giagrave presupposta in Iliade IX 189-91 allora poteacute essere allrsquointerno di una corporazione di rapsodi diretta da una grande personalitagrave di poeta che prese corpo il progetto di raccordare e trascrivere le singole sequenze effettivamente recitate nei palazzi di principi e nobili o nelle grandi e piccole feste della Ionia Disporre di un lsquocopionersquo avrebbe offerto il vantaggio nei confronti di altre gilde in concorrenza di produrre una linea narrativa insieme piugrave salda e piugrave sofisticata_ La giagrave ricordata iscrizione retrograda sulla kotyle di Ischia conservata nel Museo di Lacco Ameno presenta una divisione non solo in versi ma altresigrave nellrsquoambito dei due esametri in cola ritmici (vv 2 s)
ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι ποτηρί[ου] αὐτίκα κεῖνον ἵμερ[ος αἱρή]σει καλλιστε[φάν]ου [Ἀφροδίτης Ma chi beve da questa coppa subito lo prenderagrave desiderio di Afrodite dalla bella corona
In entrambi i versi i dicola (i due punti allineati verticalmente) tripartiscono lrsquoesametro isolando a sinistra lrsquohemiepes (lsquofemminilersquo nel primo verso ὃς δ᾽ ἂν τοῦδε π[ίη]σι rsquomaschilersquo nel secondo ἵμερ[ος αἱρή]σει) a destra il segmento terminale del verso (rispettivamente lrsquoadonio αὐτίκα κεῖνον e lo ionico a minore Ἀφροδίτης) e dunque parrebbero introdotti per garantire la corretta esecuzione ritmica della coppia di versi Questo assetto lsquoeditorialersquo presuppone nello scriba di Ischia lrsquoacquisizione giagrave negli ultimi decenni dellrsquoVIII secolo aC di una collaudata prassi scrittoria legata alla recitazione e dunque a procedimenti elaborati allrsquointerno di una cerchia rapsodica Se allora allarghiamo il senso del nome laquoOmeroraquo analogamente a come si usa fare per i grandi maestri della pittura medievale fino a comprendere i suoi adepti e discepoli puograve apparire plausibile lrsquoipotesi di una costruzione monumentale gradualmente elaborata in
Letteratura greca [1]
48
quotidiana simbiosi entro una determinata consorteria rapsodica grazie a una serie di sempre meno provvisori e sempre piugrave estesi tentativi condotti con lrsquoausilio della scrittura