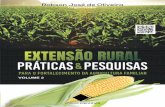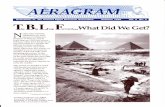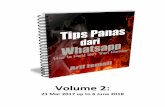Etnografie Amazzoniche volume 2
Transcript of Etnografie Amazzoniche volume 2
1
Paride Bolletin
Etnografie Amazzoniche
volume 2
BOLLETTIN_Libro Etnografie Amazzoniche vol. 2.indd 1 17/01/2012 13.26.21
2
Prima edizione: febbraio 2012
ISBN 978 88 6129 xxx x
© 2012 by CLEUP sc“Coop. Libraria Editrice Università di Padova”via G. Belzoni 118/3 – Padova (tel. 049 8753496)www.cleup.it
Tutti i diritti di traduzione, riproduzione e adattamento,totale o parziale, con qualsiasi mezzo (comprese le copie fotostatiche e i microfilm) sono riservati.
In copertina: ?????????????????????
BOLLETTIN_Libro Etnografie Amazzoniche vol. 2.indd 2 17/01/2012 13.26.21
Indice 3
Indice
Prefazione 5di Paride Bollettin, Umberto Mondini
Introduzione. Riflessioni sull’indianità 7di Paride Bollettin
1 | Proprietà e commercio di persone e piante nella Guyana Amazzonica 17 di Marc Brightman
2 | Tra nemici e bambini. Note di una ricerca in corso sul comando kalapao (Alto Xingu, Mato Grosso, Brasile) 25 di Antonio Roberto Guerreiro Júnior
3 | Relazione di una ricerca sulla salute indigena nell’alto Xingu (Mato Grosso, Brasile) 45 di Marina Pereira Novo
4 | Residui di pajelança tariano nell’abitato Branquinho, lungo il fiume Tarumã, alla periferia urbana di Manaus 61 di João Bosco Botelho, Valéria Augusta C.M. Weigel
5 | La formazione del Movimento Indigeno nel Rio Negro: prospettive di costruzione della democrazia e del dialogo interculturale in Amazzonia 73 di Sidnei Peres
6 | Missioni fondamentaliste ed etnocidio: il caso Novas Tribus e gli zo’e 89 di Thais Colaço, Antonio Jose Guimarães Brito
BOLLETTIN_Libro Etnografie Amazzoniche vol. 2.indd 3 17/01/2012 13.26.21
Indice4
7 | Professori(esse) indigeni mura. Tra pratiche di insegnamento, processi di formazione e strategie di resistenza 95 di Ana Alcídia de Araújo Moraes, Elciclei Faria dos Santos,
Rosa Helena Dias da Silva
8 | Guerra e Scambio: il caso mebengokré 111 di Clarice Cohn
9 | Umanità e trasformabilità nell’Amazzonia settentrionale 135 di Vanessa Elisa Grotti
10 | Essere umani: riflessioni sull’animismo tra gli indigeni dell’Amazzonia 143 di Elisa Galli
Bibliografia 163
BOLLETTIN_Libro Etnografie Amazzoniche vol. 2.indd 4 17/01/2012 13.26.21
Prefazione 5
Questo volume è il frutto della Tavola Rotonda “Amazzonia Indigena: 2010, stato attuale della ricerca sul campo” che è stata realizzata nel maggio del 2010 presso il Dipartimento di Studi Storico Religiosi della Sapienza, Università di Roma, nell’am-bito del XXXII Convegno Internazionale di Americanistica, organizzato dal Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”. Ringraziamo entrambe le Istituzioni per l’appoggio dato alla realizzazione sia dell’evento che del presente volume.
Questo, inoltre, vuole dare una continuità al lavoro di divulgazione in Italia di alcune tra le più recenti ricerche condotte in Amazzonia tra le popolazioni indigene, nella convinzione che da ciò possa risultarne sia uno stimolo per un approfondi-mento maggiore nel nostro paese di questo campo di indagine etnografica ed antro-pologica, quanto per un dialogo che negli anni si sta concretizzando e estendendo in maniera significativa, coinvolgendo ricercatori di diversi paesi. Questo volume, quindi, non vuole dirigersi solamente ad un pubblico di specialisti, ma più in generale vuole proporre originali ricerche che stimoleranno sicuramente l’interesse di tutti color che portano avanti ricerche in ambito antropologico, per la densità e la varietà dei contributi.
In questa prefazione, però non verranno presentati i singoli contributi, dato che ciò avverrà nel corso della successiva introduzione, una scelta motivata dal fatto che essa rappresenta una sorta di “cornice” che permette di contestualizzarli all’interno di un più ampio panorama del dibattito attuale sulle popolazioni amazzoniche. A queste per concludere, va il nostro ringraziamento più sentito, dato che sono loro le vere protagoniste di questo volume.
Prefazionedi Paride Bollettin, Umberto Mondini
BOLLETTIN_Libro Etnografie Amazzoniche vol. 2.indd 5 17/01/2012 13.26.21
Paride Bollettin, Umberto Mondini6
BOLLETTIN_Libro Etnografie Amazzoniche vol. 2.indd 6 17/01/2012 13.26.21
Introduzione. Riflessioni sull’indianità 7
IntroduzioneRiflessioni sull’indianitàdi Paride Bollettin
Ciò che voglio presentare in questa breve introduzione è una riflessione su alcune maniere di concepire l’“indianità”, ossia sulla maniera in cui le popolazioni amaz-zoniche vengono presentate nelle etnografie. Ovviamente, il tema appare talmen-te vasto che la pretesa di analizzare le specifiche posizioni di ogni antropologo nel suo specifico contesto etnografico risulta assolutamente improbabile per un testo di queste dimensioni (e forse anche per un intero volume). Ad ogni modo, credo che sia possibile individuare alcune prospettive generali che permettono di porre alcuni confini teorici, o quanto meno di accenti diversi. Un’altra precisazione che ritengo necessaria fin da subito è che affronterò principalmente il dibattito in e sull’Amazzo-nia brasiliana, non solo perché centrale per contestualizzare il presente volume, oltre che per la sua prossimità con il terreno della mia ricerca, ma anche perché ritengo che le questioni che emergono da tale dibattito siano utilizzabili anche negli altri contesti1. Per introdurre il tema credo sia utile però cominciare da una esperienza personale, che è avventa quando stavo giungendo per la prima volta in un’Area Indigena e pre-cisamente nell’Area Indigena Trincheira Bakajá, nel Brasile centrale, dove vive un gruppo mebengokré-xikrin.
Nel momento del mio primo arrivo a Mrõtidjam, con il mio bagaglio di aspettative e immaginario, pensavo che mi sarei trovato di fronte una comunità “isolata”, impe-gnata a realizzare rituali esotici e spaesanti. Appena sbarcai dalla canoa a motore sulla sponda del fiume di fronte al villaggio, venni subito colpito dalla numerosa presenza
1 Credo valga la pena di evidenziare il fatto che già il riferimento ad una area geografica attraverso l’utilizzo della nozione di Stato (in questo caso il Brasile) implica il riconoscere l’influenza della società predominante la quale però deve essere collocata all’interno di un insieme di linee di forza che contri-buiscono a significare ogni specifico contesto indigeno. Di conseguenza, il riferimento privilegiato al contesto brasiliano non significa automaticamente il riconoscimento che questo sia diverso, dal punto di vista “indigeno” dagli altri, perché, come emergerà in seguito, le situazioni locali vengono significate inevitabilmente a partire dagli idiomi locali e quindi lo Stato potrebbe anche essere un altro di quelli che occupano il bacino amazzonico.
BOLLETTIN_Libro Etnografie Amazzoniche vol. 2.indd 7 17/01/2012 13.26.21
Paride Bollettin8
di donne e bambini ad osservare l’arrivo di Bepkro, il mio ospite, della sua famiglia e il mio, incuriosendomi però per lo scarso numero di uomini. Seguendo il consiglio di Bepkro, chiesi di poter parlare con Bepeti, che il mio ospite mi aveva indicato come il benadjure, il “capo”. Subito alcuni ragazzini mi corsero incontro ridacchiando e in-dicandomi che dovevo risalire la sponda, i movimenti delle loro mani sostituivano le parole per me ancora incomprensibili che mi rivolgevano. Senza sapere però che fare, rimanevo fermo vicino alla canoa guardandomi attorno, senza poter fare a meno di notare come fossi improvvisamente divenuto il centro dell’attenzione. I ragazzini al-lora presero il mio bagaglio materiale, il mio zaino e la cassa dove avevo riposto i doni da consegnare al benadjure, senza che avessi il tempo di obiettare nulla. Di fronte alla mia esitazione mi si approssimò un ragazzo che mi disse, parlando in portoghese, che li avrebbero portati alla casa di Bepeti, dove sarebbero stati custoditi. Aggiunse poi di seguirlo per incontrare il benadjure. Lo seguii allora lungo la salita che portava dal fiume all’abitato, sempre attorniato da bambini curiosi che mentre chiaccheravano tra loro provavano anche a rivolgermi la parola, senza però che riuscissi a rispondere. Una volta giunti più in alto vidi, con grande stupore, che gli uomini erano impegnati in una attività che avrei poi scoperto essere ususale: una partita di calcio.
Il mio stupore in quel momento però fu particolarmente forte, dato che il mio carico di letture e di informazioni mi portava a pensare gli “indigeni” attraverso uno sguardo mediato da un immaginario esoticizzante che in quel momento veniva mi-nato radicalmente alla base. Quando raggiungemmo il campo, venni invitato dal mio accompagnatore a sedermi accanto ad alcuni anziani che osservavano la partita com-mentando le varie azioni giocate, probabilmente anche più esperti conoscitori del gioco di me. Dopo circa mezz’ora terminò la partita ed ecco che un uomo di circa trentacinque anni mi si avvicina con volto sorridente. Il corpo era dipinto dalla tinta a righe orizzontali che potevo vedere anche su altri suoi compagni di squadra, i capelli erano tagliati più corti lungo il centro della testa, scendono lunghi sulle spalle late-ralmente. Più o meno della stessa altezza, ci avvicinammo ed allora io mi presentai, spiegando chi ero, ma egli mi interruppe quasi subito, dicendomi che avrei dovuto dirlo dopo a tutti, e mi invitò a seguirlo alla sua abitazione, dove gli consegnai i regali che avevo portato e recuperai il mio zaino, prima di allontanarmi per raggiungere nuovamente Bepkro.
Questo breve racconto permette di comprendere in maniera chiara come ciò che viene veicolato attraverso l’uso del termine “indigeno” sia in realtà una molteplicità variegata e sfumata di accezioni che non sono neutre ma definite attraverso specifici e determinati quadri teorici. Penso sia importante chiarire, di conseguenza, in che accezione tale nozione sia una definizione utile come categoria euristica e come stru-mento di analisi. Assumiamo, così, che “indigeno” è:
“qualsiasi membro di una comunità indigena, riconosciuto da essa come tale. «Comunità indigena» è ogni comunità fondata nelle relazione di parentela o vicinanza tra i propri
BOLLETTIN_Libro Etnografie Amazzoniche vol. 2.indd 8 17/01/2012 13.26.21
Introduzione. Riflessioni sull’indianità 9
membri, che mantengono dei vincoli storico-culturali con le organizzazioni indigene pre-colombiane” (Viveiros de Castro, 2008: 132).
Questa definizione, continuando il ragionamento dell’autore, comporta alcune importanti conseguenze, perché pensare cosa significano espressioni quali “parentela o vicinanza” o “legami storico-culturali con le società precolombiane”, comporta “una dimensione mezza delirante o allucinatoria, come del resto ogni discussione in cui l’ontologico ed il giuridico entrano in un processo di pubblica unione” (Idem.: 134). Ossia tale problematica sorge nel momento in cui si cerca di reificare la nozione di “indianità”, per poterla definire e collocare all’interno di specifiche e determinate norme giuridiche, finalizzate prima alla “emancipazione” o “civilizzazione” degli “in-digeni, e successivamente ad una politica “tutelare” nei loro confronti. Ma andiamo con ordine, penso che sia utile partire dal fatto che all’interno della tradizione di studi sul Brasile indigeno si sono venute configurando principalmente due moda-lità di porsi di fronte a tale questione: una che vede gli “indigeni” come situati in Brasile, e l’altra che li vede come parte di esso (Peirano in Viveiros de Castro, 1992: 193). Vediamo un momento questa seconda posizione. Essa sorge a partire dalla constatazione che esistono differenze notevoli di potere nelle relazioni tra lo Stato, la società “envolvente”2 e le comunità “indigene”. La sua elaborazione ha portato alla definizione di concetti quali quello di “trasfigurazione etnica” (transfiguração étnica), intesa come:
“tutta la gamma di fenomeni ecologici, biotici, economici, sociali, culturali e psicologici derivanti dalla congiunzione interetnica (...) il processo attraverso il quale le popolazioni tribali che si confrontano con le società nazionali presentano i requisiti necessari alla loro persistenza come entità etniche, attraverso la successive alterazioni del loro sostrato biolo-gico, della loro cultura e delle loro forme di relazione con la società envolvente” (Ribeiro, 1979: 13).
O quello di “frizione interetnica” (fricção interétnica), la quale risulterebbe utile nell’analizzare la relazione tra “indigeni e “non indigeni” perché
“non si tratta di relazioni tra entità contrarie, semplicemente differenti o esotiche, le une in relazione alle altre; ma «contraddittorie», ossia, la cui esistenza tende a negare quella
2 La società envolvente è la società brasiliana che avanza sui territori amazzonici, ma non solo. Tale espres-sione potrebbe essere tradotta con società “avanzante”, “circondante”, “abbracciante”, o più sempli-cemente “nazionale”, ma preferisco utilizzare il termine portoghese, sia perché generalmente utilizzato nella letteratura amazzonista, ma anche perché rimette ad una specifica modalità relazionale tra le popo-lazioni indigene e i non indigeni, che spesso si caratterizza per un vero e proprio processo di “abbraccio” del territorio indigeno da parte della frontiera che avanza e che si connota come un “coinvolgimento” (traduzione letterale del termine “envolver”) del gruppo indigeno nella società non indigena.
BOLLETTIN_Libro Etnografie Amazzoniche vol. 2.indd 9 17/01/2012 13.26.21
Paride Bollettin10
dell’altra. (...) una «totalità sincretica» o, in altre parole, in quanto situazione di contatto tra due popolazioni dialetticamente «unificate» attraverso interessi diametralmente opposti, anche se interdipendenti, per quanto possa apparire paradossale” (Cardoso de Oliveira, 1996: 46-47).
Entrambe queste posizioni implicano la necessità di osservare le popolazioni “indigene” come inserite in un contesto di relazioni interetniche determinato dal-la dominanza dello Stato, e quindi inevitabilmente destinate all’assimilazione al suo interno, secondo la celebre partizione tra “indigeni isolati”, “indigeni in contatto intermittente” e “indigeni integrati”, i quali smetterebbero a questo punto di essere “indigeni”. Le vicende degli ultimi anni, però, hanno dimostrato che un tale processo pensato come lineare di perdita di una supposta “indianità” oggettivabile in carat-teristiche evidenti e definibili, ossia da una supposta condizione originale verso una progressiva integrazione nello Stato nazione, non ha avuto luogo, lasciando spazio a ibridizzazioni e ridefinizioni che hanno assunto una particolare rilevanza nel corso degli ultimi decenni3.
La questione della definizione di chi è o non è “indigeno” sorge, quindi, come una necessità politica nel momento in cui emerge la necessità di definire legalmente quando una comunità può dirsi “indigena” e quindi rivendicare i diritti che le vengo-no riconosciuti dallo stato brasiliano, quali il diritto all'educazione ed alla sanità4. La necessità di definire una “indianità” che possa essere constata oggettivamente deriva, infatti, direttamente dal fatto che gli antropologi in Brasile hanno a volte il ruolo di “giudici” dell'“indianità”, ossia si trovano chiamati a constatare se una comunità, un gruppo, una collettività, che si dichiara “indigena” sia effettivamente tale. Ma ciò fa sì che diviene indispensabile dover necessariamente reificare una “indianità” attraverso specifiche caratteristiche osservabili e identificabili, in maniera tale non da poter dire chi è indigeno, ma chi ha smesso di esserlo (Viveiros de Castro, 2008: 134-139).
Una alternativa a questa prospettiva è costituita dall'osservare queste collettività come situate all’interno del Brasile, ossia “se qualcosa è parte di qualcosa, per me è «il Brasile» che è parte del contesto in cui si trovano i gruppi indigeni” (Viveiros de Castro, 1992: 193). In questo modo emerge una nuova maniera di pensare all’“in-digeno”, che permette di porre in risalto il fatto che la mutevolezza di espressione “culturale” delle collettività che si riconoscono come “indigene” deve essere assunta come una caratteristica intrinseca del processo di costante ridefinizione di queste
3 Come dimostrano le numerose esperienze delle cosiddette “comunità risorte”, ossia quei collettivi che hanno rivendicato una appartenenza etnica “indigena” nonostante fino a poco prima non se la ricono-scessero (cfr., tra i vari lavori sul tema, Pacheco de Oliveira, 1998;; Athias, 2007;; Beserra Coelho, 2008;; Lenzi Grillini, 2010).4 La Costituzione Federale del Brasile prevede infatti specifici capitoli ed articoli che definiscono i diritti della comunità indigene riconosciute come tali, questa questione la affronterò in maniera più approfon-dita in seguito.
BOLLETTIN_Libro Etnografie Amazzoniche vol. 2.indd 10 17/01/2012 13.26.21
Introduzione. Riflessioni sull’indianità 11
stesse collettività. Ma ciò che più mi sembra rilevante è che considerare gli “indigeni” come categoria assoluta rischia di lasciare in secondo piano un aspetto che ritengo di estrema importanza: essa deriva direttamente da uno sguardo che tende a rendere secondarie le specificità di ognuna di queste comunità, così, a mio avviso, definire gli “indigeni” comporta dimenticare che esistono kayapó, yanomami, xavante, ecc., ed anche delle soggettività5. Inoltre considerare gli “indigeni” come soggetti che ven-gono identificati in base a determinate caratteristiche che essi presenterebbero in maniera “naturale”, rischia di far perdere il carattere relazionale di “invenzione” re-ciproca di significati cui accennavo più sopra. Ovvio che questo non significa che non esistano comunità che derivano direttamente da un fondo precolombiano, che presentano
“uno stato di spirito. Un modo di essere e non di apparire. In realtà, qualcosa di più (o di meno) che un modo di essere: l'indianità designava secondo noi un certo modo di diveni-re, qualcosa di essenzialmente invisibile ma non per questo meno efficace: un movimento infinitesimale di differenziazione, non uno stato massimale di «differenza» precedente e stabile, cioè una identità” (Viveiros de Castro, 2008: 137, corsivo dell’autore).
Di conseguenza, se da un lato il concetto di “indianità” non deve essere visto come qualcosa di reificabile ed oggettivabile, dall’altro non deve far passare in se-condo piano le differenze tra le comunità specifiche e tra i gruppi e gli individui. Ma soprattutto, come detto, l’“indianità” deve essere intesa come un movimento costan-te di costruzione di differenziazione che permette ai membri di queste comunità di “essere” differenti dai membri della comunità nazionale, nel senso che permette loro di rendere effettivo un costante movimento di ridefinizione e significazione della realtà che li circonda che, come dirò nel corso di questo lavoro, costituisce un tratto saliente di un costante processo di creazione di differenza corrispondente alla cre-azione dell’identità6. Ma questo non è tutto: “il fatto rilevante è che questi indigeni sono situati in Brasile per un caso” (Peirano, 2008: 59, corsivo dell’autrice, traduzione mia)7, perché se la ricerca segue la linea prima indicata, ossia quella di identificare i processi attraverso cui queste comunità attribuiscono significati a se stessi e al mondo
5 Ritengo importante questo aspetto, perché, come dirò in seguito, all’analizzare il movimento di di-slocamento e costante ridefinizione delle “frontiere” tra “indigeni” e “non indigeni” da parte dei me-bengokré, ciò che emerge è come si tratti di una categoria che, nonostante venga utilizzata dal gruppo stesso, presenta una variabilità tale e contestualizzata che implica che debba essere ridefinita a seconda del momento in cui essi la utilizzano.6 Tale necessità di “invenzione” di un “altro” da cui ottener elementi necessari a definire il proprio “io” rappresenta un aspetto al centro della riflessione antropologica sulle popolazioni delle Terre Basse su-damericane negli ultimi anni, in questo momento non ritengo necessario presentarne le riflessioni e le differenti posizioni teoriche, dato che esse saranno presentate nel corso di questo lavoro.7 “The relevant fact is that these indigenous groups are situated in Brazil as a matter of chance”.
BOLLETTIN_Libro Etnografie Amazzoniche vol. 2.indd 11 17/01/2012 13.26.21
Paride Bollettin12
che li circonda, allora diviene necessario inserire l’“alterità” costituita dallo Stato e dalla popolazione brasiliana (e non) accanto ad altre forme di “alterità” che vengono riconosciute dai membri della comunità specifica attraverso specifiche modalità di relazione che da essi vengono poste in essere.
Questa diversa modalità di concepire l’“indianità” si riflette nella produzione an-tropologica in e sulle popolazioni “indigene” dell’Amazzonia fin dall’inizio, affian-candosi ad altre, quali tupi o jê, organizzazione sociale o cosmologia, Amazzonia e Brasile centrale o Xingu, storia o etnografia, economia politica o descrizione co-smologica, ecc. La prospettiva di differenziare le società in macro gruppi socio-cul-turalmente affini indubbiamente permette di effettuare comparazioni tra società che appaiono presentare caratteristiche simili, allo stesso tempo però deve tenere presen-te le differenti modalità di significazione del reale e delle esperienze da parte di ogni gruppo e dentro i gruppi stessi. Detto altrimenti, possiamo identificare i mebengo-kré come appartenenti alla famiglia linguistica macro-jê, in quanto condividono con altre società indigene determinate caratteristiche, quali l’organizzazione spaziale del villaggio, l’enfasi sulla costruzione del corpo dei soggetti come elemento distintivo e umanizzante, l’utilizzo di determinati rituali, ecc., ed è possibile, quindi, rinvenire un sostrato che accomuna una determinata quantità di società all’interno di una “fami-glia”. Allo stesso tempo però, dobbiamo considerare le peculiari modalità attraverso cui essi interagiscono con il “mondo esterno”8, ossia diviene necessario contestualiz-zare tale condivisione di elementi all'interno di una specifica condizione contingente. Come dirò infatti in seguito, è nella modalità di relazione specifica e momentanea con l'esterno che si crea il movimento di differenziazione che permette di attribuire significati all'interno ed all'esterno, attraverso il costante processo di riattualizzazione di uno specifico “modo di essere mebengokré”. Questo non significa assolutamente che io non voglia utilizzare le categorizzazione in “famiglie” o “gruppi” linguistici, perché, come emergerà nel corso del testo, essa costituisce un importante strumento per far emergere rapporti tra società altrimenti poco identificabili. In questo senso, categorizzando specifiche società all'interno di gruppi più ampi se ne possono far emergere i tratti comuni, soprattutto in contrapposizione ad altre più distanti dal punto di vista della organizzazione socio-culturale, ma è necessario farlo in maniera critica.
Queste diverse maniere di concepire l'indianità sono rintracciabili anche nei con-tributi raccolti in questo volume, evidenziando così la necessità di interrogarsi criti-camente a riguardo dell'idea di indianità, con le conseguenze sul piano tanto teorico quanto etnografico, dalla quale i diversi autori prendono le mosse. Non credo sia però utile dare un'etichetta ai vari autori, già che le posizioni, come sempre accade,
8 In questa, vaga, definizione voglio racchiudere, per adesso ed in attesa di esplicitarne le cromaticità intrinseche, cioè le diversità di “mondi” che vi rientrano, la molteplice “alterità” che i mebengokré spe-rimentano nella loro quotidianità.
BOLLETTIN_Libro Etnografie Amazzoniche vol. 2.indd 12 17/01/2012 13.26.21
Introduzione. Riflessioni sull’indianità 13
non sono bianche o nere, ma sempre grigie, delineando così originali fusioni e rilet-ture, influenze e proposte.
L'articolo di Marc Brightman, intitolato Proprietà e commercio di persone e pian-te nella Guyana Amazzonica, affronta in una brillante analisi l’ingresso dei trio del Suriname del Sud nell’economia di mercato, attraverso diversi canali, tra i quali vi sono la domanda di “carne di foresta”, di animali vivi e di conoscenze botaniche. Avanzando l’ipotesi che le attività di caccia, raccolta e agricoltura praticate dai trio stabiliscano una relazione sociale con individui non-umani che deve essere intesa all’interno del concetto nativo di proprietà, il quale costituisce una relazione politica di ineguaglianza che localmente rappresenta il fulcro dei processi sociali, egli descrive i rapporti tra questa comunità e una Ong che vorrebbe promuovere la valorizzazione dei prodotti e dei saperi trio.
Nel suo contributo, Tra nemici e bambini. Note di una ricerca in corso sul coman-do kalapao (Alto Xingu, Mato Grosso, Brasile), Antonio Roberto Guerreiro Júnior si interroga sul significato ed il valore del comando tra i kalapalo. Partendo da una revisione della letteratura disponibile sul tema, cui critica una visione eccessivamente legata ad una lettura mediata dal concetto di “economia politica”, egli propone una rilettura dei processi locali del fare e riconoscere capi, sottolineando come questa condizione debba essere vista più come in relazione con l’esterno che non con l’in-terno del villaggio.
Il capitolo intitolato Relazione di una ricerca sulla salute indigena nell’alto Xingu – Mato Grosso – Brasile, di Marina Pereira Novo, propone una riflessione che si snoda in due direzioni. Inizialmente, l’autrice focalizza le negoziazioni e le ridefinizioni della sua specifica esperienza di ricerca sul campo nel Parque Indígena do Xingu, per pro-seguire poi analizzando i dati etnografici raccolti nella direzione di una comprensione del processo di mediazione tra i sistemi sanitari indigeni ed occidentali. Per questo lavoro di mediazione risulta fondamentale la figura degli Agentes Indígenas de Saúde, che sono incaricati dei servizi sanitari di base nei villaggi.
Il testo successivo, Residui di pajelança tariano nell’abitato Branquinho, lungo il fiume Tarumã, alla periferia urbana di Manaus, di João Bosco Botelho e Valéria Augusta Weigel, riprende il tema della malattia, affrontandolo però in una prospet-tiva che pone la propria enfasi sul pajé. Prendendo spunto dalla situazione attuale del gruppo tariano che abita vicino alla città di Manaus, i due autori ricostruiscono l’immagine che emerge dalla letteratura coloniale e contemporanea di questa figura centrale dell’organizzazione socioculturale degli indigeni amazzonici.
Il capitolo intitolato La formazione del Movimento Indigeno nel Rio Negro: pro-spettive di costruzione della democrazia e del dialogo interculturale in Amazzonia, scritto da Sidnei Clemente Peres, presenta una rilettura dell’origine del fiorire dell’as-sociazionismo indigeno nella regione del Rio Negro. Attraverso un’analisi degli svi-luppi dello stesso, un minuzioso e dettagliato percorso di ricomposizione dei diversi momenti, una presentazione dei differenti attori coinvolti e una lettura originale degli
BOLLETTIN_Libro Etnografie Amazzoniche vol. 2.indd 13 17/01/2012 13.26.21
Paride Bollettin14
avvenimenti e delle interpretazioni degli stessi, l’autore legge in questa fioritura il risultato, involontario, ma non per questo meno importante, della prassi missionaria salesiana nella regione.
Nel sesto capitolo, Missioni fondamentaliste ed etnocidio: il caso Novas Tribus e gli zo’e di Thais Colaço e Antonio Jose Guimarães Brito, gli autori rileggono l’azione delle missioni fondamentaliste protestanti Novas Tribus, ed in particolare la loro presenza tra gli zo’e, alla luce dello strumento giuridico dell’etnocidio. Presentando in maniera chiara il concetto e legandolo all’attività dei missionari i due giungono alla conclusione che queste attività effettivamente rappresentano una forma di sterminio culturale di questo popolo.
Il contributo successivo, Professori(esse) indigeni mura. Tra pratiche di insegna-mento, processi di formazione e strategie di resistenza, di Ana Alcídia de Araújo Moraes, Elciclei Faria dos Santos e Rosa Helena Dias da Silva, sposta l’attenzione verso un altro aspetto della relazione con la società nazionale: le politiche educative. In particolare, esso si concentra su di un progetto di formazione differenziata per gli indigeni mura portato avanti dall’Universidade Federal do Amazonas, che, nella ricostruzione degli autori, ha permesso una nuova esperienza della scuola sia per gli alunni che per gli stessi professori, modificando la stessa percezione dell’identità indigena.
Il capitolo di Clarice Cohn, Guerra e Scambio: il caso mebengokré, propone una rilettura della guerra nel contesto etnografico del Brasile centrale. Per contrasto con la realtà tupi, dove ad essa veniva riconosciuto un valore “produttivo”, la guerra in questa contesto etnografico, ed in particolare tra i gruppi kayapó era sempre stata vista come “distruttiva”. L’autrice dimostra, al contrario che essa risponde ad una finalità di mettere in relazione il Noi con gli Altri, allo stesso modo dello scambio e di altre modalità relazionali. Attraverso una raffinata indagine, l’autrice dimostra come la guerra sia caratterizzata da una importante funzione “produttiva” tra i me-bengokré, perché serve per creare Altri, senza i quali non sarebbe possibile creare i Noi.
Il seguente, Umanità e trasformabilità nell’Amazzonia settentrionale, di Vanes-sa Elisa Grotti, indaga un tema di grande importanza negli studi dedicati ai popoli amazzonici: il concetto di “umanità”. In particolare, la sua indagine, che prende le mosse dal contesto etnografico delle Guiane, si sofferma sulle diverse visioni di que-sta “umanità” in relazione alle altre “persone” che abitano il mondo, sui processi di formazione della corporalità che contraddistingue tale “umanità”, per evidenziare come sia necessario pensare a questa caratteristica come ad un attributo corporale.
Nell’ultimo testo, infine, Essere umani: riflessioni sull’animismo tra gli indigeni dell’Amazzonia, Elisa Galli riprende questo tema a partire dalla sua etnografia con i runa dell’Ecuador. L’autrice presenta inizialmente una panoramica di alcune posi-zioni teoriche a riguardo della condizione di “umanità”, analizzando concetti quali quelli di animismo, punto di vista, multinaturalismo, che permeano il dibattito attuale,
BOLLETTIN_Libro Etnografie Amazzoniche vol. 2.indd 14 17/01/2012 13.26.21
Introduzione. Riflessioni sull’indianità 15
per poi concentrarsi sul corpo ed i processi di costuzione di questo, soprattutto nel rapporto con l’Alterità.
Ciò che credo emerga anche da questi testi qui raccolti è che i temi affrontati (le relazioni interetniche o l’idea di possesso o di comando, la sanità, l’educazione la religiosità o la guerra, l’idea di umanità, ecc.) non sono temi neutri. Il tema inevitabil-mente influenza l’approccio, e viceversa (del resto non potrebbe essere altrimenti). In ogni caso, credo che analizzare i presupposti dell’approccio di ogni singolo autore, le basi della sua riflessione, sia un utile esercizio non solamente per leggere in maniera approfondita il lavoro di chi ha contribuito a questo volume, ma soprattutto una proficua maniera di incentivare una riflessione sulle possibilità di dialogo tra questi lavori. Alla fin fine, che il nostro interesse si focalizzi più su un aspetto o su un altro, che l’accento della nostra riflessione sia posto di preferenza su un punto di vista o un altro, credo sia più importante ricordare che sono gli stessi “indigeni” coloro che ci porteranno verso una direzione o un’altra, all’interno della relazione che si instaura durante la ricerca. Ciò perché:
“Lo studio della cultura è la cultura, (...) Lo studio della cultura è in realtà la nostra cultura: funziona con i nostri schemi, crea nei nostri modi, prende a prestito le nostre parole e i nostri concetti per conferire i suoi significati, e ricrea noi stessi attraverso i nostri sforzi” (Wagner, 1992 [1975]: 30-31, corsivo dell’autore).
In questo senso, comprendere le diverse posizioni teoriche permette di compren-dere ciò che viene negoziato nel momento della ricerca, l’approccio con cui si pensa l’indianità contribuirà a definire poi il risultato dell’indagine, tanto quanto l’esperienza etnografica. Risulta quindi chiaro che è importante osservare contemporaneamen-te l’esperienza che emerge dall’etnografia così come il posizionarsi, talvolta chiaro, talvolta più sfumato, degli autori all’interno di una serie di coordinate teoriche che disegnano molteplici assi.
BOLLETTIN_Libro Etnografie Amazzoniche vol. 2.indd 15 17/01/2012 13.26.21