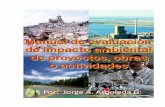Desiderio re, la regina Ansa e l'epigrafe dedicatoria di Santa Giulia di Brescia
Transcript of Desiderio re, la regina Ansa e l'epigrafe dedicatoria di Santa Giulia di Brescia
SAP SOCIETà ARCHEOLOGICA
Dalla corte regia al monastero di San Salvatore - Santa Giulia
di Brescia
a cura di
Gian Pietro Brogiolo
con
Francesca Morandini
ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI DI BRESCIACOMUNE DI BRESCIA - CIVICI MUSEI D’ARTE E STORIA
REGIONE LOMBARDIA
Dall
a c
ort
e r
egia
al
mo
nast
ero
di
San
Salv
ato
re -
San
ta G
iuli
a d
i B
resc
ia
ISBN 978-88-87115-91-8
68,00 €
Santa Giulia copertina PROVA3 con marrone_Layout 1 25/07/14 09.25 Pagina 1
WO
RLD
HERITAGE PATRIMOIN
E M
ON
DIA
L
PATR
IMONIO MONDIALE
I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 dC.)iscritti nella Lista del patrimonio mondiale nel 2011
Organizzazionedelle Nazioni Unite
per l’Educazione,la Scienza e la Cultura
Gli studi e la realizzazione di questo volumefanno parte delle azioni previste nel Pianodi Gestione del sito UNESCO I Longobardiin Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 01/07/14 09.00 Pagina 2
Dalla corte regia al monastero di San Salvatore - Santa Giulia
di Brescia
a cura di
Gian Pietro Brogiolo
con
Francesca Morandini
testi di
F. Antonelli, g.P. Brogiolo, S. cAncelliere, A. cAnci,P. corSi, F. De ruBeiS, e. Fiorin, V. gherolDi,
M. iBSen, l. lAzzArini, B. leAl, J. Mitchell, F. MorAnDini, o. SAlVADori, r. StrADiotti,
S. StrAFellA, S. tonni
SAP Società ArcheologicA Srl
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 01/07/14 11.11 Pagina 1
ISBN: 978-88-87115-91-8© 2014 SAP Società Archeologica srl - www.archeologica.it
Redazione: F. Benetti, F. Franzoni, R. Stradiotti
Rilievi di scavo ed elaborazioni grafiche: R. Benedetti, A. Maifreni
Elaborazione immagini: P. Vedovetto
Consulenza iconografica: S. Baragli, P. Tabaglio
Fotografie: oltre agli Autori, Archivio Fotografico Musei Civici d’Arte e Storia di Brescia, M. Rapuzzi(Fotostudio Rapuzzi), P. Tabaglio (Comune di Brescia, Musei d’Arte e Storia)
In copertina: San Salvatore, affresco con la scritta “Regnantem Desiderium” (elaborazione grafica P. Vedovetto)
La responsabilità del materiale pubblicato (testi e immagini) si deve agli Autoridei singoli contributi.
Ai sensi della legge n. 633 del 22 aprile 1941, e del Decreto Legislativo n.68/2003, è permessa la riproduzione, soltanto per uso personale, di una partenon superiore al 15 % dell’opera.
è vietata la diffusione di singole parti dell’opera, anche per via digitale, senzaautorizzazione scritta dell’editore.
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 01/07/14 11.09 Pagina 2
DESiDEriO rE, lA rEGiNA ANSA E l’EPiGrAFE DEDiCAtOriADi SAN SAlVAtOrE A BrESCiA
Nel 1963 Gaetano Panazza, analizzando le vi-cende legate alle fasi architettoniche della chiesadi San Salvatore in Brescia, rilevava come “i carat-teri delle grandi scritte, a tinta chiara su fondoscuro, [...], si ispirino ad un tipo epigrafico deglianteriori decenni del regno longobardo ancor li-bero”1. le iscrizioni cui fa riferimento Panazza (oggiin pessimo stato di conservazione) corrono affre-scate sotto il registro inferiore nella parete nordnella navata centrale; la morfologia delle lettere haconsentito ad Ottavio Banti di riferire l’esecuzionedell’iscrizione picta al secolo Viii2.
Sulla parete opposta, sempre lungo il registroinferiore, corre una seconda fascia iscritta (cfr. Figg.1-2), lacunosa a destra e a sinistra, la cui leggibilitàè gravemente compromessa dalle numerose mar-tellinature e dalla perdita del pigmento originario3.
in un primo tempo, fino a Gaetano Panazza cheriferisce quanto suggeritogli da Bernhard Bischoff,la lettura offerta della fascia della parete sud si limi-tava al solo regnantem Desiderium4, tralasciando lerimanenti lettere a destra di Desiderium. Successi-vamente si giunse alla proposta di integrare il testoche corre a destra di Desiderium con Tiro Hlu, com-pletando la lacuna testuale con Hlu[dovicus] e otte-nendo regnantem Desiderium Tiro Hlu[dovicus]5.
l’ipotesi ricostruttiva del testo, con l’evocazionedi ludovico giovane imperatore, sottraeva così ilciclo di affreschi all’epoca desideriana e lo conse-gnava all’età carolingia, coerentemente con le se-quenze architettoniche proposte dallo stessoPanazza (la prima chiesa desideriana, la secondacarolingia).
le controversie relative alla sequenza architet-tonica e alla decorazione della struttura erano tut-
tavia ancora lontane dall’essere risolte6: dubbi circala corretta lettura del testo tràdito permanevano,tanto da indurre A. Weis e hj. torp a contestarnela restituzione testuale7.
Nel frattempo i risultati delle indagini archeolo-giche, condotte da Gian Pietro Brogiolo negli anniOttanta, portavano a una nuova definizione crono-logica delle fasi architettoniche di San Salvatore.
l’analisi stratigrafica del complesso proposta daBrogiolo ha evidenziato l’esistenza di un edificio,preesistente, assegnato in un primo tempo alla se-conda metà del secolo Vii e oggi collocato nellaprima metà del secolo Vii, le cui strutture vennerodemolite nel secolo successivo e su di esse erettala chiesa desideriana a tre navate8.
Così, quando nel 19969 è stato affrontato lo stu-dio delle iscrizioni pictae presenti nella navata cen-trale della chiesa stessa, il problema interpretativodel testo è stato nuovamente sollevato, proprio inrelazione alle più recenti datazioni proposte perSan Salvatore di Brescia.
Nel presente lavoro ci si limiterà al solo studiodelle iscrizioni ‘incriminate’, ossia a quelle epigrafiche, menzionando Desiderio e/o un presunto lu-dovico, potrebbero fare scorrere lungo il binariodel tempo la datazione dell’intera campagna deco-rativa di San Salvatore, portandola ora sulla pienaetà desideriana, ora spostandola fino a ludovico ii.
l’analisi autoptica effettuata da chi scrivemediante l’uso della lampada di Wood, sulla fasciadedicatoria nella parete sud, ha evidenziato comeil problema interpretativo dell’iscrizione non possae non debba essere solo limitato alla ‘decifrazione’di quella sequenza di segni sui quali si è fino a oraesercitata l’esegesi epigrafico-testuale, ma che si
1 PANAzzA 1963b, p. 458.2 BANti 1992, pp. 169-170. la lettura dell’iscrizione risultaallo stato attuale fortemente compromessa dall’irraggia-mento solare che ha colpito la parete. tale irraggiamentoha determinato la scomparsa del pigmento bianco utilizzatoper la stesura del testo dell’iscrizione. A documentare il testooriginario rimangono oggi le fotografie, in bianco e nero,che Gaetano Panazza fece eseguire intorno agli anni Ses-santa, attualmente conservate presso l’Archivio fotograficodei Civici Musei di Brescia.3 PErONi 1983a, p. 22, rileva la differente successione nellastesura dell’intonachino: nella parete nord esso appartienealla medesima fase del registro soprastante; nella parete op-posta sud l’intonachino pertiene al pennacchio.4 PANAzzA 1960b, p. 175.
5 PANAzzA 1962a, p. 95; PANAzzA 1963b, p. 458. 6 rinvio per un quadro riassuntivo complessivo a lOMArtirE2007.7 WEiS 1977, p. 19 e fig. 15; l’OrANGE, tOrP 1977-1979, ii, p.129; iii, p. 207. 8 BrOGiOlO 1992, p. 201 ss. (cui si rinvia anche per la biblio-grafia esaustiva sulle vicende interpretative delle strutturebresciane) propendeva per una datazione entro la secondametà del Vii secolo. la nuova datazione in BrOGiOlO, Ar-cheologia e architettura, in questo volume. 9 lo studio delle iscrizioni bresciane trae spunto dal censi-mento, coordinato dal CiSAM, dedicato alle iscrizioni alto-medievali italiane, per il progetto Inscriptiones Medii AeviItaliae (saecula VI-XII), coordinato da chi scrive per Bresciae provincia.
89
Flavia De Rubeis
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 19/06/14 13.37 Pagina 89
F. DE rUBEiS
debbano anche risolvere ulteriori problemi dicarattere paleografico, testuale e, non da ultimo,della mise en page e della sequenza pittorica dellelettere.
1. La sequenza pittorica, la mise en page,il tratteggio
è stato già rilevato da Adriano Peroni come lostrato pittorico degli affreschi insista su una pelli-cola estremamente sottile di intonaco (intona-
chino), lisciato e in grado di trattenere i pigmentiin prima applicazione per l’elevata presenza di car-bonato di calcio; le successive stesure pittorichenon sono altrettanto ben trattenute dallo stesso in-tonachino10.
l’esame condotto sull’intera fascia epigrafica haevidenziato l’esistenza di una prima sequenza e diun eventuale probabile ritocco effettuato su alcunelettere: la prima eseguita con calce bianca su fondorosso, scarsamente visibile oggi nella parola Desi-derium; il secondo, evidente sulle lettere la cui co-lorazione appare oggi caratterizzata da pigmento
10 PErONi 1983a, pp. 21-22.
90
Fig. 1 – San Salvatore di Brescia, navata centrale, rilievo dell’iscrizione desideriana (ril. F. De Rubeis).
Fig. 2 – San Salvatore di Brescia, navata centrale, iscrizione desideriana nell’affresco.
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 19/06/14 13.37 Pagina 90
DESiDEriO rE, lA rEGiNA ANSA E l’EPiGrAFE DEDiCAtOriA Di SAN SAlVAtOrE A BrESCiA
scuro (quasi nerastro), sembrerebbe il probabileesito di un differente degrado della colorazione ori-ginaria dell’epigrafe, unita a una probabile ridipin-tura delle lettere. Questa ultima pigmentazionenerastra interessa la parola regnantem e la se-quenza dei segni grafici a destra di Desiderium.
Allo stato attuale di conservazione il pigmentobianco, dato dall’uso di calce per la realizzazionedell’epigrafe, è in parte minima visibile sulla solaparola Desiderium, come già ricordato. la progres-siva decolorazione del fondo ha portato oggi a unasorta di negativo dell’originaria epigrafe: la calce,infatti, ha trattenuto il colore rosso scuro del fondoche in altre parti al contrario è svanito11.
Altrove si osservano, come già ricordato, ritoc-chi effettuati sulle lettere che in qualche caso nehanno alterato la primitiva struttura morfologica,senza tuttavia compromettere il testo medesimo.
la stratificazione dei segni grafici, evidenziatamediante l’uso di raggi ultravioletti12, sembra do-versi attribuire a un semplice ritocco delle lettereappartenenti alla prima iscrizione picta. Diversi in-dici conducono infatti a ritenere che la scriptio su-perior – con maggiore sicurezza quanto allamorfologia delle lettere, ma forse anche quantoall’allineamento del testo – non corrisponda piena-mente alla struttura dell’originaria scriptio inferior,con una operazione di ritocco delle lettere soloparziale. Sotto la seconda N in regnantem, a esem-pio, è ben visibile in rosso una asta che corre pa-rallela all’asta della scriptio superior.
il probabile ritocco dell’iscrizione inoltre è so-stenuto dall’esame della impaginazione del testo edella regolarità di inserimento delle lettere all’in-terno del binario costituito dalle rettrici, ossia dellelinee di guida ben visibili e tracciate in rosso scuro.
la chiesa desideriana e il suo ciclo pittoricopresentano due distinte tipologie impaginative: unaprima, ancora oggi parzialmente visibile nel riqua-dro affrescato nella parete settentrionale della na-vata centrale, che prevede l’inserimento del testoin campo aperto; una seconda, che doveva correrelungo le fasce inferiori dei riquadri recanti gli af-freschi e che doveva svolgere una funzione dida-scalica-dedicatoriale, realizzata in specchio di cor-redo.
Questo secondo gruppo di iscrizioni è oggi rap-presentato dall’epigrafe dedicatoria qui esaminata,nonché, sulla parete opposta, dalla didascalia postaal di sotto del riquadro recante anche le scritturein campo aperto.
Caratteristica saliente di questa seconda tipolo-gia impaginativa è la disposizione delle lettere ri-
spetto alle rettrici. la scrittura infatti viene eseguitaall’interno di due linee guida, rispetto alle quali lelettere vengono equidistanziate regolarmente di 1cm (costante per tutta l’estensione della parola De-siderium) sia rispetto alla linea di guida superioresia rispetto a quella inferiore.
Dalla figura riassuntiva dell’impaginazione ditutte le lettere che compongono l’iscrizione dellaparete sud (Fig. 1), è possibile osservare l’irregola-rità degli appoggi dei tratti costitutivi delle lettereper le quali già si è segnalata la probabile presenzadi ritocchi a fronte della sola parola ritenuta qui lamorfologicamente corrispondente alla scrittura ef-fettuata in origine.
Si osservi poi che a questa mise en page corri-sponde una specifica maniera di eseguire il tratteg-gio delle lettere e, più in particolare, lo spessoredei pieni. le misurazioni dei pieni, ossia dei trattidi maggiore ampiezza presenti nelle lettere, hannorivelato la presenza di una misura costante corri-spondente a 1 cm regolarmente impiegata sulleaste delle lettere – ossia coincidente con i pieni –;tale spessore corrisponde alla distanza delle letteredalle rettrici.
Questo espediente – voluto e piuttosto ricercatoe rilevato sul solo Desiderium – conferisce allascrittura nel suo aspetto complessivo un’armoniosaimpaginazione.
il regnantem, al contrario, presenta un’irregolaredistribuzione dei pieni e dei filetti (a esempio laprima N, il cui tratto obliquo risulta più spesso delleaste; la A con la traversa molto bassa ed estrema-mente sottile, così come le due aste, entrambe sot-tili). Si aggiunga a ciò inoltre l’allineamentoirregolare delle lettere, le quali in alcuni casi pog-giano sul rigo di base, in altri risultano appese allalinea guida superiore (tutte, con esclusione della Me della G, la quale tuttavia tocca la linea con l’ampiaterminazione a spatola del tratto curvilineo).
Circa le lettere di seguito a Desiderium, valgonole medesime osservazioni riguardanti l’irregolare al-lineamento all’interno delle linee guida già osser-vato per il regnantem.
Questa discontinuità interessa anche la suppo-sta parola tiro, la cui r presenterebbe la porzionesuperiore contigua alla linea di guida superiore,così come l’ipotetico tratto della t.
l’ipotesi di ritocco effettuato su parti dell’iscri-zione viene inoltre rafforzata dall’analisi paleogra-fica. il Desiderium, che qui viene accolto come ilsolo originario, presenta un’estrema regolaritànell’alternanza di pieni e filetti, i quali vengono di-stribuiti con rigida scansione fra tratti verticali, obli-
91
11 Si rinvia per una analisi dettagliata della colorazione del-l’epigrafe a GhErOlDi, Evidenze tecniche, in questo volume,pp. 118-119. 12 l’analisi delle iscrizioni pictae mediante il ricorso alla lam-
pada di Wood è stata effettuata direttamente da chi scrive inoccasione dei lavori di restauro della chiesa di San Salvatore,prima degli interventi di restauro effettuati nel corso dell’al-lestimento attuale del Museo di Santa Giulia.
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 19/06/14 13.37 Pagina 91
F. DE rUBEiS
qui e curvilinei. in particolare è possibile osservareall’interno della lettera M i tratti obliqui più sottilirispetto alle aste; la r, con le curve evidenziatedall’assottigliamento nelle estremità inferiori e su-periori dell’occhiello, caratteristica quest’ultima chesi riscontra anche all’interno delle lettere D ed E.
Sotto il profilo morfologico inoltre, è interes-sante il diverso attacco dei tratti obliqui delle N nelcorpo della stessa parola regnantem: mentre nellaseconda N il tratto obliquo parte dal vertice supe-riore dell’asta, nella prima appare decisamente dif-ferente e rispecchia un modello caratterizzante laproduzione epigrafica del periodo, ossia la traversaimpostata nel corpo centrale della lettera. Diversaanche la r, che in Desiderium viene eseguita conl’occhiello, rotondeggiante, alto e con il tratto obli-quo disposto quasi parallelo all’asta e con un’ampiacurvatura superiore convessa; in regnantem la rpresenta un occhiello piuttosto sviluppato e il trattoobliquo (anch’esso, come nella r di Desideriumora analizzata disposto quasi parallelo all’asta) conla curvatura convessa nella parte superiore piutto-sto ridotta.
Se (come credo si possa affermare sulla basedell’analisi condotta sulle lettere e sulle tecnichedi esecuzione delle stesse), la fascia dedicatoriadi San Salvatore ha subìto in epoca non ancoraprecisabile un ritocco, tale restauro sembrerebbeaver ricalcato le forme grafiche precedenti di untesto in evidente stato di conservazione degradato.la probabile opera di “restauro” potrebbe esserecollocata in una cronologia posta tra l’Xi e il Xii-Xiii secolo, ossia quando sulla medesima paretevenne praticata una apertura per consentire l’ac-cesso a un deambulatorio sospeso e quando fu-rono effettuati dei lavori in prossimità dell’iscri-zione stessa.
2. La morfologia della scrittura e la suapaleografia
Se, come credo, la sola parola che non ha su-bito manomissioni dell’iscrizione didascalica è De-siderium, su questa ora vale la pena di soffermarsiper alcune considerazioni di carattere paleografico.
innanzitutto la scrittura.la tipologia scrittoria impiegata è una maiu-
scola, una capitale longobarda di alto livello ese-cutivo.
Perfettamente inquadrata all’interno di due ret-trici e equidistante da queste, come si è visto, di 1cm, la scrittura presenta una regolare distribuzione
dei pieni e dei filetti che conferiscono all’insiemeun aspetto chiaroscurato.
il modulo delle lettere è verticale, con un ac-centuato spostamento degli occhielli e delle tra-verse nella parte alta delle lettere medesime.
in particolare si osservino le forme delle letterer, con occhiello ridotto e posizionato alto sull’asta;la S, con il pieno lungo la parte mediana della let-tera e le anse superiore e inferiore ridotte; la M,che presenta l’incrocio delle traverse alte.
la lettera E appartiene al sistema onciale con lecurve superiori e inferiori di ridotta estensione.
l’insieme delle lettere reca alle estremità liberedei tratti costitutivi un sistema di apicatura a spatolapoco sviluppato.
Gli elementi qui descritti riconducono la scrit-tura utilizzata per l’iscrizione dedicatoria alla piùampia categoria delle capitali longobarde13.
Gli esempi vicini per tipologia scrittoria, per im-piego di elementi derivanti dall’onciale, per mo-dulo con sviluppo verticale, si possono rinvenirein italia settentrionale tanto nei manufatti da riferirsia officine di ambito pavese quanto in altre aree.
Un termine di confronto particolarmente vicinoall’iscrizione desideriana è costituito dall’epigrafemutila del vescovo lopiceno14 (rinvenuta durantegli scavi effettuati nella cattedrale di Modena nel1906), datata tra il 749 e il 785 e attualmente con-servata presso il Museo del Duomo, dove compareuna E onciale della medesima forma compressa la-teralmente e con il medesimo sistema di apicatura.
Ulteriori confronti, sebbene con apicatura dif-ferente, si possono rinvenire negli affreschi dellaseconda metà dell’Viii secolo di Santa Maria inValle di Cividale del Friuli. Qui le iscrizioni realiz-zate mediante l’impiego di una capitale longobardadi buon livello, elegante nelle forme e ben impa-ginata, presentano un’apicatura non sempre coin-cidente con l’iscrizione della parete sud di SanSalvatore di Brescia, mentre affinità maggiori si ri-scontrano con le iscrizioni della parete nord; cio-nonostante richiamano nella morfologia dellelettere l’iscrizione desideriana15. Si ricorderà anchequi la presenza della E nella forma onciale, conapicatura a becchi sul tratto mediano.
Al di là dei confronti stilistici qui brevemente ri-chiamati, in ogni caso l’iscrizione bresciana nonpuò, a mio parere, essere riferita a un ambito scrit-torio carolingio per una serie di ragioni di caratterestrettamente paleografico.
in primo luogo, ipotizzando una sua realizza-zione in età carolingia e accogliendo in tal modo
13 Sulla capitale longobarda v. Introduzione paleografica inDE rUBEiS 2011a, pp. 7-16.
14 GrAy 1948, p. 71, n. 36. 15 lOMArtirE 2001, pp. 455-491.
92
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 19/06/14 13.37 Pagina 92
DESiDEriO rE, lA rEGiNA ANSA E l’EPiGrAFE DEDiCAtOriA Di SAN SAlVAtOrE A BrESCiA
la lettura offerta da Panazza, dovremmo portarel’epigrafe al iX secolo, a partire dalla metà o se-conda metà del iX secolo.
i confronti più vicini sotto il profilo cronologicosono pochi in area e appaiono morfologicamentedifferenti. Caratterizzati dall’uso della capitale ca-rolina, questi manufatti indicano un assetto graficodel tutto diverso.
il modulo delle lettere, per le quali si è osser-vato lo sviluppo verticale nell’epigrafe desideriana(caratteristica in ogni caso di tutta la capitale lon-gobarda), nei prodotti carolingi tende al quadrato,con un recupero netto del modulo di tradizione (equindi imitazione) romana16.
Prescindendo poi dal modulo, la scrittura ap-pare caratterizzata da lettere morfologicamente ri-feribili al sistema della capitale longobarda. Fraqueste, la caratteristica impostazione delle traversedella lettera M che di regola appare alta sul rigo dibase, secondo un modello che si stabilizza fin dalVii secolo e che nella scrittura longobarda italo-settentrionale è destinato a essere soppiantato dalmodello con traverse poggianti sul rigo di base;l’attacco delle aste e delle traverse, nelle medesimelettere nel modello longobardo è normalmente im-postato lievemente ribassato rispetto al verticedell’asta, mentre nel modello carolingio esse sonodirettamente innestate sui vertici delle aste mede-sime.
la r, già descritta con il modulo compresso la-teralmente, presenta l’occhiello risalente sull’asta eil tratto obliquo concavo. Al contrario, la capitalecarolina presenta l’occhiello ampio e profondo e iltratto appare convesso.
la E, infine, non è in onciale come nell’iscri-zione bresciana, bensì capitale.
Prendendo quindi le iscrizioni caroline che po-trebbero essere portate a confronto per l’iscrizionedesideriana, a parità di cronologia, sarà utile osser-vare che per queste ultime la struttura morfologicadelle lettere rinvia direttamente alla capitale epigra-fica di tradizione romana.
in particolare, senza entrare nel merito diun’analisi dettagliata della capitale epigrafica diclasse carolina, a puro titolo esemplificativo e suuna campionatura effettuata direttamente sui ma-nufatti di alta produzione e committenza realizzatinel corso del iX secolo in area franco-carolingia, sipotrà osservare quanto segue.
A Nizza presso l’abbazia di Saint-Pons de Ci-miez in un’iscrizione commemorativa compare una
C quadra e la M si presenta in forma onciale.l’iscrizione, assegnata all’ultimo quarto dell’Viiisecolo, tradisce l’utilizzo di una scrittura non par-ticolarmente colta17. Di provenienza da Sainte-ra-degonde, è l’iscrizione funeraria di Mumlenau:l’epitaffio, di livello piuttosto basso e datato all’Viiisecolo18, presenta una scrittura estremamente di-sordinata, poco accurata nell’esecuzione; da os-servare la presenza di lettere come la O a rombo,la M con le aste divaricate e l’incrocio discendentequasi fino al rigo di base, la tendenza ancora pre-sente ad ampliare a spatola i tratti di alcune lettere(quali la E, la t). Un’iscrizione attualmente con-servata presso il Musée Camarguais di Arles19, da-tata alla fine del iX secolo (anno 883) e relativa alrestauro di una tomba, viene eseguita in capitaleepigrafica con la M capitale (traverse fino al rigodi base, E quadra, O tonda). Nel volume dedicatoalle iscrizioni presenti a Poitiers20, robert Favreauinserisce una serie conservata presso il Musée dela Ville. Fra queste si distinguono vari tipi di pro-duzione grafica. la n. 8421 del volume è in capitaleepigrafica di ripresa dai modelli romani, con in-trusioni delle C quadre e una h onciale: si trattadell’epitaffio di Adda, forse da identificare con lamoglie di renoul ii, conte di Poitou tra l’878 edl’890, così come è documentato nell’obituario diSaint-Germain-des-Prés. la scrittura si presentacome una capitale di buon livello, con le lettere Otonde, la M con le traverse che scendono sul rigodi base. è una iscrizione di elevata committenza,un prodotto di alto livello, come osserva lo stessoFavreau, ricercata anche sotto il profilo testuale,una composizione in distici elegiaci. è presente larigatura e le lettere P, B ed r presentano gli oc-chielli aperti. Proveniente da Saint-hilaire-le-Grand,ma anteriore rispetto all’iscrizione di Adda, l’iscri-zione funeraria di Madalfredo datata agli anni 802o 80822. la scrittura di questo epitaffio si presentadi livello decisamente più basso rispetto al testovisto per l’iscrizione di Adda: si vedano le termi-nazioni di alcune lettere che tendono ad espandersia spatola (come per le lettere S e A), la presenzadella M di tipo onciale con le curve molto accen-tuate, la C quadra, la A con traversa spezzata etratto di coronamento. Sempre proveniente daSaint-hilaire-le-Grand, l’epitaffio di Amelio datato87423 presenta una profonda rigatura, numeroselettere inscritte, la lettera O tonda e la P, B ed rcon occhiello staccato dall’asta. Da osservare lalettera N con la traversa alta e stretta nel modulo.
16 Sul modulo in età carolingia v. DE rUBEiS 2012.17 CiFM, vol. 14, n. 8, pp. 16-19, pl. iV, figg. 7-9.18 ivi, n. 91, pp. 115-116, tav. XXXiV, fig. 67.19 ivi, n. 47, pp. 84-6, pl. XXVii, fig. 56.
20 CiFM, vol. 1.21 ivi, pp. 102-104, tav. XVii, fig. 35.22 ivi, pp. 99-100, n. 82, pl. XViii, fig. 36.23 ivi, pp. 100-102, n. 83, tav. XViii, fig. 37.
93
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 19/06/14 13.37 Pagina 93
F. DE rUBEiS
l’analisi delle lettere fin qui condotta (certa-mente non esaustiva, ma puramente esemplifica-tiva), sembra indicare in area franco-carolingia unprimo periodo caratterizzato da una non ben sedi-mentata acquisizione dei modelli grafici e da unaimportante oscillazione delle forme. Ma è interes-sante osservare la presenza di elementi destinati atrovare repliche anche in ambito librario: fra questila C nella forma quadra utilizzata, ad esempio, nellescritture distintive dei codici prodotti a San Martinodi tours nella fase pre-alcuiniana e alcuiniana24, ma-noscritti per i quali è stata rilevata da Armando Pe-trucci una distanza tipologica rispetto ai codiciassegnati alla scuola di corte. Vi compaiono letterecon occhielli aperti, come P e B viste, ad esempio,nell’Evangeliario di Godescalco. Un mutamento didirezione che solo con gli inizi del iX secolo cono-scerà avvicinamenti formali con coevi prodotti ca-rolingi, quando compariranno scritture distintive piùregolari nell’impianto complessivo.
Sarà difficile trovare per la scrittura di Brescia unutile termine di confronto almeno in area franco-carolingia e per una datazione risalente tra la primametà e la fine del iX secolo.
Né potranno essere prese in considerazione leepigrafi regie e vescovili italo-settentrionali sullequali e per le quali ancora la critica non ha rag-giunto unanimità di pareri circa la loro autenticità.Senza tirare in ballo qui il plotone delle epigrafi“caroline” sulle quali si addensano le nubi di so-spette copie tardive (mi riferisco in particolare alleiscrizioni di Pipino, figlio di Carlo, morto nell’anno806, e di Bernardo, re d’italia, ucciso nell’anno811, così come rifacimenti quattrocenteschi sem-brano anche essere le iscrizioni di ludovico ii,morto nell’875 e quella del vescovo Ansperto,morto nell’881)25, basterà citare qui ad esempio leiscrizioni conservate presso i Civici Musei di Bre-scia, relative ad un abate di leno, non meglio iden-tificato, o all’abate Magno: entrambe della primametà del iX secolo, oscillano nell’incertezza di es-sere già caroline, o tardo-longobarde. la formadelle lettere, tendente al quadrato, le rende già ca-roline (con il recupero operato da parte di questascrittura del rapporto 1:1 tra altezza e larghezzadelle lettere); il tracciato di lettere come la M, conle traverse pienamente adagiate sul rigo di base,ne conferma la natura carolina, la presenza di let-tere dal tratteggio tendente al quadrato (C e G) neidentifica l’ascendenza d’oltralpe. Ma nell’insiemeesse sono scritture in fase di transizione da un si-stema dal tracciato oblungo verso un sistema di
recupero totale della capitale epigrafica di ascen-denza classica. E in ogni caso esse si presentanolontane dall’epigrafe desideriana.
i confronti stilistici quindi, e qui concludo conla paleografia e la sua cronologia, portano tutti di-rettamente verso l’Viii secolo, al più tardi la se-conda metà-fine dell’Viii secolo. E a questa datapotrebbero essere riferiti, allorquando il re Deside-rio e più in particolare la regina Ansa volle fareadornare la chiesa mirifice.
3. Un testo e la sua interpretazione
Se fin qui l’iscrizione desideriana risponde alledomande poste circa la cronologia, la tipologiascrittoria e la sua impaginazione offrendo numerosipunti fermi, non altrettanto si potrà dire della suainterpretazione.
Come ho richiamato in precedenza, il testo èstato più volte interpretato e letto con differenti le-zioni, tutte in ogni caso facenti poi capo a crono-logie carolingie o comunque a committenti caro-lingi.
la più accreditata vuole il richiamo del sovranosconfitto (Desiderio) per opera di un ludovico gio-vane, interpretando la sequenza di elementi di let-tere a destra del Desiderium con l’integrazione giàcitata in precedenza e che qui richiamo per como-dità: regnantem Desiderium Tiro Hlu[dovicus – – –
l’analisi effettuata sulle lettere non conferma lalettura qui richiamata.
in primo luogo, come è possibile osservare, itratti immediatamente a destra di Desiderium nonpossono essere interpretati come Tiro per una seriedi ragioni qui di seguito enucleate.
Non si leggono gli elementi del tratto della let-tera t, ma si individuano residui di una curvaturanella parte alta di una lettera che potrebbe esserecompletata nel margine inferiore dal tratto curvili-neo, ottenendosi così una C, mentre non comparel’asta della t; segue un’asta obliqua discendente dimedio spessore e una ascendente di ridotto spes-sore, interpretabili come una U/V; seguono quindidue aste di medio spessore con traccia di traversealte spezzate, ottenendosi così una M. la sequenzaproposta è quindi cum.
Non è presente la lettera r bensì una letteradella quale rimane un tratto concavo; né la i, men-tre è visibile una O di modulo ridotto.
Seguono quindi dei residui di lettere fino a ri-dosso della O di modulo ridotto da ritenersi inclusa,
24 PEtrUCCi 1976, pp. 822-823. 25 Circa i dubbi sulla genuinità delle iscrizioni, v. PEtrUCCi1992, pp. 64-65. Sull’iscrizione di Ansperto, v. AMBrOSiONi
1993, pp. 35-50, il quale ritiene il manufatto un prodotto ori-ginario del iX secolo. Della medesima opinione lOMArtirE1997, pp. 43-44.
94
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 19/06/14 13.37 Pagina 94
DESiDEriO rE, lA rEGiNA ANSA E l’EPiGrAFE DEDiCAtOriA Di SAN SAlVAtOrE A BrESCiA
forse in una C, come sembrerebbe dalle seguentiosservazioni. il presunto occhiello della r non èpresente e, prendendo come termine di paragonela r di Desiderium, si noterà che il suo tratto obliquoè convesso e non concavo come nella r qui ipotiz-zata che recherebbe un elemento concavo. inoltresi tenga presente che, mentre la lettera C può in-cludere una O di modulo ridotto (e non mancanoesempi per l’Viii secolo di tali inclusioni), al con-trario una r difficilmente potrà includere una O,specialmente se questa (come risulterebbe dalla let-tura in passato proposta e qui messa in discussione)le si affianca e non viene inclusa tra l’asta e il trattoobliquo. Del resto una O di modulo ridotto è pre-sente, nella medesima iscrizione, nel gruppo di let-tere che precedono il regnantem e nell’iscrizionecollocata in corrispondenza della fascia didascalicadella parete nord della navata centrale, esattamentein corrispondenza di questa che qui si discute.
tornando all’analisi delle lettere, dopo la se-quenza CO seguono due aste. Sulla prima asta,quella di sinistra, in pessimo stato di conservazionee interessata da una vasta lacuna, compare in altoverso sinistra un tratto obliquo. Posizionandoun’ideale linea di proseguimento dell’elementoobliquo, di potrebbe arrivare a ottenere una N. la
forma ipotizzata, con la traversa alta e non aggan-ciata ai vertici delle lettere, trova ampi confrontinella produzione epigrafica longobarda coeva, perla quale basterà richiamare la serie delle iscrizionipavesi di committenza regia.
tornando nuovamente all’epigrafe, dopo la N,troviamo ben leggibili una i e una U/V.
la parola che si propone qui come lettura sa-rebbe quindi coniu[ge – – –]
Dalla ricostruzione delle lettere qui effettuata sipropone quindi una nuova lettura che vedrebbeprotagonisti dell’epigrafe il re Desiderio e la reginaAnsa e forse, ma non altrimenti dimostrabile, il fi-glio Adelchi:
[—-]SANO[—-] regnantem Desiderium [c]umconiu[ge sua Ansa – – –
l’evocazione della regina Ansa, del resto, tro-verebbe qui una giusta collocazione se solo si ri-fletta alla scena affrescata al di sopra dell’iscrizionededicatoria: il riferimento è alla martire Giulia,quella stessa per la quale la regina Ansa si mosseper ottenerne le reliquie da collocare, appunto,nella chiesa di San Salvatore.
95
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 19/06/14 13.37 Pagina 95
BiBlioGrAFiA
543
Abbreviazioni
AFdM = Archivio Fotografico direzione Musei, Brescia.
AsdM = Archivio storico direzione Musei, Brescia.
CdlM = Codice Diplomatico della Lombardia medievale(secoli VIII-XII), http://cdlm.unipv.it/.
CiFM = Corpus des Inscriptions de la France Médiévale,1974 -.
dBi = Dizionario Biografico degli Italiani, istituto del-l’enciclopedia italiana, roma 1960 -.
I. I. = inscriptiones italiae.
S. I. = supplementa italica.
settimana CisAM = Atti delle settimane di studio delCentro italiano per la storia dell’Alto Medioevo.
Fonti
Acta Sanctorum, Februarii, iii, parisiis 1865.
Acta Sanctorum, Maii, V, Antverpiae 1685.
AndreA dA BerGAMo, Historia, ed. G. WAitz, MGH ss rer.lang. er italic. saec. Vi-iX, Hannover 1878, pp. 271-330.
AndreAs et AGnelli, Liber pontificalis Ecclesiae Ravenna-tis, ed. o. Holder eGGer, MGH ss rer. lang. et italic.saec. Vi-iX, Hannover 1878, pp. 265-391.
Annales Einhardi, F. Kurze (ed.), Annales Regni Fran-corum (741-829) qui dicuntur Annales LaurissensesMaiores et Einhardi, MGH ss rer. Germ. 6, Hannover1895.
Annales Fuldenses, F. Kurze (ed.), Annales Fuldenses siveAnnales regni Francorum Orientalis, MGH ss rer.Germ. 7, Hannover 1891.
Annales Mettenses Priores, B. de siMson (ed.), AnnalesMettenses Priores, MGH ss rer. Germ. 10, Hannover-lipsia 1905.
G.A. AstezAti, Indice alfabetico-istorico-cronologico-per-petuo dell’Archivio dell’insigne, e real monistero novodi S. Salvatore e S.a Giuglia di Brescia, Ms. Quer.G.i.4.
G.A. AstezAti 1728, Evangelistae Manelmi Commentario-lum de obsidione Brixiae, Brixiae.
Aurelii prudentii, Peristephanon, in Patrologia latina, 60,paris 1862, coll. 275-596.
BAedAe, Opera Historica, ed. C. pluMMer, oxford 1896;trad. ingl. d. KnoWles (ed.), Bede’s Ecclesiastical His-tory of the English Nation, london-new york 1910.
A. BAitelli 1657, Annali historici dell’edificatione eret-tione, et dotatione del Serenissimo Monasterio di S.Salvatore, et S. Giulia di Brescia, Brescia (rist. anast.Brescia 1978).
e. BArBieri, i. rApisArdA, G. CossAndi 2008, Le carte del mo-nastero di S. Giulia di Brescia I (759-1170), CdlM,http://cdlm.unipv.it/edizioni/bs/brescia- sgiulia1/
C. BluMe 1909, Analeta Hymnica Medii Aevi, v. 52, leipzig.
Breve Chronicon del monastero di leno, Catalogusregum Langobardorum et Italicorum Brixiensis et No-nantolanus, ed. G. WAitz, MGH ss rer. lang. er italic.saec. Vi-iX, Hannover 1878, pp. 501-504.
p. BroGnoli, Miscellanea bresciana, BQ, ms di rosa n.37.
CAndidus, Vita Aeigili, ed. e. düMMler, MGH poet. lat.Aevi Karol. ii, Berlin 1884, pp. 94-117.
Cdl ii, l. sCHiApArelli (ed.), Codice Diplomatico Longo-bardo, ii, istituto storico italiano per il Medioevo.Fonti per la storia d’italia 63, roma 1933.
Cdl iii, C.r. BrüHl (ed.), Codice Diplomatico Longo-bardo, iii, 1, istituto storico italiano per il Medioevo.Fonti per la storia d’italia 64, roma 1973.
CDLangobardiae, G. porro lAMBertenGHi (ed.), CodexDiplomaticus Langobardiae, Historiae patriae Monu-menta Xiii, Augustae taurinorum 1873.
Codex Carolinus, W. GundlACH (ed,), Epistolae Merowin-gici et Karolini Aevi, MGH epistolae 3, Berlin 1982,pp. 469-657.
G. CossAndi c.s., Le carte del monastero di Santa Giuliadi Brescia.
einHArdi, Vita Karoli Magni, ed. o. Holder eGGer, MGHss rer. Germ. 25, Hannover 1911.
GreGorii nysseni, Oratio laudatoria Sancti ac MagniMartyris Theodori, in Patrologia Graeca, 46, paris1863, coll. 737-739.
A.t. HACK 2006-2007, Codex Carolinus. Päpstliche Epis-tolographie in 8. Jahrhundert, 2 voll., stuttgart.
p.F. KeHr 1913 (ed.), Regesta pontificum Romanorum.Italia Pontificia: Vi, Liguria sive provincia Mediola-nensis, 1, Lombardia, Berolini.
G. Joli 1823, Museo Lechi, BQ, ms. o.Vi.30.
Liber Pontificalis, l. duCHesne (ed.), Le Liber Pontificalis:Texte, introduction et commentaire, 2 voll., paris1886-1892.
Liber Vitae, d. GeueniCHn, u. ludWiG et al. (edd.), DerMemorial- und Liturgiecodex von San Salvatore/Santa Giulia in Brescia, MGH, libri memoriales etnecrologia n.s. 4, Hannover 2000.
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 16/07/14 10.54 Pagina 543
BiBlioGrAFiA
Bibliografia
Abbazia di San Benedetto 2002, A. BAronio (ed.), L’ab-bazia di San Benedetto di Leno, nel cuore della pia-nura Padana, Atti della Giornata di studio (leno, 26maggio 2001), “Brixia sacra. Memorie storiche delladiocesi di Brescia”, 3 s., 7, fasc. 1-2.
Adelchi 1984, Adelchi. Dai Longobardi ai Carolingi, Ca-talogo della Mostra (Milano, 28 settembre-30 dicem-bre 1984), Milano 1984.
B. Al HAMdAni 1995, The fate of the perspectival meanderin Roman mosaics and its sequels, in “Cahiers Ar-cheologiques”, 43, pp. 35-56.
e. AlFAni 2004, Culto dei martiri nella pittura muralelombarda, in Arte, cultura 2004, pp. 57-68.
M. AlHAsAnAt, W. Hussin, s. KABir, e. Addison 2012, Spa-tial analysis of a historical phenomenon: using GISto demonstrate the strategic placement of theUmayyad desert palaces, in “Geo-Journal”, 77, n. 3,pp. 343-359.
M. AlMAGro et al. 1975, Qusayr ‘Amra, Residencia ybaños omeyas en el desierto de Jordania, Madrid.
A.A. AMAdio 1986, I mosaici di Santa Costanza, roma.
A. AMBrosioni 1993, “Atria vicinas struxit et ante fores”.Note in margine ad un’epigrafe del IX secolo, in A.AMBrosioni et al. (edd.), Medioevo e latinità in me-moria di Ezio Franceschini, Milano, pp. 35-50.
M. AndAloro 1987, Aggiornamento scientifico, in G. MAt-tHiAe, Pittura romana del Medioevo. Secoli IV-X. Ag-giornamento scientifico di Maria Andaloro, roma,pp. 217-307.
M. AndAloro 2003, s.v. Castelseprio, in Enciclopediadell’arte medievale, roma, iV, pp. 453-459.
M. AndAloro 2006, La pittura medievale a Roma 312-1431. Atlante, percorsi visivi, i, Milano.
G. AndennA 1992, Il monastero e l’evoluzione urbanisticadi Brescia tra XI e XII secolo, in Santa Giulia 1992,pp. 93-118.
G. AndennA 1993, Foris muros civitatis. Lo spazio urbanofuori porta Bruciata dai Longobardi alla conquistaveneta, in V. FrAti, i. GiAnFrAnCesHi, F. roBeCCHi, LaLoggia di Brescia e la sua piazza. Evoluzione di unfulcro urbano nella storia di mezzo millennio, i, Bre-scia, pp. 237-250.
G. AndennA 2001, La vita e il ruolo del monastero, in SanSalvatore-Santa Giulia 2001, pp. 41-53.
B. Anderson 1976, The Frescoes of San Salvatore at Bre-scia, Berkeley (California).
p. AnGiolini MArtinelli 1968, Altari, amboni, cibori, cor-nici, plutei con figure di animali e con intrecci, tran-senne e frammenti vari, Corpus della sculturapaleocristiana bizantina e altomedievale di ravenna,i, roma.
s.C. Antón 1997, Endocranial Hyperostosis in Sangiran2, Gibraltar 1, and Shanidar 5, in “American Journalof physical Anthropology”, 102, pp. 111-122.
544
J. MAlVezzi 1729, Chronicon Brixiense, in l.A. MurAtori
(ed.), Rerum Italicarum Scriptores, XiV, Mediolani,coll. 771-1004.
G. de MAnteyer 1940, Le martyrologe d’Adon (850) et sesadditions (886-1121), in “Bulletin de la sociétéd’études historiques, scientifiques et littéraires desHautes Alpes”, 59, pp. 5-203.
M. MilAni s.a., Introduzione, in Le carte del monasterodi S. Felice di Pavia (998-1197), CdlM, http://cdlm.unipv.it/edizioni/pv/pavia-sfelice/.
notKer BAlBulus, Gesta Caroli Magni, ed. H.F. HAeFele,Notker der Stammler Taten Kaiser Karls des Grossen,MGH ss rer. Germ. n.s. 12, Munich 1980 (new ed.).
Ordinario = BQ, ms. H.Vi.11.
G. pAsQuAli 1979, S. Giulia di Brescia, in A. CAstAGnetti
et al. (edd.), Inventari altomedievali di terre, colonie redditi, istituto storico italiano per il Medioevo.Fonti per la storia d’italia 104, roma, pp. 43-94.
Patrologia Greca, J-p. MiGne 1856-1866, Patrologiae Cur-sus Completus, Series Graeca, 161 voll., paris.
Patrologia Latina, J-p. MiGne 1844-1855, Patrologiae Cur-sus Completus, Series Latina, 217 voll., paris.
pAuli diAConi, Historia Langobardorum, ed. l. BetHMAnn,G. WAitz, MGH ss rer. lang. er italic. saec. Vi-iX 1,Hannover 1878, pp. 12-187; trad. it. C. leonArdi, r.CAssAnelli (edd.), Storia dei Longobardi, Milano 1985.
l. sCHiApArelli 1903 (ed.), I diplomi di Berengario I,roma.
tHeopHilus, De diversis artibus, ed. C.r. dodWel, london1961.
l. tHorpe 1969 (ed.), Einhard and Notker the Stammerer.Two Lives of Charlemagne, Harmondsworth.
VenAntii FortunAti, Vita Martini, ed. F. leo, MGH Auc-tores antiquissimi iV, Berolini 1881.
Vita Corbianiani episcopi Baiuvariorum, B. KrusCH
(ed.), Arbeonis episcopi Frisingensis vitae sanctorumHaimhrammi et Corbianiani, MGH ss. rer. Germ.13, Hannover 1920, pp. 188-234.
Vita di San Colombano, B. KrusCH (ed.), Ionas BobiensisVita Sancti Columbani, MGH ss. rer. Germ. 37, Han-nover-lipsia 1905; trad. it i. BiFFi, A. GrAnAtA, Vita diColombano e dei suoi discepoli, Milano 2001.
Vita Willibaldi, o. Holder eGGer (ed.), Vita WillibaldiEischstetensis et vita Wynnebaldi abbatis Heiden-heimensis auctore sanctimoniale Heidenheimensis,MGH ss rer. Germ. 15, 1, Hannover 1887, pp. 80-117.
VitruVius, Ten books on architecture, ed. i.d. roWlAnd,t.n. HoWe, M. deWAr, Cambridge 2005.
p.G. WAlsCH 1966-1967 (ed.), Letters of St. Paulinus ofNola, 2 vols, new york.
K. WAnner 1994 (ed.), Ludovici II Diplomata, MGH di-plomata Karolinorum iV, München.
r. WeBer 1975-1979 (ed.), Ambrosii Autperti Opera. Cor-pus Christianorum Continuatio Mediaevalis 27, 3voll., turnhout.
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 16/07/14 10.54 Pagina 544
BiBlioGrAFiA
i. ArCe 2007, Umayyad building techniques and themerging of Roman-Byzantine and Partho-Sassaniantraditions: continuity and change, in l. lAVAn, e.zAnini, A. sArAntis (edd.), Technology in Transition:A.D. 300-650, leiden-Boston, pp. 491-538.
Archeologia e società 2007, G.p. BroGiolo, A. CHAVArríA
ArnAu (edd.), Archeologia e società tra tardo Anticoe alto Medioevo, Xii seminario sul tardo Antico el’Alto Medioevo (padova, 29 settembre-1 ottobre2005), Mantova 2007.
G. ArCHetti 2000, Per la storia di S. Giulia nel Medioevo.Note storiche in margine ad alcune pubblicazioni re-centi, in “Brixia sacra. Memorie storiche della diocesidi Brescia”, 5, pp. 5-44.
G. ArCHetti 2001, Vita e ambienti del monastero dopo ilMille, in San Salvatore-Santa Giulia 2001, pp. 123-131.
Area di S. Giulia 1993, i. GiAnFrAnCesCHi, e. luCCHesi
rAGni (edd.), L’area di Santa Giulia: un itinerarionella storia: la domus, le capanne longobarde, il mo-nastero, il tesoro, Catalogo della Mostra (Brescia, 2luglio-12 novembre 1993), Brescia 1993.
Arredi di culto 2001, s. de BlAAuW (ed.), Arredi di cultoe disposizioni liturgiche a Roma da Costantino a SistoIV, Atti del Colloquio internazionale (roma, 3-4 di-cembre 1999), roma 2001.
e.W. ArslAn 1943, La pittura e la scultura veronese dalsecolo VIII al secolo XIII, Milano.
e.W. ArslAn 1953, Capitelli lombardi dal VI al IX, inArte del primo Millennio, Atti del ii Convegno perlo studio dell’Arte dell’Alto Medio evo, pavia, pp.297-300.
e.W. ArslAn 1954, L’architettura dal 568 al Mille, in Sto-ria di Milano, ii, Milano, pp. 500-608.
e.W. ArslAn 1963, s.v. Preromaniche scuole e correnti,in Enciclopedia Universale dell’Arte, Venezia-roma,Xi, coll. 26-29.
Arte, cultura 2004, G. AndennA (ed.), Arte, cultura e re-ligione in Santa Giulia, Brescia 2004.
Arte e iconografia 2000, M. AndAloro, s. roMAno (edd.),Arte e iconografia a Roma da Costantino a Cola diRienzo, Milano 2000.
J.K. AtAoGuz 2007, The Apostolic Commissioning of theMonks of Saint John in Muestair, Switzerland: Paint-ing and Preaching in a Churraetian Monastery, phddissertation, university of Harvard.
C. AzzArA 2002, Il re e il monastero. Desiderio e la fon-dazione di Leno, in Abbazia di San Benedetto 2002,pp. 21-32.
J. BACHArACH 1996, Marwanid Umayyad building activi-ties: speculations on patronage, in “Muqarnas”, 13,pp. 27-44.
A. BAdini 1980, La concezione della regalità in Liut-prando e le iscrizioni della chiesa di S. Anastasio aCorteolona, in Atti del 6° Congresso internazionaledi studi sull’Alto Medioevo (Milano 1978), spoleto, i,pp. 283-302.
M. BAlBi 1984-1985, Pombia e Castelnovate nel sistemadifensivo tardo antico medievale pedemontano delTicino, tesi di laurea in lettere, università Cattolicadel sacro Cuore, relatrice prof.ssa A. Ambrosioni.
A. BAllArdini 2006, Santa Maria d’Aurona, in Medioevodelle cattedrali 2006, pp. 419-431.
A. BAllArdini 2010, Scultura a Roma: standards qualita-tivi e committenza (VIII secolo), in Ottavo secolo2010, pp. 141-148.
F. BAndini, G. BottiCelli 1990, Influenza delle tecniche edei materiali esecutivi nel degrado delle pitture mu-rali, in C. dAnti, M. MAtteini, A. Moles (edd.), Le pit-ture murali, tecniche, problemi, conservazione,Firenze, pp. 23-28.
o. BAnti 1992, Considerazioni a proposito di alcune epi-grafi dei secoli VIII-IX conservate a Brescia, in SantaGiulia 1992, pp. 163-178.
A. BArBet 1985, La peinture murale romaine: les stylesdécoratifs pompéiens, paris.
s. BArlAssinA 2001-2002, Sepolture internamente intona-cate e dipinte: la presenza a Milano e nel suo terri-torio tra età paleocristiana e Medioevo, tesi di laureain Archeologia Medievale, università Cattolica delsacro Cuore, relatrice prof.ssa s. lusuardi siena.
A. BAronio 2002, Il «dominatus» dell’abbazia di San Be-nedetto di Leno. Prime ipotesi di ricostruzione, in Ab-bazia di San Benedetto 2002, pp. 33-85.
C. BArsAnti 1990, L’esportazione di marmi dal Procon-neso nelle regioni pontiche durante il IV-VI secolo, in“rivista nazionale d’Archeologia e storia dell’Arte”,s. iii, 12, pp. 91-220.
C. BArsAnti 1995, Alcune riflessioni sulla diffusione deimateriali di marmo proconnesio in Italia e in Tuni-sia, in Akten des XII. Internationalen Kongresses fürChristliche Archäologie (Bonn, 22-28 september1991), Città del Vaticano-Münster, pp. 515-523.
C. BArsAnti 1998, I capitelli, in J-p. sodini, C. BArsAnti,A. GuiGliA GuidoBAldi, La sculpture architecturale enmarbre au VIe siècle à Constantinople et dans les ré-gions sous influence constantinopolitaine, in n.CAMBi, e. MArin (edd.), Acta XIII Congressus Interna-tionalis Archaeologiae Cristianae (split-poreč, 25 set-tembre-1 ottobre 1994), roma, ii, pp. 301-376.
C. BArsAnti 2004, Aspetti e problemi della scultura di etàgiustinianea: le lastre in opera nelle gallerie dellaSanta Sofia di Costantinopoli, in CreAzzo, strAno
2004, pp. 31-50.
C. BArsAnti 2007, La scultura architettonica di epocaomayyade tra Bisanzo e la Persia sasanide: i capitellidi Qasr al-Muwaqqar in Giordania, in Medioevo me-diterraneo 2007, pp. 436-446.
Basilica di San Giosuè 1995, r. HodGes, J. MitCHell
(edd.), La basilica di Giosué a San Vincenzo al Vol-turno, Monte Cassino-Monteroduni 1995.
p. BAsso 1999, Architettura e memoria dell’antico. Teatri,anfiteatri e circhi della Venetia romana, roma.
p. BAsso 2003, Gli edifici di spettacolo nella città medie-vale, in G. tosi (ed.), Gli edifici per spettacoli nell’Ita-lia romana, roma, i, pp. 901-921.
545
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 16/07/14 10.54 Pagina 545
BiBlioGrAFiA
J. BAuM 1962, Karolingische Bildnerkunst asu Ton undStein im Iller und Nagoldtal, in H. Fillitz (ed.), Bei-träge zur Kunstgeschichte und Archäologie des Früh-mittelalters, Akten zum 7. internationalen Kongressfur Frühmittelalterforschung (Wien, 21-28 september1958), Graz-Köln, pp. 167-178.
J. BAXAriAs, J. Herrerin 2008, The Handbook Atlas of Pa-leopathology, saragozza.
H. BeCHer 1983, Das königliche Frauenkloster San Sal-vatore/Santa Giulia in Brescia im Spiegel seiner Me-morialüberlieferung, in “Frühmittelalterliche studien”,17, pp. 299-392.
p.V. BeGni redonA 2001, Aspetti della comunicazione vi-siva del culto. Il capitello e gli affreschi del cenobio,in Culto e storia 2001, pp. 149-166.
M.G. BelCAstro, F. FACCHini, e rAstelli 2006, HyperostosisFrontalis Interna and sex identification of two skele-tons from the Early Middle Ages necropolis of Vi-cenne-Campochiaro (Molise, Italy), in “internationalJournal of osteoarchaeology”, 16, pp. 506-516.
i. Belli BArsAli 1959, La diocesi di Lucca, Corpus dellascultura altomedievale i, spoleto.
G. Belotti 2001a, Il monastero dalla riforma cassineseal XVI secolo, in San Salvatore-Santa Giulia 2001, pp.169-191.
G. Belotti 2001b, Le vicende del monastero dal XVII se-colo alla soppressione napoleonica, in San Salvatore-Santa Giulia 2001, pp. 291-311.
H. BeltinG 1962, Studien zum beneventanischen Hof im8. Jahrhundert, in “dumbarton oaks papers”, 16, pp.143-193.
H. BeltinG 1967, Probleme der Kunstgeschichte Italiensim Frühmittelalter, in “Frühmittelalterliche studien”,i, pp. 94-113.
H. BeltinG 1968, Studien zur beneventanischen Malerei,Wiesbaden.
G. BerGAMAsCHi 2006, S. Giulia a Lucca: la chiesa e ilculto della santa, in “nuova rivista storica”, 90, pp.763-782.
G. BerGAMAsCHi 2009a, Da Cartagine alla Toscana a Bre-scia: i percorsi del culto a Santa Giulia, in “la viafrancigena in Valdelsa”, XVii, n. 1-2, pp. 201-245.
G. BerGAMAsCHi 2009b, Il carme “Erga pii fratres” e gliinni per Santa Giulia, in M.t.r. BArezzAni, r. tiBAldi,(edd.), Musica e liturgie nel medioevo bresciano (se-coli XI-XV), Atti dell’incontro nazionale di studio,Brescia, pp. 191-247.
É. BertAuX 1905, La sculpture en Italie du VI au X siècle, inA. MiCHel (ed.), Histoire de l’art, paris, i, pp. 384-394.
C. Bertelli 1988, Gli affreschi nella torre di Torba, Mi-lano.
C. Bertelli 1992, La pittura a S. Salvatore nel contesto ca-rolingio, in Santa Giulia 1992, pp. 217-230.
C. Bertelli 1994 (ed.), La pittura in Italia. L’altome-dioevo, Milano.
C. Bertelli 2000a, Aspetti dell’arte promossa dai Longo-bardi in Italia nell’VIII secolo, in Futuro dei Longo-bardi 2000a, pp. 189-196.
C. Bertelli 2000b, Ravenna, in Futuro dei Longobardi2000b, pp. 330-331.
C. Bertelli 2000c, Brescia, San Salvatore: affreschi sullepareti, in Futuro dei Longobardi 2000b, pp. 498-503.
C. Bertelli 2000d, Roma e i Longobardi nella crisi icono-clasta, in Futuro dei Longobardi 2000b, pp. 303-309.
C. Bertelli 2001a, I cicli pittorici e gli stucchi della basi-lica di San Salvatore, in San Salvatore-Santa Giulia2001, pp. 71-83.
C. Bertelli 2001b, La decorazione del Tempietto di Civi-dale, in Paolo Diacono 2001, pp. 437-453.
C. Bertelli 2002, Una regione italiana nel Medioevo eu-ropeo, in Lombardia medievale. Arte e architettura,Milano-Ginevra, pp. 9-130.
C. Bertelli 2004, Testimonianze epigrafiche e pittorichedel culto delle sante di Brescia, in Arte, cultura 2004,pp. 45-66.
C. Bertelli 2007, Dalla regina Ansa a Ludovico II, inDuemila anni di pittura a Brescia. i. Dall’età ro-mana al Cinquecento, Brescia, pp. 77-85.
M. Bettelli BerGAMAsCHi 1983, A proposito del “privile-gium” di Paolo I per il monastero bresciano di S. Sal-vatore (sec. VIII), i, in “nuova rivista storica”, 67, pp.119-137.
M. Bettelli BerGAMAsCHi 1984, A proposito del “privile-gium” di Paolo I per il monastero bresciano di S. Sal-vatore (sec. VIII), ii, in “nuova rivista storica”, 68,pp. 139-174.
M. Bettelli BerGAMAsCHi 1986, Per la storia del sito di S.Salvatore-S. Giulia: il contributo di due fonti tra XIIIe XV secolo, in “nuova rivista storica”, 80, n. 1, pp.35-74.
M. Bettelli BerGAMAsCHi 1992, Pallii serici a Brescia nelmonastero di Ansa e Desiderio, in Santa Giulia 1992,pp. 147-162.
F. Betti 1993, L’Alto Medioevo: decorazione architetto-nica e suppellettile liturgica, in p. zAMpetti (ed.), Scul-tura nelle Marche, Firenze, pp. 83-96.
F. Betti 1996, s.v. Liutprando, in Enciclopedia dell’ArteMedievale, roma, Vi (www.treccani.it).
F. Betti 2005, La diocesi di Sabina, Corpus della sculturaaltomedievale XVii, spoleto.
F. Betti 2007, Lapicidi longobardi fra Pentapoli, Piceno,Sabina e Roma. Un aggiornamento critico sulla scul-tura di VIII secolo nel ducato di Spoleto, in “Arte Me-dievale”, 1, pp. 47-64.
A. BettinAzzi 2005, L’età Romana e l’Alto Medioevo, in A.BettinAzzi, A. sAnGiorGi, Museo civico di Leno, le col-lezioni archeologiche nel contesto del popolamentodella bassa pianura bresciana, leno, pp. 61-137.
l. Bezzi MArtini 1987, Necropoli e tombe romane di Bre-scia e dintorni, Brescia.
s. Bini 2000, La chiesa di San Siro in Sospiro e la sua torrecampanaria. Una questione aperta nell’architetturaromanica veronese, in “Bollettino storico Cremo-nese”, Vii, pp. 13-42.
546
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 16/07/14 10.54 Pagina 546
BiBlioGrAFiA
J. BisHop et al. 2005, Domus B, in Santa Giulia 2005, pp.67-140.
s. Bistoletti BAnderA 1990 (ed.), Il sacello di San Satiro.Storia, ritrovamenti, restauri, Milano.
H. BlAKe 1995, Santa Maria delle Cacce: lo scavo archeo-logico del 1979, in H. BlAKe (ed.), Archeologia ur-bana a Pavia. i, pavia, pp. 163-192.
M. BlAnCHArd 1973 (ed.), Répertoire graphique du décorgéométrique dans la mosaïque antique, in “Bulletind’information de l’Association internationale pourl’Étude de la Mosaïque Antique”, 4.
H. BoBer 1967, On the illumination of the Glazier Codex:a contribution to early Coptic art and its relation toHiberno-Saxon interlace, in H. leHMAnn-HAupt (ed.),Homage to a Bookman: Essays on Manuscripts, Booksand Printing Written for Hans P. Kraus on his 60th
Birthday, Berlin, pp. 31-49.
G.p. BoGnetti 1952, Storia, archeologia e diritto nel pro-blema dei Longobardi, in Atti del I Congresso Inter-nazionale di Studi Longobardi (spoleto, 27-30settembre 1951), spoleto, pp. 71-136.
G.p. BoGnetti 1963, La Brescia dei Goti e dei Longobardi,in Storia di Brescia, Brescia, i, pp. 393-446.
G.p. BoGnetti, G. CHieriCi, A. de CApitAni d’ArzAGo 1948,Santa Maria di Castelseprio, Milano.
F. BoloGnA 1978, La pittura italiana delle origini, roma(2ª ed.).
i. BónA 1966, Bemerkungen zur Baugeschichte der BasilikaSan Salvatore zu Brescia, in “Acta archaeologica Aca-demiae scientiarum Hungaricae”, XViii, pp. 327-333.
l. BonA MortArA ottolenGHi 1964, Il dittico di Davide eSan Gregorio nel tesoro del Duomo di Monza, in“Arte lombarda”, iX, pp. 55-60.
A. BonAnni 1992, Catalogo delle sculture altomedievali,in F. GuidoBAldi, C. BArsAnti, A. GuiGliA GuidoBAldi
(edd.), San Clemente. La scultura del VI secolo,roma, pp. 321-376.
A. Bonini 1992, Cenni preliminari sul reimpiego di alcuneepigrafe romane negli edifici sacri di Brescia nei secolitra il XII ed il XV, in “dai Civici Musei d’Arte e storiadi Brescia. studi e notizie”, 4, pp. 91-100.
M. BordA 1958, La pittura romana, Milano.
r. BosCHi 1978, L’inventario architettonico, in San Sal-vatore 1978a, pp. 41-102.
G. BoVini 1975, Il battistero paleocristiano di Brescia edil problema della provenienza e della datazione dellecolonne e dei capitelli che l’adornano, in Capitolium1975, ii, pp. 287-294.
M. BrAdley 2009, The importance of colour on ancient mar-ble sculpture, in “Art History”, 32, n. 3, pp. 427-457.
s. BrAGA 2001, Le vicende del complesso monastico nelXIX secolo fino all’apertura del Museo Cristiano, inSan Salvatore-Santa Giulia 2001, pp. 319-327.
H. BrAndenBurGH 2004, Die frühchristlichen Kirchen inRom, regensburg.
W. BrAunsFels 1991, s.v. Aquisgrana, in Enciclopedia del-l’arte medievale (www.treccani.it).
A. BredA 1985, Brescia S. Giulia. Sondaggi nei cortili cen-trale e occidentale, in “notiziario della soprinten-denza Archeologica della lombardia”, 1985, pp.113-115.
A. BredA 1992-1993, Brescia, Via Musei 45, Acquedottoaltomedievale, in “notiziario della soprintendenzaArcheologica della lombardia”, 1992-1993, p. 108.
A. BredA 2001, Strutture architettoniche e fonti scritte, inSan Salvatore-Santa Giulia 2001, pp. 143-149.
A. BredA 2006a, Brescia, chiesa di San Giorgio, in “noti-ziario della soprintendenza Archeologica della lom-bardia”, 2003-2004, pp. 223-226.
A. BredA 2006b, L’indagine archeologica nel sito dell’ab-bazia di S. Benedetto di Leno, in San Benedetto “adLeones” 2006, pp. 111-140.
A. BredA 2008, Brescia tra preistoria e medioevo. Unasintesi di storia urbana, in n. BerluCCHi, M. Bonetti
(edd.), Brescia, le radici del futuro. Conversazioni suBrescia: passato, presente, futuro, Brescia, pp. 1-21,90-96.
B. BrenK 1966, Tradition und Erneuerung in der christ-lichen Kunst des ersten Jahrtausends. Studien zur Ge-schichte des Weltgerichtsbildes, Vienna.
B. BrenK 1973, Die frühchristlichen Mosaiken in S. MariaMaggiore zu Rom, Wiesbaden.
B. BrenK 1987, Spolia from Constantine to Charlemagne:aesthetics versus ideology, in “dumbarton oaks pa-pers”, Xli, pp. 102-109.
B. BrenK 2003, Committenza e retorica, in e. CAstel-nuoVo, G. serGi (edd.), Arti e storia nel Medioevo, ii,Del costruire: tecniche, artisti, artigiani, committenti,torino, pp. 3-42.
B. BrenK 2005, Architettura e immagini del sacro nellaTarda Antichità, spoleto.
G. BrenteGAni 1995-1997, Brescia, teatro romano. Scavostratigrafico, in “notiziario della soprintendenza Ar-cheologica della lombardia”, 1995-1997, pp. 187-188.
Brescia 1998, F. MorAndini, C. stellA (edd.), Santa Giu-lia, Museo della città. L’età romana. La città, le iscri-zioni, Milano 1998.
Brescia 1999, G.p. BroGiolo et al., L’età altomedievale:Longobardi e Carolingi, San Salvatore, Milano 1999.
Brescia altomedievale 1988, G. pAnAzzA, G.p. BroGiolo
(edd.), Ricerche su Brescia altomedievale, I, Gli studifino al 1978. Lo scavo di via Alberto Mario, Brescia1988.
Brescia romana 1979, Brescia romana. Materiali per unMuseo, I-II, Catalogo della Mostra (Brescia, 1979),Brescia 1979.
u. BroCColi 1981, La diocesi di Roma. Il Suburbio, 1, Cor-pus della scultura altomedievale Vii, tomo 5, spoleto.
G.p. BroGiolo 1989a, Analisi stratigrafica del San Salva-tore di Brescia. Nota preliminare, in “dai civici museid’Arte e di storia di Brescia. studi e notizie”, 3, pp.25-40.
G.p. BroGiolo 1989b, Civitas, chiese e monasteri, in Sir-mione longobarda 1989, pp. 13-64.
547
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 16/07/14 10.54 Pagina 547
BiBlioGrAFiA
G.p. BroGiolo, M. iBsen, V. GHeroldi 2008, Nuovi datisulla cripta del San Salvatore di Brescia, in Monasteriin Europa occidentale 2008, pp. 211-238.
C. BronK rAMsey 2005, OxCal Program v3.10, onlinemanual (http://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal3/oxcal.htm).
C. BronK rAMsey 2009, Bayesian analysis of radiocarbondates, in “radiocarbon”, 51, n. 1, pp. 337-360.
C. BronK rAMsey 2014, OxCal 4.2 Manual, (https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcalhelp/hlp_contents.html).
s.t. BrooKs, J.M. suCHey 1990, Skeletal age determinationbased on the Os Pubis: a comparison of the Acsadi-Nemeskeri and Suchey-Brooks methods, in “Humanevolution”, 5, pp. 227-238.
M. Brozzi, A. tAGliAFerri 1959-1960, Capitelli barbarici.Arte dell’alto Medioevo nel territorio bresciano, Bre-scia.
M. Brozzi, A. tAGliAFerri 1960, Arte longobarda, I, Lascultura figurativa su marmo, Cividale.
i. BroWninG 1979, Palmyra, london.
l. BruBAKer 1991, The introduction of painted initials inByzantium, in “scriptorium”, 45, pp. 22-46.
l. BruBAKer 1999, Vision and Meaning in Ninth-Century,Byzantium. Image as Exegesis in the Homilies of Gre-gory of Nazianzus, Cambridge.
l. BruBAKer 2000, 100 years of solitude: Santa Maria An-tiqua and the history of Byzantine art history, in J.osBorne, J. rAsMus BrAndt, G. MorGAnti (edd.), SantaMaria Antiqua al Foro Romano cento anni dopo,roma, pp. 41-47.
G. BrunAti 1854-1855, Vita o gesta di santi bresciani, 2voll., Brescia.
H. BuCHtHAl 1938, The Miniatures of the Paris Psalter,london.
d. BuCKton 1988, Byzantine enamel and the west, in J.d.HoWArd-JoHnston (ed.), Byzantium and the West c.850-c.1200, proceedings of the XViii spring sympo-sium of Byzantine studies (oxford, 30th March-1st
April 1984), Amsterdam, pp. 235-244.
d. BuCKton 1996, Early Christian and Byzantine art, VII,7(ii)(b): enamels, in J. turner (ed.), Dictionary of Art,9, london, pp. 659-663.
H. BusCHHAusen 1971, Die spätrömischen Metallscriniaund frühchristlichen Reliquiare, Wien.
F. Butturini 1987, La pittura frescale dell’anno Mille nelladiocesi di Verona, Verona.
A. CAGnAnA et al. 2003, Indagini archeometriche sui ma-teriali da costruzione del “Tempietto” di Santa Mariain Valle di Cividale del Friuli. I parte: gli affreschi al-tomedievali, in “Archeologia dell’Architettura”, Viii,pp. 69-87.
A. CAGnAnA, s. roAsCio, A. zuCCHiAtti 2009, Stratigrafiedegli intonaci e analisi archeometriche dei pigmentidegli affreschi altomedievali di Santa Maria di Ca-stelseprio, in G. Volpe, p. FAViA (edd.), V CongressoNazionale di Archeologia Medievale (Foggia-Manfre-donia, 30 settembre-3 ottobre 2009), Firenze, pp.111-115.
548
G.p. BroGiolo 1991, Trasformazioni urbanistiche nellaBrescia longobarda. Dalle capanne in legno al mo-nastero regio di San Salvatore, in G.C. Menis (ed.),Italia longobarda, Venezia, pp. 101-128 (ripubblicatocome BroGiolo 1992).
G.p. BroGiolo 1992, Trasformazioni urbanistiche nellaBrescia longobarda: dalla capanne in legno al mo-nastero regio di S. Salvatore, in Santa Giulia 1992,pp. 179-210.
G.p. BroGiolo 1993, Brescia altomedievale, urbanisticaed edilizia dal IV al IX secolo, Mantova.
G.p. BroGiolo 1998, La sequenza altomedievale dellacripta di San Salvatore in Brescia, in Wandmalereides frühen Mittelalters 1998, pp. 35-39.
G.p. BroGiolo 1999a, Introduzione, in Santa Giulia 1999,pp. 13-24.
G.p. BroGiolo 1999b, La nuova sequenza architettonicae il problema degli affreschi del San Salvatore a Bre-scia, in A. CAdei et al. (edd.), Arte d’Occidente. Temie metodi. Studi in onore di Angiola Maria Romanini,roma, pp. 25-34.
G.p. BroGiolo 2000a, La chiesa di San Salvatore in Bre-scia: architettura, in Futuro dei Longobardi 2000b,pp. 496-498.
G.p. BroGiolo 2000b, Desiderio e Ansa a Brescia: dallafondazione del monastero al mito, in Futuro dei Lon-gobardi 2000a, pp. 143-155.
G.p. BroGiolo 2001a, Luoghi di culto tra VII e VIII secolo:prospettive della ricerca archeologica alla luce delconvegno di Garda, in Chiese 2001, pp. 199-204.
G.p. BroGiolo 2001b, Gli edifici monastici nelle fasi al-tomedievali, in San Salvatore-Santa Giulia 2001, pp.61-69.
G.p. BroGiolo 2001c, Urbanistica di Cividale longo-barda, in Paolo Diacono 2001, pp. 357-385.
G.p. BroGiolo 2002, Oratori funerari tra VII e VIII secolonelle campagne transpadane, in “Hortus Artium Me-dievalium”, 8, pp. 9-31.
G.p. BroGiolo 2004, Sepolture privilegiate altomedievalinel monastero di San Salvatore a Brescia, in “HortusArtium Medievalium”, 10, pp. 15-24.
G.p. BroGiolo 2005, Processi di stratificazione del Pe-riodo III nelle domus di Santa Giulia (450-680), inSanta Giulia 2005, pp. 321-395.
G.p. BroGiolo 2007, Archeologia e società tra tardo An-tico e alto Medioevo, in Archeologia e società 2007,pp. 7-22.
G.p. BroGiolo 2009, Architetture e tecniche costruttive inetà longobarda: i dati archeologici, in Magistri com-macini 2009, pp. 211-237 e tavv. i-Viii.
G.p. BroGiolo 2013, Per una storia religiosa di Castelse-prio: il complesso di Torba e la chiesa di S. Maria forisportas, in Castelseprio 2013, pp. 213-254.
G.p. BroGiolo, V. GHeroldi, M. iBsen, J. MitCHell 2010,Ulteriori Ricerche sul San Salvatore II di Brescia, in“Hortus Artium Medievalium”, 16, pp. 209-232.
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 16/07/14 10.54 Pagina 548
BiBlioGrAFiA
l. CAlVelli 2012, Il reimpiego epigrafico a Venezia: i ma-teriali provenienti dal campanile di San Marco, inRiuso 2012, pp. 179-202.
A. CAlzonA 1991, La rotonda e il palatium di Matilde,parma.
A. CAlzonA 2006, Scheda [1], in Medioevo delle cattedrali2006, pp. 415-417.
A. CAMpese siMone 2003, Iscrizioni funerarie cristiane del-l’Apulia fra Tardoantico ed alto Medioevo, in r. Fio-rillo, p. peduto (edd.), III Congresso Nazionale diArcheologia Medievale (salerno, 2-5 ottobre 2003), i,Firenze, pp. 135-140.
M-t. CAMus 1996, Les stucs peints de Vouneuil-sous-Biard,in Stuck 1996, pp. 56-60.
A. CAnCi, s. Minozzi 2005, Archeologia dei resti umani,dallo scavo al laboratorio, roma.
M. CAnepA 2010, Distant displays of power: understandingcross-cultural interaction among the elites of Rome,Sassanian Iran, and Sui-Tang China, in “Ars orien-talis”, 38, pp. 121-154.
G. CAntino WAtAGHin 1995, La chiesa abbaziale: l’edificioe le sue vicende, in Abbazia di dei Ss. Pietro e Andreadi Novalesa. Dedicazione della chiesa, 15 ottobre1995, novalesa.
G. CAntino WAtAGHin 1999, Monasterium... in loco quivocatur Sexto. L’archeologia per la storia dell’abbaziadi Santa Maria di Sesto, in G.C. Menis, A. tilAtti,L’abbazia di Santa Maria di Sesto fra archeologia estoria, pordenone, pp. 3-51.
G. CAntino WAtAGHin 2000, Monasteri tra VIII e IX secolo:evidenze archeologiche per l’Italia settentrionale, inFuturo dei Longobardi 2000a, pp. 129-141.
Capitolium 1975, Atti del Convegno internazionale per ilXIX centenario della dedicazione del Capitolium eper il 150° anniversario della sua scoperta (Brescia,27-30 settembre 1973), Brescia, i-ii, 1975.
G. CAputo 1959, Il teatro romano di Sabratha e l’archi-tettura teatrale africana, roma.
r. CArdAni VerGAni 2001, Ricerche archeologiche, in “Bol-lettino storico della svizzera italiana”, s. 8, 104, n. 1,pp. 205-209.
s. CArellA 2003, Sainte-Sophie de Bénévent et l’architec-ture religieuse longobarde en Italie méridionale, in“Hortus Artium Medievalium”, 9, pp. 331-356.
G. CArletti 1795, Memorie istorico-critiche della chiesa emonastero di San Silvestro in capite di Roma, roma.
Carlo Magno 2001, Carlo Magno a Roma, Catalogo dellaMostra (Città del Vaticano, 16 dicembre 2000-31marzo 2001), roma.
Carlo Magno e le Alpi 2007, Carlo Magno e le Alpi, Attidel Xiii Congresso internazionale di studio sull’altomedioevo (susa-novalesa, 19-21 ottobre 2006), spo-leto 2007.
Carta Archeologica Brescia 1996, F. rossi (ed.), Carta Ar-cheologica della Lombardia, V, Brescia: la città, Mo-dena 1996.
p. CAsAdio, t. perusini, p. spAdeA 1996, Zu Stuckdecorationdes “Tempietto longobardo” in Cividale: technischeund naturwisseschaftliche Untersuchungsergebnisse,in Stuck 1996, pp. 37-51.
s. CAsArtelli noVelli 1974, La diocesi di Torino, Corpusdella scultura altomedievale Vi, spoleto.
s. CAsArtelli noVelli 1978, Confini e bottega «provinciale»delle Marittime nel divenire della scultura longo-barda dai primi del secolo VIII all’anno 774, in “sto-ria dell’Arte”, 32, pp. 11-21.
M. CAstAGnArA Codeluppi 2001, L’allestimento del Museo,in San Salvatore-Santa Giulia 2001, pp. 411-415.
e. CAstelnuoVo 1983, Arte delle città, arte delle corti traXII e XIV secolo, in F. zeri (ed.), Storia dell’arte ita-liana. Dal Medioevo al Quattrocento, torino, i, pp.167-216.
Castelseprio 2013, p.M. de MArCHi (ed.), Castelseprio eTorba. Sintesi delle ricerche e aggiornamenti, Man-tova 2013.
d. CAstriotA 1995, The Ara Pacis Augustae and the Im-agery of Abundance in Later Greek and Early RomanImperial Art, princeton.
l. CAtAlAno 2008, Sculture medievali dall’abbazia di SanVincenzo al Volturno, in “Hortus Artium Medieva-lium”, 14, pp. 207-230.
r. CAttAneo 1888, L’architettura in Italia dal secolo IV alMille circa. Ricerche storico-critiche del prof. RaffaeleCattaneo, Venezia.
r. CAttAneo 1890, L’architecture en Italie du 6. au 11.siècle: recherches historiques et critiques, Venise.
G. CAVAlieri MAnAsse 1990, Il monumento funerario ro-mano di via Mantova a Brescia, roma.
M.e. CApriolo 1976, Dell’istorie della città di Brescia, Bo-logna (rist. anast.: Historiae urbium et regionum Ita-liae rariores, CXXii = n.s., XXXViii).
C. CeCCHelli 1943, I monumenti del Friuli dal secolo IVall’XI, I, Cividale, roma.
C. CeCCHelli 1952, Osservazioni sull’arte barbarica in Ita-lia, in Atti del I Congresso Internazionale di StudiLongobardi (spoleto, 1951), spoleto, pp. 137-151.
C. CeCCHelli 1957, Modi orientali e occidentali nell’artedel secolo VII in Occidente, in Caratteri del secolo VIIin Occidente, spoleto, pp. 371-426.
l. CerViGni 2011, Nuove ricerche sul monastero di SanSalvatore di Sirmione, in Chiese del Garda 2011, pp.65-82.
Charlemagne 1965, Charlemagne. Oeuvre, Rayonnementet Survivances, Catalogue de l’exposition (Aix-la-Chapelle, 26 juin-19 septembre 1965), Aix-la-Cha-pelle 1965.
A. CHAVArríA 2009, Archeologia delle chiese. Dalle originiall’anno Mille, roma.
A. CHAVArríA, A. CrosAto 2006, Chiese rurali nel manto-vano tra Tardoantico e Altomedioevo, in G. AndennA,G.p. BroGiolo, r. sAlVArAni, Le origini della diocesidi Mantova e le sedi episcopali dell’Italia Settentrio-nale (IV-XI secolo), in “Antichità Altoadriatiche”, 63,pp. 383-419.
549
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 16/07/14 10.54 Pagina 549
BiBlioGrAFiA
p. CHeVAlier 1996, Ecclesiae Dalmatiae. Salona II, rome-split.
p. CHeVAlier 1999, Les installations liturgiques des églisesd’Istrie du V au VII siècle, in “Hortus Artium Medie-valium”, 5, pp. 105-117.
Chiesa di San Salvatore 1962, G. pAnAzzA, A. peroni
(edd.), La chiesa di San Salvatore in Brescia, Attidell’Viii Congresso di studi sull’Arte dell’Alto Me-dioevo, ii, Milano 1962.
Chiese 2001, G.p. BroGiolo (ed.), Le chiese rurali tra VIIe VIII secolo in Italia settentrionale, Viii seminariosul tardo Antico e l’Alto Medioevo in italia setten-trionale (Garda, 8-10 aprile 2000), Mantova 2001.
Chiese 2003, G.p. BroGiolo, M. iBsen, V. GHeroldi, A. Co-leCCHiA, Chiese dell’Alto Garda Bresciano. Vescovi,eremiti, monasteri, territorio tra tardoantico e roma-nico, Mantova 2003.
Chiese del Garda 2011, G.p. BroGiolo (ed.), Nuove ricer-che sulle chiese altomedievali del Garda, iii Conve-gno Archeologico del Garda (Gardone riviera, 6novembre 2010), Mantova 2011.
l. CHinellAto, M.t. CostAntini 2004, L’altare di Ratchis.L’originaria finitura policroma: prospetto frontale eposteriore, in “Forum iulii”, 28, pp. 133-156.
Christiana loca 2001, l. pAni erMini (ed.), Christianaloca. Lo spazio cristiano nella Roma del primo mil-lennio, Catalogo della Mostra (roma, 5 settembre-15novembre 2000), roma 2001.
G. CiAMpoltrini 1991a, “Pulchrius ecce micat nitentesmarmoris decus”. Appunti sulla scultura d’età longo-barda nella Toscana meridionale, in “prospettiva”,64, pp. 43-48.
G. CiAMpoltrini 1991b, Marmorari lucchesi d’età longo-barda, in “prospettiva”, 61, pp. 42-49.
F. CiliBerto 1996, I sarcofagi attici nell’Italia settentrio-nale, Bern.
l. CiriMBelli 1993, Leno, Dodici secoli nel cuore dellaBassa. Il territorio, gli eventi, i personaggi, Borgoponcarale.
G. ClAusse 1897, Les marbes romains et le mobilier pres-byterial, paris.
H. ClAussen, A. sKriVer 2007, Die Klosterkirche Corvey, 2,Wandmalerei und Stuck aus karolingischer Zeit,Mainz.
M.e. ColoMBo 1994-1995, Il vasso Eremberto e la chiesadei SS. Primo e Feliciano a Leggiuno: lettura archeo-logica di un edificio di committenza carolingia, tesidi laurea in Archeologia Medievale, università deglistudi di udine, rel. prof.ssa s. lusuardi siena.
M. ConWAy 1919, Lombard architecture by A.K. Porter. areview, in “the Burlington Magazine”, 34, pp. 175-177, 180-182.
G. Cordero di sAn Quintino 1829, Dell’Italiana Architet-tura durante la dominazione longobarda, Brescia.
r.s. CorMACK 1969, The mosaic decoration of S.Demetrios Thessaloniki – a re-examination in thelight of the drawings of W.S.George, in “the Annualof the British school of Archaeology at Athens”, 64,pp. 17-52.
Costantino 2012, G. senA CHiesA (ed.), Costantino 313d.C., Catalogo della Mostra (Milano, 25 ottobre 2012-17 marzo 2013; roma, 11 aprile-17 settembre 2013),Milano 2012.
t. CreAzzo, G. strAno (edd.), Atti del VI congresso Na-zionale dell’Associazione Italiana di Studi Bizantini(Catania-Messina, 2-5 ottobre 2000), Catania.
K.A.C. CresWell 1979, Early Muslim Architecture, 1, newyork.
F. CriVello 2010, I Longobardi e il manoscritto di lusso.Elementi testuali per la storia della miniatura, in Ot-tavo secolo 2010, pp. 314-319.
A. Crosetto 1998, Croci e intrecci: la scultura altomedie-vale, in l. MerCAndo, e. MiCHeletto (edd.), Archeolo-gia in Piemonte. Il medioevo, torino, pp. 309-323.
A. Crosetto 1999, Sculture altomedievali dalla città e dalterritorio, in e. MiCHeletto (ed.), Una città nel me-dioevo. Archeologia e architettura ad Alba dal VI alXV secolo, Alba, pp. 169-189.
A. Crosetto 2001, Decorazioni scultoree dalle chiese ru-rali nel Piemonte altomedievale (VII-VIII secolo), inChiese 2001, pp. 55-62.
e. CulAsso GAstAldi 1977, L’Amazzonomachia “teseica”nell’elaborazione propagandistica ateniese, in “Attidella Accademia delle scienze di torino. Classe discienze Morali, storiche e Filologiche”, 111, pp. 283-296.
Culto e storia 2001, G. AndennA (ed.), Culto e storia aSanta Giulia, Atti del Convegno (Brescia, 20 ottobre2000), Brescia 2001.
A. Cutler 1999, Reuse or use? Theoretical and practicalattitudes toward objects in the Early Middle Ages, inIdeologie e pratiche del reimpiego nell’alto Medioevo,XlVi settimana CisAM, spoleto, pp. 1055-1079.
A.M. d’ACHille 1993, s.V. Ciborio, in Enciclopedia del-l’Arte Medievale, roma, iV, pp. 718-735.
p. d’AnConA, F. WittGens, i. CAttAneo 1934, L’arte ita-liana, i, Firenze.
M. d’onoFrio 1993, s.V. Campania, in Enciclopediadell’Arte Medievale, iV, pp. 91-101.
M. dAll’ACQuA 1968, Terrecotte medievali della Rotondadi San Lorenzo in Mantova, in “Civiltà Mantovana”,18, pp. 351-358.
H. dAnnHeiMer 1986, Zur Rekonstruction der Chorschran-ken von Mals, in s. spAdA pintArelli (ed.), Festschrift/Scritti in onore di Nicolò Rasmo, Bolzano, pp. 93-102.
p. dArMstädter 1896, Das Reichsgut in der Lombardei(568-1250), strasburg.
C. dAVis Weyer 1987, Müstair, Milano e l’Italia carolin-gia, in C. Bertelli (ed.), Milano. Una capitale da Am-brogio ai Carolingi, Milano, pp. 202-238.
A. dAVril, t.M. tHiBodeu 1995, Guillelmi Duranti Ratio-nale Divinorum Officiorum i. Corpus Christianorum,Continuo Mediaevalis 140, turnhout.
A. de CApitAni d’ArzAGo 1952, La Chiesa Maggiore di Mi-lano, Milano.
550
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 16/07/14 10.54 Pagina 550
BiBlioGrAFiA
F. dell’ACQuA 2008, “Nisi ipse Daedalus […] nisi Beseleelsecundus”. L’attività artistica presso il monastero diSan Vincenzo al Volturno, in Monasteri in Europaoccidentale 2008, pp. 275-288.
A. dell’ACQuA 2008-2009, I portici del foro di Brescia: re-visione dell’alzato e catalogo della decorazione ar-chitettonica, tesi di laurea specialistica, universitàCattolica del sacro Cuore, rel. prof. F. sacchi.
p. deloGu 1991, s.v. Desiderio, in Dizionario biograficodegli Italiani, roma, 39, pp. 373-381.
p. deloGu 1992, Patroni, donatori, committenti nell’Italiameridionale longobarda, in Committenti e produ-zione artistico-letteraria nell’alto medioevo occiden-tale, XXXiX settimana CisAM, spoleto, pp. 302-339.
o. deMus 1969, Pittura murale romanica, Milano.
A. deroKo 1954, L’entrelacs en Serbie et en Croatie auMoyen Age, in Antidoron in onore di M. Abramiç, i,split (“Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatin-sku/Bulletin d’archéologie et d’histoire dalmate”, lVi-liX), pp. 252-260.
r. desHMAn 1980, The exalted servant; ruler theology inthe Prayerbook of Charles the Bald, in “Viator”, 11,pp. 385-417.
r. desHMAn 1989, Servants of the mother of God inByzantine and Medieval art, in “Word and image”,5, pp. 33-70.
G. despinis, tH. steFAnidou tiVeriou, eM. VoutirAs 1997,Catalogue of sculpture in the Archaeological Museumof Thessaloniki, thessaloniki.
e. desteFAnis 2008, La diocesi di Piacenza e il monasterodi Bobbio, Corpus della scultura altomedievale XViii,spoleto.
W. deVriendt et al. 2004, Two Neolithic cases of Hypero-stosis Frontalis Interna, in “international Journal ofosteoarchaeology”, 14, pp. 414-418.
e.t. deWAld 1932, The Illustrations of the Utrecht Psalter,princeton.
d. deXHeiMer 1998, Oberitalische Grabaltäre. Ein Beitragzur Sepulkralkunst der römischen Kaiserzeit, oxford.
A. di Muro 1996, La cultura artistica della Langobardiaminor nell’VIII secolo e la decorazione pavimentale eparietale della cappella palatina di Archechi II aSalerno, salerno.
p. diAnzAni 1989, Santa Maria d’Aurona a Milano. Fasealtomedievale, torino.
e. doBerer 1965, Die ornamentale Steinskulptur an der ka-rolingische Kirchenausstattung, in Karl der Grosse1965, pp. 203-233.
W. doriGo 2003, La cultura carolingia della prima “ca-pella Sancti Marci”, in “Hortus Artium Medievalium”,8, pp. 149-156
A. duCCi 2010a, Frammento di lastra [n. 47], in Lucca el’Europa 2010, pp. 90-91.
A. duCCi 2010b, Le sculture di Badia di Cantignano,Lucca [n. 48], in Lucca e l’Europa 2010, pp. 92-95.
B.H. dudAy 2006, Lezioni di archeotanatologia, roma.
551
p. de dArtein 1865-1882, Études sur l’Architecture lom-barde et sur les origines de l’Architecture romane-by-zantine, paris.
p.M. de MArCHi, A. BredA 2000, Il territorio bresciano inetà longobarda e la necropoli di Leno, in Futuro deiLongobardi 2000b, pp. 472-477.
F. de ruBeis 1999, Desiderio re o Ludovico imperatore?,in Brescia 1999, pp. 103-104.
F. de ruBeis 2000, La tradizione epigrafica in Paolo Dia-cono, in Paolo Diacono 2000, pp. 139-162.
F. de ruBeis 2011a, Inscriptiones Medii Aevi Italiae, 3,Veneto: Belluno, Treviso, Vicenza, spoleto.
F. de ruBeis 2011b, La capitale damasiana a Tours: espe-rimenti ed effimere primavere, in “sCriptA. An in-ternational Journal of Codicology and palaeography”,3, pp. 57-72.
F. de ruBeis 2012, La lettera di Lupo di Ferrières e la ri-nascita della capitale epigrafica: alcune riflessioni sultermine “mensura”, in p. CHeruBini, G. niColAJ (edd.),Sit liber gratus, quem servulus est operatus. Studi inonore di Alessandro Pratesi per il suo 90° comple-anno, Città del Vaticano, pp. 123-131.
F. de ruBeis 2013, Il corpus epigrafico dell’abbazia di SanGiovanni di Müstair, in H.r. sennHAuser et al. (edd.),Wandel und Konstanz zwischen Bodensee und Lom-bardei, zur Zeit Karls des Grossen, Kloster St. Johannin Müstair und Churrätien, zurigo, pp. 285-297.
l. de VAnnA 1988, L’area della basilica tra tardoantico emedioevo, in F. rossi (ed.), Piazza Labus a Brescia el'antica basilica. Scavi archeologici e recupero archi-tettonico nella nuova sede della Soprintendenza Ar-cheologica della Lombardia a Brescia, Milano, pp.49-64.
n.C. deBeVoise 1941, The origin of decorative stucco, in“American Journal of Archaeology”, 45, n. 1, pp. 45-61.
l. dei et al. 1998, Green degradation products of azuritein wall paintings: identification and conservationtreatment, in “studies in Conservation”, 43, n. 2, pp.80-88.
F.W. deiCHMAnn 1958, Frühchristliche Bauten und Mo-saiken von Ravenna, Baden-Baden.
F.W. deiCHMAnn 1969, Ravenna. Hauptstadt des spätan-tiken Abendlandes, 1, Geschichte und Monumente,Wiesbaden.
F.W. deiCHMAnn 1974, Ravenna. Hauptstadt des spätan-tiken Abendlandes, 2, Kommentar, Wiesbaden.
d.M. deliyAnnis 2010, Ravenna in Late Antiquity, Cam-bridge.
A. dell’ACQuA 2012, La decorazione architettonica delCapitolium di Brescia: catalogo dei materiali, in“lanx”, 12, pp. 80-157.
F. dell’ACQuA 2003a, “Illuminando colorat”: la vetratatra l’età tardo imperiale e l’alto Medioevo. Le fonti,l’archeologia, spoleto.
F. dell’ACQuA 2003b, “Mundus habet noctem detinet auladiem”. Il vetro nelle architetture di Brescia, Cividale,Salerno, San Vincenzo al Volturno, Farfa, nuovi datiscientifici, in Longobardi 2003, pp. 1351-1371.
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 16/07/14 10.54 Pagina 551
BiBlioGrAFiA
n. duVAl 1995 (ed.), Les premiers monuments chrétiensde la France 1, Sud-Est et Corse, paris.
A. eBAni 1973, “Antico” e “longobardo” nella scultura mi-lanese di età carolingia: note su alcuni capitelli e la-stre scolpite di San Vincenzo in Prato a Milano, in“Commentari”, 24, pp. 3-18.
A. eBAni 1978, Elementi celtici in alcuni documenti dellaCremona altomedievale, in “storia dell’Arte”, 34, pp.189-195.
V.H. elBern 1966, Vier karolingische Elfenbein-Kästen. His-torische, symbolische und liturgische Elemente in derspätkarolingischen Bildkunst, in “zeitschrift des deut-schen Vereins für Kunstwissenschaft”, 20, pp. 1-16.
J. elsner 2002, The birth of Late Antiquity: Riegl andStrzygowski in 1901, in “Art History”, 25, n. 3, pp.358-379.
J. eMeriCK 1998, The Tempietto del Clitunno near Spoleto,philadelphia.
J. eMeriCK 2001, Focusing on the Celebrant: the columndisplay inside Santa Prassede, in Arredi di culto 2001,pp. 129-159.
y. esQuieu 1995, Alba. Groupe cathédral Saint-Pierre, induVAl 1995, pp. 205-210.
r. ettinGHAusen, o. GrABAr, M. JenKins-MAdinA 2001, Is-lamic Art and Architecture 650-1250, new Haven-london.
n. eVerett 2003, Literacy in Lombard Italy, c. 568-774,Cambridge.
M. eXner 2003, Stucchi, in e. CAstelnuoVo, G. serGi
(edd.), Arti e storia nel Medioevo, II, Del costruire:tecniche, artisti, artigiani, committenti, torino, pp.655-673.
M. eXner 2007a, La pittura murale carolingia in ambitoalpino. Problemi di trasmissione della tradizione pit-torica tra l’VIII e la metà del IX secolo, in CarloMagno e le Alpi 2007, pp. 353-383.
M. eXner 2007b, Il programma iconografico della chiesaabbaziale nel contesto storico, in Müstair 2007, pp.83-108.
M. eXner 2010, La situazione della pittura murale nell’VIIIsecolo. Testimonianze nell’ambito franco, in Ottavo se-colo 2010, pp. 252-258.
M. FABriCius HAnsen 2003, The Eloquence of Appropria-tion. Prolegomena to an Understanding of Spolia inEarly Christian Rome, rome.
B. FAino 1665, Martyrologium Sanctae Brixianae Eccle-siae, Brescia.
M. FAllA CAstelFrAnCHi 1984, L’inedita tomba con arco-solio presso la cripta della cattedrale di Otranto, in“Vetera Christianorum”, 21, pp. 373-380.
r. FArioli CAMpAnAti 1991, La scultura architettonica e diarredo liturgico a Ravenna alla fine della tarda An-tichità: i rapporti con Costantinopoli, in A. CArile
(ed.), Storia di Ravenna, 2, Dall’età bizantina all’etàottoniana. 1. Territorio, economia e società, Venezia,pp. 249-267.
r. FArioli CAMpAnAti 2005, Ravenna e i suoi rapporti conCostantinopoli: la scultura (V-VI secolo), in C. riz-zArdi (ed.), Venezia e Bisanzio: aspetti della culturaartistica bizantina da Ravenna a Venezia (V-XIV se-colo), Venezia, pp. 13-43.
r.l. Feller 1967, Studies in the darkening of vermilionby light, in “report studies in the History of Arts”, pp.99-111.
d. FereMBACH, i. sCHWidetzKy, M. stlouKAl 1977-1979,Raccomandazioni per la determinazione dell’età edel sesso sullo scheletro, in “rivista di Antropologia”,60, pp. 5-51.
M.C. FerrAri 1999, Il “Liber Sanctae Crucis” di RabanoMauro. Testo, immagine, contesto, Berna.
e. Ferroni 1974, Chimica fisica degli intonaci affrescati,in G. urBAni (ed.), Problemi di conservazione, Bolo-gna, pp. 269-282.
p.A. FÉVrier 1995, Lançon-Provence. Basilique de l’oppi-dum de Constantine, in duVAl 1995, pp. 123-124.
F. FisoGni 2013, Il progetto della chiesa e della facciata.Architettura e cultura antiquaria a Brescia tra sei eSettecento, in La chiesa di Santa Maria della Carità,Brescia, pp. 19-39.
s. FiorillA 1985-1986, Laterizi decorati altomedievali delterritorio lombardo, in “sibrium”, 18, pp. 177-229.
C. Fiorio 1983-1984, I ritrovamenti veronesi nel quadrodelle sepolture altomedievali internamente intona-cate e dipinte dell’Italia Settentrionale, tesi di perfe-zionamento in Archeologia Medievale, universitàCattolica del sacro Cuore, rel. prof. M. Cagiano deAzevedo.
C. Fiorio tedone 1985, Tombe dipinte altomedievali rin-venute a Verona, in “Archeologia Veneta”, 8, pp. 251-286.
C. Fiorio tedone 1986, Dati e riflessioni sulle tombe alto-medievali internamente intonacate e dipinte rinve-nute a Milano e in Italia Settentrionale, in Milano1986, pp. 403-427.
C. Fiorio tedone 1989a, Verona, in Veneto nel Medioevo1989, ii, pp. 103-133.
C. Fiorio tedone 1989b, Santa Maria in Stelle in Val Pan-tena, in Veneto nel Medioevo 1989, ii, pp. 146-151.
C. Fiorio tedone, s. lusuArdi sienA 1987, Puntualizza-zioni archeologiche sulle due chiese paleocristiane,in p. BruGnoli (ed.), La cattedrale di Verona nelle suevicende edilizie dal secolo IV al secolo XVI, Venezia,pp. 26-78.
e.W. FitzHuGH 1986, Minium, in r.l. Feller (ed.), Artist’sPigment’s. A Handbook of their History and Charac-teristics, i, Washington, pp. 109-140.
r. FlAMinio 2011, Su un particolare tipo di colonna de-corata di età paleocristiana, in Marmoribus vestita,Miscellanea di studi in onore di Federico Guidobaldi,Città del Vaticano, ii, pp. 573-597.
M.l. FoBelli 2005, Un tempio per Giustiniano. Santa Sofiadi Costantinopoli e la Descrizione di Paolo Silenzia-rio, roma.
552
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 16/07/14 10.54 Pagina 552
BiBlioGrAFiA
G. FoGliArdi 2001, Testimonianze di pittura murale, ini. roGGer, e. CAVAdA (edd.), L’antica basilica di SanVigilio in Trento. Storia, archeologia, reperti, trento,pp. 545-584.
C.d. FonseCA 1968, Recenti studi sulla basilica del SS. Sal-vatore di Brescia, in “Brixia sacra. Memorie storichedella diocesi di Brescia”, n.s., iii, n. 1, pp. 37-39.
B. ForlAti tAMAro, F. ForlAti, F. BArBieri 1956, Il Duomodi Vicenza. Ritrovamenti e scoperte, l’architetturadella fabbrica, le opere d’arte, Vicenza.
G. FornACiAri, V. GiuFFrA 2009, Lezioni di paleopatologia,Genova.
G.H. ForsytH, K. WeitzMAnn 1973, The Monastery of SaintCatherine at Mount Sinai. The Church and Fortressof Justinian, Ann Arbor.
W. Foster 1934, Grecian and Roman stucco, mortar andglass, in “Journal of Chemical education”, 11, n. 4,pp. 223-225.
G. FoWden 2004, Qusayr ’Amra. Art and the UmayyadElite in Late Antique Syria, Berkeley-los Angeles-london.
t. FrAnCo 2007, Intorno a una pittura votiva altomedie-vale nell’ipogeo di Santa Maria in Stelle, in A. CAl-zonA, r. CAMpAri, M. Mussini (edd.), Immagine eideologia. Studi in onore di Arturo Carlo Quintavalle,Milano, pp. 73-76.
M. FrAnzini, C. GrAtziu 1988, Relazione finale sullo studiodi malte ed intonaci dell’abside di Santa Maria Forisportas (Castelseprio) in Bisanzio, Roma e l’Italianell’Alto Medioevo, XXXiV settimana CisAM (spoleto,1986), spoleto, ii, pp. 907-914.
i.C. Freestone 2003, Primary glass sources in the Mid FirstMillennium AD, in Annales du 15e Congres de l’As-sociation Internationale pour l’Histoire du Verre(new york-Corning, 2001), nottingham, pp. 111-115.
i.C. Freestone, F. dell’ACQuA 2005, Early medieval glassfrom Brescia, Cividale and Salerno, Italy: composi-tion and affinities, in d. FerrAri (ed.), Il vetro nel-l’alto medioevo, Atti del Viii Giornata nazionale distudio (spoleto, 20-21 aprile 2002), imola, pp. 65-75.
i.C. Freestrone, r.e. JACKson-tAl, o. tAl 2008, Raw glassand the production of glass vessels at Late ByzantineApollonia-Arsuf, Israel, in “Journal of Glass studies”,50, pp. 67-80.
A. Frondoni 1987, L’altomedioevo: età longobarda e ca-rolingia, in La scultura a Genova e in Liguria dalleorigini al Cinquecento, Genova, pp. 37-59.
A. FroVA 1979, Il teatro, in Brescia romana 1979, i, p.108.
Frühe Kirchen 2003, r.H. sennHAuser (ed.), Frühe Kir-chen im östlichen Alpengebiet von der Spätantike bisin ottonische Zeit, 2 voll., München 2003.
Futuro dei Longobardi 2000a, C. Bertelli, G.p. BroGiolo
(edd.), Il futuro dei Longobardi. L’Italia e la costru-zione dell’Europa di Carlo Magno. Saggi, Milano2000.
Futuro dei Longobardi 2000b, C. Bertelli, G.p. BroGiolo
(edd.), Il futuro dei Longobardi. L’Italia e la costru-zione dell’Europa di Carlo Magno, Catalogo dellaMostra (Brescia, 18 giugno-10 dicembre 2000), Mi-lano 2000.
H. GABelMAnn 1969, Altäre im Kapitol von Brescia, in“römische Mitteilungen”, 76, pp. 219-238.
H. GABelMAnn 1973, Die Werkstattgruppe der oberitali-schen Sarcophage, Bonn.
C. GABersCeK 1971, L’eredità sassanide nella scultura al-tomedievale in Friuli, in “Memorie storiche Forogiu-liesi”, 51, pp. 18-37.
C. GABersCeK 1972, L’“urna” di S. Anastasia e la rina-scenza liutprandea, in Scritti in memoria di PaoloLino Zovatto, Milano, pp. 109-115.
C. GABersCeK 1973, La scultura altomedievale in Friuli ein Lombardia, in Aquileia e Milano, in “Antichità Al-toadriatiche”, 4, pp. 383-404.
G. GAlAssi 1953, Roma o Bisanzio, II, Il congedo classicoe l’arte dell’alto medioevo, roma.
d. GAndolFi 1995, I rilievi altomedievali provenienti dairestauri della Cattedrale di Ventimiglia, in Millenariodella traslazione delle reliquie di S. Secondo, Atti delConvegno (15 dicembre 1990), in “rivista ingauna eintemelia”, n.s., 24-25, pp. 75-106.
F. GAndolFo 1998, s.v. Protiro, in Enciclopedia dell’ArteMedievale, roma, 9, pp. 755-759.
A. GArzetti, A. VAlVo 1999, Mantissa epigrafica bre-sciana, supplemento ai “Commentari dell’Ateneo diBrescia”, Brescia.
s. GAspArri 1978, I duchi longobardi, roma.
M.l. GAtti perer 1978, Testimonianze della cultura clu-niacense nel Bresciano, in San Salvatore 1978a, pp.129-140.
s. GAVinelli 2001, La liturgia del cenobio di Santa Giuliain età comunale e signorile attraverso il liber ordina-rius, in Culto e storia 2001, pp. 121-148.
s. GAVinelli 2007, Santa Sofia e le figlie, Fede, Speranzae Carità dipinte in Santa Salvatore – Santa Giulia diBrescia, in G. ArCHetti (ed.), Inquirere Veritatem.Studi in memoria di mons. Antonio Masetti Zannini,in “Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi diBrescia”, 12, n. 1-2), i, pp. 83-88.
r. GeM, e. HoWe, r. BryAnt 2008, The Ninth-Centurypolychrome decoration at St Mary’s Church, Deer-hurst, in “the Antiquaries Journal”, 88, pp. 109-164.
d. GeneQuAnd 2006, Some thoughts on Qasr al-Hayr al-Gharbi, its dam, its monastery and the Ghassanids,in “levant”, 38, pp. 63-83.
d. GeneQuAnd 2011, Les décors en stuc du bâtiment E àQasr al-Hayr al-Sharqi, in “syria”, 88, pp. 351-378.
r.J. Gettens, r.l. Feller, W.t. CHAse 1993, Vermillon andcinnabar, in A. roy (ed.), Artist’s Pigments. A Han-dbooks of their History and Characteristics, ii, Wa-shington, pp. 159-182.
553
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 16/07/14 10.54 Pagina 553
BiBlioGrAFiA
r. Gettens, e.W. FitzHuG 1993, Malachite and green ver-diter, in A. roy (ed.), Artist’s Pigment’s. A Handbookof their History and Characteristic, ii, Washington,pp. 23-26.
e.F. GHedini 1989, Un frammento di sarcofago con bat-taglia alle navi nel museo provinciale di Torcello, in“Aquileia nostra”, 60, coll. 193-206.
V. GHeroldi 2008, Il cunicolo Nord. Materiali e tecnichedi finitura, in BroGiolo, iBsen, GHeroldi 2008, pp.226-233.
V. GHeroldi 2010, Evidenze tecniche e interpretazionicronologiche, in BroGiolo, GHeroldi, iBsen, MitCHell
2010, pp. 224-232.
V. GHeroldi 2013, I rivestimenti aniconici e i dipinti mu-rali dell’abside est della chiesa di S. Maria foris portasa Castelseprio. Evidenze tecniche e relazioni strati-grafiche per la ricostruzione delle fasi storiche, in Ca-stelseprio 2013, pp. 255-292.
A. GHiroldi 2006, La chiesa di San Giorgio in platea, inM. FortunAti (ed.), Medioevo a Bergamo. Archeologiae antropologia raccontano le genti bergamasche,truccazzano, p. 46.
Giacomo Grimaldi 1972, Descrizione della basilica an-tica di S. Pietro in Vaticano, in r. niGGl (ed.), CodiceBarberini Latino 2733, Città del Vaticano 1972.
H. GiBB 1958, Arab-Byzantine relations under theUmayyad Caliphate, in “dumbarton oaks papers”,12, pp. 221-233.
A. GiuliAno 1962, Il commercio dei sarcofagi attici,roma.
A. GiuliAno, B. pAlMA 1978, La maniera ateniese di etàromana. I maestri dei sarcofagi attici, roma.
F. GlAser 2003, Der Frühchristliche Kirchenbau in dernordöstlichen Region (Kärnten/Osttirol), in FrüheKirchen 2003, pp. 413-437.
A. GoldsCHMidt 1914, Die Elfenbeinskulpturen aus derZeit der karolingischen und sächsischen Kaiser, Ber-lin, vol. i.
J. Goll 2001, Frühmittelalterliche Fenster Gläser aus Mü-stair und Sion, in F. dell’ACQuA, r. silVA (edd.), Il co-lore nel Medioevo: arte, simbolo, tecnica, Atti delleGiornate di studi (lucca, 23-25 settembre 1999),lucca, pp. 87-98.
J. Goll 2007, Le pitture parietali nello spazio e nel tempo,in Müstair 2007, pp. 47-74.
J. Goll 2010, Müstair, monastero di San Giovanni: lacappella della Santa Croce, in Ottavo secolo 2010, pp.259-262.
o. GrABAr 1954, The six kings at Qurayr Amrah, in “Arsorientalis”, 1, pp. 185-187.
o. GrABAr 1959, The Paintings, in HAMilton 1959, pp.294-326.
o. GrABAr 1973, The Formation of Islamic Art, newHaven-london.
A. GrABAr 1976, Sculptures byzantines du Moyen Âge,paris.
o. GrABAr 1978 City in the Desert: Qasr al-Hayr East,Cambridge (Massachusetts).
o. GrABAr 1987, The Formation of Islamic Art, newHaven-london (rev. ed.).
o. GrABAr 1988, La place de Qusayr Amrah dans l’artprofane du haut moyen âge, in “Cahiers archéolo-giques”, 36, pp. 75-83.
o. GrABAr 1992, The Mediation of Ornament, princeton.
o. GrABAr 1996, The Shape of the Holy: Early IslamicJerusalem, princeton.
o. GrABAr 1993, Umayyad palaces reconsidered, in “Arsorientalis”, 23, pp. 93-108.
o. GrABAr 2006, The Dome of the Rock, Cambridge(Massachusetts)-london.
G. GrAssi 1990, Scultura architettonica e spolia marmo-ree della Panaghìa di Antalya nel quadro della pro-duzione artistica dell’Asia minore meridionale inepoca paleobizantina, in F. de MAFFei, C. BArsAnti,A. GuiGliA GuidoBAldi (edd.), Costantinopoli e l’artedelle province orientali, roma, pp. 73-134.
G.d. GrAsso 1971 (ed.), Ermeneutica della pittura, na-poli.
n. GrAy 1948, The palaeography of Latin inscriptions inthe Eighth, Ninth and Tenth Centuries in Italy, in “pa-pers of British school of rome”, 16, pp. 38-167.
G.l. GreGori 1990, Brescia romana. Ricerche di proso-pografia e storia sociale. 1. I documenti, roma.
G.l. GreGori 1999, Brescia romana. Ricerche di proso-pografia e storia sociale. 2. Analisi dei documenti,roma.
M. GriesHeiMer 1997, Cimetières et tombeaux des villagesde la Syrie du Nord, in “syria”, 74, pp. 165-212.
J. Gritti 2006, Profilo storico architettonico della chiesaex plebana, in Madonna del Castello, Bergamo, ii,pp. 37-67.
i. GuArneri 1958-1959, Diario degli scavi e delle scopertearcheologiche effettuate nella basilica di San Salva-tore a Brescia fra il 1958 ed il 1959, Brescia, Archiviodei Civici Musei (manoscritto).
M. Guidetti, G. MACCHiArellA 2007, Problemi di ermeneu-tica nell’iconografia umayyade: Qusayr ‘Amra eKhirbat al-Mafğar, in A. CAlzonA, r. CAMpAri, M. Mus-sini (edd.), Immagine e ideologia. Studi in Onore diArturo Carlo Quintavalle, Milano, pp. 53-64.
F. GuidoBAldi 1992, I capitelli e le colonnine riutilizzatinel monumento funebre del cardinal Venerio, in F.GuidoBAldi, C. BArsAnti, A. GuiGliA GuidoBAldi, SanClemente. La scultura del VI secolo, roma, pp. 11-66.
F. GuidoBAldi 2001, Strutture e cronologia delle recin-zioni liturgiche nelle chiese di Roma dal VI al IX se-colo, in Arredi di culto 2001, pp. 81-99.
G. Guidoni 1997, La scultura dell’arredo liturgico dellapieve di Sestino, in XLII Corso di Cultura sull’Arte Ra-vennate e Bizantina, ravenna, pp. 443-458.
554
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 16/07/14 10.54 Pagina 554
BiBlioGrAFiA
A. GuiGliA GuidoBAldi 1988, Scultura costantinopolitanadel VI secolo: i capitelli reimpiegati nella medresadella moschea di Davut Pasha, in C. BArsAnti, A. Gui-GliA GuidoBAldi, A. iACoBini (edd.), Studi e ricerched’arte bizantina, Atti della Giornata di studio (roma,4 dicembre 1986), roma, pp. 231-244.
A. GuiGliA GuidoBAldi 1998, Spolia classiche e scultura al-tomedievale nella chiesa dei Santi Primo e Felicianoa Leggiuno, in ‘Domum tua dilexi’. Miscellanea inonore di Aldo Nestori, Città del Vaticano, pp. 451-486.
A. GuiGliA GuidoBAldi 2004, Una ricerca coordinatasull’arredo marmoreo di età giustinianea della SantaSofia di Costantinopoli, in CreAzzo, strAno 2004, pp.399-428.
J. Guyon, M. HeiJMAns 2001 (edd.), D’un monde a l’autre.Naissance d’une Chrétienté en Provence, IV-VI siècle,Catalogue de l’exposition (Arles, 15 septembre 2001-6 janvier 2002), Arles.
C-p. HAAse 2007, The development of stucco decorationin Northern Syria of the 8th & 9th centuries and thebevelled style of Samarra, in A. HAGedorn, A. sHAleM
(edd.), Facts and Artefacts: Art in the Islamic World,leiden, pp. 439-460.
r. HAMilton 1953, Carved plaster in Umayyad architec-ture, in “iraq”, 15, pp. 43-55.
r. HAMilton 1959 (ed.), Khirbat al Mafjar: an ArabianMansion in the Jordan Valley, oxford.
r. HAMilton 1988, Walid and his Friends: an UmayyadTragedy, oxford.
J. HArper 1997, The provisioning of marble for the Sixth-Century churches of Ravenna: a reconstructiveanalysis, in Pratum romanum. Richard Krautheimerzum 100. Geburtsdag, Wiesbaden, pp. 130-148.
r.M. HArrison 1986, Excavations at Saraçhane in Istan-bul, Volume 1, princeton, n.J.-Washington, d.C.
r.M. HArrison 1989, A Temple for Byzantium. The Dis-covery and Excavation of Juliana Anicia’s Palace-Church in Istanbul, london.
J.G. HAWtHorne, C. stAnley sMitH 1979, Theophilus. Ondivers arts, new york.
H. HeBlinG 1961, s.v. Ansa, in dBi, roma, 3, pp. 360-361.
F. HerBer-suFFrin 2006, Germigny-des-Prés. Une œuvreexemplaire?, in Stucs et décors 2006, pp. 179-196.
p. HetHerinGton 1974, The “Painters’s Manual” of Dio-nysius of Fourna, london.
C. HiGGitt, M. sprinG, d. sAunders 2003, Pigment-medium interactions in oil paint films containing redlead or lead-tin yellow, in “national Gallery technicalBulletin”, 24, pp. 75-95.
W.l. HildBurGH 1944, Indeterminability and confusionas apotropaic elements in Italy and in Spain, in“Folklore”, 55, n. 4, pp. 133-149.
r. HillenBrAnd 1982, La Dolce Vita in Early Islamic Syria:the evidence of later Umayyad palaces, in “Art His-tory”, 5, pp. 1-35.
r. HillenBrAnd 1999, Anjar and Early Islamic urbanism,in G.p. BroGiolo, B. WArd-perKins (edd.), The Ideaand Ideal of the Town Between Late Antiquity andthe Early Middle Ages, leiden-Boston, pp. 59-98.
r.F. Hoddinott 1963, Early Byzantine Churches in Mace-donia and Southern Serbia. A Study of the Originsand the Initial Development of East Christian Art,london.
r. HodGes 1988, Charlemagne’s elephant and the begin-nings of commoditization in Europe, in “Acta Archae-ologica”, 59, pp. 155-168.
r. HodGes 1997, Light in the Dark Ages. The Rise and Fallof San Vincenzo al Volturno, london.
J. HuBert 1968, Le arti suntuarie, in J. HuBert, J. porCHer,W.F. WolBACH, L’impero carolingio, Milano, pp. 207-267.
J. HuBert, J. porCHer, W.F. WolBACH 1969, Europe of theInvasions, new york.
p. Hudson 1987, Pavia: l’evoluzione urbanistica di unacapitale altomedievale, in Storia di Pavia, II. L’al-tomedioevo, Milano, pp. 237-315.
M. HuMpHries 2007, From emperor to pope? Ceremonial,space and authority at Rome from Constantine toGregory the Great, in K. Cooper, J. Hillner (edd.), Re-ligion, Dynasty and Patronage in Early ChristianRome, 300-900, Cambridge, pp. 21-58.
M. iBsen 2003, Sistemi decorativi nell’Alto Garda, inChiese 2003, pp. 95-132.
M. iBsen 2005, Fonti documentarie per gli altari di SanSalvatore di Brescia tra basso Medioevo ed età mo-derna. Nuovi dati e prospettive di ricerca, in “HortusArtium Medievalium”, 11, pp. 149-163.
M. iBsen 2006a, La produzione artistica, in G.p. Bro-Giolo, M. iBsen, C. MAlAGuti (edd.), Archeologia aGarda e nel suo territorio (1998-2003), Firenze, pp.257-384.
M. iBsen 2006b, Ricognizione preliminare sulla sculturaaltomedievale a Leno, in San Benedetto “ad Leones”2006, pp. 305-338.
M. iBsen 2006c, San Salvatore di Brescia, Leno e la pro-duzione scultorea per le fondazioni monastiche, co-municazione al seminario Die karolingischeFlechtwekskulptur aus dem Kloster St. Johann zu Mü-stair im internationaler Vergleich (Müstair, 6-11 giu-gno 2006).
M. iBsen 2007a, La scultura in Italia settentrionale tra VIe VIII secolo, in Longobardi 2007, pp. 311-315.
M. iBsen 2007b, Colonnina frammentaria [n. 6.16], inLongobardi 2007, p. 324.
M. iBsen 2007c, Unus populus effecti sunt? La questionelongobarda dall’Illuminismo al Romanticismo, inLongobardi 2007, pp. 291-293.
M. iBsen 2008a, L’arredo liturgico di Maguzzano. Conte-sti locali, irradiazioni sovraregionali, migrazioni, inG.p. BroGiolo, A. CHAVArríA, M. iBsen, Da fondazioneprivata a monastero del vescovo di Verona: Maguz-zano (Lonato, BS) e la sua dipendenza di Soiano,“Archeologia Veneta”, 2006-2007, pp. 147-205.
555
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 16/07/14 10.54 Pagina 555
BiBlioGrAFiA
556
M. iBsen 2008b, Le arche e le reliquie, in BroGiolo, GHe-roldi, iBsen 2008, pp. 218-226.
M. iBsen 2010, Struttura, decorazione, fruizione, in Bro-Giolo, GHeroldi, iBsen, MitCHell 2010, pp. 232-235.
M. iBsen 2011a, Ricognizione preliminare dei frammentiscultorei, in A. BredA et al., San Pietro in Mavinas aSirmione, in Chiese del Garda 2011, pp. 45-47.
M. iBsen 2011b, Santa Maria e le fasi antiche dell’inse-diamento religioso a Crema, in G. CAVAllini, M. FACCHi
(edd.), La cattedrale di Crema. Le trasformazioni neisecoli: liturgia, devozione e rappresentazione del po-tere. Atti della Giornata di studi (Crema, 8 maggio2011), Milano, pp. 47-62.
M. iBsen 2013, Scultura lapidea altomedievale nei terri-tori di Brescia, Bergamo, Mantova, in p.M. de MAr-CHi, s. pilAto (edd.), La Via Carolingia: uomini e ideesulle strade d’Europa. Dal sistema viario al sistemainformativo, Mantova, pp. 49-68.
r. inVernizzi 1998, Pavia, ex chiesa di S. Felice, in “noti-ziario della soprintendenza Archeologica della lom-bardia”, 1995-1997, pp. 247-251.
M.y. işCAn, s.r. lotH, r.K. WriGHt 1984, Age estimationfrom the rib by phase analysis: white males, in “Jour-nal of Forensic sciences”, 29, pp. 1094-1104.
M.y. işCAn, s.r. lotH, r.K. WriGHt 1985, Age estimationfrom the rib by phase analysis: white females, in“Journal of Forensic sciences”, 30, pp. 853-863.
Italia Langobardorum 2011, Italia Langobardorum. ILongobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774d.C.), spoleto 2011.
W. JACoBsen 2003, Paulinus und die Baukunst, in p.CHiesA (ed.), Paolino d’Aquileia e il contributo ita-liano all’Europa Carolingia, Atti del Convegno (Ci-vidale-premariacco, 2002), udine, pp. 245-328.
W. JACoBsen 2008, Il problema dell’utilizzazione: l’archi-tettura altomedievale e la liturgia nei conventi mo-nastici, in Monasteri in Europa occidentale 2008, pp.309-322.
C. JäGGi 1998, San Salvatore in Spoleto. Studien zur spät-antiken und frühmittelalterlichen Architektur Ita-liens, Wiesbaden.
J. JArnut 1973, Prosopographische und sozialgeschichti-liche Studien zum Langobardenreich in Italien (568-774), Bonn.
J. Jeličić-rAdonić 1999, Liturgical installations in theRoman Province of Dalmatia, in “Hortus Artium Me-dievalium”, 5, pp. 133-145.
K. JeWell 2011, Power in Plaster: the Installation of Stuc-cowork during the Late Antique and Early ByzantinePeriods, MA dissertation, university of louisville,Kentucky.
r. JoHnson 1938, The mss. of the “Schedula” of Theophiluspresbyter, in “speculum”, Xiii, pp. 86-103.
M.J. JoHnson 2009, The Roman Imperial Mausoleum inLate Antiquity, Cambridge.
s. Judd 2008, Reinterpreting al-Walid b. Yazid, “Journal ofthe American oriental society”, 128, n. 3, pp. 439-458.
M. JurKoVić, i. MAteJčić, J. ziHerl 2006, Novigradski Lap-idarij. Lapidario di Cittanova, novigrad-Cittanova.
z. Kádár 1991, s.v. Animali, in Enciclopedia dell’Arte Me-dievale, roma, ii, pp. 1-13.
G. KApitän 1980, Elementi architettonici per una basilicadal relitto navale del VI secolo di Marzamemi (Sira-cusa), in XXVII Corsi di Arte Ravennate e Bizantina,ravenna, pp. 71-136.
r. KAutzsCH 1936, Kapitellstudien. Beiträge zur einer Ge-schichte des spätantiken Kapitells im Osten vom vier-ten bis ins siebente Jahrhundert, Berlin-leipzig.
r. KAutzsCH 1939, Die römische Schmuckkunst in Steinvom 6. bis zum 10. Jahrhundert, in “römische Jahr-buch für Kunstgeschichte”, iii, pp. 1-73.
r. KAutzsCH 1941, Die langobardische Schmuckkunst inOberitalien, in “römische Jahrbuch für Kunstge-schichte”, V, pp. 3-48.
Karl der Grosse 1965, W. BrAunFels (ed.), Karl der Grosse.Werk und Wirkung, Catalog der Ausstellung (Aa-chen, 26 juni-19 september 1965), Aachen 1965.
H.l. Kessler 1985, Pictures as scripture in fifth-centurychurches, “studia Artium orientalis et occidentalis”,2, pp. 17-31. repr. in H.l. Kessler 2002, Old St. Peter’sand Church Decoration in Medieval Italy, spoleto,pp. 15-43.
H.l. Kessler 1989, L’antica basilica di San Pietro comefonte e ispirazione per la decorazione delle chiese me-dievali, in M. AndAloro et al. (edd.), Fragmentapicta. Affreschi e mosaici staccati del Medioevo ro-mano, Catalogo della Mostra (roma, 15 dicembre1989-8 febbraio 1990), roma, pp. 45-110.
C.M. Kessler, s. WolF, s. trüMpler 2005, Die frühestenZeugen ornamentaler Glasmalerei aus der Schweiz:die frühmittelalterlichen Fensterglasfunde von Sion,Sous-le-Scex, in “zeitschrift für schweizerische Ar-chäologie und Kunstgeschichte”, 62, n. 1, pp. 1-30.
K. Keune, J.J. Boon 2007, Analytical imaging studies ofcross-section of painting affected by lead soap aggre-gate formation, in “studies in Conservation”, 52, n.3, pp. 161-176.
B. KiileriCH 2008, Colour and context: reconstructing thepolychromy of the stucco Saints in the Tempietto Lon-gobardo at Cividale, in “Arte Medievale”, Vii, n. 2,pp. 9-24.
B. KiileriCH 2010, The rhetoric of materials in the Tempi-etto Longobardo at Cividale, in Ottavo secolo 2010,pp. 93-102.
d. Kinney 2011, The discourse of columns, in C. BolGiA,r. MCKitteriCK, J. osBorne (edd.), Rome across Timeand Space, Cambridge, pp. 182-199.
e. KitzinGer 1977, Byzantine Art in the Making. MainLines of Stylistic Development in Mediterranean Art,london.
e. KitzinGer 1989, L’arte bizantina. Correnti stilistichenell’arte mediterranea dal III al VII secolo, Milano.
e. KitzinGer 1993, Interlace and icons: form and functionin early Insular art, in r.M. speArMAn, J. HiGGet (edd.),The Age of Migrating Ideas: Early Medieval Art inNorthern Britain and Ireland, edinburgh, pp. 3-15.
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 16/07/14 10.54 Pagina 556
BiBlioGrAFiA
p.K. Klein 1992, The Apocalypse in medieval art, in r.K.eMMerson, B. MCGinn (edd.), The Apocalypse in theMiddle Ages, ithaca-london, pp. 159-199.
r. Kloos 1980, Zum Stil der Langobardischen Steinin-schriften des achten Jahrhunderts, in Atti del VI Con-gresso Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo(Milano, 1979), spoleto, pp. 19-182.
G. KoCH, H. siCHterMAnn 1982, Römische Sarkofage,München.
W. KoeHler 1958, Die karolingichen Miniaturen, II. DieHofschule Karls des Grossen, Berlin.
J. KollWitz, H. HerdeJürGen 1979, Die antiken Sarkopha-greliefs, 8. Die Sarkophage der westlischen Gebiete desImperium Romanum, 2. Die ravennatischen Sarko-phage, Berlin.
t. KrAus, l. Von MAtt 1975, Pompeii and Herculaneum.The Living Cities of the Dead, new york.
r. KrAutHeiMer 1989, Congetture sui mosaici scamparsi diS. Sabina a Roma, in “Atti della pontificia Accademiaromana di Archeologia, rendiconti”, 60, pp. 171-187.
r. KrAutHeiMer, s. CorBett, A.K. FrAzer 1977, CorpusBasilicarum Christianarum Romae. The Early Chris-tian Basilicas of Rome (IV-IX Cent.), Città del Vaticano.
J. KröGer 1982, Sasanidischer Stuckdekor, Mainz amrhein.
K.H. KrüGer 1971, Königsgrabkirchen del Franken, An-gelsachsen und Langobarden bis zur Mitte der 8.Jahrhunderts, München.
H. KüHn 1996, Was ist Stuck?, in Stuck 1996, pp. 17-24.
Kunstschatze der Lombardei 1949, Kunstschatze derLombardei, Kunstschatze der Lombardei. 500 vorChristus-1800 nach Christus, Catalogo della Mostra(zurich, november 1948-Marz 1949), zurich 1949.
Kunst und Kultur der Karolingerzeit 1999, C. stieGeMAnn,M. WeMHoFF (edd.), 799. Kunst und Kultur der Ka-rolingerzeit: Karl der Grosse und Papst Leo III in Pa-derborn, Katalog des Ausstellung, i, Mainz 1999.
H.p. l’orAnGe 1974, Il tempietto di Cividale e l’arte lon-gobarda alla metà dell’VIII secolo, in La civiltà deiLongobardi in Europa, Atti del Convegno internazio-nale (roma, 24-26 maggio 1971; Cividale del Friuli27-28 maggio 1971), roma, pp. 433-460.
H.p. l’orAnGe 1979, La scultura in stucco e in pietra deltempietto di Cividale, in l’orAnGe, torp 1977-1979,vol. 3.
H.p. l’orAnGe, H. torp 1977-1979, Il tempietto longo-bardo di Cividale, roma.
C. lA roCCA 1997, Segni di distinzione. Dai corredi fu-nerari alle donazioni ‘post obitum’ nel regno longo-bardo, in l. pAroli (ed.), L’Italia centro-settentrionalein età longobarda, Atti del Convegno (Ascoli piceno,6-7 ottobre 1995), Firenze, pp. 31-54.
C. lA roCCA 2000, I rituali funerari nella transizione daiLongobardi ai Carolingi, in Futuro dei Longobardi2000b, pp. 52-53.
G. lABus 1838, Osservazioni archeologiche intorno aimonumenti figurati esposti nel Museo, in Museo bre-sciano illustrato, Brescia.
C. lAMBert 1999, L’arredo scultoreo altomedievale del-l’abbazia di Sesto al Reghena, in G.C. Menis, A. ti-lAtti (edd.), L’abbazia di Santa Maria di Sesto fraarcheologia e storia, Fiume Veneto, pp. 75-95.
e. lAVAGnino 1936, Storia dell’arte italiana. Il Medioevo,torino.
e. lAVAGnino 1953, Arte medievale, torino.
M. lAVers 1971, I cibori d’altare delle chiese di Classe e diRavenna, in “Felix ravenna”, 102, pp. 131-142.
M. lAVers 1974, I cibori di Aquileia e di Grado, in Atti delIII Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana, in“Antichità Altoadriatiche”, 6, pp. 119-165.
H. leClerCQ 1914, s.v. Croix (invention et exaltation dela vraie), in F. CABrol, H. leClerCQ (edd.), Diction-naire d’Archéologie chrétienne et de liturgie, paris,tomo iii, 2, pp. 3131-3139.
t. leisten 1999-2000, Balis – first preliminary report onthe campaigns 1996 and 1998, in “Berytus”, 44, pp.35-57.
t. leisten 2002, The Umayyad complex at Balis, paperdelivered to Symposium on the Archaeology of the Is-lamic Period (Berlin, 16-18 november 2002), pp. 1-10.
p. leVeto 1988, Castel Seprio: Architecture and Painting,Ann Arbor.
r. leVi pisetzKy 2005, Storia del costume in Italia. DalTardoantico al Medioevo, in Enciclopedia dellaModa, roma, ii, pp. 3-198.
p. linAnt de BelleFonds 1985, Sarcophages attiques de laNécropole de Tyr. Une étude iconographique, paris.
r. linG 1976, Stuccowork, in d. stronG, d. BroWn (edd.),Roman Crafts, london, pp. 209-221.
r. linG 1991, Roman Painting, Cambridge.
A. lipinsKy 1960, La “Crux gemmata” e il culto dellaSanta Croce nei monumenti superstiti e nelle raffi-gurazioni monumentali, in VII Corso di culturasull’Arte ravennate e bizantina, ravenna, pp. 139-189.
p. liVerAni 2004, Reimpiego senza ideologia. La letturadegli antichi spolia dall’arco di Costantino all’età ca-rolingia, in “römische Mitteilungen”, 111, pp. 383-434.
u. loBBedey, d. JAKoBs, H. reiCHWAld 1999, Brescia, SanSalvatore. Untersuchung 12. april -15. April 1999,Brescia, Archivio dei Civici Musei (dattiloscritto).
s. loMArtire 1994, La pittura medievale in Lombardia, inC. Bertelli (ed.), La pittura in Italia. L’altomedioevo,Milano, pp. 47-89.
s. loMArtire 1997, La basilica di Sant’Ambrogio dalle ori-gini all’alto medioevo, in La Basilica di Sant’Ambro-gio. Guida storico-artistica, Milano, pp. 43-44.
s. loMArtire 1998, Riflessioni sulla decorazione del SanSalvatore di Brescia alla luce delle nuove indaginiarcheologiche, in Wandmalerei des frühen Mittelal-ters 1998, pp. 40-48.
s. loMArtire 2000a, Epitaffio del duca Audoaldo [n. 214],in Futuro dei Longobardi 2000b, p. 145.
557
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 16/07/14 10.54 Pagina 557
BiBlioGrAFiA
s. loMArtire 2000b, Frammento di pluteo con testa diagnello o di cerbiatto [n. 267], in Futuro dei Longo-bardi 2000b, pp. 250-251.
s. loMArtire 2000c, Frammento di laterizio scolpito [n.268], in Futuro dei Longobardi 2000b, p. 251.
s. loMArtire 2001, I tituli dipinti del Tempietto Longo-bardo di Cividale, in Paolo Diacono 2001, pp. 455-491.
s. loMArtire 2007, Architettura e decorazione nel S. Sal-vatore di Brescia tra alto medioevo e ‘romanico’: ri-flessioni e prospettive di ricerca, in G. AndennA, M.rossi (edd.), Società bresciana e sviluppi del roma-nico (XI-XIII sec.), Atti del Convegno di studi (Bre-scia, 9-10 maggio 2002), Milano, pp. 117-151.
s. loMArtire 2009, Commacini e marmorarii. Temi e tec-niche della scultura tra VII e VIII secolo nella “Lan-gobardia maior”, in Magistri commacini 2009, pp.151-209.
s. loMArtire 2010, Brescia e Pavia nell’VIII secolo: emer-genze monumentali e problemi aperti, in Ottavo se-colo 2010, pp. 215-225.
s. loMArtire, A. seGAGni 2000, San Felice, tomba dellabadessa Ariperga [Scheda], in Futuro dei Longobardi2000b, pp. 248-249.
Longobardi 1991, G.C. Menis (ed.), I Longobardi, Cata-logo della Mostra (Codroipo-Cividale, 2 giugno-11novembre 1990), Milano 1991.
Longobardi 2003, I Longobardi dei ducati di Spoleto e Be-nevento, Atti del XVi Congresso internazionale distudi (spoleto-Benevento, 20-27 ottobre 2002), spo-leto 2003.
Longobardi 2007, G.p. BroGiolo, A. CHAVArríA (edd.), ILongobardi. Dalla caduta dell’Impero all’alba dell’Ita-lia, Catalogo della Mostra (torino-novalesa, 28 set-tembre 2007-6 gennaio 2008), Cinisello Balsamo 2007.
Longobardi e Lombardia 1978, I Longobardi e la Lom-bardia: saggi, Catalogo della Mostra (Milano, 1978),Milano 1978.
Longobardi e Lombardia 1980, I Longobardi e la Lom-bardia: aspetti di civiltà longobarda, Atti del Vi Con-gresso internazionale di studio sull’Alto Medioevo(Milano, 21-25 ottobre 1978), spoleto 1980.
G. lorenzoni 1978, Dall’occupazione longobarda alMille, in l. puppi (ed.), Ritratto di Verona. Lineamentidi una storia urbanistica, Verona, pp. 135-169.
G. lorenzoni 1986, La cultura artistica dai Carolingi alMille, in Milano 1986, pp. 277-292.
G. lorenzoni 1993, s.V. Carolingia architettura, in Enci-clopedia dell’arte Medievale, roma, iV, pp. 304-317.
C.o. loVeJoy 1985, Dental wear in libben population: itsfunctional pattern and role in the determination ofadult skeletal age at death, in “American Journal ofphysical Anthropology”, 68, pp. 47-56.
C.o. loVeJoy, r.s. Meindl, t.r. pryzBeCK et al. 1985,Chronological metamorphosis of the auricolar sur-face of the ilium: a new method for the determinationof adult skeletal age at death, in “American Journalof physical Anthropology”, 68, pp. 15-28.
Lucca e l’Europa 2010, Lucca e l’Europa. Un’idea di Me-dioevo (V-XI secolo), Catalogo della Mostra (lucca,25 settembre 2010-9 gennaio 2011), lucca.
M. luCCo 1986, La Pittura del Duecento e del Trecentonelle provincie venete, in e. CAstelnuoVo (ed.), La pit-tura in Italia. Il Duecento e il Trecento, Milano, i, pp.113-149.
u. ludWiG 2001, Il codice memoriale e liturgico di SanSalvatore/Santa Giulia. Brescia e Reichenau, in Cultoe storia 2001, pp. 103-119.
u. ludWiG 2006, I libri memoriales e i rapporti di fratel-lanza tra i monasteri alemanni e i monasteri italianinell’Alto Medioevo, in G. spinelli (ed.), Il monache-simo italiano dall’età longobarda all’età ottoniana(secc. VIII-X), Atti del Vii Convegno di studi storicisull’italia Benedettina (nonantola, 10-13 settembre2003), Cesena, pp. 145-164.
s. lusuArdi sienA 1989a, Gazzo Veronese, in Veneto nelMedioevo 1989, ii, pp. 172-188.
s. lusuArdi sienA 1989b, L’arredo architettonico e deco-rativo altomedievale delle chiese di Sirmione, in Sir-mione longobarda 1989, pp. 93-125.
s. lusuArdi sienA 1989c, Premessa, in s. lusuArdi sienA etal., Le tracce materiali del Cristianesimo dal tardo an-tico al Mille, in Veneto nel Medioevo 1989, ii, pp. 89-102.
s. lusuArdi sienA 1997, L’arredo liturgico altomedievale,in s. lusuArdi sienA (ed.), San Martino a Rive d’Ar-cano. Archeologia e storia di una pieve friulana,udine, pp. 145-198.
s. lusuArdi sienA 2004, Santa Maria in Stelle, in F. Flores
d’ArCAis (ed.), Pittura nel Veneto. Le origini, Milano,pp. 212-220.
s. lusuArdi sienA, C. GiostrA, e. spAllA 2000, Sepolture eluoghi di culto in età longobarda: il modello regio, inG.p. BroGiolo (ed.), II Congresso nazionale di ar-cheologia medievale (Brescia, 28 settembre-1 ottobre2000), Firenze, pp. 273-283.
s. lusuArdi sienA, p. piVA 2001, Scultura decorativa e ar-redo liturgico in Friuli tra VIII e IX sec., in Paolo Dia-cono 2001, pp. 493-594.
Magistri commacini 2009, I magistri commacini. Mito erealtà del medioevo lombardo, Atti del XiX Con-gresso internazionale di studio sull’Alto Medioevo(Varese-Como, 23-25 ottobre 2008), spoleto 2009.
r. MAGuire 2012, The Early Christian Basilicas of Cyprus:Some Sources and Contexts, phd dissertation, uni-versity of east Anglia, norfolk.
p. MAJoCCHi s.a., Le sepolture regie del regno italico (secoliVI - X), http://sepolture.storia.unipd.it.
A. MAlVezzi-MAlinVerni 1919, Memoriale sul procedi-mento Malvezzi- Malinverni pel ripulimento d’opered’arte in affresco e ad olio, Milano.
C. MAnGo 1972, The Art of the Byzantine Empire, 312-1453: Sources and Documents, englewood Cliffs, nJ.
e. MAriAni 2005, Domus B, Ambiente 17, Gli affreschi, inSanta Giulia 2005, pp. 105-114.
558
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 16/07/14 10.54 Pagina 558
BiBlioGrAFiA
y.A. MArAno 2008, Il commercio del marmo nell’Adria-tico tardoantico (IV-VI secolo d.C.). Scambi, mae-stranze, committenze, tesi di dottorato, universitàdegli studi di padova.
F. MArAzzi et al. 2002, San Vincenzo al Volturno. Scavi2000-2002. Rapporto preliminare, in “ArcheologiaMedievale”, XXiX, pp. 209-274.
F. MArAzzi 2008, San Vincenzo al Volturno. L’impiantoarchitettonico fra VIII e XI secolo, alla luce dei nuoviscavi della basilica maior, in Monasteri in Europa oc-cidentale 2008, pp. 323-390.
o. MAruCCHi 1909, Élements d’archéologie chrétienne, iii,paris-rome.
M.G. MArunti 1960, s.v. Grifo, in Enciclopedia dell’ArteAntica, roma, pp. 1061-1062.
t.F. MAtHeWs 1977, The Byantine Churches of Istanbul.A Photographic Survey, philadelphia-london.
A.s. MAzzoCCHi 1744, In vetus marmoreum sanctae Nea-politanae Ecclesiae kalendarium Commentarius, na-poli.
M. MCCorMiCK 2002, Origins of the European Economy:Communications and Commerce, AD 300-900, Cam-bridge.
s. MClACHlAn 2010, Medieval Handgonnes. The FirstBlack Powder Infantry Weapons, oxford.
Medioevo delle cattedrali 2006, A.C. QuintAVAlle (ed.), IlMedioevo delle cattedrali. Chiesa e Impero: la lottadelle immagini (secoli XI e XII), Catalogo della Mostra(parma, 9 aprile-16 giugno 2006), Ginevra-Milano2006.
Medioevo mediterraneo 2007, A.C. QuintAVAlle (ed.), Me-dioevo mediterraneo. L’Occidente, Bisanzio e l’Islam,Atti del Convegno internazionale di studi (parma, 21-25 settembre 2004), Milano 2007.
H-r. Meier 2003, Ton, Stein und Stuck: Materialaspektein der Bilderfrage des Früh- und Hochmittelalters, in“Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft”, 30, pp.35-52.
A. MeluCCo VACCAro 1974, La diocesi di Roma. La II re-gione ecclesiastica, Corpus della scultura altomedie-vale Vii, spoleto.
A. MeluCCo VACCAro 1984, Policromia nell’architettura enella plastica antica. Stato della questione: studi inmargine ai restauri dei grandi monumenti marmo-rei romani, in “ricerche di storia dell’Arte”, 24, pp.19-32.
A. MeluCCo VACCAro 1988, Policromie e patinature ar-chitettoniche: antico e medioevo nelle evidenze deirestauri in corso, in “Arte medievale”, s. ii, ii, n. 2,pp. 177-204.
A. MeluCCo VACCAro 1995, Nota critica, in MeluCCo VAC-CAro, pAroli 1995, pp. 47-66.
A. MeluCCo VACCAro, l. pAroli 1995, La diocesi di Roma.Il Museo dell’Alto Medioevo, Corpus della scultura al-tomedievale Vii, spoleto.
r. MelzAK 1983, The Carolingian Ivory Carvings of theLater Metz Group, phd. dissertation, Columbia uni-versity, new york.
M. MerriField 1849, Original Treatises on the Arts ofPaintings, london.
e. MiCHeletto, s. uGGè 2003, La chiesa di San Costanzosul Monte San Bernardo (Piemonte, Cuneo) e il suoarredo scultoreo, in “Hortus Artium Medievalium”, 9,pp. 383-400.
Milano 1986, Milano e i Milanesi prima del Mille, Atti delX Congresso internazionale di studi sull’Alto Me-dioevo (Milano, 26-30 settembre 1983), spoleto 1986.
d.H. Miller 1969, Papal-Lombard relations during thepontificate of pope Paul I: the attainement of an equi-librium of power in Italy, 756-767, in “the CatholicHistorical review”, lV, pp. 358-376.
A. MilošeVić 2003, Scultura ornamentale del VII e VIII se-colo dai Balcani Occidentali, in “Hortus Artium Me-dievalium”, 9, pp. 357-383.
M. MirABellA roBerti 1986, Sepolture privilegiate nellechiese paleocristiane di Milano, in y. duVAl, J.C. pi-CArd (edd.), L’inhumation privilégiée du IV au VIIIsiècle en Occident, Actes du Colloque (Créteil, 16-18mars 1984), paris, pp. 157-160.
J. MitCHell 1990, Literacy displayed: the use of inscrip-tions at the monastery of San Vincenzo al Volturnoin the early ninth century, in r. MCKitteriCK (ed.),The Uses of Literacy in Early Mediaeval Europe, Cam-bridge, pp. 186-225.
J. MitCHell 1993, The crypt reappraised, in San Vincenzoal Volturno 1993, pp. 75-114.
J. MitCHell 1994, The display of script and the uses ofpainting in Longobard Italy, in Testo e immaginenell’alto medioevo, Xli settimana CisAM (spoleto,15-21 aprile 1993), spoleto, pp. 887-954.
J. MitCHell 1995, Arichis und die Künste, in H.r. Meier,C. JäGGi, p. Büttner (edd.), Für irdischen Ruhm undhimmlischen Lohn. Stifter und Auftraggeber in dermittelalterlichen Kunst, Berlin, pp. 47-64.
J. MitCHell 1996, The uses of spolia in Longobard Italy,in J. poesCHKe, H. BrAndenBurG (edd.), Antike Spolienin der Architektur des Mittelalters und der Renais-sance, Munich, pp. 93-115.
J. MitCHell 1997, A word on ornament and its uses, in J.ottAWAy (ed.), Le rôle de l’ornement dans le peinturemurale du Moyen Âge, poitiers, pp. 213-215.
J. MitCHell 1999, Karl der Grosse, Rom und das Ver-mächtnis der Langobarden, in Kunst und Kultur derKarolingerzeit 1999, pp. 95-108.
J. MitCHell 2000a, Artistic patronage and cultural strat-egy in Lombard Italy, in Towns and their territories2000, pp. 347-370.
J. MitCHell 2000b, L’Italia e i Franchi, in Futuro dei Lon-gobardi 2000a, pp. 414-416.
J. MitCHell 2000c, Croce funeraria dipinta con iscrizione[Scheda], in Futuro dei Longobardi 2000b, Milano, p.427.
J. MitCHell 2000d, L’arte nell’Italia longobarda e nell’Eu-ropa carolingia, in Futuro dei Longobardi 2000a, pp.173-187.
559
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 16/07/14 10.54 Pagina 559
BiBlioGrAFiA
J. MitCHell 2000e, L’arte nelle corti dell’VIII secolo, in Fu-turo dei Longobardi 2000a, pp. 233-235.
J. MitCHell 2003, San Vincenzo al Volturno: the archa-eology of the arts and magic at an early medieval mo-nastery, in I Longobardi dei ducati di Spoleto eBenevento, Atti del XVi Congresso internazionale distudio sull’Alto Medioevo (spoleto, 20-23 ottobre),spoleto, pp. 1077-1094.
J. MitCHell 2008, The power of patronage and the iconog-raphy of quality in the era of 774, in s. GAspArri (ed.),774: ipotesi su una transizione, Atti del seminario(poggibonsi, 16-18 febbraio 2006), turnhout, pp.263-288.
J. MitCHell 2013, St. Johann at Müstair: the painted deco-ration in context, in K. rotH-ruBi, H.r. sennHAuser
(edd.), Wandel und Konstanz in Churraetien: Politis-che und kulturelle Veränderungen zwischen Bodenseeund Lombardei zur Zeit Karls des Grossen, zürich, pp.367-390.
J. MitCHell et al. 1997, Cult, relics and privileged burialat S. Vincenzo al Volturno in the age of Charlemagne:the discovery of the tomb of Abbot Talaricus (817-3October 823), in s. GeliCHi (ed.), I CongressoNazionale di Archeologia Medievale (pisa, 29-31maggio 1997), Firenze, pp. 315-321.
J. MitCHell, B. leAl 2013, Wall-paintings in S. Maria forisportas di Castelseprio and the tower at Torba. Reflec-tions and reappraisal, in Castelseprio 2013, pp. 311-344.
p. MoirAGHi 1889, Sui pittori pavesi. Spigolature e ricer-che. Epoca prima, pavia.
F. Molesini 2000, Il “corpus” della scultura altomedievaledel Mantovano (VII-XI secolo), in “Civiltà manto-vana”, XXV, n. 110, pp. 89-111.
Monasteri in Europa occidentale 2008, F. de ruBeis, F.MArAzzi (edd.), Monasteri in Europa occidentale (se-coli VIII-IX): topografia e strutture, Atti del Convegnointernazionale (Castel san Vincenzo, 23-26 settembre2004), roma 2008.
G.C. Mor 1982, La grande iscrizione dipinta nel Tem-pietto Longobardo di Cividale, in “Acta ad Archaeo-logiam et Artium Historiam pertinentia”, ser. altera 8,ii, pp. 95-122.
p. MorA, l. MorA, p. pHilippot 2001, La conservazionedelle pitture murali, Bologna (2a ed.).
p. MorA, p. pHilippot 1965, Technique et conservation despeintures murales, Washington-new york.
F. MorAndini 2000a, Osservazioni su quattro sarcofagi ro-mani inediti dal monastero di Santa Giulia in Bre-scia, in “Quaderni di Archeologia del Veneto”, XVi,pp. 184-190.
F. MorAndini 2000b, Lato di sarcofago con le tre Grazie,in Futuro dei Longobardi 2000b, pp. 525-526.
F. MorAndini 2001, Sarcofagi di età romana reimpiegatinel monastero di S. Giulia, in San Salvatore-SantaGiulia 2001, pp. 403-409.
F. MorAndini 2004, Immagini greche per sarcofagi di pre-stigio, in Vita dietro le cose 2004, pp. 10-12.
F. MorAndini 2006, Il lapidario di Piazza Loggia a Bre-scia, Brescia.
F. MorAndini 2007, Frammenti di sarcofagi dalla chiesadi San Salvatore di Brescia (taf. 19-21), in Akten desSymposiums des Sarkophag-Corpus 2001 (Marburg,2.-7. Juli 2001), Mainz am rehin, p. 37.
F. MorAndini 2012, Marmi antichi nel monastero diSanta Giulia a Brescia, in Riuso 2012, pp. 203-217.
F. MorAndini, r. strAdiotti 2008, Cruz denominada deDesiderio, Brescia. Croce cosiddetta di Desiderio, inC.G. de CAstro VAldes oViedo (ed.), Signum Salutis:cruces de orfebrería de los siglos V al XII, oviedo, pp.111-117.
A. MorAssi 1939, Brescia. Catalogo delle cose d’arte e diantichità d’Italia, Brescia.
p. MurAil et al. 2005, DSP: a tool for probabilistic sex dia-gnosis using worldwide variability in hip-bone mea-surements, in “Bulletins et Mémoires de la sociétéd’Anthropologie de paris”, 17, pp. 167-176.
Museo Bresciano Illustrato 1838, G. lABus, G. niColini, r.VAntini, G. sAleri, Museo bresciano illustrato, Brescia1838.
Museo cristiano 1958, Il Museo cristiano, Brescia 1958.
Müstair 2007, J. Goll, M. eXner, s. HirsCH, Müstair: lepitture parietali medievali nella chiesa dell’abbazia,zollikon 2007.
e. nApione 2001, La diocesi di Vicenza, Corpus della scul-tura altomedievale XiV, spoleto.
G.B. nAzAri 1657, Discorso di Gio. Battista Nazari Bre-sciano, Nel quale brevemente si tratta delle Conces-sioni, Priuilegi, Essentioni, et de’ Corpi et Reliquie deSanti del Monasterio di S. Giulia di Brescia. Con ilcatalogo di tutte l’Abbadesse, che sono state di tempoin tempo, Brescia.
l. nees 2006, Charlemagne’s elephant, in “Quintana: riv-ista do departamento de Historia de Arte, universi-dade de santiago de Compostela”, 5, pp. 13-49.
l. nees 2011, Blue behind gold: the inscription of theDome of the Rock and its relatives, in J. BlooM, s.BlAir (edd.), And Divers are their Hues: Color in Is-lamic Art and Culture, new Haven-london.
J.l. nelson 1998, Making a difference in Eighth-Centurypolitics: the daughters of Desiderius, in A. CAllAnder
MurrAy (ed.), After Rome’s Fall. Narrators andSources of Early Medieval History Essays presented toWalter Goffart, toronto-Buffalo-london, pp. 171-190.
G. nepoti, M. CorsAno 1995, I reperti dallo scavo nel Se-minario nel 1970, in H. BlAKe (ed.), Archeologia ur-bana a Pavia, pavia, pp. 87-110.
t.F.X. noBle 1984, The republic of St Peter, The Birth ofthe Papal State. 680-825, philadelphia.
t.F.X. noBle, t. HeAd 1995 (edd.), Soldiers of Christ.Saints and Saints’ Lives from Late Antiquity and theEarly Middle Ages, london.
p. noVArA 1999, La chiesa pomposiana nelle trasforma-zioni medievali tra i secoli IX e XII, in A. sAMAritAni,C. di FrAnCesCo (edd.), Pomposa, Ferrara, pp. 153-175.
560
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 16/07/14 10.54 Pagina 560
BiBlioGrAFiA
M. noVello 2000, Suggestioni classiche nella chiesa diSan Salvatore a Brescia, in “Antenor”, ii, pp. 89-105.
H. notHdurFter 2001, Chiese del VII e VIII secolo in AltoAdige, in Chiese 2001, pp. 123-158.
H. notHdurFter 2002, San Benedetto a Malles, lana.
F. odoriCi 1845, Antichità cristiane di Brescia illustratede Federico Odorici in appendice al Museo Bresciano,Brescia.
F. odoriCi 1853-1865, Storie bresciane dai primi tempifino all’età nostra, Xi voll., Brescia.
r. oliVieri FArioli 1969, La scultura architettonica. Basi,capitelli, pietre d’imposta, pilastri e pilastrini, plutei,pulvini, Corpus della scultura bizantina e altomedie-vale di ravenna iii, roma.
H. oMont 1929, Miniatures des plus anciens manuscritsgrecs de la Bibliothèque Nationale du VIe au XIVe siè-cle, paris.
J. oniAns 1988, Bearers of Meaning. The Classical Ordersin Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance,princeton.
B.M. orselli 1985, L’immaginario religioso nella cittàmedievale, ravenna.
d.J. ortner, W.G.J. putsCHAr 1981, Identification ofPathological Conditions in Human Skeletal Remains,Washington.
J. osBorne 1990, The use of painted initials by Greek andLatin scriptoria in Carolingian Rome, in “Gesta”, 29,n. 1, pp. 76-85.
J. osBorne 1992, Textiles and their painted imitations inEarly Medieval Rome, in “papers of the British schoolat rome”, 60, pp. 309-351.
Ottavo secolo 2010, V. pACe (ed.), L’VIII secolo: un secoloinquieto, Convegno internazionale di studi (Cividaledel Friuli, 4-7 dicembre 2008), Cividale del Friuli2010.
V.K. oWusu 1998, Funerali in Roma e nell’Occidente nonromano, in A.J. CHupunGCo (ed.), Scientia Liturgica,Casale Monferrato, iV, pp. 363-390.
V. pACe 1982, Campania XI secolo. Tradizione e innova-zioni in una terra normanna, in Romanico padano,Romanico europeo, Convegno internazionale di studi(Modena-parma, 26 ottobre-1 novembre 1977),parma, pp. 225-256.
V. pACe 1994, La pittura medievale in Campania, in Ber-telli 1994, pp. 243-60.
V. pACe 2003, Immanenza dell’antico, congiunzioni ro-mane e traiettorie europee: aspetti dell’arte longo-barda in Umbria e Campania, in Longobardi 2003,pp. 1125-1148.
V. pACe 2007, La questione bizantina in alcuni monu-menti dell’Italia altomedievale: la perizia greca nei“tempietti” di Cividale e del Clitumno, Santa Mariaforis portas a Castelseprio e San Salvatore a Brescia,Santa Maria Antiqua a Roma, in Medioevo mediter-raneo 2007, pp. 215-223.
V. pACe 2010, L’Italia Langobardorum, Roma e altrove.La grandezza di un secolo, in Ottavo secolo 2010, pp.21-24.
B. pAlAzzo-BertHolon 2006, La nature des stucs entre leVe et le XIIe siècle dans l’Europe médiévale, in Stucs etdécors 2006, pp. 13-47.
B. pAlAzzo-BertHolon 2010, Confronti tecnici e decora-tivi sugli stucchi intorno all’VIII secolo, in Ottavo se-colo 2010, pp. 285-296.
B. pAlAzzo BertHolon, C. sApin 2004, Vouneuil sur Biard,in Stuc 2004, pp. 64-95.
A. pAlMer, l. rodley 1988, The inauguration of HagiaSophia in Edessa: a new edition and translation withhistorical and architectural notes and a comparisonwith a contemporary Constantinopolitan kontakion,in “Byzantine and Modern Greek studies”, 12, pp.117-167.
G. pAnAzzA 1942, L’arte medioevale nel territorio bre-sciano, Bergamo.
G. pAnAzzA 1952, Sculture e iscrizioni pre-romaniche nelterritorio bresciano, in Atti del I Congresso Interna-zionale di Studi Longobardi (spoleto, 1951), spoleto,pp. 427-431.
G. pAnAzzA 1953, Lapidi sculture paleocristiane e proto-romaniche di Pavia, in Arte del primo millennio, Attidel ii Convegno per lo studio dell’Arte dell’AltoMedio evo (pavia, settembre 1950), torino, pp. 211-296.
G. pAnAzzA 1957-1959, Sculture preromaniche e romani-che della Riviera occidentale del Garda, in “Memoriedell’Ateneo di salò”, 18, pp. 137-149.
G. pAnAzzA 1958, I Civici Musei e la Pinacoteca di Bre-scia, Bergamo.
G. pAnAzzA 1960a, Le scoperte in S. Salvatore a Brescia,in “Arte lombarda”, V, n. 1, pp. 13-21.
G. pAnAzzA 1960b, La basilica di San Salvatore, in “Artelombarda”, V, n. 2, pp. 161-186.
G. pAnAzzA 1962a, Gli scavi, l’architettura e gli affreschidella Chiesa di San Salvatore in Brescia, in Chiesa diSan Salvatore 1962, pp. 5-228.
G. pAnAzzA 1962b, Ricerche in S. Salvatore di Brescia, inH. Fillitz (ed.), Beiträge zur Kunstgeschichte und Ar-chäologie des Frühmittelalters, Akten zum 7. interna-tionalen Kongress fur Fruhmittelalterforschung (Wien,21-28 september 1958), Graz-Köln, pp. 139-153.
G. pAnAzzA 1963a, Le manifestazioni artistiche dal secoloIV all’inizio del secolo VII, in Storia di Brescia, I,Dalle origini alla caduta della signoria viscontea(1426), Brescia, pp. 363-391.
G. pAnAzzA 1963b, L’arte dal secolo VII al secolo XI, inStoria di Brescia, I, Dalle origini alla caduta della si-gnoria viscontea (1426), Brescia, pp. 519-557. (in-clude: G. pAnAzzA, La scultura, in Storia di Brescia,I, Dalle origini alla caduta della signoria viscontea(1426), Brescia, pp. 537-547).
G. pAnAzzA 1978a, La documentazione storica del com-plesso architettonico, in San Salvatore 1978b, pp. 14-40.
G. pAnAzzA 1978b, Altri frammenti di sculture preroma-niche, in “Brixia sacra. Memorie storiche della diocesidi Brescia”, n.s., Xiii, n. 5-6, pp. 151-152.
561
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 16/07/14 10.54 Pagina 561
BiBlioGrAFiA
A. pAntoni 1980, Le chiese e gli edifici del monastero diS. Vincenzo al Volturno, in “Miscellanea Cassinese”40, pp. 116-120.
Paolo Diacono 2000, p. CHiesA (ed.), Paolo Diacono. Unoscrittore fra tradizione longobarda e rinnovamento ca-rolingio, Atti del Convegno internazionale di studi (Ci-vidale del Friuli-udine, 6-9 maggio 1999), udine 2000.
Paolo Diacono 2001, Paolo Diacono e il Friuli altomedie-vale (secc. VI-X), Atti del XiV Congresso internazio-nale di studi sull’Alto Medioevo (Cividale delFriuli-Bottenicco di Moimacco 24-29 settembre 1999),spoleto 2001.
l. pAroli 1998, La scultura in marmo a Roma tra l’VIII eil IX secolo, in p. deloGu (ed.), Roma medievale. Ag-giornamenti, Firenze, pp. 93-122.
l. pAroli 2001, La scultura in marmo a Roma tra il VI eil IX secolo, in M.s. ArenA et al. (edd.), Roma dall’An-tichità al Medioevo. Archeologia e storia nel MuseoNazionale romano Cripta Balbi, Milano, pp. 132-143.
M.C. pArrA 1983, Rimeditando sul reimpiego: Modena ePisa viste in parallelo, in “Annali della scuola nor-male superiore di pisa, Classe di lettere e Filosofia”,s. iii, Xiii, pp. 453-483.
r. pAsQuAle 2010, La decorazione aniconica della criptasemianulare di Giosuè a San Vincenzo al Volturno,in Ottavo secolo 2010, pp. 185-190.
l. pAsQuini 2002, La decorazione a stucco in Italia fratardo antico e alto medioevo, ravenna.
l. pAsQuini 2006, Influenze dell’arte sasanide nell’Occi-dente mediterraneo: alcuni episodi decorativi, in A.pAnAino, r. zipoli (edd.), Proceedings of the FifthConference of the Societas Iranologica Europaea, II,Ancient and Middle Iranian Studies, Milano, pp. 645-660.
l. pAsQuini VeCCHi 1999, Riflessioni sul rapporto tra archi-tettura e stucco nella basilica eufrasiana di Parenzoe nel San Salvatore di Brescia, in “Bizantinistica. rivi-sta di studi Bizantini e slavi”, s. ii, 1, pp. 109-142.
B. pAssAMAni 1979, La coscienza della romanità e gli studiantiquari tra Umanesimo e Neoclassicismo, in Bre-scia romana 1979, pp. 5-17.
s.F. pAXton 1990, Christianizing Death, the Creation ofa Ritual Process in Early Medieval Europe, ithaca-london.
p. peduto 1994, La Campania, in r. FrAnCoViCH, G. noyÉ
(edd.), La storia dell’alto Medioevo italiano (VI-X se-colo) alla luce dell’archeologia, Convegno internazio-nale (siena, 2-6 dicembre 1992), Firenze, pp. 279-297.
p. peduto 2001, Paolo Diacono e la cappella palatina diSalerno, in Paolo Diacono 2001, pp. 655-670.
p. peduto, M. GAlAnte, d. MAuro, i. pAstore, M. roMito
1988, Un accesso alla storia di Salerno: stratigrafie emateriali dell’area palaziale longobarda, in “rasse-gna storica salernitana”, 10, pp. 9-63.
p. pensABene 2002, Le principali cave di marmo bianco, inM. de nuCCio, l. unGAro (edd.), I marmi colorati dellaRoma imperiale, Catalogo della Mostra (roma, 28 set-tembre 2002-19 gennaio 2003), Venezia, pp. 203-221.
562
G. pAnAzzA 1978c, Brescia e il suo territorio da Teodoricoa Carlo Magno, in Longobardi e Lombardia 1978, pp.121-142.
G. pAnAzzA 1983, Problemi della cripta, in Seminario in-ternazionale 1981, pp. 55-64.
G. pAnAzzA 1985, I Musei bresciani, in Brescia postro-mantica e liberty, 1880-1915, Catalogo della Mostra(Brescia, 30 maggio-31 agosto 1985), Brescia, pp.307-335.
G. pAnAzzA 1988, Brescia e il suo territorio da Teodoricoa Carlo Magno secondo gli studi fino al 1978, in Bre-scia altomedievale 1988, pp. 7-35.
G. pAnAzzA 1992a, Osservazioni sui frammenti scultoreidi S. Salvatore, in Santa Giulia 1992, pp. 231-244.
G. pAnAzzA 1992b, s.v. Brescia, in Enciclopedia dell’ArteMedievale, roma, iii, pp. 711-731.
G. pAnAzzA 1995, Schede relative ai pezzi di scultura al-tomedievale, Brescia, Archivio dei Civici Musei (dat-tiloscritto).
G. pAnAzzA 1996, Un frammento di scultura altomedie-vale, in Carta archeologica Brescia 1996, pp. 317-318.
G. pAnAzzA, A. tAGliAFerri 1966, La diocesi di Brescia,Corpus della scultura altomedievale iii, spoleto.
p. pAnAzzA 1987, I capitelli della cripta di S. Salvatore aBrescia, in “dai Civici Musei d’Arte e di storia di Bre-scia. studi e notizie”, 3, pp. 11-23.
p. pAnAzzA 1989, I capitelli della cripta di S. Salvatore aBrescia, in “dai Civici Musei d’Arte e storia di Bre-scia. studi e notizie”, 3, pp. 11-23.
p. pAnAzzA 2000a, Lastra trapezoidale con pavone inmarmo proconnesio (?) [n. 479], in Futuro dei Lon-gobardi 2000b, p. 521.
p. pAnAzzA 2000b, Due frammenti di lastra trapezoidalecon pavone in marmo proconnesio (?) [n. 480], in Fu-turo dei Longobardi 2000b, pp. 521-522.
p. pAnAzzA 2000c, Pilastrino frammentario in marmoproconnesio [n. 488], in Futuro dei Longobardi 2000b,p. 524.
p. pAnAzzA 2001a, Il reimpiego dei materiali, in San Sal-vatore-Santa Giulia 2001, pp. 395-401.
p. pAnAzzA 2001b, La trasformazione romanica dellacripta di San Salvatore. Architettura e apparati deco-rativi nel Basso Medioevo, in San Salvatore-SantaGiulia 2001, pp. 150-151.
p. pAnAzzA 2002, Note a margine di due sculture in stuccoaltomedievali del museo di Santa Giulia, in “Com-mentari dell’Ateneo di Brescia”, pp. 175-196.
p. pAnAzzA 2006, Per una ricognizione delle fonti artisti-che dell’abbazia di Leno: le sculture, in San Bene-detto “ad Leones” 2006, pp. 187-304.
e. pAnoFsKy 1979, Abbot Suger on the Abbey Church ofSt.-Denis and its Art Treasures (2nd ed., edited by G.pAnoFsKy-soerGel), princeton.
A. pAntoni 1970, San Vincenzo al Volturno e la criptadell’abate Epifanio, Monte Cassino.
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 16/07/14 10.54 Pagina 562
BiBlioGrAFiA
A. peroni 1960, La decorazione a stucco in S. Salvatoredi Brescia, in “Arte lombarda”, 5, n. 2, pp. 137-220.
A. peroni 1962, La ricomposizione degli stucchi preroma-nici di S. Salvatore di Brescia, in Chiesa di San Sal-vatore 1962, pp. 229-315.
A. peroni 1966, I capitelli del S. Salvatore a Brescia e ilproblema dei capitelli preromanici di tipo corinzio,in Arte in Europa. Scritti di Storia dell’Arte in onoredi Edoardo Arslan, Milano, i, pp. 177-187.
A. peroni 1969, Gli stucchi decorativi della basilica di S.Salvatore di Brescia. Appunti per un aggiornamentocritico nell’ambito dei problemi dell’arte altomedie-vale, in V. MiloJčić (ed.) 3. Kolloquium über spätan-tike und frühmittelalterliche Skulptur (Heidelberg,1972), Mainz am rhein, pp. 25-45.
A. peroni 1972, Il monastero altomedievale di S. Maria“Teodote” a Pavia. Ricerche urbanistiche e altomedie-vali, in “studi Medievali”, s. iii, Xiii, n. 1, pp. 1-93.
A. peroni 1974, La plastica in stucco nel S. Ambrogio diMilano: arte ottoniana e romanica in Lombardia, inV. MiloJčić (ed.) 3. Kolloquium über spätantike undfrühmittelalterliche Skulptur (Heidelberg, 1972),Mainz am rhein, pp. 59-119.
A. peroni 1975, Pavia. Musei civici del castello visconteo,roma.
A. peroni 1983a, Problemi della decorazione pittorica delSan Salvatore, in Seminario internazionale 1981, pp.17-46.
A. peroni 1983b, San Salvatore di Brescia: un ciclo alto-medievale rivisitato, in “Arte Medievale”, i, pp. 53-80.
A. peroni 1983c, Scultura, pittura e arti minori, in Le sedidella cultura in Emilia Romagna. L’alto Medioevo,Milano, pp. 165-188.
A. peroni 1984, L’arte nell’età longobarda. Una traccia,in Magistra Barbaritas. I Barbari in Italia, Milano,pp. 229-297.
A. peroni 1986, L’oreficeria ottoniana in Lombardia e letestimonianze del crocifisso di proporzioni monu-mentali, in Milano 1986, pp. 317-332.
A. peroni 1989, Architettura dell’Italia settentrionale inepoca longobarda (problemi e prospettive), in “Corsidi Cultura sull’Arte ravennate e Bizantina”, 36, pp.323-345.
A. peroni 1993, s.v. Capitello, in Enciclopedia dell’artemedievale, roma, iV, pp. 183-200.
A. peroni 1994, Riflessioni sul rapporto tra architettura estucco nella basilica eufrasiana di Parenzo e nel SanSalvatore di Brescia, in Scritti in onore di GaetanoPanazza, Brescia, pp. 101-115.
A. peroni 2002, Stucco, pittura e sinopie in S. Salvatore diBrescia e in S. Benedetto di Malles, in J. poesCHKe (ed.),Sinopien und Stuck im Westwerk der KarolingischenKlosterkirche von Corvey, Münster, pp. 59-69.
A. peroni 2003, Ordo et mensura nell’architettura alto-medievale, in Uomo e spazio nell’alto Medioevo, l set-timana CisAM, spoleto, pp. 1055-1117.
A. peruGini 1983, I frammenti di affresco del S. Salvatore.Saggio di catalogazione, in Seminario internazionale1981, pp. 102-118.
H. petroVitsCH 2006, Legio II Italica, linz.
A. petruCCi 1976, Aspetti simbolici delle testimonianzescritte, in Simboli e simbologia nell’alto medioevo,XXiii settimana CisAM, spoleto, pp. 814-844.
A. petruCCi 1992, Scriventi e scritture in Padania: Milanoe Bergamo, in A. petruCCi, C. roMeo (edd.), “Scripto-res in urbibus”. Alfabetismo e cultura scritta nell’Ita-lia altomedievale, Bologna, pp. 57-76.
e. pettenò, F. rinAldi 2012, Spolia da Iulia Concordia.Alcune riflessioni di carattere metodologico, in Riuso2012, pp. 127-145.
l. pietri 1996, Tours. Basilique Saint-Martin, in Sud-Ouest et Centre 1996, pp. 106-114.
M. pilutti 2004, I capitelli di navata della basilica diSanta Eufemia e della chiesa di Santa Maria delleGrazie a Grado, in “Annali della scuola normale su-periore di pisa. Classe di lettere e Filosofia”, s. 9, 2,pp. 269-303.
M. pilutti nAMer 2012, Reimpiego e rilavorazione di ma-teriali antichi nella Venezia medievale: alcuniesempi, in Riuso 2012, pp. 159-177.
p. piVA 2007, Edifici di culto e committenti imperialinell’XI secolo: il caso bresciano, in A.C. QuintAVAlle
(ed.), Medioevo: la chiesa e il palazzo, Atti dell’ViiiConvegno internazionale di studi (parma, 20-24 set-tembre 2005), Milano, pp. 249-270.
e. poesCHel 1948, Die Kunstdenkmäler des KantonsGraubünden, Basel.
B. polCi 2003, Some aspects of the transformation of theRoman domus between late antiquity and the earlymiddle ages, in l. lAVAn, W. BoWden (edd.), Theoryand Practice in Late Antique Archaeology, leiden-Boston, pp. 79-112.
J. porCHer 1968, I manoscritti dipinti, in J. HuBert, J.porCHer, W.F. WolBACH, L’impero carolingio, Milano,pp. 71-202.
p. portA 1979, Sculture altomedievali nel Sarsinate. Marmiframmentari della pieve di Montesorbo in provincia diForlì, in “Felix ravenna”, 117, pp. 77-96.
p. portA 1985, Un pluteo ricomposto della pieve del Thò aBrisighella (Ravenna), in “Felix ravenna”, 127-130,pp. 393-404.
p. portA 2002, Sculture tardoantiche, altomedievali e ro-maniche dalla basilica vigiliana di Trento: profiloiconografico e stilistico, in i. roGGer, e. CAVAdA
(edd.), L’antica basilica di San Vigilio in Trento. Sto-ria archeologia reperti, trento, ii, pp. 437-544.
p. portA 2012, I marmi: considerazioni e problemi, in M.MenGozzi (ed.), Monte Sorbo. La pieve singolare, Ce-sena, pp. 161-284.
p. portA 2013, Per il corpus della scultura altomedievale:la diocesi di Trento, in G.p. BroGiolo et al. (edd.),APSAT 10. Chiese trentine dalle origini al 1250. Vo-lume 1, Mantova, pp. 27-73.
A.K. porter 1915-1917, Lombard Architecture, london-new Haven.
M. preissler 1999, Fragmente einer verlorenen Kunst, inKunst und Kultur der Karolingerzeit 1999, pp. 197-206.
563
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 16/07/14 10.54 Pagina 563
BiBlioGrAFiA
M. preissler 2003, Die karolingischen Malereifragmenteaus Paderborn, Mainz.
A. puerAri 1976 (ed.), Museo Civico ‘Ala Ponzone’ Cre-mona. Raccolte artistiche, Cremona.
l. QuArtino 1999, Documenti iconografici: i laterizi diVentimiglia, in d. GAndolFi (ed.), Nel ricordo di NinoLamboglia. Studi e ricerche di storia, toponomastica,epigrafia, archeologia, storia dell’arte e restauro, Attidel Convegno (Genova-Albenga-Bordighera, 20-22marzo 1998) Bordighera, pp. 509-524.
A.C. QuintAVAlle 2007, Arredo, rito, racconto: la RiformaGregoriana nella ecclesia medievale in Italia, in A.C.QuintAVAlle (ed.), Arredi liturgici e architettura, Mi-lano, pp. 25-52.
C. rAGGHiAnti 1968, L’arte in Italia dal secolo V al secoloXI. Da Roma ai comuni, roma (ed. cons: C. rAG-GHiAnti, Prius Ars. Arte in Italia dal secolo V al secoloX, A. CAlCA (ed.), lucca 2010).
p. rAiMo 2010, La decorazione aniconica della cripta se-mianulare di Giosuè a San Vincenzo al Volturno, inOttavo secolo 2010, pp. 185-193.
n. rAsMo 1962, Note preliminari su S. Benedetto di Mal-les, in Stucchi e mosaici 1962, pp. 86-109.
n. rAsMo 1981, Karolingische Kunst in Südtirol, Bozen.
M. rAso 1986, Trattato di anatomia patologica clinica,vol. 3, padova.
J. rAspi serrA 1974, Le diocesi dell’Alto Lazio, Corpus dellascultura altomedievale Viii, spoleto.
J. rAspi serrA 1993, Le chapiteau d’acanthe en Italie entrele Ve et le Xe siècle, in L’acanthe dans la sculpture mo-numentale de l’Antiquité à la Renaissance, paris, pp.175-188.
l. reBAudo 2011, Per una lettura del reimpiego dall’an-tico al contemporaneo, in e. pettenò, F. rinAldi
(edd.), Memorie dal passato di Iulia Concordia. Unpercorso attraverso le forme del riuso e del reimpiegodell’antico, rubano, pp. 17-21.
F. reBeCCHi 1978, I sarcofagi romani dell’arco Adriatico,in “Antichità Altoadriatiche”, 13, pp. 201-258.
B. reudenBACH 1980, Säule und Apostel. Überlegungenzum Verhältnis von Architektur und architekturexe-getischer Literatur im Mittelalter, in “Frühmittelalter-liche studien”, 14, pp. 310-351.
C. riCCi 1909, Marmi ravennati erratici, in “Ausonia”, iV,pp. 245-289.
d. riCCi 1991, Schede VII.22, VII.23, in Longobardi 1991,pp. 315-316.
d. riCCi 1996, s.v. Longobardi. Scultura, in Enciclopediadell’arte medievale, roma, Vii, pp. 850-857.
M. riGHetti 1955, Manuale di storia liturgica, Milano.
C.M. riGHetti tosti 1988, Langobardia Minor, in G.C.ArGAn (ed.), Storia dell’Arte Italiana: il Medioevo, Fi-renze, pp. 202-210.
Riuso 2012, G. CusCito (ed.), Riuso di monumenti e reim-piego di materiali antichi in età postclassica: il casodella Venetia, in “Antichità Altoadriatiche”, 74.
G. riVoirA 1908, Le origini dell’architettura lombarda edelle sue principali derivazioni nei paesi d’Oltralpe,Milano 1908.
C.A. roBerts 2007, A bioarcheological study of maxillarysinusitis, in “American Journal of physical Anthropol-ogy”, 133, pp. 792-807.
Roma e i Barbari 2008, J.J. AillAGon (ed.), Roma e i Bar-bari. La nascita di un nuovo mondo, Catalogo dellaMostra (Venezia, 26 gennaio-20 luglio 2008), Milano.
A.M. roMAnini 1968a, La scultura pavese nel quadrodell’arte preromanica di Lombardia, in Pavia capi-tale di regno, Atti del iV Congresso internazionale distudi sull’Alto Medioevo (pavia, 1967), spoleto, pp.231-271.
A.M. roMAnini 1968b, Stucchi inediti di S. Maria Mag-giore in Lomello, in “Commentari”, n.s., 19, pp. 18-39.
A.M. roMAnini 1971, Problemi di scultura e plastica alto-medievale, in Artigianato e tecnica nella societàdell’Alto Medioevo occidentale, XViii settimanaCisAM (spoleto, 2-8 aprile 1970), spoleto, pp. 425-467.
A.M. roMAnini 1976, Il concetto di classico e l’arte medie-vale, in “romanobarbarica”, 1, pp. 203-242.
A.M. roMAnini 1979, Tradizioni e “mutazioni” nella cul-tura figurativa precarolingia, in La cultura anticanell’Occidente latino dal VII all’XI secolo, XXii setti-mana CisAM (spoleto, 18-24 aprile 1974), spoleto,pp. 759-798.
A.M. roMAnini 1991, Scultura nella Langobardia Maior:questioni storiografiche, in “Arte Medievale”, s. ii, V,n. 1, pp. 1-30.
A.M. roMAnini 1992, Committenza regia e pluralismo cul-turale nella “Langobardia Major”, in Committenti eproduzione artistico letteraria nell’alto medioevo oc-cidentale, XXXiX settimana CisAM (spoleto, 4-10aprile 1991), spoleto, i, pp. 57-92.
s. roMAno 2000, I pittori romani e la tradizione, in M.AndAloro, s. roMAno (edd.), Arte e iconografia aRoma da Costantino a Cola di Rienzo, Milano, pp.133-173.
K.l. roper peArson 1999, Conflicting Loyalties in EarlyMedieval Bavaria: a View of Socio-Political Interac-tion, 680-900, Aldershot.
G. rosA 1882, Il monastero di S. Giulia: adunanza del 29gennaio, discorso riportato in “Commentari dell’Ate-neo di Brescia per l’anno 1882”, Brescia, pp. 17-24.
F. rosentHAl 1992, The Classical Tradition in Islam, lon-don-new york.
B.H. rosenWein 1996, The Family Politics of Berengar I,King of Italy (888-924), in “speculum”, lXXi, n. 2,pp. 247-289.
F. rossi 1990, Frammento di lastra di sarcofago, in G.senA CHiesA (ed.), Milano capitale dell’impero ro-mano (286-402 d.C.), Catalogo della Mostra (Milano,24 gennaio-22 aprile 1990), Milano, p. 157.
M. rossi 2004, La Rotonda di Brescia, Milano.
564
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 16/07/14 10.54 Pagina 564
BiBlioGrAFiA
M. rossi 2010, Il problema Castelseprio, in Ottavo secolo2010, pp. 131-140.
p. rossi 1991, s.V. Ambone, in Enciclopedia dell’Arte Me-dioevale, roma, i, pp. 491-495.
K. rotH-ruBi 2006, La scultura ad intreccio da Müstair:tipologie e motivi decorativi, relazione presentata aLa scultura ad intreccio carolingia ritrovata nel Con-vento di San Giovanni a Müstair letta nel contesto in-ternazionale, Giornate di studio (Müstair, 6-11giugno 2006).
K. rotH-ruBi 2011, Das Antependium in der Klosterkir-che St. Johann von Müstair, in Vom Steinbeil bis zurFlintenkugel. Festschrift zur Pensionierung von JürgRageth, Chur, pp. 67-78.
K. rotH-ruBi, H.r. sennHAuser 2007, KarolingischeFlechtwerk-Skulptur. Kataloge der Stücke aus Müstair,Schänis und aus dem Tessin, [Müstair].
M. rotili 1986, Benevento romana e longobarda: l’im-magine urbana, napoli.
p. ruGo 1974, Le sculture altomedievali delle diocesi diFeltre e Belluno, Cittadella.
A. rusConi 1971, Il ciborio longobardo della cattedrale diAcerenza, in Atti del II Congresso nazionale di ar-cheologia cristiana (Matera 1969), roma, pp. 423-436.
G.M. rusHFortH 1902, S. Maria Antiqua, in “papers ofthe British school at rome”, 1, pp. 1-123.
e. russo 1987, La scultura del VI secolo in Palestina. Con-siderazioni e proposte, in “Acta ad Archaeologiam etArtium Historiam pertinentia”, s.a. Viii, Vi, pp. 113-248.
e. russo 1991, Sculture del complesso eufrasiano di Pa-renzo, napoli.
e. russo 1992, Su S. Salvatore di Spoleto e sul Tempiettodel Clitumno, in “Acta ad Archaeologiam et ArtiumHistoriam pertinentia”, s.a. Viii, pp. 87-143.
e. russo 1999, La scultura a Efeso in età paleocristiana ebizantina. Primi lineamenti, in Efeso paleocristianae bizantina = Frühchristiliches und byzantinischesEphesos. Referate des vom 22. bis 24. Februar 1996im Historischen Institut beim Österreichischen Kul-turinstitut in Rom durchgeführten internationalenKongresses aus Anlass des 100-jährigen Jubiläumsder Österreichischen Ausgrabungen in Ephesos,Wien, pp. 27-53.
e. russo 2002, Considérations sur la sculpture architec-turale à Nicée à l’époque paléochrétienne, in “Bizan-tinistica”, s. 2, 4, pp. 1-11.
G. e d. sACCHi 1828, Antichità romaniche d’Italia. Dellacondizione economica, morale e politica degli Ita-liani nei Bassi Tempi. saggio i: Intorno all’architet-tura simbolica, civile e militare nei secoli VI-VII-VIII,Milano.
F. sACCHi 2003, Ianua leti: l’architettura funeraria di Mi-lano romana, Milano.
F. sACCHi 2012, Mediolanum e i suoi monumenti dallafine del II secolo a.C. all’età severiana, Milano.
A. sAlA 1834, Pitture ed altri oggetti di belle arti di Bre-scia, Brescia.
M. sAlMi 1962, San Salvatore di Spoleto, il tardo antico el’alto medioevo, in Il passaggio dall’antichità al me-dioevo, iX settimana CisAM (spoleto, 6-12 aprile1961), spoleto, pp. 497-520.
Salona 1994, n. duVAl, e. MArin, C. MetzGer, Salona I.Catalogue de la sculpture architecturale paléochré-tienne de Salone, rome-split 1994.
r. sAlVi 1962, Analisi chimiche degli stucchi, in Chiesadi San Salvatore 1962, pp. 316-321.
San Benedetto “ad Leones” 2006, A. BAronio (ed.), SanBenedetto “ad Leones”. Un monastero benedettino interra longobarda, Atti del Convegno (leno, 26 feb-braio 2005), “Brixia sacra. Memorie storiche delladiocesi di Brescia”, 3 s., 11, n. 2.
San Salvatore 1978a, San Salvatore di Brescia. Materialiper un Museo. i, vol. 1, Catalogo della Mostra (Bre-scia, giugno-novembre 1978), Brescia 1978.
San Salvatore 1978b, San Salvatore di Brescia. Materialiper un Museo. i, vol. 2. Contributi per la storia delmonastero e proposte per un uso culturale dell’areastorica di Santa Giulia, Brescia 1978.
San Salvatore-Santa Giulia 2001, r. strAdiotti (ed.), SanSalvatore-Santa Giulia a Brescia. Il monastero nellastoria, Milano 2001.
San Vincenzo al Volturno 1993, r. HodGes (ed.), S. Vin-cenzo al Volturno. 1. The 1980-1986 excavations,part I, london 1993.
San Vincenzo al Volturno 1995, r. HodGes (ed.), SanVincenzo al Volturno. 2. The 1980-1986 ExcavationsPart II, london 1995.
San Vincenzo Maggiore 2011, r. HodGes, s. leppArd, J.MitCHell (edd.), San Vincenzo Maggiore and itsWorkshops, london 2011.
M. sAnnAzAro 2008, Il complesso religioso di Gallianoprima di Ariberto, in e. BiAnCHi, M. BAsile WeAtHerill
(ed.), Ariberto da Intimiano. Fede potere e cultura aMilano nel secolo XI, Cinisello Balsamo, pp. 71-85.
Santa Giulia 1992, C. stellA, G. BrenteGAni (edd.), S.Giulia di Brescia, Archeologia, arte, storia di un mo-nastero regio dai Longobardi al Barbarossa, Atti delConvegno internazionale (Brescia, 4-5 maggio 1990),Brescia 1992.
Santa Giulia 1999, G.p. BroGiolo (ed.), Santa Giulia diBrescia. Gli scavi dal 1980 al 1992. Reperti prero-mani, romani e alto medievali, Firenze 1999.
Santa Giulia 2005, G.p. BroGiolo, F. MorAndini, F. rossi
(edd), Dalle domus alla corte regia. S. Giulia di Bre-scia. Gli scavi dal 1980 al 1992, Firenze 2005.
A. sAntAnGelo 1936, Cividale, roma.
Santi, Banchieri, Re 2006, A. AuGenti, C. Bertelli (edd.),Santi, Banchieri, Re. Ravenna e Classe nel VI secolo.San Severo e il tempio ritrovato, Catalogo della Mostra(ravenna, 4 marzo-5 novembre 2006), Milano 2006.
d. sAunders, M. sprinG, C. HiGGitt 2002, Colour change inred lead-containing paint films, in ICOM–CC 13th Tri-ennial Meeting (rio de Janeiro, 2002), ii, pp. 455-463.
565
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 16/07/14 10.54 Pagina 565
BiBlioGrAFiA
M. sCellès 1996, Toulouse. Église Notre-Dame de la Dau-rade, in Sud-Ouest et Centre 1996, pp. 190-196.
e. sCHAFFrAn 1941, Die Kunst der Longobarden in Italien,Jena.
Schede da Ponte s.d., Schede da Ponte, Brescia, Archiviodell’Ateneo di scienze, lettere ed Arti, Archivio deiCivici Musei (manoscritto).
r.W. sCHeller 1987, Towards a typology of medievaldrawings, in W. strAuss, t. FelKer (edd.), DrawingsDefined, new york, pp. 13-34.
n. sCHiBille, i. Freestone c.s., Composition, Productionand Procurement of Glass at San Vincenzo alVolturno: an Early Medieval Monastic Complex inSouthern Italy.
G. sCHiller 1968-1991, Ikonographie der christlichenKunst, Gütersloh.
J. von sCHlosser 1892, Schriftquellen zur Geschichte derKarolingischen Kunst, Wien.
J. von sCHlosser 1896, Quellenbuch zur Kunstgeschichtedes abendländichen Mittelalters, Wien (ed. anast. Fi-renze 1992).
d. sCHluMBerGer 1939, Les fouilles de Qasr el-Heir el-Gharbi (1936-38), in “syria”, 20, pp. 195-238.
d. sCHluMBerGer 1986, Qasr el-Heir el-Gharbi, paris.
H. sCHlunK 1947, Arte visigodo, in Ars Hispaniae. Historiauniversal del Arte Hispánico, Madrid, ii, pp. 233-326.
F. sCireA 2012, Pittura ornamentale del Medioevo Lom-bardo. Atlante (secoli VIII-XIII), Milano.
A. seGAGni MAlACArt 1987, La scultura in pietra dal VI alX secolo, in Storia di Pavia. II, L’Alto Medioevo, pavia,pp. 373-405.
Seminario internazionale 1981, Seminario internazionalesulla decorazione pittorica del San Salvatore di Bre-scia, Atti (Brescia, 10-20 giugno 1981), pavia 1983.
G. senA CHiesA 2002, Sacra dactyliotheca: la Croce di De-siderio a Brescia ed il suo ornato glittico, in G. senA
CHiesA (ed.), Gemme, dalla corte imperiale alla corteceleste, Milano, pp. 154-164.
H.r. sennHAuser 2002, Baugeschichte und Bedeutung desKlosters St. Johann, in A. Wyss, H.e. rutisHAuser, M.A.nAy (edd.), Die mittelalterlichen Wandmalereien imKloster Müstair, zürich, pp. 17-30.
H.r. sennHAuser 2003a, Zur Außengestaltung frühmittel-alterlicher Sakralbauten in Schweizer Alpengebiet, inFrühe Kirchen 2003, pp. 899-913.
H.r. sennHAuser 2003b, Typen, Formen und Tendenzenin frühen Kirchenbau del Östlichen Alpengebietes:versuch einer Übersicht, in Frühe Kirchen 2003, pp.919-980.
H.r. sennHAuser 2003c, Katalog der früchristlichen undfrümittelalterlichen kirchlichen Bauten in der Dio-zöse Chur und in der nördlich und südlich angre-zenden Landschaften (A1-A125), in Frühe Kirchen2003, i, pp. 43-221.
H.r. sennHAuser 2007, Architettura e scultura nelle Alpicentro orientali e il caso di Müstair, in Carlo Magnoe le Alpi 2007, pp. 337-351.
H.r. sennHAuser 2008, Monasteri del primo millennionelle Alpi Svizzere, in Monasteri in Europa occiden-tale 2008, pp. 43-65.
s. settis 1984, Tribuit sua marmora Roma: sul reimpiegodi sculture antiche, in Lanfranco e Wiligelmo. Ilduomo di Modena, Milano, pp. 309-317.
s. settis 1986, Continuità, distanza, conoscenza. Tre usidell’antico, in s. settis (ed.), Memoria dell’antico nel-l’arte italiana. III. Dalla tradizione all’archeologia,torino, pp. 373-486.
d. sGArzi 2005, Iscrizioni bresciane tardo-antiche e al-tomedievali (V-IX secolo), in “Brixia sacra. Memoriestoriche della diocesi di Brescia”, s. iii, X, n. 3-4, pp.9-120.
G. silAGi 2001, I testi liturgici per la Santa, in Culto e sto-ria 2001, pp. 15-28.
Sirmione longobarda 1989, G.p. BroGiolo, s. lusuArdi
sienA, p. sesino, Ricerche su Sirmione longobarda, Fi-renze 1989.
t. sJøVold 1990, Estimation of stature from long bonesutilizing the line of organic correlation, in “Humanevolution”, 5, pp. 431-447.
p. sKuBiszeWsKi 1995, L’arte europea dal VI al IX secolo,torino.
F. slAVAzzi 2005, I reperti marmorei, in Santa Giulia 2005,pp. 313-319.
F. soGliAni 1985, Elementi architettonici paleocristiani diVerona, in “Felix ravenna”, 127-130, pp. 419-435.
F. soGliAni 2003, Nuovi dati sull’arredo scultoreo altome-dievale del monastero di San Vincenzo al Volturno(IS), in p. peduto, r. Fiorillo (edd.), III CongressoNazionale Archeologia Medievale, Firenze, pp. 97-102.
M. sorteni 1983, Brescia: Affreschi di S. Salvatore, in Se-minario internazionale 1981, pp. 75-77.
p. souCeK 1993, Solomon’s bath/Solomon’s throne: modelor metaphor?, in “Ars orientalis”, 23, pp. 109-134.
M. sprinG, r. Grout 2002, The blackening of vermilion:an analitical study of the process in paintings, in “na-tional Gallery, technical Bulletin”, 23, pp. 50-61.
d.J. stAnley 2004, Santa Costanza: history, archaeology,function, patronage and dating, in “Arte medievale”,3, n. 1, pp. 119-140.
l. steFAnini 2010, La chiesa di Santa Maria in Solario.Problemi storici e linguistici di un’antica denomina-zione, in “Civiltà Bresciana”, XiX, pp. 33-49.
C. stellA 1978, Fronte di sarcofago con Thyasos Bacchicoin San Salvatore di Brescia. Scheda II.138, in SanSalvatore 1978a, pp. 72-74.
C. stellA 1987, Guida al Museo Romano di Brescia, Bre-scia.
C. stellA 1990, Materiali di epoca romana dall’area delleCattedrali, in G. pAnAzzA (ed.), Le Basiliche paleo-crstiane e le Cattedrali di Brescia. Problemi e sco-perte, Brescia, pp. 59-65.
H. stern 1958, Les mosaïques de l’église de Sainte-Constance à Rome, in “dumbarton oaks papers”, 12,pp. 159-218.
566
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 16/07/14 10.54 Pagina 566
BiBlioGrAFiA
o. stieHl 1898, Die Backsteinbau romanischer Zeit be-sonders in Oberitalien und Norddeutschland, leipzig.
M. stoFFellA 2008, Le relazioni tra Baviera e Toscana traVIII e IX secolo: appunti e considerazioni preliminari,in “Mélanges de l’École Française de rome: Moyen-àge”, 120, n. 1, pp. 73-85.
r. strAdiotti 1980, Inediti capitelli del monastero di S.Salvatore in Brescia, in Longobardi e Lombardia1980, ii, pp. 665-677.
r. strAdiotti 2001, Le decorazioni affrescate. Architet-tura e apparati decorativi nel Basso Medioevo, in SanSalvatore-Santa Giulia 2001, p. 151.
s. strAFellA 2000-2001, Sepolture intonacate e dipinte tratarda Antichità e Medioevo in Italia: aggiornamentoe bilancio critico attraverso la catalogazione infor-matica, tesi di laurea in Archeologia Medievale, uni-versità cattolica del sacro Cuore, rel. prof.ssa s.lusuardi siena.
s. strAFellA 2006, Una sepoltura dipinta nell’abbazia diSan Benedetto di Leno, in “Brixia sacra. Memorie sto-riche della diocesi di Brescia”, s. iii, Xi, n. 2, pp. 159-186.
s. strAFellA 2007, La tomba dipinta con arcosolio nellaCattedrale di Otranto, in “l’eco idruntina, Bollettinodiocesano ufficiale per gli Atti dell’Arcivescovo edella Curia”, lXXXViii, n. 4, pp. 519-528.
s. strAFellA c.s., Voci sepolte: l’uso sepolcrale dell’area.Le tombe dipinte, in Piazza Duomo prima delDuomo. Contributo alla conoscenza del complessoepiscopale milanese nel centenario della nascita diAlberto de’ Capitani d’Arzago e Mario Mirabella Ro-berti, c.s.
e. stronG, n. JolliFFe 1924, The stuccoes of the under-ground Basilica near the Porta Maggiore, in “Journalof Hellenic studies”, 44, pp. 65-111.
F. stroppA 2011, Santa Giulia di Brescia. Un percorsosull’iconografia claustrale della martire cartaginese,in “Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi diBrescia”, XVi, n. 1-2, pp. 61-172.
F. stroppA 2012, Santa Giulia di Brescia. Percorsi artisticinell’agiografia monastica. L’esempio di San Salva-tore, Brescia.
J. strzyGoWsKiJ 1908, Das orientalische italien, in “Mo-natshefte für Kunstwissenschaft”, 1, pp. 16-34.
Stuc 2004, C. sApin (ed.), Le Stuc. Visage oublié de l’artmédiéval, Catalogo della Mostra (poitiers, 16 septem-bre 2004-16 janvier 2005), paris 2004.
Stuc et décors 2006, C. sApin (ed.), Stucs et décors de lafin de l’Antiquité au Moyen Âge, Actes du Colloqueinternational (poitiers, 16-19 septembre 2004), turn-hout 2006.
Stucchi e mosaici 1962, Stucchi e mosaici alto medioevali,Atti dell’Viii Congresso di studi sull’arte dell’alto Me-dioevo, vol. i, Milano 1962.
Stuck 1996, M. eXner (ed.), Stuck. Des frühen und hohenMittelalters, Hildesheim 1996.
e.A. stüCKelBerG 1909, Langobardische Plastik, Mün-chen.
W. studer 2004, Disentis, in Stuc 2004, pp. 144-163.
W. studer 2011, Byzanz in Disentis, zurich.
Sud-Ouest et Centre 1996, Les premiers monuments chré-tiens de la France, 2, Sud-Ouest et Centre, paris 1996.
A. tAGliAFerri 1959, Il pavone del Museo cristiano di Bre-scia, in Miscellanea di studi bresciani sull’alto me-dioevo, Brescia, pp. 55-71.
A. tAGliAFerri 1981, Le diocesi di Aquileia e Grado, Cor-pus della scultura altomedievale X, spoleto.
C.H. tAlBot 1981, The Anglo-Saxon Missionaries in Ger-many (new ed.), london.
r. tAlGAM 2004, The Stylistic Origins of Umayyad Sculp-ture and Architectural Decoration, Wiesbaden.
G. tAnFoGlio, F. rAFFAini 2007, San Cristo. SantissimoCorpo di Cristo, Brescia.
H. tArAGAn 1998, The Peopled Scrolls at the UmayyadPalace in Jericho- Some Observations, in “Assaph”, 3,pp. 93-108.
e. teA 1957, Arte Universale, III, Il Medioevo, torino.
A. terry 1988, The sculpture at the Cathedral of Eufrasiusin Porec, in “dumbarton oaks papers”, 42, pp. 13-64.
t. tHiBodeu 2010, The Rationale Divinorum Officiorumof William Durand of Mende. A New Translation ofthe Prologue and Book One, new york.
d.V. tHoMpson 1932, The Schedula of Theophilus presby-ter, in “speculum”, Vii, pp. 199-220.
d.V. tHoMpson 1933-1934, Artificial Vermilion in theMiddle Ages, in “technical studies in the Field of theFine Arts”, ii, pp. 62-70.
e. tHunø 2011, Inscription and divine presence: goldenletters in the early medieval apse mosaic, in “Wordand image: a Journal of Verbal/Visual enquiry”, 27,n. 3, pp. 273-291.
t.W. todd 1921, Age changes in the pubic bone, in“American Journal of physical Anthropology”, 4, pp.1-70.
p. toesCA 1912, La pittura e la miniatura nella Lombar-dia dai più antichi monumenti alla metà del Quat-trocento, Milano.
p. toesCA 1912, La pittura e la miniatura in Lombardia,Milano.
p. toesCA 1927, Storia dell’arte italiana. Il Medioevo, to-rino.
p. toMeA 2001, Intorno a S. Giulia. Le traslazioni e le “ra-pine” dei corpi santi nel regno longobardo (Neustriae Austria), in Culto e storia 2001, pp. 29-100.
s. toMezzoli 1996-1997, Le sculture in pietra e in terra-cotta della chiesa altomedievale di S. Salvatore a Bre-scia, tesi di laurea, università degli studi di padova,rel. prof. G.p. Brogiolo.
s. toMezzoli 1999a, Scheda II.48, in Kunst und Kulturder Karolingerzeit 1999.
s. toMezzoli 1999b, Scheda II.44, in Kunst und Kulturder Karolingerzeit 1999.
567
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 16/07/14 10.54 Pagina 567
BiBlioGrAFiA
s. tonni 2000, Frammenti pittorici altomedievali da SanSalvatore, in Futuro dei Longobardi 2000b, p. 519.
s. tonni 2001, Lavori svolti nell’ambito del restauro e laricollocazione di stucchi altomedievali in San Salva-tore a Brescia, in San Salvatore-Santa Giulia 2001,pp. 387-393.
s. tonni 2005, Le pitture conservate sugli alzati: dati ri-levati con la prima schedatura, Domus B Ambiente17, in Santa Giulia 2005, pp. 115-117.
s. tonni 2009, I frammenti pittorici di San Martino diSerravalle, in San Martino di Serravalle e San Barto-lomeo De Castelàz. Due chiese di Valtellina: scavi ericerche, pp. 200-201.
s. tonni 2010, Note a margine del restauro degli stucchialtomedievali della chiesa di San Salvatore a Brescia,in Ottavo secolo 2010, pp. 127-130.
H. torp 1959, Il problema della decorazione originariadel Tempietto Longobardo di Cividale del Friuli. Ladata e i rapporti con San Salvatore di Brescia, in“Quaderni della Face”, 18, pp. 5-47.
H. torp 1977, L’architettura del Tempietto di Cividale, inl’orAnGe, torp 1977-1979, Vii.2.
H. torp 1983, Intervento, in Seminario internazionale1981, pp. 85-86.
H. torp 2006, Il Tempietto Longobardo: la cappella pala-tina di Cividale, Cividale del Friuli.
s.B. tosAtti 2006, Le tecniche della pittura medievale, inp. piVA (ed.), L’arte medievale nel contesto. 300-1000:funzioni, iconografia, tecniche, Milano, pp. 295-434.
Town and their territories 2000, G.p. BroGiolo, n. GAu-tHier, n. CHristie (edd.), Towns and their Territoriesbetween Late Antiquity and the Early Middle Ages,leiden-Boston-Köln 2000.
J.M.C. toynBee, B. WArd perKins 1950, Peopled Scrolls: ahellenistic motif in imperial art, in “papers of theBritish school at rome”, 18, pp. 1-44.
C. treFFort 1996, L’église carolingienne et la mort. Chris-tianisme, rites funéraires et pratiques commémora-tives, lyon.
J. trillinG 1995, Medieval interlace ornament: the mak-ing of a cross-cultural idiom, in “Arte Medievale”, 9,n. 2, pp. 59-86.
M. trotter, G.C. Gleser 1952, Estimation of stature fromlong bones of American whites and negroes, in“American Journal of physical Anthropology”, 10, pp.463-514.
G. troVABene 1984, Il Museo Lapidario del Duomo, Mo-dena.
A. turCHini, G. ArCHetti 2003 (edd.), Visita apostolica edecreti di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia. I.La città, Brescia.
d.H. uBelAKer 1989, Human Skeletal Remains: Excava-tion, Analysis, Interpretation, Washington.
M. uBoldi 1999, I vetri, in Santa Giulia 1999, pp. 271-307.
s. uGGè 2007, Scheda (6.20), in Longobardi 2007, p. 326.
i. VAJ 2002, Il tempietto di Cividale e gli stucchi omayyadi,in s. lusuArdi sienA (ed.), Cividale Longobarda: ma-teriali per una rilettura archeologica, Milano, pp.175-204.
G. VAlenzAno 2005, Intorno ad alcuni altari delle chiesedelle Venezie tra VIII e XIII secolo, in “Hortus ArtiumMedievalium”, 11, pp. 131-137.
A. VAlVo 2010, Regio X- Venetia et Histria, Brixia- Bena-censes- Valles Supra Becanum, Sabini- Trumplini-Camunni, “supplementa. italica. nuova serie”, 25,pp. 141-325.
K. VAn der Horst, W. noel, W.C.M. WüsteFeld 1996(edd.), The Utrecht Psalter in Medieval Art. Picturingthe Psalms of David, Westrenen.
r. VAn MArle 1923, The development of Italian school ofpainting, I, the Hague.
r. VAntini 1838, Dichiarazione delle tavole architettoni-che e ornamentali, in Museo bresciano illustrato1838, pp. 53-119.
M. VeCCHi 1995, Sculture tardo-antiche e alto-medievalidi Murano, roma.
Veneto nel Medioevo 1989, A. CAstAGnetti, G.M. VArAnini
(edd.), Il Veneto nel Medioevo. Dalla ‘Venetia’ allaMarca Veronese, Verona 1989.
A. Venturi 1902, Storia dell’arte italiana, II, Milano.
p. Verzone 1942, L’architettura religiosa dell’Alto Me-dioevo nell’Italia Settentrionale, Milano.
p. Verzone 1945, L’arte preromanica in Liguria ed i rilievidecorativi dei secoli barbari, Milano.
p. Verzone 1953, I capitelli del tipo corinzio dal IV all’VIIIsecolo, in Forschungen zur Kunstgeschichte unChristlichen Archäologie, Baden Baden, pp. 87-97.
p. Verzone 1963, La scultura decorativa dell’alto Me-dioevo in Oriente e in Occidente, in “Corso di Culturasull’Arte ravennate e Bizantina”, 10, pp. 381-388.
p. Verzone 1968, Da Bisanzio a Carlomagno, Milano.
C. ViBert-GuiGue, G. BisHeH 2007, Les peintures de Qu-sayr ’Amra: un bain omeyyade dans la bâdiya jor-danienne, Beirut.
d. ViCini 1987, La civiltà artistica: l’architettura, in Storiadi Pavia, Milano, ii, pp. 317-341.
M. ViellArd-troieKouroFF 1962, Tables de canons et stucscarolingiens, in Stucchi e mosaici 1962, pp. 154-175.
M. ViGnoli 2000, Il capitello di Cunimondo. La pieve diSan Martino in Gusnago dai Longobardi ai Gon-zaga, san Martino in Gusnago.
l. VillA 2003, Edifici di culto in Friuli tra l’età paleocri-stiana e l’altomedioevo, in Frühe Kirchen 2003, pp.501-579.
B. ViolAnte 1963, La chiesa bresciana nel Medioevo, inStoria di Brescia, Brescia, i, pp. 1001-1020.
A. VisCoGliosi 1996, Il tempio di Apollo in Circo e la for-mazione del linguaggio architettonico augusteo,“Bollettino dei Musei Comunali di roma”, suppl. 3.
568
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 16/07/14 10.54 Pagina 568
BiBlioGrAFiA
569
Vita dietro le cose 2004, F. rossi (ed.), La vita dietro lecose. Riflessioni su alcuni corredi funerari da Brixia,Milano 2004.
K. VoiGt 1909, Die königlichen Eigenklöster im Lango-bardenreiche, Gotha (rist. anast., Aalen 1969).
W.F. VolBACH 1976, Elfenbeinarbeiten der Spätantike unddes frühen Mittelalters, Mainz (3rd ed.).
V. VoltA 1994, Le vicende edilizie della chiesa e del con-vento di San Francesco, in La chiesa e il convento diSan Francesco d’Assisi in Brescia, Brescia, pp. 11-80.
V. VoltA 2004, Brescia città d’arte: una sosta a San Fran-cesco, in A. sABAtuCCi (ed.), La chiesa di San France-sco. Una storia di fede e di arte. I nuovi restauri,Brescia, pp. 103-124.
Volto storico di Brescia 1978-1985, G. pAnAzzA (ed.), Ilvolto storico di Brescia, 5 voll., Brescia 1978-1985.
s. WAetzoldt 1964, Die Kopien des 17. Jahrhundertsnach Mosaiken und Wandmalereien in Rom, Mu-nich.
A. WAlMsley 2000, Production, exchange and regionaltrade in the Islamic east Mediterranean, in i.l.HAnsen, C. WiCKHAM (edd.), The Long Eighth Century:Production, Distribution and Demand, leiden-Boston, pp. 265-343.
A. WAlMsley 2007, Economic developments and the na-ture of settlement in the towns and countryside ofSyria-Palestine, in “dumbarton oaks papers”, 61, pp.319-352.
Wandmalerei des frühen Mittelalters 1998, M. eXner
(ed.), Wandmalerei des frühen Mittelalters. Bestand,Maltechnik, Konservierung. Tagung des deutschenNationalkomitees von ICOMOS (lorsch, 10-13 ottobre1996), Münich 1998.
B. WArd-perKins 1984, From Classical Antiquity to theMiddle Ages: Urban Public Building in Northern andCentral Italy, AD 300-850, oxford.
A. Weis 1977, Die langobardische Königsbasilika vonBrescia. Wandlungen von Kult und Kunst nach derRombelagerung von 756, sigmaringen.
K. WeitzMAnn 1948, The Joshua Roll, a Work of the Mace-donian Renaissance, princeton n.J.
K. WeitzMAnn 1951, The Fresco Cycle of S. Maria di Cas-telseprio, princeton n.J.
K. WeitzMAnn 1979 (ed.), The Age of Spirituality. Late An-tique and Early Christian Art, Third to Seventh Cen-tury, Catalogo della Mostra (new york, 1977november 19-1978 february 12), new york.
s. WeMple 1985, S. Salvatore/S. Giulia. A case study in theEndowment and Patronage of a Major femaleMonastery in Northern Italy, in J. KirsHner, s. WeMple
(edd.), Women of the Medieval World, oxford, pp.85-102.
d. WHitCoMB 1988, Khirbet al-Mafjar Reconsidered: theCeramic Evidence, in “Bulletin of the Americanschools of oriental research”, 271, pp. 51-67.
d. WHitCoMB, H. tAHA 2013, Khirbat al-Mafjar and itsplace in the archaeological heritage of Palestine, in“Journal of eastern Mediterranean Archaeology andHeritage studies”, 1, pp. 54-65.
d. WHiteHouse 2003, ‘Things that travelled’: the surpris-ing case of raw glass, in “early Medieval europe”, 12,n. 3, pp. 301-305.
H. WHiteHouse 2001, The Paper Museum of Cassiano delPozzo. A.I. Ancient Mosaics and Wall-paintings, lon-don.
M. WHittAKer 1967 (ed.), Die apostolischen Väter I: DerHirt des Hermas, Berlin (2nd rev. ed.).
C. WiCKHAM 2005, Framing the Early Middle Ages: Europeand the Mediterranean, 400-800, oxford.
C. WiCKHAM 2009, The Inheritance of Rome: a History ofEurope from 400 to 1000, london.
J. Witte orr 2010, Kirche und Wandmalereien am Kamal-Ahbariya – Jahrbuch für Antike und ChristentumErgänzungsband 36, Münster Westfalen.
J. zeMp, r. durrer 1906, Le couvent de St. Jean a Munsterdans les Grisons, Geneve.
M.G. ziMMerMAnn 1897, Oberitalienische Plastik, leipzig.
p.l. zoVAtto 1964a, L’arte altomedioevale, in Verona e ilsuo territorio, Verona, ii, pp. 479-582.
p.l. zoVAtto 1964b, Il ciborio di San Giorgio di Valpoli-cella nell’ambito della cultura figurativa altomedie-vale e longobarda, in Problemi della civiltà e dellaeconomia longobarda, Milano, pp. 125-136.
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 16/07/14 10.54 Pagina 569
InDICE
Premesse ..........................................................................................
Immagini del monastero ................................................................
Gian Pietro brogiolo Dalla fondazione del monastero al mito di Ansa e Santa Giulia
Gian Pietro brogiolo Archeologia e architettura delle due chiese di San Salvatore ..
flavia De rubeis Desiderio re, la regina Ansa e l’epigrafe dedicatoria di SanSalvatore a Brescia ...................................................................
vincenzo Gheroldi evidenze tecniche e rapporti stratigrafici per la cronologia delsistema decorativo della basilica di San Salvatore II ..............
vincenzo Gheroldi La cripta e il cunicolo settentrionale. Materiali, tecniche difinitura, sequenze ..................................................................
Monica Ibsen Sistemi decorativi per la basilica di Ansa e Desiderio .............
John Mitchell The painted decoration of San Salvatore di Brescia in context
Stefania Tonni I frammenti pittorici provenienti dalla chiesa di San Salvatore
bea leal The stuccoes of San Salvatore, Brescia, in their Mediterraneancontext .......................................................................................
Stefania Tonni Gli stucchi altomedievali della basilica di San Salvatore.Ricerche e ricomposizioni degli schemi decorativi ..................
Serena Strafella Sepolture dipinte nel monastero di San Salvatore ...................
Monica Ibsen Scultura architettonica e arredo liturgico in San Salvatore enel complesso monastico ...........................................................
francesca Morandini La presenza dell’antico nelle strutture del monastero ............
renata Stradiotti Gli interventi alle strutture architettoniche della chiesa di SanSalvatore dal medioevo ai giorni nostri ...................................
renata Stradiotti I restauri nella chiesa di San Salvatore dalla soppressione delmonastero ai giorni nostri ........................................................
Gian Pietro brogiolo Dalla corte regia al monastero di San Salvatore. Le sequenzedi scavo ......................................................................................
alessandro Canci, Pamela Corsi, Studio bioarcheologico dei resti scheletrici umani dellesepolture del monastero di Santa Giulia a Brescia .................
Enrico fiorin, ornella Salvadori, Indagini di fluorescenza X portatile e stratigrafiche sullepellicole pittoriche .....................................................................
fabrizio antonelli, Stefano Cancelliere, lorenzo lazzarini, Indagini di laboratorio conparticolare riferimento agli strati preparatori del colore ........
Bibliografia ...............................................................................
3
10
17
35
89
97
121
141
169
203
221
247
255
269
341
383
405
419
505
521
533
543
+Z-SGiuliaBS_1_SGiuliaBS 19/06/14 14.06 Pagina 571