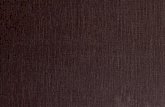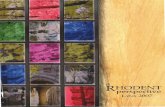Da Rhodes a Carosi: per la storia della stampa italiana - 2010
-
Upload
unitusdistu -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Da Rhodes a Carosi: per la storia della stampa italiana - 2010
«Culture del testo e del documento», 11., 2010., n° 32, Maggio-Agosto, p. 131-165.
DA RHODES A CAROSI: PER LA STORIA DELLA STAMPA ITALIANA PIERO INNOCENTI* § 1. Premessa. Chi scorra una ideale bibliografia della storia della stampa in Italia, trova il descrittore VITERBO occupato, nel sec. 20., da due nomi: Dennis E. Rhodes e Attilio Carosi, che si vanno ad aggiun-gere al minimo elenco pre-esistente: essenzialmente, il solo Coretini (Roma, Stamperia di San Michele a Ripa Grande, 1774). Per il primo, si è trattato della tappa di un itinerario lunghissimo, snodatosi nel mon-do e in Italia toccando località le più diverse e remote, purché ospitas-sero una collezione libraria di adeguato spessore retrospettivo; per il secondo si è trattato dell'impegno appassionato di una vita umbratile e monotopica. Ambedue bibliotecarî, l'uno ha sviluppato la propria carriera in una capitale bibliotecaria (e non solo), Londra; l'altro nella oscurità di una biblioteca civica, in una delle province più incolte del centro Italia: Viterbo. Le loro strade si sono incontrate, senza conflitto (ma senza collaborazione) il tempo necessario per verificare interessi comuni e divergenza d'intendimenti su come coltivarli quanto a me-todo, scelta di pubblico, canali comunicativi. Non un duello, ma cer-tamente non un accordo; forse una involontaria (e quindi subìta) complementarità. Fra il 1997 e il 2000 mi è capitato di dover fare i conti direttamente col loro lavoro, perché a ciò mi portava il percorso dei miei doveri istitu-zionali di allora, come spiego in queste pagine, che vedono la luce do-po molto tempo, per il sostanziale imbarazzo suscitato da una vicenda che mi precedeva di così tanto, da ogni punto di vista. Ora, forse, è giusto e possibile renderne conto col necessario distacco.
*** Il 9 giugno 1999 la Facoltà di Conservazione di beni culturali di Viter-bo decise di proporre Rhodes per il conferimento di una laurea honoris
* Dipartimento di Storia e culture del testo e del documento, Viterbo; e-mail: <[email protected]>, <[email protected]>.
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
132
causa, con questa motivazione: «Il Consiglio di Facoltà, unanime, ac-coglie la proposta che proviene dal Dipartimento di storia e culture del testo e del documento, e ritiene di indicare per l'eventuale confe-rimento di una laurea d'onore in Beni culturali il nome di Dennis Rhodes. "Bibliotecario emerito della Biblioteca del British Museum, poi British Library, dove per decennî si è occupato delle sezioni bi-bliografiche retrospettive riguardanti l'Italia, Dennis Rhodes ha illu-strato la professione bibliografica con numerosissimi scritti di riso-nanza internazionale, occupandosi fra l'altro di tipografia viterbese, cui ha dedicato studi pionieristici, coi quali ha dimostrato come si possa trattare un tema periferico e marginale in modo e con ottica non provinciali. Rhodes si è dedicato anche con competenza a temi della tradizione d'interesse per l'Etruria e il mondo antico»1. Fatta propria la proposta da parte degli organi accademici sovraordinati, la cerimonia di conferimento, presieduta dal rettore pro tempore, Marco Mancini, si svolse il 24 maggio del 2000, nell'aula intitolata a Gregor Mendel', al-lora Aula Magna dell'Ateneo2. Mi piace ricordare quell'accaduto per tre motivi. Il primo è il valore bibliografico e bibliotecario dell'insignito, che ha esercitato un co-stante e fecondo magistero sulle questioni inerenti la storia della stampa in Italia. Il secondo è che si tratta dell'unica laurea honoris
causa espressa durante il primo ventennio di vita di una Facoltà nata con quattro anime (Archeologia, Archivistica, Bibliografia, Storia dell'arte), da sùbito in costante conflitto fra loro, per lo più de mini-
mis; sul nome di Rhodes si interruppe per un istante lo scontro, ces-sando la Facoltà di fissare lo specchio di Narciso, per guardare all'e-sterno. Poi le turbolenze ripresero, e la presidenza di d'Auria rimane, si può dire fino a ieri, l'ultimo governo assennato di quell'insieme accademico, più collage che collège. Il terzo motivo è che la Facoltà mi designò ad oratore ufficiale della laudatio; per ragioni istituzionali, e non per meriti: ero l'ordinario anziano di materie bibliografiche e mi trovavo, per di più, a dirigere il dipartimento nel momento in cui la proposta aveva preso forma.
1 La approvò un Consiglio presieduto da Elio d'Auria (verbale n° 118. 9 giugno 1999, punto 4.2, c. 15-16). 2 Ne dà cronaca MARIA CRISTINA MISITI, Laurea honoris causa a Dennis Rhodes, «Biblioteche oggi», 18., 2000, n° 8, ottobre, p. 90-91.
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
133
Il protocollo che l'Ateneo viterbese segue per il conferimento della laurea honoris causa è apprezzabilmente sobrio, e la cerimonia per Rhodes non fece eccezione. Dopo che il Rettore dichiara aperta la se-duta, informando su chi sia il candidato, e perché si ritiene che abbia raggiunto, grazie alla sua attività e dedizione allo studio, chiara fama a livello nazionale e internazionale, il Preside pro tempore della Facol-tà proponente presenta il candidato, leggendone un breve profilo, per cedere poi la parola all'incaricato della laudatio, il quale introduce l'argomento della lezione che sarà tenuta dal candidato, richiamando l'attenzione della Commissione sul contributo da lui dato al progres-so delle conoscenze. Il Rettore rivolge alla Commissione formale domanda se il laureando possa essere ammesso a sostenere la lezio-ne sulla base delle informazioni che sono state fornite dal laudator; avutane risposta affermativa, invita il candidato a svolgere la lezio-ne. Quando questa è terminata, il Rettore invita il candidato a pren-dere posto davanti alla Commissione, che si alza in piedi per per-mettere al Rettore di pronunziare la proclamazione: «Visti i risultati della discussione della tesi dal titolo (etc.), in virtù dei poteri conferi-timi dalla Legge, proclamiamo il dottor (etc.) Dottore in (etc.) honoris
causa». Il Rettore scende dalla cattedra, e legge la formula rituale: De-
siderio desideraui te corona doctorea sublimare in scientiis humanitatis pra-
eseruandae alendaeque, quibus te nutristi. Accipe, inquam, a me biretum
siue diadema doctorale quod capiti tuo impono. Tibi librum clausum mo-
xque apertum feliciter praebeo. Anulo aureo in nomine scientiae laetanter
desponso. Il Rettore abbraccia il candidato, gli dà la parola per il rin-graziamento, dopo di che dichiara chiusa la seduta. Il fascicolo recuperato dal cassetto in cui lo avevo volontariamente occultato, mi restituisce il testo del discorso, che qui riporto, come lo lessi, solo corredato di note, allora non necessarie.
LAUDATIO ACADEMICA di D. E. Rhodes. 24 Maggio 2000. Magnifico Rettore, signori Studenti, amplissimi Presidi, chiarissimi Colleghi, Autorità, gentili intervenuti. Il Consiglio della Facoltà di Beni culturali mi ha incaricato di tratteggiare in pubblico le motivazioni che ci fanno ritenere Dennis Rhodes meritevole di essere iscritto honoris causa fra i nostri laureati. Non mi ritengo degno di questo onore; ma non mi sfuggiva, accettando l'incarico, che esso è, in fondo, facile da svolgere, e di poca fatica, tanto il curriculum del can-didato, laureato a Cambridge e poi bibliotecario di carriera in British Li-brary, parla chiaro dei suoi meriti, del suo lavoro, dei suoi studî nell'àmbito
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
134
delle discipline del libro, e in particolare della storia della stampa tipografi-ca.
In un testo concepito nel 1960, divulgativo e rapido, che può essere con-siderato esemplificativo del livello di senso comune sull'argomento, e che è ancora di valore, Emanuele Casamassima (indimenticabile direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze fra il 1965 e il 1970), studioso del di-segno dei caratteri tipografici, schizza una breve storia dell'arte tipografica da tale punto di vista, ignorando volutamente gli aspetti della tipografia in quanto azienda pre-editoriale: come gli ebbe a obiettare Barberi, committen-te del testo per conto di Massimo Pallottino3, in una lettera ad oggi non ri-trovata, ma di cui sopravvive la responsiva, che ne lascia intuire il senso. Ciò avviene, è lecito supporre, non solo perché Casamassima intende qui portare la riflessione circa l'arte tipografica entro l'alveo della storia della scrittura, disciplina preferita e quindi suo interesse soggettivo, ma anche perché sente mancanti i presupposti psicologici e logistici per fare storia della tipografia in quanto somma di storie biografiche, mentali e sociali degl'individui, economiche delle aziende: oltre a mancare di cronologie consolidate. Lo testimoniano sia il taglio del testo giunto alla pubblicazio-ne (ridimensionato rispetto alle prime intenzioni), sia il suo carteggio con Barberi4.
3 Francesco Barberi (1905-1988), bibliotecario formatosi a Roma a studî classici, fu in prima nomina (1933) alla Nazionale di Firenze; poi (1935-1944) soprintendente, poi (1944-1952) direttore dell'Angelica; poi ispettore e ispettore generale, fino al collocamento a riposo (1970); a lungo inse-gnante per incarico nella Scuola speciale per archivisti e bibliotecarî di Roma, La Sapienza. Fonte il Dizionario dei bibliotecarî curato per l'Aib da Simonetta Buttò: <http://www.aib.it/aib/editoria/dbbi20/>. Per una valuta-zione critica del personaggio e della sua influenza sull'ambiente profes-sionale bibliotecario, v. alcuni scritti di Enzo Bottasso (1918-1998, su cui la scheda, sempre di Buttò, nel medesimo repertorio), in part. Il catalogo per autori (Torino, Associazione piemontese dei bibliotecari, 1978), passim. Quanto a Massimo Pallottino (1909-1995), fondatore dell'Etruscologia in Italia (Premio Balzan 1982 per le sue scoperte), qui compare in veste di di-rettore dell'Enciclopedia di cui alla n. successiva. 4 E. CASAMASSIMA, Tipografia, in Enciclopedia universale dell'arte, v. 6. (Gha-na-Grünewald), Venezia-Roma, Istituto per la collaborazione culturale, [post 1960], col. 511-527, in part. 523-524. Accenni al testo preparatorio, più esteso (riportato infra, Appendice, n° 2), stanno nel carteggio con Barberi, lettere del 1960: 9 e 23 marzo, 1 aprile, 11 aprile, infine 20 giugno, nella quale C. comunica che Pallottino, direttore dell'Enciclopedia, ha chiesto una sensibile riduzione del testo. Come ho ricordato altrove e a suo tempo (Miscellanea Maltese, 1995) sono debitore a Giorgio De Gregori per l'aiuto nella consultazione di queste lettere e per avermene autorizzata la ripro-
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
135
È un'impostazione classica per la storia della materia, ereditata dalla tradizione ottocentesca, che prevede la morfologia come linea-guida della ricerca. Si pensi allo studio sul frontespizio dello stesso Barberi5, alla costi-tuzione del Typenrepertorium come via di accesso alla genealogia dei pale-otipi, o al modo in cui, 1900, Hart ha condotto l'analisi sulla evoluzione dei tipi all'interno della tipografia oxoniense settecentesca6.
Lo studio del carattere è solo uno degli aspetti dello studio del libro an-tico; un altro è quello testuale, un terzo è quello del modo di produzione (e delle fonti che lo documentano, in primo luogo l'archivio d'azienda), un quarto è la comprensione del diaframma che da esso ci separa e che dob-biamo superare per raggiungere l'obiettivo della ricerca. Il catalogo è il punto di arrivo del percorso: in quanto descrizione bibliografica, è esso infatti che richiama l'attenzione sull'unità.
Nel gennaio 1998 Maria Iolanda Palazzolo, ponendosi questioni storia del libro moderno e contemporaneo in termini di storia dell'editoria, non più di storia della tipografia, osserva: «Tra i tanti problemi che deve af-frontare chi voglia disegnare l'evoluzione storica dell'editoria libraria in Italia vi è quello di tracciare una mappa quanto più possibile precisa delle aziende editoriali. La particolare natura dello sviluppo nazionale italiano, la mancanza di una capitale culturale "forte", come è stato sottolineato in molte sedi, ha portato alla proliferazione nei diversi territori della peniso-
duzione, nel marzo 1993. Nello studio di esse sono stato aiutato, intorno al 2000, da Katiuscia Dormi, mia scolara. Qualcosa di inerente alla logistica preliminare all'Iter Germanicum ne è stata anticipata in E. CASAMASSIMA, Viaggio nelle biblioteche tedesche (1956-1963). Con un saggio di bibliografia dei suoi scritti 1951-1995, Manziana, Vecchiarelli, 2002, passim; v. a. gli atti del Convegno Il nomos della biblioteca, San Gimignano 2001, pubblicato nel 2008. 5 Ci si riferisce a Il frontespizio nel libro italiano del Quattrocento e del Cinque-cento, Verona, [s. e.], 1977 (Verona, Stamperia Valdonega), 2 v. (Documen-ti sulle arti del libro. 7); rist. anast. dell'ed.: Milano, Il Polifilo, 1969. Il fron-tespizio nel libro italiano del Seicento, Firenze, Olschki, 1983, estr. da «La Bi-bliofilia», 85., [1983], disp. 1, p. 49-72; Frontespizio e antiporta nel libro italia-no del Settecento, [Roma,] Bulzoni, [1985?], estr. da «Il Bibliotecario», 1985, n° 4/5, p. 45-55. 6 Ci si riferisce nel testo rispettivamente al titolo di Konrad Haebler (su cui v. ora EDOARDO BARBIERI, Haebler contro Haebler, Milano, Università Catto-lica, 2008), e a HORACE HART, Notes on a Century of Typography at the University Press, 1693-1794, Oxford, Clarendon, Press, 1970: reprint del-l'ed. 1900 (l'analisi infra, in Appendice, n° 3).
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
136
la di imprese tipografiche con identità e caratteristiche peculiari, talune volte fortemente competitive tra loro»7.
Non si può qui approfondire che cosa è successo nella storiografia di set-tore, durante i quattro decennî intercorsi fra lo scritto di Casamassima e quello di Palazzolo (1958-1998), che hanno visto l'intensa attività di ricerca di Rhodes; va rilevato che son continuati, con esiti più o meno felici, alcuni lavori di scavo, fra i quali potremmo citare, fra gli italiani, forse quelli di Vi-spi per Gubbio (1974), di Tammaro Conti per Orvieto (1977), di Giochi e Mordenti per Ancona (1980); senz'altro e sopratutto, almeno in questa sede, il lavoro (anch'esso quarantennale) da Attilio Carosi dedicato a Viterbo [V. in Appendice i n° 3, 4, 5, 1, e la seconda parte di questo saggio], oltre alla decina di titoli ricavabili dal repertorio di Clerici, Falcetto e altri8, aggiorna-to da Zappella quanto ai cataloghi di edizioni del Cinquecento e da Solari per quanto concerne gli ultimi tre secoli9.
Anche a partire da un mondo minore, se così si può dire, qual è la tipo-grafia, per l'Italia dobbiamo fare i conti con un luogo di accentuato poli- 7 M. I. PALAZZOLO, Esiste una questione meridionale dell'editoria?, «La fabbri-ca del libro. Bollettino di storia dell'editoria in Italia», 3., 1997, n° 2, p. 2-6, in part. p. 2. 8 Editoria libraria in Italia dal Settecento a oggi. Bibliografia degli studi 1980-1990, a c. di Luca Clerici, Bruno Falcetto, Giovanni Ragone, Gianfranco Tortorelli, Roma, Aib, 1991, che elencano: FIORELLA MARCHET, L'attività tipografica-editoriale di mons. Angelo Folani (Pisa, 1771-1803), «La bibliofilia», 82., 1980, 1, p. 51-74 (CLERICI-FALCETTO, p. 15). ALESSANDRO VISCONTI, Pi-rola: due secoli 1781-1981, a c. di Guido Bezzola, Milano, Pirola, 1981, p. 134, ill. (ivi, p. 22). MARIA E. MENICHETTI BIANCHI, Annali tipografici di Car-lo Baduel, Perugia, Regione dell'Umbria-Volumnia, 1983, p. 536, ill. (ivi, p. 5). ENZO COLOMBO, Giuseppe Lucchesini stampatore-libraio bolognese fra '700 e '800: inventario del carteggio e documenti, «L'Archiginnasio», 1984, p. 287-311 (ivi, p. 11). TONI IERNANO, Intellettuali e stampatori a Livorno tra '700 e '800, Livorno, Edizioni nuove, 1984, p. 152 (ivi, p. 14). FIORELLA ROMANO, Francesco Ricciardi libraio, editore e tipografo a Napoli nella prima metà del Set-tecento, «Accademie e biblioteche d'Italia», 1985, 1, p. 3-13 (ivi, p. 19). Lavo-ri preparatori per gli Annali della Tipografia Soliani, a c. di Ernesto Milano, Modena, Mucchi, 1986, p. lxxii, 456, ill. (ivi, p. 4). Immaginare il testo. Mo-stra storica dell'editoria siciliana dal Quattrocento agli inizi dell'Ottocento, a c. di Diana Malignaggi, Palermo, Regione Sicilia, 1988, p. 336, ill. (ivi, p. 4). EUGENIO DI RIENZO, Intellettuali, editoria e mercato delle lettere in Italia nel Settecento, «Studi storici», 1988, 1, p. 103-125 (ivi, p. 11). 9 GIUSEPPINA ZAPPELLA, Cataloghi italiani di cinquecentine. Riflessioni metodo-logiche e rassegna bibliografica (1984-1997), «Accademie e biblioteche d'ita-lia», 67., n. s. 50., 1999. n° 1, gennaio-marzo, p. 19-53. GABRIELLA SOLARI, Studi di storia del libro in Italia (secc. XVIII-XX), ivi, 65., n. s. 48., 1997, n° 4, ottobre-dicembre, p. 31-36.
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
137
centrismo, sommatoria di microrealtà di cui mancano talvolta anche gli strumenti di ricognizione preliminare. Un esempio della problematica, nello stesso numero di «Fabbrica del libro», è studiato da Montanari, che illustra il lavoro da farsi presso l'Archivio di Stato di Milano e l'Archivio della Curia vescovile della medesima città per arrivare ad una ricostru-zione attendibile della editoria lombarda, sempre per il secolo 18.10. Si trat-ta di una situazione diversa dalla stratificazione storica, caratterizzata da forte unitarietà di accentramento delle fonti, che in altre tradizioni ha reso possibili fatiche come quella di Hart, o nel 1904 di Toribio Medina sulla tipografia di Oaxaca fra il 1720 e il 1820; o quella di Corroënne sulla pro-duzione di bibliofilia a Lille, Lione, Orléans11. Premesse necessarie del fat-to che si possano, con situazioni quasi intatte di concentrazione delle fon-ti, scrivere su basi solide lavori come quelli dei Fuks (1984-1987) sulla ti-pografia ebraica in Olanda lungo due secoli, Seicento e Settecento12.
Dennis Rhodes la sua carriera di bibliotecario l'ha percorsa, appunto, in uno dei luoghi di massima concentrazione delle fonti librarie, in cui è parti-colarmente facile indulgere alla tentazione di spaziare: Londra, il Museo, la sua Biblioteca, leggendario epicentro del sapere materiale e scritto. Quella biblioteca, come sappiamo, da tempo è divenuta The British Library, con ciò esplicitandosi ad archivio della produzione editoriale britannica, e conclu-dendo una traiettoria impostata più di un secolo prima da Panizzi, che la concepiva così quando ancora così non si chiamava.
Nel 1993 la British Library volle onorare i primi settanta anni di vita di Rhodes; la sua bibliografia allora ammontava a 438 titoli13. In quell'elenco, che già sarebbe da aggiornare, si trovano tutti gli elementi che possono far vedere nella carriera di Rhodes non solo il grande bibliotecario, non solo il grande studioso di storia della stampa, dell'erudizione e delle biblioteche, e più in generale di storia della cultura, ma anche il grande amico dell'Italia, perché di essa conoscitore sub specie typographica, dopo averla conosciuta sub
specie militari per dovere bellico, durante la II Guerra mondiale.
10 ANNA PAOLA MONTANARI, L'editoria lombarda del XVIII secolo, ivi, p. 7-11. 11 Cfr. JOSÉ TORIBIO MEDINA, La imprenta en Oaxaca 1720-1820, Amsterdam, Israel, 1964. Facsimile dell'ed. 1904; A. CORROËNNE, Livres-bijoux précur-seurs des Cazins. Biblioiconographie historique des premières collections fondées de 1773 à 1779, à Lille, à Lyon et à Orléans, Paris, Corroënne, s. d. 12 Cfr. LAJB FUKS-R. G. FUKS-MANSFELD, Hebrew Typography in the Northern Netherlands 1585-1815. Historical Evaluation and Descriptive Bibliography, Leiden, Brill, 1984-1987. 13 Bibliography of the Published Works of D. R. to the End of September, 1992, a c. di D. V. Reidy, London, The British Library, 1993.
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
138
Moltissime, oltre la settantina, sono le località italiane e le aree, regionali o interregionali, cui l'Autore si è applicato; le cito in ordine di frequenza de-crescente degli studî ad esse dedicati, indicando fra parentesi i numeri di occorrenza nell'elenco Reidy: 23 occorrenze: ITALIA in generale (9, 61, 62, 66, 149, 155, 163, 170, 200, 207, 233, 249, 256, 263, 269, 277, 292, 314, 320, 322, 379, 380, 423). 19 occ.: FIRENZE (91, 119, 131, 151, 179, 213, 243, 289, 301, 315, 324, 327, 329, 333, 342, 358, 360, 363, 402). 16 occ.: VENEZIA (75, 96, 107, 130, 218, 220, 251, 295, 300, 318, 375, 397, 398, 429, 435, 438). 10 occ.: MILANO (82, 83, 90, 99, 177, 199, 309, 352, 362, 416), Roma (165, 168, 172, 188, 189, 194, 198, 252, 338, 343). 9 occ.: BOLOGNA (76, 80, 109, 181, 270, 347, 350, 394, 404). MANTOVA (19, 22, 30, 40, 41, 47, 57, 147, 351). 6 occ.: BRESCIA (6, 144, 356, 369, 381, 389), SIENA (70, 158, 174, 337, 382, 406). 5 occ.: PADOVA (103, 135, 140, 159, 353), VERONA (210, 316, 341, 382, 433), VITERBO (93 del 1961, 118 del 1963, 131 del 1964, 164 del 1968, 261 del 1977). 4 occ.: BRINDISI (67, 215, 246, 302), GENOVA (115, 202, 422, 438), MONDOVÌ (1, 2, 5, 71), TORINO (110, 112, 237, 273), TREVISO (336, 348, 377, 415). 3 occ.: BARI (13, 18, 53), COSENZA (11, 39, 169), TARANTO (111, 137, 222). 2 occ.: CALABRIA (48, 102), CASELLE (110, 237), FOGGIA (38, 67), GAETA (278, 294), MANFREDONIA (38, 247), MONTEFIA-
SCONE (220, 253), NAPOLI (185, 368), PIEMONTE (122, 161), PUGLIA (192, 214), VERCELLI (69, 131), VOLTERRA (293, 307). 1 occ.: ASSISI (117), AVELLINO (77), AVERSA (94), BARLETTA (38), BENEVENTO (77), BERGAMO (32), BORGO LAVEZ-
ZARO (311), CAPUA (94), CASTELLAMMARE DI STABIA (294), CILENTO (219), COLLE VAL D'ELSA (396), CORREGGIO (413), CRESCENTINO (121), EMILIA (346), FAENZA (262), FOLIGNO (221), GALATINA (305), LECCE (231), LUNIGIANA (7), MODENA (431), MONTEFUSCOLO (77), MUGELLO (385), NUSCO (175), ORVIETO (411), PAVIA (21), PERUGIA (188), PISA (339), PISTOIA (128), SALERNO (282), SANTORSO (393), SARDEGNA (178), SCIGLIANO (143), TODI (311), TORREBELVI-
CINO (393), TRANI (23), TRENTO (374), TRIESTE (183), TRINO VERCELLESE (334), URBINO (173), VELLETRI (108), VICENZA (393).
A queste devono aggiungersi i tre interventi su G. Dennis (1814-1898): Dennis of Etruria (n° 216, del 1973, trad. in italiano nel 1992 a Siena, cfr. n° 437); la prefazione al suo The Cities and Cemeteries of Etruria, 1985 (n° 354).
A temi italiani è dunque dedicata poco meno di metà del totale della bi-
bliografia di Rhodes; non so se questo renda lecito pensare ch'egli abbia u-n'anima (bibliografica, naturalmente) dimidiata, per arrivare a concludere che una delle due metà è italiana. Certamente consente di osservare che, se è normale che chi si occupa di tipografia manuale studî e scriva su Venezia, Firenze, Milano e Roma, è meno normale che nella medesima persona s'in-corporino competenze legate anche alla conoscenza, non solo bibliografica ma anche collezionistica e di storia della biblioteca di un territorio che geo-graficamente e culturalmente non è il suo, su un'ampiezza, come si è appe-
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
139
na visto, da Nord a Sud. Il bilinguismo culturale di Rhodes culmina nel 1969 in una traduzione dall'italiano.
Il primo suo lavoro di una certa estensione è di bibliografia contempora-nea, su Edward Hutton e, composto per ragioni amicali, esce nel 1955, in occasione degli ottant'anni del bibliografato14; del 1956 è la curatela, in col-laborazione con Anna E. C. Simoni, di due v., l'8. e il 9., di un dizionario di anonimi e pseudonimi della letteratura inglese (n° 31 e 105). Del 1958 (l'an-no che precede il suo primo soggiorno viterbese, realizzatosi nel Settembre 1959) è la nota su Pelberto di Timisoara, il cui Pomerium de sanctis fu stam-pato ad Augsburg non prima del 1502 (n° 55), dello stesso Pelberto, l'anno successivo, vengono rintracciate altre due edizioni (n° 74). Del 1960 è lo studio sull'introduzione dei caratteri greci in Spagna (n° 85) e sulla stampa in caratteri greci e in Grecia (più in generale, sulla circolazione di letteratura greca) Rhodes tornerà a più riprese, studiando tipi, formazioni di raccolte, cataloghi di libri greci (come nei n° 223, 229 del 1974, 240 del 1975, 252 del 1976, 265 del 1977, 291 del 1979, 304 del 1981, 351 del 1984).
Nel 1958 era già uscita, per altro, la presentazione al pubblico di Bangalo-re, India, della propria esperienza in alcune grandi biblioteche europee (n° 40); l'anno dopo egli dedica alla medesima località uno studio sul primo li-bro ivi pubblicato (n° 64); nel 1960 recensisce per «The Library» la storia della stampa in India di Kabka Priolkar (n° 86), nel 1961 tenta una bibliogra-fia storica dell'India (n° 95), nel 1969, nel 1970 e poi nel 1974 torna sull'ar-gomento con saggi sulla stampa ancora in India, ma anche in Pakistan, Sri Lanka (allora Ceylon), Birmania e Thailandia (n° 176), a Bangalore fra il 1840 e il 1850 e nel 1848 (n° 197 e 228). Nello stesso anno 1974, dedicato alla tipografia coloniale, pubblica il lavoro sui primi libri stampati a Montefia-scone (n° 230) e non gli sfugge, nella sua novità di metodo, il saggio di Ca-samassima sulla prima edizione della Comedìa, a Foligno, nel 1472 (n° 221). L'intreccio fra Oltremare e Alta Tuscia dice, forse, qualcosa del distacco del-l'osservatore.
La quasi decennale collaborazione (1955-1963) a «Italian Studies», con le nove rassegne annuali di Works of Italian Interest Published in Great Britain, è una continua finestra aperta sui mondi delle sue due lingue, quella materna e quella d'elezione, applicata a come l'Inghilterra vede l'Italia (si tratta dei n° 17, 33, 42, 59, 73, 84, 98, 113, 120: una all'anno). Atteggiamento a specchio, l'Inghilterra guardata dall'Italia, applicato a un problema di bibliografia re-
14 The Writings of E. H. A Bibliographical Tribute, compiled and presented to E. H. on eightieth birthday by his friend Dennis E. Rhodes, London, Hollis & Carter, 1955, 64 p., [2] leaves of plates : ill., port.; n° 15: all'autore Rhodes dedicherà (1970) un necrologio sul «Burlington Magazine» (n° 186 R.).
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
140
trospettiva, troviamo nella rassegna di libri inglesi recensiti a Roma fra il 1668 e il 1681, pubblicata in Italia nel 1965 (n° 136).
Un ruolo importante nella formazione di Rhodes ha giocato la figura di Victor Scholderer15, dei cui scritti egli si è fatto curatore nel 1966 (n° 148) e cui ha dedicato altri notevoli contributi biografici, metodici e di testimo-nianza: gli auguri per gli ottant'anni nel 1959 (n° 88), la cura dei saggi in suo onore, nel 1970 (n° 190), un commosso necrologio nel 1972 (n° 205). È stato anche coeditore dei saggi in onore di Roberto Ridolfi nel 1973 (n° 213) e di Conor Fahy nel 1986 (n° 371).
Spiccano poi fra i suoi interessi la cucina e i ricettari, negli aspetti sia lin-guistici, sia simbolico-rituali: è del 1968 la recensione al Handlist della colle-zione di lord Westbury (n° 162), ma anche l'edizione, 1969, di un libro di ri-cette del 1698, pubblicato con impeccabile glossario (n° 171); un intervento su un banchetto del Cinquecento in Italia (1598), del 1972 (n° 171). (Con questi titoli ho dovuto fare i conti personalmente quando, fra il 1987 e il 1994, ho lavorato in Sorengo di Lugano alla costruzione della base di dati della Fondazione B.In.G. sulla gastronomia16.)
È imponente, infine, ed è il punto di arrivo del percorso che stiamo se-guendo, la serie di monografie, traduzioni, cataloghi, la cui responsabilità è di Rhodes, equamente suddivisa fra sedi di pubblicazione italiane e inglesi: il saggio sulla stampa a Viterbo del 1963 (n° 118: Olschki, l'analisi del quale è qui in Appendice, n° 7); la già ricordata traduzione dall'Italiano di Yanoáma, di Ettore Biocca, del 1969 (n° 184: Allen & Unwin); gli annali di Lazzaro de' Soardi, del 1978 (n° 270: Olschki); gli Studies in Early Italian Printing, del 1982 (n° 320: The Pindar Press); il saggio sulla stampa a Treviso nel Quat-trocento, del 1983 (n° 336: Biblioteca comunale); gli studi sulla stampa e il collezionismo librario in Europa, del 1984 (n° 340: The Pindar Press); il cata-logo Riccardiano sulla stampa a Firenze 1471-1550 (n° 342: Olschki); la parte XII del catalogo degl'incunabuli della British Library, del 1985 (n° 357); il catalogo dei libri italiani del Settecento, sempre di BL, del 1986 (n° 380); il saggio sulla tipografia a Vicenza nel Quattrocento, del 1987 (n° 393: Biblio-teca Bertoliana); gli annali tipografici di Firenze nel Quattrocento, del 1988 (n° 402: Olschki); il catalogo dei libri spagnoli in BL, del 1989 (n° 408), i Fur-
15 1880-1971, egli pure per tutta la sua vita di lavoro in servizio al British Museum; nel 1970 fu Rhodes a curare il suo giubileo: Essays in Honour of V. S., Mainz, Pressler, 1970. Sul «passaggio di testimone» fra Scholderer e Rhodes a Londra v. ora BARBIERI, Haebler contro Haebler cit., p. 40, 41 e n. 16 Cfr. Introduzione di FONDATION BIBLIOTHÈQUE INTERNATIONALE DE GA-STRONOMIE, Catalogo del fondo italiano e latino delle opere di gastronomia. Sec. XIV-XIX, a c. di Orazio Bagnasco, 3 v., Sorengo, B.In.G., 1994, v. 1., p. 15-39.
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
141
ther Studies in Italian and Spanish Bibliography, del 1991 (n° 425: The Pindar Press).
Per capire l'estensione e il peso specifico delle collaborazioni editoriali di Rhodes, basterà dire riassumendo che figurano nell'elenco delle sue pubbli-cazioni i titoli praticamente di tutti i più importanti periodici professionali italiani, inglesi, statunitensi, tedeschi; che le sue opere sono tradotte in varie lingue; che il catalogo dell'editore Olschki, storico pilastro della Bibliografia italiana, non sarebbe lo stesso senza il suo nome.
In questo pur breve colpo d'occhio si trovano tutti gli elementi ‒ anche questo è già stato detto ‒ che fanno vedere nella carriera di Rhodes il gran-de bibliotecario, il grande studioso, il grande amico dell'Italia. Ma anche al di fuori di questa cerchia di considerazioni, la stessa periodizzazione adot-tata nel suo titolo viterbese del 1963, «dagl'incunabuli all'Ottocento», segna il rimanente della sua produzione (che non è la parte quantitativamente meno estesa), senza escludere incursioni nel Novecento.
Caratteristica del suo metodo, come di tutti i veri scienziati (non sempre, curiosamente, di tutti i bibliografi), è l'esame diretto dell'oggetto dell'inda-gine, nel suo caso l'esemplare tipografico: «Il mio lavoro d'altronde è basato esclusivamente su libri che ho veduto io e non su di un'evidenza documen-taria, come dice a p. 9 di La stampa a Viterbo (1963, n° 118 R., v. infra, Ap-pendice, n° 7)». Il libro a stampa, saremmo portati a interpretare noi, rife-rendo il portato dei migliori studî italiani di settore, è un documento, in virtù del testo di cui è veicolo, un oggetto archeologico in virtù delle testimonianze di materialità specifica di cui è intrinsecamente portatore, e infine un oggetto
archivistico, perché molti dei dati significativi che da esso si ricavano sono comprensibili solo come occorrenze di una serie. Occasionalmente, può an-che avere un valore estetico. Il libro lo si studia dunque come storia dei ca-ratteri, come storia del testo, come storia degli esemplari e della lettura. Per studiarlo, ci si basa su un criterio descrittivo asciutto e tecnicamente sempli-ce, ma di sicuro approccio identificativo, del quale ecco qui l'esempio di una descrizione relativa al 1783 (scheda n° 526, p. 201): 526 1783
1a. LA DIFESA | DELL ANTICO METODO | DELLA | VIA CRUCIS | E LA CENSURA
DEL NUOVO, | SCRITTE DA F.F.A.F.O. | Vendicate dal giudizio proferito | Dai
Gazzettieri Fiorentini nei fogli | intitolati | ANNALI ECCLESIASTICI. | [fregio] IN VITERBO 1783. | [linea] Per il Poggiarelli. )o( Con Lic. de' Sup.
Ottavo. 104 carte. [*2] A-M8 N8. pp. 203. La carta H 2 è segnata G 2 erroneamente.
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
142
Melzi, I, p. 299. L'autore è Frate Flaminio Annibali da Latera. È una risposta all'opera di D. Giuseppe Maria Pujati. Flaminio da Latera è nominato nel testo. Una copia di questo libro è catalogata nella Bibl. Comunale, Viterbo (V.G.2.57), ma fu distrutta durante la guerra. Firenze, Bibl. Marucelliana, 6.H.IV.29.
Il rapporto fra esemplari ed edizioni è questione antica: fino a che punto si spinge la serialità del prodotto di un'operazione a stampa, e quando l'e-semplare assume caratteristiche di unicità ed irripetibilità? I modelli di Bo-wers e di Gaskell risalgono alla metà e ai tre quarti del secolo scorso, e du-rante il decennio Ottanta la catalogazione ha avuto cambiamenti cospicui: alcune cose sono certamente da rispensare. Quando, cambiando i mezzi della comunicazione e collocandosi in una prospettiva diversa il libro a stampa, ci si è venuti sempre più accorgendo che la scrittura tipografica da documento andava diventando monumento (il fenomeno prende corpo con le prime fotocompositrici) forse non si è percepito quanto Rhodes avesse già dato ‒ con la sua fatica instancabile ed anni prima ‒ una lezione impareg-giabile di come col monumento tipografico occorra misurarsi. Di questa le-zione occorrerà che una nuova catalogazione tenga conto.
Se è consentito chiudere con un qualche ricordo e considerazione perso-nale, vorrei dire che bisogna aver visto il bibliotecario Dennis Rhodes all'o-pera in veste di lettore in biblioteca per capire davvero cos'è l'animale bi-bliografico, e perché oggi lo festeggiamo con una laurea honoris causa. Io l'ho conosciuto come un bibliotecario allora giovane poteva conoscere una leg-genda vivente, durante uno dei suoi soggiorni fiorentini. Non è breve il percorso ‒ sia cronologico, sia psicologico ‒ che mi porta a pronunciare, non senza emozione, queste parole conclusive. La quieta ma ferma cortesia con cui Rhodes chiedeva come ovviamente disponibili informazioni il cui livello era ben al di sopra della preparazione normalmente richiesta dallo standard professionale, era di per sé una lezione di lavoro, di stile, e se vogliamo di vita. Quando il suo fiuto (non saprei esprimermi diversamente) lo portava a cozzare contro l'apparente evidenza di un catalogo, era quasi sistematica-mente il suo fiuto a dimostrare, alla fine della verifica, di avere ragione; ma, nello stesso tempo, da bibliotecario esperto, Rhodes aveva la massima con-sapevolezza che il catalogo di una grande biblioteca rappresenta comunque la stratificazione di un linguaggio, e che quindi va prima di tutto rispettato e interpretato, mai disprezzato, nemmeno nell'errore. Anche Rhodes, come Kristeller, può dire, penso, di avere trascorso un suo diuturno Iter Italicum per le biblioteche nostrane, delle quali è stato ed è un grandissimo interlo-
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
143
cutore; resta il dubbio se esse abbiano sfruttato al meglio l'opportunità di averlo ad interlocutore.
Licenziando il lavoro su Viterbo, egli scrive nel 1963: «Se solo una picco-la città ha potuto produrre tanto materiale stampato prima dell'anno 1800, possiamo farci un'idea del lavoro gigantesco che ancora aspetta i biblio-grafi di tutta Italia»17. Quanto sia stato fatto, o sia da fare, non spetta alle valutazioni di oggi, che è giornata di festa e non di lavoro. Bisogna solo dire che da quando Rhodes ha incominciato la sua interlocuzione con le strutture bibliotecarie, per avviare i preliminari di quest'opera gigantesca, non uno anno della sua vita è trascorso senza che egli facesse pubblico dono di qualche frutto, piccolo o grande, dei suoi studî, delle sue ricerche, dei suoi pensieri: di ciò non possiamo che essergli grati. § 2. Settecento tipografico negli Stati pontificî: il contributo di Attilio Ca-
rosi. Il mio intervento su Rhodes si legava, indirettamente, ad una vicenda di un paio d'anni prima. Nel 1997 compariva di A. Carosi Il Settecento, a conclusione di un lungo percorso dedicato alla fab-brica del libro nel Viterbese; il volume occupa il numero 4. di una collana (serie editoriale) dedicata a tale programma, come ne recita esplicitamente il titolo: «Annali della tipografia viterbese»18. Sareb-be appropriato, forse, parlare di opera in quattro volumi, più che di collana, dal momento che nessun altro autore vi ha pubblicato al-cunché, ed essa è nata e morta con Carosi. Né appare possibile ap-plicarle il dinamismo (culturale ed imprenditoriale) che si suole collegare al concetto di "serie": non solo essa è emanazione di un editore improprio (i quattro titoli sono editi dal Comune, e occa-sionalmente dalla Provincia, della cittadina laziale), ma si è seria-lizzata solo dopo che il primo intervento sui Discepoli, uscito in forma non autonoma nel 1962 all'interno di un periodico locale, veniva recuperato trent'anni dopo come unità nella serie, singolare
17 D. RHODES, La stampa a Viterbo, p. 10 (l'analisi in Appendice, n° 7). 18 A. CAROSI, Il Settecento, Viterbo, Comune-Agnesotti, 1997 («Annali della tipografia viterbese. 4.»), p. XV, 481: l'analisi in Appendice, n° 1. Il 18 set-tembre 1998, per cura dell'assessorato alla cultura del Comune di Viterbo, fui invitato a tenerne una presentazione a Palazzo Brugiotti: ciò che dissi nella circostanza fa da spunto alla riflessioni che qui offro, in memoria. (Mentre scrivo, il testo di questo § 2 è stato consegnato come separatum per la miscellanea dedicata allo storico laziale, scomparso nel 2008, ed è, mi si dice, in corso di stampa presso l'Editore Sette Città di Viterbo).
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
144
caso di nuova emissione a più di un quarto di secolo dalla prima. Eccone un sommario "schedone", di consistenza:
1. Librai, cartai e tipografi in Viterbo e nella provincia del Patrimonio di S.
Pietro in Tuscia nei secoli 15. e 16., Viterbo, Comune, 1988, 151 p. 2. Girolamo Pietro e Agostino Discepoli (1603-1631), 1. ed. Viterbo, Agne-
sotti, 1962, 248 p., con in testa al front. Annali della tipografia viterbese, estr. da: «Miscellanea di studi viterbesi della Biblioteca provinciale "A. Ansel-mi" di Viterbo», e anche con tit. variante: La tipografia Discepoli. Registrata in BNI col n° 63-2959, 249 p. Poi in 2. ed.: Girolamo Pietro e Agostino Disce-
poli (1603-1631), Viterbo, Comune, 1993, stessa pag. 3. Le edizioni di Bernardino, Mariano e Girolamo Diotallevi (1631-1666) e di
Pietro Martinelli (1666-1704). Annali e documenti, in appendice: Ancora edi-
zioni Discepoli (1603-1631), ivi, 1990, 373 p. 4. Il Settecento, cit. supra, in n. 18.
Studio annalistico della produzione tipografica, dell'approvvigio-namento della carta, dell'attività biografica ed economica dei sog-getti produttivi sono i parametri applicando i quali Carosi orienta la ricerca su produzione e diffusione del libro nell'area geografica scelta come teatro di osservazione. L'accento viene posto su feno-meni leggermente diversi da quelli della tradizione degli studî ti-pografici in Italia; attestati, nel periodo in cui egli incominciava il suo lavoro (cioè, come ricorda egli stesso, primi anni Cinquanta del Novecento), allo studio del fenomeno grafico, al suo livello più al-to. Mette conto ricordare, ai fini del tema di oggi, che a Barberi si deve l'elaborazione, standard per l'epoca e per l'Italia, della tecnica di approccio all'annalistica tipografica19, ed è all'incirca a questa li-nea di metodo che Carosi si accosta. Nella prima parte ho accennato ad una pagina divulgativa di Casa-massima sulla storia della tipografia; gioverà ora leggerla estesamen- 19 Di Barberi, cui già si è accennato in n. 3, ricordiamo del 1941 la noticina su i rapporti fra P. Manuzio e Plantin; quella dell'anno dopo: Paolo Manu-zio e la Stamperia del popolo romano (1561-1570). Con documenti inediti, Roma, Tip. Cuggiani, 1942, Bollettino 1942-5336. Sono del 1951 lo studio Annali della tipografia romana di Baldassarre jr. e Girolama Cartolari (1540-1559), «La Bibliofilia», 53., p. 69-120, in estr.: Bollettino 1953-964; del 1965 I Dorico, tipografi a Roma nel Cinquecento, ivi, 67., disp. 2, p. 221-261; per arrivare alla raccolta conclusiva: Tipografi romani del cinquecento: Guillery, Ginnasio Me-diceo, Calvo, Dorico, Cartolari, Firenze, Olschki, 1983.
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
145
te, nella parte relativa alla evoluzione dal Seicento in poi, per avere lo sfondo su cui si va a stagliare l'approccio di Carosi: «Nel disegno dei tipi, in Francia, la tradizione del Garamond e della sua scuola è ancora vitale nel secolo XVII, con J. de Sanlecque, con P. Moreau – il quale disegna caratteri che imitano, sull'esempio delle 'lettres de ci-vilité' del Granjon, la scrittura corsiva – e specialmente con lo svizze-ro J. Jannon (Sedan), al quale spettano i 'typi Academiae', a lungo at-tribuiti al Garamond. I migliori prodotti del secolo XVII, tuttavia, sono olandesi e si devono agli Elzevier di Leida, creatori di un tipo di libro di piccolo formato (dal 1630), dagli snelli caratteri (diritti e corsivi) e dalla sobria decorazione (frontespizi in rame; vignette, te-state, finalini, lettere iniziali – 'lettres grises' – in legno). Anche sui disegnatori ed incisori olandesi (Christoffel van Dyck) assai forte è l'influenza dei "Garamond"20. Nel secolo XVIII l'evoluzione dei tipi verso forme geometriche, cri-stalline, già riconoscibile nei "Garamond" e palese nei prodotti o-landesi del secolo XVII, conduce alla creazione del 'romain du roi', il cui disegno, per volere di Luigi XIV, fu preparato da una com-missione dell'Académie Royale des Sciences. Ph. Grandjean de Fouchy21, cui venne affidata la realizzazione dei caratteri (1693), in-terpretò con libertà il progetto accademico, fondato su principi ma-tematici e geometrici. Il classicismo dei tipi della Imprimerie Roya-le, che apparvero in una prima serie già nel 1702 ma furono termi-nati solo nel 1745 da J. Alexandre e L. Luce, non dipende tanto dal-la costruzione geometrica delle lettere, quanto dal taglio netto – che 20 Claude Garamond (1480?, 1499?-1561); Jacques de Sanlecque, Pierre Mo-reau (attivo ca. 1640), parigini. Robert Granjon, operoso nella seconda me-tà del Cinquecento fra Lione, Roma, Parigi, Anversa. Jean Jeannon, attivo anche a Parigi, produce nel 1621 un famoso specimen di caratteri. Lodewijk Elzevir (ca. 1540-1617) è il fondatore della dinastia tipografica, poi edito-riale, omonima (nota anche col nome francesizzato: Elsevier); Christopher van Dyck (1601-ca. 1672), disegnatore e incisore tedesco, lavorò ad Am-sterdam creando il carattere cui è rimasto il nome "Elzevir". 21 Philippe Grandjean de Fouchy (1664-1714) rinunziò alla carriera eccle-siastica per dedicarsi, a Parigi, all'attività di fonditore di caratteri e tipo-grafo; l'incarico di disegnare nuovi punzoni e caratteri fu affidato in realtà il 7 febbraio 1692; nel 1702 vedeva la luce Les médailles sur les principaux événements du règne de Louis le Grand, prima opera in cui fu impiegato il nuovo alfabeto. Alla sua morte, la vedova Marie-Madeleine Hynault con-tinuò l'attività per conto della Imprimerie Royale fino al 1725.
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
146
rivela l'incisione in rame –, dal deciso chiaroscuro e, in particolare, dall'impiego di "grazie" orizzontali e sottili: innovazioni che furono determinanti per il futuro disegno dei caratteri. Dai 'typi règi', re-stringendone le proporzioni e riducendo il risalto delle grazie die-tro l'esempio del 'goùt hollandois' (J. M. Fleischmann22), mosse l'ar-tista e teorico P. S. Fournier le Jeune per i suoi numerosi, apprezza-tissimi caratteri (Manuel typographique, 1764-1766). La tipografia in-glese, che nel secolo XVII è stata debitrice dell'Olanda, acquista nel XVIII importanza europea. Il merito va agli incisori di caratteri: a W. Caslon, il quale, come il Fournier, risente l'influenza degli olan-desi, ma ottiene risultati meno uniformi, grazie alla finissima tecni-ca d'incisione e all'accurata gradazione dei grossi e dei fini. Alla se-conda metà del secolo appartiene l'attività di J. Baskerville, al quale i tipi inglesi devono maggiore fermezza e plasticità nella pagina di equilibrio epigrafico, in accordo con il gusto dell'epoca (Virgilio, 1757)23. La tendenza verso il classicismo trovò conclusione, prima della fine del secolo XVIII, in Fr.-A. Didot, la maggiore personalità della fa-miglia di tipografi-editori parigini, e nel tipografo della Stamperia Palatina di Parma (1768), G. B. Bodoni24. Per entrambi il modello fu dapprima il Manuel del Fournier. Ma l'opera del Baskerville eserci-tò presto su di essi, e specialmente sul Bodoni (177I), un'influenza decisiva. Maestro nella composizione e nell'impaginazione, dotato di un finissimo senso del colore tipografico, il Bodoni mira all'effet-to chiaroscurale attraverso il contrasto dei grossi e dei fini e me-diante la fusione delle lettere – costruite con rigore geometrico – con il bianco della carta. La perfezione delle edizioni bodoniane dell'ultimo periodo, ottenuta – come dal Baskerville, ma con più a-stratta classicità – con i soli mezzi tipografici, fu oggetto di ammi-razione ai suoi tempi e ha conservato efficacia di modello (Manuale
tipografico, 1788 e 1818). Un diverso aspetto del classicismo è rap-
22 La definizione sembra essere sviluppata piuttosto da A. F. Johnson, «The Library», 1939, s. 4., XX (2), p. 180-196. 23 Pierre-Simon Fournier le Jeune (1712-1768), incisore, fonditore di carat-teri e tipografo a Parigi. William Caslon (1692–1766), primo di una stirpe di fonditori a Londra. John Baskerville (1706-1775), tipografo a Birmin-gham: l'opera qui menzionata è le Bucoliche. 24 F.-A. Didot (1730-1804) e G. B. Bodoni (1740-1813): universalmente noti.
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
147
presentato dalle numerose edizioni del Didot; il quale, pur muo-vendo dai medesimi modelli francesi e inglesi e svolgendosi secon-do una linea che presenta più di un'analogia con quella del Bodoni, giunge a risultati | [524] meno severi, di una maggiore "leggibilità". A sua volta il classicismo italiano e francese aveva riflessi in Inghil-terra, nei tipi di W. Martin per la Shakespeare Press di W Bulmer25, e in Spagna, nell'opera eccezionale, personalissima, di J. Ibarra y Marín26. In relazione con il Baskerville, il Didot, il Bodoni, l'Ibarra, è anche l'ultima attività tipografica di B. Franklin27. Un prodotto del neoclassicismo può riconoscersi, infine, nel "grottesco", dagli spessi tratti uniformi (1800-1803), dell'inglese R. Thorne28. L'ultimo de-cennio del secolo XVIII vide anche il rinnovarsi della Fraktur: J. G. I. Breitkopf ritornava ai modelli del Cinquecento, che interpretava con gusto tardo-barocco (1793 e 1798); mentre J. F. Unger, formatosi sullo stile francese e neoclassico, dava negli stessi anni (1793-1794) una Fraktur dal fluido, graduale chiaroscuro29. Il secolo XIX vide un ripetersi di tipi imitati dai modelli del Didot e del Bodoni, ed insieme l'effimera fortuna di caratteri romantici di fantasia. L'industrializzarsi della fonderia, i procedimenti meccani-ci della stampa (prima d'impressione 1811; e più tardi di composi-zione, 1884), l'impiego di nuove tecniche per l'illustrazione, che co-stituisce tuttavia il maggior pregio delle edizioni ottocentesche, la fabbricazione meccanica della carta, insieme con lo straordinario sviluppo dell'editoria, contribuivano intanto a trasformare sempre
25 Su cui v. ora: PETER ISAAC, William Bulmer: the Fine Printer in Context, 1757-1830, London, Bain & Williams, 1993, che sviluppa alcune conferen-ze presentate nel 1984 a Cambridge, per il ciclo delle «Sandars Lectures». 26 Joaquín Ibarra y Marín (1725-1785), tipografo madrileno, stampò, fra l'altro, Sallustio e Cervantes. 27 Benjamin Franklin (1706-1790), fratello di un tipografo e tipografo lui stesso, fu anche scienziato e uomo politico. 28 Robert Thorne, attivo fino al 1836 ca. 29 Johann Gottlob Immanuel Breitkopf (1719-1794), tipografo di Lipsia, fondatore di una casa editrice specializzatasi in pubblicazioni musicali. È curioso che nel 2003 Ralph M. Unger, disegnatore di caratteri nato nel 1953, ha creato una Fraktur che ha denominato Breitkopf-Unger perché uariatio del carattere Breitkopf... In ogni caso, qui ci si riferisce alla Fraktur disegnata da Johann Friedrich Unger (ca. 1800) e adottata nel campionario caratteri dell'editore Hermann Berthold.
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
148
più il libro in un prodotto dell'industria»30. Questa presentazione a volo d'uccello della tipografia fra tardo Sei-cento e primi dell'Ottocento ha un'impostazione nella quale, dice-vamo, ha peso presso che esclusivo l'analisi della forma scrittoria, cui aggiunge qualche dato di sintesi Palazzolo quando, gennaio 1998, qualche mese dopo il Settecento di Carosi, osserva: «[...] per il Settecento si stanno sviluppando gli studi sulle singole realtà re-gionali – ed il recentissimo volume di Renato Pasta sulla Toscana [Cioè: Editoria e cultura nel Settecento, Firenze, Olschki, 1997] ne è un'ulteriore conferma [...]»31. Chiarito all'interno di quale quadro di riferimento (ampio) dob-biamo considerare l'opera di Carosi sul Settecento viterbese, venia-mo ai particolari descrittivi. Essa si presenta dedicata, p. V, «A Sandro Vismara (1919-1987) e Vincenzo Frittelli (1912-1994) amici fraterni»32. Nella premessa (p. VII) l'A. ringrazia le autorità cittadi-ne, e in particolare Corrado Buzzi, già assessore alla cultura del Comune), che «a lungo e con tenacia ha operato presso la Giunta amministrativa di allora e di oggi perché fossero dati alle stampe tutti i volumi». Nella Introduzione, l'A. spiega che non si è limitato a coprire il Settecento, ma si è spinto fino al 1828, «perché i longevi Poggiarelli stamparono» sino a quella data, «stancamente condu-cendo la loro ormai superata officina, ostinati e fiduciosi fino alla morte di risollevarne le sorti per mezzo dell'adozione di giovani ti-pografi, ricchi per beni di famiglia e capaci quindi di acquistare nuovi caratteri e nuovi torchi». Si forniscono le principali date di riferimento e si ragiona della consistenza del materiale esaminato, circa 500 edizioni, la maggior parte delle quali (228) sono state pro-dotte dai De Giulij. Seguono le 162 dei Poggiarelli, le 71 di Domeni-co Antonio Zenti, le 25 di Benedetti e le 5 di Parentati. Per oltre la metà si tratta di pubblicazioni di poche pagine e di piccolo formato,
30 CASAMASSIMA, Tipografia cit., col. 511-527, in part. 523-524. Per il testo preparatorio, come ho già detto, v. infra, in Appendice. 31 PALAZZOLO, Esiste una questione meridionale dell'editoria? cit., p. 2. All'e-poca non era ancora uscita la ricchissima 2. ed. di MARCO SANTORO, Storia del libro italiano, Milano, Bibliografica, 2008 (1. ed.: ivi, 1994), che nei capi-toli 4.-5. sintetizza le vicende più significative, con corredo bibliografico. 32 Si tratta di due studiosi di cose viterbesi; ve ne è traccia nella stampa e nella biblioteca locale, su temi i più disparati.
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
149
interessanti solo Viterbo e quindi scarsamente vendute al di fuori della cerchia cittadina, dove sono state oggetto di forze in contrasto fra loro; consumo, ma anche collezionismo, e a ciò se ne deve la re-sidua sopravvivenza. Carosi abbozza la seguente percentuale di di-stribuzione per argomenti, identificando grosso more diciassette suddivisioni.
Esse però, a ben guardare, si riducono a due: ciò che è chiesastico (ed è pari al 60% del totale) e ciò che non lo è. Con le prime tre si arriva infatti a tale quota: 1. Agiografia, Sinodi, letteratura religiosa: 24%. 2. Pubblicazio-ni per eventi religiosi (monacazioni, panegirici, in onore di predicatori, ecc.): 21%. 3. Fogli volanti per monacazioni, nozze, etc.: 15%.
Il restante 40% è costituito da: 4. Drammi ed oratorî per musica: 7%. 5. Dissertazioni di laurea: 6%. 6. Avvisi e relazioni: 5%. 7. Calendari civili e religiosi: 4%. 8. Storia locale: 3%. 9. Agricoltura, veterinaria, attività arti-gianali: 2%. 10. Letteratura italiana settecentesca: 2%. 11. Stampe popolari profane: 2%. 12. Grammatiche: 2%. 13. Classici greco-latini: 2%. 14. Eventi naturali: 2%. 15. Stampe popolari religiose: 1%. 16. Commedie: 1%. 17. Cause civili: 1%. Si esita a definirlo compiutamente laico. Il lavoro di Carosi può essere fatto rientrare nella categoria degli an-nali tipografici, cioè delle opere che registrano le pubblicazioni in ordine cronologico, allegando anche i documenti relativi alle edizio-ni (pochi, nel caso nostro, ma non insignificanti), in modo che il let-tore abbia sott'occhio sia il prodotto tipografico, sia la documenta-zione degli atti che sono stati necessarî per arrivare a produrlo. Pre-suppone, dunque, una duplice ricerca, in biblioteche (nel nostro caso 16 fra Viterbo, Roma, Firenze e Londra) e in archivî (3, tutti a Viter-bo: per l'analisi particolareggiata, v. infra, Appendice). A fianco dei li-bri s'individuano documenti quali patenti (cfr. il n° 1 di p. 337), li-cenze (n° 4 di p. 338), atti matrimoniali, rilevanti per gl'impegni pa-trimoniali che ne derivano (n° 8 di p. 341-342), o documenti d'inte-resse più specifico, come l'inventario della tipografia e del magazzi-no di de' Giulij, documento n° 13 di p. 350-362, etc. L'ordinamento cronologico è sviluppato all'interno di ogni singola azienda tipogra-fica, mentre il prospetto delle edizioni (p. 331-334) allinea in sinossi anni, aziende ed edizioni (ad es.: nel 1701, 1 di De Giulij e 1 di Mar-tinelli; nel 1702, 7 di De Giulij e 1 di Martinelli; nel 1703 29 di De Giu-lij e nessun'altra, e così via).
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
150
Che rapporto c'è fra il lavoro di Carosi e quello di altri studiosi che si sono posti l'obiettivo di esplorare e censire la produzione tipo-grafica locale, in altri lembi dello Stato pontificio? Alludo a Vispi per Gubbio (1974), Tammaro Conti per Orvieto (1977), Giochi e Mordenti (1980) per Ancona (per le analisi v. infra, Appendice, n° 3, 4, 5). Dal Governatorato di Viterbo, alla Marca di Ancona, al Go-vernatorato di Orvieto, allo Stato di Urbino e Pesaro, che sono le aree di insistenza, possono emergere osservazioni su marginalità e centralità produttive, che non necessariamente, ma di fatto, si pos-sono trasformare talvolta in marginalità di linguaggio. Dal punto di vista patrimoniale, le caratteristiche produttive rappresentano la stessa, o analoga, distribuzione di temi documentata a Viterbo. Più interessante è esaminarne la tecnica descrittiva: ricordo che l'Isbd(A), 1979, ha impiegato circa un decennio per imporsi nella prassi italiana, non senza discussioni, per lo più di retroguardia. Ricordo altresì che The Crisis in Cataloging, che introduce il princi-pio della descrizione interpretativa, è del 194133. Vispi usa un modello di descrizione che prevede la trascrizione in facsimile del frontespizio, con analisi semplice della pubblicazione: ecco qui l'esempio della n° 27, relativa ad edizione del 1761 (p. 22): VITA | DEL GLORIOSO | S. UBALDO | VESCOVO, E PRIMO PROTETTORE | DELLA
CITTÀ DI GUBBIO | E Canonico Regolare | Scritta dal B. Teobaldo di lui Suc-cessore | a Federico Primo Imperatore | Dal latino nell'italiano idioma tradotta | DA GIAN FRANCESCO MANARESI | Accresciuta di altre cose, al-l'Imperatore dal B. | non scritte; e di osservazioni ad altre fattesi | da Au-tore moderno della Vita del | Santo Stampata in Loreto. | [un fregio] IN
GUBBIO MDCCLXI | [una linea] Nella Stamperia di Giuseppe Bartolini. | Con
Lic. de' Superiori. |
33 Si fa riferimento allo scritto di Andrew Delbridge Osborn (1902-1997), comparso in «The Library Quarterly», 11., 1941, n° 4, October, p. 393-411. Per le discussioni in prima applicazione della Isbd(A), v. MARIELISA ROSSI, Isbd(A) o descrizione diplomatica. Una questione attuale sul libro antico, «Bi-blioteche oggi», 1., 1983, n° 1, Novembre-Dicembre, p. 47-53. L'A. è poi tornata sull'argomento in forma sistematica con Il libro antico dal 15. al 19. secolo. Analisi e applicazione della seconda edizione dell'ISBD(A), presentazio-ne di Giovanni Solimine, Firenze, Olschki, 1994 (Biblioteconomia e biblio-grafia. 27), poi in 2. ed.: 1999.
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
151
190 x 130 rom. *2 A2V2. pp. VIII, 160. testo corpo 10.
A c. *2 dedica al Marchese Filippo Biscaccianti. Nell'antiporta vi è una ri-produzione calcografica di S. Ubaldo con la dicitura: «S. Ubaldus Episco-pus Eugubinus». Gubbio, Bibl. Sper. [= Sperelliana] Tammaro Conti usa un modello molto semplice di descrizione di-scorsiva sommaria, ispirata alle regole di catalogazione del 1956, incrociate con criterî di bibliografia citazionale: la intestazione in tutte maiuscole; il titolo in corsivo; gli estremi delle note tipografi-che e la collazione in tondo. È allegata la collocazione della biblio-teca dove è stato visto l'esemplare, del quale si danno le dimensioni (hxb). Dò qui l'esempio della descrizione n° 229, relativa a pubbli-cazione del 1783 (p. 51): 229. LAUDES in festo Corporis Christi continuo alternatim recitandae, dum SS.
Sacramentum cum Sanctiss. Corporali e Cathedrali Ecclesia Sanctae Mariae so-
lemni processionali ritu circumfertur per Civitatem Urbevetanam donec ad eam-
dem Ecclesiam reditur. Urbeveteri, MDCCLXXXIII, Per Josephum Perfetti Typ. Cam. Episcop. et Pub. 23 x 17, pp. 16 - B.C.O. Giochi-Mordenti usano un modello più analitico, sempre fondato sulla trascrizione diplomatica del frontespizio, del quale dò un e-sempio settecentesco, relativo al 1781, la scheda n° 708 di p. 323: 1781 [BONAVIA BERTRANDO] LA FORTUNA RESA SEGUACE / DEL MERITO / CANTATA A QUATTRO VOCI / PER
LA PROMOZIONE ALLA SAGRA PORPORA / DELL'EMO [trattino lungo sopra-scritto alla «M»] E RMO [trattino lungo soprascritto alla «M»] SIG. CAR-
DINALE / GIANNOTTAVIO / MANCINFORTE / FATTA RAPPRESENTARE / FRA LE
ALTRE DIMOSTRAZIONI DI GIUBILO / DALLA COMMUNITÀ DI ANCONA / DI LUI
OSSEQUIOSISSIMA PATRIA / Nell'occasione di collocarsi stabilmente con Ap-plauso Universale / nella Sala del Pubblico Palazzo di detta Città / entro Elegante Marmoreo Contorno / L'ACCLAMATA EFFIGIE / DI COSÌ GLORIOSO / CONCITTADINO. / IN ANCONA MDCCLXXXI / PRESSO GLI EREDI DELLA STAMPE-
RIA BELLELLI / CON PERMISSIONE.
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
152
pp. XXII. Front. a doppia inchiostratura nera e rossa, frontoni, iniz. fig., fregi decorativi, final. Cm. 27 x 18. Copie Osimo BCom.; Castelfidardo Archivio Ferretti di Cf.; Camerano BMan-
cinforteS. (Esemplare con il titolo ad intera inchiostratura rossa); Ancona Archivio di Stato AC An; Pesaro BOliv. Bibl. ALBERTINI, Storia, Lib. 13, p. II, c. 107. La musica è di G. Borghi maestro di Cappella della Basilica Lauretana. Il canone descrittivo impiegato da Carosi è vicino alla tradizione italiana (alla Audiffredi), appena rinfrescata con un'occhiata alle regole del 1956, piuttosto che alle successive evoluzioni della tecni-ca descrittiva, internazionale o anche solo nazionale. I modelli pro-posti da Barberi o da Rhodes, ovviamente da lui conosciuti, sono però sostanzialmente pretermessi. Ecco l'esempio di una sua de-scrizione, relativa ad unità del 1781 (scheda n° 350, p. 248): PER LA SAGGIA –––––––––– elezione che l'Università de' Mercanti, unita alle Magnifiche Quattro Arti della Città di Viterbo, ha fatta del suo Gran Protettore nella degna Persona dell'Eminentissimo Principe il Signor Cardinale Lazzaro Opizio Pallavicini, Segretario di Stato Sonetti [fregio] ln Viterbo, MDCCLXXXI, per Domenico Antonio Zenti, con Licenza de' Su-periori. foglio volante cm 29 x 42 B.Ca.V. [= Bibl. Capitolare di Viterbo], foglio di guardia del codice 167. Quando si fa riferimento ad opere non viste, si ricalca (avverte l'A.) il modulo descrittivo della fonte, come avviene, ad es., per il n° 326, che ad essa si limita. In conclusione, Carosi fa sì un quadro della stampa viterbese che, pubblicato dopo circa trent'anni dallo scavo di Rhodes (1963), pre-senta impinguato il panorama di consistenza: in Rhodes (che arriva
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
153
al 1800) le edizioni del Settecento occupano dal n° 405 al 545 inclu-so, per un totale di 141, mentre le edizioni qui sono, come si è detto, 491, e corredate di documenti, a fronte della evidenza solo biblio-grafica in Rhodes. Continua, per altro, a rimanere in vita – dal pun-to di vista metodologico del linguaggio descrittivo – una evidente arretratezza, che accentua morfologicamente le differenze fra l'uno e l'altro, ma ribadisce nello stesso tempo la complementarità che da sùbito Rhodes ammetteva, in un'ampia quanto allusiva narrazione dei suoi rapporti col bibliotecario viterbese:
«Questo volume si propone di descrivere dettagliatamente tutti i volu-mi stampati o pubblicati a Viterbo dal "1488" al 1800 che sono stato capace di rintracciare. (Spiegherò nell'introduzione perché ho messo tra virgolet-te la prima di queste due date). Non è una bibliografia per soggetto; non comprende perciò opere su Viterbo che siano state stampate altrove; è e-sclusivamente un catalogo di ciò che è stato stampato e pubblicato in quella città.
Sulla storia di Viterbo sono stati pubblicati almeno tre libri, due dei quali non fanno alcuna menzıone della stampa locale: FELICIANO BUSSI, Istoria della città di Viterbo, Roma, 1742, volume in folio di circa 500 pagine, e CESARE PINZI, Storia della città di Viterbo, in quattro volumi (Roma, 1887 e 1889, e Viterbo, 1899 e 1913 [La Storia del Pinzi poi si chiude all'anno 1534, e cosi non avrebbe potuto parlare che dell'unico incunabolo viterbese.]). Il terzo comunque si è compiaciuto di certi preziosi dettagli che ho voluto includere al loro giusto posto in questa bibliografia. Si tratta del volume di GAETANO CORETINI, Brevi notizie della città di Viterbo, e degli uomini illu-
stri dalla medesima prodotti, Roma, 1774. Il fatto che questo libro sia stato scritto da un Inglese residente a Londra
anziché da un Italiano residente in Italia ha avuto senza dubbio un effetto (che spero vivamente non disastroso) sul risultato. Il periodo limitato di tempo che ho potuto trascorrere in Italia ha inevitabilmente fatto sì che la mia bibliografia non avesse alcuna pretesa di essere completa; tuttavia mi consola pensare che nessuna bibliografia può mai essere completa. Molto del materiale proviene dal | [p. 8] British Museum e una piccola parte dal Warburg Institute di Londra; diversi libri ho potuto trovare nella Bibliote-ca Universitaria e in quella del Trinity College a Cambridge; altri ancora nella Biblioteca Bodleiana di Oxford; e molti volumi apparentemente uni-ci nella Biblioteca Nazionale di Parigi. Inoltre ho lavorato nell'ottobre del 1958 a Milano, Bologna e Firenze e ciascuna di queste città ha arricchito la mia lista di nuovi indizi se non di nuove edizioni. Nel giugno 1959 mi fu regalato dalla gentile Dr.ssa Laura Dentini, Direttrice della Biblioteca Co-
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
154
munale degli Ardenti di Viterbo, una copia del catalogo della Mostra Sto-rica del Libro Viterbese (compilato a cura del Dr. Attilio Carosi), che era stato pubblicato come guida alla Mostra allestita nel 1957 nel Palazzo dei Priori a Viterbo. Il mio lavoro era già molto avanti allorché venni a cono-scenza dell'esistenza sia del Catalogo che della Mostra, ma mi è stato d'immenso aiuto ed il mio riferimento ad esso è in questo volume: MSLV.
Il catalogo contiene 428 numeri ma non tutti di interesse per il mio stu-dio poiché circa ventuno degli esemplari presenti alla mostra erano ma-noscritti, diciassette stampati a Roma, circa sedici a Ronciglione, diciotto a Montefiascone, parecchi a Orvieto, Perugia, Siena, Milano e altrove. Dei rimanenti più di metà erano stati stampati dopo il 1800 e non possono es-sere inclusi in questo volume.
Naturalmente il British Museum e altre biblioteche dove ho lavorato possiedono molti esemplari che non erano presenti alla Mostra di Viterbo nel 1957, nondimeno il catalogo mi ha fornito parecchi titoli che mi sareb-bero altrimenti mancati: si trattava per la maggior parte di volumi prove-nienti da collezioni private.
Devo la mia gratitudine ai molti amici e colleghi delle diverse bibliote-che, specialmente di Roma e Viterbo dove non ebbi l'opportunità di lavo-rare fino al settembre 1959. Un ringraziamento particolare va ai miei amici Dr. Enrichetta Valenziani e Dr. Emidio Cerulli della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma che mi hanno assistito dando prova di u-n'infinita pazienza; il Dr. Lamberto Donati della Biblioteca Vaticana per il gentilissimo aiuto; la Dr. Laura Dentini, il Dr. Augusto Pepponi e il Dr. Giustino Frare di Viterbo i quali tutti oltre ad essermi stati amici e ad a-vermi incoraggiato, mi hanno offerto la loro attiva collaborazione. In In-ghilterra desidero ringraziare il mio amico e collega Sig. Patrick J. Fairs della Biblioteca | [p. 9] del British Museum per la sua erudita assistenza nel risolvere un problema particolarmente difficile e che interpellai per la sua speciale conoscenza della bibliografia slava.
Appare infine necessaria una parola di spiegazione sulle circostanze che hanno portato alla realizzazione finale del mio libro. Questo infatti era già ad un buon punto di preparazione quando arrivai per la prima volta a Viterbo nel settembre 1959 e venni a conoscenza che il Dr. Attilio Carosi, Direttore della Biblioteca Provinciale A. Anselmi di Viterbo, stava prepa-rando, su basi diverse, un suo lavoro sulla stampa a Viterbo. Dopo molto discutere fu deciso che ciascuno di noi sarebbe andato avanti nel proprio lavoro indipendentemente e che vi sarebbero state così due pubblicazioni su uno stesso soggetto piuttosto che una pubblicazione unica. Egli ha la-vorato estesamente su documenti d'archivio ed ha anche messo insieme una notevole collezione sua propria di libri stampati in Viterbo attraverso i tempi (collezione che mi ha sempre permesso gentilmente di consultare).
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
155
Il mio lavoro è d'altronde basato esclusivamente su libri che ho veduto io e non su di un'evidenza documentaria. La mia pubblicazione apparirà quindi giustificata anche se solo in base al fatto che io ho veduto molti li-bri in Inghilterra, Francia e nell'Italia del Nord che il Dr. Carosi non ha vi-sto e che probabilmente non vedrà. I due libri pubblicati devono perciò considerarsi l'uno complementare dell'altro perché sarà inevitabile il fatto che ciascuno conterrà in molti punti dettagli che nell'altro mancheranno. È da sperare comunque che entrambi contribuiranno largamente a dare un quadro completo dell'argomento trattato. A questo punto aggiungerò che il bel volume del Dr. Carosi, Girolamo Pietro e Agostino Discepoli, 1603-1631 (Estratto dalla Miscellanea di Studi Viterbesi della Biblioteca Provinciale «A. Anselmi» di Viterbo) vide la luce nel mese di marzo 1962 quando questo mio era già in tipografia.
Chiedo ai lettori italiani di avere indulgenza per i miei difetti ed omis-sioni che vorrei scusare facendo presente quanto difficile sia per un uomo eseguire qualcosa che cerchi di essere un catalogo esauriente allorché ha preso la determinazione di studiare nei particolari la bibliografia di un paese diverso dal suo proprio dove ragioni economiche lo costringono a risiedere. So bene, per esempio, che devono esistere molti Bandi stampati che non si trovano in questa bibliografia. Ho | [p. 10] veduto con i miei occhi certe enormi pile polverose di Filze o buste in sotterranei dove se ne restano ammucchiati a centinaia; ma non basterebbe la vita di un uomo trascorsa interamente in Italia a spolverarli e a collocarli per non dire a ca-talogarli34. Questo lavoro dovrebbe perciò venir considerato semplicemen- 34 Scontando un qualche gusto per il colore locale, è un fatto che fra le non pochissime tesi che mi sono trovato a guidare a Viterbo (su cui v., ormai da aggiornare: TIZIANA CALVITTI, MANUELA GRILLO, Storia, teoria e tecniche della catalogazione nella Università della Tuscia-Viterbo fra il 1992 e il 2005: una rasse-gna, «Culture del testo e del documento», 7., 2006, n° 19, Gennaio-Aprile, p. 47-80), un certo numero hanno avuto a che fare con situazioni di inesplorata o solo parzialmente esplorata catalogazione entro la Biblioteca degli Arden-ti, e precisamente: 1 su bandi, sia mss sia a stampa 1570-1589 (Sonia Proietti, a. a. 1993/1994); 4 su edizioni del Cinquecento: Claudia Fioravanti, 1994/1995; Marco Arcangeletti, 1996/1997; Stefania Gatti, 1996/1997. Elisa-betta Zonno, 1999/2000; 5 su edizioni del Seicento: Emanuela Puccilli, 1998/1999; Stefania Chielli, 2000/2001; Valeria Lorenzetti, 2000/2001, Alessia Ricci, 2001/2002; Maria Banaudi, 2004/2005. Questi lavori documentano che, quanto alla produzione dei secoli 16. e 17., si depositano nelle raccolte della comunale le stesse percentuali di filoni linguistici e di cultura, nonché di mercato editoriale, che si riscontrano altrove nella penisola. Col che sareb-bero praticamente esaurite le evidenze, e il materiale sarebbe pronto per la revisione definitiva e l'inserimento a bonifica di catalogo: cosa che però non ha destato, né allora né in séguito, interesse presso le autorità comunali in-
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
156
te come la pietra di fondamento sulla quale possa esser costruita un gior-no la storia completa della stampa a Viterbo»35.
Se è normale a) che la vicenda degli studî sia cosmopolita, b) che quando essa s'incentra su piccole porzioni di territorio, le guardi con punto di vista generale, c) che i conseguimenti di ciascuno stu-dioso siano gradino a chi verrà; allora è normale conseguenza di tutto ciò anche l'isomorfia poligenetica, per cui le stesse idee talvol-ta vengono a più d'uno in luoghi diversi, ma con possibilità diverse di sviluppo. Suona dunque a merito di Carosi il pieno riconosci-mento che gli venne, con notevole fair play, da chi, oltre ad essere un grande incunabulista a tutto tondo, rimane anche il più grande studioso di storia della tipografia viterbese.
APPENDICE
Ho collocato in Appendice, per non appesantire la trattazione, le analisi strutturali di alcune opere utilizzate nel testo, e cioè oltre al Settecento del Carosi, n° 1, anche i lavori di 2. Casamassima. 3. Hart. 4. Vispi. 5. Tamma-ro Conti. 6. Giochi-Mordenti. 7. Rhodes.
1. Il Settecento di Carosi, cit. Non ostante la pubblicazione in sede peri-
ferica, l'opera ha conosciuto una circolazione non minima; alla ultima consultazione utile, infatti (3 Aprile 2010), prima del licenziamento di queste pagine, essa resultava posseduta, in Italia, da biblioteche di Ac-quapendente, Civita Castellana, Jesi, Mantova, Milano, Modena, Orvieto, Pavia, Rimini, Roma, Soriano nel Cimino, Valentano, Venezia, Viterbo. Fuori d'Italia: BVB-Verbundkatalog, SWB-Südwestdeutscher Bibliothe-ksverbund, Copac, Washington (LC).
digene, da cui la biblioteca dipende. Sono rimasti non pubblici anche i due lavori sulla produzione tipo-editoriale per lo più in età contemporanea di SILVIO CAPPELLI, Saggio di bibliografia viterbese. Catalogo di una collezione, a. a. 1994/1995; Catalogazione e clessificazione di pubblicazioni d'interesse viterbese, a. a. 2002/2003. Grazie all'egregio lavoro delle bibliotecarie che si sono avvi-cendate nel tempo alla biblioteca di Conservazione dei beni culturali (in primis Maria Grazia Franceschini e Livia Saldicco), le queste tesi sono, ben descritte e ben indicizzate, a disposizione del pubblico, col solo vincolo del-le norme vigenti in materia. 35 RHODES, La stampa a Viterbo«1488»-1800 cit., p. 7-10.
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
157
Struttura dell'opera: [I.] Introduzione, p. IX-XIII. [II.] Siglario, p. XV; spie-ga con quali sigle vengono citati le istituzioni di conservazione, che sono: Firenze: Marucelliana, Nazionale centrale. Londra: British Museum Li-brary. Napoli: Nazionale Vittorio Emanuele 3. Orvieto: Comunale. Roma: Accademia dei Lincei, fondo Corsini; Alessandrina; Angelica; Besso, Fon-do Goretti; Casanatense, Nazionale centrale, Vallicelliana. Viterbo, archi-vî: Storico del Comune presso la Biblioteca Comunale degli Ardenti; di Stato; della Curia Vescovile. Biblioteche: Capitolare presso la Cattedrale di S Lorenzo; Comunale degli Ardenti; Provinciale «A. Anselmi»; Raccolta A. Carosi, Viterbo. Le edizioni segnate con l'asterisco non sono state viste, e molte delle opere essendo state reperite negli inventarî delle pubbliche biblioteche nei primi anni Cinquanta, alcune segnature, si avverte, posso-no non corrispondere alle moderne. [III.] [Cenni storici] relativi a: Giulio De Giulij ed eredi, p. 1-14; Michele Benedetti, p. 15-17; Famiglia Poggiarel-li, p. 19-26; Domenico Antonio Zenti, p. 27-31; Gli ultimi tipografi del Set-tecento, p. 32-34; Viterbo, falso luogo di stampa, p. 35-44. [IV.] Annali delle edizioni, p. 45-330. Le edizioni registrate, in numero di 491, coprono il pe-riodo 1700-1828. [V.] Prospetto cronologico delle edizioni, p. 331-334. [VI.] Documenti, p. 335-435. Sono cinque raggruppamenti, per un totale di 85 documenti esaminati, relativi a De Giulij ed eredi (37 documenti). Bene-detti (16 documenti). Poggiarelli (16 documenti). Zenti (5 documenti). Pa-squale e Arcadio Parentati, Giuseppe Mezzetti, Luigi Polidori e Francesco Orioli, Giuseppe Matthey e Tranquillino Zeppi, Giuseppe Matthey e Ca-millo Tosoni, Bartolomeo Poggiarelli e Rocco Monarchi (11 documenti). [VII.] Bibliografia, p. 436-437; registra 17 voci, redatte con criterî soggettivi, come si vede dalla loro forma: LEONE ALLACCI, Drammaturgia... accresciuta
e continuata fino all'anno MDCCLV, (Venezia, 1755). Arcadi (Gli) dal 1690 al
1800, Onomasticon, a c. di Anna Maria Giorgetti Vichi (Roma, 1977). CESA-
RE BRUSCAGLI, Cronaca dei teatri di Viterbo (1805-1903) - voll. 8 - manoscritto integrato da fogli a stampa - Comunale di Viterbo: II.F.V.22-29. A. CAROSI, Il calendario di Viterbo 1956, a c. di Augusto Egidi e A. C. (Viterbo, Edizioni Agnesotti, 1956). ID., i n° 1, 2 e 3 degli «Annali della tipografia Viterbese», III) FRANCESCO M. D'ORAZI, L'arte della stampa in Ronciglione nei secoli XVII
e XVIII - Catalogo descrittivo della Mostra (Ronciglione, Centro ricerche e studi, 1991). SAVERIO FRANCHI, Drammaturgia romana. Repertorio bibliografi-
co cronologico dei testi drammatici pubblicati a Roma e nel Lazio - vol I (secolo XVII) (Roma 1988). vol II. (1701-1750), con introduzione sui teatri romani nel Settecento e commento storico-critico sull'attività teatrale e musicale 1701-1730; in collaborazione con Orietta Sartori. (Roma, 1997). [11.] ID., Le
impressioni sceniche. Dizionario bio-bibliografico degli editori e stampatori ro-
mani e laziali di testi drammatici e libretti per musica dal 1579 al 1800; in col-lab. con O. Sartori (Roma, 1994). [12.] Mostra storica del libro viterbese. Cata-
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
158
logo e cenni storici a c. di A. Carosi (Viterbo, 1957). BEATRICE PREMOLI, Spettacolo d'attori e cantastorie. Edizioni viterbesi del Seicento tra letteratura e
tradizione popolare nella Biblioteca della Fondazione (Roma, Collana della Fondazione Besso, XIV, 1996). D. E. RHODES, La stampa a Viterbo, "1488"-
1800, Catalogo descrittivo (Firenze, 1963). CLAUDIO SARTORI, I libretti italiani
a stampa dalle origini al 1800. Catalogo analitico con 16 indici (Cuneo, 1900-1997). CARLOS SOMMERVOGEL, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus (Bruxel-les-Toulouse, 1890-1930). Stamperie, carte e cartiere nella Ronciglione del XVII
e XVIII secolo. Atti della Giornata di Studio, 26 ottobre 1991, a c. di F. M. D'Orazi (Ronciglione, Centro Ricerche e Studi, 1996). [VIII.] Indice dei no-mi e delle cose notevoli, p. 439-480. [IX.] Indice, p. 481.
2. E. CASAMASSIMA, abbozzo della voce Tipografia, per Enciclopedia univer-
sale dell'arte (v. supra, nota 15). Contenuto in una lettera a F. Barberi, datata Firenze, 9 marzo 1960, consultata e riprodotta nella biblioteca dell'Aib (Ro-ma) nel marzo 1993; 3 c. num. per p., cm 28,5x19, mss, in inchiostro. Nella trascrizione si sono rispettati gli "a capo", indicandoli col segno "|"; sono omessi i preliminari non inerenti l'argomento, come anche in fine lettera, incluse le clausole di cortesia: «[...] Ho ricevuto anche la lettera dell'Istituto per l'Enc. dell'arte e il contratto. Dunque, mi sono assegnate 12 cartelle. Credo che siano sufficienti. Immagino invece che Lei debba incontrare qualche difficoltà di spazio per la sua voce, che è molto più complessa e va-ria di accenti36. Se lo ritiene necessario, potrei cederLe 1 cartella. Mi dica Lei... | Ho già raccolto il materiale per la stesura della voce e ho già tracciato uno schema piuttosto ampio. Mi trovo un po' a disagio per il numero assai ridotto di illustrazioni 4 tavole – ricorda? – ossia 8 illustrazioni. Con 14 illu-strazioni, ossia 7 tavole la voce Tipografia acquisterebbe in chiarezza ed || [p. 2] anche in utilità: il testo stesso, orientato sulle illustrazioni sarebbe più preciso e rilevato. Con 14 illustrazioni potrei illustrare quasi tutti i tipi più importanti: 1) textus quadratus 2) semigotica o gotico-antiqua 3) rotunda 4) bastarda (bâtarde oppure schwabacher) 5) antiqua primitiva 6) antiqua per-fezionata 7) cancelleresca (Aldo [ovviamente Manuzio]) 8) Fraktur 9) una Elzevier 10) un Caslon o Baskerville o Fournier o Didot 11) una Breitkopf o Unger 12) Bodoni [ovviamente Giambattista] 13) un tipo della rinascita morrisiana37 14) un tipo più recente [soprascritto a «attuale»] (espressioni-sta?). Penso di utilizzare le illustrazioni sotto diversi aspetti: non soltanto
36 Si tratta di F. BARBERI, Grafica e arte del libro, estr. da: Enciclopedia univer-sale dell'arte, v. 6, Venezia-Roma, Istituto per la collaborazione culturale, [s. a.], p. 510-511, 526-539. 37 Riferimento a William Morris (1834-1896), fondatore della Kelmscott Press nel 1891.
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
159
riguardo ai tipi, ma anche per l'impiego di capitali, letterine, etc.; sceglierò pagine di incipit; per i tipi più tardi potrò utilizzare frontespizi, illustrando così un altro aspetto dell'estetica tipografica. Crede che sia molto difficile ottenere altre 3 tavole? Ho rinunciato naturalmente ad illustrare i tipi greci ed orientali. Cosa può significare, nella ricca evoluzione della tipografia greca, una sola illustrazione? Per quanto riguarda la stesura della voce, Lei già sa che ad una trattazione [soprascritto a: «un compendio»] analitico-sistematica preferisco uno svolgimento cronologico e secondariamente geo-grafico, ossia propriamente storico. Cercherò di fondere insieme, nei limiti del possibile la trattazione dell'evoluzione dei caratteri e della estetica della pagina, del frontespizio, etc. Muovo dal sistema grafico del tardo Medioevo Umanesimo, che si contrappongono l'un l'altro e coesistono, ed accenno al-l'origine come Ersatz del libro "di forma" rispetto al libro "di penna": quindi imitazione delle "litterae" e conseguentemente del formato, impaginazione, colonne, incipit, explicit, commenti, etc., tutti elementi dipendenti dalla || [p. 3] "littera", che a sua volta è legata alla natura del testo. Ecco il riflesso dei due sistemi grafici nel libro a stampa: | 1) textura o meglio textus qua-dratus (libri liturgici, Bibbie, etc.) (v. fig. 1) | 2) semigotica o gotico-antiqua (preferisco col Cencetti38 il primo termine) (testi di natura varia, anche clas-sici) (v. fig. 2) | 3) rotunda (testi scientifici, filosofici, giuridici, etc.) (v. fig. 3) | 4) Bastarda (testi in lingua nazionale) (v. fig. 4) problema della bastarda in Italia: vedremo in séguito quale "littera" potremo designare con questo ter-mine. | 5) Intanto (tenterò di mettere d'accordo la trattazione per tipi con la cronologia) Antiqua primitiva (testi di autori classici, testi di umanisti) (v. fig. 5) | 6) Antiqua perfezionata (v. fig. 6). Tra l'una e l'altra antiqua corre la trattazione delle restaurate capitali lapidarie (fino al Merille e al Paciolo39) Per la illustrazione delle capitali, v. la stessa fig. 6). | 7) Cancelleresca (v. fig. 7). Qui cade in acconcio l'accenno ai maestri di calligrafia (Grifo, Vicentino, etc.). Sua diffusione, imitazione, elaborazione successiva (Cresci40), anche in Francia (Garamond, etc.). Si può definirla, accettando la terminologia del tempo, come la bastarda italiana. | 8) Fraktur (v. fig. 8), sostituisce grada-tamente le altre bastarde tedesche. | Si conclude a questo punto il I periodo: il libro ha raggiunto il suo aspetto compiuto (Frontespizio, etc.); è il vero "li-
38 Giorgio Cencetti (1908-1970), paleografo. 39 Se il riferimento è a Edmond Merille (ma non sono sicuro della lezione), egli visse fra il 1579 e il 1647; Luca Pacioli (ca. 1445-post 1514), matematico e disegnatore. 40 Francesco Griffo (ca. 1450-ca. 1518): tipografo e disegnatore di caratteri, per altri (per Manuzio disegnò il corsivo) e in proprio; Ludovico degli Ar-righi detto il Vicentino (1475-1527), amanuense e disegnatore di caratteri. Giovanni Francesco Cresci, calligrafo milanese del sec. 16.
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
160
bro". Le || [p. 4] posizioni sono rovesciate. I futuri manoscritti, rari, imite-ranno il libro a stampa. Nella parte seguente, senza interruzione, è trattato il lungo periodo che va dalla metà circa del '500 alla fine dell'800. Elaborazioni successive dell'antiqua e della cancelleresca (Garamond, Granjon, Plantin41), fino agli Elzevir (v. fig. 9), Van Dyck. Cenno al libro del '600, epoca in cui l'estetica tipografica cede a quella decorativa e illustrativa. Ed ecco con il '700 il ritorno ai tipi classici in Inghilterra (Caslon, Baskerville, v. fig. 10) in Francia (Fournier e poi Didot), in Spagna, in Italia (Bodoni, v. fig. 10). Paral-lela rinascita della Fraktur, molto deterioratasi nel '600 (da Breitkopf a Un-ger, v. fig. 11). Ritorno ad una estetica propriamente tipografica, o almeno all'equilibrio fra questa e l'illustrazione. '800. L'industrialismo nella tipogra-fia; accenno ai pochi tipi dignitosi inglesi e francesi. La terza parte tratta del-la rinascita che ha nome da William Morris e che è legata non soltanto ad una restaurazione dei tipi rinascimentali ma ad una nuova valorizzazione della "littera" manoscritta come modello (rinascita anche della calligrafia) (v. fig. 13). Carattere intellettualistico di questa rinascita, rispetto a quella del '700; sua relativa vitalità artistica, ma utilissima reazione all'industriali-smo. Stamperie private. La rinascita in Francia, Germania, Stati Uniti (cen-ni), Italia. La situazione attuale dopo i tentativi, più decorativi che tipografi-ci, dell'espressionismo tedesco (fig. 14). Per i brevi cenni all'evoluzione dei tipi greci mi sarà molto utile il bel catalogo dello Scholderer, che possiedo42. Per la tipografia || [p. 5] orientale darò notizie sommarie. | Perdoni la con-fusa esposizione: ma Lei sa leggere tra le righe. Come vede le figure hanno una funzione, più che illustrativa, organica, di ordinamento, di cardini. Po-trei avere, prego, altre 3 tavole? | Le sono molto grato di avere pensato a me per la compilazione della voce Tipografia; è per me un vero onore, lo dico senza paura ma non so trovare altra parola, collaborare, con Lei, all'Enc. dell'Arte. La prego di farmi tutte le osservazioni che crede, ed anche di darmi qualche suggerimento, circa l'abbozzo di schema che ho tracciato. [...] | P.S. Non credo che sia necessario sollecitare il dott. De Marinis43, poiché avrà ricevuto anche lui la lettera e il contratto della Enc. che parlano molto chiaro, purtroppo, del 31 marzo come termine di consegna del manoscritto [poscritto scritto verticalmente, sul mg. sn. di p. 5]».
41 Christophe Plantin (1520-1589), operoso ad Anversa. 42 Greek Printing Types 1465-1927. Facsimiles from an Exhibition of Books Illus-trating the Development of Greek Printing Shown in the British Museum 1927, with an Historical Introduction, London, By order of the Trustees, 1927. 43 Tammaro De Marinis (1878-1969), storico del libro, bibliografo, bibliofi-lo; la miscellanea per i suoi 85 anni (Studi di bibliografia e di storia in onore di T. D. M., v. 4, Verona, Stamperia Valdonega, 1964) è uno dei non numero-sissimi titoli importanti nella Bibliografia italiana del Novecento.
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
161
3. HORACE HART, Notes on a Century of Typography at the University Press,
1693-1794, Oxford, Clarendon, Press, 1970: reprint dell'ed. 1900. [I.] Abbre-
viations, p. XI*. Contiene l'elenco delle abbreviazioni usate sia per i luoghi di conservazione, sia per la bibliografia a stampa. [II.] Introduction, p. 1*-16*. [III.] The Facsimile. Hart's Century of Typography, etc., photographically repro-
duced, with his revisions in the form of supplementary leaves and with the addition
of three pages omitted from the Specimen of 1693, p. I-XVI, 1-172. Il contenuto è specificato a p. V: [1.] Prefatory Notes, p. vii-xvi. [2.] Summary of the 'Make-up',
Contents, &c., of the Eight Specimens, p. 1. [3.] List of Founts, &c., mentioned and
Exemplified, p. 3-4. [4.] The Eight University Press Specimens, p. 5; The 1693 Specimen. The 1695 Specimens. [5.] A Page of Arrangements of Fell Orna-ments. [6.] Appendice I. [7.] Appendice II. [8.] Appendice III,. [IV.] Notes and
appendixes added to this reprint, p. [173]-[194]. [1.] Additional notes, p. 175-193. [2.] Appendix to Appendix III, part II: Extracts from letters from Thomas Marshall
to Samuel Clarke of 1668, p. [194]. [V.] List of recipients of the 150 copies printed
of the original edition, p. [195]-198. Fra il giugno 1900 e il gennaio 1903 le cen-tocinquanta copie furono spedite ai loro destinatarî, nell'ordine e secondo le quantità specificate (in un elenco autografo di John De La Mare, tipografo dell'Università. [VI.] Index, p. [199-203].
3. MARIA VISPI, Annali tipografici eugubini (1623-1972), Arti Grafiche Cit-
tà di Castello, 1974, p. 67. Struttura della pubblicazione: [I.] Premessa, p. 5. [II.] Storia della tipografia, p. 7-15. [III.] Annali tipografici, p. 15-65. Registra e descrive 229 pubblicazioni; del Seicento, schede n° 1-22; s. a. la n° 23; del Settecento, le n° 24-28; dell'Ottocento, le n° 28-82; del Novecento, le n° 83-229. Modulo descrittivo che registra il facsimile dei frontespizî. [IV.] Fonti
inedite, p. 66. Registra i documenti di due contenitori: il primo è Gubbio, Sottosezione di Archivio di Stato. Serie: Riformanze, 1564-1656; Serie: Pro-
tocolli notarili, nn. 1236-1241; Serie: Archivi di Corporazioni religiose. S. Pietro,
Entrate e Uscite. C. Il secondo è: Gubbio, Archivio della Cattedrale. Status
animarum. [V.] Bibliografia, p. 66. Registra 10 voci: [1.] G. M. MAZZUCHELLI, Gli scrittori d'Italia, Brescia, Bossini, 1753-1763. [2.] F. UGOLINI, Storia dei
Conti e Duchi d'Urbino. Firenze, Grazzini, Giannini e C., 1859. [3.] O. LU-
CARELLI, Memorie e guida storica di Gubbio, Città di Castello, Lapi, 1888. [4.] VESPASIANO DA BISTICCI, Vite di uomini illustri del sec. XV, Bologna, Roma-gnoli-Dall'Acqua, 1892. [5.] G. FUMAGALLI, Lexicon Typographicum, Firenze, Olschki, 1905. [6.] A. COLASANTI, Gubbio, Bergamo, Istituto italiano d'Arti grafiche, 1925. [7.] E. GIOVAGNOLI, Gubbio nella storia e nell'arte, Città di Castello, Tip. Leonardo da Vinci, 1932. [8.] G. CECCHINI, Mostra dell'Arte
della Stampa in Umbria, Roma, Palombi, 1942. [9.] G. KNUTTEL, The Letter as
a Work of Art, Amsterdam, Typefoundry «Amsterdam», 1951. [10.] F. CO-
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
162
STANTINI, Sconosciute o poco note tipografie Eugubine nei secoli XVII-XX. In: «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», 60., 1963, p. 147-154. [VI.] Indice, p. 67.
4. LUCIA TAMMARO CONTI, Annali tipografici di Orvieto, Perugia, Deputa-
zione di storia patria per l'Umbria, 1977, p. XXXII, 298, tav. («Fonti per la sto-ria dell'Umbria. 11»). [I.] PIER LORENZO MELONI (Presidente pro tempore della Deputazione di storia patria per l'Umbria), Presentazione, p. v: salutando il lavoro, ricorda un precedente lavoro sulla tipografia assisiate di FERNANDO
MORETTI, Tipografia ed editoria in Umbria: Assisi, Perugia, [xxx], 1966 (non in-dividuato, non reperito, non visionato). [II.] L. TAMMARO CONTI, La stampa in
Orvieto dalle origini al secolo XX, p. IX-XXI: ricorda il precedente di Domenico Tordi (La stampa in Orvieto nei secoli XVI e XVII, parte I, «Bollettino della R. Deputazione di storia patria per l'Umbria» 6 e 7, fasc. 2., n° 16-19, rist. in Pe-rugia, 1903), che riguarda il Cinquecento e il primo ventennio del Seicento. Corredato di 58 note bibliografiche e documentarie. [III.] Indice dei tipografi, p. XXIII. Elenca in ordine alfabetico i 25 tipografi di cui nel catalogo si passa in rassegna la produzione, in ordine cronologico. [IIII.] Indice cronologico, p. xxv-XXXII: elenca cronologicamente le edizioni, numerandole col rimando alle schede. Per il Settecento se ne contano una cinquantina. [V.] Catalogo, p. 1-265. Elenca 1.797 registrazioni, tipografo per tipografo (all'interno della tipografia in ordine cronologico) per altrettante edizioni, segnalando a parte le opere non viste. La prima opera registrata è del [1527], l'ultima del 1899. Descrizione discorsiva sommaria.
Il catalogo è preceduto dall'elenco delle abbreviazioni, (p. 2), dove si troveranno in sigla i 3 archivî (tutti in Orvieto) e le 18 biblioteche, fra pub-bliche e private, in cui si è svolta la ricerca. Archivî: dell'Ordine dei Servi di Maria, di Stato, Vescovile. Biblioteche: Città del Vaticano: Apostolica Vaticana. Firenze: Marucelliana, Nazionale, Riccardiana. Orvieto: Comu-nale, Opera del Duomo, Privata Mario Bizzarri, Privata Giuseppe Brocchi, Privata Luigi Muzi. Perugia: Augusta, Universitaria. Roma: Angelica, Ca-sanatense, Corsiniana, Nazionale. S. Venanzo (Terni): Privata Maria Majo. Viterbo: Comunale, Privata A. Carosi. Vengono trattati 25 tipografi, in or-dine cronologico: Tipografo della Bolla di Clemente 7., Pier Matteo Tesori (1538-1557), Rosato Tintinnassi (1582-1583), Baldo Salviani (1585-1586), Tito Diani (1587), Antonio Colaldi (1587-1618), A. Colaldi e Flaminio Pe-retti (1588-1589), A. Colaldi e Ventura Aquilini (1598), Bartolomeo Zannet-ti (1621), Rinaldo Ruuli e Michelangelo Fei (1621-1625), R. Ruuli (1619-1654), Palmerio Giannotti (1662-1689), Livio Tosini (1696-1748), Giuseppe Perfetti (1776-1796), Luigi Carlucci (1788-1799), Ridolfo Tosini (1793-1824), Tosini (1809-1900), Alessandro Tosini (1810-1833), A. Tosini e Figlio (1827-1833), Sperandio Pompei (1825-1866), A. Tosini e Gioacchino (1828-1842),
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
163
G. Tosini (1842-1859), Ernesto Tosini (1874-1897), Marsilio Marsili (1876-1900), Alessandro Maglioni (1897-1900), Opere s. t.: 1588-1891. Opere s. t. e s. a. Opere non viste. Attribuzioni. Opere non viste senza indicazione di tipografia (1591-1673). Opere non viste s. n. t. e s. a. Periodici. [VI.] Indice degli autori, p. 267-278. [VII.] Indice di nomi di persone e cose notevoli, p. 279-293. [VIII.] Indice delle 14 tav., p. 295.
5. FILIPPO M. GIOCHI - ALESSANDRO MORDENTI, Annali della tipografia in
Ancona. 1512-1799, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1980, p. LXXXII, 422 («Sussidi eruditi. 35»). [I.] Premessa, p. VII-X. Queste le intenzioni e i criterî: «Non figurano inseriti negli Annali gli Editti in forma di fogli volanti (bandi, manifesti, affissi, etc.) in quanto considerati atti amministrativi, così come non appaiono gli atti giudiziari a stampa, che risulteranno nella bibliografia generale, sotto altro profilo metodologico. Sono stati invece presi in consi-derazione i disposti amministrativi e legislativi, ove la loro composizione tipografica configuri un'opera libraria, e i fogli volanti che recano testi in poesia o in prosa, in generale di carattere letterario». Le parti della scheda tipo e i criteri seguiti sono: Intestazione. Corpo della scheda. Collazione dei carat-
teri fisici e grafici della pubblicazione (formato, paginazione, composizione tipogra-
fica, illustrazioni). Reperibilità. Bibliografia. Note dei curatori. [II.] Fonti biblio-grafiche, p. XI-XXI. Elenca circa 200 voci. [III.] BibIioteche e archivî citati, p. XXII-XXVIII. Elenca numerosissime sedi di conservazione (pubbliche e priva-te): Aberystwyth, Aix Méjanes, Amiens, Ancona, Ascoli Piceno, Assisi, Bel-grado, Bergamo, Berkeley, Bethesda, Bologna, Budapest, Cagliari, Cambri-dge, Camerano, Camerino, Casale Monferrato, Castelfidardo, Catania, Ce-sena, Chicago, Città del Vaticano, Città di Castello, Civitanova Marche, Cu-pramontana, Dubrovnik, Fabriano, Faenza, Falconara Marittima, Fano, Fermo, Ferrara, Firenze, Forlì, Glasgow, Grottaferrata, Harward [sic], Ithaca (New York), Jesi, Katowice, Lawrence (Kansas), Lejda, Lisboa, Lubiana, Lodz, Londra, Loreto, Lucca, Macerata, Madrid, Milano, Modena, Momba-roccio, Mondolfo, Montefiore dell'Aso, Montpellier, Morrovalle, Mosca, Monaco di Baviera, Napoli, Narni, New Haven (Connecticut), New York, Novi Sad, Numana, Offagna, Osimo, Oxford, Padova, Parigi, Perugia, Pesa-ro, Philadelphia (Pennsylvania), Pisa, Porto Recanati, Potenza Picena, Pra-ha, Pula, Ravenna, Recanati, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Rouen, Sanseve-rino Marche, Sarajevo, Sarnano, Sassoferrato, Senigallia, Siena, Sirolo, Sivi-glia, Spalato, Teramo, Tolentino, Torino, Trento, Treia, Trieste, Urbana (Illi-nois), Urbino, Varsavia,Venezia, Verona, Vicenza, Viterbo, Washington, Wien, William Stown [sic, pro Williamstown], Zadar, Zagabria. [IV.] Note su-
gli annali della tipografia in Ancona, p. XXIX- LXXII. [V.] [Descrizioni], p. 1-370 per complessive 841 schede, così suddivise: Sec. 16., p. 1-92 (schede n° 1-118). Sec. 17., p. 93-190 (schede n° 119-348). Sec. 18., p. 191-368 (schede n°
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
164
349-838). Addenda, p. 369-370 (schede n° 839-841). [VI.] Indici, a c. di Gianni Orlandi, p. 371-422. Indice dei titoli, p. 375-399. Indice dei nomi, p. 401-422.
7. DENNIS E. RHODES, La stampa a Viterbo, "1488"-1800, Catalogo descritti-
vo, tr. di Jolanda Galigani, Firenze, Olschki, 1963, p. 218, tav. («Biblioteca di bibliografia italiana. 41»). Struttura dell'opera: [I.] Prefazione [dell'A.], p. 7-10: Non spiega i criterî di descrizione, che vanno desunti: è il metodo che, dopo Hain e passando per Gerber, si è chiamato della trascrizione di-plomatica del front. corredato da una descrizione analitica del contenuto. [II.] Introduzione [dell'A.], p. 11-19, dove si traccia il profilo della storia della stampa a Viterbo sino alla fine del Settecento. Questa la conclusione (p. 19): «Come la bibliografia dimostra, l'epoca d'oro della stampa a Viter-bo fu la prima metà del secolo XVII e gli anni di maggiore attività furono quelli dal 1606 al 1619, con più di venticinque libri stampati nella sola an-nata del 1619». [III.] Marche tipografiche, p. 21-22. [IV.] Bibliografia, p. 23. E-lenca 15 lemmi: GIOVANNI CINELLI CALVOLI, Biblioteca volante (seconda e-dizione), 4 tomi, Venezia, 1734-1747. Catalogo della Libreria Capponi, Roma, 1774. GAETANO CORETINI, Brevi notizie d ella città di Viterbo e degli uomini
illustri dalla medesima prodotti, Roma, 1774. Dizionario di opere anonime e
pseudonime di scrittori italiani... di G. M. (GAETANO MELZI), 3 tomi. Milano, 1848-1859 (1863). G. B. GIULIARI, Della tipografia veronese, Verona, 1871. Ca-
talogue de la Bibliothèque de feu M. le Comte Jacques Manzoni, 4 parti, Città di Castello, 1892-94. Catalogo dei libri posseduti da Charles Fairfax Murray, 2 parti, Londra (stampato a Roma), 1899. Catalogue des livres composant la bi-
bliothèque de M. G. Cavalieri à Ferrara, Florence, 1908. A. M. (ANTONELLI
MERCURIO), La prima stamperia viterbese, «Bollettino storico-archeologico viterbese», a. 1., fasc. 4, Viterbo, 31 dicembre 1908, p. 153-155. Questo arti-colo dubita dell'esistenza del Servio del 1488 e ricorda l'invito rivolto nel 1546 a Pier Matteo di Tesoro e ad Antonio Blado di recarsi a Viterbo. De-scrive inoltre molto bene l'attività di Agostino Colaldi ed elenca nove dei suoi libri stampati tra il 1571 e il 1595. EDUARDO TODA Y GÜELL, Bibliografia
Espanyola d'Italia dels origens de la imprempta fins a l'any 1900. 5 v., Castell de Sant Miquel d'Escornalbou, 1927-31. Autori Italiani del '600. (Catalogo
bibliografico), a c. di Sandro Piantanida, Lamberto Diotallevi, Giancarlo Li-vraghi. Fasc. 1-4. (Il fasc. 5 che doveva contenere gl'indici non fu mai pub-blicato). Milano, 1948-51. Il Calendario di Viterbo 1956, Viterbo, Agnesotti, 1956. [IV.13.] Mostra Storica del Libro Viterbese. Catalogo (a c. di A. Carosi). Viterbo, Agnesotti, 1957. D. E. RHODES, «Libri viterbesi scomparsi dei secoli
XVI e XVII», in Biblioteca degli Ardenti della città di Viterbo. Studi e ricerche
nel 150° della fondazione, a c. di Augusto Pepponi, Agnesotti, Viterbo [sic], 1960, p. 39-47. IDEM, Accertamenti sulla stampa a Velletri prima del 1700, «Studi Secenteschi» (Firenze, Olschki), v. 2. , 1961, p. 287-291. [v.] Tipografi
INNOCENTI: Da Rhodes a Carosi
165
ed editori di Viterbo «1488»-1800, p. 24. Elenca i 17 tipografi, considerati nel lavoro: Stampatore del Servio, 12 Gennaio «1488» (1478?). A. Colaldi (da Foligno), 1568-1601. Girolamo Discepolo (da Verona), 1603-1614. Pietro e Agostino Discepolo, 1615-1622. Agostino Discepolo, 1622-1630. Eredi di A. Discepolo, 1631. Lodovico Grignani (per lo piú a Roma), 1632-1634. Ber-nardino Diotallevi, 1632-1657. Mariano Diotallevi 1639-1653. Girolamo Diotallevi 1655-1665. Pietro Martinelli (Typographia Brancatia) 1661?-1702. Righettini (editore di due soli libri, e presumibilmente non a Viter-bo). Giulio de' Giulii, 1702-1711. Michele Benedetti, 1705-1718. Eredi di G. de' Giulii, 1713-1788. Domenico e/o Giuseppe Poggiarelli, 1749-1828. Do-menico Antonio Zenti (Typographia Episcopalis), 1751-1790. Pasquale Pa-rentati c. 1799-1810. [VI.] Catalogo descrittivo, p. 25-207.
Registra e descrive 551 pubblicazioni fra accettate e scartate: 1 del Quat-trocento, 30 del Cinquecento; 374 del Seicento; 140 del Settecento. Appendice.
Libri scartati, p. 208-210. Elenca e descrive 6 pubblicazioni rifiutate dal cano-ne viterbese: 2 del 1584, 2 del 1621, 1 di circa il 1625?, 1 del 1652. [VII.] Indice
dei tipografi, editori e librai, p. 211-212. Registra le menzioni relative a una quarantina di tipografi. [VIII.] Indice degli autori, traduttori e redattori, p. 213-218. [IX.] Indice generale, p. [219]. [X.] Tavole (9).
ABSTRACT. The purpose of this paper is to remind the laurea honoris causa, obtained by D. E. Rhodes (formerly Keeper of Italian Books in the British Library) in Viterbo (Università della Tuscia), 2000, May, 24th. The Author was, in such circumstance, the official Speaker; the first part of this paper presents the text of that official speech; it deals with the special knowledge that Rhodes has about the history of printing in Viterbo. The second part of the paper is devoted to Attilio Carosi (dead in 2008) and his studies about the same theme.