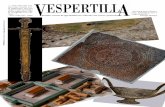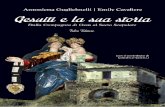Indagini archeologiche nella Tenuta Torre Serpentana al V miglio della Salaria
Culture archeologiche e spiegazione del mutamento culturale: il caso \"San Ciriaco di Terralba\"
Transcript of Culture archeologiche e spiegazione del mutamento culturale: il caso \"San Ciriaco di Terralba\"
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI
CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI
CULTURE ARCHEOLOGICHE E SPIEGAZIONE DEL
MUTAMENTO CULTURALE: IL CASO “SAN CIRIACO DI
TERRALBA”
Relatore: Tesi di laurea di:
Prof. Carlo Lugliè Gianmarco Loddi
ANNO ACCADEMICO 2013 ˗ 2014
As always, our material for study consists of things, but what we are really looking for is the people behind
the things. (David H. Trump)
1
Sommario
1 Introduzione ..................................................................................................................................... 3
2 Il concetto di cultura archeologica .......................................................................................... 5
2.1 Le origini del concetto di cultura ........................................................................ 5
2.2 L’archeologia storico-culturale ........................................................................... 6
2.3 L’archeologia storico-culturale americana.......................................................... 8
2.4 Vere Gordon Childe e il concetto di cultura archeologica ................................ 10
2.5 Gli approcci funzionalisti e la conjunctive archaeology di Taylor ..................... 13
2.6 New Archaeology .............................................................................................. 15
2.7 Le culture archeologiche secondo David Clarke ............................................... 21
2.8 Le culture archeologiche nel post-processualismo ........................................... 24
2.9 Le culture archeologiche nella paletnologia sarda ........................................... 28
3 La cultura di San Ciriaco ............................................................................................................ 33
3.1 Storia degli studi ............................................................................................... 33
3.2 Inquadramento cronologico ............................................................................. 34
3.3 Distribuzione geografica e modalità insediative ............................................... 35
3.4 La ceramica ....................................................................................................... 37
3.5 L’industria litica ................................................................................................. 42
3.6 La piccola statuaria ........................................................................................... 45
3.7 La produzione vascolare in pietra ..................................................................... 52
3.8 Contesti funerari ............................................................................................... 54
4 Evoluzioni interne e apporti extrainsulari .................................................................. 57
4.1 La cultura di Bonu Ighinu ............................................................................... 57
4.2 La cultura di Ozieri .......................................................................................... 60
4.3 La facies funeraria corso-gallurese ................................................................ 62
4.4 Apporti extrainsulari ....................................................................................... 66
5 Considerazioni conclusive......................................................................................................... 69
Riferimenti bibliografici ............................................................................................... 72
3
1 Introduzione
Quando vengono pubblicate le ultime edizioni delle maggiori opere compendiarie
della paletnologia sarda (Lilliu 2003; Contu 2006), la cultura di San Ciriaco non
vi compare in nessun modo; tra le righe, rare allusioni a evidenze poco chiare o ad
anomalie locali sigillano rapidamente un discorso mai realmente aperto. Ciò
sorprende in misura ancora maggiore, se si tiene conto delle non poche
pubblicazioni che hanno preceduto le due sopracitate, nelle quali il fenomeno San
Ciriaco, declinato come cultura o come facies, è stato oggetto di studio (e.g.
Santoni 1982a/b; Atzeni 1987; Ugas 1990; Ferrarese Ceruti 1995; Santoni et al.
1997; Lugliè 1998; Alba 1999; Molinari 2002; Lugliè 2003). Il fatto che l’aspetto
di Bonu Ighinu sia stato unanimemente recepito come una cultura archeologica
già dalla sua prima enucleazione a opera di Loria e Trump (1978), rende evidente
la necessità di: (a) individuare di quale natura siano le differenze tra le evidenze
pertinenti alla cultura di Bonu Ighinu e quelle riconducibili al San Ciriaco; (b)
stabilire se tali differenze vadano ricondotte ad una superiore conoscenza delle
evidenze Bonu Ighinu rispetto ai dati disponibili per il San Ciriaco, implicando
così una particolare cautela nell’estendere a quest’ultimo aspetto lo status di
cultura archeologica; (c) individuare i criteri con i quali stabilire quando una
associazione ricorrente di tratti culturali possa essere considerata una cultura
archeologica. Non è da escludersi, del resto, che le ambiguità che
contraddistinguono il concetto stesso di cultura archeologica possano aver giocato
un ruolo importante nel mancato accordo degli studiosi sulla natura (quando non
sull’esistenza) del fenomeno San Ciriaco. Una ulteriore questione, strettamente
legata alle precedenti, riguarda invece il San Ciriaco esplicitamente inteso come
cultura archeologica; tale valenza è da considerarsi nell’accezione di fase
cronologica, con il conseguente primato delle datazioni assolute sui tratti culturali,
o è di questi ultimi che si deve, in prima istanza, tenere conto, ammettendo così la
possibilità che un manufatto datato ad un periodo corrispondente a quello in cui
era operativa la cultura di San Ciriaco possa, tuttavia, non esserne espressione? E,
4
ammettendo questa eventualità, è possibile risalire alle cause dei mutamenti
culturali operanti all’interno di una regione mediante un’analisi incentrata sul
concetto di cultura archeologica? Nel corso del presente lavoro, è sembrato
dunque opportuno indagare la genesi di tale concetto, la sua evoluzione nella
storia del pensiero archeologico, e le modalità con le quali è stato recepito,
interpretato (o accantonato) dalle differenti scuole di pensiero; un quadro sinottico
delle conoscenze attualmente edite per la cultura di San Ciriaco è stato inoltre
comparato con la precedente cultura di Bonu Ighinu, con la seriore cultura di
Ozieri, nonché con aspetti che, nello stesso quadro San Ciriaco, risaltano come
“anomalie”, distinguendosi per alcune discrepanze rispetto alle evidenze
comunemente note per tale cultura. Chiariti i tratti culturali riconducibili al San
Ciriaco, si è infine passati all’esame dei rapporti extrainsulari, al fine di
comprendere se ci siano stati degli apporti allogeni alle spinte evolutive interne
alla cultura, e quale potesse essere la loro natura e portata. L’approccio che si è
scelto di adottare è di matrice storico-culturale, al fine di verificare se uno studio
incentrato sul concetto di cultura archeologica, che di tale approccio è il fulcro,
possa condurre ad una esaustiva comprensione dell’origine, dei limiti cronologici
e spaziali, e del perdurare, mutare ed esaurirsi di un fenomeno complesso come
appare, già ad un’analisi preliminare, quello del San Ciriaco.
5
2 Il concetto di cultura archeologica
2.1 Le origini del concetto di cultura
Il concetto di cultura, intesa come un insieme di attributi e di prodotti delle società
umane e perciò del genere umano che sono extra-somatici e trasmissibili con
meccanismi diversi da quelli dell’eredità biologica, non si riscontra mai nel XVIII
secolo (Kroeber e Kluckhohn 1952: 296). Le premesse epistemologiche, però,
compaiono già nel 1750 in An essay Concerning Human Understanding di Locke,
in cui il filosofo inglese teorizzava che la mente umana fosse equiparabile a uno
scrigno vuoto: la conoscenza di cui va poi riempiendosi viene acquisita durante
quel processo che oggi definiremmo di inculturazione (Harris 1971: 17).
Sebbene, dal 1850 in poi, tale concetto cominci ad essere usato di fatto in alcune
regioni della Germania, fu l’etnologo Tylor a fornire la prima esplicita definizione
di “cultura”, indicata come “quell’insieme complesso che include la conoscenza,
le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e
abitudine acquisita dall’uomo come membro di una società” (1871). Tylor era un
evoluzionista (meno unilineare di quanto possa apparire ad un’analisi
superficiale), sostenitore della teoria dell’unità psichica e del metodo comparativo
in un momento storico in cui l’evoluzionismo culturale, forte delle teorie di
Spencer e -soprattutto- di Darwin, e di progressi concettuali quali il Sistema delle
Tre Età messo a punto da Thomsen e le teorie sull’antichità dell’uomo di De
Perthes (1841) trionfava definitivamente sulla reazione politico-teologica post
napoleonica e su teorie, come il degenerazionismo, alle quali la reazione si
appoggiava; era inoltre un propugnatore dell’importanza dei dati archeologici da
affiancare a quelli etnologici, riconoscendo in essi un apporto fondamentale alla
teoria dello sviluppo naturale della civiltà (Tylor 1878), ed ammettendo il debito
degli evoluzionisti nei confronti delle scoperte archeologiche. Tuttavia, quando –
pochi decenni più tardi- il concetto di cultura iniziò ad essere sistematicamente ed
esplicitamente applicato all’archeologia, l’asse del pensiero antropologico si era
già spostato dall’evoluzionismo culturale al particolarismo storico e al
6
diffusionismo; gli ultimi colpi di coda di una reazione teista che non aveva esitato
ad appoggiarsi alle emergenti teorie di Boas –stravolgendone, perlopiù, il senso-
pur di affossare il darwinismo culturale, possono essere riassunti nelle
affermazioni di Laufer, che scriveva «…la teoria dell’evoluzione culturale (…) un
giocattolo di poco prezzo per il divertimento di bambini grandi, merita di essere
distrutta (…) la natura non ha leggi, quindi nemmeno la cultura ne ha» (1918), e
dello storico ceco Ràdl, che nel 1930 affermava «Il darwinismo come dottrina
tirannica, che incatena con la sua arroganza le menti degli uomini, è morto».
2.2 L’archeologia storico-culturale
Se si vuole comprendere il perché dell’eclissi dell’evoluzionismo culturale
nell’antropologia del primo XX secolo, e il conseguente avvio del concetto di
cultura archeologica maturato in un ambiente diffusionista, la strategia dei
boasiani e le spinte teiste non sono sufficienti a fornire una spiegazione
convincente; nel primo caso, perché l’antievoluzionismo della scuola di Boas è
stato abbondantemente ridimensionato, così come una sua presunta applicazione
sistematica del concetto di diffusione (e.g. Harris 1971), nel secondo caso perché
le posizioni reazionarie più estreme non trovarono, di fatto, un seguito
paragonabile a quello che, ad esempio, ebbero nel XIX secolo le teorie di De
Maistre o di W. Cooke Taylor. Quando, nel 1911, il filologo tedesco Kossinna
pubblicò Die Herkunft der Germanen (L’origine dei Germani), sistematizzando
per la prima volta l’esposizione e la sintesi archeologica con un misto di
determinismo razziale, diffusionismo e sciovinismo, l’Europa si trovava a dover
fare i conti con le contraddizioni della rivoluzione industriale, espresse nella
forma di fatiscenti agglomerati urbani, crisi economiche, concorrenza economica
sempre più pressante tra i vari stati; la perdita della fiducia nel progresso si unì al
tentativo di sostituire i conflitti di classe interni agli stati con i conflitti tra stato e
stato, e questo portò all’emergere dei nazionalismi e al recupero del determinismo
biologico come spiegazione della diversità culturale. La corsa all’identità culturale
e alle radici storiche dei gruppi etnici, per stabilire antichità e “purezza”, doveva
7
necessariamente passare per l’archeologia. In questo quadro, la visione di
Kossinna era che l’Europa centrale, a partire almeno dal Paleolitico Superiore,
fosse da intendersi come un mosaico di culture, la cui collocazione geografica e
gli aspetti sostanziali erano mutati col tempo; le culture erano il riflesso
dell’etnicità, per cui quando si riscontravano somiglianze o differenze nella
cultura materiale, queste dovevano corrispondere a somiglianze o differenze in
campo etnico. La strategia diffusionista consisteva in questo caso nell’individuare
una prima distinzione, che vedeva da una parte popoli culturalmente creativi,
dall’altra popoli culturalmente passivi; essendo le culture più progredite il
risultato di una superiorità biologica, l’unica conclusione alla quale si poteva
giungere era che le idee e le invenzioni potevano spostarsi da una regione all’altra
solo per mezzo di migrazioni di popoli, e non mediante la semplice diffusione di
idee o invenzioni. Così, con la sua Siedlungsarchäologie (archeologia degli
insediamenti), Kossinna intendeva rintracciare e delineare i territori in cui erano
vissuti specifici gruppi tribali nella preistoria, partendo dalla distribuzione dei
manufatti caratteristici di ogni gruppo; una volta identificati gruppi storicamente
noti, sarebbe poi stato possibile, grazie all’archeologia, tracciarne la storia
risalendo nel tempo (Trigger 1989: 175).
Ben presto, il concetto di cultura applicato all’archeologia varcò i confini tedeschi
per diventare un tòpos della letteratura archeologica britannica; Casson (1921:
212), ad esempio, associava la stirpe ellenica dei Dori con “la comparsa e il
costante sviluppo di una cultura, distinta per oggetti di ceramica e bronzo,
conosciuti come geometrici”. Allo stesso modo, Crawford e Wheeler (1921: 133-
40) facevano riferimento alla cultura del Bronzo Recente per definire gli
assemblaggi del sito di Llyn Fawr, e Fox (1923:85) parlava della “cultura di
Halstatt” e della “cultura del Ferro di pre-La Tène”, nei suoi studi sull’archeologia
della regione di Cambridge. La stessa enfasi sulla correlazione tra distinti modi di
vita e distinti gruppi culturali o comunità è evidente nella posizione di Crawford
(1921) sulle tecniche per l’identificazione delle culture; afferma infatti che “la
cultura può essere definita come la somma di tutti gli ideali, delle attività e dei
materiali che caratterizzano un gruppo di esseri umani. È per una comunità ciò
che i tratti caratteriali sono per un individuo (…) e gli archeologi dovrebbero
8
inoltre verificare l’esistenza di culture omogenee tramite l’analisi di un vasto
range di tipi di manufatti, e della loro distribuzione temporale e spaziale (ibidem:
132). Per quanto non parlasse espressamente di “cultura archeologica”, Greenwell
asseriva già nel 1905 che due distinte sepolture del Ferro nella regione dello
Yorkshire dovessero appartenere a gruppi che condividevano abitudini e modi di
vita, in virtù dei molteplici elementi in comune riscontrati nelle tombe; si doveva
dunque guardare al legame tra questi gruppi come ad un’affinità di sangue
(Greenwell 1905: 307). Se confrontate con questi ultimi, sia l’iconica definizione
childeiana di cultura archeologica del 1929, sia quelle degli archeologi americani
suoi contemporanei appaiono quasi minimalistiche e, in qualche misura, “caute”
riguardo alle interpretazioni in chiave etnica della cultura materiale.
2.3 L’archeologia storico-culturale americana
L’eredità del particolarismo storico di matrice boasiana influenzò sensibilmente
l’archeologia americana per tutta la prima metà del XX secolo; ben lungi dal
ricercare qualsiasi regolarità o legge culturale, gli archeologi americani mettevano
a punto la strategia particolarista e spiccatamente empirica del paziente accumulo
dei dati, che avrebbero naturalmente portato al progresso della ricerca. L’esempio
del sistema tassonomico messo a punto da un gruppo di studiosi guidati da
McKern nel corso degli anni’30 può far comprendere meglio l’impostazione
predominante in questa particolare fase della ricerca archeologica; le sequenze
regionali stabilite fino a quel momento dagli archeologi che operavano
nell’America Settentrionale avevano raggiunto una varietà e un numero tale da
indurre McKern, che in quegli anni dirigeva il Dipartimento di Antropologia del
Milwaukee Public Museum, ad elaborare un sistema di classificazione in grado di
riordinare i dati provenienti dal registro archeologico entro schemi ordinati, dai
quali si potesse poi risalire alle distribuzioni spaziali e ai range cronologici delle
evidenze materiali. Ad un’analisi dei tratti culturali, il Sistema tassonomico opera
una suddivisione in focus → aspect → phase → pattern → base, corrispondenti a
classi via via sempre meno dettagliate. Un focus comprenderà dunque le evidenze
9
caratterizzate da tratti peculiari ad un’analisi estremamente dettagliata (ad es.
schemi decorativi nella ceramica) riscontrate in differenti siti, e in alcuni casi può
corrispondere a ciò che in etnologia viene chiamata “tribù locale” (McKern 1939:
308); una comparazione tra due foci, metterà in luce che alcuni di essi presentano
caratteristiche simili, una volta eliminati i tratti maggiormente peculiari di
ciascuno, e questo porterà ad individuarli come parte di uno stesso aspetto.
Muovendosi dal particolare al generale, i dettagli culturali assumeranno via via
sempre meno importanza; ad esempio, laddove schemi decorativi particolari nella
ceramica saranno determinanti per individuare un focus, e schemi generali
individueranno un aspetto, gli elementi meccanici nella tecnica della decorazione
condivisi da più aspetti potrebbero essere i tratti decorativi più dettagliati
applicabili alla successiva classe, chiamata fase. Fasi differenti possono
condividere un insieme di tratti comuni ad un livello di analisi ancor meno
dettagliato, dando così luogo ad un pattern; più patterns condivideranno infine
elementi in comune, come l’orticultura, l’utilizzo della ceramica, o l’adozione di
pratiche funerarie, dando luogo alla quinta e ultima classe di analisi, chiamata
base.
È evidente la derivazione del modello dalla tassonomia linneana, da cui è mutuato
il concetto della suddivisione in classi; l’accezione del termine “cultura” o
dell’aggettivo “culturale” da parte di McKern non è invece sempre chiara.
McKern fa riferimento al suo metodo tassonomico come ad un culture taxonomic
method (McKern 1939: 303); fa però notare come le suddivisioni culturali
nell’approccio archeologico debbano differire da quelle di un approccio
etnologico, basate su “fattori linguistici, razziali, tradizionali e geografici” e, in
generale, su «reali fattori culturali, e non su dati selezionati, o messi a punto allo
scopo di creare un quadro tanto semplificato quanto inaccurato». «Le divisioni
culturali rappresentate dai comparti del contenitore tassonomico», continua
McKern, «sono difficili da visualizzare in termini di divisioni in senso etnologico,
poiché basate interamente su fattori culturali, gli unici fattori sempre e
immediatamente disponibili per l’archeologo, laddove i concetti etnologici sono
pensati come variamente determinati da una base di cultura, di mero linguaggio,
di razza, di tradizione e di collocazione geografica, sia considerando isolatamente
10
ognuno di questi fattori, sia nel caso in cui siano associati tra essi» (ibidem: 305).
Allo stesso modo, non è chiaro come McKern intendesse stabilire delle sequenze
culturali senza tenere conto del fattore cronologico; questa lacuna caratterizza
anche il sistema classificatorio di Gladwin e Gladwin (1934), nel quale però viene
adottato uno schema dendritico che renderebbe perlomeno implicita una
prospettiva temporale. Tra gli archeologi americani operanti durante il regno del
particolarismo storico, l’eccezione di Kidder, che deplorava il particolarismo in
cui era caduta l’archeologia e ne criticava l’impostazione prevalentemente
descrittiva e la mancanza di qualsiasi prospettiva storica (Kidder 1936: 146) non
mutò dunque un quadro generale all’interno del quale le culture erano considerate
poco più che collezioni di tratti individuali risultanti da “accidenti storici” e
slegati non solo dai comportamenti, ma anche dalla prospettiva cronologica; negli
stessi anni, nel Vecchio Continente, archeologi come Clark e Childe
cominciavano invece ad adottare un approccio funzionalistico che avrebbe
ribaltato questa tendenza.
2.4 Vere Gordon Childe e il concetto di cultura archeologica
«L’archeologo non cerca di ricostruire le società passate, studiando gli scheletri dei loro
membri, ma basandosi sull’esame delle tracce del loro comportamento giunte fino a noi –
il vasellame, la pianta delle costruzioni, i ninnoli personali, gli oggetti funebri rituali, i
materiali importati da altri luoghi, e così via. Tali vestigia sono dagli archeologi divise e
classificate in «tipi»; quando i medesimi tipi sono a più riprese trovati riuniti in luoghi
diversi di una regione determinata, essi vengono raggruppati e considerati come
l’espressione di quello che noi chiamiamo una “cultura”» (Childe 1958: 10).
Vere Gordon Childe è stato una figura chiave per il pensiero archeologico della
prima metà del XX secolo; marxista, sostenitore della teoria di Morgan sulla
successione di stati, si sentiva distante tanto dall’evoluzionismo unilineare quanto
dal diffusionismo estremo di Smith (Childe 1946). Insieme al concetto di cultura
archeologica (che perfezionò e sistematizzò nel corso dei suoi studi), prese
inizialmente in prestito da Kossinna alcune idee sulla raffinatezza della lingua
11
quale indicatore della purezza razziale (1926), che si affrettò a disconoscere, una
volta resosi conto che coincidevano con quelle della Germania nazista; questo
portò all’abbandono, nei suoi lavori successivi, oltre a qualunque traccia di
determinismo biologico, di tutti i dati che non derivassero dalla cultura materiale.
Il concetto di cultura archeologica di Gordon Childe differiva in maniera
sostanziale da quello degli archeologi classificatori americani; in una lettera del
1946 all’antropologo statunitense Braidwood, scriveva:
«Ammetto che l’uso del termine “cultura” da parte degli archeologi è aperto a diverse
obiezioni. . . .Le culture degli archeologi dovrebbero essere equiparabili a quelle degli
etnografi. Questo non elimina l’obiezione che la cultura venga utilizzata in molte altre
accezioni. Ma gli assemblaggi, per quanto corretti sul piano descrittivo, tendono a
confermare quella che R. B.1 definì la teoria “degli stracci e dei frammenti”, che vedeva
la cultura come l’insieme di tratti disparati, messi assieme da un accidente storico. . . . E
gli archeologi, oggi, provano a descrivere le loro culture “funzionalmente”, così come
fanno molti etnografi» (Childe a Braidwood, 29 Maggio 1946; trad. di chi scrive).
In un articolo scritto qualche anno prima, Childe mette in evidenza come le
culture non dovessero essere intese come gruppi di fossili inanimati, ma come
organismi viventi e funzionanti:
«Le periodizzazioni basate sulla tipologia possono avere, nella migliore delle ipotesi,
validità regionale, in grado di fornire un comodo quanto provvisorio impalcato per
classificare le antichità locali. (…) In secondo luogo, le classi oggetto di studio della
storia naturale sono estremamente astratte: le specie e i generi dei naturalisti vengono
adottate non tenendo conto delle molteplici differenze tra singoli alberi di quercia (…) in
modo da focalizzare l’attenzione su un limitato numero di tratti comuni. La storia della
letteratura, d’altro canto, è fatta di singole personalità. La preistoria non può accontentarsi
di un’umanità astratta. Non può, in effetti, arrivare all’individuale, ma può apprezzare le
differenze tra nazione e nazione, differenze dovute a diverse tradizioni sociali. Solo
1 R.B. sono le iniziali di Radcliffe-Brown; l’episodio degli “stracci e frammenti” è evidentemente
da ricondurre ad una frase di Lowie, che nell’ultimo capoverso di Primitive Society definiva la
civiltà, dal punto di vista degli storici, “quel caotico miscuglio, quella cosa formata di stracci e
frammenti” (Lowie 1920: 441). Radcliffe-Brown la riprenderà per definire il punto di vista di
alcuni etnologi riguardo all’ipotesi funzionale (Radcliffe-Brown 1952, 20).
12
allora, l’archeologia preistorica potrà rispondere alle legittime domande poste dai filologi
e dagli storici della letteratura: donde giunsero gli Indo-Europei? Quando, i Celti,
raggiunsero per la prima volta la Gran Bretagna? Furono i Sumeri o i Semiti i primi ad
insediarsi nella Mesopotamia? Questo implica l’applicazione di categorie più ristrette, per
i suoi materiali. “Pietra levigata celta” è un termine piuttosto astratto, che mette assieme
una varietà di oggetti differenti per forma, materia e funzione. Il significato di questa
varietà diventa manifesto, una volta tenuto conto di come lo strumento è stato fabbricato,
immanicato e adoperato, una volta che guardiamo ad esso non come ad un oggetto
naturale, ma come ad un utensile fabbricato dall’uomo affinché lo mettesse in condizione
di far fronte all’ambiente in cui si trovava. Lo studio delle società umane viventi come
organismi funzionanti ha rivelato all’archeologia questo approccio ai materiali. Ha
portato alla corretta definizione e interpretazione del concetto di cultura. E con questo
concetto, l’archeologia può muovere dall’astrazione delle scienze naturali alla
concretezza comparativa della preistoria. La cultura non è una categoria a priori elaborata
dagli studi dei filosofi e calata dall’alto sugli archeologi. Le culture sono i fatti osservati.
(…) I tratti di una cultura si presentano pertanto riuniti assieme, agli occhi
dell’archeologo, perché sono la creazione di un singolo popolo, adattamenti all’ambiente
approvati dall’esperienza collettiva» (Childe 1935: 10; traduzione di chi scrive,
corsivi aggiunti).
Nell’ultimo capoverso compaiono tanto l’influenza di White quanto il carattere
normativo della trasmissione culturale; i processualisti accoglieranno l’influenza
di White, ma criticheranno con forza il secondo aspetto (e.g. Binford 1972). Non
vi è più traccia, inoltre, degli aspetti razziali. Se in The Aryans (1926: xii) Childe
era ancora incline al determinismo biologico, a partire dagli anni ’30 la sua
posizione riguardo a una possibile correlazione tra razza e raggruppamenti
archeologici e linguistici divenne piuttosto critica: «la cultura è un patrimonio
sociale; corrisponde a una comunità che condivide tradizioni comuni, istituzioni
comuni e comuni modi di vita. Un simile gruppo può ragionevolmente essere
chiamato popolo (…) e dunque è a un popolo che deve corrispondere la cultura di
un archeologo. Se etnico è l’aggettivo per popolo, potremmo dire che
l’archeologia preistorica ha buone speranze di mettere a punto una storia etnica
dell’Europa, mentre una storia razziale sembra irrimediabilmente lontana» (Childe
1933: 198-9). Simili argomentazioni vennero riproposte in una successiva
13
discussione di Childe sulla metodologia archeologica, quando mise in evidenza
che le arbitrarie peculiarità dei manufatti sono “considerate la concreta
espressione delle comuni tradizioni sociali che tengono insieme un popolo»
(Childe 1956: 31). In contrasto con Kossinna, Childe poneva l’enfasi
sull’importanza dell’associazione di particolari tipi di manufatti a condizione che
si potesse riscontrare il loro contemporaneo utilizzo nella stessa società,
mostrando così di fare maggiore affidamento sugli assemblaggi materiali più che
sui manufatti individuali. Ciò significa che per Childe la cultura archeologica era
un’unità formale, non geografica o cronologica. I suoi limiti dovevano essere
stabiliti empiricamente dalla delineazione delle culture piuttosto che dalla
seriazione di tipi individuali. Nondimeno, nonostante Childe mettesse in evidenza
l’importanza di tutti gli aspetti del registro materiale nella descrizione delle
culture archeologiche, nella pratica la maggior parte veniva definita sulla base di
un ridotto numero di manufatti diagnostici (e.g. Childe 1956: 121). Il concetto di
cultura archeologica in Gordon Childe è ad ogni modo più strettamente legato ai
produttori degli assemblaggi archeologici di quanto non lo fosse nell’archeologia
nordamericana, in cui le culture archeologiche coincidevano per lo più con il
“prodotto”, senza tenere particolarmente conto né di chi le aveva prodotte, né di
come queste rispecchiassero un adattamento all’ambiente regolamentato da norme
sociali condivise da un gruppo umano. Si cominciava, dunque, a rispondere
positivamente all’appello lanciato dall’archeologo finlandese Tallgreen (1937)
affinché si smettesse di considerare i manufatti più reali e vivi delle società che li
avevano prodotti e delle genti che li avevano realizzati per sopperire alle proprie
necessità (Trigger 1989: 283).
2.5 Gli approcci funzionalisti e la conjunctive archaeology di Taylor
Quando, nel 1939, Clark pubblicò Archaeology and Society, le culture
archeologiche erano ormai considerate un indispensabile e imprescindibile
strumento euristico a disposizione degli archeologi per la lettura del passato; egli
stesso affermava che l’interpretazione dei dati archeologici era subordinata ad una
14
fase classificatoria, in cui era necessario stabilire una successione delle culture, e
alla comprensione di come funzionassero le comunità preistoriche ad esse legate
(Trigger 1989: 284). Già in Prehistoric England (1940), però, i capitoli
organizzati funzionalmente, anziché cronologicamente, indicano che la fase
classificatoria dell’archeologia storico-culturale cominciava ad essere messa in
discussione. Diversamente da Childe, Clark vedeva nel fattore ecologico la causa
prima del mutamento culturale; non trascurava affatto, ad ogni modo, i fattori
economici, intesi come parte integrante dell’organizzazione sociale che intendeva
ricostruire (1952). Parallelamente, l’archeologia dell’America Settentrionale
cercava di superare l’approccio eminentemente storico-classificatorio affermatosi
con il fiorire degli ormai molteplici metodi tassonomici; l’esigenza di
un’interpretazione funzionale e comportamentale dei dati archeologici era, del
resto, la naturale ripercussione delle idee divulgate dalle scuole antropologiche di
Radcliffe-Brown e Malinowski, e l’eco degli approcci funzionalisti di archeologi
del Vecchio Continente quali Childe e Clark non doveva certamente aver
risuonato inascoltato. Kluckhohn e Taylor, in particolare, si fecero portatori
dell’istanza di un approccio “scientifico”, in aperta rottura con l’archeologia
storico-culturale; Taylor raccolse l’invito di Kluckhohn (1940) ad adottare un
approccio congiunto che unisse gli studi delle relazioni tra diversi siti con studi
particolareggiati del singolo sito, nei quali avrebbero giocato un ruolo chiave gli
aspetti quantitativi e la distribuzione spaziale dei manufatti, dedicando
contemporaneamente un’estrema attenzione a tutti i manufatti, anziché
privilegiare alcune classi (Trigger 1989: 296). Quale fu, dunque, il ruolo delle
culture archeologiche in questa fase della ricerca? Taylor distingue tra la
“cultura”, intesa nella sua accezione partitiva, e la Cultura in senso olistico;
quest’ultima è un concetto descrittivo o esplicativo per i costrutti mentali messi a
punto e trasmessi dagli individui – ma non si escludono idiosincrasie scostanti dal
processo di trasmissione (1948: 109). Le culture archeologiche sarebbero invece
dei sistemi mutuati dalla storiografia, composti da tratti culturali e di norma
condivisi all’interno di un gruppo o di una società (ibidem: 110): fenomeni
mentali, anch’esse. Sostenere che la cultura sia un concetto mutuato dalla
storiografia, significa affermare che la scala della ricerca è quella del sito,
15
circoscritto in termini di tempo e spazio: in questo, così come nel non negare a
priori la possibilità di stabilire leggi o generalità –considerandola, tuttavia, una
possibilità piuttosto remota-, sta l’influenza di Boas su Taylor (ibidem: 38). Ciò
che è ancora più importante, ad ogni modo, è che la visione della Cultura e delle
culture come fenomeno mentale esclude che si possa parlare di “cultura
materiale”, dal momento che i manufatti e le evidenze archeologiche in generale
sarebbero un mero riflesso, un’oggettivazione della Cultura, residente sul piano
superorganico; le critiche a questa concezione non mancarono, a partire dal
materialista White, che sosteneva il legame concettuale tra la cultura extra-
somatica e le espressioni di questa, “misurabili” empiricamente e considerabili, a
pieno titolo, esse stesse cultura (White 1959: 237). La visione di Taylor verrà
recuperata, decenni dopo, dalle archeologie cosiddette post-processuali; prima di
allora, i processualisti della New Archaeology si schiereranno in gran parte con
White (ma cfr. Caldwell 1959), in particolar modo colui che verrà considerato il
principale esponente della New Archaeology: Lewis R. Binford (e.g. 1972).
2.6 New Archaeology
Le pubblicazioni di The New American Archaeology di Joseph Caldwell
(1959) e di due articoli di Lewis Binford, Archaeology as Anthropology (1962) e
Archaeological Systematics and the study of Culture Process (1965), vengono
generalmente considerate il giro di boa del pensiero archeologico; in realtà,
nonostante l’indubbio elemento di rottura rappresentato dalla New Archaeology, è
ancora possibile scorgere elementi di continuità con i precedenti approcci
funzionalistici, per quanto “filtrati” dalle teorie di White in un momento storico in
cui il neoevoluzionismo si riprendeva la ribalta sulla scena dell’antropologia
culturale americana. Nel 1966 veniva pubblicato An Introduction to American
Archaeology di Gordon Willey; in una delle recensioni, ad opera di Kent Flannery
e avente come titolo Culture history v. culture process: a debate in American
archaeology (1967) venivano messe in evidenza le differenze cruciali tra
l’approccio storico-culturale e quello processuale. Se anche un archeologo
16
funzionalista ed esponente (tra i principali) della scuola ecologica veniva
inquadrato, per sua stessa ammissione, tra gli archeologi storico-culturali, si
capisce come la New Archaeology rappresentasse per molti versi una rottura con il
passato; nonostante non mancassero delle premesse comuni – Binford cita lo
stesso Willey, asserendo che “l’archeologia è antropologia o nient’altro” (Willey e
Sabloff 1959, citato in Binford 1962: 217) – le differenze vertevano sul ruolo che
l’antropologia, e con essa l’archeologia che ne era una branca, doveva avere nella
spiegazione del passato. La tendenza idiografica, come quella portata avanti da
Willey nella sua sintesi sull’archeologia precolombiana, doveva – a detta dei
processualisti – cedere il passo ad un approccio nomotetico che avrebbe portato
alla ricerca di regolarità nei processi culturali, per mezzo di un metodo non più
induttivo, bensì deduttivo. Se, dunque, le culture archeologiche avevano fino a
quel momento avuto il ruolo di tessere di un mosaico che, una volta completato,
avrebbe fornito cronologie e distribuzioni spaziali dei gruppi etnici preistorici, da
Binford in poi ci si occupò di analizzare funzionalmente ogni singola tessera, non
più nell’ottica di una sua collocazione geografica e temporale, bensì in vista di
una spiegazione sulla genesi dei singoli processi, laddove un processo è inteso
come l’insieme delle modalità con cui un sistema, ossia un complesso di elementi
interconnessi tra loro che funziona come una singola entità, opera e subisce
modifiche strutturali (Binford 1962)
Quando Binford coniò l’espressione “archeologia normativa” (1965) per
designare la teoria di trasmissione della cultura propria degli archeologi storico-
culturali, forzava consapevolmente il pensiero di questi ultimi al fine di porre la
maggiore distanza possibile tra il loro pensiero e la sua visione di come
l’archeologia dovesse spiegare i cambiamenti culturali; ne criticava, in particolare,
la propensione ad intendere le culture come insiemi di assemblaggi, tipicamente
denominati “tratti culturali”, soggetti a “trasmissione ideativa”, e suscettibili di
modifiche strutturali a partire da singole “derive” idiosincratiche. Un esempio di
quale grado di correlazione esistesse tra le differenze nell’intendere la cultura e il
modo in cui questa venisse trasmessa e subisse variazioni, e le differenze nello
stabilire quali fossero gli obbiettivi della ricerca archeologica, ci viene offerto da
due pubblicazioni, redatte a distanza di un anno l’una dall’altra, aventi come
17
oggetto generale la c.d. Cultura di Red Ocher. Nel 1962, Ritzenthaler e Quimby
pubblicano uno studio sulle evidenze pertinenti alla Cultura di Red Ocher
distribuite lungo i quattro Grandi Laghi del Nordamerica, con l’obbiettivo di
“definire approssimativamente la Cultura di Red Ocher dall’analisi di tutte le
relazioni dei siti di cui si ha notizia, e tracciarne la distribuzione”; tale cultura
viene intesa come la somma di tratti “nucleari” costantemente ricorrenti (velo di
ocra rossa nelle sepolture a inumazione flessa, grandi lame in selce biancastra
“dall’aspetto solutreano”, lame “a coda di tacchino” in selce grigia-bluastra,
piccole punte ovali o triangolari, presenza di oggetti in rame, perline tubolari
ricavate da conchiglie), tre dei quali -grandi lame cerimoniali, punte ovali-
triangolari e lame “a coda di tacchino”- ritenuti diagnostici, a cui si aggiungono
sporadicamente tratti cosiddetti marginali (inumazioni in tumuli, cremazioni o
altre tipologie di seppellimento secondario, presenza di blocchi grezzi di galena,
collane di conchiglie circolari o ovali, birdstones). La cultura di Red Ocher viene
quindi confrontata con quella di Glacial Kame, sovrapponibile geograficamente e
cronologicamente e caratterizzata dai medesimi tratti “marginali” della prima, ma
avente un differente tratto “diagnostico”: la collana fatta di conchiglie marine
lavorate cosiddette sandal-sole shaped; nell’esaminare una sepoltura ritenuta
Glacial Kame, gli autori affermano che “se invece delle collane a suola di sandalo
ci fosse stata una o più lame a coda di tacchino, avremmo assegnato il sito al Red
Ocher” (ibidem: 256; traduzione di chi scrive, corsivi aggiunti). Viene, infine,
presa in esame l’eventualità che entrambe le culture derivino da quella
denominata Old Copper, e si conclude datando la Red Ocher sulla base di
relazioni geologiche, associazioni stratigrafiche e date radiocarboniche; si segue,
in sostanza, una tipica procedura storico-culturale. Un anno dopo, Binford
pubblica – anch’egli – un lavoro che ha come oggetto generale di indagine la
cultura di Red Ocher: le premesse, però (a partire dal titolo: “Red Ocher caches
from the Michigan area: a possible case of cultural drift”), sono affatto differenti,
così come l’impostazione e le conclusioni a cui tende. L’oggetto di analisi non è,
in questo caso, la cultura Red Ocher intesa come contenitore del quale si
intendano trovare i limiti geografici e cronologici e si possa, così facendo,
valutare cosa sia lecito inserire al suo interno; si intende, piuttosto, testare l’ipotesi
18
della deriva culturale come spiegazione della presenza, all’interno di singole
sepolture rinvenute nel sito di Pomranky – Michigan, di lame di differenti varietà.
Le domande a cui si tenta di rispondere sono: (a) se esistano o meno altre
sepolture “Red Ocher” che presentino singolarmente differenti varietà di lame
deposte al loro interno; (b) se esistano varietà ricorrenti in più di un sito -il che
suggerirebbe un’origine locale differente per ognuna di esse, ma anche una loro
circolazione all’interno della regione-; (c) se le differenze osservabili all’interno
della popolazione statistica delle lame in oggetto siano la spia di differenti
patterns regionali, ponendo così le basi per la comprensione dei processi di
cambiamento e differenziazione culturale aventi avuto luogo nel range
cronologico pertinente ai campioni (1963: 89). La questione (c), in particolar
modo, presupponeva la ricerca di un modello esplicativo che Binford individuò ˗
con le dovute riserve e qualche modifica, in modo da renderlo uno strumento
analitico di effettiva applicabilità al registro archeologico (ibidem: 91) ˗ nel
concetto di “deriva culturale”, una teoria mutuata dalla genetica e dalla linguistica,
secondo la quale i cambiamenti all’interno di un sistema possono avere luogo a
partire da singole idiosincrasie consistenti in scostamenti casuali dalle proporzioni
attese (alla stregua dei cosiddetti “errori di campionamento” propri della deriva
genetica). Buona parte dell’analisi di Binford verte sulla comparazione tra le
variazioni nella fabbricazione dei manufatti a livello del singolo sito e quelle
registrate nei siti culturalmente affini e geograficamente prossimi; la seriazione
statistica prende il posto della mera seriazione tipologica. Non solo non vi è
traccia di culture archeologiche differenti in spazio e tempo, ma la stessa cultura
di Red Ocher non è soggetta ad un’indagine volta a stabilirne limiti e peculiarità,
bensì viene fatta oggetto di un’analisi funzionale e processuale limitatamente ad
alcuni aspetti, tralasciandone volutamente alcuni altri (tra cui quello eponimo
della cultura, ossia la velatura di ocra rossa sui corpi inumati). Nel primo caso, la
sola spiegazione al problema su come abbiano avuto origine le manifestazioni
culturali che caratterizzano la Red Ocher, viene fornita in termini di dipendenza
filetica dalla precedente cultura di Old Copper; nel caso del lavoro di Binford,
l’approccio processuale utilizza un modello per spiegare alcuni dei processi
ritenuti cruciali nella genesi dei cambiamenti avvenuti nel quadro del sistema Red
19
Ocher. Nemmeno i seguaci della New Archaeology, tuttavia, potevano ignorare il
mosaico delle culture archeologiche messo a punto fino a quel momento, tant’è
che le singole culture continuavano a svolgere il ruolo di singole unità discrete al
cui interno erano osservabili affinità di cui era necessario tenere conto, anche in
vista di analisi focalizzate su singoli sottoinsiemi. Eppure, l’antistoricismo che
caratterizzava gran parte della ricerca dell’archeologia processuale americana,
specchio di una disistima nella storia in quanto priva di carattere pratico che era,
in quegli anni, una tendenza imperante in un’America più propensa ad attribuire
valore a ciò che era tecnologicamente utile, portò molti archeologi a prendere le
distanze da una comprensione del passato di tipo storico, in favore di un approccio
teso a trovare le regole generali del comportamento umano e che veniva
considerato il sommo risultato per un archeologo (Trigger 1989: 338). Le culture
archeologiche, che erano gli attori storici per eccellenza in quanto portatrici di
specificità e unicità e, in virtù di questo, fenomeni irripetibili, non potevano avere
all’interno dell’archeologia processuale un ruolo di primo piano. Un punto di
contatto tra le classificazioni e i taxa delle culture archeologiche e il metodo
deduttivo della New Archaeology è stato proposto da Fritz e Plog:
«Noi tutti sappiamo che gli archeologi possono direttamente osservare le proprietà
formali e contestuali dei loro dati, mentre non possiamo osservare direttamente le
funzioni di questi dati. Nondimeno, assegniamo di buon grado a oggetti particolari utilizzi
particolari. Ciò non viene fatto arbitrariamente, ma con la convinzione che tali oggetti
abbiano tali utilizzi. Senza tale convinzione, non ci sarebbe alcun fondamento logico
nello scegliere alcune caratteristiche tra il potenzialmente infinito numero che un oggetto
possiede, né nell’affermare che ciò è dovuto alla funzione dell’oggetto. Ma deve esserci
una ragione alla base di questa convinzione. Ipotizziamo che gli archeologi affermino che
tale relazione esista in un caso particolare perché pensiamo che esista in tutti i casi simili.
Queste convinzioni, dunque, hanno forma di asserzioni universali condizionali.
Affermano, essenzialmente, che se una particolare attività è avvenuta, allora un certo
insieme di caratteristiche sarà rinvenuto nel registro archeologico. Ad esempio, quando
classifichiamo un oggetto come “ascia”, lo facciamo perché pensiamo che tutti gli oggetti
usati come asce abbiano in comune alcune caratteristiche che anche questo oggetto
possiede. In breve, sosteniamo che molte classificazioni siano esplicative e conformi al
modello di Hempel-Oppenheim. (…) Osserviamo un oggetto o un tratto saliente, e
20
notiamo che ha un determinato insieme di caratteristiche. Spieghiamo queste
caratteristiche classificandolo; ossia, affermando che ebbe una determinata funzione in
passato. Questa classificazione è inevitabile ovvero logicamente necessaria, in quanto il
ragionamento è deduttivo; cioè, passa da una premessa generale a una premessa
particolare, fino ad una conclusione particolare. (…) La classificazioni delle “culture”, o
di altri più generici taxa, ad esempio, richiedono alcuni assunti o leggi sulla natura delle
“culture” in generale, e sulle loro manifestazioni empiriche. Interpretazioni di relazioni
generiche tra culture specifiche o di processi culturali all’interno di una data sequenza
culturale sono anch’esse derivate da leggi su tali fenomeni in senso generale» (Fritz e
Plog, 1970; traduzione di chi scrive).
È stato fatto notare (Levin 1973) che «l’affermazione secondo la quale la
classificazione fa di per sé uso di leggi è corretta; ciò che non è condivisibile è la
ragione per cui la classificazione archeologica sarebbe esplicativa e nomotetica,
dal momento che, classificando un ciottolo scheggiato su ambo i lati come “un
chopper”, faccio uso della generalizzazione “tutti i bifacciali scheggiati su ambo i
lati erano, una volta, choppers”, ma questa generalizzazione non serve a
comprendere perché fosse un chopper». La caratteristica presentata da Fritz e Plog
come un trait d’union mette invece in evidenza come la distanza tra i due approcci
resti, in realtà, consistente. Bisogna comunque considerare che la rivoluzione
apportata nel campo della cronologia dal metodo del radiocarbonio, messo a punto
all’inizio degli anni ’50 e perfezionato nei decenni successivi, deve aver svolto un
ruolo decisivo nello spostamento dell’attenzione verso problemi differenti da
quello della collocazione dei manufatti sul piano temporale (Manacorda 2008:
217). Le culture archeologiche erano percepite come strumenti sempre meno utili
al lavoro dell’archeologo, sempre più impegnato a cercare leggi universali del
comportamento umano tanto da far sorgere il dubbio che lo scopo potesse, in fin
dei conti, essere raggiunto tanto indagando un sito Arikara del sedicesimo secolo,
quanto un deposito di rifiuti della Tucson del 1981 (Flannery 1982: 274).
Nell’esasperato tentativo di molti degli archeologi che operavano seguendo il
paradigma processuale di rendere l’archeologia una scienza oggettiva, e di
equipararla all’antropologia, andava perdendosi –oltre all’innocenza- la cultura
come spiegazione dei comportamenti umani. Il concetto di cultura archeologica
21
non era del tutto incompatibile con la metodologia adottata dall’archeologia
processuale, semplicemente le culture archeologiche non erano più l’oggetto
centrale della ricerca.
2.7 Le culture archeologiche secondo David Clarke
Diversamente da quanto avveniva negli USA, in cui i dipartimenti di archeologia
erano strettamente collegati a quelli di antropologia, nel mondo accademico
europeo l’archeologia era sempre stata legata ai dipartimenti di storia, per effetto
evidente dell’archeologia classica, per cui nessuno, nel Vecchio Continente, sentì
mai l’esigenza di far coincidere in toto la disciplina archeologica e quella
antropologica. David Clarke, che pure è stato uno dei più influenti processualisti,
affermava del resto che “l’archeologia è l’archeologia è l’archeologia” (1968). Nel
dare una prima definizione operativa di cultura archeologica, Clarke la indica
come “un gruppo politetico di tipi di manufatto specifici e comprensivi che
compaiono insieme in modo consistente in insiemi entro un’area geografica
limitata” (ibidem: 190). Una prima, sostanziale differenza rispetto alle definizioni
di Childe è data dall’aggettivo “politetico” ad indicare la natura degli insiemi
archeologici costitutivi di una cultura; poco oltre, Clarke aggiunge:
«La manipolazione persistente delle culture archeologiche come gruppi rigidi,
reciprocamente esclusivi, monotetici di manufatti hanno giustamente mancato di
impressionare generazioni di studenti. Cosiddette culture composte quasi interamente da
singoli aspetti della cultura materiale hanno portato aggiunte a questa cattiva reputazione.
Metodi mal definiti e ad ampia diffusione della tecnologia degli utensili in selce sono stati
persistentemente elevati a status di cultura in un modo che annulla le affinità e le
somiglianze dell’intero insieme di manufatti implicato (…) vi sono state culture definite
da singoli tipi ceramici in modo tale che la ceramica grossolana comune è stata posta in
una cultura e la ceramica più fine in un’altra – anche di fronte a una persistente
associazione fisica. (…) La linea disturbante di usi vari e indefiniti del termine “cultura”
potrebbe essere estesa senza fine senza neppure avere il merito della coerenza in alcuni
autori. Anche se il continuo cattivo uso di un concetto fondamentale deve danneggiare
seriamente il suo valore residuo di informazione non dovremmo cadere nell’errore di
supporre che l’entità non riesce a restare un’entità fondamentale, o che è impossibile
22
definirla adeguatamente. Non possiamo sperare in un accordo tra archeologi sulla
definizione di termini particolari ma almeno possiamo insistere sul fatto che essi
indichino che cosa vogliono dire con un termine prima di usarlo» (ibidem: 191).
Si può notare come una delle prime critiche mosse da Clarke ai modelli
archeologici generalmente proposti – sia implicitamente che esplicitamente –
riguardi la natura monotetica delle tassonomie prese in esame dagli archeologi al
momento di definire un insieme, un gruppo o una cultura. Un gruppo monotetico
è un gruppo di entità all’interno del quale ogni membro deve necessariamente
avere tutti gli attributi qualificanti; Clarke obbietta che nessun gruppo di insiemi
culturali di un’unica cultura contiene mai, né ha mai contenuto, tutti i manufatti
culturali prodotti da quella cultura, e oppone a questa classificazione l’altra classe
di gruppi tassonomici – i gruppi politetici, gruppi all’interno dei quali ogni entità
possiede un gran numero degli attributi del gruppo, ogni attributo è condiviso da
un gran numero di entità e nessun singolo attributo è necessario e sufficiente per
l’appartenenza al gruppo (ibidem: 39). La prima e più diretta conseguenza, è la
critica alla frequente quanto eccessiva fiducia riposta nei c.d. fossili-guida come
criterio decisivo dell’appartenenza di un attributo a un gruppo; il concetto stesso
che sta alla base dell’individuazione di attributi denominati “tipici” è visto con un
certo scetticismo, in particolare per la loro natura di attributi individuati a priori,
anziché in seguito ad un’analisi completa che sia, dunque, anche quantitativa. In
questo senso, nemmeno la sostituzione del termine “tipico” con il termine
“diagnostico” sarebbe sufficiente a ridurre il problema ad un livello nominale, in
quanto la “diagnosi” indicherebbe ancora una volta un’analisi meramente
qualitativa, rispondente nella maggior parte dei casi a valutazioni elaborate, sì, a
posteriori dal confronto con altri complessi considerati appartenenti ad un’entità
altra rispetto a quella della quale l’attributo o il manufatto chiamato diagnostico
sarebbe espressione, ma a priori rispetto a qualsiasi analisi di tipo statistico. Una
volta definita la “cultura archeologica”, Clarke individua al suo interno una serie
di suddivisioni che chiama sottoculture archeologiche, ognuna delle quali sarebbe
“un segmento o allineamento di attività infraculturali caratterizzato da uno
specifico complesso di tipi”; il concetto potrebbe essere inteso come parzialmente
23
sovrapponibile a quello di facies (cfr. Cocchi Genick 2005), ma il considerarle
come entità semi-indipendenti porta naturalmente ad un approccio diversificato a
seconda della varietà di sottocultura che si intende analizzare. In particolare, nel
fornire alcuni esempi di formati di sottocultura, Clarke propone ad esempio
spiegazioni di tipo ecologico nel tracciare l’analisi di una sottocultura regionale,
spiegazioni di matrice materialistico-culturale per quanto attiene alle sottoculture
occupazionali, o di natura sociologica nell’indagine di sottoculture sociali o
sessuali; è, questo, un approccio pienamente funzionale –oltre che processuale-,
non solo nell’individuazione di sottocategorie costitutive della cultura, ma anche
nelle modalità con le quali si affronta la spiegazione della genesi (e della “morte”,
specialmente nel caso delle sottoculture etniche) di ciascuna di esse. Le culture
archeologiche, così definite, rappresenterebbero il sottosistema di cultura
materiale di un sistema socioculturale specifico, nonché le categorie di entità con
il più grande contenuto di informazione; spostando l’indagine su una scala più
ampia, le singole culture sono anche parte di gruppi di culture, a loro volta facenti
parte di categorie ancora più generali designate come tecnocomplessi, entità che
comprendono gruppi di culture caratterizzate da complessi che condividono una
gamma politetica ma differenti tipi specifici delle stesse famiglie generali di tipi di
manufatto, condivisi come risposta ampiamente diffusa e interconnessa a fattori
comuni nell’ambiente, nell’economia e nella tecnologia (ibidem: 249). Clarke non
si sottrae, inoltre, alla questione della corrispondenza tra entità archeologiche e
raggruppamenti sociali, linguistici e razziali; la cultura archeologica, in questo
senso, viene intesa come “il prodotto di un gruppo di persone con
un’organizzazione tribale, un sistema di linguaggio e una popolazione largamente
omogenei, che la popolazione stessa riconosca l’insieme o meno. La cultura
archeologica disegna un’entità che esisteva realmente, segnando
un’interconnessione reale; che questa entità non sia identica a entità storiche,
politiche, linguistiche o razziali non la rende meno vera o importante. Le entità
archeologiche riflettono realtà altrettanto importanti di quelle riconosciute dalle
classificazioni tradizionali di altre discipline; le entità in tutti questi campi sono
ugualmente reali, ugualmente arbitrarie e semplicemente diverse.”
24
In un momento storico in cui l’archeologia sembra volersi disfare delle
culture archeologiche, viste come un trucco concettuale per raggruppare insieme
siti e manufatti in assenza di metodi di datazione assoluta indipendente, o ritenute
fuorvianti ai fini del riconoscimento della variabilità rilevante nel comportamento
umano (e.g. Daniel 1971; Binford 1973; Higgs 1975), Clarke riassegna loro un
ruolo centrale nella ricerca paletnologica, quali unità organizzative di analisi
indispensabili per lo studio di sistemi che sono stati in passato operativi. Al pari
dei processualisti americani, considera la narrativa storica un pericolo
costantemente in agguato quando ci si appresta a veicolare i risultati archeologici,
in quanto viziata da una finalità apparente e fondata su probabilità complesse;
diversamente da Binford e da gran parte dei processualisti del Nuovo Continente,
però, non ritiene che l’archeologia debba essere totalmente sovrapponibile
all’antropologia, assegnando piuttosto a quella la dimensione temporale di questa
– e dell’etnologia. Nell’affermare che “l’archeologia è l’archeologia, è
l’archeologia”, Clarke invocava il riconoscimento della specificità di una
disciplina in termini di natura dei dati raccolti, di spiegazioni proposte, in scopi,
concetti e procedimenti archeologici (ibidem: 22); un decennio più tardi, con la
frammentazione dell’archeologia nelle molteplici “archeologie post-processuali”,
avvenne però l’opposto.
2.8 Le culture archeologiche nel post-processualismo
L’avvento delle cosiddette archeologie post-processuali ha fatto sì che la scala
dell’analisi andasse nuovamente spostandosi e, con essa, l’oggetto della ricerca
archeologica; prendendo come modello la scala delle inferenze di Hawkes (1954),
si può affermare che l’elemento comune tra le varie scuole post-processuali sia il
livello di analisi focalizzato sui gradini più alti di tale scala, quelli cioè legati al
superorganico; le idee di Weber, e in particolar modo la teoria secondo cui
l’ideologia e l’economia si influenzerebbero reciprocamente e costantemente
devono, in questo senso, aver giocato un ruolo importante nel processo di
allontanamento dalla visione materialista e da qualsiasi determinismo della
25
struttura nei confronti della sovrastruttura. I nuovi approcci alla spiegazione della
complessità sembravano, inoltre, incompatibili con il concetto di cultura
archeologica; la distinzione tra associazioni casuali e non-casuali, ha sollevato più
di una perplessità riguardo l’effettiva classificazione dei tratti culturali di una
determinata area geografica in unità discrete inquadrabili come culture
archeologiche: le associazioni casuali, sarebbero (Hodder e Orton 1976) il frutto
della scelta arbitraria di un punto di partenza, all’interno di una regione, sulla base
del quale cercare affinità e divergenze culturali nelle aree contigue, creando così
dei confini inattendibili quanto il concetto stesso di cultura archeologica. Renfrew
(1977: 94) ha addirittura proposto, sulla scorta di questa ipotesi, che le culture
archeologiche cessassero di ricoprire il ruolo di unità discrete di analisi nella
ricerca archeologica. Con ogni probabilità, i numerosi abusi legati all’utilizzo del
concetto di cultura archeologica devono anch’essi aver influito in maniera
decisiva sulla sua scomparsa dall’agenda di buona parte dell’archeologia post-
processuale; basterebbe pensare, ad esempio, a come le rivalità tra studiosi
possano portare ad un’elevata inflazione delle culture archeologiche individuate in
un territorio, come evidenziato dal numero delle culture dell’Età del Bronzo lungo
le steppe Eurasiatiche (Roberts e Vander Linden 2011: 5), o ancora, che persino
dietro alle pretese avanzate su territori contesi tra diversi gruppi etnici nell’ex
Unione Sovietica comparissero le culture archeologiche (Galaty e Watkinson
2004: 13). Per di più, da un punto di vista metodologico, un accumulo massivo di
dati può portare ad una formulazione apparentemente infinita di sottogruppi
culturali, come è avvenuto per le ceramiche della cultura Jomon in Giappone
(Habu 2004: 37). Ad ogni modo, le obiezioni di Hodder e Orton, così come quelle
di Renfrew, recavano con esse una domanda cruciale: le culture archeologiche
riscontrate empiricamente erano uno specchio attendibile dei mutamenti culturali?
Hodder tentò di rispondere a questa domanda in Symbols in Action (1982),
scaturito da uno studio etnoarcheologico nel distretto di Baringo, in Kenya; le
conclusioni a cui pervenne (ibidem: 185 e sgg.) rivelano un notevole scetticismo
sull’attendibilità del ricorso alla cultura materiale nella lettura del passato,
perlomeno in assenza di un approccio “emico” che tenga conto del ruolo attivo
che questa svolge all’interno delle società – e del singolo individuo -. La ricerca
26
etnoarcheologica, da questo momento in poi, verrà largamente utilizzata nel
dibattito sulla formazione dello stile, seguito sempre più frequentemente da
discussioni concernenti il ruolo delle persone nella costruzione e nell’utilizzo
della cultura materiale; questo ha indubbiamente favorito la sostituzione della
ricerca delle azioni individuali con il tentativo di contestualizzare i manufatti,
dando luogo a studi sulla trasmissione culturale e sull’agentività nel corso dei
quali vengono esplorati i processi nello stile formale, nella strutturazione spaziale
o in ogni altra forma di organizzazione materiale, al livello delle corrispondenti
azioni umane (e.g. Dobres e Robb 2000; Gamble 2001). In una recente intervista,
però, Hodder muove quella che è forse la sua critica più esplicita riguardo al
concetto e all’utilizzo tanto del termine “cultura” nella sua accezione olistica,
quanto delle singole culture archeologiche:
«Sono dell’opinione che cultura non sia un termine utile. Tende ad essere reificante e
pericoloso. Preferisco disgregarlo e parlare dei vari processi che lo costituiscono. In
archeologia è un termine molto, molto negativo. C’è un problema con la cultura,
specialmente nel contesto europeo, per via della tradizione storico-culturale. Anche al
giorno d’oggi, il modo in cui le persone rivendicano le culture come parte di processi
sociali contemporanei è, credo, molto preoccupante. Non vedo molti vantaggi nel
conservare il termine. (…) Se dovessi chiederti cosa intendi con “culturale”, risponderesti
probabilmente “relazioni semiotiche” o “relazioni fenomenologiche”. Per quale motivo
dovremmo avere bisogno della parola “culturale” come aggettivo di fronte a “categorie”?
Le variazioni ceramiche (…) sono il risultato di un intero range di processi differenti:
sociali, ed economici, e di ogni sorta. Hai effettivamente bisogno di estrapolare questi
processi e lavorarci su. E c’è, realmente, un continuum di variazioni in ciò. Il problema è
quando si tenta di sopprimerlo, e si dice “lo affronterò in una determinata maniera”,
perché come sappiamo, ogni genere di struttura categorica e tipologica è legata ad una
particolare prospettiva. Così, nel mondo contemporaneo, è preoccupante tentare di creare
gruppi culturali, perché questo è sempre legato a posizioni di interesse. Provare a definire
le culture nel passato è sempre, come sappiamo, parte di un tentativo che mira a ritrovare
le nostalgiche origini di qualcuno, o a creare un senso di continuità». (fonte:
http://ucexchange.uchicago.edu/)
27
Nel 1982 Flannery aveva previsto, nel suo The Golden Marshalltown, uno
scenario molto simile a quello tracciato da Hodder; il concetto di cultura cessava
di essere il tema unificante dell’archeologia, allegoricamente rappresentato dalla
trowel dell’Old Timer Archaeologist, rivestita d’oro dalla nuova generazione di
archeologi in occasione del pensionamento anticipato del suo proprietario, in
modo da renderla un pezzo da museo non più spendibile nella ricerca
archeologica.
Bisogna ad ogni modo tenere presente che il fenomeno post-processuale è un
fenomeno accademico (Shanks 2009), così come lo è stato quello processuale, ed
è bene soffermarsi su questo punto, se si vuole comprendere perché, tutto
sommato, si continui a fare riferimento alle culture archeologiche. Se si guarda
agli USA, le politiche di conservazione del patrimonio archeologico messe in atto
a partire dalla metà degli anni ’70 hanno portato ad un incremento degli
archeologi slegati dal mondo accademico, e inquadrabili nel Cultural Resources
Management (CRM); nel 2009, quest’ultima categoria costituiva il 90% degli
archeologi negli USA (Watson 2009). Si comprende, dunque, come si renda
difficile per gli archeologi CRM mantenere una partecipazione e una presenza
costante all’interno della comunità accademica dei non-CRM, e mantenere allo
stesso tempo gli impegni di lavoro sul campo, di laboratorio e di tutela e
valorizzazione del patrimonio archeologico. Il dibattito teorico sui massimi
sistemi dell’archeologia ha quindi visto un contributo minimo da parte della
categoria che, al momento, si occupa della gran parte del lavoro sul campo
nell’archeologia statunitense (ibidem, 32), e che resta purtroppo distante dal
mondo della ricerca per obbiettivi e approcci (Shanks 2009: 21). Un parallelismo
può essere tracciato guardando alla situazione italiana; la tutela preventiva e gli
scavi di emergenza sono stati affidati nel 1974 alle Soprintendenze
Archeologiche, e questo ha fatto sì che per le problematiche affrontate dagli
addetti ai lavori fossero di scarso aiuto tanto gli approcci funzionalistici, legati al
ruolo adattivo delle componenti dei sistemi culturali, quanto la ricerca delle
generalità dell’archeologia processuale o gli approcci cognitivi, strutturalisti o
agentivi propri del post-processualismo. Questo ha fatto sì che il concetto di
cultura archeologica non venisse definitivamente accantonato, ma il prezzo da
28
pagare è stato probabilmente una tendenza alla classificazione e allo studio
tipologico a discapito di una ricerca focalizzata alla natura, alle modalità e ai
meccanismi di mutamento culturale. A questo si aggiunga che in Italia, per varie
ragioni, il mondo accademico si è a lungo dimostrato impermeabile alle questioni
sollevate dall’archeologia processuale (Bietti Sestieri 2001), venendo così a
mancare l’elemento che più di ogni altro avrebbe potuto rinnovare l’approccio
storico-culturale e, con esso, il concetto di cultura archeologica.
2.9 Le culture archeologiche nella paletnologia sarda
Nelle considerazioni di Taramelli (1927) sulla genesi della “civiltà nuragica” e sui
rapporti tra questa e i “neolitici” si assiste ad una inaspettata interpretazione
evoluzionista; i termini “civiltà”, “razza” e “schiatta” ci informano, peraltro, che
sarebbe inutile cercare tra le righe il concetto di cultura archeologica basato sugli
assemblaggi e sulle associazioni ricorrenti. Le culture archeologiche sembrano
comparire in Sardegna a partire dai primi anni ’60, con le prime sintesi di ampio
respiro; prima di allora, nell’affrontare le evidenze materiali di quella che verrà
poi definita la cultura di Ozieri, si parlava genericamente di “civiltà Anghelu
Rùju-San Michele d’Ozieri” (Lilliu 1957: 42). Ancora nel 1958, Audibert parlava
di “style Ozieri I e II”, ma l’unità formale tra i materiali della grotta eponima e
quelli di altre località dell’Isola non andava oltre le analogie nella decorazione
ceramica; il riconoscimento di un’omogeneità culturale che comprendesse l’isola
intera era ancora lontano. Nel 1963 la cultura di Ozieri (alternativamente chiamata
“di San Michele”) compare in tre lavori, due dei quali di matrice anglosassone:
The Ozieri Culture in Sardinia (Warwick Bray), Sardinia (Margaret Guido) e La
civiltà dei Sardi di Giovanni Lilliu. In quest’ultima sintesi, la cultura di San
Michele assume per la prima volta la nota veste di «cultura basica o di fondo,
potremmo anche dire popolare. Essa costituisce l’orditura generale della civiltà
isolana dell’età del rame, quella per cui, nelle complicanze particolari di talune
aree specifiche, l’organismo culturale mediterraneo, in forme materiali e nel suo
29
abito etico, conserva, anche in Sardegna, la sua essenziale unità, il suo volto
caratteristico» (Lilliu 1963: 36).
«La classificazione progressiva delle culture paleosarde si basa ancora sul criterio della
comparazione dei resti che le costituiscono con elementi affini di aree di civiltà (iberiche,
centroeuropee, italiche, balcaniche ed orientali in specie) le quali mostrano di avere una
certa conclusione o stabilità cronologica. Criterio e strumenti incerti, per la verità, tenuto
conto che l’isola (...) ha avuto solo in alcuni periodi una certa circolazione culturale nel
circuito panmediterraneo ed europeo (…) Tuttavia, in attesa del meglio, non respingiamo
il metodo comparativo, con le riserve del caso, e fondiamo su questo anche il nostro
schema. In attesa e con l’augurio che, in sede internazionale, possa trovarsi e concordarsi
un modo di caratterizzare e distinguere le culture antiche fuori del principio della materia
di cui si compongono gli oggetti relativi (principio naturalistico sebbene ripreso
nell’alone della poesia di Lucrezio), su questo metodo classificatorio, in cui si trovano
però anche valori positivi (si pensi all’importanza rivoluzionaria della lega del bronzo e
del metallo del ferro nello sviluppo e nella trasformazione delle civiltà e delle società
umane), noi fondiamo ancora il profilo progressivo delle culture sarde prenuragiche e
nuragiche» (Lilliu 2003: 11).
Il primato del confronto tipologico sui metodi di datazione assoluta è
ribadito con l’affermazione che le tabelle di cronologia assoluta sono fornite “a
puro titolo di orientamento, [con la consapevolezza] che questa della
periodizzazione dei momenti culturali è quanto di più relativo possa esistere”
(ibidem: 14). Non deve sorprendere, inoltre, il richiamo ad un sistema alternativo
a quello delle Tre Età; da Lilliu in poi, la periodizzazione della Sardegna è sempre
stata costruita distinguendo in prima analisi tra età (Civiltà) Nuragica, e
Prenuragico (e relative culture).
Ercole Contu, in una delle rare teorizzazioni che la paletnologia sarda ha elaborato
intorno al concetto, stabilisce una dicotomia tra “cultura preistorica” e “Civiltà”,
escludendo l’opportunità di quest’ultimo termine tanto per le fasi preistoriche,
quanto per quelle protostoriche, in virtù del fatto che:
«con la Civiltà si precisano la specializzazione dei mestieri, un conseguente maggiore
progresso tecnico, una più diffusa produzione di beni ed un ampio commercio dei
30
medesimi, una elevata organizzazione civile. A tutto ciò consegue poi l’invenzione e
l’uso della scrittura, prima a scopi amministrativi e quindi per gli impieghi più disparati.
Non fa perciò meraviglia se gli antichi abitatori della Sardegna non useranno la scrittura,
che pure altrove era stata inventata alcuni millenni prima: e questo proprio perché mai si
raggiunse nell’isola il livello della Civiltà Urbana, dato che lo sviluppo si fermò al livello
del villaggio: le prime città sarde saranno quelle impiantate alcuni secoli dopo il 1000 av.
C. dai conquistatori fenicio-punici. Se quindi al termine di civiltà si dà il significato più
sopra indicato – ma non esiste accordo fra gli studiosi a questo riguardo – si vede che la
Preistoria e la Protostoria, con le pur splendide manifestazioni che le caratterizzano in
Sardegna, non possono includersi in questo termine. In questi casi, e con queste premesse
è perciò più esatto usare, invece di civiltà, un termine che da tempo gli studiosi
dell’archeologia preistorica hanno mutuato dagli studiosi dei popoli primitivi attuali
(etnologi): il termine di cultura o, nel caso specifico, di cultura preistorica. E così, come si
parla per l’Africa attuale di Cultura Boscimana, si può parlare per esempio, per la
Sardegna preistorica, di Cultura di Bonnànnaro. . . . Cultura, in questa accezione del
termine, significa quindi la somma di tutti i dati materiali e spirituali che caratterizzano
un determinato gruppo umano, in un determinato tempo e con una determinata
collocazione geografica» (Contu 2006: 13-14; corsivi aggiunti).
Ci si aspetterebbe, dunque, la comparsa dell’espressione “cultura Nuragica” ad
indicare la fase protostorica dell’Isola; in realtà, verrà comunque adottata la
denominazione di Civiltà Nuragica (ibidem: 443 e sgg.), alternandogli
arbitrariamente il termine “cultura”, dando luogo ad alcune contraddizioni anche
all’interno di una stessa frase (ibidem: 778; vedi anche 16, fig.1; cfr. Sirigu 2012).
Un’altra riflessione sul concetto di cultura archeologica la troviamo in
Trump (1983: 37), che fa sostanzialmente coincidere ogni cultura con una fase
cronologica, in una successione esclusivamente verticale; il motivo è che,
indagando un’area ridotta come quella della grotta di Filiestru, le differenze
riscontrabili nella cultura materiale erano realmente imputabili a diversi orizzonti
temporali, ma la corrispondenza tra culture e fasi cronologiche continua
comunque a marcare l’intera preistoria della Sardegna. Così, il fenomeno dei
“Circoli di Arzachena” viene risolto nella sua assimilazione all’interno della
cultura di Ozieri (Contu 2006), oppure all’interno del precedente quadro culturale
di San Ciriaco (Ugas 1990; Ferrarese Ceruti 1995; Antona 2003). Più ambigua la
31
posizione di Lilliu, che lo interpreta ora come facies della fase Ozieri (2003: 12),
ora come cultura autonoma competitiva con l’Ozieri (ibidem: 80). Nessun
accenno al San Ciriaco, ma quando si fa riferimento al Bonu Ighinu come
all’«aspetto culturale più trasparente del Neolitico medio sardo» (ibidem: 46) si
deve evidentemente pensare che Lilliu non considerasse il San Ciriaco
sufficientemente “trasparente” da assumere né la valenza di cultura archeologica
autonoma, né quella di facies ceramica distinta dal Bonu Ighinu o dall’Ozieri
classici. Contu, d’altra parte, la liquida rapidamente come una facies locale
dell’Ozieri (2006: 103). Sirigu (2009: 49) definisce le facies come «insiemi di
reperti che paiono tra loro legati da un certo “feeling culturale” pur senza aver
forse raggiunto la coerenza e la complessità che caratterizza le culture vere e
proprie», aggiungendo poi che «tra gli studiosi si sta però sempre più affermando
la convinzione che sia più corretto attribuire la valenza di cultura anche
all’insieme di evidenze materiali ascrivibili all’orizzonte San Ciriaco»; la valenza
di facies gli viene comunque preferita nel proseguo del lavoro (ibidem). Ugas, che
nella sua monografia L’alba dei Nuraghi (2005) recupera addirittura il metodo
etnostorico-culturale (ibidem: 24-34; cfr. Lilliu 1963: 9-10), parla di facies
archeologica tardo-neolitica di San Ciriaco (ibidem: 13); non è chiara la
distinzione che l’Autore opera tra facies archeologica e cultura archeologica, ma
se si considera la prima nell’accezione datale da Cocchi Genick (2005: 8), la sua
applicazione stride con la descrizione data del fenomeno San Ciriaco (Ugas 2005:
13-14). Viene invece denominata “cultura di San Ciriaco” in Usai 2009, mentre
Tanda (2009) la considera un momento iniziale della cultura di Ozieri, precedente
alla cosiddetta fase “classica”.
In questo quadro sembra di percepire una sovrapposizione, più o meno
critica, dei concetti di cultura archeologica, facies archeologica e fase cronologica;
un esempio di questa tendenza lo ritroviamo anche in Moravetti (2002: Tab. 1),
che fa riferimento alla “cultura di Perfugas” nonostante la definizione di cultura
proposta poco oltre2 non sia in nessun modo applicabile alle evidenze di Perfugas
2 Con il termine cultura l’archeologia (...) indica l’insieme delle forme di organizzazione di una
società, le sue tecniche produttive, la sua economia, la sua religione, i suoi costumi e le sue
«idee», intendendo però che esse – per una serie di limiti, primo fra tutti l’ignoranza della
32
(e.g. Martini e Pitzalis: 1981). Il San Ciriaco viene, invece, considerato una
“facies di raccordo tra il Neolitico medio e quello recente” (ibidem: 17);
quest’ultima lettura è evidentemente mutuata da Santoni (e.g. 1982a/b; Santoni et
al. 1997), e la ritroviamo in Dyson e Rowland (2007: 19), ben oltre i confini
isolani.
Appare chiaro come la questione del San Ciriaco meriti di essere approfondita;
nelle discordanze in merito alla sua interpretazione (considerando come una
precisa interpretazione anche il silenzio di alcuni Autori) sembra infatti di
scorgere un importante indicatore delle modalità con cui il concetto di cultura
archeologica è stato recepito e interpretato dalla ricerca paletnologica sarda.
scrittura – non sono state in grado di evolversi in forme superiori, capaci non solo di espandersi
ma anche di conquistare le comunità vicine (Moravetti 2002: 16).
33
3 La cultura di San Ciriaco
3.1 Storia degli studi
Attorno alla metà degli anni ’70 del secolo scorso, le conoscenze sul
Neolitico della Sardegna erano assai lacunose e frammentarie; si teorizzava una
generica collocazione al IV millennio a.C. per l’arrivo dei primi gruppi umani
nell’Isola (Lilliu 1975: 15), e un momento finale intorno al 2000 a.C., coincidente
con l’inizio dell’Età del Rame. Tra questi due estremi, si distinguevano una fase a
ceramiche impresse, corrispondente al Neolitico Antico, e un Neolitico recente
caratterizzato da ceramiche di derivazione chasseana e con influssi di stile
Bougon, premessa della seriore cultura Ozieri individuata allora come una delle
tre culture del Calcolitico (ibidem); si attribuivano ad una fase intermedia vasi di
argilla figulina bianca, dipinti di rosso (red on white) che presentavano analogie
con alcuni contesti del Neolitico di Ripoli e dell’Italia meridionale (Alba 1976)3.
Una più corretta periodizzazione del Neolitico sardo si è resa possibile in
seguito alle indagini di R. Loria e D. H. Trump nelle grotte di Filiestru (Loria,
Trump 1978) e di Sa Ucca ’e su Tintirriolu (Trump 1983) le quali hanno restituito
le prime stratigrafie attendibili pertinenti al Neolitico sardo, chiarendo alcuni
rapporti di cronologia relativa tra le diverse fasi di occupazione - anche in virtù
della contestuale enucleazione della fase medio-neolitica di Bonu Ighinu - e
fornendo per esse una serie di datazioni radiocarboniche che ne hanno precisato la
collocazione in cronologia assoluta.
Nel 1982, V. Santoni rende noto, mediante una nota preliminare di scavo,
un «inedito aspetto culturale a carattere abitativo» individuato nel sito di
Cuccuru is Arrius nel corso delle campagne di scavo degli anni immediatamente
precedenti; il nuovo orizzonte neolitico, denominato “ facies di Cuccuru s’Arriu”,
viene considerato già allora un possibile raccordo tra le fasi Bonu Ighinu e Ozieri
in virtù della giacitura stratigrafica dei materiali ad esso attribuiti. Santoni
3 La collocazione cronologica si è poi rivelata corretta in termini assoluti, ma errata in cronologia
relativa, in quanto tali ceramiche sono inquadrabili in un momento successivo alla fase Ozieri.
34
riconosce inoltre l’affinità tra questo complesso ceramico e alcuni frammenti fittili
rinvenuti nel 1973 a Terralba in seguito ad alcuni interventi edilizi nel quartiere di
San Ciriaco, e già descritti da C. Puxeddu nella sua sintesi sul territorio della
diocesi di Ales-Usellus-Terralba (Puxeddu 1975: 83); questa affinità formale
porterà G. Ugas a rinominare la fase in esame come “facies di San Ciriaco di
Terralba-Cuccuru s’Arriu” (Ugas 1990), indicata più semplicemente come “San
Ciriaco” a partire dalle successive pubblicazioni sul tema.
3.2 Inquadramento cronologico
Già a partire dalla prima individuazione di un aspetto inedito e distinto all’interno
del quadro neolitico isolano (Santoni 1982/b), apparve chiaro come questo potesse
costituire un momento di raccordo tra il quadro Bonu Ighinu e quello Ozieri, sia in
virtù dei rapporti stratigrafici, sia dalla semplice analisi comparativa dei materiali.
Nei siti in cui si è potuto disporre di stratigrafie attendibili, la successione Bonu
Ighinu – San Ciriaco – Ozieri è stata sistematicamente riscontrata, confermando
così le prime ipotesi sulla collocazione del San Ciriaco in cronologia relativa; il
limite cronologico superiore della fase Bonu Ighinu (4300 B.C.) e quello inferiore
dell’Ozieri (4000 B.C.) (Tykot 1994) costituiscono dunque un range - per quanto
indicativo e suscettibile di eventuali precoci comparse del fenomeno o
attardamenti nella fase successiva – utile a stabilirne la durata. L’unica datazione
radiometrica al momento disponibile per il San Ciriaco riporta peraltro al 5423 ±
47 BP (Boschian et al. 2001), coerentemente con le datazioni in cronologia non
calibrata che attesterebbero la fase in esame tra il 3400 e il 3200 a.C. (Ugas 2005:
12). Nel quadro dell’articolazione in fasi del Neolitico sardo, il San Ciriaco è stato
inizialmente considerato un fenomeno inquadrabile nel Neolitico Superiore
(Santoni 1982/b; Santoni et al. 1997) o Neolitico Recente (Ugas 1990; 2005); con
il prosieguo della ricerca, una sua collocazione in una fase tarda del Neolitico
Medio (Usai 2009; Lugliè 2009) appare, forse, maggiormente convincente.
35
3.3 Distribuzione geografica e modalità insediative
Da una analisi della distribuzione delle evidenze a carattere abitativo pertinenti
alla fase San Ciriaco, si contano ad oggi 45 siti editi ed inquadrabili in detta fase;
di questi, solo 16 sono stati sottoposti ad indagini di scavo (~35%), sebbene in
alcuni casi si disponga per essi di dati desueti e talvolta privi di informazioni
stratigrafiche attendibili, essendo stati indagati in momenti storici in cui le
procedure di scavo e documentazione non sfociavano, se non di rado, in registri
archeologici che possano considerarsi tutt’ora fonte di nuovi contributi alla ricerca
paletnologica4. Pur non restituendo informazioni sulla reale sovrapposizione delle
fasi abitative e sulla natura dei siti, questi risultano comunque validi al momento
di delineare un quadro generale della distribuzione insediativa dei gruppi umani
durante la fase in esame. Un primo dato emergente è quello del predominio degli
insediamenti all’aperto rispetto a quelli in grotta, i quali sono comunque
rappresentati, specie in area sulcitana e nel Sassarese; per quanto attiene alle
stazioni all’aperto, le strategie insediative vertono verso un’intensa occupazione
delle aree planiziali e sub-costiere, come si evince dall’alta concentrazione di
villaggi che interessano l’intera area del Campidano (almeno 17 siti), e i litorali, o
il loro prossimo retroterra, del Sulcis-Iglesiente, dell’Oristanese e del Sassarese.
Lo sfruttamento opportunistico di tutte le nicchie ecologiche disponibili da parte
dei gruppi umani di fase San Ciriaco, lascia peraltro supporre che la quasi totale
assenza di evidenze lungo il versante orientale dell’Isola5 possa essere almeno in
parte imputabile a lacune nella ricerca.
4 La descrizione degli scavi effettuati a Grotta Rureu nel 1952 , in Lilliu 1994, pp. 632-635, è
indicativa di come, da pubblicazioni tanto datate, sia difficile recuperare informazioni che vadano
oltre quelle relative alla mera analisi comparativa dei materiali. 5 Fatta eccezione per il sito a carattere funerario di Li Muri – Arzachena, è attestato un solo
insediamento situato sul versante orientale della Sardegna (Posada – Anfratto del Castello di
Posada), sul cui inquadramento nella fase San Ciriaco sono state peraltro espresse opinioni non
del tutto concordi (cfr. Fadda 2001; Usai 2009)
36
Fig. 1 – Distribuzione degli abitati di fase San Ciriaco
Circa la metà dei siti all’aperto, ad ogni modo, sono stati individuati a
partire da recuperi o prospezioni di superficie (si vedano ad es. Meloni 1993,
Marras 1994, Lugliè 1998) o, ancora, dal rinvenimento di elementi quali statuine
fittili o litiche perlopiù decontestualizzate, e ritenute cronologicamente
diagnostiche sulla base di seriazioni tipologiche non sempre sufficientemente
sorrette da dati certi (§ 1.4.4); la generica attribuzione di “fondi di capanne”
assegnata alla gran parte delle strutture infossate individuate nel corso delle
indagini archeologiche, inoltre, meriterebbe un’approfondita revisione critica, al
fine di verificare la reale distribuzione delle unità a carattere residenziale
all’interno dei siti, e di distinguere da esse eventuali altre strutture connesse con
37
differenti attività rispetto a quella prettamente abitativa (clay pits, siloi, fosse di
scarico, etc)6.
La frequentazione di grotte e ripari sotto roccia, nei casi in cui non vi siano
evidenze di usi funerari o rituali, potrebbe essere legata alla necessità di ripari
(stagionali?) per gli armenti, o di punti di appoggio per i gruppi umani che
integravano l’economia agricola con pratiche di caccia e raccolta.
3.4 La ceramica
Un quadro della produzione fittile pertinente alla fase in esame può, allo stato
attuale degli studi, essere tracciato in maniera sufficientemente esaustiva.
L’aspetto ceramico è, peraltro, l’elemento che per primo ha consentito
l’enucleazione di un orizzonte culturale a sé stante, e sebbene la ricerca
archeologica abbia messo in luce una notevole quantità di siti ad esso attribuibili,
continua ad essere il principale fossile guida, sia in virtù della sua specificità, sia
per via di una non sempre chiara diversificazione dei restanti aspetti della cultura
materiale di fase San Ciriaco rispetto ai contesti precedenti o successivi.
Il repertorio ceramico San Ciriaco non presenta numerose forme; le fogge
vascolari maggiormente documentate sembrano essere le ciotole carenate, nelle
varianti ad orlo estroflesso (tav. 1,1), a collo distinto (tav. 1,2) e a bassa carena e
parte superiore a pareti verticali (tav. 1,3; 1,4). Tra le altre forme aperte si
attestano le tazze e le scodelle, non sempre chiaramente distinguibili le une dalle
altre a causa della frequente frammentarietà dei reperti; nei casi in cui tale
distinzione si sia resa possibile, si sono potute documentare tazze a profilo
sinuoso (tav. 1,5; 1,7) e tazze carenate, con piccoli orli spesso estroflessi (tav. 1,8)
e, tra le scodelle, fogge cilindro-coniche (tav. 1,9) e tronco-coniche (Usai 2008).
Compaiono, specie nei siti dell’Oristanese (ma vi è l’attestazione di almeno un
esemplare a Filiestru) (Trump 1983: fig. 16,z) i mestoli a cucchiaio o attingitoi, a
6 Già in occasione degli scavi Chierici del 1873 si assiste ad una discussione tra studiosi quali Luigi
Pigorini, Carlo Boni e Arsenio Crespellani, sull’interpretazione funzionale dei cd. “fondi di
capanna”. In tempi più recenti, tra i lavori in cui ci si è confrontati sul tema, è opportuno citare,
tra gli altri, Radmilli 1967, Trump 1966, Barker 1973, Giannitrapani et al. 1989, Giannichedda
2002, Cattani 2009, Cavulli 2009.
38
vasca ellittica e muniti di una grande ansa nastriforme impostata sull’orlo e
sopraelevata (tav. 1,10). Alcuni frammenti sembrano essere pertinenti a forme
basse e molto larghe, forse spiane o tegami. Tra le forme basse figurano anche
piatti fittili quadrangolari, eretti su piedi parallelepipedi in alcuni casi rastremati.
Le forme chiuse comprendono olle globulari e ovoidi (tav. 1,11), anfore (Santoni
et al. 1997), vasi a collo - tra i quali un esemplare triansato da Bau Angius (Lugliè
2003: fig. 3) - e bicchieri, seppur documentati in misura minoritaria.
Gli impasti sono in genere fini, ben depurati, con inclusi di piccole
dimensioni laddove presenti; il ridotto spessore delle pareti e la loro accurata
lucidatura mediante lisciatura a stecca e brunitura sono anch’esse tra le
caratteristiche tecnologiche meglio note per quanto riguarda la fase in questione.
Nondimeno, è documentata una classe di fittili le cui caratteristiche tecnologiche
divergono, in parte, da quelle citate poc’anzi, in quanto gli impasti appaiono più
grossolani, meno depurati, con inclusi maggiori per dimensioni e numero, e le cui
superfici sono interessate da un trattamento più sommario. Le differenze di
lavorazione e di trattamento riscontrate tra i fittili possono essere imputabili alle
diverse destinazioni d’uso degli stessi, come suggerirebbe il dato di una maggiore
frequenza di forme aperte (scodelle, ciotole, tazze) tra le ceramiche più fini
(ibidem). Il colore delle superfici varia dal grigio-nero, al bruno, al rossastro,
caratterizzandosi talvolta per tonalità più chiare tendenti all’arancio, al camoscio o
al rosa.
Tra gli elementi di prensione sono attestate ansette ad anello (fig. 3, 4-6),
prese a listello verticale forato (Tav. 2, 7-8; tav. 3,1), ansette a gomito di profilo
trapezoidale, anse verticali a bastoncello che talora presentano motivi corniformi
all’estremità superiore (Tav. 2, 3), anse tubolari. Figurano altresì le prese a
bugnetta (Tav. 2, 1-2), sia nella variante emisferica, sia in quella forata e allungata
a linguetta che dà luogo ad uno pseudorocchetto; l’elemento di presa più
caratteristico del quadro materiale San Ciriaco è, ad ogni modo, l’ansa a rocchetto
pieno, documentata in diversi contesti (Ugas 1990: Tav. LXIII b; Meloni 1993:
Tav. III, 22) e nelle varianti stilizzata e insellata. Un elemento di innovazione
nella tettonica dei fittili è dato dalla comparsa dei fondi piatti distinti, già
eccezionalmente attestati in un contesto tardo (e, peraltro, a carattere funerario) di
39
Tav. 1 – forme ceramiche di fase San Ciriaco (da Usai 1998)
Cuccuru is Arrius, ma riscontrabili con maggiore frequenza in forme proprie del
repertorio San Ciriaco (Lugliè 2003: 729).
Le ceramiche si distinguono generalmente per la sobrietà nella
decorazione che, quando presente, è spesso limitata ad una linea orizzontale incisa
a crudo mediante l’utilizzo di una punta fine, tanto che l’uniformità delle superfici
è stata a lungo uno dei criteri di attribuzione dei fittili alla fase in esame (Ugas
1990); sono però attestati una serie di motivi decorativi ormai unanimemente
accettati come caratteristici della facies, quali il pointillèe entro triangoli ottenuti
40
ad impressione ed excisione, la decorazione a cerchi concentrici, a linee incise a
cotto e disposte ad andamento obliquo o radiale, a minute taccheggiature
impostate sull’orlo o a punzonature disposte per ordini paralleli; non è raro che
linee, tacche o punti siano interessate da incrostazioni di pasta bianca, con
particolare frequenza nell’area dell’Oristanese (Santoni et al. 1997: fig, 11,2;
11,3; 11,5; Tav. 3,10). Sono noti anche motivi a meandro realizzati mediante
incisione a crudo, specie in ambito sulcitano (Tav. 4.1,3; Ferrarese Ceruti 1995:
fig. 5).
Tra i materiali ceramici sono inoltre presenti le fusaiole, lenticolari o del
tipo biconico e talvolta decorate su una sola o su ambo le facce con segmenti
rettilinei o file di minute tacchette triangolari disposte radialmente (Santoni et al.
1997, fig. 15. 11-12).
Tav. 2 – Elementi di prensione nelle ceramiche San Ciriaco (da Lugliè 2003)
41
Tav. 3 – Elementi di prensione nelle ceramiche San Ciriaco (da Lugliè 2003)
Tav. 4 – Ceramiche decorate da Grotta S. Giovanni – Domusnovas (1) (Atzeni 1987), Cuccuru
s’Arriu – Cabras (2) (Santoni 2012), Grotta della Campana – Carbonia (3) (Perra 2008), Posada –
Anfratto del Castello (4) (Fadda 2001)
42
3.5 L’industria litica
Le conoscenze sulla produzione di strumenti litici durante la fase San
Ciriaco appaiono, allo stato attuale degli studi, piuttosto scarse; il deficit di
informazioni a riguardo potrebbe essere imputabile all’esiguità di contesti puri
pertinenti alla fase in esame, tra quelli sottoposti ad indagini sistematiche, il che
rende difficoltosa l’individuazione di eventuali peculiarità relative ai complessi
industriali.
I siti indagati stratigraficamente dai quali provengono strumenti litici associati a
ceramica di tipo San Ciriaco sono al momento Contraguda, Torre Foghe, Cuccuru
s’Arriu.
Per quanto riguarda il sito di Contraguda, l’industria litica in esame è riferita allo
strato 4 – Area 4, che ha restituito ceramiche compatibili con il repertorio noto per
la fase San Ciriaco, e per il quale è inoltre disponibile una datazione
radiocarbonica che riporta al 5423 ± 47 BC. La selce locale è la materia
predominante, a fronte di un 2,5% costituito da ossidiana; i manufatti ritoccati
sono principalmente di dimensioni piccole e medio-piccole, con una tendenza
generalizzata alla laminarità che caratterizza marcatamente il complesso dal punto
di vista tipometrico (Boschian et al. 2001). Sul piano dell’analisi tipologica,
l’industria litica di Contraguda è caratterizzata dalla prevalenza dei gruppi del
Substrato (con alti indici di raschiatoi corti e denticolati) e da un ritocco quasi
sempre periferico e parziale (ibidem: 283).
Interamente su ossidiana, invece, l’industria litica della sacca 380 di
Cuccuru s’Arriu, considerata inquadrabile integralmente, a pieno titolo,
nell’orizzonte culturale San Ciriaco (Santoni et al. 1997: 239). Da un’analisi della
materia prima utilizzata, è emerso come le differenti qualità dell’ossidiana
abbiano portato ad altrettante differenze nelle chaînes di débitage documentate;
se, infatti, si attestano produzioni laminari intenzionali e specializzate su nuclei a
grana fine, con una marcata trasformazione del supporto di base mediante ritocco
radente, invadente o coprente, si riscontra altresì un débitage laminare
opportunista e meno accurato su nuclei in ossidiana granulosa, forse più
propriamente “adatta ai bisogni funzionali degli occupanti la sacca” (ibidem:
289). Oltre alle lame sono ben rappresentate le schegge, che non sempre
43
manifestano una chiara volontà di fabbricazione, ma testimoniano comunque un
sistema di gestione degli scarti di lavorazione che venivano impiegati
opportunisticamente, come si evince dalle tracce d’uso presenti su di esse. Quattro
percussori in calcare rinvenuti all’interno della sacca testimonierebbero un
débitage locale messo in atto mediante percussione diretta, ma alcune lame
presentano incidenti di scheggiatura tipiche della tecnica della percussione
indiretta; non vi è invece attestazione di prodotti laminari ottenuti per pressione.
Analoghe tecniche di scheggiatura (percussione diretta e indiretta, assenza di
prodotti ottenuti per pressione) sono attestate nel sito neolitico di Torre Foghe; il
complesso litico, proveniente da un paleosuolo in cui comparivano associati
alcuni vasi completi, è costituito da fonoliti (10%), da selce idrotermale (10%) e
da ossidiana (80%) (Dini 2007). L’industria in fonolite non sembra essere
altamente specializzata, ed è composta da strumenti di grosse dimensioni quali
Fig. 2 – particolare dell’area di scavo e vasi San Ciriaco dal sito di Torre Foghe – Tresnuraghes
(fonte: http://interreg.humnet.unipi.it/)
“picconi” a ritocco bifacciale e anelloni per bastoni da scavo, oltre che da
elementi del Substrato, numericamente preponderanti; l’industria in selce è
costituita da 133 blocchi non ritoccati, 8 nuclei e 42 strumenti, con buone
percentuali di raschiatoi, denticolati e scagliati (ibidem). Per quanto attiene
all’industria in ossidiana, emerge il dato dell’assenza di nuclei e di prodotti
ottenuti mediante scheggiatura avanzata e controllata; i manufatti sono infatti il
44
risultato delle prime fasi di lavorazione dei nuclei, nelle quali avviene la
preparazione del débitage. Una possibile spiegazione è quella che vedrebbe
nell’insediamento di Torre Foghe un sito di importazione (quasi esclusivamente
dalla sorgente SC, con due soli frammenti provenienti dalla sorgente SB2 e
altrettanti dalla sorgente SA) (De Francesco, Bocci, 2007), e di lavorazione dei
blocchi naturali o appena testati, i quali dopo una prima messa in forma che li
preparava al pieno débitage sarebbero stati immessi nel circuito di distribuzione
dell’ossidiana sarda (Dini 2007).
Fig. 3 – differenti qualità di ossidiana e refitting di un blocco originario da Torre Foghe –
Tresnuraghes (fonte: http://interreg.humnet.unipi.it/)
45
3.6 La piccola statuaria
Il fenomeno della piccola statuaria antropomorfa preistorica sembra essere,
in Sardegna, una prerogativa neolitica (che perdurerà comunque fino al primo
eneolitico delle fasi Filigosa e Abealzu), la cui unica eccezione potrebbe essere
costituita dall’esemplare di S’Adde – Macomer, per il quale sono state proposte
datazioni che oscillano dal Neolitico Antico (Lilliu 1999) fino a quella, ben più
problematica, del Paleolitico superiore (Mussi 2009). Nel Neolitico Medio ha
avvio la produzione di statuine in stile volumetrico, realizzate a tutto tondo, con
un’accentuazione delle forme dei glutei e dei seni che lascia pochi dubbi sulla
natura femminile delle stesse; la resa volumetrica e naturalistica verrà poi
gradualmente superata in favore di uno stile definito geometrico (Atzeni 1978) o
planare (Lilliu 1999), proprio del Neolitico Finale, e marcato dalla stilizzazione
delle forme umane, ancora riconoscibili come proprie del genere femminile, ma
prive delle caratteristiche volumetrie della fase precedente.
Alla fase S. Ciriaco vengono attualmente attribuiti, per ragioni quasi
essenzialmente stilistiche, alcuni esemplari che sembrano rientrare in un filone
intermedio tra lo stile volumetrico e quello geometrico – planare; la
denominazione di “folded arms figurines”, già utilizzata per designare un tipo di
produzione plastica di matrice cicladica, può a buon diritto essere estesa alle
statuine sarde di cui sopra, per via della comune rappresentazione delle braccia
conserte poggianti sul ventre o sul petto (Paglietti 2008). L’attribuzione di questa
tipologia statuaria alla fase in esame scaturisce, in prima analisi, dal ritrovamento
di un frammento di statuina fittile avvenuto nel corso degli scavi nel sito di San
Ciriaco – Terralba (Santoni et al. 1997: 247); l’esemplare manca del capo e del
tratto inferiore del corpo, ma dalla porzione pervenutaci si distinguono le braccia
piegate a gomito, le mani accostate a confronto e provviste di dita rese
graficamente “a frangia”, con i pollici eretti che poggiano sui seni - elemento,
quest’ultimo, che conferisce alla statuina una chiara connotazione femminile -. La
sua collocazione in ambito San Ciriaco si deve all’associazione con alcuni
elementi pertinenti alla suddetta fase, per i quali, peraltro, si dispone di un mero
quadro esemplificativo, mancando attualmente un’edizione dell’intero intervento
di scavo (ibidem: 242).
46
Partendo dalla statuina di San Ciriaco – Terralba, e postulando per essa un quadro
cronologico di appartenenza all’omonima fase per i motivi sopra citati, sono state
individuate alcune analogie con altri esemplari già attribuiti a fasi precedenti o
successive; le braccia conserte o ripiegate a gomito su statuine di tipo
volumetrico, in particolare, sembrano costituire un raccordo tra i primi esemplari
di statuaria a tutto tondo, nei quali le braccia sono impostate lungo i fianchi, e lo
stile c.d. planare in cui gli arti superiori, privi di volume, sono disposti in modo da
formare una linea perpendicolare all’asse testa-corpo (con gli arti inferiori quasi
mai indicati) con una tendenza che sfocerà negli esiti geometrici e svuotati di ogni
naturalismo propri delle statuine a placchetta cruciforme.
Fig. 4 – statuina frammentaria da San Ciriaco – Terralba (da Santoni et al. 2007)
Un primo elemento di confronto può essere individuato nell’esemplare
proveniente da Su Cungiau de Marcu – Decimoputzu (fig. 5); si tratta di una
figura
47
Fig. 5 – Statuina in alabastro da Su Cungiau de Marcu – Decimoputzu (da Lilliu 1999)
antropomorfa assisa, femminile - come suggeriscono la resa plastica dei seni e
quella, ben più evidente, dei glutei -, scolpita in alabastro; le braccia sono
ripiegate all’altezza del gomito, le mani sono separate dagli avambracci mediante
un leggero solco e si toccano tra esse, poggiando sul ventre. Proprio nella
posizione delle mani in contatto tra esse, nella resa c.d. “a frangia” o “a pettine”
delle dita, e nell’indicazione dei pollici eretti che poggiano sui seni7, stanno le
analogie formali con la statuina frammentaria di San Ciriaco; pur limitate alla sola
porzione pervenutaci, quella del busto, suggeriscono una comune volontà di
rappresentazione, e fanno ipotizzare che si sia attinto da un medesimo modello di
riferimento, i cui esiti convergono pienamente sul piano formale anche quando vi
sono importanti differenze nella materia utilizzata (nella fattispecie pietra e
terracotta). Un’ulteriore conferma, in questo senso, è offerta da tre statuine
realizzate in osso e provenienti dalla grotta di Monte Meana – Santadi (fig. 6);
non è chiaro se, in questo caso, siano state le volumetrie ad essere ridimensionate
dal supporto osseo o se, al contrario, vi fosse sin dal principio la precisa
intenzione di realizzare delle figure che, per quanto ancora tridimensionali nella
7 Non di questo avviso Lilliu (1999) che interpreta i segni curvilinei all’altezza dei seni come
un’indicazione grafica degli stessi.
48
resa finale, sono marcate da un geometrismo e da una stilizzazione che sembra
una premessa del seriore stile geometrico – planare.
Fig. 6 – Statuine in osso dalla grotta di Monte Meana – Santadi (da Lilliu 1999)
Due delle tre statuine sono pressoché integre e raffigurate in posizione stante; una
sola ci è pervenuta mutila della parte inferiore del corpo, fatta eccezione per una
piccola porzione del gluteo e della coscia sinistri, accentuati però al punto da far
supporre la posizione seduta; non vi è accenno di seni, ma la femminilità è
comunque palese nel risalto conferito al triangolo pubico, ancor più che nella pur
evidente steatopigia. A parte le ipotetiche differenze posturali e alcune varianti nel
trattamento del volto, le tre statuine presentano una notevole affinità formale tra
esse, tanto nella rotondità dei glutei a cui fa da contrasto la sottigliezza del busto,
quanto nella resa del capo cilindrico e, in particolar modo, nella scelta di
rappresentare ancora una volta le braccia come piegate all’altezza del gomito e
convergenti sul ventre; se in due di esse si possono apprezzare delle linee incise
ad indicare le dita delle mani, una ne è invece sprovvista, e presenta un unico
blocco perpendicolare all’asse capo – busto – gambe, comprendente avambracci e
mani che si incontrano senza che possano essere distinte l’una dall’altra. La
medesima soluzione è stata adottata per altre due statuine, una fittile proveniente
da Conca Illonis – Cabras e pervenutaci acefala (fig.7), e una litica da Cotte ’e
Baccasa – Segariu (fig. 8) (Paglietti 2008); si tratta in entrambi i casi di statuine
49
probabilmente femminili8, assise, realizzate a tutto tondo e marcatamente
steatopigiche, le cui braccia sono piegate fino a congiungersi all’altezza del ventre
senza alcun elemento che indichi lo stacco dei polsi o le dita. L’estrema
stilizzazione delle estremità superiori contrasta in entrambi gli esemplari con il
trattamento dei piedi, solcati da linee incise ad indicare le dita; manca inoltre
qualsiasi elemento plastico o grafico che indichi i seni.
Una statuina fittile da Sant’Antioco di Bisarcio – Ozieri, pur essendo danneggiata
e forse non finita, sembra presentare analoga impostazione assisa e a braccia
conserte e portate sul ventre. Da Gribaia – Nurachi, infine, proviene una statuina
frammentaria in argilla (fig. 9), associata a ceramiche di tipo San Ciriaco (Soro
2012), della quale si conserva solo la parte relativa al busto; le braccia, visibili sia
sulla parte anteriore che su quella posteriore, sono rese mediante incisione e si
congiungono all’altezza del ventre. L’assenza di attributi femminili lascia aperta
l’ipotesi di una raffigurazione maschile o asessuata.
L’interpretazione di queste statuine resta problematica, e il fatto che buona
parte di esse provenga da recuperi asistematici porta inevitabilmente a dover fare
a meno del dato fondamentale relativo all’originario contesto di provenienza; un
loro legame con un presunto culto della Dea Madre, peraltro, è stato a lungo un
assioma della paletnologia sarda, per quanto si debba invece constatare l’assenza
di elementi in grado di corroborare tale ipotesi . Per tale motivo andrebbero forse
sottoposte a verifiche le proposte interpretative relative al culto legato ad una Dea
Madre ovvero ad una dea della fertilità, il suo supposto legame con una divinità
maschile individuata perlopiù in un paredro dalle fattezze taurine (Ugas 2005: 14),
e la stessa generica denominazione di “idoletti” relativa alle statuine .
8 Le proporzioni dei fianchi e dei glutei nelle statuine assise non sono necessariamente indicative
del sesso delle stesse, come fa notare Ucko (1962, p. 42): “It cannot be finally decided whether
these sexless figurines represent males, females or immature children (or something more
abstract like humanity) (…) the secondary sexual female characteristic – swelling of the hips –
does not give the answer to this question, for the proportion of the hips to the waist of the sitting
males is larger than that of the females; while the proportion is reversed between the standing
males and the standing females”.
51
Fig. 8 – statuina da Cotte ‘e Baccasa – Segariu (da Paglietti 2008)
Fig. 9 – Statuina fittile frammentaria da Gribaia – Nurachi (da Soro 2012)
52
3.7 La produzione vascolare in pietra
L’analisi comparativa con le forme ceramiche e i motivi decorativi ha
portato alla collocazione in ambito San Ciriaco di una serie di recipienti litici
precedentemente attribuiti a differenti fasi; si tratta, nella maggior parte dei casi,
di manufatti provenienti da contesti la cui carenza di dati rende difficoltoso un
loro puntuale inquadramento cronologico – culturale, che dovrà dunque essere
sviluppato su base tipologica.
La coppetta in steatite proveniente dalla tomba a circolo n. 1 di Li Muri è
stata ascritta (Santoni et al. 1997; Antona 2003) alla fase San Ciriaco per ragioni
essenzialmente stilistiche, in virtù delle anse a rocchetto pieno, della forma a
sezione bitroncoconica e del profilo a bassa carena, caratteristiche riscontrabili in
esemplari fittili attribuiti alla fase in esame e considerati ormai diagnostici della
stessa. Una singola presa a rocchetto pieno compare anche in una coppa carenata
in calcite, di forma emisferica e a colletto rientrante, proveniente da un’ipogeo di
Bingia ’Eccia – Dolianova (Fig. 10, a sinistra), le cui analogie con l’esemplare di
Li Muri possono essere individuate, oltre che nell’elemento di prensione, nelle
tracce di ocra rossa ancora visibili sulla superficie. Alcuni vaghi di collana in
clorite, rimasti inglobati nell’incrostazione di ocra rossa (Antona 1998: fig. 15.4
B), erano con ogni probabilità parte del corredo insieme ad un piatto tetrapode in
calcare, che presenta una protome zoomorfa presumibilmente taurina, se si
interpretano come corna gli elementi stondati che sovrastano il muso (Fig. 10, a
destra). La protome taurina, ottenuta mediante analoghe soluzioni stilistiche, la si
ritrova in un piatto proveniente da Ludosu – Riola Sardo (Lilliu 1999: fig. 96 A)
ricavato da un blocco di marna arenacea; il solo piede pervenutoci, tra quelli che
elevavano il piatto, riproduce il muso dell’animale nella parte funzionale
terminante con un taglio netto, ed è sormontato da due appendici stondate e
divergenti, che dovevano verosimilmente essere finalizzate alla presa, simulanti le
corna dell’animale.
53
Fig. 10 – vasi in pietra dall’ipogeo di Bingia Eccia – Dolianova (da Lilliu 1999)
Tra i recipienti litici che vengono attribuiti al quadro San Ciriaco (Ferrarese Ceruti
1995) figura inoltre un piatto in clorite da Locòe – Orgosolo a orlo lievemente
estroflesso distinto dal fondo per via di una marcata incisione perimetrale (Lilliu
1999); l’ornato interessa tanto l’interno quanto l’esterno del piatto, e si esplicita in
una trama composta da decorazioni spiraliformi racchiuse entro spazi delimitati da
motivi a V, i cui vertici sono rivolti verso il centro del recipiente. Tre linee
concentriche segnano la divisione della vasca dall’orlo, interessato anch’esso da
sporadiche incisioni a V. Il piatto viene ascritto alla fase in esame (Ferrarese
Ceruti 1995; Santoni et al. 1997 ) in virtù dei motivi decorativi
Fig 11 – Coppetta in steatite da Li Muri - Arzachena
54
Fig. 12 – Piatto in clorite da Locòe – Orgosolo (da Lilliu 1999)
spiraliformi ottenuti con una tecnica che rimanda all’excisione realizzata, con
simili esiti ornamentali, su recipienti fittili quali ad es. l’olletta biconica della
sacca San Ciriaco C.S.A. 392/1979 di Cuccuru s’Arriu (Tav. 4,2) o sul vaso a
collo distinto proveniente dalla Grotta di San Giovani – Domusnovas – (Tav. 4,1).
3.8 Contesti funerari
Da un esame dei contesti funerari ascrivibili alla fase San Ciriaco, o per
questa ipotizzabili, emerge un quadro generale affatto composito, all’interno del
quale si distinguono differenti tipologie di sepolture che rimandano ad altrettante
concezioni dei culti riservati ai defunti, degli spazi destinati alla morte e dei gradi
di separazione di questi rispetto alle aree residenziali.
Gli usi funerari durante la fase San Ciriaco sembrerebbero contemplare
l’inumazione singola in fossa e la sepoltura in contesti submegalitici e ipogeici,
55
nonché in grotte naturali. La gran parte dei contesti funerari noti, presentano ad
ogni modo una serie di problematiche legate alla loro effettiva pertinenza alla fase
in esame; a Cuccuru s’Arriu - Cabras è documentato un corredo fittile “sottoposto
a una sacca San Michele di Ozieri, la n. 382, in un contesto presumibilmente
abitativo, cui è associata una inumazione terragna” (Santoni 1982/a: 80). Se,
nella fattispecie, le ceramiche e la loro giacitura stratigrafica sembrano costituire
un valido motivo di attribuzione al San Ciriaco per la sopracitata sepoltura, sono
invece documentati casi in cui la presenza di materiali di tale fase in contesti
funerari non sembra tuttavia essere sufficiente ad una collocazione degli stessi nel
quadro cronologico in esame. All’interno della Tomba dei Guerrieri di Sant’Iroxi
– Decimoputzu, i materiali San Ciriaco sono i più antichi tra quelli rinvenuti
durante lo scavo dell’ipogeo, ma la loro giacitura stratigrafica, che li vede
sovrapposti a ceramiche ed altri manufatti di fasi successive (San Michele di
Ozieri, Monteclaro, Campaniforme, Bonnannaro) potrebbe essere interpretata
come un’intrusione legata ad un prelievo di terra dal contiguo villaggio, al fine di
realizzare un battuto di pareggiamento pavimentale per un riutilizzo dell’ipogeo in
una fase successiva al suo primitivo impianto, che sarebbe dunque da attribuire
alla fase Ozieri (Ugas 1990). Ceramiche San Ciriaco, peraltro, sono state
rinvenute nei settori prossimi al dromos di accesso di un altro contesto funerario
ipogeico, quello della Tomba X di Santu Pedru – Alghero (Melis 2009); tali
materiali provengono da due strati sconvolti dall’azione di mezzi meccanici
(ibidem: 99), il che impedisce una puntuale ricostruzione delle fasi di
realizzazione e primo utilizzo della struttura ipogeica. Resta comunque il dato di
una presenza di gruppi umani che utilizzavano ceramiche di tipo San Ciriaco
nell’area contigua alla tomba, per quanto l’assenza di evidenze archeologiche di
tale fase nelle aree all’interno dell’ipogeo ponga ancora una volta dei limiti
all’ipotesi di una realizzazione ed utilizzo dello stesso durante fasi antecedenti
all’Ozieri.
Da un riesame dei materiali rinvenuti all’interno delle Tombe A e C della
necropoli a domus de janas di Anghelu Ruju, spiccano però alcuni frammenti
decorati a punzonatura o a triangoli incisi riempiti da un fitto puntinato (Levi
1936, fig. 7,2 e figg. 8,2;4;6), con esiti del tutto simili a quelli presenti su
56
ceramiche già inquadrate nel San Ciriaco e provenienti da Cuccuru is Arrius
(Santoni et al. 1997: fig. 11,1), a riprova di un probabile avvio di tale architettura
funeraria già a partire dalla fase in argomento; si spiegherebbe in tal senso anche
la presenza dei due vasi in calcite all’interno dell’ipogeo di Bingia Eccia -
Dolianova.
Per quanto attiene ai contesti megalitici, la necropoli di Li Muri è stata
attribuita alla fase San Ciriaco in ragione dei confronti tra la coppetta in steatite,
che costituiva parte del corredo in uno dei circoli tombali, e alcune forme
ceramiche particolarmente ricorrenti all’interno del repertorio noto per la fase (§
1.4.2); tra queste, una ciotola carenata proveniente dal dolmen di Motorra –
Dorgali – (Lilliu 1966: 13, fig. 4 (1)) complicherebbe ulteriormente il quadro
degli usi funerari concernenti il San Ciriaco. Continuerebbe, infine, l’uso - già
attestato per la precedente fase Bonu Ighinu – (Biagi 1980) del seppellimento in
grotta naturale, come suggerirebbero le ceramiche provenienti dai contesti
funerari di Grotta Verde e Grotta Rureu – Alghero – (Lilliu 1994; Santoni et al.
1997: 240).
Una tale varietà di usi funerari rende evidentemente problematico giungere
ad un denominatore comune in un quadro tanto diversificato per pratiche,
architetture e associazioni di materiali, e lascia intravvedere un’autonomia
“culturale” dei gruppi umani che mal si concilierebbe, dunque, con l’idea di
un’omogeneità sovrastrutturale su larga scala del fenomeno San Ciriaco.
57
4 Evoluzioni interne e apporti extrainsulari
4.1 La cultura di Bonu Ighinu
Le stratigrafie nelle quali è emersa una fase Bonu Ighinu sottostante ad una
San Ciriaco sono, al momento, quelle delle grotte di Sa ’Ucca de su Tintirriolu e
di Filiestru (Santoni et al. 1997: 237; Alba 1999: 37); da un riesame delle
materiali è infatti possibile riconoscere alcuni elementi tipici del San Ciriaco
(decorazione limitata a un solco lungo la circonferenza, fondi piatti, orli
estroversi), peraltro segnalati in alcuni casi come anomalie già dagli stessi Autori
(Loria e Trump 1978: 174; Trump et. al. 1983: 50), la giacitura stratigrafica dei
quali si collocherebbe proprio tra i livelli Bonu Ighinu e gli strati Ozieri. La
seriorità del San Ciriaco rispetto al Bonu Ighinu è comprovata, inoltre, dalle
datazioni radiocarboniche che attesterebbero la transizione attorno al 4300 a.C.
(Tykot 1994).
L’analisi della produzione ceramica consente di cogliere alcune importanti
differenze. Un primo elemento di discontinuità è dato dalla concezione delle
forme: nel Bonu Ighinu sembrano essere assenti le forme chiuse, per via delle
spalle, il cui profilo è sistematicamente concavo, facendo sì che il diametro
dell’orlo sia maggiore o uguale (con qualche eccezione) a quello della carena. Nel
San Ciriaco, viceversa, la spalla del vaso è sistematicamente convessa o sub-
rettilinea, molto raramente concava (e.g. Alba 1999: figg. 5,2-3-4-6). Le anse a
rocchetto, per quanto rare, sembrano essere esclusive delle produzioni San
Ciriaco, così come i fondi distinti; gli impasti e il trattamento delle superfici sono,
relativamente alle classi più fini, di ottima fattura in entrambi i casi. Non
sembrano essere attestati temi decorativi comuni, sebbene il motivo spiraliforme,
frequente nella decorazione vascolare del San Ciriaco, compaia già su una
raffigurazione fallica da Bau Angius attribuita al Bonu Ighinu (Lugliè 2008),
nonché su un pendaglietto in osso dalla Grotta Rifugio, considerata un sito
funerario utilizzato da “un gruppo umano in possesso della cultura Bonu Ighinu”
(Agosti et al. 1980: 119). I rituali funerari, peraltro, sono lungi dall’essere
58
uniformi; al caotico “ossario” di Grotta Rifugio si contrappongono, infatti,
l’ordine e la standardizzazione di rituali e architetture della necropoli a grotticelle
artificiali di Cuccuru is Arrius. Tra i materiali di corredo delle tombe ipogeiche, le
ceramiche possiedono sia tratti culturali di tradizione Bonu Ighinu, quali le pareti
svasate, sia tratti di tradizione San Ciriaco (la decorazione limitata al risalto della
carena, i fondi distinti), le statuine presentano i medesimi tratti di quelle attribuite
al San Ciriaco, eccezion fatta per le braccia disposte lungo i fianchi, i vaghi di
collana e l’ocra rossa compaiono tanto a Grotta Rifugio quanto a Li Muri; recenti
datazioni radiocarboniche effettuate sugli inumati delle tombe 385 e 387 di
Cuccuru is Arrius collocano la necropoli nel secondo quarto del V millennio, in
un momento, dunque, pienamente ascrivibile allo sviluppo del Bonu Ighinu (Sebis
et al. 2009: 500). L’ipogeismo funerario di Cuccuru is Arrìus non trova, ad ogni
modo, confronti nel quadro medio-neolitico sardo; a voler scartare, perché poco
convincenti, le ipotesi di un avvio dell’architettura funeraria a domus de janas già
a partire dal San Ciriaco, bisognerà attendere lo sviluppo della cultura di Ozieri
per assistere alla ricomparsa del fenomeno ipogeico, configurandosi in tal modo
una “zona d’ombra” corrispondente proprio al San Ciriaco.
Fig. 13 - a sinistra: ceramiche Bonu Ighinu (da Loria e Trump 1978); a destra: ceramiche San
Ciriaco (da Alba 1999)
60
4.2 La cultura di Ozieri
Le datazioni radiocarboniche note per la cultura di Ozieri mostrano uno
sviluppo di tale orizzonte culturale in un momento successivo alla fase Bonu
Ighinu, con uno hiatus cronologico che sarebbe dunque colmato dalla fase San
Ciriaco (Tykot 1994: 122); i rapporti stratigrafici a Sa’Ucca de su Tintirriolu,
Filiestru e Contraguda confermano peraltro questa sequenza, che è invece solo
ipotizzabile a Pabaranca (Usai 2005), Monte d’Accoddi (Tiné e Traverso 1992),
Grotta Verde (Lo Schiavo 1979) e Monte Majore (Foschi Nieddu 1987). Nell’area
abitativa di Cuccuru is Arrius, una sepoltura in fossa terragna con corredo di tipo
San Ciriaco sarebbe stata obliterata da una struttura abitativa di cultura Ozieri
(Santoni 1982a/b); nello stesso sito parrebbe inoltre di riconoscere una fase di
transizione esemplificata da alcune forme vascolari caratterizzate da elementi
comuni, quali il vaso a cestello realizzato “su impianto tecnologico San Ciriaco”
(Santoni et al. 1997: 229). Sull’origine del vaso a cestello, si è peraltro ipotizzato
che questa possa essere individuata in un’evoluzione della tazza troncoconica di
tradizione San Ciriaco (Falchi et al. 2009). Superando l’ormai generica
definizione di “momento di raccordo tra il quadro tra Bonu Ighinu e San
Michele”, il San Ciriaco può comunque aver costituito, nella sua fase finale, le
premesse formali, stilistiche e insediative della cultura di Ozieri; un importante
elemento di transizione è forse da ricercarsi nella ceramica pointillée del tipo
attestato a Cuccuru is Arrius (Santoni et al. 1997: fig. 11,1;4;7), Sa ’Ucca de su
Tintirriolu (Loria e Trump 1978: tav. XXI,4), Grotta Verde (Lo Schiavo 1985: fig.
4,9), Monte d’Accoddi (Tiné e Traverso 1992: tav. XXXIII a) e nella tomba III di
Anghelu Ruju (Levi 1952: fig. 8,6); il fatto che questa ceramica la si rinvenga
associata ora a elementi schiettamente San Ciriaco, ora a elementi di tradizione
più marcatamente Ozieri, farebbe pensare ad un tipo di decorazione di lunga
durata, o di durata sufficiente a coprire perlomeno una fase finale del San Ciriaco
e una fase inziale dell’Ozieri, spiegando così anche la sua presenza all’interno di
una struttura ipogeica complessa come quella di Anghelu Ruju. Nonostante questi
tratti ibridi, la specificità della cultura di Ozieri è ben riconoscibile e distinta dal
San Ciriaco nell’avvento di nuove forme ceramiche, quali lo stesso vaso a
cestello, la pisside, il vaso tripode; nei parossismi e cromatismi decorativi; nelle
61
anse a tunnel; nell’architettura funeraria pienamente orientata verso l’ipogeismo
articolato, monumentale, collettivo e distinto dalle aree di abitato; nella perdita di
naturalismo e volume delle figurine antropomorfe; nella comparsa delle grandi
lame in selce; nelle prime attestazioni della tecnologia metallurgica.
Fig. 15 - Vaso a cestello di cultura Ozieri (da Loria e Trump 1978)
62
4.3 La facies funeraria corso-gallurese
Il fenomeno gallurese dei circoli sub-megalitici a carattere funerario è stato
inquadrato come una cultura calcolitica (Lilliu 1963), neolitica (idem: 2003),
come una facies della cultura di Ozieri (Contu 2006), come un fenomeno corso-
gallurese (Antona 2003); limitatamente al suo aspetto più noto, quello della
necropoli di Li Muri – Arzachena, questa è stata considerata appartenente alla
cultura/facies di San Ciriaco (Ugas 2005), e facente parte “dell’orizzonte San
Ciriaco, privo di interferenze San Michele” (Santoni et al. 1997). Eppure, sono
proprio i tratti tipici del San Ciriaco, peraltro minoritari, a costituire una
“interferenza” rispetto ad un sostrato culturale differente. La coppetta litica rientra
formalmente nella tradizione San Ciriaco (bassa carena, spalla rientrante,
peduccio anulare), sebbene vi siano dei confronti convincenti con alcune
ceramiche di stile Diana, munite di anse a rocchetto pieno allungato con leggera
insellatura che si avvicinano all’esempio di Li Muri in misura anche maggiore
rispetto agli esemplari sardi. Le lame in selce potrebbero essere state importate,
come prodotto grezzo ovvero finito, in quanto non vi è attestazione di industrie
litiche su supporti laminari ottenuti per pressione durante la fase San Ciriaco (e.g.
Lugliè 2009; Guilbeau 2010; Melosu e Pinna 2012), e la materia prima parrebbe
essere, ad un’analisi macroscopica, differente da quella dei giacimenti
dell’Anglona9. L’architettura funeraria sub-megalitica del tipo osservabile a Li
Muri e a La Macciunitta trova, più che un confronto, una precisa corrispondenza
con i coffres corsi di Tivulaghju, Cozza Torta, Muchjastru, Monte Rotondo-
Poghjaredda e Vasculacciu (Tramoni et al. 2007), facenti a loro volta parte del
coevo quadro del Midi francese chasseano; esempi di sepoltura in cista litica sono
attestati per la facies di Montbolo, per il gruppo di Roquefort e per l’aspetto
meridionale dello Chasseén (Vaquer 1998). In Corsica le corrispondenze sono
però più puntuali: ritroviamo infatti i pomi sferoidali, i vaghi di collana in clorite,
e le asce litiche a Tivulaghju (Tramoni et al. 2007), Cardiccia e Monte Revincu
(Leandri et al. 2007). L’ocra rossa è attestata nei rituali di Cuccuru is Arrìus, e
ciottoli con tracce di ematite ocracea sono stati rinvenuti anche nel villaggio di
9 Come osservato da Ferrarese Ceruti (Tiné e Traverso 1992: 183)
63
San Ciriaco di Terralba; fuori dall’isola, la ritroviamo nel meridione in contesti
Serra d’Alto (e.g. Zambotti 1943: 27), nell’area padana alpina in contesti Vbq
(e.g. Pedrotti 2001; Bernabò Brea et al. 2006), ma i confronti potrebbero
teoricamente estendersi a qualsiasi area del pianeta (e.g. Binford 1963).
L’associazione dei circoli tombali e dei menhir è riscontrata in diversi siti della
Corsica meridionale (Tramoni et al. 2007: 251). In questa fase del neolitico medio
si assiste, inoltre, ad un intensificarsi dei contatti tra le due isole; lo testimoniano
l’ossidiana sarda, presente in Corsica anche in forma di blocchi grezzi o solo
parzialmente lavorati (ibidem: fig. 6), e le ceramiche rinvenute a Tivulaghju,
inquadrabili a tutti gli effetti come San Ciriaco. L’ipotesi della presenza umana
sarda in Corsica (Lugliè 2009: 219) non contrasterebbe, dunque, con quella di
un’ibridazione tra i gruppi umani delle due isole, che ha poi dato luogo ad una
esportazione di tratti culturali - tra i quali, appunto, i rituali funerari - la cui
estensione resta però confinata alla Gallura, escludendo così l’area sulla quale si
presume che questi gruppi umani esercitassero una qualche forma di controllo, e
cioè quella dell’Oristanese. L’attribuzione dei circoli funerari galluresi alla cultura
di San Ciriaco appare dunque coerente con i dati archeologici, ma il concetto di
sottocultura archeologica proposto da Clarke (1968: 236) si presterebbe forse ad
una più attenta lettura del fenomeno, tenendo così conto dei fattori di natura
economica, ecologica (ed etnica?) che hanno sicuramente pesato nella
differenziazione di tale manifestazione culturale rispetto al restante quadro
regionale.
Fig. 16 - Necropoli di Li Muri ˗ Arzachena ˗ (fonte: http://amisdumusee-carnac.blogspot.it/)
65
Fig. 18 - Circoli tombali, a): Vasculacciu ˗ Corsica Meridionale ˗; b) Li Muri ˗ Arzachena ˗ (da
Leandri et al. 2007; rielab. a cura di chi scrive)
Fig. 19 - Cardiccia ˗ Sartène ˗ pomi sferoidi dal coffre di Foce-Pastini (da Leandri et al. 2007)
66
4.4 Apporti extrainsulari
Abbandonata da tempo la visione della Sardegna neolitica come di un’area
di accantonamento culturale (cfr. Tiné 1997: 51), si può ormai guardare ai
confronti extrainsulari a partire dai dati che attestano reali contatti tra i gruppi
umani isolani e continentali. Nell’ultimo quarto del V millennio a.C. l’intera area
settentrionale dell’Italia è interessata dalla cultura dei Vasi a Bocca Quadrata,
nella fase II o c.d. meandro-spiralica. I primi apporti di matrice chasseana
cominciano in questa fase ad intaccare il sostrato Vbq dell’area ligure, come
documentato ad Alba (Venturino Gambari 1995) e a La Maddalena di Chiomonte
(Fedele 2008), interessando poi buona parte della penisola italiana (Borrello
1984); i contatti tra la Sardegna e l’area ligure-padana chasseana sono comprovati
dall’ossidiana sarda presente nella Caverna delle Arene Candide (Bernabò Brea
1946), alla Romita di Asciano (Peroni 1963) e Podere Casanuova (Aranguren et
al. 1991) e indiziati dalle analogie nella produzione ceramica, per la quale, oltre ai
confronti già proposti (e.g. Alba 1999: 25-33; Lugliè 2003: 72-3) si possono citare
i siti di Le Mose (Maffi 2013: 151) e di Botteghino (Mazzieri e Dal Santo 2007:
fig. 6), entrambi datati all’ultimo quarto del V millennio a.C. Gli influssi di
tradizione Vbq sembrano invece riguardare prevalentemente la decorazione delle
superfici vascolari: le analogie tra il coperchio di Vecchiazzano e il piatto in
steatite di Locòe, così come la decorazione meandro-spiralica caratterizzante la
produzione ceramica del Vbq II riscontrata su vasi provenienti in buona parte
dall’area sulcitana, nonché su elementi di parure (la placchetta in osso da Grotta
Rifugio), sono elementi che indiziano rapporti solidi tra la Sardegna e l’area
padana in questa fase del neolitico medio. Ma guardando al meridione della
penisola italiana, le analogie tra le forme vascolari e alcuni elementi di prensione
delle culture di Serra d’Alto e Diana-Bellavista sono ugualmente rimarchevoli; la
scoperta di una tomba a grotticella artificiale a Carpignano, datata al 5665±30 BP,
oltre a fugare gli ultimi dubbi sull’attendibilità dell’esempio di Arnesano riguardo
alle prime attestazioni dell’ipogeismo peninsulare (Lo Porto 1972; cfr. Tiné e
Traverso 1992: ), lascia supporre che le affinità nella produzione ceramica siano il
portato di contatti tra il Salento e la Sardegna, più che un mero fenomeno di
convergenza. I raffronti tra la coppetta di Li Muri e alcune ciotole provviste di
67
anse a rocchetto allungato dalla stazione preistorica di Diana (Bernabò Brea 1960:
fig. 15 g, i), e quelli tra la ciotola in calcite di Bingia ’Eccia e un’analoga forma,
stavolta fittile, con singola ansa a rocchetto allungato dalla tomba di Piano Conte
(ibidem: tav. XXVIII, 5) sono particolarmente stringenti; allo stesso modo, una
statuina proveniente da S. Matteo Chiantinelle – Foggia (Gravina 2008: fig. 2)
trova più di un confronto con gli esemplari di Su Cungiau de Marcu e Conca
Illonis. Alcune analogie con la produzione ceramica maltese di fase Skorba (Sluga
Messina 1988: fig. 3 b; Trump 1998: tav. 2.1, 2.3) potrebbero invece indiziare, più
che contatti diretti tra le due isole, una comune assimilazione da modelli
dell’Italia meridionale; la precocità degli aspetti Diana peninsulari è peraltro
confermata da datazioni radiocarboniche che ne attestano una comparsa già dalla
metà del V millennio a.C, in parziale sovrapposizione, quindi, con la cultura di
Serra d’Alto (Pessina e Radi, fig. 27). L’Italia peninsulare e l’area padana erano,
del resto, in costante contatto durante questa fase del neolitico, come testimoniato
dalla circolazione delle ollette del tipo San Martino, di tradizione Serra d’Alto ma
presenti in un gran numero di sepolture Vbq (Mazzieri et al. 2012), e delle accette
in pietra verde, di provenienza alpina ma circolanti lungo l’intera penisola
(ibidem: 355). Nonostante la marcata eterogeneità culturale che caratterizza la
penisola italiana nel neolitico medio, l’attestazione dei rapporti fra le aree
meridionali e quelle centro-settentrionali lascia intravvedere una parziale
ibridazione dei tratti culturali di partenza delle specificità locali; l’inserimento
della Sardegna nel quadro di contatti interregionali, fa pensare ad una ricezione di
tradizioni e modelli da gruppi umani extrainsulari, mai accolte in toto, ma
costantemente rielaborate e mescidate ad una altrettanto costante evoluzione
culturale interna. Distinguere, caso per caso, tra le spinte evolutive interne e le
rielaborazioni di apporti esterni, è un’operazione che non può essere svolta se si
considera il mutamento culturale come il semplice risultato di una trasmissione
verticale o orizzontale, ma necessita di una lettura a più ampio raggio che tenga
conto del ruolo giocato dai fattori ambientali ed economici, che devono aver agito
tanto da “filtro” di ricezione, quanto da meccanismo di mutamento culturale
interno all’ideologia dei gruppi autoctoni. In quest’ottica sarà forse più semplice
comprendere le cause in ragione delle quali alcuni tratti culturali esterni (la
68
decorazione meandro-spiralica Vbq, le anse a rocchetto di tipo Diana) sono stati
accolti e fatti propri, mentre altri (l’imboccatura quadrata eponima della cultura
Vbq, le ollette del tipo San Martino) non hanno intaccato, se non marginalmente
(e.g. Loria e Trump 1978: 186, tav. XL 28), il sostrato culturale “ricevente”.
Fig. 20 – A sinistra: coperchio fittile da Vecchiazzano (fonte: www.Vecchiazzano.it); a destra:
piatto litico da Locòe (da Lilliu 1999)
Fig. 21 Bingia ‘Eccia – Dolianova (1) (da Ferrarese Ceruti 1995); Piano Conte – Lipari (2) (da
Bernabò Brea 1960)
69
5 Considerazioni conclusive
A quali evidenze, tratti culturali o segmento cronologico si fa riferimento,
dunque, quando si parla di “cultura di San Ciriaco”? Gli usi funerari sono poco
noti e in nessun caso, tra le evidenze edite, è stato possibile individuare una
tipologia funeraria caratterizzante la cultura in esame; quantitativamente scarsi,
allo stesso modo, sono i dati editi sull’industria litica, sulla tipologia delle
strutture a carattere abitativo e sull’estensione degli stessi abitati. La produzione
ceramica non presenta, a una prima analisi, particolari problemi interpretativi, ma
il quadro si complica quando compare la ceramica pointillée, in modo particolare
in contesti funerari ipogeici. Si è, inoltre, parlato di ibridazione, tanto per indicare
la transizione graduale dei tratti culturali da una cultura a un’altra, quanto per
definire il processo di assimilazione di elementi allogeni; tale concetto deve
necessariamente essere accolto in un’accezione puramente euristica, utile a una
sintesi dei processi, ma poco aderente a una esaustiva spiegazione degli stessi. A
ben vedere, un discorso sull’ibridazione dei tratti culturali è, il più delle volte,
insostenibile, poiché tratti culturali ibridi presuppongono tratti “puri”, che devono
però essere stabiliti in maniera arbitraria, per via della analoga ˗seppur necessaria˗
arbitrarietà con la quale si fissano le scansioni cronologiche. Le obiezioni di
Hodder e Orton (1976) e Renfrew (1977) riguardo alla validità del concetto di
cultura archeologica, muovevano da un discorso sulle associazioni casuali e non-
casuali intese in senso diatopico; nel caso della cultura di San Ciriaco, il discorso
può essere applicato in senso diacronico e, per certi versi, non è invece applicabile
nella sua accezione spaziale, perché l’insularità implica una inevitabile (e non più
arbitraria) rottura di qualsivoglia omogeneità culturale, per quanto mitigata da
eventuali contatti extrainsulari. Questo fatto può, forse, aiutare a comprendere
alcune delle ragioni per le quali il concetto di cultura archeologica si sia
sviluppato (e resti, ad oggi, meno vulnerabile) a supporto di una visione
diffusionista; nondimeno, ristabilire una dicotomia serrata tra evoluzione e
diffusione sarebbe poco opportuno, metodologicamente scorretto e affatto sterile,
dal momento che entrambi i fenomeni esistono, hanno avuto luogo, ed è
necessario tenerne conto. Tuttavia, per una analisi che non sia più meramente
70
descrittiva, ma che si proponga di essere esplicativa delle spinte evolutive in seno
ad una società relativamente omogenea, quale può apparire (anche tenendo conto
delle contraddizioni e delle lacune conoscitive citate poc’anzi) la cultura di San
Ciriaco, è necessario superare i vincolanti confini del concetto di cultura
archeologica fondato sui “tratti culturali”, tanto utile in una fase preliminare della
ricerca, quanto limitante nel momento in cui i dati archeologici e antropologici
vengono forzati all’interno di un quadro tassonomico e interpretativo
necessariamente rigido. La reductio ad unum delle molteplici associazioni di
manufatti datati entro un lasso di tempo e distribuiti in una precisa regione
geografica è un imprescindibile punto di partenza per individuare una omogeneità
culturale e, di riflesso, le discontinuità da cui ha avuto luogo e quelle che ha, a sua
volta, generato; nel momento stesso in cui ci si appresta a comprendere le cause di
tali mutamenti culturali, il concetto di cultura archeologica non solo non è più
sufficiente, ma risulta fuorviante in ragione delle contraddizioni latenti al suo
interno, che i nuovi interrogativi faranno necessariamente emergere. Ogni
cambiamento culturale affonda le sue radici nelle condizioni economiche e sociali,
le quali influenzano a loro volta i fattori ideologici, che ne costituiscono una
rappresentazione. Senza una lettura di tali condizioni, il riconoscimento di
un’evoluzione dei tratti di cultura materiale all’interno di una società resta un
mero esercizio di seriazione tipologica; allo stesso modo, la diffusione dei tratti
culturali ci informa unicamente circa una loro disponibilità, ma non aiuta a
comprendere per quali ragioni essi siano stati assimilati. Si può ragionevolmente
concludere, dunque, che le culture archeologiche costituiscano un valido sistema
di classificazione e di scansione delle fasi archeologiche, laddove manchi un
chiaro quadro crono-tipologico, e per questa ragione è necessario un criterio
univoco nello stabilire quando un “gruppo politetico di tipi di manufatto specifici
e comprensivi che compaiono insieme in modo consistente in insiemi entro
un’area geografica limitata” (Clarke 1968: 190) possa essere considerato una
cultura archeologica. Sebbene, alla luce dei dati emersi fino a questo momento,
possa apparire un’operazione oziosa, non sarà tuttavia superfluo ribadire che
l’associazione di tratti culturali indicata come “San Ciriaco” debba intendersi, a
tutti gli effetti, come una cultura archeologica. Una volta completata la fase
71
classificatoria, i tratti culturali si riveleranno naturalmente come effetti, e non
cause, del mutamento che l’enucleazione della cultura archeologica ha messo in
evidenza, e si potrà procedere a una analisi incentrata sugli aspetti sociali,
economici e ambientali; in questo modo, prendendo come riferimento l’“indiano
che sta dietro al manufatto”, sarà ancora difficile tracciare una storia etnica
dell’indiano, ma sarà altresì superata la fase classificatoria del manufatto, e si
potrà giungere a comprendere quale fosse il sistema sociale che stava dietro ad
entrambi.
72
Riferimenti bibliografici
AGOSTI, F., BIAGI, P., CASTELLETTI, L., CREMASCHI, M., GERMANÀ, F,
1980, La Grotta Rifugio di Oliena (Nuoro): caverna ossario neolitica, in Rivista
di Scienze Preistoriche, XXXV.
ALBA, L. 1976, Attuali conoscenze sul neolitico della Sardegna, in Speleologia
Sarda, n. 3.
ALBA, L. 1999, Nuovo contributo per lo studio del villaggio neolitico di San
Ciriaco di Terralba (OR), in Studi Sardi XXXII, Cagliari.
ANTONA, A. 1998, Le statuette di “Dea Madre” nei contesti prenuragici:
alcune considerazioni, in Sardinian and Aegean chronology : towards the
resolution of relative and absolute dating in the Mediterranean : proceedings of
the International colloquium "Sardinian stratigraphy and Mediterranean
chronology", Tufts university, Medford, Massachusetts, March 17-19, 1995.
ANTONA, A. 2003, Il megalitismo funerario in Gallura: alcuni aspetti sulla
necropoli di Li Muri, in Rivista di Scienze Preistoriche, LIII.
ARANGUREN, B.M., DUCCI, S., PERAZZI, P.1991, Il villaggio neolitico di
Podere Casanuova (Pontedera, Pisa), in Rivista di Scienze Preistoriche, XLIII.
ATZENI, E. 1978, La Dea Madre nelle culture prenuragiche, in Studi Sardi XIV,
Cagliari.
ATZENI, E. 1987, La preistoria del Sulcis-Iglesiente, in AA. VV., Iglesias. Storia
e Società, Rotary Club, Iglesias.
AUDIBERT, J. 1958, Préhistoire de la Sardaigne: résultats de mission
archéologique, in Bulletin du Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco, 5.
73
BARKER, G.W. 1973, Cultural and Economic Change in the Prehistory of
Central Italy, Proceedings University of Sheffield.
BASOLI, P., FRAU, M., MELONI, G. M., NIEDDU, M. R., TANDA, G., USAI,
L. 1999 Il Neolitico in Sardegna, in Criteri di nomenclatura e di terminologia
inerente alla definizione delle forme vascolari del neolitico/eneolitico e del
bronzo/ferro : atti del Congresso di Lido di Camaiore, 26-29 marzo 1998.
BERNABÒ BREA, L. 1946, Gli scavi nella Caverna delle Arene Candide, in
Rivista di Scienze Preistoriche, IV.
BERNABÒ BREA, L. e CAVALIER, M. 1960, La stazione preistorica della
contrada Diana e la necropoli protostorica di Lipari, in Meligunìs Lipàra, I.
BIETTI SESTIERI, A. M. 2001, L'archeologia processuale in Italia, o
l'impossibilità di essere normali, in N. Terrenato (a cura di), Archeologia teorica,
X Ciclo di lezioni sulla ricerca applicata in Archeologia. Certosa di Pontignano
(Siena), 9-14 agosto, Firenze. Edizioni All'Insegna del Giglio.
BINFORD, L. R 1962, Archaeology as anthropology, American Antiquity, 28.
BINFORD, L. R. 1963, “Red Ocher” Caches from the Michigan Area: A Possible
Case of Cultural Drift, Southwestern Journal of Anthropology, 19, 1.
BINFORD, L. R. 1965, Archaeological systematics and the study of culture
process, American Antiquity, 31.
BINFORD, L. R. 1972, An Archaeological Perspective, New York: Seminar
Press.
74
BORRELLO, M. 1984, The Lagozza Culture (3rd millennium b.C.) in Northern
and Central Italy, in Studi Archeologici, vol. 3, Bergamo.
BOSCHIAN, G., BRILLI, P., FALCHI, P., FENU, P., MARTINI, F., PITZALIS,
G., SARTI, L., TOZZI, C. 2001, Prime ricerche nell’abitato neolitico di
Contraguda (Perfugas, Sassari), in Rivista di Scienze Preistoriche LI, 1.
BRAY, W. 1963, The Ozieri Culture in Sardinia, in Rivista di Scienze
Preistoriche, XVIII.
CALDWELL, J. R. 1959, The New American Archaeology, Science, 129.
CASSON, S. 1921, The Dorian Invasion Reviewed in the Light of Some New
Evidence, Antiquities Journal.
CATTANI, M. 2009, I “fondi di capanna” e l’uso residenziale delle strutture
seminterrate nella Pre-Protostoria dell’Italia settentrionale, in IpoTesi di
Preistoria, 2, 2009.
CHILDE, V. G. 1924, The Aryans: A study of Indo-Europeans Origins, London,
Kegan Paul.
CHILDE, V. G. 1925, The Dawn of European Civilisation, London, Kegan Paul.
CHILDE, V. G. 1929, The Danube in Prehistory, Oxford, Oxford University
Press.
CHILDE, V. G. 1933, Races, peoples, and cultures in prehistoric Europe, History
18.
CHILDE, V. G. 1935, Changing methods and aims in prehistory, Proceedings of
the Prehistoric Society, 1.
75
CHILDE, V. G. 1946, Archaeology and Anthropology, South-western Journal of
Anthropology, 2.
CHILDE, V. G. 1956, Piecing Together the Past; The Interpretations of
Archaeological Data, London, Routledge & Kegan Paul.
CHILDE, V. G. 1958, The Prehistory of European Society, Harmondsworth,
Penguin; trad. it. Preistoria della società europea, Firenze, Sansoni.
CLARK, J. G. D. 1939, Archaeology and Society, London, Methuen.
CLARK, J. G. D. 1940, Prehistoric England, London, Batsford.
CLARK, J. G. D. 1952, Prehistoric Europe: The Economic Basis, London,
Methuen; trad. it. 1969, Europa preistorica, Torino, Einaudi.
CLARKE, D. L. 1968, Analytical Archaeology, London, Methuen; trad. it.
Archeologia Analitica, Milano, Electa, 1998.
COCCHI GENICK, D. 2005, Considerazioni sull'uso del termine "facies" e sulla
definizione delle facies archeologiche, in Rivista di Scienze Preistoriche, LV.
CONTU, E. 2006, La Sardegna Preistorica e Nuragica, Sassari, Carlo Delfino
editore.
CRAWFORD, O. G. S. e WHEELER, R. E. M. 1921, The Llynfawer and Other
Hoards of the Bronze Age, Archaeologia 71.
DANIEL, G. E. 1971, From Worsae to Childe: the models of prehistory,
Proceedings of the Prehistoric Society, 1971, XXXVII.
76
DE FRANCESCO, A. M., BOCCI, M. 2007, Risultati dell’analisi non distruttiva
in XRF sulle ossidiane dei siti di Cala Giovanna Piano (Arcipelago Toscano) e
Torre Foghe, in Preistoria e Protostoria dell’area Tirrenica, : a cura di Tozzi, C.,
Wess, M.C., Pisa: Ed. Felici.
DINI, M. 2007, L’industria in ossidiana dei siti neolitici di S. Caterina Pittinuri e
Torre Foghe sulla costa occidentale della Sardegna, in Preistoria e Protostoria
dell’area Tirrenica, : a cura di Tozzi, C., Wess, M.C., Pisa: Ed. Felici.
DOBRES, M. A. e ROBB, J. E. 2000, Agency in Archaeology, Routledge,
London.
DYSON, S. L. e ROWLAND, R. J. 2007, Archaeology and history in Sardinia
from the stone age to the middle ages: shepherds, sailors & conquerors,
Philadelphia, University of Pennsylvania museum of archaeology and
anthropology.
EVANS, A. 1921, The Palace of Minos: A Comparative Account of the
Successive Stages of the Early Cretan Civilization as Illustrated by the
Discoveries at Knossos. London.
FADDA, M. A. 2001, Posada: preistoria sarda all'ombra di un castello, in
Archeologia Viva, v. 20, n. 85.
FALCHI, P., FENU, P., MARTINI, F., PITZALIS, G., SARTI, L., TOZZI, C.
2009, L’insediamento neolitico di Contraguda (Perfugas, Sassari):
aggiornamento delle ricerche, in Atti della XLIV Riunione dell'Istituto Italiano di
Preistoria e Protostoria (Cagliari, Barumini, Sassari 23-28 novembre 2009).
Firenze.
FEDELE, F. 2008, Il cimitero neolitico di Chiomonte ‘La Maddalena’ in alta
Valsusa: scoperta, scavo e contesto, in Atti. 2° Congresso Internazionale
77
‘Ricerche paletnologiche nelle Alpi Occidentali’ / 3° Incontro ‘Arte rupestre
alpina’ ricordando Piero Barocelli ed Osvaldo Coïsson. Pinerolo, 17, 18, 19
Ottobre 2003.
FERRARESE CERUTI, M. L. 1995, Nuovi elementi delle grotta funeraria di
Tanì (Carbonia), in Carbonia e il Sulcis Archeologia e territorio, Oristano.
FLANNERY, K. V. 1967, Culture history v. cultural process: a debate, Scientific
American 217, 2.
FLANNERY, K. V. 1987, The Golden Marshalltown: a parable for the
archaeology of the 1980s, American Anthropologist, 84.
FOSCHI NIEDDU, A. 1987, La grotta di Sa Korona di Monte Majore (Thiesi,
Sassari). Primi risultati dello scavo 1980, in Atti della XXVI. Riunione
Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze, 7-10 novembre
1985.
FOX, C. 1923, Archaeology of the Cambridge Region, Cambridge, The
Cambridge University Press.
FRITZ, J. M. e PLOG, F. T. 1970, The nature of archaeological explanation,
American Antiquity, vol. 35, 4.
GALATY, M. L. e WATKINSON, C. 2004, Archaeology Under Dictatorship,
New York, Kluwer Academic, Plenum Publishers.
GAMBLE, C. 2001, Archaeology: The Basics, London, Routledge.
GIANNICHEDDA, E. 2002, Buche, discorsi, esperimenti e dizionari, in Omaggio
a Santo Tiné. Miscellanea di studi di Archeologia preistorica e protostorica,
Genova.
78
GIANNITRAPANI, E., SIMONE, L., TINÈ, S. (a cura di) 1989, Interpretazione
funzionale dei fondi di capanna di età preistorica. Atti del seminario di
archeologia sperimentale, Milano, 29-30 aprile 1989, Casamara Ed., Genova.
GIMBUTAS, M. 1974, The Goddesses and Gods of Old Europe: Myths and Cults
Images, London: Thames and Hudson.
GLADWIN, W. e GLADWIN, H. S. 1934, A Method for the Designation of
Cultures and their Variations, Globe, Medallion Papers 15.
GRAVINA, A. 2008, Due statuine fittili femminili da S. Matteo-Chiantinelle
(Serracapriola, Foggia), in Bullettino di Paletnologia, 97.
GREENWELL, W. 1905, Iron Age Burials in Yorkshire, Archaeologia 60.
GUIDO, M. 1963, Sardinia, London, Thames and Hudson.
GUILBEAU, D. 2010, Les grandes lames et les lames par pression au levier du
Néolithique et de l’Énéolithique en Italie, Thèse de Doctorat. Université Paris
Ouest; Sous la direction de C. Perlès.
HABU, J. 2004, Ancient Jomon of Japan, Cambridge, Cambridge University
Press.
HARRIS, M. 1971, The Rise of Anthropological Theory. A History of Theories of
Culture, New York, Thomas Y. Crowell, 1969; trad. it., L’evoluzione del pensiero
antropologico, Bologna, Il Mulino, 1971.
HAWKES, C. F. 1954, Archaeological theory and method: some suggestions
from the Old World, American Anthropologist, 56.
HIGGS, E. S. (a cura di) 1975, Palaeoeconomy, Cambridge.
79
HODDER, I. 1982, Symbols in Action: Etnoarchaeological Studies of Material
Culture, Cambridge, Cambridge University Press.
HODDER, I e ORTON, C. 1976, Spatial Analysis in Archaeology, Cambridge,
Cambridge University Press.
INGRAVALLO, E., TIBERI, I. 2009, Le società di V millennio alla luce dei
rituali funerari: la tomba a grotticella di Carpignano Salentino (LE), in P. F.
Fabbri e C. Pagliara (a cura di), Prima di Carpignano. Documentazione e
interpretazione di una sepoltura neolitica, Lecce.
KENYON, K. 1956, Jericho and its Setting in Near Eastern History. Antiquity,
30
KIDDER, A. V. 1936, Speculations on New World Prehistory, in Lowie (ed.),
Essays in Anthropology, Berkeley, University of California.
KLUCKHOHN, C. 1940, The conceptual structure in Middle American studies, in
C.L. Hay et al. (a cura di), The Maya and their Neighbors, New York, Appleton-
Century.
KOSSINNA, G. 1911, Die Herkunft der Germanen. Zur Methode der
Siedlungsarchäologie, Mannus Bibliothek 6, Würzburg: Kabitzsch.
KROEBER, A. e KLUCKHOHN, C. 1952, Culture: A Critical Review of
Concepts and Definitions, Harvard University, Papers of The Peabody Museum of
Amer. Archaeol. And Ethn., vol. 47; trad. it., Il concetto di cultura, Bologna, il
Mulino, 1972.
LAUFER, B. 1918, Review of R. H. Lowie’s Culture and Ethnology, in
«American Anthropologist», XX.
80
LAVIOSA ZAMBOTTI, P. 1943, Le più antiche culture agricole europee :
l'Italia, i Balcani e l'Europa centrale durante il neo-eneolitico, Milano; Messina:
Principato.
LEANDRI, F., GILABERT, C., DEMOUCHE, F. 2007, Les chambres funéraires
des Vᵉ et IVᵉ millénaires av. J-C.: le case de la Corse, in Moinat, P., Chambon, P.
Eds – Les cistes de Chamblandes et la place des coffres dans les pratiques
funéraires du Néolithique moyen occidental: actes du colloque de Lausanne, 12 et
13 mai 2006, Lausanne - Paris, Cahiers d’Archéologie romand, Société
préhistorique française.
LEVI, D. 1952, La necropoli di Anghelu Ruju e la civiltà eneolitica della
Sardegna, in Studi Sardi X – XI, Cagliari.
LEVIN, M. E. 1973, On Explanation in Archaeology: A Rebuttal to Fritz and
Plog, American Antiquity, vol. 38, 4.
LILLIU, G. 1957, La religione della Sardegna prenuragica, in Bullettino di
Paletnologia Italiana IX, Roma, Museo preistorico etnografico L. Pigorini.
LILLIU, G. 1963, La Civiltà dei Sardi: dal Neolitico all’età dei Nuraghi, Torino,
ERI.
LILLIU, G. 1966, Il dolmen di Motorra (Dorgali-Nuoro), in Studi Sardi XX,
Cagliari.
LILLIU, G. 1994, Le grotte di Rureu e Verde nella Nurra d'Alghero (Sassari),
nota del socio corrispondente Giovanni Lilliu, in Atti della Accademia nazionale
dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Rendiconti, CCCXCI
Roma.
81
LILLIU, G. 1999, Arte e religione della Sardegna prenuragica : idoletti,
ceramiche, oggetti d'ornamento; Sassari: C. Delfino.
LILLIU, G. 2003, La Civiltà dei Sardi: dal Paleolitico all’età dei Nuraghi,
Nuoro, Il maestrale.
LO PORTO, F. G. 1972, La tomba neolitica con idolo in pietra di Arnesano, in
Rivista di Scienze Preistoriche, XXVII.
LO SCHIAVO, F. 1979, Alghero (Prov. di Sassari): Grotta Verde. Scoperte e
scavi preistorici in Sardegna negli anni 1978 e 1979, in Rivista di Scienze
Preistoriche, XXXIV.
LORIA, R., TRUMP, D. H. 1978, Le scoperte a «Sa ‘Ucca de su Tintirriòlu» e il
Neolitico sardo, Roma, Accademia nazionale dei Lincei.
LUGLIÈ, C. 1998, Elementi culturali del Neolitico medio-superiore da alcuni
insediamenti del Sinis, in atti del 2. convegno La ceramica racconta la storia :
Oristano-Cabras, 25-26 ottobre, 1996
Cagliari: Condaghes, 1998.
LUGLIÈ, C. 2003, La ceramica di facies S. Ciriaco nel Neolitico superiore della
Sardegna: evoluzione interna e apporti extrainsulari, in Atti della XXXV
Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria Le comunità
della preistoria italiana. Studi e ricerche sul neolitico e le età dei metalli in
memoria di Luigi Bernabò Brea (Lipari, 2-7 giugno 2000).
LUGLIÈ, C. 2008, L’inconsueto maschile: una raffigurazione fallica del neolitico
medio da Bau Angius (Sardegna centro-occidentale), in Il segno e l'idea: arte
preistorica in Sardegna / a cura di Giuseppa Tanda, Carlo Lugliè. Cagliari: CUEC.
82
LUGLIÈ, C. 2009, L’obsidienne néolithique en Méditerranée Occidentale, in
L'homme et le précieux: matières minérales précieuses / édité par Marie-Hélène
Moncel and François Fröhlich; Oxford: John and Erica Hedges.
MAFFI, M. 2013, Componenti culturali nei siti neolitici emiliani tra Neolitico
Recente e Finale, tesi di Dottorato.
MARRAS, V. 1994, Le culture prenuragiche nella collezione Vargiu di Villasor
(CA), in Studi Sardi XXXI, Cagliari.
MARTINI, F. e PITZALIS, G. 1981, Il Paleolitico in Sardegna, in Atti della 23.
riunione scientifica dell'Istituto italiana di preistoria e protostoria, Firenze, 7-9
maggio 1980.
MAZZIERI, P., DAL SANTO, N. 2007, Il sito del Neolitico recente di Botteghino
(Parma), in Rivista di Scienze Preistoriche, LVII.
MAZZIERI, P., COLOMBO, M., BERNABÒ BREA, M., GRIFONI
CREMONESI, R. 2012, Contatti e scambi tra la cultura Serra d’Alto e i Vasi a
Bocca Quadrata: il caso delle ollette tipo San Martino, in Rubricatum, Revista
del Museu de Gavà, 5.
MCKERN, W. C. 1939, The Midwestern Taxonomic Method as an Aid to
Archaeological Culture Study, American Antiquity 4.
MELIS, P. 2009, Lo scavo della Tomba X nella necropoli ipogeica di Santu Pedru
(Alghero - Sassari): una domus de janas delle prime fasi del Neolitico Recente, in
Rivista di Scienze Preistoriche – LIX.
MELONI, L. 1993, Le ceramiche Bonu Ighinu e San Ciriaco di “Puisteris”
(Mogoro) nella collezione Puxeddu, in Quaderni della Soprintendenza
Archeologica per le Provincie di Cagliari e Oristano, v. 10.
83
MELOSU, B., PINNA, V. 2012, Le grandi lame della Sardegna: il contributo
dell’analisi spaziale allo studio del fenomeno, in Rubricatum, Revista del Museu
de Gavà, 5.
MOLINARI, I. 2002, La facies neolitica di San Ciriaco, in Omaggio a Santo
Tiné: miscellanea di studi di archeologia preistorica e protostorica
(Genova): Facoltà di lettere, Dipartimento di archeologia, filologia classica e loro
tradizioni: Tilgher (distributer).
MORAVETTI, A. 2002, La Preistoria: dal Paleolitico all'età Nuragica, in
Brigaglia, Manlio; Mastino, Attilio; Ortu, Gian Giacomo (a cura di) Storia della
Sardegna. 1: dalla Preistoria all'età bizantina, Roma-Bari, Editori Laterza.
MUSSI, M. 2009, The Venus of Macomer, a little-known prehistoric figurine from
Sardinia, In: P. Bahn (ed.) An Enquiring Mind. Essays in Honor of Alexander
Marshack, American School of Prehistoric Research, Harvard University.
PAGLIETTI, G. 2008, La piccola statuaria femminile della Sardegna neolitica.
Proposta di una seriazione evolutiva attraverso l'applicazione di metodi stilistici e
dimensionali, in Il segno e l'idea: arte preistorica in Sardegna / a cura di Giuseppa
Tanda, Carlo Lugliè; Cagliari: CUEC.
PEDROTTI, A. 2001, Il neolitico, in Lanzinger, M., Marzatico, F. e Pedrotti, A.
(a cura di): Storia del Trentino. La Preistoria e la Protostoria, I: 119-181. il
Mulino, Bologna.
PERONI, R. 1963, La Romita di Asciano (Pisa): riparo sotto roccia utilizzato
dall'età neolitica alla barbarica, in Bullettino di Paletnologia Italiana, 71/72
PERRA, C. (a cura di) 2008, Museo Archeologico Villa Sulcis: guida alle
esposizioni, Carbonia: Envisual, 2008.
84
PESSINA, A., RADI, G. 2002, L’aspetto di Fossacesia e il Neolitico recente
dell’Italia centroadriatica, in A. Ferrari, P. Visentini (a cura di), Pordenone Il
declino del mondo neolitico. Ricerche in Italia centro-settentrionale fra aspetti
peninsulari, occidentali e nord-alpini (Atti del Convegno, Pordenone, 2001).
PUXEDDU, C. 1975, La Preistoria, in La Diocesi di Ales - Usellus – Terralba:
aspetti e valori.
RÀDL, E. 1930, The History of Biological Theories, London, Oxford University
Press.
RADMILLI A. 1967, I villaggi a capanne del Neolitico italiano, Archivio per
l’Antropologia e l’Etnologia, XCVII.
RENFREW, A. C. 1977, Space, time and polity, in J. Friedman e M. Rowlands
(eds.) The evolution of social systems, Duckworth, London.
RITZENHALER, R. E. e QUIMBY, G. I. 1962, The Red Ocher Culture of the
Upper Great Lakes and adjacent areas, Chicago Natural History Museum, vol.
36, 11.
ROBERTS, B. W. e VANDER LINDEN, M. 2011, Investigating Archaeological
Cultures: Material Culture, Variability and Transmission, New York, Springer.
SANTONI, V. 1982a, Il mondo del sacro in età neolitica, in Le Scienze, Ottobre
1982.
SANTONI, V. 1982b, Cabras, Cuccuru s’Arriu. Nota preliminare di scavo (1978,
1979, 1980) in Rivista di Studi Fenici, X, 1, 1982.
85
SANTONI, V. 2012, Il neolitico di Capo Sant'Elia, Cagliari, in Epi Oinopa
Ponton. Studi sul Mediterraneo antico in ricordo di Giovanni Tore, a cura di Carla
Del Vais, Oristano, S'Alvure, 2012.
SANTONI, V., BACCO, G., SABATINI, D. 1997, L'orizzonte Neolitico
superiore di Cuccuru s'Arriu di Cabras: le sacche C.S.A. nn. 377, 380/1979 e n.
2/1989, in La cultura di Ozieri : la Sardegna e il Mediterraneo nel 4. e 3. millennio
a.C. : atti del 2. Convegno di studi : Ozieri 15-17 ottobre 1990.
SEBIS, S., LUGLIÈ, C., SANTONI, V. 2009, Il Neolitico medio di Cuccuru is
Arrius (Cabras, OR) nella struttura abitativa 422, in Atti della XLIV Riunione
dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (Cagliari, Barumini, Sassari 23-28
novembre 2009), Firenze.
SHANKS, M. 2009, Post Processual archaeology and after, in Handbook of
Archaeological Methods and Theories, Bentley, Maschiner and Chippindale
(eds.), Walnut Creek, Altamira Press.
SIRIGU, R. 2009, Archeologia preistorica e protostorica in Sardegna, Cagliari,
CUEC.
SIRIGU, R. 2012, È mai esistita la ʽCiviltà Nuragicaʼ? Riflessioni sul metodo, in
Bernardini, P. e Perra, M. (a cura di), I nuragici, i fenici e gli altri. Sardegna e
Mediterraneo tra Bronzo finale e prima età del Ferro: atti del 1. congresso
internazionale in occasione del venticinquennale del Museo “Genna Maria” di
Villanovaforru, 14-15 dicembre 2007.
SLUGA MESSINA, G. 1988, La ceramica neolitica maltese nel quadro
dell'Europa mediterranea ed occidentale, in Missione a Malta: ricerche e studi
sulla preistoria dell'arcipelago maltese nel contesto mediterraneo; a cura di Ariela
Fradkin Anati, Emmanuel Anati. Capo di Ponte: Centro camuno di studi
preistorici.
86
SORO, L. 2012, Gli idoli “cicladici” della Sardegna preistorica: attraverso la
tipologia e la distribuzione nel territorio, nuove osservazioni sull’uso, significato
e valore, in XLII Riunione scientifica dell’I.I.P.P. L’arte preistorica in Italia.
Trento, Riva del Garda, Val Camonica, 9-13 ottobre 2007.
TALALAY, L. E. 1993, Deities, Dolls, and Devices: Neolithic Figurines from
Franchthi Cave, Greece. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
TALLGREEN, A. M. 1937, The method of prehistoric archaeology, Antiquity 11.
TARAMELLI, A. 1927, La ricerca archeologica in Sardegna, in Il Convegno
Archeologico in Sardegna : giugno 1926, Reggio nell'Emilia: coi tipi delle
officine grafiche reggiane.
TAYLOR, W. W. 1948, A Study of Archaeology, Menasha (Wisconsin), American
Anthropological Association (Memoir, 69).
THEOCHARIS, D.R. 1973, Neolithic Greece, National Bank of Greece, Athens.
TINÉ, S. 1997, Sardegna, Sicilia ed Eolie, in La cultura di Ozieri: la Sardegna e il
Mediterraneo nel 4. e 3. millennio a.C., atti del 2. Convegno di studi, Ozieri 15-17
ottobre 1990.
TINÉ, S., TRAVERSO, D. 1992, Interpretazione storica dei dati, in Tiné e
Traverso (a cura di), Monte d’Accoddi, 10 anni di nuovi scavi, AA. VV, Genova.
TRAMONI, P., D’ANNA, A., PASQUET, A., MILANINI, J.L., CHESSA, R.
2007, Le site de Tivulaghju (Porto-Vecchio, Corse-du-Sud) et les coffres
mégalithiques du sud de la Corse, nouvelles données, in Bulletin de la Société
préhistorique française, 104, 2.
87
TRIGGER, B. 1989, A history of archaeological thought, Cambridge, Cambridge
University Press; trad. it., Storia del pensiero archeologico, Scandicci (Firenze),
La Nuova Italia Editrice.
TRUMP, D.H. 1966, Central and Southern Italy before Rome, London.
TRUMP, D. H. 1983, La grotta di Filiestru a Bonu Ighinu, Mara (SS), Sassari,
Dessì.
TRUMP, D. H. 1998, Les Iles de Malte, in AA.VV. Atlas du Néolithique
européen, Volume 2A, L’Europe occidentale, Eraul (Etudes et Recherches
Archéologique de l’Université de Liège),46, Liège.
TYKOT, R.H. 1994, Radiocarbon dating and absolute chronology in Sardinia
and Corsica, in Radiocarbon dating and Italian prehistory, edited by Robin
Skeates and Ruth Whitehouse, London: The British School at Rome: Accordia
Research Centre, University of London, 1994 X.
TYLOR, E. B. 1871, Primitive Culture: Researches into the Development of
Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom, London, J. Murray.
TYLOR, E. B. 1878, Anthropology, in Encyclopaedia Britannica, vol. II.
UCKO, P. J. 1962, The Interpretation of Prehistoric Anthropomorphic Figurines.
The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland,
92 (1).
UCKO, P. J. 1968, Anthropomorphic Figurines of Predynastic Egypt and
Neolithic Crete with Comparative Material from the Prehistoric Near East and
Mainland Greece. London: A. Szmidla.
UGAS, G. 1990, La tomba dei guerrieri di Decimoputzu, Cagliari, Noras.
88
UGAS, G. 2005, L’alba dei Nuraghi, Cagliari, Fabula.
USAI, L. 2005, Il villaggio prenuragico di Pabaranca (Sorso), Sardinia Corsica
et Baleares Antiquae III.
USAI, L. 2009, Il Neolitico Medio, in Atti della XLIV Riunione dell'Istituto
Italiano di Preistoria e Protostoria (Cagliari, Barumini, Sassari 23-28 novembre
2009). Firenze.
VAQUER, J. 1998, Le Néolithique du sud de la France, in AA.VV. Atlas du
Néolithique européen, Volume 2A, L’Europe occidentale, Eraul (Etudes et
Recherches Archéologique de l’Université de Liège),46, Liège.
VENTURINO GAMBARI, M. (ed) 1995, Navigatori e contadini. Alba e la valle
del Tanaro nella Preistoria, in Quaderni della Soprintendenza Archeologica del
Piemonte, Notiziario, 7.
WATSON, P. J. 2009, Processualism and after, in Handbook of Archaeological
Methods and Theories, Bentley, Maschiner and Chippindale (eds.), Walnut Creek,
Altamira Press.
WHITE, L. A. 1959, The Evolution of Culture, New York, McGraw-Hill.
WILLEY, G. R. 1966, An Introduction to American Archaeology, vol. I North and
Middle America, Prentice Hall.