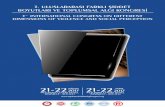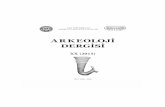Testi scritti e testi orali: differenze, interazioni, intersezioni
«Copisti di testi romanzi ed ecdotica». .in : Translatar i transferir. La transmissió dels textos...
-
Upload
xn--universitchieti-fjb -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of «Copisti di testi romanzi ed ecdotica». .in : Translatar i transferir. La transmissió dels textos...
TRANSLATAR I TRANSFERIRLA TRANSMISSIÓ DELS TEXTOS I EL SABER
(1200-1500)
Edició a curad’ANNA ALBERNI, LOLA BADIA i LLUÍS CABRÉ
Santa Coloma de Queralt
2009
ACTES DEL PRIMER COL·LOQUI INTERNACIONAL DEL GRUP NARPAN
«CULTURA I LITERATURA A LA BAIXA EDAT MITJANA»
Barcelona, 22 i 23 de novembre de 2007
Comitè científic extern
JUAN MANUEL CACHO BLECUA (Universidad de Zaragoza),PEDRO M. CÁTEDRA (Universidad de Salamanca), GÉRARD
GOUIRAN (Université de Montpellier), GENÉVIÈVE HASENOHR
(École Pratique des Hautes Études, París), MICHAEL
MCVAUGH (University of North Carolina at Chapel Hill),MARÍA DE LAS NIEVES MUÑIZ (Universitat de Barcelona).
Comitè organitzador
LOLA BADIA (Universitat de Barcelona), LLUÍS CABRÉ (Uni-versitat Autònoma de Barcelona), MIRIAM CABRÉ (Universi-tat de Girona), LLUÍS CIFUENTES (Universitat de Barcelona),SADURNÍ MARTÍ (Universitat de Girona), JOSEP PUJOL (Uni-versitat Autònoma de Barcelona).
Amb el suport de
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Facultat de Filologia (Ajuts per a la recerca 2007)
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
UNIVERSITAT DE GIRONA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Proyecto Coditecam I: Hum2005-07480-C03Acción Complementaria: Hum 2006-28007-E/Filo
GENERALITAT DE CATALUNYA
Grup Consolidat: SGR-05-00346Arcs: 2007/ARCS1/00002
SOCIEDAD DE ESTUDIOS MEDIEVALES Y RENACENTISTAS (Semyr)
COPISTI DI TESTI ROMANZI ED ECDOTICA
MARIA CARERI
(Università di Chieti)
Nel paragrafo del suo manuale di critica del testo intitolato«Diversità di problemi, elasticità del metodo» Paolo Chiesa evi-denzia molto chiaramente il fatto che, al di là delle teorie pro-poste, ogni tradizione manoscritta ha caratteristiche proprielegate al testo che trasmette e alle condizioni storico-geografichee culturali nelle quali esso è stato copiato (Chiesa 2002: 143-146). Per quanto riguarda in particolare i testi romanzi, inoltre,diversi studiosi (da ultimo Varvaro 2001 e 1999) hanno sottoli-neato la specificità del copista caratterizzato da una gran sinto-nia con il testo che tende a modificare in modo cosciente edincosciente in fase di trascrizione, arrivando spesso ai limiti dellariscrittura.
Frequentando da una parte le edizioni critiche (mi riferiscospecialmente a quelle di scuola italiana)1 e dall’altra i manoscrit-ti romanzi si ha però l’impressione che queste indicazioni nonsiano sempre seguite nella pratica editoriale; più precisamenteuna certa terminologia ecdotica, sganciata dal suo significato ori-ginario, sembra ormai essere stata generalizzata a tutte le situa-zioni. Mi riferisco in particolare ad una serie di formule ormaicomunemente adottate come errore paleografico, scriptio conti-nua, saut du même au même, contaminazione ed ai criteri ecdo-tici ad esse collegate e da esse derivate.
1 Per una intelligente disamina critica dei metodi editoriali italiani suitesti medievali (innanzitutto italiani ma le osservazioni possono essere este-se anche ai testi romanzi) si veda Zinelli (2006).
L’ERRORE PALEOGRAFICO
L’errore paleografico (o errore di lettura o errore ottico) deriva dalfatto che «certe lettere possono essere scambiate per altre, singo-larmente o a gruppi» (West 1991: 28). Gli esempi noti a tutti sonogli scambi tra le lettres à jambages (u, v, n, m, i), tra alcune lette-re o gruppi di lettere tra loro somiglianti (es. d/cl, s/f), l’errato scio-glimento delle abbreviazioni ecc. In realtà, come di nuovo è bensottolineato dai manuali, si deve tenere conto che il copista nonsbaglia nel leggere una lettera ma un’intera parola e che in questoerrore oltre ad una eventuale difficoltà di lettura di singoli ele-menti concorre una serie di altri fattori. Già nel manuale classicoe ancora utilissimo di Havet (1911: 55) si leggeva: «Les fautes con-ditionnées par la ressemblance des lettres sont presque toujoursconditionnés aussi par autre chose ... Complexité souvent mécon-nue; on discerne le côté optique de la faute et on en oublie le côtépsychologique. Dans la réalité rien de plus rare qu’une pure “fautegraphique”».2 Il concetto è ripreso da molti altri tra cui Dain (1964:47) «J’ai cru, au début de ma carrière, devoir insister sur la recher-che des fautes de copie dues aux erreurs de lecture: ces fautes sontplus nettes et leur correction est souvent mieux assurée et plusspectaculaire. Mais j’ai dû, à la longue, reconnaître que l’aspectgraphique des mots avait moins d’importance que leur aspectsonore ou leur contenu affectif». E, in ambito romanzo, Roncaglia1975 (111-112): «l’errore di lettura ha quasi sempre un supportopsicologico: si scambia una lettera per un’altra simile, perché silegge una parola apparentemente appropriata al senso invece diun’altra oggettivamente o soggettivamente meno banale (perchéinsomma la lettura mira al senso piuttosto che al segno, e unainterpretazione banale s’impone più rapidamente del riconosci-mento d’un significante e d’un significato meno banali). Se uncopista legge calamo invece di talamo non è soltanto perché loscambio tra c e t minuscole è facile, ma anche perché nel momen-to della copia il calamo gli è più presente del talamo».3
42 TRANSLATAR I TRANSFERIR
2 La citazione deriva dal capitolo XXVII intitolato Les fautes graphiquescon il significativo sottotitolo La rareté des fautes purement graphiques.
3 Per l’errore paleografico si veda anche Timpanaro (1974 : 11-12 e 5,nota 2).
Inoltre, si deve tenere conto del fatto che «Gli errori partico-lari che possono verosimilmente verificarsi variano naturalmentein relazione alle forme di scrittura d’uso corrente nelle diverseetà» (West 1991: 28-29) e che «È utile dunque avere dimestichez-za con scritture di epoche ed ambienti diversi per essere in gradodi produrre verosimili ipotesi sulla forma grafica originaria diuna parola fraintesa dal copista, e restaurare quindi l’esatta lezio-ne» (Stussi 1994: 101). Così ad esempio, per quanto riguarda lenostre scritture (in generale gotiche databili ai secc. XIII-XIV) saràinverosimile l’ipotesi di uno scambio d/cl dal momento che dopoil sec. XII la d dritta diviene una eccezione rispetto alla più comu-nemente adottata d onciale; scambi possibili si potranno inveceipotizzare tra s ed f, tra c e t, e in generale tra le lettres à jam-bages anche se la m e la n sono quasi sempre ben distinguibilidalla u/v e specialmente dalla i, che presenta un apice inseritoproprio per disambiguarne il significato.
Rispetto a queste premesse teoriche in alcuni casi mi pare chenella pratica editoriale, nel corretto tentativo di razionalizzare lagenesi delle varianti (e degli errori), il termine paleograficovenga spesso evocato in modo almeno in parte improprio. Vedia-mo in primo luogo qualche esempio derivato dallo spoglio di piùo meno recenti edizioni di autori provenzali ed italiani:
I. Maria Pia Betti (2006: 247), per giustificare la scelta editorialeal v. 37 del testo di Peire de Maensac scrive: «La lezione del can-zoniere C, que leus al far, prescelta da Audiau, risulta facilior,spiegabile anche come errore paleografico (leual flar > leus alfar)» .
II. Roberto Antonelli (1979: 29) nell’edizione di Meravigliosa-mente di Giacomo da Lentini accetta al v. 42 la correzione conti-niana ca facemi ancosciare, (i manoscritti riportano: e facemiangosciare C, che mi face ancosciare A, che mi fac’angosciare B)e spiega che si tratta di una «lezione mista che dà conto dell’er-rore di C su motivazioni paleografiche».4
EL TALLER DE CÒPIA 43
4 Antonelli (2006) edita invece al v.42 «che facemi ancosciare».
III. Giosuè Lachin (2004: 153) nella recente edizione del trovato-re Elias Cairel ipotizza che ci sia stata una «sostituzione —giusti-ficabile anche paleograficamente— di els in en» e (p. 152, n.7)che la lezione a mos di R6 (amoros altri mss.) possa essere «natadalla mancata lettura di una abbreviazione *amo’s = amoros, conr soprascritta» (tipo di abbreviazione che non mi pare avereriscontro nei codici provenzali).
IV. Luigi Milone (2004, p.70) in sede di edizione di una canzonedi Raimbaut d’Aurenga (BdT 389,8) commenta la lezione «l’usque Barrabans» al v.23: «l’errore d’archetipo [de Barrabans, lezio-ne condivisa da tutti i testimoni] è errore paleografico, di lettura,de per qe».
Più problematici i casi in cui si usa la paleografia per rico-struire il presunto errore di un manoscritto unico. A partire dauna lezione non accettabile, l’editore verificherà le varie ipotesidi correzione paleograficamente spiegabili, fino a trovare quellache lo soddisfi, quasi come in un cruciverba:
I. Nel recente manualetto di critica del testo Tavani (1997: 57-59)individua un problema nel testo a tradizione unica edito daMorel Fatio: Planys del cavaller Mataró:
e aurets vostra font luente vostra cap gint petinate vostra pits trop reparate tots l’als qui és a pinzelc’aportats axi [un] almellque no·y fall res pel coll tencar
In particolare gli ultimi due versi qui citati sarebbero da leggere«c’aportats axi a livell / que no·y fall res pel coll trencar»: nelsecondo caso l’errore deriverebbe da omissione di abbreviazio-ne, nel primo da ragioni paleografiche (dietro la m si nasconde-rebbe iu/iv).5
44 TRANSLATAR I TRANSFERIR
5 a livell sarebbe da tradurre: «perpendicolarmente».
II. Claudio Giunta (2006: 655, nota 5) in un breve saggio sultesto di «Quando eu stava», a proposito della eziologia dell’er-rore che avrebbe portato da «Null’om non cunsillo de penare» a«Null’om cun cunsillo de’ penare» scrive: «Quanto alla genesi del-l’errore, bisogna pensare che la sequenza cun cunsillo —conl’eventuale uso di tituli abbreviativi qui stesso o in om— fosseparticolarmente esposta ad essere fraintesa dai copisti. E forseproprio a partire da un’aplografia, e dal fraintendimento di cun-sillo come verbo e di de’ come preposizione si produsse Null’omcunsillo de penare: verso ipometro, a sanare il quale poté esse-re introdotta una negazione —in forma abbreviata: n— a suavolta fraintesa come ?, onde la sequenza Nullom? della perga-mena ravennate». Il mio dubbio sta nell’ultima parte dell’ipotesiche prevede la confusione tra n(on), normalmente attestato (sivedano ad esempio le tavole riprodotte da Bertelli 2002), edu(n), che mi pare assai meno diffuso. Certo, siamo agli alboridella trascrizione di testi volgari e dunque abbiamo pochi ter-mini di confronto.
III. Lucia Lazzerini (2006: 33) propone di emendare la lezionedesanat in resana[n]t (Marcabruno BdT 293,4) spiegando: «Lamia soluzione comporta l’emendamento di una diversa lettera (d->r-)...» [nota 76: «Con d- dovuta a erronea ripetizione dell’inizia-le del verso precedente o a equivoco ottico R/D (paleografica-mente più verosimile in presenza di maiuscola)»].
IV. Il più bell’esempio viene comunque da Roncaglia (1993), ilquale propone una ipotesi affascinante quanto azzardata. L’edi-tore ricostruisce a partire da una lezione unica il testo primitivosulla base di una serie di errori paleografici. Dietro alla lezioneattestata daufve sarebbe un originario claustre con ben tre erro-ri di lettura: tra d e cl, tra f ed s, tra ue e tre.
Nei manuali si avverte anche, giustamente, che l’errore paleo-grafico può essere poligenetico. Tuttavia, mentre il criterio è cor-retto per i casi classici, nei quali esso deriva veramente solo daun errore di lettura, mi pare pericoloso applicare la proprietàdella poligenesi ad un caso come il seguente:
EL TALLER DE CÒPIA 45
I. Nel commento all’edizione di Jaufre Rudel, No sap chantar pro-posta dal Rialto (a firma di Antonella Martorano: www.rialto.it), sidiscute il testo del v. 19, dove «Chiarini abbandona la lezione di E(i mss. Ea1b3 leggono soven errore che viene considerato mono-genetico e utile a postulare l’esistenza del ramo ß della tradizio-ne; forse più facilmente paleografico, e perciò poligenetico, dasuau [mss. CMRg3] messo a testo)». Dunque si propone la possi-bilità che il passaggio da suau originario a soven, presente in tremanoscritti, essendo errore paleografico sia anche poligenetico.
LA «SCRIPTIO CONTINUA»
Altro sintagma a volte usato a sproposito è quello di scriptio con-tinua. Spieghiamo sempre ai nostri studenti che nei manoscrittimedievali o in generale antichi le parole erano una di seguitoall’altra e dunque si possono essere verificati nella copia proble-mi legati all’erronea individuazione delle parole. A questo pro-posito va sottolineato il fatto che da quando si scrive in volgare«a partire dal XII secolo la separazione delle parole è per lo piùaffatto chiara» (Bischoff 1992: 246); uno degli elementi caratte-rizzanti la nuova littera textualis consiste proprio nella separa-zione delle parole allo scopo di agevolare la lettura, separazioneche non coincide completamente con quella che adottiamo noiperché prevede agglutinazioni dei clitici (articolo, pronomi), dicerte preposizioni, talora di brevi avverbi ed aggettivi, ma chenon ha niente a che spartire con la scriptio continua.6 Ne derivache l’intervento di restauro testuale attraverso una diversa sepa-razione delle parole è corretto solo a partire da gruppi graficiattestati nei manoscritti.
IL «SAUT DU MÊME AU MÊME»
Da sempre molto amato dai filologi (e anche dagli studenti) l’er-rore causato da saut du même au même. In generale mi pare che
46 TRANSLATAR I TRANSFERIR
6 Cf. Andrieux-Reix – Monsonégo (1999) e (1997).
esso sia quello più facilmente globalizzabile dal momento checompare con una notevole frequenza in situazioni di copia moltodiverse tra di loro. Vorrei in proposito segnalare un problema rela-tivo alla proprietà di poligenetico che viene sia nella teoria chenella pratica attribuita a questo errore. Infatti a me pare che duecopisti possano autonomamente incorrere in questo errore solo separticolari condizioni testuali (cf. Brambilla Ageno 1984: 67) e/odi mise en page li inducono a memorizzare la stessa pericope(penso ad esempio ad una serie di versi copiati uno sotto l’altroo, al caso molto più raro, di una serie di codici nei quali si va acapo allo stesso modo o a quello di testi suddivisi in paragrafi).
Meno evidente mi pare la applicazione della proprietà dellapoligenesi ad un errore come il seguente:
I. Vita Nova 10.29 [XIX.18] dalla [parte della] nobiltà del suocorpo«Integrazione necessaria, per ragioni di simmetria, di un fram-mento di testo che manca in tutti i manoscritti capitali ... Un’esi-gua parte della tradizione ha sanato congetturalmente la lacuna,e d’altra parte c’è il sospetto di un salto du même au même: ilche ovviamente inficia una sua eventuale promozione a errored’archetipo» (Gorni 1996: 321). Mi pare molto difficile che lacaduta di «parte della» possa essere avvenuta in più testimoni inmodo autonomo.
II. Nella nota al testo di Elias Cairel VIII, Giosuè Lachin scrive: «Lavariante di maggior rilievo, che ritengo poligenetica, per omote-leuto o per il mancato riconoscimento della misura del verso, èl’omissione di ades al v. 17, che accomuna AMN» . Riporto diseguito il testo:
Be.n fora plus valensmos chans e plus prezatzs’ieu fos per lieis amatzon valors e beutatzvai doblan, mas pauc blans’ieu mor per lieis desiran,doncs laissar m’en vuoill. «Non far, car apreslo mal ven lo bes ades».«Serai suffrens?» «Oc, tro merces la.t venssa».
EL TALLER DE CÒPIA 47
Sono d’accordo sulla probabile poligenesi dell’errore, ma non apartire da una lacuna per omoteleuto.
LA CONTAMINAZIONE
L’ultimo argomento che voglio affrontare, e forse quello per ilquale interviene di più la specificità dei testi romanzi, è quellodella contaminazione. Anche questo termine viene spesso usatocon scarsa consapevolezza della realtà storico-culturale nellaquale i nostri copisti operarono. Lo stesso termine copista èmolto generico e andrebbe sempre differenziata la copia all’in-terno di un atelier organizzato da quella di altro tipo, che lamaggior parte delle volte non sappiamo definire. In primo luogoandrebbe chiarita la motivazione che spinge il copista a operareuna collazione: solo in parte coincidono i casi di contaminazio-ne dovuti a incompletezza evidente del modello con quelli spie-gabili con la ricerca di un testo migliore o giusto.7 In generale,quando ci troviamo di fronte ad interventi di correzione (su rasu-ra, in interlinea o a margine) pensiamo subito che questi sianofrutto di collazione con altri testimoni e dunque contaminazione.In realtà molto spesso si tratta del risultato di una normale ope-razione di controllo della copia a partire dal modello.
I. Si veda l’esempio del manoscritto della Riccardiana 2943 delPerceval, nel quale diversi correttori hanno ritoccato l’opera delcopista principale. Secondo Busby (2002: 119) essi avrebberoverificato il testo anche «from another copy, and on a few occa-sions, their “corrections” are in fact what appear elsewhere in thetraditions as variants»; saremmo dunque in presenza di un atteg-giamento nuovo nei confronti del testo: la ricerca di: «... a preci-se and definitive text. This runs counter to the widely acceptedmodern view of medieval textuality and suggest at the very leastthat the concept of a fixed vernacular text was not alien to theearly thirteenth century, even if it may have been unusual ...
48 TRANSLATAR I TRANSFERIR
7 Una casistica del tipo di contaminazione e delle diverse conseguenzeecdotiche in Segre (1961).
group of scribes ... seem to bear on the establishment, not of atext, but of the text of Chrètien’s last romance». Se andiamo averificare il manoscritto risulta però evidente che quanto trovia-mo nel codice della Riccardiana è un caso normale e attestato diverifica della copia col suo esemplare (in questo caso molto pun-tuale ed attenta, anche a causa di un copista disattento e forseaddirittura dislessico, come dimostra lo stesso Busby). Non c’en-tra nulla né la contaminazione né la ricerca di un testo autenti-co, tanto meno d’autore.8
È vero che di fronte a una correzione condivisa da altri testi-moni viene subito il sospetto che essa sia frutto di contamina-zione ma se non ci sono prove è giusto proporre l’ipotesi piùeconomica che è quella del controllo tra copia e modello.
II. Così Lino Leonardi nell’edizione del Canzoniere di Guittoned’Arezzo (1994: 267), dove di fronte all’esame di alcune corre-zioni presenti sul codice Laurenziano, concordanti con la lezionedel Vaticano, conclude: «la ricorrente coincidenza del testo cor-retto con la lezione di V elimina la possibilità di una attività con-getturale; il manoscritto di controllo non può d’altronde essere Vo un suo affine, essendovi interventi anche in sonetti mancantiin V. Il fatto poi che le due lacune di L [...] non siano state sana-te fa pensare che, piuttosto che una collazione da un terzo mano-scritto, sia stato eseguito un controllo sul modello stesso di L [...]sembra dunque il caso di considerare gli interventi come fruttodi una revisione interna allo scriptorium d’origine, e quindi omo-genea alla tradizione rappresentata da L».
Esistono ovviamente anche casi di contaminazione sicura edimostrabile, come ad esempio il seguente:
III. Nell’edizione di Llull, Llibre d’amic e d’amat Soler (1995: 9,22-25, tav. 2) nota la presenza di varianti marginali nel ms. D:
EL TALLER DE CÒPIA 49
8 Stessa critica va fatta a Busby (2002: 119-125) a proposito della suainterpretazione delle correzioni presenti sul ms. della Chanson d’Aspremontdella Biblioteca Bodmer di Ginevra : non si tratta di «medieval philology»,ma di controllo del testimone con il suo modello o di varianti marginali inse-rite molto dopo da lettori (e dunque estranee alla copia in questione).
precisiamo che si tratta sempre di integrazioni a lacune (deri-vando da altra fonte è anche giusto chiamarle varianti). In que-sto caso sembra sicuro che l’intervento di correzione sia il risul-tato di collazione con altro esemplare (e non con quello sulquale è stata eseguita la copia) perché le lacune di D coincidonosempre con quelle degli altri manoscritti del ramo a cui D appar-tiene secondo lo stemma proposto dall’editore.
In situazioni particolari può anche essere stata operata unacollazione con vero scrupolo filologico, ma sono casi che si veri-ficano «in centri scrittorî di qualche importanza dove eranodisponibili più codici contenenti la stessa opera dai quali attin-gevano più copisti per migliorare o correggere il testo in singolipunti; c’è ragione di ritenere che a tale scopo fosse allestito uncollettore di varianti (editio variorum, o minuta di laboratorio),cioè un manoscritto dove, sui margini o nell’interlinea, si trova-vano annotate le diverse lezioni presenti in altri manoscritti»(Stussi 1994: 15).
IV. Esempi noti sono quelli dei canzonieri provenzali copiati inVeneto (la cosiddetta famiglia ?, distinta anche per questa caratte-ristica da y). Qui troviamo sia convincenti casi di conseguenzedovute anche all’uso di una editio variorum ricostruibili sulla basedell’esame della varia lectio,9 sia anche manoscritti con correzio-ni (marginali e su rasura) derivate sicuramente da altre fonti efinalizzate non solo ad integrare i testi, caso che è il più frequen-te, ma anche ad indicare lezioni alternative (si veda l’esempiodella sezione dedicata dal canzoniere provenzale H al trovatoreArnaut Daniel, dove le varianti marginali sono introdotte daalias).10 E’ chiaro che il secondo caso (quello di H) rinforza forte-mente il primo (quello ricostruito dagli editori): in un determina-to ambiente (qui quello della tradizione veneta dei canzonieri pro-venzali) si sono operate collazioni tra manoscritti in parte visibilimaterialmente sui codici in parte nascoste da copie successive.
Al contrario in altri casi si fa ricorso ad ipotesi di situazioninon assolutamente attestate dalla tradizione manoscritta.
50 TRANSLATAR I TRANSFERIR
9 Si vedano Avalle (1993: 37-43) e Barbieri (1995).10 Cf. Careri (1990).
V. Così Eusebi (2001: 10), in sede di introduzione alla sua recen-te edizione della Vie de Saint Alexis, per spiegare le irregolaritàtestuali nei mss. PP2, ipotizza che un antigrafo potesse presenta-re due versioni affiancate della fine del testo. Da uno spogliocompleto dei manoscritti francesi del sec. XII non risulta nemme-no un caso di versione sinottica (a parte quello tutto particolaredei salteri e dei testi bilingui). Il ragionamento di Eusebi risultateoricamente corretto, ma eccessivamente formale e svincolatodalla realtà culturale nella quale i codici furono copiati.
Altra possibilità di spiegazione della contaminazione è quelladi un cambio di esemplare legato al metodo di copia. Mi pareinteressante segnalare una serie di casi confrontabili apparte-nenti ad aree diverse:
VI. Nella tradizione di Francesc Eiximenis, Dotzè llibre del Crestiàlo stemma cambia in diverse zone del testo in modo netto e chia-ramente riconoscibile e questo secondo gli editori dipende daltipo particolare di copia eseguita in serie e a partire da esemplaridiversi. Si leggano in proposito Sadurní i Guixeras (2002): «Segu-rament el volum de treball aconsellava dividir la còpia entrediversos amanuenses, que s’encarregaven de blocs differents detext. Com a conseqüència, els models que cada copista havia fetservir per copiar el seu fragment de text, en un manuscrit aca-bat, duen a filiacions variables en una mateixa unitat codicòlogi-ca. El resultat final, doncs, és un text compost, no pas el sentitde ‘contaminat’, sinó en el sentit que a diverses regions del texthi corresponen filiacions diferents, característica que van anartransmetent als seus successors» (si veda anche Xavier Renedo2005: XLV).
VII. Altro esempio è segnalato nella tradizione del romanzo diPerceval di Chrètien de Troyes da A. Micha (1939: 203-209): piùscribi utilizzano più esemplari sfascicolati, derivanti da diversefonti col risultato di prodotti contaminati.11 Margot van Mulken
EL TALLER DE CÒPIA 51
11 Micha arriva addirittura a fare dei conti per capire se i cambi di fontepossono derivare da precedenti cambi di fascicolo (1939: 206-209). Cf. ancheEdwards – Pearsall (1989: 257-278).
approfondisce lo stesso caso proponendo ulteriori elementi:«... we must admit the possibility of a scriptorium or writing mas-ter employing several copyists at the same time (simultaneouscopying), and using more than one exemplar to meet thedemand. These exemplas would have been split up into quires,in order to divide up the work. By recollecting the differentquires and rebinding them, the quire from an exemplar couldhave been mixed up with a newly copied quire, or the works ofseveral scribes could have been bound together» (1993: 47).L’ipotesi è interessante, ma un po’ inverosimile, di nuovo perchénon abbiamo riscontri relativi a questo tipo di operazioni inepoca contemporanea ai manoscritti in questione che datano apartire dalla prima metà del XIII.
VIII. Infine, in ambito italiano, Marco Cursi nel suo recente librosu Il Decameron: scritture, scriventi, lettori, a proposito di alcu-ne particolarità codicologiche del codice di Stoccolma Vu 6 scri-ve: «nella bottega alla quale faceva riferimento il nostro copista—come del resto in quelle cui facevano capo coloro che tra-scrissero i codici Barberiniano latino 4057 e Parigino Arsenal8538— circolavano più copie del Centonovelle, sciolte in fascico-li, messe nello stesso momento a disposizione di scribi differen-ti» (2006: 103). Questa è un’ipotesi che trova corrispondenzanelle modalità di produzione libraria ricostruite da Cursi nellasua indagine.12
Si deve infine sempre tenere conto che una apparente conta-minazione può nascondere innovazioni di natura poligenetica.Ad esempio, nell’ambito della tradizione manoscritta dell’epicafrancese la tipologia del testo fortemente ripetitiva può averindotto i copisti ad introdurre delle varianti formulari in qualchecaso coincidenti in più testimoni (è l’ipotesi più economica e cheevita di postulare una quantità enorme di contaminazioni):
IX. McMillan discute l’edizione Bertin del Moniage Rainouartproprio su questo punto: «on est mystifié par la suggestion qu’ila fallu que copistes, scribes, réviseurs, éditeurs-remanieurs aient
52 TRANSLATAR I TRANSFERIR
12 Si vedano anche le osservazioni di Beltran (2006).
eu sous les yeux deux modèles pour y picorer, tantôt à droite,tantôt à gauche, des alternances aussi banales que : Del port s’e-smeuvent / Del port s’en issent, ou a une aube esclarie / au maina l’esclairie ou encore : volontiers et de grés / de bone volantés»(1997: 56-57).
X. Anche Blecua (1983: 95-96) di fronte alla coincidenza di alter-nanza fra più mss. di El Conde Lucanor delle lezioni XXXVI.5matassen la candela / matassen la lumbre, dopo aver propostola contaminazione, lascia aperta l’ipotesi della poligenesi.
XI. Ancora un esempio dalla tradizione manoscritta della Gestedes Loherains. Il ms. M, appartenente alla cosiddetta famiglialorenese (assieme a EPX) se ne separa in alcune lezioni adiaforecome la seguente:
dieu le glorious del ciel EPXSDdieu qui tot a a jugier M et alii
In sede di valutazione della varia lectio, prima di pensare allacontaminazione, si dovrà tenere aperta la possibilità di innova-zione poligenetica in contesto formulare.13
L’«USUS SCRIBENDI» (DEI COPISTI) O «TRANSCRIBENDI»
Per concludere vorrei parlare di un altro criterio di valutazioneanch’esso menzionato in tutti i manuali. Si tratta delle possibilitàecdotiche che in casi particolari possono derivare dall’esame del-l’usus scribendi del copista (in parte coincidente con la psicolo-gia del copista). Questo criterio si utilizza normalmente all’inter-no di un testo, ma può essere valido anche nei rari casi nei qualila mano dello stesso copista è riconoscibile in più manoscritti oin quelli più frequenti in cui allo stesso scriba si deve la copia dipiù testi in un manoscritto (dai canzonieri alle raccolte antologi-che).
EL TALLER DE CÒPIA 53
13 Si vedano Careri (2001) e Careri – Rinoldi (2004).
I. Chanson de Guillame: il testimone è unico per questa anticachanson de geste pre-ciclica ma il copista aveva trascritto anchenello stesso libro, oggi smembrato in tre manoscritti separati, unaversione dello Pseudo Turpin ed una del Gui de Warwick ,entrambe tradite anche da altri testimoni. L’esame degli erroritipici del copista permette di meglio valutare alcune correzioni altesto del Guillaume (cf. Careri 2002). Si veda il seguente esem-pio, dove se per Gui de Warwick l’integrazione ([fait il]) è opera-ta sulla base della collazione con gli altri testimoni, invece perGuillaume si appoggia al confronto col Gui (qui come altrove ilcopista tende ad omettere i verba dicendi):
Gui 10635 «Sire quons, [fait il], jo m’en irai».Guillaume 2372 «Sire [dist-ele] qu’as tu fait de Walter».
II. L’importante raccolta di testi antico-francesi contenuta nel ms.BNF, n. acq. fr. 4503 riporta tra l’altro la Chanson de Saint Alexis(il manoscritto è siglato A dagli editori) in una redazione piùbreve rispetto a quella degli altri testimoni. Per meglio valutareil rapporto di questa versione con le altre pare importante tene-re conto del fatto che anche gli altri testi copiati dallo stesso ama-nuense nel codice sono in una redazione più corta rispetto aquella degli altri testimoni che li conservano. Dunque allargandol’esame delle lacune a tutti i testi tràditi dal codice (lacunebrevi/lunghe, volontarie/ involontarie ecc.) dovrebbe essere pos-sibile distinguere tra quelle attribuibili allo stadio di copia rap-presentato dal codice conservato (o da un suo antecedente dallostesso contenuto) e quelle derivate dalla tradizione precedente.14
III. Un bell’esempio di applicazione del criterio ci viene offertoda McMillan nell’edizione della Chevalerie Vivien, dove l’editorededica un paragrafo all’«Usus scribendi du copiste» del mano-
54 TRANSLATAR I TRANSFERIR
14 Dunque la «volontà di tagliar corto» potrà essere attribuita non comepropone Eusebi al copista di β, antigrafo di A, ma, almeno in ipotesi, allostesso copista di A, per analogia con gli altri testi da lui copiati (Eusebi 2001:10).
scritto di Oxford (Bodleian Library, French e.32) tenendo contodel fatto che nel codice oltre alla Chevalerie Vivien si trova anchel’Aliscans (1997: 81-119).
IV. In certi casi questa verifica non viene fatta; l’esempio più ecla-tante è quello del codice marciano della Chanson de Roland notoai filologi con la sigla V4. Nello stesso codice e di mano dellostesso copista segue il testo della Chanson d’Aspremont eppurenei tanti studi linguistici, paleografici, filologici su V4 non sitrova una indagine dell’atteggiamento del copista nella trascri-zione dei due testi.
Da quanto esposto fin qui si possono trarre alcune riflessioni.Negli esempi riportati si sono esaminati sia casi di sempliceambiguità terminologica in sede di registrazione di varianti ederrori (la variante comunque è presente e la sua classificazionenon è obbligatoria), sia casi più gravi nei quali all’individuazio-ne del tipo di errore (paleografico, saut du même au même, ecc.)consegue l’applicazione della sua proprietà secondo la teoriastemmatica (monogenetico o poligenetico), il ché ha ovviamenteconseguenze ecdotiche. Nell’insieme risulta che il recente ritor-no ai manoscritti (si è coniato anche il termine molto infelice difilologia materiale) non ha sempre prodotto un cambiamentonella prassi editoriale. Da una parte la passione per i manoscrit-ti (a volte anche maniacale) è spesso svincolata da quella edito-riale e dall’altra gli editori di testi, specie in presenza di tradizio-ni ricche, si soffermano troppo poco sulla realtà manoscritta econtinuano a lavorare in modo teorico e astratto su anonimesigle e varianti. Negli stessi studi ormai alla moda sui canzonieriprovenzali e francesi si è solo raramente cercato di provare acapire se il manoscritto presentava una specificità testuale e dun-que un sistema riconoscibile e razionalizzabile di varianti o dierrori.
EL TALLER DE CÒPIA 55
OPERE CITATE
Andrieux-Reix, Nelly – Monsonego, S., 1997. «Ecrire des phrasesau Moyen Âge, Matériaux et premières réflexions pour uneétude des segments graphiques observés dans des manuscritsfrançais médiévaux», Romania, 115, pp. 289-336.
Andrieux-Reix, Nelly – Monsonego, S., 1999. «Les unités graphi-ques du français médiéval: mots et syntagmes, des représen-tations mouvantes et problématiques», Langue française, 119,pp. 30-51.
Antonelli, Roberto, ed., 1979. Giacomo da Lentini, Poesie, Roma:Bulzoni.
Antonelli, Roberto, 2006. «Per un problema ecdotico “pisano”:Giacomo da Lentini, Meravigliosa-mente», in Studi di Filologiaromanza offerti a Valeria Bertolucci Pizzorusso, Pisa: Pacini,I, pp. 35-65.
Avalle, D’Arco Silvio, 1993. I manoscritti della letteratura in lin-gua d’oc, nuova edizione a cura di Lino Leonardi, Torino:Einaudi.
Barbieri, Luca, 1995. «Doppie lezioni ed arcaismi linguistici pre-vulgata : la stratigrafia delle fonti nel canzoniere provenzaleestense (D)», Cultura Neolatina, LV, pp. 7-40.
Beltran, Vicenç, 2006. «Cubiertas removibles, cuadernos inesta-bles: entre filología y codicología», in Studi di Filologia ro-manza offerti a Valeria Bertolucci Pizzorusso, Pisa: Pacini, II,pp.187-225.
Bertelli, Sandro, 2002. I manoscritti della letteratura italianadelle origini. Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze:Sismel.
Betti, Maria Pia, 2006. «La canzone del trovatore Peire de Maen-sac “Estat aurai de chantar” (BdT 194.7)», in Studi di Filologiaromanza offerti a Valeria Bertolucci Pizzorusso, Pisa: Pacini,I, pp. 227-260.
Bischoff, Bernhard, 1992. Paleografia latina. Antichità e medioe-vo, ed. italiana a cura di G. P. Mantovani e S. Zamponi, Pado-va: Antenore.
Blecua, Alberto,1983. Manual de crítica textual, Madrid: Casta-lia.
56 TRANSLATAR I TRANSFERIR
Brambilla Ageno, Franca,1984. L’edizione critica dei testi volgari,Padova: Antenore.
Busby, Keith, 2002. Codex and Context. Reading Old FrenchVerse Narrative in Manuscript, Amsterdam – New York: Rodo-pi.
Careri, Maria, 1990. Il canzoniere provenzale H (Vat. Lat. 3207),Modena: Mucchi.
Careri, Maria, 2001. «Codici facsimilati e tradizione attiva nellaGeste des Loherains», Romania, 119, pp. 323-356.
Careri, Maria, 2002. «Membra disiecta. I mss. di Londra, BL,Add. 38662 (Gui de Warewic), 38663 (Chanson de Guillau-me) e 40142 (Pseudo-Turpin)», Cultura Neolatina, 62, pp.211-228.
Careri, Maria – Rinoldi, Paolo, 2004. «Copisti e varianti: codicigemelli nella tradizione manoscritta della Geste de Guillaumed’Orange e della Geste des Loherains», Critica del testo, 7.1,pp. 41-104.
Chiesa, Paolo, 2002. Elementi di critica testuale, Bologna: Pàtron.Cursi, Marco, 2007. Il Decameron: scritture, scriventi, lettori,
Roma: Viella.Dain, Alphonse, 1964. Les manuscrits, Paris: Les Belles Lettres.Edwards, A. S. G. – Pearsall, Derek, 1989. «The Manuscripts of the
Major English Poetic Texts», in Book Production and Publi-shing in Britain, 1375-1475, ed. J. Griffiths – D. Persall, Cam-bridge University Press, pp. 257-278.
Eusebi, Mario, 2001. La Chanson de Saint Alexis, Modena: Muc-chi.
Giunta, Claudio, 2006. «Quando eu stava, V.11», in Studi di Filo-logia romanza offerti a Valeria Bertolucci Pizzorusso, Pisa:Pacini, I, pp. 653-656.
Gorni, Guglielmo, 1996. Dante Alighieri, Vita Nova, Torino:Einaudi.
Havet, Louis, 1911. Manuel de critique verbale appliquée aux tex-tes latins, Paris: Hachette; rist. Roma: L’Erma di Bretschnei-der, 1967.
Lachin, Giosuè, 2004. Il trovatore Elias Cairel, Modena: Mucchi.Lazzerini, Lucia, 2006. «Zoonimi e cruces interpretative nella liri-
ca dei trovatori: i casi di Marcabru e Peire de Cols», CulturaNeolatina, LXVI , pp. 7-44.
EL TALLER DE CÒPIA 57
Leonardi, Lino, ed., 1994. Guittone d’Arezzo, Canzoniere. I sonet-ti d’amore del codice Laurenziano, Torino: Einaudi.
Martí, Sadurní – Guixeras David, 2002. «Apunts sobre la tradiciódel Dotzè del Crestià I», in Literatura i Cultura a la Coronad’Aragó (S. XIII-XV), ed. L. Badia – M. Cabré – S. Martí, Bar-celona: PAM, pp. 211-223.
McMillan, Duncan, 1997. La Chevalerie Vivien, Aix-en-Provence:CUERMA.
Micha, Alexandre, 1939. La tradition manuscrite de romans deChrétien de Troyes, Paris: Droz.
Milone, Luigi, 2004. «Cinque canzoni di Raimbaut d’Aurenga(389, 3, 8, 15, 18 e 37)», Cultura Neolatina, LXIV, pp. 7-185.
Mulken, Margot van, 1993. «Perceval and Stemmata», in Lesmanuscrits de Chrétien de Troyes, ed. K. Busby, T. Nixon, A.Stones, et L. Walters, Amsterdam: Rodopi, I, pp. 41-48.
Renedo, Xavier, ed., 2005. Francesc Eiximenis, Dotzè llibre delCrestià, coord. S. Martí, Universitat de Girona: Obres de Fran-cesc Eiximenis.
Roncaglia, Aurelio, 1975. Principi e applicazioni di critica testua-le, Roma: Bulzoni.
Roncaglia, Aurelio, 1993. «L’immagine paleografico-visiva dell’an-tecedente perduto e l’immagine intellettuale della strutturaoriginaria, strumenti di critica del testo», in La filologiaromanza e i codici, a cura di S. Guida e F. Latella, Messina:Sicania, pp. 15-28.
Segre, Cesare, 1961. «Appunti sulla contaminazione dei testi inprosa», in Studi e problemi di critica testuale, Bologna: Pàtron,pp.63-67; rist. Segre 1998.
Segre, Cesare, 1998. Ecdotica e comparatistica romanze, Milano– Napoli: Ricciardi, pp. 71-74
Soler i Llopart , Albert, 1995. Ramon Llull, Llibre d’amic i amat,ENC.
Stussi, Alfredo, 1994. Introduzione agli studi di Filologia Italia-na , Bologna: Il Mulino.
Tavani, Giuseppe, 1997. Lezioni sul testo. L’Aquila – Roma: Japa-dre.
Timpanaro, Sebastiano, 2002. Il lapsus freudiano. Psicanalisi ecritica testuale, a cura di F. Stok, Torino: Bollati Boringhieri(I ed. Firenze: La Nuova Italia, 1974).
58 TRANSLATAR I TRANSFERIR
Varvaro, Alberto, 1999. «Il testo letterario», in Lo spazio letterariodel Medioevo. 2. Il Medioevo volgare. 1. La produzione deltesto, ed. Pietro Boitani, Mario Mancini, Alberto Varvaro,Roma: Salerno, vol. 1, pp. 387-422.
Varvaro, Alberto, 2001. «Elaboration des textes et modalités durécit dans la littérature française médiévale», Romania, 119,pp. 1-75; rist. Varvaro 2004, pp. 285-355.
Varvaro, Alberto, 2004. Identità linguistiche e letterarie nell’Eu-ropa romanza, Roma: Salerno, pp. 285-355.
West, M. L., 1991. Critica del testo e tecnica dell’edizione, Paler-mo: L’Epos; trad. italiana dell’ed. Stuttgart: Teubner, 1973.
Zinelli, Fabio, 2006. «L’Édition des textes médiévaux italiens enItalie», in Pratique philologiques en Europe, éd. F. Duval, Paris:École de Chartes, Études et rencontres de l’École des Chartes,21, pp. 77-113.
EL TALLER DE CÒPIA 59























![Filologia dei testi a stampa, Cagliari, CUEC, 2008 [pdf integrale del volume]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6324f849c9c7f5721c01d64a/filologia-dei-testi-a-stampa-cagliari-cuec-2008-pdf-integrale-del-volume.jpg)