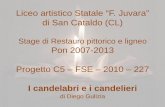Costruzione e rappresentazione nel Quarticciolo: l’architettura come simulazione della città
COME RACCOGLIERE E CONSERVARE I FRUTTI (FOSSILI!)
Transcript of COME RACCOGLIERE E CONSERVARE I FRUTTI (FOSSILI!)
Su
pp
lem
en
to a
l Bo
llettin
o d
ella
So
cie
tà P
ale
on
tolo
gic
a Ita
lian
a v
.39
n.3
Sp
ed
izio
ne
in A
.P. -
45
%, co
mm
a 2
0/B
- L
eg
ge
66
2/9
6, F
ilia
le E
PI d
i Mo
de
na
. Ta
xe P
erç
ue
. Ta
ssa
ris
coss
a.
MUCCHI - MODENA
Newsletter della Società Paleontologica Italiana
Numero 3Febbraio 2001
PaleoItaliaPaleoItalia
PALEOITALIA4
La nascita di questo utile perio-dico d’informazione paleontologicami ha spinto a richiamare l’attenzio-ne di appassionati e professionisti,che sono sempre alla ricerca di nuo-vi documenti della vita passata, suuna categoria di fossili sinora larga-mente trascurata, eppure piuttostofrequente nelle rocce sedimentariedella nostra giovane penisola. Sitratta delle strutture riproduttivemacroscopiche (o quasi) prodottedalle piante terrestri, strutture spes-so dotate di parti coriacee (benchénon mineralizzate) che possono fa-cilmente sfuggire ai processi di de-composizione e, qualora venganotrasportate in un ambientedeposizionale adatto, possono poiconservarsi per milioni di anni sen-za apprezzabili trasformazioni(“mummificate”).
Le ricerche condotte negli ulti-mi vent’anni in Italia hanno permes-so di individuare associazioni fos-sili a frutti e semi, con una diversitàvariabile da 5-6 a più di 100 specie(Ca’ Viettone e Sento nel Pliocenepiemontese), in una cinquantina disiti fossiliferi, per lo più delPliocene-Pleistocene inferiore (vedibibliografia). E’ comunque proba-bile che molti altri giacimenti inte-ressanti siano ancora del tutto sco-
nosciuti, soprattutto in Italia meri-dionale, area in cui sono noti benpochi fossili di vegetali terrestri.
Il merito delle pregressesegnalazioni di alcuni fra i siti piùinteressanti va ad alcuni appassio-nati, che svolgono ricerche con cu-riosità e meticolosità simili a quelledei professionisti, per di piùattingendo alle loro personali risor-se finanziarie. Per esempio il sig.Ecclesia segnalò diversi anni fa alloscrivente una successione pliocenicaparticolarmente ricca di resti“mummificati” di piante terrestri,affiorante nell’alveo del T. Cervopresso Biella. Essa ha restituito,dopo settimane di analisi ecampionamenti sul terreno e mesi dilavoro in laboratorio, diverse florefossili ancora in corso di studio esolo in parte in via di pubblicazione(Cavallo & Martinetto, in stampa).
Altre interessanti segnalazionisono pervenute dal dott. Rattazzi,che ha rinvenuto minuti resti di pian-te terrestri nei sedimenti marini delCretaceo e Paleocene dell’Appen-nino Ligure, e dal sig. Giuntelli, cheha recentemente scoperto alcunistrati ricchi di frutti e semi fossilinel Pliocene continentale di Fossano(Cuneo). Al fine di agevolare chivolesse cimentarsi in ricerche di
COME RACCOGLIERE E CONSERVAREI FRUTTI (FOSSILI!)
EDOARDO MARTINETTO
PALEOITALIA 5
questo genere tenterò di illustrare diseguito gli indizi utili al riconosci-mento dei sedimenti fossiliferi adattie le metodologie di estrazione e con-servazione dei “carpoliti”, terminecon cui si usa designare i resti fossi-li di frutti, semi, strobili ed altrestrutture ad essi annesse.
Metodi di estrazione e prepara-zione
Strati contenenti resti di vegetaliterrestri sono presenti in molte suc-cessioni sedimentarie, sia marineche continentali, ma i più interessan-ti per lo studio dei carpoliti sonoquelli costituiti da sedimenti pococoerenti o incoerenti, con un bassogrado di carbonificazione della so-stanza organica, di cui sono chiariindizi il colore bruniccio e l’aspettofibroso dei legni fossili (alla frattu-ra). Se poi, osservando bene le su-perfici degli affioramenti, si identi-
ficano delle concentrazioni di fram-menti di legno o addirittura si nota-no dei frutti macroscopici che spor-gono dal sedimento, è probabile checi si trovi di fronte a un depositointeressante. Le probabilità di suc-cesso sono maggiori in depositifluvio-palustri, lacustri o deltizi, tut-tavia i carpoliti si trovano frequen-temente anche in facies di mare bas-so. In Italia le suddette condizionisi incontrano per di più in sedimen-ti più recenti del Tortoniano, poichéquelli più antichi risultano di solitotroppo cementati o troppo compat-ti.
Onde evitare facili delusioni con-viene specificare che, vista l’abbon-danza di materiale disponibile, ilsingolo reperto o una collezione dipochi resti problematici, difficil-mente potrà interessare agli specia-listi della materia. Diverso è il casoin cui una nuova località forniscaqualche decina di specie di carpoliti:
Piccolo e delicato frutto di betulla rinvenuto nei sedimenti tardo-pliocenici (2 milioni dianni circa) di Castelletto Cervo, Piemonte. Si noti come si siano conservati anche i mini-mi dettagli: ali membranose, stili e semi (visibili in trasparenza).
PALEOITALIA6
indipendentemente dall’età edall’ubicazione del sito, l’interesseè garantito!
Per l’estrazione di frutti e semidai sedimenti viene usualmenteadottata la seguente procedura:• campionamento in massa dei se-
dimenti con resti vegetalicarbonificati: a volte è necessarioprelevarne decine di dm3 per ot-tenere un buon risultato;
• disgregazione dei sedimenti trami-te immersione in perossido diidrogeno diluito;
• setacciatura con eliminazione del-la frazione terrigena;
• estrazione (picking) degli elementifossili determinabili in base allasola morfologia, i quali rappresen-tano di solito una esigua porzionedel residuo.
Si ottiene così un’associazionecostituita da vari “carpoliti”: frutti,semi, strobili ed altre strutture an-nesse a questi organi. Si possonoanche prendere in considerazionemegaspore di Pteridofite (“felci”acquatiche come Azolla), foglieaghiformi e rametti di Conifere, chehanno una robustezza sufficiente daresistere alle preparazioni.
Il materiale necessario è il se-guente:- perossido di idrogeno concentra-
to, da diluire in soluzione acquosaal 3% per la disgregazione dei se-dimenti;
- tele con maglie di ca. 0,3 mm e reticon maglie di ca. 1,5 mm per lasetacciatura;
- una pinzetta e un pennellino perl’estrazione dei carpoliti;
Schema del procedimento utilizzato per estrarre i carpoliti dai sedimenti.
PALEOITALIA 7
- polietilenglicole 4000 (PEG), unasostanza solida idrosolubile simi-le a scaglie di sapone, utile per ilconsolidamento dei fossili mag-giori e reperibile presso i rivendi-tori di prodotti chimici;
- stereomicroscopio o una buonalente per la selezione e identifica-zione dei fossili (gli specialistiimpiegano spesso anche il micro-scopio elettronico a scansione).
Alcuni sedimenti sabbiosi pos-sono essere setacciati direttamentesul terreno, utilizzando l’acqua cor-rente di un fiume o acqua stagnante(conviene usare maglie di circa 1,5mm). I sedimenti argillosi e limosivanno invece trattati in “laborato-rio”, il quale può semplicementeessere rappresentato da un lavandi-no di servizio o da una presa d’ac-qua in giardino. Normalmente con-viene lasciar asciugare il sedimentoe quindi sminuzzarlo in blocchettidi dimensioni non superiori a 10 cm.A questo punto si può immergere ilmateriale in perossido di idrogeno,la cui quantità e concentrazione van-no adattate al tipo ed al volume disedimento: in linea di massima siottiene un buon risultato con unasoluzione al 3%, in quantità pari alvolume del sedimento campionato.
Una volta terminata la disgrega-zione, quando il perossido d’idro-geno non è ancora del tutto esaurito(da mezz’ora a due ore), si deveaggiungere acqua sino a riempirecompletamente il recipiente. Con-viene quindi lasciar decantare perqualche minuto in modo che resti agalla solo il materiale con peso spe-cifico minore, come semi e frutti didimensioni millimetriche oppureresti di varia natura che contengono
cavità riempitesi di gas. A questopunto, versando lentamente il liqui-do in tele con maglie del diametrodi circa 0,3 mm, si possono concen-trare i frutti, semi e affini, i qualitendono a galleggiare in quanto leloro cavità interne si riempiono digas.
Gli elementi di grandi dimensio-ni, come frammenti di legno, alcunifrutti e pigne, saranno ovviamenterimasti sul fondo del recipiente didisgregazione con la maggior partedel sedimento. Questa porzione va“sciacquata” per pochi minuti conun getto d’acqua, versando il mate-riale in sospensione in una rete (ot-tima è la rete antizanzare che si ac-quista in ferramenta, con maglie di1,5 mm).
Se il campione originario conte-neva una frazione di sabbia grosso-lana o ghiaia, questa sarà rimasta alfondo del recipiente di disgregazio-ne e potrà essere esaminata somma-riamente ad occhio nudo, perchénormalmente non contiene molti“carpoliti”. Tutte le frazioni di resi-duo precedentemente isolate vannolasciate all’aria aperta fino a che ivari frammenti non aderiscano piùfra loro, pur rimanendo umidi (se siseccano possono guastarsi); a que-sto punto possono essere nuovamen-te setacciate in modo da ottenere unfrazionamento in 3-4 classi dimen-sionali, per esempio < 1,5 mm, tra1,5 e 3 mm, > di 3 mm.
Poiché i carpoliti “mummificati”di dimensioni superiori a circa 3 mm(ma soprattutto quelli > 10 mmcome le pigne) si deterioranoirrimediabilmente in seguito ad ec-cessiva disidratazione è necessarioprelevarli ancora umidi ed immer-
PALEOITALIA8
gerli in una soluzione acquosa al 30-40% in peso di polietilenglicole4000 (PEG). La fase di immersionesi può prolungare per diverse setti-mane, in modo che il PEG impre-gni bene i fossili e l’acqua evaporilentamente dal recipiente (un cati-no o vassoio aperto, protetto concarta porosa), fino a che la soluzio-ne non assume una consistenza ole-osa. Ad impregnazione ultimata ilmateriale può essere scolato edasciugato; è anche possibile elimi-nare a posteriori un eventuale ecces-so di PEG risciacquando rapida-mente. L’aspetto finale è di solitomolto soddisfacente.
La frazione di residuo costituitada particelle di dimensioni inferioriai 3 mm può essere lasciata essicca-re senza che sia sottoposta ad alcunparticolare trattamento. Questa par-te di residuo è destinata all’analisicon lo stereomicroscopio per indi-viduare gli elementi utili(“carpoliti”, ecc.) e separarli dalla
gran massa di frammenti legnosinon identificabili su basemorfologica. Gli esemplari così iso-lati possono essere conservati incontenitori adatti (provette di vetro,scatolette di plastica, ecc.) per deisecoli, come provano le collezionidei coniugi Reid, depositate pressoil Natural History Museum di Lon-dra da fine ‘800.
Identificazione e interpretazione
L’identificazione dei carpoliti ètutt’altro che facile, poiché non esi-stono atlanti iconografici esaurienti(pochi anche quelli che raffiguranomateriale attuale) e le pubblicazio-ni necessarie, benché abbondanti,sono scritte in almeno 5 lingue (fracui il russo) e sono disperse su variperiodici difficilissimi da reperire.Al momento direi che è indispensa-bile, per l’appassionato che vogliaaddentrarsi in questa materia, pren-dere contatti con uno specialista; a
Confronto fra unasquama fossile (im-pronta del Pliocenepiemontese) e una at-tuale di Pseudolarix,una conifera a fogliecaduche che oggi cre-sce solo su alcunimonti della Cina.
PALEOITALIA 9
tal scopo può risultare utile consul-tare il sito internet del Dipartimen-to di Scienze della Terra di Torino(http://www.dst.unito.it/ricerca/paleocarp/paleocarpnorth.htm), cheattualmente dedica alcune paginealla paleocarpologia, incluso il rap-porto annuale “Palaeocarpology ofthe Northern Hemisphere”, dove èpossibile trovare indirizzi ebibliografia dei principali speciali-sti.
Molto utile per perfezionarel’identificazione dei reperti risulta ilconfronto con frutti e semi attuali,ma anche in questo campo le diffi-coltà non mancano, poiché nellecollezioni botaniche italiane non è
facile trovare frutti e semi di pianteesotiche, di solito molto abbondan-ti nelle associazioni a carpoliti delCenozoico.
Un aspetto che può incoraggiarele ricerche sui carpoliti è la relativafacilità di imbattersi in nuovi taxa,vista la scarsità di ricerche sistema-tiche in questo settore; basti pensa-re che il paleobotanico tedesco Mai,in un lavoro del 1995, ha descrittoben 6 specie nuove nel suo studiosulla flora del Pliocene continenta-le di Villafranca d’Asti. In effettiqualche esemplare di frutto o semefossile è presente in quasi tutte lecollezioni paleontologiche italiane,tuttavia si tratta di raccolte occasio-
Distribuzione attuale e passata di Sargentodoxa, una liana della Cina meridionale recen-temente documentata allo stato fossile anche in Europa.
PALEOITALIA10
nali e non del risultato di indaginispecifiche e continuative. Non cre-do di errare sostenendo che soltan-to presso il Dipartimento di Scien-ze della Terra di Torino è attualmen-te conservata una collezione in gra-do di documentare la diversità delleassociazioni a carpoliti del tardoCenozoico italiano. Tale collezioneattualmente conta circa 3000 esem-plari isolati e classificati e un nume-ro ancor maggiore di fossili da or-dinare. Ovviamente non si tratta dimateriale con un interesse puramen-te collezionistico, anzi pur da appas-sionato del genere, devo confessareche tali reperti si presentano spessopiuttosto antiestetici o insignifican-ti al confronto con altri tipi di fossi-li. Tuttavia la loro identificazione einterpretazione ecologica può con-sentire la raccolta di una gran moledi informazioni paleoclimatiche ebiogeografiche. Ad esempio sco-priamo che le Magnolie, alberi cheoggi crescono spontanei solo inAmerica ed Asia, erano presenti inItalia con ben tre specie nel Plioceneinferiore-medio (circa 3-4 milioni dianni fa), una delle quali permanesino al Pleistocene inferiore. Nellostesso intervallo di tempo erano pre-senti in Italia anche diverse liane adaffinità tropicale-subtropicale cheindicano clima più caldo dell’attua-le: Cyclea, Toddalia, Sargentodoxa(fig a pag. 9). La lista potrebbe con-tinuare a lungo, ma tutto sommatosi può concludere in breve afferman-do che la flora pliocenica italiananon doveva discostarsi di molto dal-la rigogliosa e varia flora della Cinadei giorni nostri. Proprio la consa-pevolezza di questo drastico cam-biamento della flora, in poco più di
due milioni di anni, fa sperare checon il procedere degli studi le asso-ciazioni a carpoliti possano rivelar-si utili per risolvere problemistratigrafici relativi ai depositi con-tinentali tardo-cenozoici.
Bibliografia
CAVALLO O. & MARTINETTO E., 1996, Floreplioceniche del bacino del Tanaro. AlbaPompeia, 17 (1): 5-31.
CAVALLO P. & MARTINETTO E., in stampa,Flore carpologiche del Pliocene diCastelletto Cervo (Biella). Boll. Mus.Reg. Sci. Nat. Torino.
GHIOTTO, P., 1995, Contributo preliminareallo studio della macroflora del bacinolacustre “villafranchiano” di Steggio(Prealpi Venete, Italia Settentrionale). IlQuaternario, It. J. Quat. Sci., 8: 193-202;Roma.
GREGOR H.-J., 1986. Preliminary reportabout the macrofloral history of theStirone-River sequence (Zanclean,Piacenzian, “Calabrian”). Mem. Soc.Geol. It., 31: 219-227.
GREGOR, H.-J., 1990, Contribution to theLate Neogene and Early Quaternaryfloral history of the Mediterranean. Rev.Paleobot. Palynol., 62: 309-338.
MAI, D.H., 1995, Palaeocarpologicalinvestigations in the Villafranchian(Pliocene) of Italy. Boll. Mus. Reg. Sci.Nat. Torino, 13 (2): 407-437.
MARTINETTO E., 1994a, Analisipaleocarpologica dei depositi continen-tali pliocenici della Stura di Lanzo. Boll.Mus. Reg. Sci. Nat. Torino, 12 (1): 137-172.
MARTINETTO E., 1994b, Paleocarpology andthe “in situ” ancient plant communitiesof a few Italian Pliocene fossil forests.In: Matteucci R., Carboni M.G. & PignattiJ.S. (eds.): Studies on Ecology andPaleoecology of Benthic Communities -Boll. Soc. Paleont. Ital. Spec. Vol. 2, pp.189-196, Mucchi, Modena.
MARTINETTO E., in stampa, Chronologicalframing of Pliocene to Early Pleistoceneplant macrofossil assemblages fromnorthern Italy. Acta Palaeobot.