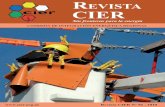Arnaldo Momigliano lettore di Droysen, «Incidenza dell’antico», 8, 2010, 39-79.
Transcript of Arnaldo Momigliano lettore di Droysen, «Incidenza dell’antico», 8, 2010, 39-79.
Incidenza dell’Antico 8, 2010, 39-79
ARNALDO MOMIGLIANO LETTORE DI DROYSEN
Julius Beloch e Gaetano De SanctisLa questione riguardante il dialogo che in un lungo arco di tempo Arnaldo Momigliano intrattenne con Johann Gustav Droysen appare cospicua sotto punti di vista differenti. In primo luogo perché entrambi si occuparono ap-profonditamente di Storia antica e della Tarda Antichità; poi, perché tanto le riflessioni dello storico piemontese come quelle droyseniane sembrano sempre insofferenti verso qualsivoglia limite di carattere disciplinare. Per-tanto non stupisce che all’interno dei loro saggi la storia dell’antichità lasci spazio alla riflessione riguardante la Weltgeschichte e al ruolo qui svolto dai singoli popoli; o, ancora, ed è questo soprattutto il caso di Momigliano, che il piano storico incroci quello storiografico ed entrambi siano posti in comunicazione con quello legato in maniera precipua alla situazione politica del presente.
D’altronde la convinzione che la Storia si occupasse di ciò che, come risultato o residuo, apparteneva ancora al presente, aveva costituito un punto fermo nella riflessione di Droysen sin dal 1857, anno in cui tenne per la prima volta a Jena il corso sulla Istorica, le lezioni su enciclopedia e me-todologia della scienza storica1. Proprio il legame col presente rende le sue
1 «Noi non osserviamo noi stessi con sufficiente attenzione se riteniamo che ciò che in tal modo definiamo storico appartenga effettivamente alle epoche passate, da esse continui a parlare fino a noi, sia il loro stesso linguaggio. Esse sono effettivamente passate, tranne che in quel punto che di loro ancora è presente come risultato o come residuo. Se non indaghiamo con acume il cammino
Francesco GuerraUniversità degli Studi di Pisa
40 FRANCESCO GUERRA
opere qualcosa che sempre travalica il singolo oggetto preso in esame. La narrazione delle gesta di Alessandro e i lavori sull’Ellenismo illuminano non solo quei secoli della storia dell’umanità ritenuti fino ad allora erroneamente bui, ma offrono a Droysen spunti di riflessione per comprendere le dinamiche politiche del proprio tempo, il ruolo assunto e l’importanza acquisita dalle singole personalità storiche nel succedersi degli eventi, elementi decisivi anche ai fini della sua riflessione metodologica.
Parimenti, guardando ai lavori di Momigliano, non si può fare a meno di notare come le pagine da lui dedicate all’Ebraismo rispondessero a un’esi-genza non solo storica, ma anche biografica, di reinserimento del popolo ebraico nella trama della storia universale. Da questo angolo visuale le per-sonalità dei due storici sembrano per certi versi affini e talvolta, su precipui punti, quasi collimare. Entrambi hanno cercato nella storia antica qualcosa che sempre la supera, quel contesto weltgeschichtlich entro il quale gli eventi storici subiscono una vera e propria torsione in senso filosofico. Era stato questo il luogo in cui Droysen aveva sostituito Roma con la Macedonia di Alessandro Magno e relegato Atene all’anacronismo di una enclave demo-cratica in un periodo segnato dallo scontro tra differenti forme di monarchia quali quella macedone e persiana.
Da parte sua Momigliano, su questo punto fedele alla lezione mommse-niana, riconnetteva quel contesto weltgeschichtlich piuttosto alla storia di Roma che non a quella della Macedonia, sebbene nel 1934 avesse dedicato un saggio fondamentale alla figura di Filippo il Macedone2; mentre, per quanto concerne l’Ellenismo, ossia i secoli successivi alla morte di Alessandro, lo storico piemontese sarà inizialmente vicino alle posizioni di Droysen e al tempo stesso ne prenderà lentamente, ma in maniera sostanziale, le distan-ze: vale a dire che, se da un lato la cornice entro la quale Droysen aveva
del nostro ricercare e del nostro conoscere, ma anche nella scienza cadiamo nell’assuefazione [alla nostra percezione e al nostro pensiero], non facciamo altro che stipare la notte delle epoche passate di immagini, rappresentazioni e nessi schematici per poi chiamare tutto ciò storia; analogamente, nel disegnare le carte geografiche, si fa uso di segni convenzionali per indicare le montagne, le città, ecc.: solo che il viaggiatore non pretenderà poi di vedere l’equatore in carne ed ossa, o di riscontrare qualche somi glianza tra il vero Monte Bianco e la sua stilizzazione carto grafica. {Non dunque l’accaduto, né tutto ciò che è acca duto né solo la più parte o una determinata parte di esso è storia. Poiché l’accaduto è passato nella misura in cui fu di natura esteriore, e nella misura in cui non è pas sato, esso appartiene al presente, non alla storia»: J.G. Droysen, Istorica. Lezioni di enciclopedia e metodologia della storia (1857), tr. it. di S. Caianiello, Napoli 1994, 86 [tr. it. di Texte zur Geschichtstheorie. Mit ungedruckten Materialen zur ‘Historik’, hrsg. v. G. Birtsch und J. Rüsen, Göttingen 1972; Historik. Die Vorlesungen von 1857, hrsg. v. P. Leyh, Stuttgart - Bad Canstatt 1977].
2 A. Momigliano, Filippo il Macedone. Saggio sulla storia greca del IV secolo a.C., Firenze 1934 (= Momigliano 1934). L’opera fu ripubblicata, postuma, nell’ottobre del 1987 con una nuova ‘Prefazione’ di Momigliano e una appendice bibliografica curata dallo storico piemontese e da Giampiera Arrigoni.
41ARNALDO MOMIGLIANO LETTORE DI DROYSEN
trattato quel periodo storico è mantenuta da Momigliano, per altro verso l’inserimento del popolo ebraico all’interno di questo quadro rappresenta un elemento di rottura rispetto a quanto sostenuto da Droysen in entrambe le edizioni della Geschichte Alexanders des Großen e della Geschichte des Hellenismus3.
Quanto fin qui sostenuto sembrerebbe profilare una ricezione di Droysen in Momigliano, per così dire, mediata da figure quali Julius Beloch, Gaetano De Sanctis, che di Momigliano fu maestro, e quella, non meno significativa, di Felix Gilbert. Beloch è un nome di cui occorre tenere conto non solo per gli intensi rapporti che questi ebbe con De Sanctis quanto per il ruolo di ponte tra cultura classica di scuola tedesca e italiana da lui svolto negli anni di insegnamento a Roma.
Nel lavoro di Beloch Le monarchie ellenistiche e la repubblica romana, pubblicato con questo titolo in Italiano nel 1933, il professore tedesco in apertura del volume sembrava riprendere quasi integralmente la classica tesi droyseniana secondo la quale alla base della rovina della nazione greca non vi era stata solo la capacità militare e organizzativa della Macedonia di Filippo e Alessandro, bensì quella Kleinstaaterei, quel particolarismo e ristrettezza di vedute in ambito di politica internazionale che non aveva permesso ai Greci, sebbene Droysen pensasse soprattutto agli Ateniesi, di comprendere gli sviluppi della storia universale4. La trascuratezza della dimensione weltge-schichtlich della politica aveva, di fatto, decretato l’inesorabile declino della nazione greca. La situazione politica si era progressivamente polarizzata in una dicotomia tra impero persiano e macedone, che avrebbe condotto a uno scontro tra differenti modelli monarchici e costretto la democrazia ateniese, o ciò che ne rimaneva, a sposare l’una o l’altra causa. Beloch nel suo saggio, scrivendo sull’impero macedone, osservava:
La politica dei piccoli stati fu la maledizione della nazione greca. Era sua la colpa se l’espansione coloniale nel corso del VI secolo era venuta ad arrestarsi, e se poi, al principio del IV secolo, gran parte del mondo greco era caduta sotto il dominio straniero, e se il re dei Persiani era divenuto arbitro degli affari della Grecia. Infine era riuscito al re Filippo, dopo la vittoria di Cheronea, di unificare la Grecia nella forma di una confederazione di stati sotto l’egemonia macedone.
3 La Geschichte Alexanders des Großen era apparsa nel 1833, mentre inizialmente la Geschichte des Hellenismus era formata dai due volumi Geschichte der Nachfolger Alexanders (1836) e Geschichte der Bildung des hellenistischen Staatensystems (1843). Nella scansione della seconda edizione, risalente al biennio 1877/1878, la Geschichte Alexanders des Großen costituiva il primo volume della Geschichte des Hellenismus, la Geschichte der Diadochen il secondo, mentre l’ultimo era costituito dalla Geschichte der Epigonen.
4 Si veda Droysen 1931 [1833], 462-468, e J.G. Droysen, ‘Teologia della storia’, in Droysen 1966 [1857], 377-394.
42 FRANCESCO GUERRA
Ma l’opera fu compiuta solo a metà; rimaneva ancora il compito di liberare i fratelli d’Asia dall’oppressione del giogo persiano5.
Questa liberazione, che coinciderà col crollo dell’impero persiano, sarà il lavoro storico che svolgerà Alessandro, come messo in evidenza nelle pagine successive da Beloch, la cui riflessione, pur nella brevità dell’esposizione, era di nuovo debitrice alla prospettiva droyseniana. Su un altro punto, tutta-via, l’ex-allievo di Mommsen e lo storico di Alessandro trovavano una più profonda sinergia. Riferendosi in maniera del tutto critica alle sollevazioni che si verificarono in Grecia alla notizia della morte di Alessandro, Beloch concludeva:
La plebe vede solo gli attori che agiscono sulla scena del mondo: per le forze che operano dietro di loro e dominano in realtà lo svolgimento della storia, le manca ogni comprensione. Questo avvenne allora in Atene6.
Lo sguardo portato sulla storia antica non si limita, perciò, alla mera narra-zione degli eventi che in antico si sono svolti, piuttosto si prefigge di dare risposta a interrogativi di carattere storico-filosofico.
La politica dei piccoli stati e il sempre più diffuso frazionamento della vita statale greca avevano sullo sfondo una mancata comprensione degli svolgimenti politici in atto, ragione per cui la Grecia era condannata a vi-vere nel ricordo di un passato ormai svanito e a subire al presente la domi-nazione persiana, mentre le rivolte scatenatesi contro la Macedonia dopo la morte di Alessandro evidenziavano una pressoché totale sottovalutazione dell’impero macedone come potenza mondiale. La forza di Alessandro, non spentasi con la sua morte, restava impressa nella formazione e prepa-razione del proprio esercito e, più in generale, nelle strutture amministrati-ve e militari del suo impero. Atene, pensa Beloch con Droysen, deve subire lo scacco perché ancora una volta non ha compreso l’entità dello scontro e le reali capacità proprie e dell’avversario7.
5 Beloch 1933, 3. 6 Ibidem, 8. 7 «Atene dovette accogliere un presidio nel Pireo e la sua costituzione dovette mutarsi in senso
oligarchico. Da allora, per la durata di un secolo, con brevi intervalli, essa rimase soggetta alla Macedonia: il suo dominio sul mare era per sempre finito»: Beloch 1933, 8. Cfr. Droysen 1931 [1833], 3. Pur essendosi qui cercate le somiglianze tra talune posizioni droyseniane e questa opera di Beloch, nel complesso è del tutto condivisibile quanto sostenuto nel 1917 da Arthur Rosenberg, nella ‘Einleitung’ di J.G. Droysen, Geschichte Alexanders des Großen, hrsg. v. S. Hedin und A. Rosenberg, Berlin 1917, XIII-XIV, e nel 1931 da Helmut Berve, nel ‘Nachwort’ in Droysen 1931 [1833], 515-516. In generale su Beloch, anche in rapporto a Droysen, si veda A. Momigliano, ‘Giulio Beloch’, in Dizionario Biografico degli Italiani, VIII, Roma 1966, 32-45 (= Id., Terzo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, I, Roma 1966, 239-265).
43ARNALDO MOMIGLIANO LETTORE DI DROYSEN
Beloch morì nel 1929, mentre sulla cattedra di Storia antica all’Università di Roma andrà, pur per un tempo assai breve, appena due anni, Gaetano De Sanctis. Questi nel 1932, dunque un anno prima della pubblicazione della traduzione del testo di Beloch cui si è fatto riferimento, pubblicò il volume dal titolo Problemi di storia antica, che conteneva un aperto riconoscimento del lavoro storiografico svolto dal suo maestro Beloch. Parimenti De Sanctis tornava su taluni aspetti che incrociavano il nome di Droysen. Nelle pagine dedicate alla storia greca, compresa nel periodo che va dalla pace di Antal-cida fino alle battaglie di Leuttra e Mantinea, lo storico romano riprendeva, variandone più il tono che la sostanza, alcuni argomenti già messi in luce in precedenza da Beloch:
La necessità della unione fondata sopra una parziale rinunzia alle autonomie appariva chiara alle menti elette, e se ne faceva eco il maggior pubblicista di allora, l’ateniese Isocrate. Soltanto, fiaccate le potenze egemoniche, non si vedeva quale potesse essere il centro intorno a cui radunarsi. Diede questo centro Filippo di Macedonia. Lasciando da parte la questione, su cui si sono inutilmente gingillati gli storici, se i Macedoni fossero o no di razza greca, essi si fecero certamente greci di nazionalità col loro proposito di immedesimarsi tutti gli elementi essenziali della civiltà greca, di fare del greco la loro lingua culta, d’inserirsi nella storia della nazione, dirigendo la nazione stessa al con-seguimento di quegli ideali a cui effettivamente mirava […]. Aver chiarito, insistendo sulla via già segnata dal Droysen, che la battaglia di Cheronea non segna la fine della storia greca, ma il principio di un nuovo sviluppo di essa, che ebbe capitale importanza nella storia della civiltà mondiale, è merito pre-cipuo di Giulio Beloch8.
Di fronte alla forza espressa dal potere del Gran Re, agli stati greci non rima-neva altra possibilità che quella di riunirsi attorno ad un forte centro al fine di arginare l’inarrestabile, così almeno sembrava essere prima dell’ascesa di Alessandro, espansione persiana. Alla base di questo ragionamento di De Sanctis si trovava quel medesimo redde rationem nei confronti soprattutto di Atene e delle sue istituzioni democratiche già presente nelle pagine della pri-ma edizione della Geschichte Alexanders des Großen di Droysen e in quelle di Beloch richiamate in precedenza. In tal modo la rinuncia alle autonomie, corrispettivo desanctisiano della droyseniana Kleinstaaterei, costituiva la prima condizione per rintracciare quel centro attorno a cui riunirsi.
Nell’opera condotta da Filippo di Macedonia, prima, e da suo figlio Ales-sandro, poi, è possibile ritrovare quel coordinamento all’interno della vita politica greca, la cui assenza prolungata era stata all’origine della sostanziale
8 De Sanctis 1932, 23.
44 FRANCESCO GUERRA
egemonia persiana sui frammentati territori greci. Alla luce di una siffatta prospettiva, droyseniana prima ancora che belochiana, De Sanctis respingeva come priva di significato la questione della vera o presunta appartenenza greca dei Macedoni, da tempo dibattuta e invero non placatasi ancora alla data di pubblicazione di questo scritto, proponendo una rimodulazione degli eventi della storia greca in virtù della quale la battaglia di Cheronea non avrebbe rappresentato la fine di questa storia quanto, piuttosto, l’inizio di un suo ulteriore sviluppo; sviluppo, di cui, a ragione, De Sanctis sottolineava che «ebbe capitale importanza nella storia della civiltà mondiale», conclu-dendo che questo era stato il maggior merito da ascriversi alla lezione di Droysen e a quella di Beloch.
Al tempo stesso, tuttavia, De Sanctis proponeva una declinazione degli eventi successivi alla morte di Alessandro tesa a problematizzare quel pe-riodo storico in misura maggiore rispetto a quanto fatto in precedenza da Droysen e Beloch. Lo storico romano riconosceva i risultati, da lui definiti perfino miracolosi, conseguiti dall’unione della Grecia sotto l’egemonia macedone attraverso la Lega di Corinto, poiché le falangi greco-macedoni avevano messo a nudo l’intrinseca debolezza dell’impero persiano decretan-done il crollo. Quanto inizialmente parve aprirsi dinanzi al popolo greco fu la possibilità di una sua più ampia espansione e una sua maggiore capacità di penetrazione civile ed economica. Ma si trattò soltanto di una fase, perché alla morte di Alessandro «la volontà del sacrifizio delle autonomie cittadine nell’interesse collettivo della nazione venne meno». Fu questo l’inizio di quella guerra lamiaca che, se pure con tempi diversi, segnò il declino tanto della potenza greca come di quella macedone. La più ampia questione legata al ruolo weltgeschichtlich che spetterebbe all’impero macedone è adesso affrontata da De Sanctis. Questi osservava come molti storici, col che in-tende in particolare Droysen, abbiano narrato una storia dell’Ellenismo che racchiuderebbe «le vicende degli Stati greci e macedonici da Alessandro alla conquista romana», una prospettiva che De Sanctis in queste pagine tendeva a respingere, vedendovi una forzatura, tanto dal punto di vista greco come da quello macedone, perché questi storici «vanno contro la volontà nettissima dei Greci e dei Macedoni, che tale storia comune non vi fosse». La sua tesi verteva sul fatto che l’impero di Alessandro aveva a base del proprio potere e come condizione per l’esistenza dello stesso la Grecia unita, all’interno della quale veniva ricompattandosi lo stesso popolo macedone. Tuttavia alla morte di Alessandro ben più sensibile si fece la spaccatura tra l’elemento greco e quello macedone dell’impero, mentre «il suo centro non poteva trovarsi certo nei cantoni montuosi della Macedonia, che pure
45ARNALDO MOMIGLIANO LETTORE DI DROYSEN
gli fornivano la classe dirigente e l’elemento militare, ma là dove lo aveva cercato per l’appunto Alessandro, nella valle dell’Eufrate»9.
Si creò pertanto uno stato di tensione tra l’elemento macedone-occiden-tale dell’impero e quello più spiccatamente orientale, persiano si potrebbe dire, invero innescato e fomentato dallo stesso Alessandro, che portò alla dissoluzione dell’impero e al formarsi dei tre grandi regni ellenistici. Fu questo il momento nel quale la storia del mondo passò dalla Macedonia a una nuova emergente potenza, quella di Roma. Si può dire che gli stessi stati ellenistici caddero vittime di quella frammentarietà che in precedenza aveva condannato all’impotenza gli stati greci, in primis Atene. Come De Sanctis costatava:
Volontà di unione permanente tra i regni non ci fu mai e non ce ne fu mai la possibilità. […] Separatamente vissero, separatamente perirono dinanzi alle forze preponderanti di Roma, senza, non diciamo volontà, ma neppure velleità di difesa comune10.
La centralità di Roma rispetto alla Macedonia di Filippo e Alessandro in un’ottica storico-universale tornava nella pagina desanctisiana a segnare la differenza tra civiltà antica e moderna. Mentre quest’ultima è al presente condannata ad aspirare soltanto all’unità politica, la prima l’ha pienamente attuata, «anzi la stessa unità civile del mondo mediterraneo non si è costi-tuita che sulla base dell’unità politica creata da Roma, unità che seguiva altri tentativi concreti, sebbene riusciti solo parzialmente, di creare una unità simile»11.
Sulla scia di queste riflessioni De Sanctis osservava come il diretto tra-smettitore a Roma «della tradizione stessa del ‘Weltreich’» fosse l’impero di Alessandro. Tuttavia, segnando una cesura tra la sua riflessione e quella di Beloch, mai condivise la tesi del maestro secondo la quale il macedone fu impero più universale di quello di Roma, in particolare perché buona parte dell’Occidente barbaro e civile, o semicivile, ne era escluso. De Sanctis concludeva che era giusto vedere l’impero di Alessandro non in opposizione a quello romano, ma come un suo precursore, «il primo grande tentativo in parte realizzato di fondare il dominio universale sulla base della unificazione tra Oriente e Occidente»12.
Il legame tra l’analisi desanctisiana e un insieme di motivi già presenti nel Droysen del 1833 non sono da subito riconoscibili né se ne può cal-
9 Ibidem, 24-25. 10 Ibidem, 25. 11 Ibidem, 32; cfr. 34-35. 12 Ibidem, 36.
46 FRANCESCO GUERRA
colare l’esatta portata in mancanza di perspicui riferimenti di De Sanctis. Parimenti un cauto accostamento tra i due storici appare possibile a partire dal riconoscimento di un medesimo sfondo storiografico. Nel volume del 1932 lo storico romano notava come la declinazione della storia antica in senso politico non potesse che coincidere con la tendenza alla formazione di stati civili, che cominciò a emergere intorno al 1500 a.C., che verso il 500 divenne pienamente consapevole e che trovò infine nella conquista romana la sua più coerente attuazione. Questo processo non doveva essere esteso a conquiste violente e passeggere come furono quelle «di un Attila, di un Gengis-khan o di un Tamerlano», perché si tratta di una tendenza fondata «sulla consapevolezza della propria forza e dei propri compiti che ha ogni stato civile», come pure «sulla vigoria etnica e volontà di espansione carat-teristica della maggior parte delle genti mediterranee». Inoltre occorreva a questi stati una sorta di principio di pacificazione universalmente ricono-sciuto, «storicamente la possibilità di un tale legame al mondo mediterraneo non è stata fornita che dal Cristianesimo»13.
Pertanto in De Sanctis la storia antica diviene storia politica nel momento in cui si registra la tendenza consapevole di questi stessi stati a trasformarsi in imperi universali, mentre il connotato dell’universalità può spettare in senso pieno soltanto a Roma perché qui, ma più in generale nel mondo mediterraneo, esso fu sanzionato dalla diffusione della religione cristiana. Professare una stessa fede permise alle genti mediterranee di sentirsi inti-mamente legate all’interno di una medesima comunità in una condizione di pacifica convivenza.
Qualcosa di simile rispetto a quanto sostenuto in queste pagine da De Sanctis era stato avanzato poco più di un secolo prima da Droysen nella Ge-schichte Alexanders des Großen. Il venticinquenne allievo di August Böckh aveva esaltato le gesta di Alessandro, assegnando al condottiero macedone un rilievo a tutti gli effetti storico-universale. Attraverso la sua azione era stato possibile unire i popoli sotto il profilo dei rapporti commerciali, il traffico commerciale nel Mediterraneo crebbe in modo straordinario e Alessandria d’Egitto divenne un punto centrale all’interno di questo traffico. Più ancora, però, Alessandro si dedicò all’apertura di nuovi collegamenti marittimi come alla fondazione di città alla foce dei fiumi Indo, Eufrate e Tigri e anche se la rovina del periodo seguente non ha reso possibile portare a termine tali piani, ciononostante la nuova forma che il commercio e le attività lavorati-ve in genere hanno ricevuto attraverso l’opera civilizzatrice di Alessandro contribuì in modo straordinario all’ellenizzazione dell’Occidente asiatico14.
13 Ibidem, 36.14 Droysen 1931 [1833], 479-480.
47ARNALDO MOMIGLIANO LETTORE DI DROYSEN
Già in Droysen, dunque, è presente quel legame tra storia politica e fioritura di stati civili riscontrato in De Sanctis.
Tuttavia le affinità tra i due storici sembrano ancora più marcate. In uno degli ultimi paragrafi del testo del 1833 della Geschichte Alexanders des Großen, dal titolo Die Völkermischung, il professore pomerano prendeva in esame quel processo di mescolanza e fusione tra le popolazioni occidentali e quelle orientali, per mezzo del quale la grandezza di Alessandro raggiunse la sua akme. La Völkermischung, sempre vista dal sovrano macedone come scopo principale delle proprie campagne militari, testimoniava il carattere sostanzialmente universale dell’azione di Alessandro e precorreva il ruolo che in seguito spetterà al potere di Roma:
In un periodo di dieci anni è stato scoperto e conquistato un mondo, milioni di persone erano state conquistate al trono di un forestiero e riportate nuovamente in vita grazie allo spirito di una parte di mondo a loro estranea. Erano cadute le barriere che separavano Occidente e Oriente e aperte le strade che dovevano unire l’uno con l’altro i paesi dove sorgeva il sole con quelli nei quali tramontava. Uno scrittore antico disse: come in una coppa piena d’amore gli elementi di tutta la vita dei popoli furono mescolati l’uno nell’altro, e i popoli, insieme, bevvero da questa coppa e dimenticarono la vecchia inimicizia e la propria impotenza15.
Quella trasformazione nella vita dei popoli, avviata per mezzo delle con-quiste di Alessandro e delle innovazioni politiche e sociali da lui introdotte, giunse a piena maturazione nei secoli successivi alla morte del grande sovrano macedone. Furono questi, in senso stretto, i secoli dell’Ellenismo. Lo stesso universalismo, all’insegna del quale la conquista macedone si era compiuta, germogliò quando Alessandro era ancora in vita, ma fiorì completamente solo in un momento successivo. La lenta scomparsa dei pregiudizi nazionali, l’avvicinamento reciproco in fatto di bisogni, costumi e opinioni tra caratteri popolari, un tempo separati, creò le premesse per una vita sociale del tutto nuova. Fu questo il terreno sul quale venne afferman-dosi «una Weltbildung, che dal Nilo al Giassarto faceva valere le medesime forme convenzionali: quelle della buona società e del mondo colto», mentre «la lingua e il costume attici erano la regola delle corti di Alessandria e Babilonia, di Bactra e di Pergamo».
Anche quando l’Ellenismo perse la propria autonomia davanti alla potenza romana, esso poté comunque diffondersi a Roma come moda ed educazione. Elemento, questo, che giustificherebbe la definizione in base alla quale l’Ellenismo fu la prima unità universale (Welteinheit) nella storia dell’umanità, e cui va aggiunto – suggerisce Droysen in un parallelo con
15 Ibidem, 480-481.
48 FRANCESCO GUERRA
il regno degli Achemenidi, caduto sotto i colpi di Alessandro e della sua falange – che nei paesi dell’Ellenismo i singoli stati non furono mai un mero aggregato, uniti solo per mezzo di un dispotico potere centrale, bensì, anche quando sorsero differenti regni, all’interno di questi paesi rimase la più elevata unità delle usanze, della moda e dell’educazione16. L’Ellenismo fu la prima unità universale nella storia dell’umanità, mentre la centralità della figura di Alessandro discende dal fatto di essere stato l’iniziatore di questo processo, che, pur tra rotture, giungerà fino a Roma.
Il ruolo che De Sanctis aveva assegnato al Cristianesimo è, per così dire, retrodatato nella pagina droyseniana, costituendo il lascito forse maggiore di Alessandro ai secoli successivi. Pertanto «si può affermare che attraverso questo illuminismo, per quanto nel particolare esso appaia sfavorevole e livellatore, è stata spezzata la forza del Paganesimo ed è divenuto possibile uno sviluppo più spirituale della religione». Lungi dall’essere un periodo scarsamente significativo, l’Ellenismo ha avviato il superamento di ogni culto pagano, dando alla sfera religiosa quella profondità e sostanza di cui il Cristianesimo rappresenterà l’espressione ultima e più elevata. Parimenti questo illuminismo è stato a sua volta preparato dall’azione individualiz-zante e universalizzante svolta da Alessandro attraverso le sue conquiste. Parallelamente alla Völkermischung, infatti, il grande condottiero macedone realizzò anche «quell’insolito fenomeno della mescolanza delle divinità (Göttermischung), della teocrasia, alla quale nei secoli successivi tutti i popoli dell’ellenismo presero parte».
Questi, animato dall’aspirazione all’unità dei popoli, poté spezzare il Paganesimo inteso come declinazione religiosa di una precipua diversità storica e nazionale. Onorando ogni culto nazionale e riunendo i popoli sotto un medesimo potere, Alessandro fu l’artefice di un processo di progressiva sintesi tra istanze religiose e differenti professioni di fede, che avrebbe avuto come punto terminale l’affermazione della religione cristiana. Egli fece in modo che si rendessero locali divinità straniere e si ritrovassero divinità del proprio paese in quelli stranieri. Dal confronto e dalla concordanza tra i cicli di leggende e le teogonie dei differenti popoli si diffuse sempre più la consapevolezza che tutti i popoli adoravano all’incirca le stesse divinità e che le differenze riscontrabili nei loro nomi e attributi sarebbero state soltanto casuali e apparenti. Divenne perciò chiaro che il tempo delle reli-gioni nazionali e pagane sarebbe passato, mentre già emergeva il bisogno, espresso dall’umanità, di una religione unica e universale.
16 Ibidem, 484.
49ARNALDO MOMIGLIANO LETTORE DI DROYSEN
La teocrasia, voluta da Alessandro e sviluppatasi dopo la sua morte, fu il più serio tentativo operato nella storia antica «di produrre attraverso la mescolanza di tutti quei sistemi religiosi nazionali una unità, che in que-sta, però, non poteva essere raggiunta». Ciò avrebbe costituito il precipuo lavoro dei secoli ‘ellenistici’; gli elementi di una più alta unione potevano manifestarsi soltanto una volta che si fosse ridestato «il sentimento della finitezza e dell’impotenza, il bisogno della penitenza e della consolazione, la forza della più profonda umiltà e dell’elevazione alla libertà in Dio». Nella persona di Alessandro si era compiuto «l’antropomorfismo del Paganesimo greco», con lui, prima di Cristo, «l’uomo era Dio», in Dio l’uomo si trovava elevato fino alla vetta ultima della finitezza e attraverso di lui l’umanità era abbassata davanti a quello stesso Dio ad adorare un mortale17.
Con Droysen era essenzialmente mutato l’asse di rotazione della storia universale, passato da Roma alla Macedonia di Alessandro, più ancora che a quella di Filippo. Il suo universalismo si sostanziava in termini quali Völ-kermischung, Göttermischung e Theokrasie, mentre la narrazione delle gesta del grande condottiero macedone sembrava aver lasciato progressivamente spazio a una teologia della storia entro la quale lo stesso Alessandro incarnava il punto archimedeo dei futuri sviluppi storici dell’umanità.
Felix Gilbert e Arnaldo MomiglianoAll’interno del panorama di studi droyseniani la figura e l’opera di Felix Gilbert rappresentano un caso esemplare. Questo figlio di un oculista inglese, nato e cresciuto in Germania, nel 1931 conseguì il Dottorato sotto la guida di Friedrich Meinecke con un lavoro dal titolo Johann Gustav Droysen und die preußisch-deutsche Frage. Dopo questa data, e in concomitanza con l’ascesa in Germania del Nazionalsocialismo, Gilbert fu costretto a lasciare il proprio paese trovando rifugio negli Stati Uniti. Qui, dopo una collaborazione con l’ufficio dei servizi strategici del Dipartimento di Stato, insegnò in vari luoghi prima di ricevere nel 1962 una cattedra a Princeton alla School of Historical Studies presso l’Institute for Advanced Study18.
17 Ibidem, 486-487. Tra i numerosi contributi sulla figura e l’opera di De Sanctis si segnalano due memorie di Momigliano scritte a non troppa distanza di tempo l’una dall’altra. La prima, ‘In memoria di Gaetano De Sanctis (1870-1957)’ (RSI 69, 1957, 177-195 = Secondo contributo alla storia degli studi classici, Roma 1960, 299-317), fu composta in seguito alla scomparsa dello storico romano, mentre la seconda, ‘Gaetano De Sanctis (1870-1957)’ (AAT 104, 1969-1970, 69-77 = Momigliano 1975, I, 179-185), risale al 1969 e sviluppa alcuni temi che nel saggio precedente erano stati soltanto accennati.
18 Su Gilbert si veda l’importante studio di G.A. Ritter, ‘Die emigrierten Meinecke-Schüler in den Vereinigten Staaten. Leben und Geschichtsschreibung zwischen Deutschland und der neuen Heimat: Hajo Holborn, Felix Gilbert, Dietrich Gerhard, Hans Rosenberg’, HZ 284, 2007, 59-102.
50 FRANCESCO GUERRA
L’interesse verso la riflessione di Gilbert muove dal fatto che questi si occupò di Droysen, almeno in maniera estesa, solo nella monografia del 1931: nei decenni successivi i suoi interessi storiografici cambiarono radi-calmente indirizzo, orientandosi piuttosto su Machiavelli, Guicciardini e, più in generale, sul Rinascimento italiano. Le analisi che il giovane Gilbert, peraltro in un periodo della vita tedesca già segnato da una crisi profonda, svolse su Droysen esercitarono un’influenza profonda dentro e fuori i confini nazionali, come mostrerà il caso di Momigliano. Tuttavia Gilbert era unito a Droysen anche sotto un altro punto di vista, ossia per avere avuto come maestro quel Meinecke, la cui riflessione si mostrerà sempre debitrice, tanto in ambito politico quanto metodologico, verso lo storico di Alessandro. E al tempo stesso anche la data di pubblicazione del lavoro di Gilbert, il 1931, è tutt’altro che priva di significato, se accostata alla complessiva produzio-ne meineckiana. A questa data, infatti, l’esperienza politica di Meinecke aveva affrontato due sconfitte brucianti: la prima guerra mondiale (il che riportava l’allievo di Droysen a interrogarsi su prussianesimo e monarchia degli Hohenzollern) e il tramonto delle aspettative suscitate dalla repubblica di Weimar nel quinquennio 1926-1930, cui corrispose il sempre maggiore radicamento nel paese, evidente già nei risultati elettorali del giugno del 1930, delle forze nazionalsocialiste19.
Nel suo lavoro su Droysen e la questione prussiano-tedesca Gilbert intese concentrarsi in modo particolare sugli anni della vita di Droysen compresi tra la chiamata come professore di storia a Kiel nel 1840 e le prime fasi della Geschichte der preußischen Politik risalenti ai primi anni ’50, quando Droy-sen insegnava a Jena. La tesi di Gilbert consiste nel riconoscimento di due momenti nel pensiero storico-politico di Droysen: l’uno, collocabile dagli anni di Kiel sino al fallimento dell’esperienza della Nationalversammlung francofortese nel 1849, avente di mira una unificazione della Germania su base confederale, mentre l’altro, databile dal 1849, più spiccatamente filo-prussiano e teso a unificare il territorio tedesco sotto l’egida della Prussia e della casata degli Hohenzollern. Da una parte vi era il Droysen sostenitore dello stato tedesco unitario e dall’altra il convinto fautore della Machtpolitik prussiana da esercitarsi su tutto il territorio tedesco, in tal modo unificandolo manu militari20.
19 Fin dal 1916 Meinecke sembrò operare una drastica revisione del proprio pensiero politi-Meinecke sembrò operare una drastica revisione del proprio pensiero politi-co, che lo porterà a riflettere sulla possibilità di avviare un processo di democratizzazione delle istituzioni monarchiche.
20 Cfr. F. Gilbert, J.G. Droysen und die preußisch-deutsche Frage, München - Berlin 1931, 66-72. Mi sia qui permesso rimandare per una più ampia disamina del rapporto Gilbert-Droysen, nel quadro del prussianesimo di quest’ultimo, a F. Guerra, ‘Questa fu la Prussia. Il carteggio tra Johann Gustav Droysen e Heinrich von Treitschke’, AIIS 23, 2008, 567-633, spec. 567-582.
51ARNALDO MOMIGLIANO LETTORE DI DROYSEN
La cesura così nettamente stabilita da Gilbert rendeva necessario supporre un repentino cambio di orizzonte storico e politico da parte di Droysen. Un punto, questo, particolarmente controverso, mentre più utile è cercare di comprendere la posizione droyseniana di questi anni partendo da due termini che ricorrono spesso negli scritti politici dello storico pomerano: unità e libertà. Rispetto ad altre situazioni europee paradigmatico è il caso inglese, dove il pensiero liberale prese forma sulla base dell’idea di libertà, mentre in Droysen, e più in generale tra i liberali tedeschi settentrionali a cavallo tra prima e seconda metà dell’Ottocento, il punto archimedeo dell’analisi politica era rintracciabile nell’idea di unità.
Alla base degli atteggiamenti politici di Droysen dopo il 1840 e negli anni successivi al fallimento del tentativo costituzionale francofortese sembra esservi proprio la centralità dell’idea di unità rispetto a quella di libertà. In questo senso, come il calcolo politico aveva permesso di arrivare a un compromesso per mezzo del quale si pensava di poter unificare la Germania per via federale, così, nel momento in cui questa opzione svanì, anche a Droysen la sola via percorribile per riunire il popolo tedesco dovette sem-brare quella di sostenere una politica di unificazione diretta dalla Prussia. Ciononostante, coerente con la sua visione pragmatica della politica, lo storico di Alessandro considerava la potenza della Prussia il mezzo, non il fine, per dare unità e pace all’instabile territorio tedesco, mentre dopo la formazione del Reich bismarckiano questa potenza avrebbe fornito la necessaria stabilità al nuovo stato.
Quanto potrebbe essere concesso all’analisi di Gilbert, la quale però si arresta molto prima, è che negli anni di Berlino, soprattutto a partire dalla vittoria sull’Austria nel 1866 e dall’avvicinamento a talune posizioni poli-tiche espresse da Bismarck, la riflessione di Droysen divenne più contigua a quella Machtpolitik che il neofondato Reich pose effettivamente in atto, e di conseguenza a questa data l’argomento della stabilità dello stato sembrerà funzionale ad una politica di potenza verso l’esterno e tesa, con ogni mezzo, al mantenimento dello status quo all’interno.
Il testo di Gilbert incrociò il percorso di studi di Momigliano nel momento in cui questi nel corso dei primi anni ’30 concentrò la sua analisi sulla figura di Filippo il Macedone. Per quanto l’allievo di Meinecke si fosse dedicato in maniera quasi esclusiva al Droysen dei Freiheitskriege, arrestandosi sulla soglia della Geschichte der preußischen Politik, e alla sua esperienza quale delegato per lo Schleswig-Holstein alla Nationalversammlung di Franco-forte, parimenti si può dire che il suo lavoro fornì a Momigliano la griglia interpretativa entro cui inserire le riflessioni del Droysen storico di Alessan-dro e dell’Ellenismo. In tal modo la drastica distinzione gilbertiana di due
52 FRANCESCO GUERRA
fasi all’interno della produzione storiografica di Droysen fu sostanzialmente ripresa da Momigliano ed estesa dalla storia moderna a quella dell’antichità, stabilendo al tempo stesso un più serrato legame tra il pensiero politico di Droysen e gli studi di quest’ultimo sulla storia prussiana e l’Ellenismo.
Momigliano portò a termine il saggio su Filippo il Macedone due anni pri-ma della sua effettiva pubblicazione. La posizione da lui espressa è senz’altro filo-macedone e critica nei confronti di Demostene e, più in generale, verso l’ideale della polis21. Sin dalla ‘Introduzione’ lo storico piemontese chiariva quali fossero gli intenti connessi al suo lavoro e quale l’impostazione che avrebbe seguito nell’interpretazione dell’Ellenismo droyseniano. Egli am-metteva che nel momento in cui Droysen pubblicò il primo volume della Geschichte Alexanders des Großen le correnti panelleniche del pensiero politico del IV secolo a.C. erano ampiamente trascurate22.
Il contributo di Droysen si traduceva in una rilettura delle vicende con-nesse alle conquiste di Filippo senza farne il soggetto che conclude la storia greca, ma, al contrario, colui che «distrusse l’autonomia delle singole città per effettuare l’unità dell’Ellade e riunire in un fascio solo le forze logorantisi nelle contese fraterne». Questo pensiero sarebbe stato provocato dal fatto che lo storico di Alessandro non mise mai al centro della propria trattazione le aspirazioni greche di arrivare alla formazione di un unico stato, ma la «mediazione tra Classicismo e Cristianesimo nel mondo ellenistico», qui rintracciando «la forza costruttrice nello Stato di Filippo, anche se natural-mente in tal concetto già germinava quella esaltazione dello Stato prussiano, che pervaderà la sua opera degli anni maturi e si rifletterà nel modo più preciso nella rielaborazione del suo lavoro giovanile pubblicata nel 1877»23.
Queste prime righe di Momigliano permettono di fare due considerazioni. La prima, peraltro espressa in nota dall’autore, concerne il legame con la tesi proposta da Gilbert, mentre l’altra è più specificamente legata al testo droyseniano. Momigliano coglieva giustamente che nella prima edizione della Geschichte Alexanders des Großen Droysen aveva mantenuto una du-plice prospettiva: l’una sulla questione religiosa, il passaggio da un mondo pagano a uno che già prefigura la presenza di Cristo; un’altra, politica, in virtù della quale la Macedonia di Filippo e Alessandro avrebbe unificato la
21 Due elementi, questi, che pongono il testo di Momigliano in netta antitesi rispetto al lavoro di Piero Treves su Demostene e la libertà greca. Si veda Momigliano 1934, XV-XVI, 93-96 e soprattutto i capitoli IV e V; cfr. P. Treves, Demostene e la libertà greca, Bari 1933 (in particolare i capitoli II e IV per i riferimenti a Droysen). Su Treves vd. R. Pertici, ‘Piero Treves storico di tradizione’, RSI 106, 1994, 651-734: 699-700 (con particolare riferimento alla triangolazione Treves-Momigliano-Droysen).
22 Cfr. la ‘Avvertenza’, in Momigliano 1934, VII.23 Momigliano 1934, XI.
53ARNALDO MOMIGLIANO LETTORE DI DROYSEN
Grecia e superato il particolarismo statale tipico degli stati greci del periodo, in particolare di Atene. La considerazione sul versante politico dell’opera di Droysen già rifletteva una cospicua presenza di Gilbert, evidenziata dal riferimento alla seconda edizione della Geschichte des Hellenismus.
Ancora più esplicito Momigliano lo era a distanza di poche pagine, quando lamentava che l’attenzione pressoché esclusiva riservata a Isocrate confermerebbe che si è sempre visto un solo panellenismo, quello isocra-teo appunto, e lo si è fatto coincidere con un movimento teso verso l’unità politica. Di qui, «accentuando ancora quella che era la già mutata posizione del Droysen della seconda edizione in confronto al Droysen della prima, si è dimenticato ciò che nella lotta politica del IV secolo poteva far presagire il cosmopolitismo del mondo ellenistico, che ne uscirà fuori, e si è visto tutto alla luce del moto nazionale». In tal modo «il secondo Droysen, lo storico della politica prussiana col suo problema della forza unificatrice della nazione (Prussia, Macedonia), aveva vinto sul primo Droysen dal problema religioso: vittoria non priva di esigenze positive, naturalmente, come quella che sottolineava gli sforzi greci di uscire dalla polis, ma in sé deformatrice della storia greca»24.
Stando a questa lettura, sembrerebbe che Droysen nel 1833 avesse scritto un’opera di profilo storico-universale nella quale Alessandro era il mezzo per una più ampia trasformazione religiosa, mentre nel 1877, sulla spinta delle vittorie bismarckiane e della formazione del Reich, il sovrano macedone avrebbe incarnato finalità di carattere strettamente politico, unificando la Grecia sotto l’egida della Macedonia, come Bismarck aveva unificato la Germania sotto l’egida della Prussia25.
Il respiro storico-universale della prima edizione della Geschichte Ale-xanders des Großen si sarebbe perciò atrofizzato, trasformandosi in pane-girico, pur di pregevole fattura, teso a mostrare la Macedonia come Prussia dell’antichità. La tensione tra nazionalismo e cosmopolitismo, che nel 1833 sembrò risolversi a favore del secondo termine, costituirebbe il dato più rilevante della prima edizione della Geschichte Alexanders des Großen e parimenti la più grave perdita dalla prima alla seconda redazione dell’opera26.
24 Momigliano 1934, XII-XIII. 25 Cfr. P. Payen, ‘Johann Gustav Droysen et l’Histoire de l’Hellénisme. L’époque hellénistique
entre Alexandre et la Prusse’, in J.G. Droysen, Histoire de l’Hellénisme, traduit de l’Allemand sous la direction de A. Bouché-Leclercq. Avec préface, note sur l’histoire de la traduction, bibliographies, révision du texte de P. Payen, I, Grenoble 2005, 5-82.
26 Sebbene questo slittamento sia avvertibile nel passaggio dalla prima alla seconda edizione, appare troppo netta la cesura stabilita da Momigliano al livello delle opzioni politiche di Droysen successive al 1848. Piuttosto nel periodo compreso tra le due edizioni dell’opera, con particolare riferimento ai lavori su Alessandro, il professore pomerano sembrerebbe aver preso le distanze da una lettura di tipo storico-universale degli eventi storici e da una prospettiva riconducibile
54 FRANCESCO GUERRA
La storia greca del IV secolo poteva riacquistare la propria specificità solo se accanto alla sua incapacità di generare indipendenza e unità della nazione, in tal modo ammettendo quei limiti che apriranno le porte all’imperialismo macedone, si fosse cercato di rendere ragione di quei «valori che la storia successiva in antitesi al particolarismo greco è venuta creando non già in senso nazionale, ma in senso cosmopolitico». Nella stessa pagina Momi-gliano osservava come questa tensione avesse costituito nel primo Droysen uno iato tra unità nazionale, a tutti gli effetti avviata da Filippo e realizzata da Alessandro sotto il segno di una comunità statale greco-macedone, e la civiltà supernazionale che le conquiste di Alessandro in Oriente sembra-vano avere realizzato. L’esito di questo processo sarebbe stato un drastico ridimensionamento nel secondo Droysen del concetto di Ellenismo, una revisione per mezzo della quale l’Ellenismo da «principio genetico di una fase storica dell’umanità» si trasformava o, per meglio dire, era ridotto «a semplice formula riassuntiva di un processo non più chiaramente veduto come unitario»27.
In questo suo primo lavoro Momigliano ben coglieva l’istanza weltge-schichtlich con cui lo storico pomerano aveva inteso declinare la figura di Alessandro, un’istanza che correva lungo due direttrici: la prima era quella che da Alessandro si irradiava verso il cosmopolitismo, verace superamento dello statico ideale del Kleinstaat, già prefigurante il Cristianesimo e che, da ultimo, vedeva in Alessandro una anticipazione della stessa figura di Cristo; la seconda investiva il piano politico. Alessandro, infatti, aveva inaugurato un’epoca segnata dalle sue conquiste, cui era però seguita una pace sempre più diffusa. Uno stato di cose che «precederà e condizionerà i
in buona parte a Hegel. Su questo ultimo punto si veda quanto scrisse il curatore francese della Geschichte des Hellenismus, Auguste Bouché-Leclercq, nella ‘Avant-propos du traducteur’, in J.G. Droysen, Histoire d’Alexandre le Grand, I, Paris 1883, XVI-XVII. A conferma di questa lettura si vedano i seguenti luoghi: Droysen 1931 [1833], 1-3, 197-201, 227-230, 317-318, 440, 462-464 e 473-487, mentre, della edizione del 1877 (Droysen 1952 [1877]), vd. le pp. 3-4, 198-207, 222-223, 266-267, 378, 404-411, 420-424, 439-445. Benedetto Bravo criticò la lettura di Momigliano, muovendo obiezioni cui lo storico piemontese rispose in una recensione pubblicata sulla Rivista Storica Italiana: B. Bravo, Philologie, Histoire, Philosophie de l’Histoire. Étude sur J.G. Droysen, historien de l’Antiquité, Wroclaw - Varsovie - Cracovie 1968, spec. 394-400, e A. Momigliano, RSI 81, 1969, 679-682 (= Momigliano 1975, II, 898-902). Le critiche di Bravo a Momigliano furono in parte riprese da Remo Bodei nella assai pregevole recensione al volume di Bravo apparsa in RFIC 98, 1970, 483-490, spec. 489-490. Per una più recente trattazione dell’argomento si veda C. Wagner, Die Entwicklung Johann Gustav Droysen als Althistoriker, Bonn 1991, 84-140, e, sul rapporto di Droysen con la figura di Alessandro e l’Ellenismo, spec. il II e il V capitolo. Infine, cfr. R. Bichler, Hellenismus. Geschichte und Problematik eines Epochenbegriffs, Darmstadt 1983, 69-73, 92-98, 101-103.
27 Momigliano 1934, XV-XVI, che così concludeva: «Ma, quando si elimini, come noi tentere-mo di fare, il dissidio intrinseco al Droysen, il punto di partenza sarà sempre quello del suo primo Alessandro: che lo spirito umano ha sorpassato la libertà politica dei Greci nel cosmopolitismo, che preparò l’avvento del Cristianesimo».
55ARNALDO MOMIGLIANO LETTORE DI DROYSEN
monarchi ellenistici e poi gli imperatori romani in cui la concordia, la pace, la prosperità dei sudditi sono ideali di governo, ora più ora meno sentiti, ma sempre messi di fronte all’opera concreta come a suo paragone».
In tal modo Momigliano sembrava fare coincidere il piano religioso con quello politico della riflessione del primo Droysen, una prospettiva storico-universale che forniva continuità alla lettura della storia antica, ponendo lo stesso Filippo all’origine di quella mentalità «che porterà alla dissoluzione la insufficiente libertà dei Greci», ma ancor più, forse, per il riferimento alla insufficiente libertà presente nella Roma repubblicana la quale aveva concretamente posto le condizioni per lo sviluppo del Cristianesimo, ossia «per lo sviluppo di una libertà non più politica ed egoistica e insomma sopraffattrice, ma altruistica ed umana»28.
Il libro su Filippo il Macedone, come detto nella ‘Avvertenza’, era stato portato a termine nel 1932, sebbene la sua pubblicazione avvenisse due anni dopo. Nel 1933 apparve sulla rivista Leonardo uno studio di Momigliano dedicato alla prima edizione della Geschichte Alexanders des Großen dal titolo ‘Per il centenario dell’«Alessandro Magno» di J.G. Droysen. Un contri-buto’. Richiamando una vasta letteratura, Momigliano proponeva, di nuovo, la tesi che già un anno prima nel suo lavoro su Filippo il Macedone, tuttavia inedito a questa data, aveva messo a frutto, ossia che la prima edizione della Geschichte Alexanders des Großen e, più in generale, la Geschichte des Hellenismus risponderebbero ad una precisa esigenza di carattere religioso «o forse meglio filosofico-religiosa», quanto Momigliano riportava alla presenza di Hegel nel pensiero del giovane Droysen, ben testimoniata dal fatto che questi aveva seguito a Berlino sei corsi del filosofo di Stoccarda.
Parimenti Momigliano rilevava, a ragione, che la presenza di Hegel in Droysen sarebbe tutt’altro che semplice da contestualizzare, perché «dallo Hegel egli deriva la consapevolezza del divenire della storia e anche la raf-figurazione dell’individuo come ‘portatore’ dell’idea, ma contro lo Hegel tiene fermo alla indeducibilità del reale». Tenendo sullo sfondo Hegel e senza soffermarsi sulla droyseniana teologia della storia, Momigliano ritenne che il professore pomerano attraverso questo lavoro intendesse fare luce sul trapasso dalla civiltà classica a quella pagana, esigenza che lo avrebbe portato a stabilire un legame diretto tra l’affermazione storica di Alessandro e la rivelazione di Dio in Cristo.
Per altro verso, appariva centrale anche la relazione che avrebbe unito la grecità al mondo orientale attraverso un processo di mistione culturale che in Alessandro aveva il suo artefice, per quanto resti senza risposta l’inter-
28 Momigliano 1934, 178. Sulla sostituzione dell’assolutismo ellenistico alle formazioni repubblicane della Grecia si veda p. 179.
56 FRANCESCO GUERRA
rogativo riguardante il modo e la misura in cui Droysen vide agire insieme Greci e orientali. Momigliano, in uno dei passaggi più intensi dell’opera droyseniana, rintracciava questa Verschmelzung, dalla quale era disceso il «processo di disintegrazione del Paganesimo», la distruzione della fede precedente e di qui il bisogno della nuova29.
Punto archimedeo per la lettura della Geschichte Alexanders des Großen di Droysen restava il saggio di Gilbert. Tuttavia, rispetto al lavoro su Filippo il Macedone, qui Momigliano poteva soffermarsi con maggiore dovizia di particolari sulla differenza tra la prima e la seconda edizione dell’opera. Il federalismo del primo Droysen costituiva l’origine della riuscita architettura della Geschichte Alexanders des Großen e ciò che gli permise di tenere ben distinta la «vicenda antica dalla moderna» e di rivivere «il carattere super-etnico dell’una, mentre profondamente compartecipava al carattere nazionale dell’altra». Per converso, la seconda edizione riuniva idealmente i differenti poli della storia antica e di quella moderna provocando una indebita sovrapposizione tra la Macedonia e la Prussia, in virtù della quale la Macedonia si trasformava nella Prussia dell’antichità.
Questa profonda revisione apportata da Droysen rispetto al lavoro del 1833 coincideva con una «conversione politica» della Geschichte Alexan-ders des Großen alle sollecitazioni provenienti dallo scenario tedesco del periodo, profondamente segnato dai successi militari di Bismarck. La cesura non sarebbe potuta essere più netta; la seconda edizione della Geschichte Alexanders des Großen amplificava il contenuto politico degli eventi presi in esame, mettendo la sordina «al problema religioso dominante negli anni giovanili» e divenendo la monarchia macedone non più il punto di avvio di un processo storico-universale, che conduceva al Cristianesimo, ma solo «la unificatrice della nazione greca»30.
Dopo aver accostato la ‘Einleitung’ alla prima edizione della Geschichte Alexanders des Großen con il primo capitolo della seconda edizione della Geschichte des Hellenismus, Momigliano sosteneva che le due redazioni sarebbero testimoni della irriducibile duplicità dell’opera di Droysen. Lo storico pomerano si rese conto che l’Ellenismo aveva dato vita a una ci-viltà cosmopolita e che al tempo stesso si trovava in Grecia «un profondo movimento inteso a superare la polis e […] questo movimento si continua e perfeziona nelle monarchie militari dell’Ellenismo». Parimenti, se lo stato di Filippo e Alessandro fu nazionale, non poté certo dare inizio a una
29 Momigliano 1987, 140-143 (= ‘Per il centenario dell’«Alessandro Magno» di J.G. Droysen. Un contributo’, Leonardo 4, 1933, 510-516 = Momigliano 1955, 263-274). Vd. Droysen 1931 [1833], 486-487.
30 Momigliano 1987, 144-145 (cfr. la n. precedente).
57ARNALDO MOMIGLIANO LETTORE DI DROYSEN
civiltà cosmopolita; o la Macedonia aveva unificato le frammentate e mal coordinate realtà politiche greche sotto la sua egida oppure lo stato greco-macedone rappresentava l’ultimo anello della catena, l’agente «che dissolve la nazionalità greca, e quindi la civiltà greca, nell’Ellenismo»31.
Nel periodo in cui lavorava al saggio sulla prima edizione della Geschichte Alexanders des Großen, Momigliano teneva all’Università di Roma le sue lezioni sull’Ellenismo, cercando in esso la mediazione tra mondo antico e mondo cristiano. Il prodotto di quei seminari fu il saggio ‘Genesi storica e funzione attuale del concetto di Ellenismo’, pubblicato per la prima volta sul Giornale critico della filosofia italiana nel 1935. Qui Momigliano intese affrontare dall’interno del mondo intellettuale tedesco il problema della decadenza del mondo greco, dell’ascesa di quello romano e, più in generale, il passaggio dal mondo antico a quello moderno e ciò che questo processo implicò. Per quanto concerne la riflessione di Droysen, ci si soffermava a considerare l’influenza che sul giovane studioso poté esercitare Böckh, suo maestro a Berlino.
La centralità di Böckh rispetto a Droysen può meglio comprendersi, se si considera ciò che Momigliano aveva in precedenza scritto su Filippo il Macedone e sulla prima edizione della Geschichte Alexanders des Großen. Pur non trovandosi alcun esplicito riferimento fatto da Böckh al nome o al concetto di Ellenismo, egli, come in seguito Droysen, aveva riconosciuto «che il momento fondamentale della distinzione tra il mondo antico e il mondo moderno è dato dal Cristianesimo in cui si attua […] la libertà umana e non più solo la libertà politica». Ciò a cui Böckh non aveva dato risposta riguardava il quando e il dove della storia, il momento in cui, di fatto, il mondo pagano aveva lasciato spazio a quello cristiano. Droysen per la sua concezione dell’Ellenismo avrebbe ripreso uno spunto suggerito da Böckh, quello volto a cercare la mediazione tra Paganesimo e Cristianesimo in una sintesi che si sarebbe realizzata a partire dalla fusione dell’elemento greco con quello orientale32.
Su un punto, però, Momigliano concedeva che tra il Droysen del 1833 e quello del biennio 1877-1878 vi fosse unità di vedute: quello riguardante «il concetto di libertà greca, di cui […] si dà come carattere essenziale
31 Ibidem, 149-150. 32 Momigliano 1955, 180-181 (= ‘Genesi storica e funzione attuale del concetto di Ellenismo’,
GCFI 16, 1935, 10-37). Qui Momigliano riprendeva la tesi già sostenuta nel lavoro del 1933, confermando al tempo stesso il suo legame con l’opera di Gilbert su Droysen pubblicata due anni prima. Sull’influenza che su Droysen esercitarono storici quali Barthold Georg Niebuhr, Wilhelm von Humboldt e Böckh, si veda F. Tessitore, ‘Weltgeschichte o Universalgeschichte? Lo storici-smo dei filosofi e lo storicismo degli storici’, ora in Id., Contributi alla storia e alla teoria dello storicismo, I, Roma 1995, 100-103, mentre in particolare su Niebuhr vd. Canfora 1987, 15-36.
58 FRANCESCO GUERRA
l’individualismo che, essendo illimitato, è libertà di sopraffazione e quindi tirannide». Il referente per queste analisi era adesso la ‘Prefazione’ privata al II volume della Geschichte des Hellenismus, nota col titolo ‘Teologia della storia’, pubblicata nel 1843 e stampata in pochi esemplari33.
Ciò che emergeva in quello scritto era l’idea secondo cui l’insufficien-te libertà greca aveva posto le basi per gli sviluppi storici successivi, «la necessità di una sua integrazione con l’assolutezza dello spirito religioso dell’Oriente». Questo processo si sarebbe configurato nella prima edizione della Geschichte Alexanders des Großen come un incontro/scontro tra Eu-ropa e Asia pacificato per mezzo dell’azione di Alessandro, anticipazione di Cristo come la Macedonia lo era di Roma; mentre nella seconda edizione, a seguito delle mutate convinzioni politiche di Droysen, l’insufficiente libertà greca avrebbe trovato risoluzione nella fondazione della monarchia greco-macedone avviata da Filippo e conclusa da Alessandro.
Sostanzialmente la lettura data da Momigliano era rimasta invariata dalla stesura dell’opera su Filippo il Macedone, pur rendendo, almeno nella forma, più sfumato il passaggio dalla prima alla seconda edizione della Geschichte Alexanders des Großen. Ciò che gli sembrava il portato maggiore della prima redazione dell’opera era una compattezza concettuale dell’Ellenismo droyseniano che nella seconda non solo mancava, ma la cui presenza non avrebbe avuto alcuna ragion d’essere. Tale compattezza, infatti, risultava plausibile laddove si fosse continuato a vedere l’Ellenismo primariamente come uno sviluppo di civiltà in una dimensione weltgeschichtlich, più ancora, filosofico-religiosa. Oriente, Grecia e Cristianesimo erano in questa lettura elementi imprescindibili di un processo di trasformazione più ampio, teso a risolvere il secolare contrasto tra grecità e mondo orientale in una più alta unità religiosa, «nel sincretismo preparatore del Cristianesimo»34.
Il legame da Droysen stabilito tra mondo antico e sviluppo della grecità nella Weltmonarchie di Alessandro, sotto altra prospettiva, nel contributo del 1933 era stato visto come esclusivo e, al tempo stesso, escludente e preannunciante l’impero romano. Il professore pomerano, come opportu-namente ricordato da Momigliano, nel I volume delle Kleine Schriften zur alten Geschichte aveva riconnesso il termine Ellenismo anche allo sviluppo di Roma. In questo modo, però, Roma assumeva uno status secondario nello sviluppo storico-universale dell’umanità, non concrescendo accanto, bensì essendo successiva alla dominazione di Alessandro e ai secoli ‘ellenistici’. Più ancora, la polarizzazione stabilita da Droysen tra mondo greco e mondo orientale sembrava essere una deliberata opzione storiografica al fine di ri-
33 Cfr. supra, n. 4. 34 Momigliano 1955, 181-183 (cfr. n. 32).
59ARNALDO MOMIGLIANO LETTORE DI DROYSEN
comprendere l’impero romano entro le coordinate che erano state tracciate dalla civiltà ellenistica.
Lo scarto era considerevole e di questo si accorgeva Momigliano quando, al termine del suo intervento su Droysen, osservava: «È facile rendersi conto che se il Droysen stesso dovette abbandonare il significato originario della sua formula, non mancava una elementare e decisiva ragione: cioè che la considerazione dell’Ellenismo come trapasso fra la civiltà greca e la civiltà cristiana dimenticava l’esistenza dell’impero romano»35.
Roma rappresentava per Momigliano uno dei due grandi convitati di pietra. L’altro era l’Ebraismo, presente nelle pagine del Droysen studioso di Alessandro e dell’Ellenismo. Qui più che in altri luoghi la distanza tra i due storici investiva il piano della storia universale. Momigliano accettava ben volentieri da Droysen la sua rivalutazione dei secoli ‘ellenistici’, ma trovava assai poco plausibile che nei processi di trasformazione avviatisi in epoca ellenistica non vi fosse stata mediazione alcuna da parte di Roma e dell’Ebraismo. Per altro verso, l’esclusione di Roma sembra coerente con una lettura che legava la riflessione del giovane Droysen a quella che lo storico pomerano portò avanti negli anni seguenti al fallimento della Nationalversammlung di Francoforte e che infine sarebbe culminata in una nazionalizzazione del concetto di Ellenismo entro cui la Macedonia diveniva la Prussia dell’antichità.
La centralità di Roma nel suo intreccio con l’eredità dell’Ellenismo giungeva ad espressione nella voce ‘Roma’, scritta da Momigliano nel 1936 per l’Enciclopedia Italiana. Era questo un lungo intervento entro il quale lo storico piemontese sembrava prendere le distanze da Droysen almeno su due questioni specifiche. La prima, come in altri luoghi, era la sottolineatura della potenza romana in un’ottica weltgeschichtlich, mentre l’altra riguardava la figura di Cesare, bistrattato da Droysen nelle pagine del Briefwechsel36 e oggetto di apprezzamenti da parte di Momigliano in apertura del saggio. Cesare e Roma erano considerati da Momigliano eredi dei successori di Alessandro, questo perché «l’opera di Roma repubblicana aveva dissolto l’equilibrio politico del bacino del Mediterraneo creato dai successori di Alessandro Magno». Tale equilibrio, a causa dell’estremo frazionamento territoriale, era in realtà sempre piuttosto instabile, fondandosi su «guerre reciproche per impedire eccessivi spostamenti di potenza», mentre i singoli
35 Ibidem, 187. 36 Nella lettera del 6 luglio 1883 all’amico Alfred Dove, Droysen definiva Cesare «oltremodo
ipocrita e tendenzioso» (Droysen, Briefwechsel, II, 961-962). La traduzione di tutti i passi tratti dall’epistolario di Droysen è di chi scrive.
60 FRANCESCO GUERRA
paesi sembravano essere attraversati al loro interno da un processo di disfa-fa-cimento che ogni giorno di più toglieva loro vitalità37.
Pertanto al centro della storia universale non potrebbero porsi gli stati ellenistici, tanto più di fronte all’ascesa di Roma. Qui Momigliano svolgeva un’operazione singolare; se, da un lato, prendeva consapevolmente conge-do dallo schema di storia universale proposto da Droysen in entrambe le edizioni della Geschichte des Hellenismus, prefigurando nel frazionamento statale ellenistico il ruolo che sarebbe stato ricoperto da Roma, dall’altro, sembrava tornare alla Geschichte Alexanders des Großen del 1833, quan-do osservava che a tanto logoramento esterno ed interno «Roma aveva contrapposto una forma politica, che potenzialmente significava il ritorno all’impero universale di Alessandro». L’universalismo incarnato da Roma era stato quindi preparato dalle conquiste di Alessandro, il suo ideale della Weltmonarchie rivolta all’Oriente era stato fatto proprio dall’impero romano e portato al suo massimo splendore. Di ciò si era avuta conferma a partire dal III secolo a.C. con «l’allargamento dei rapporti commerciali e la tutela della cultura greca», cui va aggiunto che «i circoli intellettuali di Roma […] avevano saputo afferrare quell’esigenza etica, di giustizia, di concordia e di pace, che i Greci avevano posto nelle loro elaborazioni teoretiche a criterio del dominio del più forte, e a cui, come a ideale, si erano confrontati gli stati ellenistici». L’istanza universalizzante che legherebbe l’imperialismo macedone a quello romano sembrerebbe rimandare alla lettura che a partire dai primi anni ’30 Momigliano aveva dato della Geschichte Alexanders des Großen di Droysen e più in generale del suo concetto di Ellenismo, lettura, questa, che suggeriva due piani che lo storico pomerano avrebbe seguito nel corso delle ricerche: uno precipuamente filosofico-religioso, in cui Alessandro e l’Ellenismo sono visti come i momenti aurorali di uno sviluppo che culmina nel Cristianesimo, e l’altro legato alla sfera politica, che vedeva nel condottiero macedone colui che dette sostanza all’ideale della monarchia universale. Questo piano dell’analisi droyseniana, che peraltro manteneva un considerevole spessore filosofico, è adesso, implicitamente, preso in considerazione da Momigliano e da lui impiegato come una sorta di principio euristico con cui leggere gli sviluppi, all’interno come all’esterno, della storia romana in età imperiale38.
37 Momigliano 1936, 628 (la voce, con il titolo ‘Roma in età imperiale’, è stata riedita in A. Momigliano, Sesto Contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, II, Roma 1980, 591-673).
38 Ibidem, 628-629. Si legge a p. 629: «Anche se le province orientali non avessero avuto, tra i modi di esprimere la propria influenza, cioè, poi, implicitamente i loro desiderata, la concezio-ne del sovrano, che, essendo superiore a tutti i suoi sudditi, tutti li parifica davanti a sé e perciò tende a eliminare le differenze fra dominati e dominatori; anche se in tal modo esse non avessero
61ARNALDO MOMIGLIANO LETTORE DI DROYSEN
La continuità stabilita tra Cesare e Alessandro, tuttavia, segna una cesura profonda tra la riflessione droyseniana e quella di Momigliano e appare tanto più acuita nel momento in cui lo storico piemontese non solo rintracciava in Roma il punto archimedeo della storia universale da un punto di vista politico, ma vedeva in Alessandro il precursore di quella idea di impero, che solo con Cesare giungerà a piena maturazione. L’impero, visto come questione centrale, costituiva anche lo sfondo delle riflessioni di Droysen, quando accostava la stagnazione politica greca e persiana alle incalcolabili trasformazioni cui la Macedonia dette avvio con le sue conquiste.
A ciò si aggiunga che «l’armoniosa collaborazione dei singoli elemen-ti» che componevano la struttura imperiale romana, frutto del potere di un uomo, «l’imperatore, sostenuto dall’esercito» che «si elevava a forza regolatrice da cui quella collaborazione dipendeva», si legava alla medesi-ma caratterizzazione che di Alessandro e del rapporto col proprio esercito Droysen aveva fornito nelle differenti redazioni della sua opera. L’elemento di rottura introdotto dalla Macedonia sotto il profilo precipuamente politico, tanto rispetto alla Grecia come alla Persia, era consistito proprio in questa identificazione di ruoli tra potere sovrano e comando dell’esercito.
La monarchia militare macedone poteva dunque dirsi tale perché al suo interno la massima autorità politica era al tempo stesso la suprema carica militare, una coincidenza di piani che creò le premesse per quella collabora-zione armoniosa che Momigliano, a ragione, riferiva a Roma. Sempre sulla scia di Droysen, Momigliano rilevava che il portato maggiore del potere imperiale era stato un concetto di pace inteso in senso duplice, come fine dei conflitti all’interno dei singoli territori e traduzione pratica di quell’idea di pace comune «che attraversa tutta l’età ellenistica asserendo la necessità dell’abolizione delle guerre fra i partecipi di civiltà identica»39. In uno degli ultimi capitoli della prima edizione della Geschichte Alexanders des Großen Droysen, dopo aver precisato che l’opera di Alessandro non fu la brutale instaurazione di una Weltmonarchie, bensì la consapevole creazione di una Weltbildung, ne esaltava l’azione perché il Macedone ruppe con divinità e miti del Paganesimo frutto di una diversità storica e nazionale incompatibile con la «sua incessante aspirazione all’unione dei popoli».
offerto una concreta connessione storica con l’ideale di Alessandro Magno, si dovrebbe già di per sé riconoscere che con Cesare si ha il momento decisivo dell’elevazione dello stato romano a cosmopoli. Quel che era realtà potenziale fin dal momento in cui lo stato romano aveva assunto l’eredità degli stati ellenistici, ora diventava nettamente realtà effettiva, e non è necessario dire con quale diversa maturità politica, con quale diverso orientamento, non solo geografico, di fronte ai piani di Alessandro, lo diventava. Tutto è detto nella constatazione che presso i più varî popoli, Cesare, e non Alessandro, è diventato il simbolo dell’autorità imperiale».
39 Ibidem, 629.
62 FRANCESCO GUERRA
Pur non parlando mai in maniera esplicita di pace comune, Droysen a tale concetto si riferiva quando dichiarava che Alessandro, spinto da quella aspirazione, fece quanto era in suo potere per realizzarla, trovandosi, tale unione, «preformata nella sua persona e nel suo dominio». Fu nel senso di questa ‘pax macedone’ che egli «onorò ogni culto nazionale senza differenza e con la stessa devozione fece offerte agli dei di Egitto e India, di Babilonia e dell’Ellade; il suo esempio fu attivo in circoli sempre più vasti, si comin-ciarono a rendere locali divinità dei paesi stranieri e si ritrovarono divinità del proprio paese in quelli stranieri». Una ‘pax macedone’ già declinabile nei termini di una pace comune, che prefigurava quel sentimento di appar-tenenza a una medesima civiltà che permise il radicarsi della convinzione secondo la quale tutti i popoli, pur in modi diversi, avrebbero adorato uguali divinità40. Le conquiste di Alessandro avevano rivelato che il tempo delle religioni nazionali presto sarebbe passato lasciando spazio a una religione unica e universale, il Cristianesimo, ciò di cui l’umanità da tempo sarebbe stata bisognosa.
Pertanto, mentre Momigliano forniva un fondamento del tutto politico all’idea della pace comune, ancorandolo alla capacità dello stato romano di universalizzare il proprio potere, il Droysen del 1833 affrontava questo stesso tema riconnettendo il piano politico della sua esposizione con quello religioso, invero essendo costretto a risolvere il primo nel secondo perché consapevole che la continuità nell’universalità apparteneva al Cristianesimo e, sotto il profilo politico, all’impero romano, ma mai fu conquistata dalla monarchia di Alessandro, la cui universalità dovette estinguersi con lui41.
40 Cfr. supra, 49 e n. 17. 41 Nel saggio dedicato a Droysen risalente al periodo anteriore alla guerra (‘La unità della
storia politica greca. A proposito della Storia dei Greci di G. De Sanctis’, 1939), Momigliano osservava: «La scoperta dell’Ellenismo era stata compiuta in nome dei motivi universalistici della storiografia romantica ansiosa di trovare una mediazione tra mondo classico e Ellenismo, mentre la trasformazione dei due Macedoni in realizzatori dell’unificazione nazionale fu il pro-dotto del configurarsi in senso nazionalistico della cultura del più tardo secolo XIX. Ma poiché fu singolare destino che lo scopritore dell’Ellenismo, J.G. Droysen, si trasformasse poi da storico dell’annunciazione del Cristianesimo in storico dell’idea nazionale […] questi motivi opposti egli combinò inconsapevolmente nella sua opera, e in specie nella seconda edizione della Ge-schichte des Hellenismus». La questione posta dalla presente recensione di Momigliano riguarda la peculiare unità della storia greca, la quale non consisterebbe «in un problema di unificazione politica», quanto, piuttosto, in una «unità di civiltà», «in una interdipendenza e comunanza di problemi politici e culturali». Nella ‘Premessa’ alla Storia dei Greci De Sanctis dichiarava (p. 3) «che essa [la storia greca] non ha organicità e quindi dignità vera di storia se non là dove si è manifestato continuamente e con risultati sempre più larghi il conato verso una effettiva unità politica». Parimenti il portato maggiore di questo lavoro sta nel fatto di avere fornito «la più sicura base alla eliminazione completa di ogni interferenza dell’unità politica nella storia greca», ciò che, secondo Momigliano, emergerebbe dalla stessa conclusione dell’opera. Così declinata, la storia politica greca coincideva con la storia di tutti quei problemi che non possono esaurirsi nel quadro politico di un solo stato, ma che rimandano alla collettività degli individui o degli
63ARNALDO MOMIGLIANO LETTORE DI DROYSEN
La presente lettura di Momigliano, tuttavia, sembra incontrare alcune difficoltà già considerando il piano dell’opera del 1833. Questa prevedeva una suddivisione in nove capitoli di cui cinque recano nel titolo espliciti riferimenti alle campagne militari sostenute da Alessandro, da quella in Asia Minore fino all’ultima combattuta in India contro il re Poro. A fronte di questa presenza dell’elemento politico si ha, in effetti, un’analisi condotta da Droysen non solo su un argomento diverso, quello religioso, ma ben più estesamente su un altro livello, quello relativo alla storia universale42.
Parimenti l’interpretazione data da Momigliano può divenire maggior-mente plausibile, riconoscendo che il problema religioso, nella prima come nella seconda edizione della Geschichte Alexanders des Großen, costituisce una sorta di motivo interno alla trattazione di Droysen. Questo discorso, non a caso affrontato in maniera cospicua proprio al termine di entrambi i volumi, sembra essere una parte di un insieme più grande, quello politico, al centro del quale stava la questione di come fornire un’identità comune ai popoli dell’Europa, ai Greci soprattutto, e a quelli dell’Asia, quanto Droysen in termini di storia universale verrà a caratterizzare con l’efficace imma-gine della Völkermischung. In tal modo la Verschmelzung costituirebbe in primis l’esito pratico della creazione di uno stato supernazionale e al tempo stesso l’unica possibilità per tenere legate tra loro le differenti realtà via via abbracciate dall’imperialismo macedone, cui va aggiunto che Droysen vide sempre nell’unione e nell’affermazione del carattere greco-macedone l’esito della storia greca. Questo perché nel 1833 come nel 1877 lo stato nazionale rappresenta un momento che deve essere trasceso in una Weltmonarchie.
stati greci, avendo rappresentato un problema comune per tutti i Greci. Da ultimo, dunque, «il contenuto della coscienza nazionale greca non è un dato, ma coincide con lo stesso svolgersi degli interessi comuni ai Greci, e fu coscienza politicamente nazionale in quanto tali interessi furono politici. C’è una nazione greca perché ci sono stati problemi comuni tra i Greci (forse anche quello di cercarsi un avo comune), e non viceversa. Questa è la vera storia greca, la quale è largamente distribuita nelle opere fin qui composte, e massimamente del Grote e del De Sanctis, perché essi hanno avuto lo sguardo maggiormente rivolto alle realizzazioni dei Greci nel campo dei valori etico-politici, ma deve ancora assumere la sua piena autonomia: risolvere in sé le storie di Sparta e Atene e Arcadia e Rodi per il fatto stesso di riconoscerle distinte» (A. Momigliano, ‘La unità della storia politica greca. A proposito della Storia dei Greci di G. De Sanctis’, ora in Id., Nono contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, a cura di R. Di Donato, Roma 1992, 459-463). Sebbene la complessità dell’argomento non lo consenta, sarebbe qui da esaminare il legame che unisce il tema della storiografia romantica, e più in generale del Romanticismo, a quello dell’unificazione nazionale nella lettura di Droysen offerta da Momigliano. Più ancora sarebbe da chiarire quanto l’aver riconnesso i motivi universalistici presenti nel primo Droysen alla storiografia romantica possa, da ultimo, aver influenzato Momigliano nella comprensione dei motivi nazionali dell’Ellenismo del secondo Droysen.
42 Per i riferimenti alle campagne militari di Alessandro si veda l’indice della Geschichte Alexanders des Großen, mentre per le tematiche di carattere storico-universale, in particolare la parte finale del capitolo VIII, pp. 479-487 (Droysen 1931 [1833]). Cfr. W. Nippel, Johann Gustav Droysen: ein Leben zwischen Wissenschaft und Politik, München 2008, spec. 19-40.
64 FRANCESCO GUERRA
Le due edizioni della Geschichte Alexanders des Großen, dunque, sem-brano essere state da Droysen consapevolmente divise in due momenti di cui uno è maggiore, anche dal punto di vista quantitativo, rispetto all’altro. Si tratta del momento dell’unificazione delle frazionate realtà grandi e piccole dell’epoca, Kleinstaaterei greca e tarlato impero persiano, in una Weltmonarchie cui Filippo e Alessandro miravano da sempre. Un progetto politico sarebbe alla base della Geschichte Alexanders des Großen, ciò che, pur con qualche cautela, potrebbe riconnettere Droysen ad un insieme di motivi, che in seguito declinati in senso kleindeutsch, costituiranno lo sfondo concettuale dei suoi scritti di storia moderna e di quelli politici; progetto rispetto al quale la lettura droyseniana della Weltgeschichte rappresenterebbe il momento minoritario, sebbene nelle due edizioni su questo precipuo punto vi sia uno scarto sensibile.
Sotto questo profilo appare sintomatico un certo distacco da Hegel con riferimento al ruolo della personalità in storia e sulla questione del male, avvertibile in Droysen tra la prima e la seconda redazione della Istorica. Tale distacco è più cospicuo tra la prima e la seconda edizione della Geschichte Alexanders des Großen e non sembra riguardare soltanto l’eredità hegeliana, ma investire l’intero rapporto tra Droysen e la lettura degli eventi storici in senso filosofico. Mentre nella prima edizione tali eventi mantenevano un contatto con un disegno di storia universale (solo per fare un esempio si pensi alle pagine dedicate alla Völkermischung o alla descrizione delle nozze di Susa), nella scansione dell’opera del 1877 la stessa Vermischung, pur non priva di accenti filosofici, è declinata in termini tesi a sottolineare il carattere politico dell’unione/unificazione dell’elemento/popolo greco-macedone con gli elementi/popoli orientali, in modo particolare con quello persiano43.
Pertanto Momigliano ha ragione quando rintraccia nel Droysen soprat-tutto della seconda edizione della Geschichte Alexanders des Großen una Steigerung, di cui un segno evidente sarebbe l’inserimento dell’opera nel quadro della storia ellenistica e non più come suo momento aurorale. Tut-tavia, e qui sta la distanza rispetto alla lettura di Momigliano, la questione politica, prussiana o meno che sia alla radice, attraversa da sempre la rifles-sione di Droysen, posta in tensione continua con l’altro elemento, quello della Weltgeschichte, il quale nel corso degli anni andrà mitigandosi (ecce-zion fatta per il primo periodo delle lezioni su enciclopedia e metodologia della storia), per poi sfumare anche qui di fronte all’ascesa del Positivismo e a un dibattito storiografico sempre più polarizzato tra natura/storia ed Erklären/Verstehen.
43 Cfr. Droysen 1952 [1877], 358-383, 387-412.
65ARNALDO MOMIGLIANO LETTORE DI DROYSEN
Infine, alcune osservazioni di carattere storico-biografico sulla secon-da edizione della Geschichte des Hellenismus e in generale sul rapporto instaurato da Droysen con la storia dell’antichità a partire dagli anni ’60. Nella Antrittsrede tenuta all’Accademia di Berlino il 4 luglio 1867 lo storico pomerano dichiarava come «in anni andati» si fosse dedicato allo studio di quel periodo della storia antica che va «da Alessandro a Cesare e dalla grecità conduce al Cristianesimo». Anche qui il disegno storico-universale sembrava essere una cornice entro la quale trovavano espressione contenuti precipuamente politici, che a loro volta si irradiavano sulla tematica religiosa. Droysen riferiva come mutate condizioni esteriori, ponendogli compiti del tutto nuovi, lo avessero allontanato dal suo primo progetto sull’Ellenismo, ciononostante la mediazione della storia antica doveva rimanere nella sua riflessione pur nelle mutate condizioni esteriori44.
In una lettera da Jena inviata all’amico Wilhelm Arendt il 10 marzo 1858, Droysen faceva alcune considerazioni su Heinrich von Sybel, riconoscendo le indubbie qualità dei suoi lavori sulla monarchia degli antichi Tedeschi e sulla storia della Rivoluzione francese, perché egli era stato misurato nel giudizio, mantenendo un nobile atteggiamento etico senza cercare di fare presa sul lettore mediante frasi a effetto o cercando l’effetto drammatico. Tuttavia,
a lui come a tutta la scuola rankiana manca il mondo antico e forse perciò il bisogno o la capacità della grande concezione storico-universale, che certo non si ottiene senza Isaia e Eschilo, senza Aristotele e Agostino. Potrei anche esprimerlo così: Sybel non giunge alle questioni ultime e nel complesso la storia è per lui ciò che riguarda le cose statali; ma che questo è soltanto un lato della storia, che per questa sono altrettanto essenziali i riferimenti sociali e spirituali, che in tutte queste sfere vi sono solo molte forme di espressione dell’Uno, che le muove, determina il fatto che noi dobbiamo cercare la nostra scienza in Dio […] e che la nostra scienza ha da essere in modo concentrico unita alla nostra più interna vita etica: queste cose certamente non sono interessanti per Sybel. Tu conosci le mie mancanze, e anche io su per giù le conosco; ma so anche di comprendere Bacone, Dante, Omero e un poco anche il Pentateuco; del resto un pregio, che ha i suoi pericoli, e di cui io non sono meno consapevole45.
La relazione sembra stabilirsi tra ricezione del mondo antico da parte dello storico e sua capacità di dare forma a un quadro di storia-universale entro cui gli eventi descritti possano essere compresi nelle loro più interne connessioni. Qui, più che in altri luoghi, il luterano Droysen sembra esprimere con parole
44 ‘Discorso di recezione all’Accademia di Berlino’, in Droysen 1966 [1857], 435. 45 Droysen, Briefwechsel, II, 534-535.
66 FRANCESCO GUERRA
diverse un sentimento che già aveva esposto nella ‘Prefazione’ privata al II volume della Geschichte des Hellenismus nel 1843. Più complesso appare invece comprendere la portata effettiva di questo pensiero nelle singole opere droyseniane, da quelle su Alessandro e l’Ellenismo ai quattordici volumi che compongono la Geschichte der preußischen Politik, perché in queste righe la trattazione «della grande concezione storico-universale» rimanda a quella sulle «questioni ultime» che sempre dovrebbe competere allo storico.
Questioni ultime, le quali, al di là delle proposizioni teoriche di Droysen, rimangono sostanzialmente inoperanti sotto il profilo pratico. Per quanto lo storico pomerano non si limiti mai alla semplice esposizione delle questioni politiche proprie di uno Stato, parimenti nei suoi lavori trovano spazio que-stioni di carattere sociale come spirituale, le «molte forme di espressione dell’Uno», senza però che questi piani si incontrino con quello religioso. Piuttosto sembra potersi leggere in quel legame tra scienza storica e Dio una sorta di imperativo della ricerca e ciò che sempre, «in modo concentrico», la riporta alla sua radice etica. Pertanto, se su un piano meramente contenuti-stico le singole opere droyseniane sono più vicine a esposizioni politiche o, come è il caso della Geschichte Alexanders des Großen e della Geschichte des Hellenismus nelle due scansioni dell’opera, anche di storia della civiltà, si tratta per lui di garantire la dimensione etica della scienza e ciò può av-venire solo con una sanzione di tipo teologico. Almeno a un livello teorico, studio della storia, fede in Dio e vita etica sono uniti attraverso un richiamo vicendevole, che esclude ogni preminenza di un momento sull’altro.
Nel corso degli anni tuttavia il legame tra Droysen e la storia dell’antichità andò progressivamente allentandosi, per quanto egli continuasse a tenere lezioni e seminari sulla alte Geschichte. Cospicua testimonianza di questo atteggiamento si può ricavare dalla lettura di talune pagine del Briefwechsel comprese tra il 1859, anno della chiamata a Berlino, e i primi anni Ottanta (Droysen morirà il 19 giugno 1884). Mentre sarà da rivolgere una particolare attenzione al periodo precedente al biennio 1877/1878 al fine di ritrovare nell’epistolario tracce di quella rielaborazione della Geschichte des Hellenismus cui faceva riferimento Momigliano.
In una lettera del 27 novembre 1873 a Heinrich von Treitschke, Droysen riferiva dei corsi di Storia antica che intendeva svolgere. Quattro anni prima della pubblicazione della seconda edizione della Geschichte des Hellenismus scriveva: «Per l’estate io terrò un corso sulla Storia dell’epoca della Rifor-ma e in più uno sulle Fonti della storia moderna, nell’inverno poi uno sulla Storia dal 1648 al 1763 e un altro sulla Storia greca». Il primo riferimento a questa seconda edizione si trova in una lettera al figlio Gustav risalente al 26 dicembre 1876: «Sono impegnato nelle noiose correzioni dell’Elle-
67ARNALDO MOMIGLIANO LETTORE DI DROYSEN
nismo, di cui deve essere accelerata la stampa perché io porti a termine il lavoro. Questo già da molto tempo mi ha trattenuto da compiti per me più importanti»46.
In una successiva lettera sempre al figlio Gustav del 31 gennaio 1877, il professore pomerano tornava sul medesimo argomento: «Adesso ho finito con i miei lavori per l’Alessandro, i Diadochi e gli Epigoni, e deve affrettarsi il più possibile la stampa. Presto riceverai anche un piccolo saggio, legato anch’esso a questo ambito di studi». Il tono tradiva una certa soddisfazione motivata non solo dall’avere portato a termine un’impresa lunga e difficile, ma dal fatto di poter tornare a lavorare su ciò che più gli stava a cuore, la storia politica della Prussia e la figura di Federico il Grande:
Quindi intendo tornare ad occuparmi di ciò di cui ho nostalgia. Nonostante la prefazione cosmopolitica di Ranke, scritta come introduzione alla guerra del 1756, un intero decennio di questioni e intrichi, che mai sono stati toccati, è ancora da chiarire […]. Non posso lavorare senza un moto dell’animo, e meno di tutto posso farlo, se nella memoria sopravvive e se rifletto su un simile ‘uomo’, che era tale nel più pieno senso del termine. In ciò consiste il piacere che provo nel lavoro47.
In un arco temporale di diciotto anni, dal 1859 al 1877, Droysen solo occasionalmente richiama la seconda edizione della Geschichte des Hellenismus, mostrando una certa insofferenza nei confronti di questo progetto, lamentando l’impossibilità di lavorare sulla storia prussiana e più ancora senza mai affrontare in modo approfondito questioni riguardanti la storia dell’antichità. A questo impegno in direzione prussiana, e per converso al disimpegno nei confronti della alte Geschichte, contribuì senz’altro la delicata fase storica tedesca di questi anni oscillanti tra la fondazione del Reich nel 1871 e il suo complesso processo di stabilizzazione, ciò che da ultimo fa pensare che una certa stabilità politico-istituzionale, conferita da Bismarck allo stato verso la metà degli anni ’70, poté incoraggiare, se non proprio spingere, Droysen a riprendere in mano il suo primo progetto su Alessandro e i successivi secoli ‘ellenistici’. Parimenti deve costatarsi che, per quanto mitigata, la mediazione dell’Antico nella riflessione storiografica droyseniana non verrà mai meno: prova ne sia che questi continuò a svolgere lezioni e a pubblicare, o in certi casi a ripubblicare, lavori aventi a oggetto
46 Droysen, Briefwechsel, II, 911-912, 918. 47 Ibidem, II, 920. Sul saggio richiamato in precedenza in questa lettera, il riferimento di
Droysen è a ‘Alexanders des Großen Armee’, Hermes 12, 1877, 226-256 (= Droysen 1894, II, 208-231), oppure a ‘Beiträge zu der Frage über die innere Gestaltung des Reiches Alexanders des Großen’, Monatsberichte der Berliner Akademie 1877, 23-45 (= Droysen 1894, II, 232-252).
68 FRANCESCO GUERRA
i più diversi temi di storia dell’antichità48. Un distacco sostanziale ci fu, ma mai portato del tutto a termine, percepibile fin nelle più tarde lettere del professore pomerano e da lui stesso testimoniato come emerge da una pagina delle Erinnerungen di Wilamowitz. Questi, rievocando l’incontro avuto verso la metà degli anni ’70 con Droysen a casa di Emil Hübner, filologo classico e marito della prima figlia di Droysen, Marie, dichiarava che l’ancora stimatissimo storico dell’Ellenismo, malgrado fosse passato ad altro ambito di studi, avesse già in testa la nuova edizione del suo Alessandro e dei Diadochi e che, dopo avergli parlato di Callimaco, si rivolgesse a lui dicendogli: «‘ich bin jetzt anderweitig verheiratet, aber ich treibe immer noch einige Buhlschaft mit meiner Jugendliebe’»49: amore di gioventù fortemente ridimensionatosi nel corso della propria carriera, ma mai spentosi, il rapporto dell’ultimo Droysen con la storia dell’antichità appare sotto diversi aspetti poroso, talvolta quasi conflittuale, comunque non pacificato. Il 6 aprile 1883 così scriveva al figlio Gustav:
Ancora una volta gli antichi Greci incombono su di me al punto che ne ho fin sopra i capelli. Alcune letture sulle città anseatiche e la loro maledetta politica dei monopoli, la cui conseguenza fu un grave dissanguamento della pianura circostante e all’estero, dove queste installarono i loro insediamenti, uffici commerciali e le loro Stahlhöfe, mi hanno condotto ad una revisione della storia greca, la quale altro non sarebbe che anseatismo e particolarismo e la cui vita ha termine non appena al di sopra della loro grettezza e meschinità si fondano stati ordinati provvisti di un comando e di soldati50.
D’altra parte in una lettera all’amico Eduard Bendemann, datata 9 luglio 1883, Droysen tornava sul tema della personalità storica, tema a lui caro esposto mezzo secolo prima nelle pagine della Geschichte Alexanders des Großen. All’epoca il giovane condottiero macedone aveva rappresentato
48 Nel 1881 apparve la terza edizione della traduzione delle opere di Aristofane, dopo che una seconda era già apparsa nel 1869. In una lettera al figlio Gustav del 20 settembre 1881 si legge: «Non sono ancora tornato ad occuparmi della storia prussiana. Quanto ho di fronte, ha bisogno di un particolare accento e di un enorme lavoro preparatorio. In quest’ultimo ancora affogo, perché moltissime cose sono da recuperare o, forse, solo da scovare. Avrei dovuto essere venti anni fa al punto in cui sono adesso, in questo caso sarebbe stato possibile portare a termine l’opera. Questa ora resterà un torso come l’Ellenismo» (Droysen, Briefwechsel, II, 948).
49 U. v. Wilamowitz-Moellendorff, Erinnerungen 1848-1914, Leipzig 1928, 174. Per una maggiore resa testuale, e vista anche l’originalità della frase di Droysen, si è preferito lasciarla nella versione tedesca. Tuttavia la si potrebbe tradurre come segue: «Adesso sono sposato ad un altro argomento, ma mi concedo sempre qualche avventura col mio amore di gioventù».
50 Droysen, Briefwechsel, II, 957. Altrettanto indicativo è il fatto che Droysen nella lettera del 10 maggio dello stesso anno inviata ad August Bouché-Leclerq, professore a Parigi, che avrebbe tradotto in francese la Geschichte des Hellenismus, non scrivesse niente sulle questioni concernenti la storia dell’antichità, piuttosto soffermandosi su aspetti legati in generale alla scienza storica (Droysen, Briefwechsel, II, 959-960).
69ARNALDO MOMIGLIANO LETTORE DI DROYSEN
quel Werkzeug posto al servizio della storia, capace di condurre l’umanità da un’epoca a un’altra, superiore, e di lasciar prefigurare in se stesso la prossima venuta di Cristo. Al presente, però, non appartiene Alessandro, ma Federico II di Prussia, mentre il riconoscimento accordato alla personalità che agisce nella storia non ne inscrive l’azione in uno svolgimento storico-universale, che segnerebbe il passaggio dal Paganesimo al Cristianesimo, al Dio che si è fatto uomo, perché l’azione di Federico, egli essendo «uomo di stato e di guerra», si risolve tutta nel pensare «a partire da un Io più alto», quello del proprio stato e delle sue ragioni. Era questo lo spirito che permeava anche le righe successive della lettera a Bendemann:
So leggere ancora piuttosto bene la grandezza di una personalità – e se non è sfacciato da dire – anche vederla e rallegrarmene. Anzi, in realtà, trovo stimolante solo questa grandezza e sono nella fortunata situazione di potermi imbattere in ciò continuamente nei miei lavori e nei miei pensieri. Perciò adesso sono molto legato al vecchio Fritz51 e studio questo nobile spirito, questo lavoratore severo e dotato di grande senso del dovere, ammirando sempre più questo uomo di stato e di guerra, che non agisce per ostinazione ed egoismo, bensì sempre, per così dire, a partire da un Io più alto, quello del proprio stato. Egli non ha quell’entusiasmo capace di incantare proprio di Alessandro, non il tipico sno-bismo di quel maledetto romano che era Giulio Cesare, né la genialità grezza e grossolana di Cromwell, e meno di tutto ha una qualche somiglianza col grande Napoleone, ‘un gigante di talento’, ma che in sé non ha né raffinatezza né en-tusiasmo, bensì si è portato dietro per tutta la vita una forte dose di meschinità corsa e dissolutezza francese52.
Infine, la centralità assegnata alle singole personalità storiche era ribadita in una delle ultime lettere, quella del 10 maggio 1884 al figlio Gustav: «È una mia vecchia convinzione che vi siano pochi veri personaggi in storia, come per esempio Napoleone, il vecchio Fritz o quel mascalzone di Carlo V. Mi riferisco a quei personaggi per i quali vale la pena trattare la storia del loro tempo come se questa costituisse il loro ambito»53.
Pertanto, se vi è una reminiscenza hegeliana nell’ultimo Droysen, essa sembra rintracciabile nel riferimento alle personalità che sono in grado di fare storia. Ciononostante questo riconoscimento non è più declinato in senso filosofico ma esclusivamente politico, mentre lo sfondo storico-universale della riflessione del primo Droysen sembra aver lasciato il posto a quel «ricercare attentamente e picchiettare», «a quelle piccole, precise ricerche singole», di cui si ha una perspicua testimonianza nella seconda edizione
51 Il riferimento è a Federico II di Prussia.52 Droysen, Briefwechsel, II, 963-964. 53 Ibidem, II, 980.
70 FRANCESCO GUERRA
della Geschichte des Hellenismus dove la Weltgeschichte si riversa tutta in una descrizione della Völkermischung precipuamente storica, e più ancora, in seguito, nei suoi studi relativi alla Storia delle finanze e a quella della Numismatica, i cui risultati furono da lui esposti all’Accademia di Berlino nel 188254.
Il Droysen di Momigliano tra Greci ed EbreiNegli anni del Dopoguerra Momigliano tornò a occuparsi di Droysen con una intensità diversa a seconda dei temi presi in esame. Mentre negli anni precedenti lo storico piemontese, affrontando le pagine droyseniane su Alessandro e l’Ellenismo, ne aveva sottolineato la duplice valenza filosofico-religiosa e storico-politica, adesso sembrava tornare all’Ellenismo con una vocazione non droyseniana, che originava dal tentativo di reinserire il popolo ebraico nella trama della storia universale. Pur parzialmente, era questo un cambiamento di prospettiva – su cui occorre riflettere – rispetto a quanto lui stesso aveva scritto negli anni ’30.
La barbarie del Nazismo, che gli aveva portato via entrambi i genitori, quella del Fascismo, che nel 1924 aveva condotto al suicidio il cugino Felice Momigliano, come pure l’immane tragedia del secondo conflitto mondiale, cui corrispondeva un clima politico-culturale assai diverso rispetto a quello di pochi anni prima, contribuirono ad allontanare Momigliano dal Droysen cantore della monarchia militare macedone. Troppo sospetta doveva apparir-gli la declinazione politica del concetto di universalità presente nella prima edizione della Geschichte Alexanders des Großen, tanto più se si pensa che nella voce ‘Roma’ lui stesso ne aveva espunto ogni riferimento di carattere filosofico-religioso, riportando il tema della pace comune nell’alveo di
54 Il riferimento è ai seguenti scritti di Droysen: ‘Zum Finanzwesen der Ptolomär’, ‘Zum Fi-nanzwesen des Dionysios von Syrakus’, ‘Zum Münzwesens Athens’, Sitzungsberichte der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1882, 1013-1027 (= Droysen 1894, II, 275-305, 306-320, 321-344). Per il primo di questi scritti si veda la lettera del 7 febbraio 1882 a Gustav Hirschfeld, professore di Archeologia a Königsberg (Droysen, Briefwechsel, II, 949). L’espressione «ricercare attentamente e picchiettare» era stata usata nel 1930 da Friedrich Meinecke per caratterizzare la ricerca storica di Droysen. Egli così scriveva: «La singola indagine esasperata, il ‘ricercare attentamente e picchiettare’ gli dava perfino gusto e distensione. Otto Hintze, uno degli ultimi che ebbero la fortuna di partecipare alla sua ‘società istorica’, al seminario che teneva a casa sua davanti a una tazza di tè, udì una volta da lui il detto che suonava già disperato, secondo il quale in generale non si può scrivere storia universale, ma bisogna avvicinarsi alle cose con piccole, precise ricerche singole. Ciò risultava paradossale pronunciato dalla sua bocca, perché disprezzava proprio il nascente specialismo e la piccola maestria della corporazione degli storici» (F. Meinecke, ‘J.G. Droysen, il suo epistolario e la sua storiografia (1929-1930)’ [tr. it. di ‘J.G. Droysen, sein Briefwechsel und seine Geschichtsschreibung’, HZ 141, 1930, 249-287], in Id., Pagine di storiografia e filosofia della storia, a cura di G. Di Costanzo, Napoli 1984, 306-307).
71ARNALDO MOMIGLIANO LETTORE DI DROYSEN
una spiegazione completamente politica in cui l’imperialismo romano e la figura di Cesare erano i termini principali55. Si comprende allora perché quando nei decenni successivi alla guerra Momigliano tornerà sulle pagine di Droysen, lo farà privilegiando l’elemento filosofico-religioso rispetto a quello politico, che pure sarà presente.
I saggi ‘Introduzione all’Ellenismo’, pubblicato nel 1970 su Rivista Storica Italiana, ‘Hellenismus und Gnosis. Randbemerkungen zu Droysens Geschichte des Hellenismus’, anch’esso risalente al 1970 e pubblicato sulla rivista tedesca Saeculum, e ‘J.G. Droysen between Greeks and Jews’, ap-parso nello stesso anno su History and Theory e in seguito ripubblicato in traduzione italiana col titolo ‘J.G. Droysen tra Greci ed Ebrei’ in Tra storia e storicismo (1985), testimoniano della profonda vicinanza tra Momiglia-no e l’Ellenismo e di un segreto dialogo che lo storico piemontese sempre mantenne con la declinazione datane da Droysen.
In ‘Introduzione all’Ellenismo’ l’analisi di Momigliano si concentrava inizialmente su una considerazione di carattere temporale, volta a individuare il periodo storico per il quale sarebbe possibile parlare di Ellenismo. Era questo un aspetto problematico con cui già Droysen, in entrambe le edizioni della sua opera, si era confrontato e al quale aveva cercato di dare risposta. Momigliano sosteneva che con Ellenismo era da intendere quella fase sto-rica che va dalla morte di Alessandro nel 323 a.C. alla fine della monarchia dei Lagidi in Egitto nel 30 a.C. a seguito della morte di Cleopatra. L’altra incertezza riguardava i limiti geografici a cui questo concetto poteva essere applicato nel periodo compreso appunto tra il 323 e il 30 a.C.: Momigliano concludeva che si poteva estendere il termine Ellenismo a tutti gli stati sorti sulle ceneri dell’impero persiano con l’aggiunta della Macedonia e della Grecia.
Ripartire dalle coordinate spaziali e temporali entro cui collocare i secoli ‘ellenistici’ rappresentava il punto di avvio di un nuovo confronto con Droysen. Lo storico pomerano non era stato il primo a interessarsi
55 Nel corso di un intervento nel 1967, Momigliano, riferendosi ai legami che gli studi di storia antica ebbero con Nazismo e Fascismo, dichiarava: «Ora non c’è dubbio che la connessione tra gli studi di storia greca e il nazismo è stata stretta [...]. Ma più ancora pesa sugli studi di storia greca l’illusione che ha avuto espressioni estreme – quasi incredibili, perfino in Wilamowitz – sulla af-finità tra greci e tedeschi con conseguente interpretazione della storia greca in chiave nazionalista tedesca. Naturalmente noi abbiamo avuto in Italia la contaminazione di fascismo e storia romana, che non è da dimenticare né da condonare. Ma per il fatto stesso che i maggiori storici di Roma, Gaetano De Sanctis e Plinio Fraccaro, furono antifascisti, la contaminazione fu più superficiale»: A. Momigliano, Sui fondamenti della storia antica, Torino 1984, 423-424 (= ‘Prospettiva 1967 della storia greca’, RSI 80, 1968, 5-18 = Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, Roma 1969, 43-58).
72 FRANCESCO GUERRA
di Ellenismo, e sulla scia di Rudolf Pfeiffer, Momigliano proponeva qui la tesi di una possibile affinità di pensiero tra Herder e Droysen. Questo perché a partire da Herder «si trovano esempi del termine Ellenismo, che pur conservando il significato linguistico fondamentale, tendono a farne un concetto culturale, quasi una mistione di cultura greca ed ebraica». Droysen nella prima redazione della Geschichte Alexanders des Großen «formulò per primo la nozione oggi prevalente di un periodo storico caratterizzato da mistione di greco e orientale, soprattutto nel campo religioso»56.
La questione relativa alle influenze di Herder sul pensiero storico di Droysen meriterebbe una trattazione a parte ed è stata già oggetto di appro-fondite analisi. In questa sede ci si limiterà a osservare come, fatte salve le indubbie corrispondenze che possono stabilirsi tra Droysen e Herder, nei due volumi del Briefwechsel siano del tutto assenti significativi riferimenti a Herder sia su un piano generale che nel contesto degli studi droyseniani di storia dell’antichità57. Parimenti di questo dovette rendersi conto lo stesso Momigliano, il quale richiamava Herder, ma al tempo stesso precisava come la preoccupazione principale di Droysen non fosse stata rivolta agli Ebrei, bensì al clima culturale entro il quale il Cristianesimo poté svilupparsi, ossia, alla commistione di elementi greci e orientali; osservazione, questa, ribadita poco oltre, quando lo storico piemontese proponeva una diversa linea di sviluppo per la posizione espressa da Droysen. Questi, infatti, non sembrò anticipare la riflessione della Scuola di Tubinga, in particolare quella di Fer-dinand Christian Baur, sui legami tra pensiero greco e giudaico nel processo di formazione del Cristianesimo, quanto, piuttosto, talune tesi «di R. Rei-tzenstein, F. Cumont e altri sulla esistenza delle correnti misteriche pagane precristiane che continuarono a vivere dentro e accanto al Cristianesimo»58.
Si trattava di una lettura sotto certi aspetti condivisa anche da Momiglia-no, il quale concludeva il proprio saggio rilevando come la traduzione della Bibbia in Greco la rese, almeno in teoria, accessibile a tutti coloro che sape-vano leggere quella lingua, quanto può considerarsi «una non intenzionale preparazione al Cristianesimo e un aiuto al proselitismo». Parimenti, però, al di fuori della cerchia dei proseliti raramente i Greci si dedicarono alla lettura della Bibbia; una constatazione che rendeva Momigliano incline a rintracciare più «nell’Ellenismo pagano che non nel Giudaismo i presupposti
56 Momigliano 1970a, 781 (= Momigliano 1975, I, 267-291). In questa pagina Momigliano ricorda che Droysen estendeva la denominazione fino al periodo romano-bizantino della cultura greca. Il limite inferiore di questo periodo rimase vago e comunque non operativo, giacché il lavoro di Droysen mai si spinse al di là del III secolo a.C.
57 Sull’argomento si vedano in particolare Canfora 1987, 37-48; Caianiello 2005, 163-204, 281-289.
58 Momigliano 1970a, 782.
73ARNALDO MOMIGLIANO LETTORE DI DROYSEN
del mistero della Resurrezione, nonché del più tardo culto dei Santi e della Vergine». Così declinato, lo sviluppo del Cristianesimo era da riconnettere alla storia dei secoli ‘ellenistici’ perché «risulta da una prima fase di iso-lamento del Giudaismo» – qui stava la vicinanza con Droysen – «e da una seconda fase in cui il messaggio messianico di Gesù è interpretato in greco per Ebrei e non Ebrei», e qui l’aggiunta di Momigliano, confermata poco più avanti con la distinzione tra due forme diverse di Ellenismo: «All’Ellenismo che fa tutt’uno con il pensiero politico degli stati ellenistici succede un altro Ellenismo – con un’altra storia, legata alle città dell’impero romano e poi alla società romano-cristiana dell’impero bizantino»59.
Nell’articolo ‘Hellenismus und Gnosis’ lo storico piemontese, contra-riamente a quanto sostenuto in precedenti lavori, si mostrava scettico sulla possibilità di legare la fase del Droysen studioso di Alessandro e dell’El-lenismo con quella dello storico delle guerre di liberazione e della politica prussiana, osservando come il crescente interesse mostrato da Droysen per la storia moderna non può considerarsi la circostanza decisiva per l’abbandono della progettata Kulturgeschichte ellenistica. Quanto Momigliano trovava singolare nei dodici anni in cui Droysen lavorò sulla storia politica elleni-stica, è il fatto che questi all’incirca nello stesso periodo si dedicasse con pari intensità ad argomenti concernenti la letteratura classica e la religione della Grecia, mentre non vi sarebbe traccia di ricerche sulla letteratura e la religione dei secoli ‘ellenistici’.
Pertanto, se da un lato Droysen in quegli anni veniva formulando un piano di ricerca incentrato sulla cultura ellenistica, dall’altro raggiunse risultati assai considerevoli dal punto di vista storico-culturale in altri ambiti, con le interpretazioni di Eschilo e Aristofane, i lavori sulla trilogia della tragedia e quelli sull’Antigone e gli Ermocopidi di Sofocle. Era questa una scissione tra il classicismo conservatore, espresso da Droysen nel campo della letteratura, e un superamento dello stesso in altri campi, che non si sarebbe ricomposta e a cui, in certa misura, contribuì l’amicizia e la collaborazione poetica di Droysen con Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Parimenti il classicismo letterario non era la sola difficoltà riscontrabile nelle opere droyseniane, cui si aggiungeva quella più specificamente legata all’assenza dell’Ebraismo nella Geschichte Alexanders des Großen del 1833 e nei due successivi volumi della Geschichte des Hellenismus. In particolare nel primo di questi lavori e in quello del 1836 Droysen avrebbe avanzato la tesi secondo cui la rivelazione cristiana rappresenterebbe l’intervento di Dio nella storia al fine di umiliare e perciò superare il Paganesimo. Tuttavia
59 Ibidem, 798-799.
74 FRANCESCO GUERRA
l’Ebraismo non trovava spazio in questa idea, che, per altro verso, si mostra-va sempre più inconciliabile con la coeva ricerca sulla storia dell’Ebraismo alessandrino e sull’origine del Cristianesimo60. Da ultimo, era questa una lettura che sembrava voler rendere plausibile l’ipotesi secondo la quale l’esclusione da Droysen operata dell’Ebraismo rimanderebbe a motivazioni più di ordine biografico che non relative alla ricerca storica.
Nel saggio ‘J.G. Droysen tra Greci ed Ebrei’, Momigliano avanzava la tesi secondo la quale a partire dal 1838 Droysen si sarebbe interessato in misura maggiore al Giudaismo. Tesi che troverebbe conferma in tre momenti della produzione droyseniana: la recensione al libro di Gottfried Bernhardy Grun-driss der griechischen Literatur, una pagina presente nel secondo volume della Geschichte des Hellenismus e infine una lettera a Friedrich Gottlieb Welcker del 12 settembre 1843. Un fermento, però, che ebbe vita breve, né Droysen si espresse mai su tali argomenti. D’altronde includere l’Ebraismo nel complessivo piano dell’Ellenismo avrebbe non solo comportato «una revisione radicale della sua visione originaria», coinvolgendolo «nei difficili problemi esegetici sollevati dai teologi di Tübingen», ma anche «avrebbe sfiorato […] i più intimi recessi della sua vita individuale»61.
Nel 1829, su proposta di Böckh, Droysen era stato scelto come precet-tore privato per il giovane Felix Mendelssohn-Bartholdy, nonostante che questi fosse più giovane di Droysen di soli sei mesi. Tra i due si instaurò una profonda amicizia di cui la prima parte del Briefwechsel droyseniano reca una cospicua testimonianza. Quello che di lì a pochi anni si sarebbe fatto conoscere come lo storico di Alessandro, si trovò, quasi all’improvviso, a far parte di uno dei più importanti circoli culturali berlinesi frequentato da intellettuali quali Goethe, Alexander e Wilhelm von Humboldt, Hegel, Gans, Heine e naturalmente il suo maestro Böckh62. La caratteristica di questo circolo era di essere formato per la gran parte da Ebrei convertiti al Protestantesimo a partire proprio dal padre di Fe-lix, Abraham Mendelssohn-Bartholdy63. A questo ambiente Droysen si
60 Momigliano 1970b, 186. 61 A. Momigliano, ‘J.G. Droysen tra Greci ed Ebrei’ [tr. it. di ‘J.G. Droysen between Greeks
and Jews’, H&T 2, 1970, 139-153], in Momigliano 1985, 225-226 (ma già in Momigliano 1975, I, 109-126).
62 La prima lettera del Briefwechsel droyseniano è quella dell’11 luglio 1829 inviata alle tre sorelle: Auguste, Mathilde e Ulrike. Qui Droysen si dichiara felice di aver avuto la possibilità di conoscere più da vicino Heine. Tra i due dovette instaurarsi un buon rapporto di amicizia attestato anche dalla lettera di Heine del 6 settembre 1829 (Droysen, Briefwechsel, I, 4, 9-10).
63 «Abraham Mendelssohn-Bartholdy [...] non era [...] solo un ricco banchiere in grado di tenere un salotto di alto stile, ma anche il figlio di Moses Mendelssohn, il filosofo ebreo che era stato una delle figure più rilevanti dell’illuminismo tedesco. Abraham si era convertito su pressione della famiglia della moglie, protestante, che lo vincolò ad aggiungere al suo il loro cognome» (Caianiello 2005, 266).
75ARNALDO MOMIGLIANO LETTORE DI DROYSEN
legò in maniera ancora più stretta quando nel 1836 sposò Marie Mendel, anch’essa di origine ebraica.
La lettura proposta da Momigliano consisteva nel riconnettere il silen-zio di Droysen sull’Ebraismo, tanto più avvertibile dopo il 1838, a questo ambiente di Ebrei convertiti, i quali, pur avendo vissuto seriamente la pro-pria conversione, certamente non avevano dimenticato origine e tradizioni ebraiche. Ciononostante «la società che stava loro intorno chiedeva a questi uomini e a queste donne di comportarsi come se non avessero avuto un passato ebraico, ed in genere essi si adattarono a questa necessità». Regola sociale, dunque, che, per quanto non scritta, agì come un tabù in uno dei più colti e raffinati salotti berlinesi della prima metà dell’Ottocento e che renderebbe al tempo stesso verosimile la tesi di un Droysen che preferì non portare a termine il suo primo lavoro sull’Ellenismo, non affrontando il problema dei rapporti tra Ebraismo e Cristianesimo, pur di rispettare tale dettame. Del resto «egli doveva sapere che i suoi amici stavano riflettendo nei loro silenzi su questo tema. Rimase anch’egli in silenzio»64.
L’ultimo intervento di Momigliano sull’Ellenismo, pur non direttamente riguardante Droysen, data 1975. Il testo, una serie di conferenze tenute nel maggio del 1973 all’Università di Cambridge e in forma riveduta nel febbraio-marzo del successivo anno al Bryn Mawr College, apparve dapprima in lingua inglese col titolo Alien Wisdom. The limits of Hellenization e cinque anni più tardi in Italiano col titolo Saggezza straniera. L’Ellenismo e le altre culture. La vicinanza temporale con gli altri contributi di Momigliano sul rapporto tra Ellenismo ed Ebraismo attesta il profondo ripensamento che lo storico piemontese operò nei decenni successivi alla guerra per reinserire, di fatto, il mondo ebraico in una più ampia spiegazione di carattere storico-universale65.
Una rilettura dei secoli ‘ellenistici’, che, come si è visto, si saldava a una sua parziale reinterpretazione dell’opera e della figura di Droysen, fino a formulare l’ipotesi che lo storico pomerano avesse interrotto il suo primo lavoro sull’Ellenismo per non urtare la sensibilità religiosa del circolo di Ebrei convertiti al Protestantesimo riuniti attorno alla famiglia Mendelssohn-Bartholdy, tra cui la prima moglie di Droysen Marie Mendel e amici cari quali Felix e Fanny Mendelssohn-Bartholdy ed Eduard Bendemann. Questo contributo fin dal sottotitolo (The limits of Hellenization), maldestramente tradotto in italiano con un’immagine tesa a sottolineare la relazione tra Ellenismo e altre culture, sembrerebbe potersi leggere in sostanziale conti-nuità con la parte finale del saggio ‘J.G. Droysen tra Greci ed Ebrei’, dove
64 Momigliano 1985, 228. Cfr. Momigliano 1970b, 188. 65 Con riferimento a questo lavoro si veda il recente Salmeri 2006.
76 FRANCESCO GUERRA
Momigliano osservava come in Droysen lo sviluppo dell’Ellenismo avrebbe significato una progressiva presa d’atto dei limiti dello stesso e perciò anche discutere delle origini del Cristianesimo affrontando il delicatissimo tema dei suoi rapporti con l’Ebraismo.
Nel primo capitolo, ‘I Greci e i loro vicini’, Momigliano tornava a dare centralità all’imperialismo romano, e alla serie di fattori che contribuirono al suo successo, in un senso completamente diverso rispetto a quanto alcu-ni decenni prima aveva fatto nella voce ‘Roma’ scritta per l’Enciclopedia Italiana. All’epoca l’impero romano era stato posto in parallelo con la potenza greco-macedone dell’impero di Alessandro, sebbene anche allora lo storico piemontese rilevasse come Roma non avesse soltanto fatto pro-prio l’universalismo di Alessandro, affinandolo in misura considerevole. Adesso l’imperialismo romano non era visto in una scala di imperi come un accrescimento rispetto a quanto lo aveva preceduto, dove la Macedonia di Alessandro avrebbe fatto da precursore. Piuttosto l’attenzione di Momi-gliano sembrava rivolta a quei popoli, «gli Ebrei e gli Iranici», che per un certo tempo respinsero gli attacchi romani, e a sottolineare come «quattro dei cinque protagonisti della nostra storia – Greco-macedoni, Romani, Ebrei e Celti – entrarono in contatto fra loro per la prima volta nel periodo ellenistico». Così declinata l’età ellenistica non rappresentava più solo il passaggio dal Paganesimo al Cristianesimo, quanto «il confronto […] tra i Greci e quattro altre civiltà, tre delle quali praticamente sconosciute prima d’allora, e la quarta conosciuta in circostanze assai diverse»66.
Ciò che mutava rispetto all’impianto ellenistico droyseniano era il preci-puo rilievo assegnato da Momigliano alla triangolazione di Ebrei, Romani e Greci. Più ancora, egli ritenne caratteristico della civiltà ellenistica «il ruolo eccezionale che giunsero a giocarvi due gruppi stranieri, Ebrei e Romani». Ma il più sensibile superamento di Droysen avveniva riguardo al Cristiane-simo. Gli Ebrei non si erano solamente limitati a preservare le loro credenze e il loro sistema di vita di fronte alla potenza romana; essi mantennero un continuo dialogo con i Greci, confrontando sempre le loro idee con quelle greche, «assorbendo nel contempo molti concetti e costumi greci», in tal modo trovandosi progressivamente coinvolti «in quel confronto globale tra valori greci e valori ebraici che chiamiamo Cristianesimo».
In Droysen il terreno sul quale sarebbe sorto il Cristianesimo era stato preparato attraverso un processo di fusione (Verschmelzung) che aveva coinvolto l’elemento greco-macedone, impersonato da Alessandro, e le spente popolazioni dell’Oriente, di cui la Persia poteva considerarsi il più
66 Momigliano 1980, 3-4.
77ARNALDO MOMIGLIANO LETTORE DI DROYSEN
illustre esponente67. In queste pagine di Momigliano la Völkermischung non prevedeva un elemento attivo e uno passivo, che offrirebbe la materia per la trasformazione, bensì una mediazione frutto di confronto, prestiti e influenze reciproche. Momigliano sapeva che non era possibile porre su un medesimo piano queste tre popolazioni, perché i Romani «agivano da una posizione di forza e, senza darsi troppo da fare, conservarono una netta coscienza della propria identità e superiorità». Perciò, interrompendo la triangolazione tra Ebrei, Greci e Romani e attraverso l’isolamento del terzo termine, lo storico piemontese proponeva una lettura dei secoli ‘ellenistici’ del tutto originale.
L’Ellenismo non solo non era stato un mero passaggio dal Paganesimo al Cristianesimo, avvenuto unendo tra loro la popolazione greco-macedone con quella orientale; più ancora, esso non era stato un processo unitario. La relazione tra Greci ed Ebrei condusse a un Ellenismo di tipo greco e di qui al Cristianesimo, tuttavia tra Greci e Romani si stabilì un nuovo confronto e per questa via «attraverso l’assimilazione e l’appropriazione di tante divinità, convenzioni letterarie, forme artistiche, idee filosofiche e costumi sociali di origine greca, i Romani crearono fra sé e i Greci un rapporto reciproco tutto particolare», favoriti in questo dal fatto di avere reso la propria lingua «uno strumento culturale che poteva rivaleggiare con quella dei Greci»68.
67 Pur con l’importante mediazione della geografia di Karl Ritter, questa lettura data da Droysen appare influenzata da una diffusa vulgata europea sull’Oriente che ne Lo spirito delle leggi di Montesquieu, in particolare nell’esposizione della cosiddetta teoria dei climi, come pure in taluni lavori di Leopold von Ranke e di Hegel, solo per citare autori che potevano essere accessibili a Droysen, ricevette una cospicua trattazione. Sull’argomento si veda E. Schulin, L’idea di Oriente in Ranke e Hegel, Napoli 1999 [tr. it. di Die weltgeschichtliche Erfassung des Orients bei Hegel und Ranke, Göttingen 1958].
68 Momigliano 1980, 12-13; sul rapporto tra Greci ed Ebrei si veda in particolare il IV capitolo, ‘La scoperta ellenistica del Giudaismo’, pp. 78-100. Sull’eredità droyseniana nelle pagine di Momigliano si rimanda al classico lavoro di G. Sasso, ‘Il «contributo» di Arnaldo Momigliano’, in Id., Il guardiano della storiografia. Profilo di Federico Chabod e altri saggi, Napoli 2002, spec. 231-277; mentre, con particolare riferimento all’ultimo Momigliano nel suo rapporto con Droysen e con il Giudaismo, al saggio di M. Isnardi Parente, ‘Arnaldo Momigliano, la VII epistola platonica e l’autobiografia’, in Ead., I miei maestri, Napoli 2003, 112-116. Più in generale su Momigliano si vedano C. Dionisotti, ‘Ricordo di Arnaldo Momigliano’, ASNP 17, 1987, 549-564, e il volume con lo stesso titolo (Bologna 1989). Invece su Momigliano e l’Ebraismo sono da vedere I. Cervelli, ‘Su alcuni aspetti della ricerca ebraistica di Arnaldo Momigliano’, StudStor 29, 1988, 599-643; E. Gabba, ‘Aspetti della storiografia di Arnaldo Momigliano’, RSI 100, 1988, 361-380, spec. 374-375; S.H. Hughes, ‘Arnaldo Momigliano: la storia universale, la civiltà ellenistica e gli Ebrei’, ibidem, 414-421; E. Patlagean, ‘Ebraismo e storia degli studi classici secondo Arnaldo Momigliano’, ibidem, 440-446; E. Gabba, ‘Ricordo di Arnaldo Momigliano storico del mondo antico’, in Omaggio a Momigliano, 19-22; F. Parente, ‘Ellenismo e giudaismo nell’interpretazione di Arnaldo Momigliano’, ibidem, 96-101; Id., ‘Arnaldo Momigliano e il giudaismo. Tra storia e autobiografia’, StudStor 30, 1989, 66, 72; C. Dionisotti, ‘Momigliano e il contesto’, Belfagor 52, 1997, 633-635. Infine, si veda anche G. Granata, ‘La resistenza all’ellenizzazione. Il corpus di inediti momiglianei sul giudaismo ellenistico (1977-1982)’, in Studi Ellenistici, a cura di B. Virgilio, XII, Pisa - Roma 1999, 73-92; E. Gabba, ‘Appunti per una discussione’, in Momigliano nel Novecento, 235-238; Salmeri 2006; L. Troiani, ‘Le «Pagine ebraiche»’, in Momigliano nel Novecento, 139-148.
78 FRANCESCO GUERRA
Era stato così possibile che accanto a un Ellenismo di origine greca si formasse a partire dal III secolo a.C. un Ellenismo latino, che nel giro di due secoli avrebbe conquistato il mondo di lingua greca: una triangolazione dun-que, che prevedeva l’elemento greco come solvente in grado di sciogliere il forte senso di appartenenza di Ebrei e Romani e portarli a un superiore grado di civiltà rappresentato dal Cristianesimo. Pur mantenendosi le differenze tra le diverse declinazioni dell’Ellenismo, a un certo momento le due linee di sviluppo poterono ricomporsi all’interno di un processo che avrebbe trovato la propria conclusione nella diffusione del messaggio di Cristo.
Quanto detto costituiva il limite estremo verso cui poteva tendersi l’ele-mento greco, perché se «in clima ellenistico […] Latini ed Ebrei appresero la lingua dei Greci, assimilarono le loro idee, misero in discussione il loro sistema di vita», rimaneva indiscutibilmente vero che «la fusione delle tradizioni dei tre popoli fu opera del Cristianesimo»69.
Abbreviazioni bibliografiche
Beloch 1933G. Beloch, Le monarchie ellenistiche e la repubblica romana, Bari 1933.
Caianiello 2005S. Caianiello, Scienza e tempo alle origini dello storicismo tedesco, Napoli 2005.
Canfora 1987L. Canfora, Ellenismo, Roma - Bari 1987.
De Sanctis 1932G. De Sanctis, Problemi di storia antica, Bari 1932.
Droysen 1931 [1833]J.G. Droysen, Geschichte Alexanders des Großen, hrsg. v. H. Berve, Leipzig 1931 [Berlin 1833].
Droysen 1966 [1857]J.G. Droysen, Istorica. Lezioni sulla Enciclopedia e Metodologia della storia, traduzione italiana di L. Emery, Milano - Napoli 1966 [tr. it. di Historik. Vorle-Vorle-sungen über Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte, hrsg. v. R. Hübner, München - Oldenburg 1936].
Droysen 1952 [1877]J.G. Droysen, Geschichte des Alexanders des Großen, hrsg. v. E. Bayer, Basel 1952 [Gotha 1877].
69 Momigliano 1980, 167.
79ARNALDO MOMIGLIANO LETTORE DI DROYSEN
Droysen 1894J.G. Droysen, Kleine Schriften zur alten Geschichte, hrsg. v. E. Hübner, I-II, Leipzig 1894.
Droysen, BriefwechselJ.G. Droysen, Briefwechsel, hrsg. v. R. Hübner, I-II, Stuttgart - Berlin - Leipzig 1929.
Momigliano 1934A. Momigliano, Filippo il Macedone. Saggio sulla storia greca del IV secolo a.C., Firenze 1934.
Momigliano 1936A. Momigliano, ‘Roma, impero’, in Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, XXIX, Roma 1936, 628-654, 661-663.
Momigliano 1955A. Momigliano, Contributo alla storia degli studi classici, Roma 1955.
Momigliano 1970aA. Momigliano, ‘Introduzione all’Ellenismo’, RSI 82, 1970, 781-799.
Momigliano 1970bA. Momigliano, ‘Hellenismus und Gnosis. Randbemerkungen zu Droysens Geschichte des Hellenismus’, Saeculum 21, 1970, 185-188.
Momigliano 1975A. Momigliano, Quinto Contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, I-II, Roma 1975.
Momigliano 1980A. Momigliano, Saggezza straniera. L’Ellenismo e le altre culture, Torino 1980 [tr. it. di Alien Wisdom. The limits of Hellenization, Cambridge 1975].
Momigliano 1985A. Momigliano, Tra storia e storicismo, Pisa 1985.
Momigliano 1987A. Momigliano, Storia e storiografia antica, Bologna 1987.
Momigliano nel NovecentoArnaldo Momigliano nella storiografia del Novecento, a cura di L. Polverini, Roma 2006.
Omaggio a MomiglianoOmaggio ad Arnaldo Momigliano. Storia e storiografia sul mondo antico (Convegno di studio, Cuneo-Caraglio, 22-23 ottobre 1988), a cura di L. Cracco Ruggini, Como 1989.
Salmeri 2006G. Salmeri, ‘«Alien Wisdom»’, in Momigliano nel Novecento, 149-179.