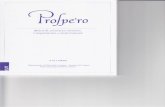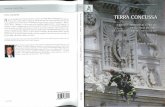Il luogo e il volto. Note a margine della crisi del monumento dopo il 1945
Architetture onorarie dell'agorà di Alesa, 1. Il monumento dei Seviri Augustales: analisi e...
Transcript of Architetture onorarie dell'agorà di Alesa, 1. Il monumento dei Seviri Augustales: analisi e...
ARCHITETTURE ONOR AR IE DELL’AGOR À DI ALESA 1.
IL MONUMENTO DEI SEVIR I AUGUSTALES : ANALISI E PROPOSTA RICOSTRUTTIVA
Rocco Burgio
Allo stato attuale delle ricerche sulle agorai tardo ellenistiche della Sicilia, quella di Alesa 1 si distingue, tra l’altro, per la presenza, sia nella piazza che nelle stoai, di un
considerevole numero di monumenti minori, innalzati a scopi celebrativi, commemora-tivi o devozionali, da parte di una committenza ora istituzionale – pubblica o religiosa – ora privata (Figg. 1-2). 2 Sebbene ancora non scavata interamente, l’agorà ha restituito un’ampia esemplificazione di questa tipologia di strutture – ad oggi ne sono state indi-viduate circa venti, diversificate sia per morfologia che per impianto (Fig. 3). La singola forma si presenta talvolta isolata, ma più spesso è riprodotta – fedelmente o con minime variazioni – in più esemplari, che formano gruppi omogenei e distinti. 3 In tal caso i mo-numenti insistono particolarmente su determinate aree, per cui la loro presenza finisce col caratterizzare e connotare alcuni settori circoscritti dell’agorà (Fig. 3). 4
Il tipo architettonico seguiva la moda e l’ideologia corrente con varianti ed elabora-zioni locali e/o provinciali. La sua morfologia poteva differenziarsi sulla base dei gusti e delle richieste personali della committenza, ma anche per iniziativa degli stessi costrut-tori, elaboratori effettivi ed operatori materiali nella realizzazione delle strutture, i quali spesso dovevano misurarsi con la necessità di coniugare la forma del monumento con quella dell’architettura dell’agorà, adattandola allo spazio ad essa destinato. 5
Desidero ringraziare innanzitutto la dott. G. Tigano, direttore dell’u.o. x Archeologica della Soprintendenza bb.cc.aa. di Messina e responsabile scientifico del sito di Alesa Arconidea, con la quale collaboro dal 1998 nelle ricer-che sui monumenti dell’antica città, per avere permesso il presente studio ; e il dott. M.S. Todesco, direttore del Parco dei Nebrodi Occidentali, per avere agevolato i lavori di rilievo. Un ringraziamento particolare va a J.R.W. Prag per i preziosi suggerimenti e all’amico L. Campagna per l’incoraggiamento e per la disponibilità. Sono grato, infine, al personale del sito di Alesa, che mi è stato vicino in tutte le fasi del lavoro, e in particolare a N. Tita, C. Lorello, S. Lo Cascio, S. Di Marco e G. Lombardo per alcuni impegnativi interventi, come lo spostamento dei blocchi iscritti.
1 Sull’agorà di Alesa vedi : Carettoni 1961, pp. 285-296 ; Scibona 1971, 1975 e 2008d ; Scibona 2009, pp. 20-43, tavv. 1-2 ; Tigano 2008 ; Tigano c.d.s. Sulle agorai ellenistiche della Sicilia, vedi in generale : Wilson 1990 ; Portale 2005 ; Campagna 2006. In particolare, sull’agorà di Solunto vedi Portale 2005 e 2006, Wolf 2009 ; sull’agorà di Segesta, Ampolo – Parra 2009 ; sull’agorà di Termini Imerese, Belvedere et alii 1993 ; sull’agorà di Monte Iato, Isler 2009 ; sulla ipotizzata agorà di Messina, Lentini 2009 e 2010 ; sull’agorà di Centuripe, Patanè 2002, 2006 e 2009 ; sull’agorà di Taormina, Bacci 1980-81, Lentini 2005, pp. 314-315, 321, Campagna – La Torre 2008 e Campagna 2009. Sulle agorai nel mondo greco, vedi soprattutto Coulton 1976.
2 Sui monumenti onorari dell’agorà di Alesa, oltre ad alcuni cenni in Wilson 1990 (pp. 46-48), Scibona 2008d (p. 19) e Scibona 2009 (pp. 38-40), vedi una prima presentazione in Tigano c.d.s. e l’edizione delle esedre in Burgio 2011 e Burgio c.d.s. Su questo tipo di architetture, in generale, vedi soprattutto Lauter 1999, pp. 191-195 e von Thüngen 1994. Per gli esempi in Sicilia, vedi Angeletti 2009 ; Portale 2005, pp. 77-78 ; Belvedere et alii 1993, p. 28, fig. 10 ; Isler 2009 ; Wolf 2009.
3 Occorre precisare che, a causa del loro stato di conservazione, alcune forme sono state riconosciute mentre altre sono in corso di definizione o ancora da definire.
4 L’area porticata antistante gli ambienti, nonché il settore della piazza ad essa prospiciente, sembrano le zone più interessate dalla presenza di monumenti ninori. Vedi Scibona 2008d, p. 19 ; Scibona 2009, pp. 38-40 ; Tigano c.d.s.
5 Cfr. Burgio 2011, pp. 103-107.
architetture onorarie dell’agorà di alesa 1 13
Fig. 2. Agorà : assonometria delle strutture conservate.
architetture onorarie dell’agorà di alesa 1 15
Sebbene, come appena detto, tipologicamente abbastanza diversificati, i monumenti alesini, partendo da una comune matrice ideologica, presentavano tuttavia un medesimo standard compositivo generale. Dal punto di vista strutturale essi erano infatti realizzati secondo un sistema costruttivo caratterizzato dall’associazione e dal relativo assemblag-gio di tre elementi costitutivi : l’elemento architettonico, che conferiva alla costruzione un carattere di monumentalità ; 1 l’elemento statuario (statua o gruppo), imperniato sul coronamento, 2 e quello epigrafico, che erano entrambi destinati a rappresentare nel mo-do più efficace il messaggio voluto dal committente. L’epigrafe poteva trovare posto su una semplice lastra, spesso in marmo, utilizzata come elemento di rivestimento e appli-cata anteriormente al corpo del monumento (Fig. 4a), 3 in altri casi era invece incisa diret-tamente sugli ortostati del monumento stesso (Fig. 4b-c), 4 oppure sui blocchi del corona-mento, in posizione frontale (Fig. 4d), 5 oppure ancora sulla base della statua (Fig. 4e). 6
Dal punto di vista morfologico, l’elemento architettonico si manifesta ad Alesa secon-do le seguenti varianti : semplice pilastro (cosiddetto monumento a pilastro), libero (Fig. 5a) o addossato ad una delle colonne del portico (Fig. 5b-c), all’esterno o all’interno di esso, solitamente a sezione quadrata, ma talvolta anche circolare ; 7 setto murario, come nel caso oggetto di questo contributo, di forma parallelepipeda, isolato (Fig. 5d) oppure addossato a parete (Fig. 5e) o a colonna (Fig. 5f ) ; basso podio quadrangolare o rettango-lare (Fig. 5g) ; esedra di forma arcuata o a sezione di cerchio (Fig. 5h).
In ognuna di queste rappresentazioni architettoniche è sempre presente, con varianti o particolari accorgimenti, la seguente ripartizione : lo zoccolo, il corpo centrale ed il coronamento. Nella maggior parte dei monumenti lo zoccolo, o profilo di base, è fon-dato direttamente sulla pavimentazione (Fig. 6a), 8 in alcuni casi poggia invece su una crepidine (Fig. 6b). 9 Poteva essere realizzato in materiale lapideo (più frequentemente in marmo) ma anche in cotto, ad elemento unico e distinto, oppure a più elementi lavorati singolarmente, configurati a cornice ed applicati perimetralmente alla base dell’elevato (Fig. 6c-d).
Il corpo centrale è di solito a blocco unico nel monumento a semplice pilastro (Fig. 5c), in muratura allettata nei monumenti di dimensioni più grandi (Fig. 5a-d-e-f-g). 10
1 Cfr. Lauter 1999, p. 192. 2 Ad Alesa nessun elemento statuario, tra quelli recuperati, è stato rinvenuto nella sua posizione originaria o tale
da essere associabile ad un monumento. Della statua di Cerere, rinvenuta nello spazio antistante i sacelli i e ii (vedi Scibona 2009, p. 19), i dati di scavo non sono sufficienti a stabilire a quale basamento appartenesse. Il lato posteriore della statua è poco rifinito, dunque è possibile ipotizzare che essa poggiasse su un basamento addossato a una parete o a colonna : cfr. Portale 2009, pp. 77-82.
3 Numerose sono le epigrafi onorifiche incise su lastre marmoree rinvenute nell’agorà e conservate nel museo e nei magazzini di Alesa.
4 Diversi blocchi lapidei con iscrizioni onorarie sono stati rinvenuti sia nell’agorà che in altre aree del sito. Vedi Burgio 2011 ; Prestianni c.d.s.
5 Tra gli elementi architettonici rinvenuti nell’agorà, si distinguono alcuni blocchi e cornici con iscrizioni perti-nenti ad elementi di coronamento.
6 È il caso della statua di Cerere citata alla nota 7. Vedi anche Scibona 2008a, pp. 30-31. 7 Elementi a sezione circolare sono stati rinvenuti riadoperati in altre strutture e sono conservati nei depositi
del sito. 8 Sono tuttavia attestate cornici in marmo fondate su trincee praticate lungo la fascia perimetrale della struttu-
ra, dopo avere opportunamente ritagliato la pavimentazione in cotto, come nella cosiddetta “tribuna degli oratori”. Sono documentati anche profili di base di monumenti a pilastro, ad unico elemento, impiantati direttamente sul terreno in seguito all’asportazione della corrispondente porzione di pavimentazione. È da escludere l’ipotesi che i monumenti siano stati realizzati precedentemente alla pavimentazione della piazza e delle stoai : cfr. Burgio 2011, p. 90 e nota 10.
9 Realizzata da due o più gradini ricoperti da malta lisciata e rifiniti con stucchi modanati e policromi.10 In questo caso il nucleo può essere costituito da calcestruzzo foderato all’esterno da paramenti in pietra, talvol-
ta in una tecnica accurata, come nel caso dell’opus reticulatum della “tribuna degli oratori”.
16 rocco burgio
Il coronamento, o profilo superiore, che completava la costruzione e che nel piano di attesa solitamente ospitava l’elemento statuario, raramente è stato rinvenuto in crolli primari, 1 più spesso i suoi elementi sono stati trovati riadoperati in strutture murarie di epoche più tarde. La forma, il materiale impiegato e la lavorazione degli elementi del co-ronamento differiscono a seconda della morfologia della struttura, e si possono presen-tare ora come capitello modanato di pilastro ad unico blocco (nei monumenti a pilastro) (Fig. 7a), ora come composizione di blocchi sagomati e configurati a capitelli (nel caso in esame) (Fig. 4d), ora come composizione di lastre (nel gruppo delle esedre) (Fig. 7b). 2
1 È il caso, per esempio, degli elementi del coronamento di una delle esedre : vedi Burgio 2011, pp. 96-99.2 In tutti i casi sinora studiati – l’esedra A (ham 1) e il monumento oggetto di questo contributo – il coronamento
è costituito da composizioni di tre elementi lapidei : vedi Burgio 2011, pp. 96-99.
Fig. 4. Esempi di collocazione delle epigrafi.
architetture onorarie dell’agorà di alesa 1 17
Fig. 5. Tipi architettonici dei monumenti.
Un’importanza particolare va attribuita alla collocazione specifica dei monumenti. Il luogo scelto doveva contribuire ad esaltare il carattere di ufficialità della struttura e, nello stesso tempo, evidenziare l’autorevolezza del suo committente. Per tali ragioni le struttu-re sorgevano in punti che ne garantivano la massima visibilità per un ampio raggio, spes-so in stretta vicinanza con monumenti simili 1 o comunque di analoga valenza e rilevan-
1 Cfr. Stucchi-Bacchielli 1983, pp. 34 e 38 ; Angeletti 2009, p. 181 ; Battistoni 2009, p. 59 sgg.
18 rocco burgio
za ideologica, nelle aree che diremmo più sensibili dello spazio agoraico. Non è un caso che essi risultino concentrati nel settore nord dell’agorà, là dove ricade una fila di sacelli, tra cui quello dedicato ad Augusto (Fig. 3). I monumenti sono dislocati sia nell’area della piazza prospiciente tale settore, sia sulla crepidine del colonnato e all’interno del portico, nell’angolo tra le stoai ovest e nord. Nel portico nord, in particolare, si trovano cinque monumenti a pilastro, di cui tre sono addossati alle colonne del colonnato interno (Fig. 3, ham 22-23 e 25), uno è libero all’interno del portico (Fig. 3, ham 24) (di esso rimango-no, sulla pavimentazione in cotto del portico, l’impronta della base e i resti delle grappe metalliche di fissaggio) e l’altro è addossato alla terza colonna del colonnato esterno, poggiato sulla crepidine (Fig. 3, ham 26) ; dei monumenti a setto murario, invece, uno è addossato con il lato corto sinistro alla seconda colonna del filare interno ovest (Fig. 3, ham 21), mentre il secondo, oggetto di questo studio, è addossato alla parete di fondo, all’interno del portico (Fig. 3, ham 18). Due basse basi quadrate, rivestite in marmo, insi-stono nella stessa area, ai lati dell’ingresso del sacello degli augustali (Fig. 3, ham 19-20), e tre esedre curve – ma è probabile che il loro numero fosse maggiore – si trovano sulla crepidine e sullo stilobate dello stesso angolo, due situate a ovest e la terza a nord (Fig. 3, ham 1-3).
Tra i monumenti liberi nella piazza si distinguono : una grande struttura quadrata a forma di podio in calcestruzzo, foderata in opera reticolata e inquadrata da pilastri e cin-ture in laterizi, che occupa lo spazio dell’angolo nord-ovest della piazza, quasi a ridosso delle due crepidini (Fig. 3, ham 4) ; le basi di due monumenti a pilastro a sezione quadrata (Fig. 3, ham 6-7) e di tre setti murari rettangolari non ancora ben definiti (Fig. 3, ham 13-15) ; tre basi rettangolari allineate parallelamente al portico, identificate come probabili altari su crepidine, collocate in linea con i sacelli vi e vii, quasi rasenti la crepidine ovest (Fig. 3, ham 10-12).
Fig. 6. Tipologia della parte basamentale.
20 rocco burgio
Chiudono la sequenza dei monumenti minori a Sud due tempietti affiancati (naiskoi) di forma quadrangolare. Posti sull’asse centrale est-ovest dell’agorà, nel lato ovest essi si im-postano sullo stilobate del colonnato esterno, inglobando le colonne xi-xii-xiii da Nord, e si sviluppano per la maggior parte verso Est, invadendo la piazza (Fig. 3, ham 16-17).
M
O
N
U
M
E
N
T
I
M
I
N
O
R
I
D
E
L
L’
A
G
O
R
À
D
I
A
L
E
S
A
tipologia posizione collocazione
MONUMENTO A PILASTRO
(a sezione quadrata o circolare)
LIBERO
DENTRO IL PORTICO
SULLA PIAZZA
SULLA CREPIDINE
ADDOSSATO A COLONNA
DENTRO IL PORTICO
SULLA CREPIDINE
MONUMENTO A SETTO MURARIO
LIBERO SULLA PIAZZA
ADDOSSATO A PARETE DENTRO IL PORTICO
ADDOSSATO A COLONNA DENTRO IL PORTICO
MONUMENTO SU PODIO
E/O SU CREPIDINE
LIBERO SULLA PIAZZA
ESEDRE CURVE
(a sezione di cerchio o di ellisse)
TRA LE COLONNE SULLA CREPIDINE E SULLO STILOBATE
TEMPIETTI (NAISKOI) UN LATO TRA LE COLONNE SULLA CREPIDINE E SULLA PIAZZA
Le ricerche recenti hanno dimostrato l’esistenza di monumenti onorari nell’agorà di Ale-sa già a partire dal suo primo impianto, 1 ma ne hanno d’altra parte segnalato la presenza anche in seguito, nelle fasi più tarde di vita della città, fino al suo abbandono. 2 Tra i mo-numenti più antichi sono le esedre curve, di recente individuazione : 3 gli ortostati iscritti negli alzati che compongono le spalliere – in particolare nell’esedra A (Fig. 3, ham 1 e Fig. 8), ma anche nella C (Fig. 3, ham 3) – hanno infatti consentito di stabilire con buona
1 Cfr. Tigano c.d.s. ; Burgio 2011, pp. 90, 104-105.2 L’agorà vive almeno sino ad età costantiniana. Vedi Scibona 2008a, p. 29 ; Scibona 2009, p. 28 ; Portale 2009, pp.
88-91 ; Tigano c.d.s. 3 Burgio 2011 ; Burgio c.d.s.
architetture onorarie dell’agorà di alesa 1 21
precisione la datazione dei monumenti stessi. 1 L’unica iscrizione superstite dell’esedra A, delle due che ne costituivano la composizione epigrafica, rinvenuta in fase di crollo e re-cuperata tra le macerie, è la nota iscrizione di Apollodoro Lapirone, 2 databile tra il ii e il i sec. a.C., cioè pochi decenni dopo la realizzazione dell’agorà (Fig. 4b). Mentre all’esedra C abbiamo proposto di attribuire un’altra iscrizione rinvenuta nei pressi, quella dedicata a Caninio Nigro, che cronologicamente è stata collocata ancora prima. 3 La rispettosa conservazione di queste strutture nei secoli seguenti dimostra il significato che esse dove-vano rivestire per la città e per i suoi abitanti. 4
Successivamente alla realizzazione delle esedre, la metà nord dello spazio agoraico venne a poco a poco occupata da altri monumenti, che, come si è detto, furono elevati sia nella piazza che all’interno del portico, in una relazione di vicinanza che derivava dai
1 Ibidem. 2 Cfr. Scibona 1971, scheda 2, pp. 11-13, tav. iii, fig. 1 ; Scibona 2008a, p. 26.3 Cfr. Scibona 1971, scheda 1, pp. 5-10, tav. ii ; Scibona 2008a, p. 26 ; Prestianni Gianlombardo c.d.s.4 Nell’Esedra A, cui appartiene l’iscrizione di Apollodoro Lapirone, sono presenti antichi interventi di restauro nel
paramento posteriore. Vedi Burgio 2011, pp. 92, 107, fig. 8.
Fig. 8. Esedra A.
22 rocco burgio
comuni contenuti celebrativi e propagandistici. La loro notevole quantità attesta il favo-re che l’impiego di questa pur piccola forma di rappresentazione architettonica ebbe ad Alesa per tutto il periodo romano. Il dato numerico dei monumenti risulta così elevato, in proporzione alla grandezza dello spazio pubblico che li ospita, che ad oggi non si ri-scontrano esempi analoghi né in ambito regionale – vedi ad esempio le agorai di Taormi-na, Termini Imerese, Segesta, Solunto, Iaitas 1 – né in quello peninsulare. 2 Confronti più calzanti vanno ricercati, a nostro avviso, nell’area egeo-anatolica, soprattutto a Priene, e nel Nord Africa. 3
Per quanto riguarda la tecnica costruttiva, i monumenti presentano caratteri differenti che in molti casi contribuiscono al loro inquadramento cronologico. I monumenti più antichi, quelli cioè realizzati a partire dalla fine del ii sec. a.C. sino all’età augustea, risul-tano per lo più realizzati con una tecnica costruttiva e una messa in opera dei materiali piuttosto accurate, con l’impiego di blocchi lapidei squadrati dal profilo netto e ben rifi-nito. 4 È quasi del tutto assente l’utilizzo del mattone e minimo risulta l’impiego di malta per legare le muratura ; viene infatti preferito l’uso di grappe metalliche o la commistione di queste ultime con sottili letti di malta di calce. Per i rivestimenti erano utilizzati ma-teriali pregiati come i marmi, posti in opera e montati accuratamente. L’esterno era poi completato mediante l’applicazione di raffinate cornici modanate. Per i monumenti privi di rivestimento erano adoperate pietre più resistenti, trattate e rifinite in superficie. 5
Nei monumenti realizzati a partire dalla seconda metà del ii sec. d.C. in poi, invece, l’intera struttura è, di solito, in muratura mista di mattoni e blocchetti di pietre sbozzate e di differente natura – spesso di riutilizzo -, regolarizzati mediante scampoli di tegole, laterizi vari, pietre di piccola e media pezzatura e allettati con abbondante malta di calce. Sulla struttura si nota di solito un rivestimento di malta di calce grossolana, rifinita con intonaci e cornici in stucco o in laterizi sagomati. Solo in casi particolari si riscontra l’im-piego di tecniche più accurate nel corpo del monumento, come per la cosiddetta “tribuna
1 In realtà, solo nel caso dell’agorà di Segesta (Parra 2006, p. 117 ; Ampolo – Parra 2009, p. 132 sgg., figg. 122-123, 139 ; Angeletti 2009) siamo a conoscenza del numero esatto di monumenti onorari sinora individuati, cioè sei : una base rettangolare, due ad L, un’esedra semicircolare e due lacune nella pavimentazione della piazza. Per quanto riguarda gli altri siti, invece, i pochi dati disponibili si deducono per lo più dalla documentazione grafica edita. A Ta-ormina, nell’area dell’agorà-foro, erano probabilmente presenti quattro basi di monumenti onorari iscritte, di cui due già riferite a statue in bronzo (Bacci 1980-81) ; mentre in Campagna – La Torre 2008 (pp. 124-125) – dove L. Cam-pagna propone una nuova interpretazione delle cosiddette Naumachie come stoà tardo ellenistica prospiciente una piazza – una lacuna quadrangolare sulla pavimentazione antistante il portico, quasi a ridosso della crepidine, viene letta quale sarcitura dell’impronta di un monumento onorario a pilastro. Per quanto riguarda l’agorà di Solunto, nella documentazione grafica in Wolf 2009, figg. 98-99, 115 e 119, sembrano presenti cinque monumenti onorari a ridosso della crepidine : un’esedra semicircolare del tipo di quella di Segesta, un basamento quadrangolare che sembra con-frontabile con la cosiddetta “tribuna degli oratori” di Alesa, due monumenti a pilastro e una colonna votiva. A propo-sito dell’agorà di Termini Imerese, sappiamo del rinvenimento di un grande basamento per statua onoraria o simili, addossato ai gradini del colonnato esterno, che, nell’unica pianta edita dei rinvenimenti (Fiorelli 1878, pp. 148-150 ; Belvedere et alii 1993, p. 29), mostra strette affinità planimetriche con la già citata “tribuna” di Alesa, nonché con la base quadrangolare di Solunto. Nell’agorà dell’antica Iaitas, infine, sono stati recuperati solo frammenti di statue onorarie in marmo e in bronzo, ma non risultano al momento documentati resti di monumenti o basi ; l’unica strut-tura significativa potrebbe essere un basamento con modanature, provvisto di quattro gradini di accesso, che è stato interpretato dagli scavatori come tribuna per i magistrati legata alla basilica (Isler 2009, pp. 106-107, figg. 83-85).
2 Su Scolacium : Donzelli 1989 ; Arslan 1998, pp. 89-93. 3 Su Priene vedi : Raeck 1993 ; von Kienlin 2002 ; Hellmann 2006, pp. 199-236. Sull’agorà di Cirene, vedi Stuc-
chi – Bacchielli 1983.4 I monumenti a pilastro, ad esempio, sono realizzati con ortostati monolitici o mediante l’assemblaggio di più
blocchi ; il corpo del monumento oggetto di questo lavoro è in blocchi di pietra squadrati ; le esedre curve sono arti-colate composizioni di blocchi sagomati, assemblati e ammorsati mediante grappe metalliche.
5 È il caso delle esedre curve : le superfici dei blocchi delle spalliere e dei coronamenti sono rifiniti a leggero bu-gnato inquadrato da fasce lisce. Vedi Burgio 2011.
architetture onorarie dell’agorà di alesa 1 23
degli oratori”, che è realizzata in opera cementizia e foderata in opera reticolata, a sua volta rivestita con spesse lastre marmoree e cornici anch’esse in marmo. 1
L’uso di materiali di risulta e a basso costo nei monumenti più recenti è il segno di un impoverimento della società, anche della classe più elevata, che tuttavia, perpetuando la consuetudine di erigere monumenti onorari, non volle mai rinunziare ad autocelebrarsi.
Lo stato di conservazione piuttosto precario dei monumenti alesini spesso non ne con-sente una lettura soddisfacente. I motivi di ciò si devono rintracciare, oltre che nello spoglio sistematico, perpetrato dopo l’abbandono della città, di quasi tutti i rivestimenti marmorei per ottenere calce, anche nel prelievo di materiale lapideo dalle strutture mu-rarie, protrattosi sino a tempi recenti. 2 Ma una causa fondamentale del degrado è costi-tuita anche dall’utilizzo di una pietra locale, la ben nota calcarenite marnosa, di colore prevalentemente grigio, largamente impiegata in tutta l’attività edilizia dell’antica città, la quale, se pur facilmente reperibile e lavorabile, purtroppo presenta un alto grado di friabilità, dovuto a scarsa coesione per carenza di materia legante e per la presenza di una elevata percentuale di componente sabbiosa. Esposta all’aperto, questa pietra viene sot-toposta a sollecitazioni che determinano l’innesco di un processo di deterioramento len-to e continuo, i cui effetti, ben percepibili visivamente, si manifestano con lo sfaldamento e la disgregazione della componente inerte (Fig. 9a). 3 Proprio per queste caratteristiche petrografiche negative del materiale da costruzione, che dovevano essere già note in an-tico, le strutture venivano spesso ricoperte da strati di intonaco protettivo anche di note-vole spessore 4 (Fig. 9b).
Il Monumento dei Seviri Augustales
Dei monumenti onorari dell’agorà di Alesa abbiamo scelto di esaminare in dettaglio quel-lo che riteniamo possa essere identificato con il Monumento dei Seviri Augustales (Fig. 3, ham 18).
I risultati della ricerca sono emersi in primo luogo dall’osservazione diretta e dall’ana-lisi di tutti gli elementi della struttura, in situ e non, e nello stesso tempo dalla minuziosa documentazione grafica 5 e fotografica. Riguardo quest’ultima, ci si è avvalsi, oltre che delle foto relative alla situazione attuale, anche dell’esame della documentazione foto-grafica storica d’archivio risalente al momento dello scavo. 6 L’insieme dei dati raccolti ha portato al riconoscimento di alcuni elementi, precedentemente ritenuti privi di qualsiasi dato legante tra loro, come appartenenti invece alla composizione architettonica in og-getto. Si è passati quindi al loro assemblaggio grafico e all’individuazione degli elementi mancanti, identificati come lacune : il monumento è risultato infatti mutilo di alcuni suoi componenti, come il rivestimento esterno del basamento, il blocco centrale del corona-mento e la rappresentazione statuaria (Fig. 10).
1 Vedi supra, nota 15.2 Per il periodo compreso tra il xiv e il xvi secolo, vedi la copiosa mole di dati d’archivio nel recente volume Pet-
tineo 2012, pp. 255-256. 3 Si tratta di un calcare “tipo scaglia” (calcilutite) : vedi i risultati delle analisi mineralogico-petrografiche eseguite
dal prof. M. Triscari del Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Messina (vedi “Determinazione archeo-metrica su materiali archeologici provenienti dagli scavi di Alesa”, relazione dell’1.06.2005, archivio Unità Operativa x per i Beni Archeologici, Soprintendenza di Messina). Vedi anche Burgio 2009, p.134.
4 In alcuni casi lo spessore delle malte di rivestimento e di rifinitura, di solito stese in vari strati via via più sottili a partire dalla muratura, può arrivare anche a dimensioni comprese tra 0,15 e 0,25 m, come lungo la parete di fondo del portico ovest e sulle colonne in cotto del colonnato interno.
5 Piante prospetti e sezioni sono in scala 1 :5, mentre i dettagli sono in scala 1 :1.6 Cfr. Burgio 2011.
24 rocco burgio
Fig. 9. a) Degrado della pietra alesina ; b) Spessore dell’intonaco.
Fig. 10. Assemblaggio grafico dei elementi individuati.
I reperti lapidei pervenutici, sia quelli presenti in situ che quelli riconosciuti nei depositi archeologici di Alesa, hanno infine consentito di definire – grazie anche alle integrazioni grafiche delle suddette lacune – sia il volume originario del monumento che l’articolazio-ne strutturale e morfologica della sua architettura (Fig. 11).
La riconfigurazione grafica virtuale e la ricomposizione, in parte anche materiale, de-gli elementi individuati, hanno contribuito, oltre che all’identificazione del monumento, anche a quella della committenza che lo ha proposto, mentre all’attribuzione si è perve-
architetture onorarie dell’agorà di alesa 1 25
nuti grazie ad una epigrafe di carattere dedicatorio incisa sulla fronte dei blocchi ricono-sciuti come pertinenti al coronamento.
1. Descrizione
La costruzione sorgeva nella navata interna del doppio portico ovest, con la fronte ri-volta ad Est, verso la piazza (Fig. 3, ham 18). Come si è detto, si tratta della parte set-tentrionale del portico, quella su cui si apre una serie di vani, originariamente tabernae, trasformati in sacelli in epoca romana imperiale. Il monumento fu edificato all’esterno dei vani v e vi, innestato posteriormente nel tratto di muratura delimitato dai loro in-gressi, in corrispondenza del setto murario interno che li separa e rispetto al quale esso è ortogonale.
Analisi tecnica della struttura portante
Il monumento è conformato come un basamento costituito da (Figg. 10 e 11) :- uno zoccolo di base, composto da una piattaforma in muratura ;- un setto murario riferibile al corpo del monumento, di forma parallelepipeda, realiz-
zato in quattro grandi blocchi squadrati a base quadrangolare, disposti orizzontalmente su due filari, allettati con malta di calce e privi di grappe metalliche di collegamento ;
- una composizione di tre blocchi sagomati, ammorsati da grappe metalliche, che for-mano il coronamento o profilo superiore del monumento, a capitello di pilastro.
Solo i resti del corpo del monumento sono stati rinvenuti nella posizione originaria, gli elementi del coronamento sono stati invece da noi identificati tra i reperti depositati nei magazzini dell’area archeologica e associati alla struttura conservatasi in situ.
Fig. 11. Proposta ricostruttiva del monumento.
26 rocco burgio
Il corpo del monumento, come si è detto, era innestato nella parete retrostante, men-tre il coronamento doveva essere libero rispetto alla parete di fondo, come dimostra una modanatura continua presente su tutte e quattro le facce. A giudicare dalla lavorazione delle superfici lapidee e dagli incassi presenti nella faccia superiore dei blocchi, esso era sormontato da una statua o da un gruppo statuario di cui non si è trovata traccia.
Analisi dei materiali costruttivi
I materiali utilizzati per la realizzazione del monumento sono tutti lapidei, ma bisogna precisare che per il basamento è stata impiegata la pietra calcarea marnosa locale di cui si è detto, 1 pertanto è presumibile che la sua superficie, come in moltissimi altri casi ad Alesa, fosse ricoperta da uno strato di malta di calce, a sua volta probabilmente rivestito – considerata l’importanza del monumento – da lastre marmoree delimitate da cornici anch’esse in marmo. Per il coronamento erano utilizzati invece blocchi in pietra arenaria gialla di provenienza non locale – tenera e facilmente lavorabile appena estratta, ma dura e resistente se esposta all’aria – dello stesso tipo di quella impiegata per tutti gli elementi architettonici del colonnato esterno del portico, verosimilmente al fine di garantirne una maggiore durata. Di solito, le strutture e gli elementi architettonici realizzati con questa pietra erano ricoperti da un sottile strato di intonaco a grana fine a base di calce sia a pro-tezione della pietra che anche come supporto per le rifiniture cromatiche. 2
Analisi degli elementi strutturali e del loro stato di conservazione
Come si è detto, il corpo del monumento è collocato parallelamente alla parete esterna che delimita i vani prospettanti il portico e posteriormente è innestato, almeno in parte, al centro del tratto di muro che separa gli ingressi dei due vani v e vi (Figg. 11 e 20). La struttura, che oggi è priva del rivestimento esterno, si presenta sconnessa probabilmente per azioni telluriche a cui deve essere stata sottoposta nel corso dei secoli, 3 ma anche a causa dell’asportazione della cornice in marmo della base (Figg. 12 e 13).
Le dimensioni conservate della struttura sono : altezza m 0,67, lunghezza m 1,62, pro-fondità m 0,65. Essa non poggia direttamente sulla pavimentazione in cotto del portico ovest, 4 bensì, a giudicare da quanto si osserva al di sotto del blocco destro del filare di ba-se, si imposta su di uno zoccolo. Quest’ultimo è costituito da uno strato di malta di calce e sabbia arenaria steso direttamente sulla pavimentazione, sul quale è stata realizzata una piattaforma rettangolare in muratura di altezza pari a quella della cornice, che doveva
1 Vedi supra, p. 000 e nota 33.2 Ad Alesa l’impiego dell’arenaria, di sicura importazione, non è molto diffuso. In antico essa era utilizzata prin-
cipalmente per la realizzazione di elementi architettonici, sia con funzioni strutturali che decorative, per la maggior parte pertinenti a edifici pubblici, ma anche a civili abitazioni. Dall’area dell’agorà provengono alcuni elementi in arenaria confrontabili con i nostri : si tratta soprattutto di capitelli di pilastri riferibili a coronamenti di monumenti onorari con incassi sulla faccia superiore per ancorare statue ; oppure basi e blocchi con decorazione modanata utiliz-zati come coronamenti di altari o basamenti di statue.
3 Per i terremoti nell’area, vedi Scibona 2009, pp. 25-26, nota 56. 4 Le mattonelle in cotto della pavimentazione (m 0,35 x 0,52) sono state messe in opera mediante filari posti per-
pendicolarmente al muro esterno dei sacelli, al quale si legano tramite un listello in cotto di delimitazione e a fughe alterne. Oggi, nel tratto in cui poggia il monumento, il pavimento presenta un avvallamento dovuto al cedimento degli strati fondali, forse per il peso della struttura o del crollo al momento della distruzione ; tale avvallamento si presenta più marcato in corrispondenza dell’estremità destra del monumento, con una forte inflessione delle lastre su cui poggia lo spigolo anteriore destro. Non è da escludere che tale fenomeno si sia verificato in antico : ciò spie-gherebbe infatti la presenza di pietre di maggiori dimensioni al di sotto del basamento nel tratto destro per livellare il piano pavimentale.
architetture onorarie dell’agorà di alesa 1 27
Fig. 12. Documentazione grafica del corpo del monumento.
28 rocco burgio
Fig. 13. Documentazione fotografica del corpo del monumento con schema dei dissesti.
architetture onorarie dell’agorà di alesa 1 29
essere di circa m 0,10. Le pietre che compongono la piattaforma sono di medie e piccole dimensioni, a loro volta ricoperte da uno strato di minute scaglie e scarti di lavorazione dei blocchi compattati, che livella il piano e accoglie i blocchi del primo filare. Lo zoccolo doveva essere delimitato sui tre lati liberi da una consistente cornice, molto probabilmen-te in marmo, su plinto, che costituiva il profilo di base e di cui oggi è visibile solo il vuoto di lacuna e l’impronta in negativo, in parte incassata nella muratura. 1 (Figg. 10-13)
Il primo filare di blocchi, partendo dalla base, è alto m 0,30 e lungo m 1,55 circa, ed è composto da due blocchi di forma rettangolare in prospetto, rispettivamente della lun-ghezza di m 0,65 (blocco destro) e m 0,85 (blocco sinistro). Il filare oggi sembrerebbe stac-cato dalla parete adiacente, dato che le facce posteriori dei blocchi si presentano spezzate e mutile di grosse porzioni, ma è molto probabile invece che, in origine, queste fossero addossate al muro, in quanto i rispettivi spigoli interni, corrispondenti alle facce di com-baciamento, si conservano effettivamente sino alla parete di fondo. 2 Viste le manomis-sioni verificatesi nel corso dei lavori di restauro del complesso monumentale, effettuati negli anni Ottanta del secolo scorso, è molto difficile stabilire se i blocchi fossero in parte anche inseriti nella muratura portante della parete, come invece è possibile osservare per il blocco sinistro del filare superiore.
Tale secondo filare, alto m 0,27, è costituito da due blocchi analoghi, in prospetto, a quelli del filare sottostante. Il blocco posto a sinistra presenta la faccia laterale destra di combaciamento ben conservata, netta, lavorata con punteruolo grosso, mentre quella sinistra risulta spezzata, abrasa e interessata da fenomeni di esfoliazione, 3 pertanto la sua lunghezza conservata massima è di m 0,73, m 0,63 in prospetto e m 0,55 nel tratto poste-riore. Il vuoto di lacuna all’estremità sinistra del filare, delle dimensioni in prospetto di m. 0,27, indica che il blocco doveva avere una lunghezza originaria di m 1,00 circa, mentre la profondità complessiva del piano di attesa del monumento, sino alla parete limitrofa, doveva essere di circa m 0,60/0,65. Il piano si presenta come una spessa lastra quadrango-lare, posta orizzontalmente e incassata – oggi in parte, ma in origine probabilmente per tutta la lunghezza – nella parete adiacente. Il blocco di destra del filare, che ha una lun-ghezza conservata di circa m 0,60, presenta una lacuna di forma triangolare nella faccia si-nistra di combaciamento ; è spezzato posteriormente, come si evince dalla parete, per cui ha una larghezza conservata di m 0,35, ed è interessato da consistenti segni di abrasione sia nella faccia laterale esterna destra che nel piano di attesa. A causa delle lacune il blocco aderisce a quello limitrofo solo per via dello spigolo anteriore sinistro (Figg. 12 e 13).
Purtroppo i restauri moderni sopra menzionati hanno in parte alterato lo stato ori-ginario della struttura, per cui oggi non è possibile giungere ad una lettura chiara del-le murature, in particolare dell’innesto ; tuttavia, la documentazione fotografica storica d’archivio effettuata al momento del rinvenimento si è rivelata in questo senso una pre-ziosa fonte di informazioni e ad essa dedicheremo pertanto una trattazione specifica più avanti.
Ora, sulla base dei pochi dati emersi dall’analisi delle murature, si possono avanzare due ipotesi : la prima è che il monumento sia stato realizzato contemporaneamente alla costruzione del muro di fondo, come sembrerebbero suggerire le tracce dell’innesto che collega le due strutture ; la seconda è che il monumento sia invece posteriore e che, per
1 Non è da escludere che della cornice possa esistere ancora qualche frammento, ad oggi non identificato, tra i reperti rinvenuti nel corso degli scavi e conservati nei depositi archeologici di Alesa.
2 In generale, la presenza delle lacune nei tratti posteriori del basamento ha reso difficile la lettura dei blocchi. Oggi infatti è visibile un vuoto a mo’ di intercapedine tra il basamento e il prospetto esterno del muro limitrofo, ma che è da riferire solo allo stato di conservazione dei resti. 3 Vedi supra, nota 42.
30 rocco burgio
motivi connessi con la sua stabilità, 1 sia stato ancorato alla parete limitrofa già esisten-te mediante un incasso per l’alloggiamento dei blocchi del secondo filare. A favore di quest’ultima, bisogna ricordare che i blocchi del filare di base poggiano al di sopra della pavimentazione, per cui devono essere stati messi in opera successivamente ad essa. I blocchi in “aggetto” che formano il secondo filare della muratura, sulla fronte, poggiano semplicemente su quelli sottostanti, mentre posteriormente, come già detto, dovevano essere incassati e cementati all’interno della parete adiacente, per circa un terzo della loro lunghezza totale. Essi erano conformati e messi in opera – a giudicare da quello posto a sinistra, meglio conservato – in modo da formare una falsa mensola, con una faccia di attesa orizzontale piana, di forma rettangolare, dalle dimensioni ricostruibili di m 1,60 di lunghezza e m 0,65 di larghezza, escluso il rivestimento (Figg. 12 e 13). L’inserimento nel-la muratura, in un tutt’uno con la struttura portante dell’edificio, conferiva al basamento una forma di appendice.
Tutti i blocchi che compongono il corpo del monumento in prospetto, nonostante i dissesti, si presentano a piombo, così come dovevano essere nelle pareti laterali prima dei distacchi. Oggi qui si manifestano notevoli segni di degrado diffuso, dovuti prin-cipalmente all’abrasione del materiale lapideo causata dall’azione eolica e degli altri agenti atmosferici e non (abrasione, esfoliazione e lesione). Lo stato avanzato di degra-do dei singoli elementi lapidei e, in generale, di dissesto della muratura era già osserva-bile al momento del rinvenimento, per cui è lecito ipotizzare che in antico il basamen-to (privo del suo rivestimento espoliato) fu sottoposto ad una prolungata esposizione all’aperto. I blocchi, soprattutto in corrispondenza degli angoli, sono in parte mutili di frammenti anche di grandi dimensioni e ciò, oltre che per i motivi sopra descritti, an-che a causa degli sforzi di compressione e taglio che hanno interessato la struttura in seguito all’impatto con la massa di detriti del crollo degli elevati del portico, nonché per il probabile uso improprio del manufatto. 2 La struttura presenta inoltre evidenti segni di dissesto statico, probabilmente causato dalle scosse sismiche sopra accennate : 3 essi consistono soprattutto nella rotazione dei blocchi – in senso orario, riguardo i blocchi posti nella metà sinistra, e antiorario, riguardo quelli posti nella metà destra – e nel loro scorrimento lungo i piani orizzontali di combaciamento in senso contrapposto verso la mezzeria della costruzione. Non è da escludere, d’altra parte, che la rotazione sia da addebitare anche alla già accennata asportazione della cornice che definiva il profilo della base del monumento (Fig. 13).
Per quanto concerne la lavorazione e il taglio dei blocchi, solo nelle facce di attesa di quelli del filare superiore e, come già detto, nella parete laterale interna di quello di si-nistra, è possibile notare poche e labili tracce di lavorazione con punteruolo grosso per livellare le superfici e aumentarne il grado di aderenza, visto che dovevano accogliere i blocchi del coronamento (Figg. 12 e 13).
Della composizione di tali blocchi, in numero di tre, ci sono pervenuti solo i due late-rali angolari. Molto probabilmente quello centrale è stato asportato nel corso della fase di espoliazione, oppure si è frammentato nel crollo degli elevati dell’agorà. I blocchi aderiva-no lateralmente tra loro con le rispettive facce di combaciamento interne ed erano legati nella faccia superiore da grappe metalliche di forma a pi greco, delle quali sono visibili i resti e gli incassi (Fig. 14a, b, Fig. 15a, b). Così posizionati, essi creavano superiormente un piano orizzontale rettangolare della larghezza di m 0,68, e della lunghezza, ricostrui-
1 Staticamente, oltre al peso proprio, la struttura doveva sopportare anche quello dei carichi trasmessi dalle rap-presentazioni statuarie. 2 Vedi supra, p. 000. 3 Vedi supra, p. 000 e nota 39.
architetture onorarie dell’agorà di alesa 1 31
bile graficamente, di m 1,82 (Fig. 11). 1 I due blocchi presentano forti analogie tra loro per il materiale adoperato, il taglio, la lavorazione, la decorazione, la presenza di superfici iscritte, il tipo di degrado e la presenza di analoghe lacune in prospetto. Entrambi hanno la medesima altezza di m 0,35, ma quello sinistro, che chiameremo blocco A, si differenzia dall’altro, che chiameremo blocco B, per la sua lunghezza di poco superiore.
I blocchi hanno forma di cornice di coronamento e dunque rientrano nella categoria dei capitelli di pilastri. 2 La modanatura è aggettante e si sviluppa orizzontalmente nella zona superiore delle tre facce contigue, delle quali occupa i due terzi dell’altezza totale. Il quarto lato è corrispondente alle rispettive facce di combaciamento interne di ogni singolo blocco, che dovevano aderire a quelle laterali interne del blocco centrale mancan-te. Sulla fronte principale la parte sommitale della modanatura risulta mutila del tratto destro nel blocco A e del tratto sinistro nel blocco B, per cui ipotizziamo che tali blocchi abbiano subito un forte impatto per il crollo degli elevati del portico, soprattutto in corri-spondenza della mezzeria, con fratture e distacchi di materiale, e che proprio l’elemento centrale della composizione, oggi assente, abbia riportato i danni maggiori, frantuman-dosi. Allo stato attuale, non è possibile verificare se tali blocchi fossero originariamente ricoperti da strati di intonaco di finitura, semplice o decorato. 3
Sulle facce anteriori dei blocchi è incisa una epigrafe dedicatoria che corre su due righe (Fig. 4d). Essa si sviluppava orizzontalmente lungo la zona inferiore della fascia modana-ta, corrispondente al prospetto frontale dei plinti di base, ma, per via dell’assenza del bloc-co centrale oggi si presenta lacunosa. All’interno delle incisioni delle lettere, soprattutto nel blocco B, sono visibili tracce di colore rosso della rubricatura. Nelle parti conservate è possibile leggere un elenco di nomi riferibili ad un gruppo di seviri, i quali, verosimil-mente a proprie spese, commissionarono il monumento, dedicandolo ad un ignoto per-sonaggio, forse l’imperatore o un componente della sua famiglia, oppure ad una divinità.
Sui tre lati del blocco in cui è presente la modanatura aggettante, la distanza tra il pro-filo esterno dell’abaco e le facce del plinto di base non è costante (lato anteriore cm 12, lato posteriore cm 9, lato esterno cm 10).
Il blocco A (Fig. 14), partendo dal piano di posa, si articola nel seguente modo : il dado di base o plinto, alto cm 17, largo cm 47 e lungo cm 58 ; tre listelli digradanti, corrispon-denti agli anuli, ciascuno dei quali alto cm 1, separati da sottili fascette incavate di cm 0,5 di altezza ; il guscio o cavetto, alto cm 4, arretrato rispetto al profilo esterno del listello superiore di cm 4 ; il listello o fascetta, alto cm 1,5, arretrato rispetto al profilo esterno dell’abaco di cm 1,5 ; l’abaco, alto cm 5,5, lungo cm 69 e largo cm 68.
Piano di posa (Fig. 14e).È poco rifinito e semplicemente sbozzato. Sulla superficie segni di lavorazione a scalpello e
tracce di malta di calce. Lungo la fascia posteriore e ortogonalmente allo spigolo adiacente, a cm 20 dall’estremità sinistra esterna del piano e a cm 35 da quella dello spigolo interno, è presente un incasso di forma rettangolare molto largo e profondo (altezza cm 14, larghezza cm 3, profondità cm 11,5). Esso è inciso perpendicolarmente all’interno del blocco ed è visibile anche esternamente per tutta la sua lunghezza, poiché taglia la superficie del prospetto posteriore del blocco. Per forma,
1 Una composizione analoga di tre blocchi in arenaria con profilo modanato è presente all’interno del iv sacello, addossata alla parete di fondo. Il blocco centrale è più grande dei laterali ed è posto al di sopra di un plinto aggettante, per cui il profilo anteriore della composizione non risulta continuo bensì spezzato. È probabile che inizialmente il plinto fosse la base isolata di una statua, come in altri sacelli dell’agorà ; successivamente la parete a cui aderiva venne foderata da una muratura in mattoni intonacata e dipinta che accolse, lateralmente al blocco centrale, gli altri due elementi architettonici del coronamento della nuova composizione, forse per sostenere un gruppo statuario.
2 Sui capitelli a pilastro in Sicilia, vedi Villa 1988, pp. 40-50, 129-134, figg. 18-22, tavv. xxxiii-xxxix.3 Vedi supra, p. 000.
32 rocco burgio
Fig. 14. Blocco A.
dimensioni e posizione, è presumibile che l’incasso sia da mettere in relazione con un perno per l’ancoraggio del blocco sia con il piano di attesa del basamento che con la parete della muratura alle spalle del monumento.Piano di attesa (Fig. 14a, b).
È molto abraso e usurato per la prolungata esposizione all’aperto ed è interessato in tutta la superficie da avvallamenti che presentano un perimetro curvilineo sagomato, presumibilmente
architetture onorarie dell’agorà di alesa 1 33
corrispondente all’impronta di una statua e al suo alloggiamento. Sulla superficie sono visibili ampie zone di colore rossastro riferibili al contatto del blocco con il fuoco, forse quello degli in-cendi verificatisi durante la distruzione dell’edificio. Il tratto anteriore ed esterno destro sino allo spigolo, in corrispondenza della cornice aggettante, risulta spezzato per una lunghezza pari alla metà di quella totale del piano. Scheggiature e abrasioni meno marcate sono presenti in corrispon-denza dello spigolo posteriore sinistro. I resti di due perni di fissaggio in ferro – grappe a pi greco – sono presenti lungo la fascia destra della superficie. Di essi rimane : l’incasso di quello anteriore per l’alloggiamento che si conserva spezzato, visibile in sezione, in corrispondenza della frattura di cui si è detto, e vuoto per l’assenza del perno ; il dado in ferro del perno posteriore nel suo al-loggiamento, rivestito in superficie da piombo fuso, incastonato nel rispettivo alloggiamento che presenta sulla testa i resti della staffa orizzontale spezzata, che lo collegava con il blocco centrale della composizione ad esso limitrofo. I perni sono di forma quadrata del lato di cm 2,5, allineati e disposti parallelamente al profilo destro del blocco ; sono distanti tra loro cm 50, cm 11 dal profilo destro, cm 8 dal profilo anteriore e cm 8 da quello posteriore. Sono presenti, inoltre, tre incassi si-mili tra loro in corrispondenza di rispettivi avvallamenti più marcati della superficie di forma più o meno ellittica e a sezione verticale troncoconica. Di essi due sono uguali per forma e dimensioni ; larghi circa cm 8 e lunghi cm 11.5. Uno è collocato a destra della superficie, in linea con il perno anteriore ed è quasi rasente ad esso ; il secondo è posto al centro della fascia posteriore del piano, in corrispondenza forse della sagoma di un piede, e dista dal profilo esterno posteriore di cm 12,5. Un terzo leggermente più stretto ed allungato degli altri due, è quasi rasente l’angolo interno anteriore sinistro, ed è posto sulla bisettrice di esso ; nell’estremità esterna si presenta spezzato. È largo cm 5 e lungo cm 11. Lo schema geometrico degli incassi è quello di un triangolo isoscele con i lati uguali della lunghezza di cm 50 e un terzo di cm 40. Gli incassi sono internamente scavati a semicalotte con superfici lisciate e caratterizzati dalla presenza di marcati colpi di subbia isolati e per lo più disposti parallelamente (scalpello a punta piatta di cm 2) e di punteruolo grosso, neces-sari per migliorare l’aderenza, visto che dovevano accogliere l’elemento statuario. Una incisione più marcata e continua è presente perimetralmente all’interno degli incassi uguali. Essi molto probabilmente, sono da riferire agli alloggiamenti in negativo dei rispettivi tre perni di aderenza che dovevano essere presenti al di sotto della base di una statua, corrispondente alla superficie del piano di posa di questa.Prospetto frontale (Fig. 14c).
È ben rifinito e lisciato. Come già detto, presenta un’iscrizione incisa sul plinto, che si dispone su due righe (altezza delle lettere : rigo superiore cm 1,6, rigo inferiore cm 4,5) delle quali quella su-periore è continua. Oltre alla lacuna sul lato destro della modanatura, la faccia presenta abrasioni e distacchi diffusi su tutta la superficie, sia in corrispondenza della cornice che negli spigoli e nel profilo superiore a sinistra. Per via di questi degradi le lettere del rigo inferiore dell’iscrizione risul-tano lacunose al centro e alla base. Sono presenti inoltre degradi dovuti all’uomo, che consistono in marcate incisioni parallele, soprattutto in corrispondenza degli anuli e del cavetto, realizzati con un attrezzo a percussione metallico e a punta ; i segni incisi hanno un’inclinazione di circa quaran-tacinque gradi rispetto all’asse verticale del blocco, resi dall’alto verso il basso e in senso antiorario. È molto probabile che tali segni siano da riferire ai lavori di scavo al momento del rinvenimento del blocco.Prospetto posteriore (Fig. 14d).
È poco rifinito nella lavorazione, soprattutto per quanto riguarda gli anuli e la cornice, dato che non doveva essere a vista. Sulla superficie del plinto sono ben visibili i segni di lavorazione a scalpello (martellina) a punta piatta e larga e quelli con punteruolo. In particolare tali segni sono più marcati nella metà destra del plinto dove si distinguono i colpi dell’attrezzo praticati dal basso verso l’alto e a raggiera. Nella stessa zona è presente l’incasso verticale di cui si è detto sopra, che ha gli spigoli del profilo inferiore scheggiati. Per quanto concerne lo stato di conservazione, la superficie mostra scheggiature e distacchi lungo tutto il profilo inferiore ; la superficie dell’abaco si presenta ribassata e usurata ; lo spigolo superiore destro è spezzato e la superficie della frattura è abrasa.
34 rocco burgio
Prospetto laterale (Fig. 14g).La superficie del plinto è lisciata. Gli spigoli sono scheggiati, mentre la cornice è fratturata in
corrispondenza dello spigolo sinistro e dell’estremità destra. La fascia degli anuli è interessata da lacune e distacchi nella zona centrale.Faccia di combaciamento (Fig. 14f ).
È caratterizzata da marcati segni di lavorazione su tutta la superficie. Sono visibili incisioni con punteruolo e con martellina. Questi ultimi sono realizzati con punta piatta e larga e disposti a raggiera. Al centro della faccia è presente una marcata incisione orizzontale poco rifinita, della lunghezza di cm 12, profondità cm 5,5 e della larghezza di cm 2, forse per perno orizzontale o per il sollevamento del blocco (incasso per olivella ?) ; sono presenti inoltre labili tracce di incisioni, pro-babilmente riferibili ad una anathyrosis appena accennata, (forse un ripensamento ?), soprattutto nella metà destra della faccia, dove è presente una linea verticale incisa.
Il blocco B (Fig. 15) è meglio conservato rispetto a quello A. Partendo dal piano di posa, esso si articola nel seguente modo : il plinto di base, alto cm 17, largo cm 47 e lungo cm 42 ; il listello, il guscio e i tre anuli, delle stesse dimensioni del blocco A ; l’abaco, alto cm 5,5, lungo cm 53 e largo cm 68.
Piano di posa (Fig. 15e).È lisciato e conserva labili segni di lavorazione a scalpello. Sono presenti poche scheggiature in
corrispondenza dell’angolo posteriore sinistro.Piano di attesa (Fig. 14a, b).
È mutilo di entrambi gli spigoli di sinistra, che corrispondono rispettivamente alle zone in cui ricadono gli incassi per due perni di fissaggio per grappe, che sono in parte fratturate. Le grappe erano di forma a pi greco, analoghe a quelle del blocco A, e consentivano il collegamento con il blocco di centro. Gli incassi sono di forma quadrata, profondi cm 5 e con il lato di cm 2,5 ; non è da escludere che le fratture siano state provocate intenzionalmente per prelevare il metallo col quale erano realizzate le grappe. I resti di un’altra grappa, in questo caso probabilmente per perno ver-ticale, sono presenti all’incirca al centro del piano ; distano cm 30 dal profilo anteriore e cm 21 da quello sinistro. Del perno si conserva il dado metallico in ferro, di forma quadrata, che presenta la testa spezzata ed è bene incastonato nel suo alloggiamento. A circa cm 3,5 dallo spigolo destro del dado, parallelamente ad esso, è presente un incasso rettangolare (lato maggiore cm 10 e lato minore cm 3,5), in posizione normale al blocco, che si sviluppa verso il profilo anteriore. L’incasso, molto probabilmente per grappa verticale, è obliterato da un inserto realizzato con lo stesso tipo di pietra utilizzata per il blocco, ed è ben sigillato e cementato con malta di calce tranne che sul lato corto anteriore, dove è visibile un vuoto. La presenza dell’inserto indica che il blocco è stato oggetto di interventi di rilavorazione. Lungo il profilo sinistro, nella metà posteriore, si conserva parte di un incasso circolare per statua analogo a quelli del blocco A. L’incasso era scavato in corri-spondenza dell’asse di combaciamento della faccia sinistra del blocco con quella destra del blocco centrale. Della parte ricadente nel blocco B si conserva la metà anteriore ; per la restante parte l’in-casso è mancante per la frattura dello spigolo posteriore sinistro del blocco. In generale il piano, escludendo le zone interessate dalle fratture, è in buono stato di conservazione ; il profilo destro è integro, come gran parte di quello posteriore ; quello anteriore si presenta invece sbrecciato e caratterizzato da distacchi. La superficie è orizzontale e non presenta avvallamenti come quelli del blocco A, ma è interessata dalla presenza di incisioni più o meno marcate. Di esse quella più evidente è posta al centro lungo l’asse trasversale ed è lunga cm 8 ; le altre incisioni sono disposte apparentemente senza logica, ma alcune di esse, per forma e caratteristiche, potrebbero far pen-sare a segni alfabetici greci 1
1 Si potrebbe trattare di lettere riferibili all’ordine di collocazione del blocco nella composizione, oppure di segni di cava. D’altra parte, non è da escludere che il blocco B appartenesse in origine ad una più antica composizione epi-grafica, successivamente rilavorata e riutilizzata nel nostro monumento.
architetture onorarie dell’agorà di alesa 1 35
Fig. 15. Blocco B.
Prospetto anteriore (Fig. 15c).La zona inferiore è meglio conservata rispetto a quella superiore tranne che per lo spigolo
laterale sinistro che è interessato da scheggiature e distacchi. La cornice risulta spezzata per un consistente tratto a sinistra, a partire dagli anuli sino al piano di attesa, e in parte anche a destra, nella zona compresa tra il cavetto e l’abaco. In generale la lavorazione è accurata e le linee sono nette e ben definite.
36 rocco burgio
Prospetto posteriore (Fig. 15d).È privo di un consistente tratto di forma triangolare a destra, nella fascia superiore del blocco.
Lo spigolo sinistro è abraso e usurato. In generale la faccia è ben conservata. La superficie è poco rifinita e presenta segni di lavorazione a scalpello.Prospetto laterale (Fig. 15g).
È in buono stato di conservazione, tranne che per lo spigolo sinistro, in corrispondenza della cornice, che risulta spezzato dal cavetto al piano di attesa, e in minima parte per lo spigolo destro, spezzato all’altezza dell’abaco. La superficie è lisciata e gli spigoli sono netti.Faccia di combaciamento (Fig. 15f ).
È mutila dello spigolo superiore sinistro e in parte di quello superiore destro. Sono presenti scheggiature lungo il profilo destro, soprattutto nel tratto inferiore. Tutta la superficie è caratte-rizzata dalla presenza di segni di lavorazione a scalpello disposti a raggiera dall’angolo inferiore sinistro.
Del blocco centrale (Figg. 10-11), che non si è conservato, si ipotizza, date le dimensioni del piano di attesa dell’intera composizione dedotte dalla proposta ricostruttiva (m 0,68 x 1,82), che la base del plinto fosse di forma rettangolare, largo m 0,47 e lungo m 0,60, mentre la faccia superiore era di m 0,68 di larghezza e m 0,60 di lunghezza.
2. Documentazione fotografica degli anni ’70 del secolo scorso
L’ipotesi che i due blocchi modanati e iscritti appartenessero al coronamento del mo-numento conservatosi in situ, è scaturita sia dall’analisi degli elementi lapidei pervenu-ti, sia soprattutto dall’osservazione della documentazione fotografica storica d’archivio. Per questo studio, infatti, sono risultate di fondamentale importanza due serie di riprese fotografiche effettuate personalmente da G. Scibona nel settore dell’agorà in cui ricade il monumento ; la prima al momento del rinvenimento, negli anni Settanta del secolo scorso, la seconda nel corso dei già citati lavori di restauro degli anni Ottanta. Le prime foto testimoniano che le opere murarie appena messe in luce si trovavano in uno stato di conservazione precario e staticamente molto compromesso. Tutte le strutture risultava-no collassate, sia quelle del monumento che quelle dei muri a cui esso doveva innestarsi, e si presentavano come cumuli e ammassi informi di detriti e di pietre slegate. La loro altezza rispetto al piano di calpestio non superava i m 0,70 circa. Tra di esse emergeva il paramento esterno del monumento e, soprattutto, il piano di attesa del blocco sinistro, con la sua sagoma dal profilo insolito (Fig. 16c e Fig. 17a, b).
Nelle successive riprese, via via che le strutture venivano liberate dall’interro e dal crollo, si nota con maggiore chiarezza il corpo del monumento e, per la prima volta, si scorge una sorta di intercapedine tra il basamento e il muro limitrofo, forse in parte già presente al momento del rinvenimento, ma probabilmente accentuata dalle operazioni di scavo (Fig. 16d).
Nelle foto posteriori al restauro, le strutture si presentano oramai del tutto libere dai detriti, la parete alle spalle del monumento risulta restaurata, integrata, sarcita e in parte rialzata fino a circa m 1,50, e il blocco sinistro del secondo filare del basamento si rivela inserito in parte all’interno di essa (Fig. 17c, d).
È interessante osservare che, nelle riprese fotografiche, sul lato sinistro del basamento compare un frammento di lastra in pietra biancastra 1 di forma rettangolare, poco spessa,
1 Purtroppo le riprese fotografiche storiche sono in bianco e nero, per cui risulta difficile apprezzare i dettagli degli elementi lapidei e il loro riconoscimento cromatico.
architetture onorarie dell’agorà di alesa 1 37
poggiata direttamente sulla pavimentazione (Fig. 17a-d) ; il suo profilo anteriore presenta il bordo arrotondato e il lato corto sinistro risulta spezzato, mentre gli altri due lati non sono visibili in quanto aderenti al basamento e al muro di fondo. La lastra, considerata la sua posizione, sembrerebbe collocata sulla pavimentazione intenzionalmente, tuttavia si potrebbe ipotizzare anche un suo scivolamento, dovuto a distacco, dalla parete esterna del muro adiacente. Tale elemento non è stato ancora rintracciato tra i reperti conserva-ti, quindi al momento non è possibile verificarne l’appartenenza alla composizione del monumento, anche se la sua collocazione ravvicinata la rende molto probabile. Non è da escludere che la lastra fosse impiegata con una duplice funzione, sia decorativa che compositiva : una sorta di marcapiano utile a segnare la linea di separazione tra il corpo del monumento e il volume del coronamento (Fig. 11).
Purtroppo non si hanno dati di scavo specifici sul monumento, né notizie relative ad un’eventuale sua interpretazione da parte dello scavatore. Dei due blocchi superstiti del coronamento, tuttavia, il blocco A, rinvenuto per primo nel 1970, è stato oggetto di uno studio di carattere epigrafico da parte dello stesso Scibona, che in effetti ne ipotizzò l’ap-partenenza ad un « basamento di piccolo monumento (statua ?) ». 1 Dell’epigrafe lo studio-so riportava, tra l’altro, il preciso luogo di rinvenimento : « a diretto contatto del lastricato del portico, capovolta, presso la colonna v ovest, come fasciata dall’intonaco gessoso del
1 Scibona 1971, scheda 6, p. 16, tav. iv, fig. 1.
Fig. 16. Foto storiche dello scavo degli anni Settanta.
38 rocco burgio
crollo di questa ». 1 Ora, essendo la quinta colonna da Nord del portico interno ubicata davanti agli ambienti v e vi che prospettano sul portico stesso, e considerato che lo strato a cui il blocco apparteneva viene riferito dallo Scibona alla distruzione dell’edificio, ne deriva che, con molta probabilità, il blocco doveva far parte di un monumento presente nelle immediate vicinanze e precisamente di quello da noi preso in esame, dal momento che nell’area non vi è traccia di altre strutture analoghe (Figg. 3 e 18).
In una delle riprese fotografiche effettuata da Nord durante lo scavo, è possibile in-travedere il blocco appena affiorato, mentre in un’altra foto esso appare già recuperato e temporaneamente collocato sul piano di campagna, a sud del limite di scavo, insieme ad altri reperti lapidei selezionati e recuperati dallo smontaggio delle macerie del crollo (Fig. 16).
In altre immagini si nota che la zona antistante il monumento, a diretto contatto con la pavimentazione in cotto del portico, nonché una fascia lungo tutto il perimetro dello stesso, erano ricoperte da uno spesso strato di macerie compattate di piccole e medie dimensioni, di colore prevalentemente biancastro, dello stesso tipo di quelle ancora og-gi presenti all’interno della già menzionata intercapedine alle spalle del monumento. Si
1 Scibona 1971, nota 50.
Fig. 17. Foto storiche dopo il restauro.
architetture onorarie dell’agorà di alesa 1 39
trattava delle macerie depositatesi in seguito al disfacimento degli intonaci e delle malte a base di calce che rivestivano sia le colonne del portico che le superfici parietali degli elevati, e tali macerie, a loro volta, erano ricoperte dal crollo degli elementi strutturali dell’edificio e dagli strati di abbandono (Fig. 16c, d).
A questo punto, bisogna aggiungere che lo scavo ha restituito anche le tracce di un’in-tensa attività di spoliazione che dovette svolgersi, a più riprese, nei secoli successivi alla distruzione del complesso monumentale. 1 A differenza, però, di quanto può dirsi, come vedremo, nel caso del blocco B, il blocco A non sembra essere stato mai asportato dallo strato di crollo per essere riutilizzato. Dalle riprese fotografiche, infatti, è possibile notare che, nei pressi dei resti della v colonna del portico interno, si trovavano alcune sepolture pertinenti ad un cimitero impiantatosi sul luogo in epoca bizantina, 2 e che il blocco A era coperto dallo strato di materiale terroso, misto a macerie, in cui risultavano praticate le fosse (Figg. 16, 17 e 18). Possiamo quindi ritenere che la posizione del blocco al momen-to del rinvenimento fosse quella di crollo in giacitura primaria : staccatosi dalla base del monumento, sia per le scosse sismiche che per il violento impatto con la massa di detriti dovuta al crollo del muro adiacente, l’elemento collassato deve essere stato balzato in avanti nei pressi dei resti della v colonna, anch’essa caduta, rimanendo sigillato tra le macerie della distruzione.
Passando ora al blocco b, dalla documentazione d’archivio risulta che anch’esso venne recuperato dallo Scibona durante lo scavo del 1971, ma non fu pubblicato, mentre compa-re incluso in un elenco di documenti epigrafici redatto dallo stesso studioso per la stesura di un lavoro rimasto inedito. 3 In una serie di riprese fotografiche è possibile osservare, con maggiore nitidezza rispetto a quanto riscontrato a proposito del blocco a, che al mo-mento del rinvenimento il reperto si trovava nel portico ovest, quasi rasente la iii colonna interna a partire da Nord, davanti al iii sacello, quello cioè dedicato al culto di Augusto (Figg. 16b, 18 e 19). Esso giaceva al di sotto di uno spesso strato di accumulo dovuto al dilavamento dalle pendici collinari a monte, su cui era stata impiantata una tomba bizan-tina, 4 e poggiava con la sua faccia inferiore (piano di posa) al di sopra di uno strato bian-castro di detriti calcinosi. Il blocco era in posizione ruotata, con la fronte iscritta rivolta verso il sacello. Dall’analisi della sua collocazione, appare evidente che esso non fosse in posizione di crollo, bensì sistemato intenzionalmente. Avvalora tale ipotesi il fatto che il blocco era sormontato da un altro elemento architettonico con profilo modanato, sicura-mente non pertinente allo stesso monumento (forse base o elemento di coronamento di monumento a pilastro). La composizione dei due reperti suggerisce inequivocabilmente l’idea di un loro riutilizzo : prelevati in punti diversi del crollo, essi furono probabilmente riadoperati durante una delle fasi di riadattamento degli spazi antistanti i sacelli, prece-dentemente alla realizzazione della necropoli. Poco tempo dopo la distruzione dell’agorà, infatti, l’area fu liberata in parte dalle macerie, i sacelli furono rioccupati con funzioni
1 Il crollo venne sfruttato come un vero e proprio giacimento di materiali edilizi per la realizzazione, sia in loco che altrove, di nuove costruzioni. Le operazioni di prelievo del materiale devono aver intaccato pesantemente lo strato di distruzione, al punto che oggi i resti degli elementi strutturali, architettonici e non, che un tempo costituivano la monumentale agorà, appaiono di gran lunga meno consistenti. Ciò ha gravato notevolmente sull’analisi del monu-mento e ha comportato non poche difficoltà per lo studio architettonico dell’agorà, soprattutto per quanto riguarda la sua ricostruzione grafica e lo studio degli elevati, tuttora in corso. Vedi : Scibona 2008, pp. 12-13, Scibona 2009, pp. 18-20 ; Tigano c.d.s. 2 Sulla necropoli, vedi Scibona 2009, pp. 15-18, Tigano 2009, pp. 44-60.
3 Si tratta della stesura di Epigrafica Alesina ii, oggi in corso di elaborazione a cura di Cettina Giuffrè Scibona. Colgo l’occasione per ringraziare l’amica Cettina per la grande disponibilità e affettuosità con cui mi ha permesso di consultare la documentazione, in gran parte inedita, raccolta dal compianto marito Giacomo sugli scavi di Alesa, materiale prezioso e indispensabile per il mio studio sui monumenti alesini.
4 Si tratta della tomba 5 : Tigano 2009, p. 51, fig. 21. Sulla necropoli, vedi anche supra nota 55.
40 rocco burgio
forse abitative e lo spazio prospiciente trasformato dalla realizzazione di nuovi vani me-diante setti murari che collegavano le colonne del portico interno tra loro e con la parete di fondo. 1 Si trattava di apprestamenti grossolani, caratterizzati dall’utilizzo dei materiali presenti sul posto ma anche nei dintorni. 2 In questa fase, dunque, il blocco B deve essere stato reimpiegato nel muretto di chiusura dello spazio antistante il iii ambiente, tra la seconda e la terza colonna ovest del colonnato interno (Fig. 18).
3. Conclusioni
Riassumendo quanto è emerso dalla nostra ricerca, all’interno del portico ovest dell’ago-rà di Alesa è stato identificato un monumento onorario di modeste dimensioni, dalla composizione architettonica piuttosto semplice. Dal punto di vista morfologico, esso è classificabile tra i monumenti a setto murario e, allo stato attuale, rappresenta l’unico esemplare di questo tipo ad Alesa di cui sia stato possibile ricostruire la composizione originaria (Fig. 11). 3 La struttura consiste in un setto murario di forma parallelepipeda, sormontato da un coronamento a capitello di pilastro. La presenza di incassi sul piano sommitale del coronamento indica che il monumento era completato da un gruppo sta-tuario che purtroppo non si è conservato ; tuttavia, nei blocchi dello stesso coronamento, resta parte dell’epigrafe dedicatoria incisa (Fig. 4d). Le lacune del testo non consentono di leggere per intero i nomi dei dedicanti, ma, a giudicare dalle dimensioni ricostruibili della composizione, vi dovevano essere menzionati almeno due personaggi, che com-
1 L’esempio meglio conservato e documentato riguarda l’area antistante il sacello iv. 2 Come nel caso dei rocchi di colonne del cosiddetto “portico orientale” : vedi Tigano c.d.s. Tra i materiali impie-
gati per la realizzazione dei muretti che delimitavano l’area venne riutilizzata l’epigrafe di Caninio Nigro, prelevata dall’esedra C, posta nel tratto di crepidine antistante il sacello. Vedi Burgio 2011, p. 105.
3 Vedi supra, p. 000.
Fig. 18. Pianta dello scavo degli anni ’70 con ubicazione dei blocchi del coronamento, dei muri di chiusura degli spazi antistanti i sacelli e delle tombe bizantine.
architetture onorarie dell’agorà di alesa 1 41
missionarono l’opera a loro spese. Si tratta di seviri, dunque liberti sacerdoti del culto imperiale. 1 Sulla base dell’analisi epigrafica, lo Scibona ha datato l’opera tra la fine del I e gli inizi del ii sec. d.C. 2 La costruzione, sita nella navata interna del doppio portico ovest dell’edificio più importante della città, divenuto basilica in epoca imperiale, 3 è posta nei pressi del terzo sacello, già identificato come luogo principale del culto di Augusto. 4 È importante sottolineare il rinvenimento, nella stessa zona dell’agorà, di iscrizioni dedica-torie analoghe, 5 che suggeriscono una precisa destinazione d’uso dell’area : si potrebbe pertanto ipotizzare che l’intera sequenza dei sacelli fosse sotto la giurisdizione del colle-gio dei Seviri Augustales. 6
La posizione del monumento è singolare : si tratta infatti dell’unico caso nell’agorà in cui un monumento onorario è posto a ridosso della parete di fondo del portico, tra due sacelli. 7 Non conosciamo a quali culti questi ultimi fossero dedicati, 8 tuttavia la presen-za del monumento tra i due ingressi suggerisce un loro probabile legame. 9
La sua ubicazione non sembra casuale, bensì rispondente ad un progetto d’insieme che doveva tener conto dell’impianto architettonico dell’intero complesso. Rispettando il principio di assialità, il monumento è posto infatti lungo una fuga prospettica libera e in posizione centrale, in modo da essere visibile dalla piazza, inquadrato dalle colonne vi e vii, da Nord, del portico esterno : è probabilmente per questo che la struttura risulta di poco decentrata rispetto al muro su cui si addossa verso destra (Fig. 20).
Il monumento rimase in vita almeno fino all’inizio del iv sec. d.C. Dopo l’età tetrar-
1 Nel blocco A si conserva il nome quasi completo di un tale Q.(uintus) Caecilius Q.(uinti) L.(ibertus) Hime.... (Sci-bona 1971, pp. 16-17). Di un secondo nome resta solo la parte finale nel blocco B : ...S.(…) Э.(…) L.(…) Sabinus (iscri-zione inedita).
2 Non è da escludere tuttavia una datazione più alta, nella piena età augustea (comunicazione personale di J. R. W. Prag). 3 Almeno nella zona nord, interessata dalla presenza dei sacella.
4 Scibona 1971 ; Scibona 2009 ; Manganaro 1988 ; Wilson 1990 ; Portale 2009.5 Si tratta di un frammento in marmo di dedica/donario alla Concordia Augusta da parte di un Seviro Augustale,
che Scibona data tra il i e il ii secolo d.C., rinvenuta davanti al ii sacello (Scibona 1971, scheda 7, p. 17, tav. v, fig. 1 ; Scibona 2008a, p. 26), e della dedica sulla base della statua in marmo di Cerere già citata (vedi nota 7), offerta dal Seviro Augustale Iulius Acilius Hermes e messa in luce tra il ii e iii sacello (Scibona 1971, scheda 9, p. 19, tav. vi, figg. 1-2 ; Scibona 2008a, pp. 30-31 ; Portale 2009, pp. 77-87). Per questi rinvenimenti vedi anche : Manganaro 1988, p. 47 sgg. ; Wilson 1990, pp. 46-47 ; Facella 2006, pp. 340-342.
6 Vedi Facella 2006, pp. 340-342 ; Wilson 1990, pp. 46-47, 113, 289, 297, 361 ; Manganaro 1988, p. 48.7 Se si escludono le due basse basi quadrate rivestite in marmo bianco ai lati dell’ingresso del sacello di Augusto.8 Cfr. Portale 2009, pp. 77-87. 9 Vedi supra, p. 000.
Fig. 19. Foto storiche del rinvenimento del blocco B.
42 rocco burgio
chica, 1 probabilmente, un disastroso sisma, che provocò il crollo parziale dell’agorà, di-strusse il piano superiore della struttura : l’apparato scultoreo ed il coronamento, investiti dal crollo degli elevati dell’edificio, vennero sbalzati via sul lastricato del portico e sigillati dalle macerie.
Nei decenni successivi al sisma, si assistette ad un’articolata attività di espoliazione e di riutilizzo di tali macerie, insieme con una, pur precaria, rifunzionalizzazione degli
1 Sull’età tetrarchia ad Alesa, vedi Portale 2009, p. 88 ; Tigano c.d.s.
Fig. 20. Stralcio planimetrico dell’area del monumento con l’indicazione del cono ottico assiale.
architetture onorarie dell’agorà di alesa 1 43
edifici dell’agorà, forse a scopo abitativo nonché di deposito e smistamento di materia-li edilizi. 1 In questa fase, molto probabilmente, i resti delle statue a coronamento del monumento vennero ridotti in calce ; il basamento venne spoliato dei marmi di rivesti-mento e della cornice di base, che venne estratta dalla struttura compromettendone la stabilità. Dei blocchi di coronamento, quello centrale verosimilmente era già stato distrutto dall’impatto violento del crollo dovuto al sisma e i frammenti furono riadope-rati come pietrame da costruzione ; mentre il blocco di destra venne reimpiegato per la costruzione del tratto sinistro del muretto anteriore esterno di chiusura di quello che un tempo era stato lo spazio esterno porticato prospiciente l’ingresso del sacello dedi-cato ad Augusto.
Verosimilmente alla fine del iv sec. d.C., un nuovo evento sismico colpì pesantemente i resti dell’antica agorà rifunzionalizzati. 2 È probabile che, in questa occasione, si sia ve-rificato il crollo di ampi tratti del muro di fondo, già gravemente danneggiato dal sisma precedente.
Da allora l’area non venne più rioccupata e si assistette ad un lento accumulo di detriti terrosi scivolati dal lato monte, che si depositarono in maniera consistente, in pendenza, ricoprendo le macerie del crollo. 3 A questo punto, probabilmente solo alcuni brevi tratti della sezione sommitale della parete di fondo, che fungeva anche da muro di conteni-mento, rimasero a vista e proprio a ridosso di essi si sviluppò una necropoli tardo roma-na, divenuta in seguito cimitero bizantino. 4 Delle tombe bizantine, una venne impiantata al di sopra dei resti della iii colonna del portico ovest, nei pressi di uno dei blocchi del coronamento (blocco B) (Figg. 16b e 18).
Oggi lo stato di conservazione delle strutture risulta alquanto precario : i resti si pre-sentano molto compromessi, sia da un punto di vista statico che per l’avanzato degrado dei materiali, pertanto necessitano di urgenti interventi di consolidamento e restauro. Ciononostante, l’agorà di Alesa è da ritenersi sempre una preziosa fonte di dati e informa-zioni e, in questo quadro, il riconoscimento del monumento dei Seviri Augustales rappre-senta un tassello significativo per la comprensione dell’importante area urbana nonché un contributo alla conoscenza della vita pubblica e religiosa dell’antica città.
Bibliografia
Ampolo – Parra 2009 = C. Ampolo, M. C. Parra, L’agora di Segesta : uno sguardo d’assieme tra iscrizioni e monumenti, in Agorai di Sicilia, agorai d’Occidente. Atti del Seminario di Studio (Pisa, 30 giugno-2 luglio 2008), a cura di C. Ampolo, Pisa, Pre-print, 2009, pp. 125-141.
Angeletti 2009 = V. Angeletti, Nell’agora di Segesta : un contributo sui monumenti minori, in Ago-rai di Sicilia, agorai d’Occidente. Atti del Seminario di Studio (Pisa, 30 giugno-2 luglio 2008), a cura di C. Ampolo, Pisa, Pre-print, 2009, pp. 177-183.
Arslan 1998 = E. A. Arslan, Urbanistica di Scolacium, in La città romana. Atti del Secondo Con-gresso di Topografia Antica (Roma, 15-16 Maggio 1996), « Rivista di Topografia Antica », viii, 1998, pp. 79-110.
Bacci 1980-81 = M. G. Bacci, Ricerche a Taormina negli anni 1977-1980, « Kokalos », xxvi-xxvii, 1980-81, pp. 737-748.
Battistoni 2009 = F. Battistoni, Osservazioni sulle clausole per la pubblicazione di iscrizioni nell’ago-
1 Un consistente quantitativo di tali materiali fu infatti rinvenuto, ridotto in frammenti e stipato, nel vii sacello dell’agorà (statue, lastre in marmo con epigrafi, cornici e lastre di rivestimento parietali, oggetti in bronzo, vetri, ecc.). Cfr. Scibona 2009, p. 19 ; Tigano c.d.s.
2 Segni di questo sisma sono visibili nel vuoto di lacuna del tratto centrale del muro di fondo del portico ovest, il cui crollo è ancora oggi riverso sulla pavimentazione antistante. 3 Scibona 2009, p. 15.
4 Scibona 2009, pp. 15-18 (la necropoli vive dal vi al vii sec. d.C.) ; Tigano 2009, pp. 44-60.
44 rocco burgio
ra, in Agorai di Sicilia, agorai d’Occidente. Atti del Seminario di Studio (Pisa, 30 giugno - 2 luglio 2008), a cura di C. Ampolo, Pisa, Pre-print, 2009, pp. 59-64.
Belvedere et alii 1993 = O. Belvedere et alii, Termini Imerese. Ricerche di topografia e di archeologia urbana, Palermo, 1993.
Burgio 2009 = R. Burgio, Analisi tecnica e ipotesi ricostruttiva del cosiddetto “Colombario” di Hala-esa Arconidea. Patologie e forme di alterazione, in Alaisa-Halaesa, a cura di G. Scibona e G. Tigano, Messina, 2009, pp. 133-152.
Burgio 2011 = R. Burgio, Contributo allo studio dei monumenti minori dell’agorà di Alesa : Le esedre curve, in Da Halaesa ad Agathyrnum. Studi in memoria di Giacomo Scibona, Sant’Agata di Militello, 2011, pp. 87-124.
Burgio c.d.s = R. Burgio, Monumenti minori dall’agora di Alesa : Le esedre curve. Analisi e ricostru-zione, in Agora, foro e istituzioni politiche in Sicilia e nel Mediterraneo antico, Settime Giornate In-ternazionali di Studi sull’Area Elima e la Sicilia occidentale e nel contesto mediterraneo (Erice, 12-15 ottobre 2009), in corso di stampa.
Campagna 2006 = L. Campagna, L’architettura di età ellenistica in Sicilia : per una rilettura del quadro generale, in Sicilia ellenistica, consuetudo italica. Alle origini dell’architettura ellenistica d’Occidente (Atti Convegno Spoleto 2004), a cura di M. Osanna, M. Torelli (« Biblioteca di “Sicilia Antiqua” », i), Roma, 2006, pp. 15-34.
Campagna – La Torre 2008 = L. Campagna, G. F. La Torre, Ricerche sui monumenti e sulla topografia di Tauromenion : una stoà ellenistica nell’area della Naumachia, « Sicilia Antiqua » v, 2008, pp. 115-146.
Campagna 2009 = L. Campagna, Urbanistica dei centri siciliani d’altura in età ellenistica : il caso di Tauromenion, in EIS AKRA. Insediamenti d’altura in Sicilia dalla Preistoria al iii secolo a.C. (Atti Convegno di studi Caltanissetta 2008), a cura di M. Congiu, C. Miccichè, S. Modeo, Caltanisset-ta-Roma, 2009, pp. 205-226.
Carettoni 1961 = G. F. Carettoni, Tusa. Scavi di Alesa (seconda relazione), « Notizie degli Scavi », 1961, pp. 266-321.
Coulton 1976 = J. J. Coulton, The Architectural Development of the Greek Stoa, Oxford, 1976.Donzelli 1989 = C. Donzelli, L’edificio pubblico celebrativo, in Da Skylletion a Scolacium. Il Parco
archeologico della Roccelletta, a cura di R. Spadea, Roma-Reggio Calabria, 1989, pp. 123-127.Facella 2006 = A. Facella, Alesa Arconidea, Ricerche su un’antica città della Sicilia tirrenica, Pisa,
2006.Fiorelli 1878 = G. Fiorelli, xxxi Termini, « NSc », 1878, pp. 148-150.von Gaertringen 1906 = F. Frhr. H. von Gaertringen, Inschriften von Priene, Berlin, 1906.Hellmann 2006 = M.-Chr. Hellmann, L’Architecture Grecque, 2, Architecture religieuse et funéraire,
Paris, 2006.Isler 2009 = H. P. Isler, L’agora ellenistica di Iaitas, in Agorai di Sicilia, agorai d’Occidente. Atti del
Seminario di Studio (Pisa, 30 giugno-2 luglio 2008), a cura di C. Ampolo, Pisa, Pre-print, 2009, pp. 105-115.
von Kienlin 2002 = A. von Kienlin, Das stadtzentrum von Priene als monument bürgerlicher selbst-darstellung, in Macht der architektur – Architektur der Macht, a cura di E.L. Schwandner e K. Rheidt, Berlin, 2002, pp. 114-120.
Lauter 1999 = H. Lauter, L’Architettura dell’Ellenismo, Milano, 1999.Manganaro 1988 = G. Manganaro, La Sicilia da Sesto Pompeo a Diocleziano, in Aufstieg und Nie-
dergang der römischen Welt, ii, 1988, pp. 3-89.Parra 2006 = M. C. Parra, Note di architettura ellenistica a Segesta, intorno all’agorà, in Sicilia elle-
nistica, consuetudo italica. Alle origini dell’architettura ellenistica d’Occidente (Atti Convegno Spoleto 2004), a cura di M. Osanna e M. Torelli (« Biblioteca di “Sicilia Antiqua” », i), Roma, 2006, pp. 107-122.
Patanè 2002 = R. P. A. Patanè, Centuripe in età ellenistica : i rapporti con Roma, in Scavi e ricerche a Centuripe, a cura di G. Rizza, Catania, 2002, pp. 127-167.
Patanè 2006 = R. P. A. Patanè, Centuripe ellenistica. Nuovi dati dalla città, in Sicilia ellenisti-ca, consuetudo italica. Alle origini dell’architettura ellenistica d’Occidente (Atti Convegno Spoleto
architetture onorarie dell’agorà di alesa 1 45
2004), a cura di M. Osanna e M. Torelli (« Biblioteca di “Sicilia Antiqua” », i), Roma, 2006, pp. 201-210.
Patanè 2009 = R. P. A. Patanè, Centuripe, ex Mulino Barbagallo, Prime indagini al foro di età repub-blicana, « Sicilia Antiqua », vi, 2009, pp. 117-127.
Pettineo 2012 = A. Pettineo, Tusa dall’Universitas Civium alla Fiumara d’Arte, Messina, 2012.Portale 2005 = E. C. Portale, Sicilia, in E.C. Portale, S. Angiolillo, C. Vismara, Le grandi isole
del Mediterraneo occidentale. Sicilia Sardinia Corsica, 2005, pp. 11-186.Portale 2006 = E. C. Portale, Problemi dell’archeologia della Sicilia Ellenistico-Romana : il caso di
Solunto, « Archeologia Classica », lvii, n.s. 7, 2006, pp. 49-114.Portale 2009 = E. C. Portale, Le sculture da Alesa, in Alaisa-Halaesa, a cura di G. Scibona, G.
Tigano, Messina, 2009, pp. 67-92.Prestianni Giallombardo c.d.s. = A. M. Prestianni Giallombardo, Spazio pubblico e memoria
civica. Le epigrafi dall’agora di Alesa, in Agora, foro e istituzioni politiche in Sicilia e nel Mediterraneo antico, Settime Giornate Internazionali di Studi sull’Area Elima e la Sicilia occidentale e nel con-testo mediterraneo (Erice, 12-15 ottobre 2009), in corso di stampa.
Raeck 1993 = W. Raeck, Der mehrfache Apollodoros. Zur Präsenz des Bürgers im hellenistischen Stadt-bild am Beispiel von Priene, in Stadtbild und Bürgerbild im Hellenismus, a cura di M. Wörrle e P. Zan-ker, München, 1993, pp. 231-238.
Scibona 1971 = G. Scibona, Epigrafica Halaesina (Schede 1970), i, « Kokalos », xvii, 1971, pp. 3-21.Scibona 1975 = G. Scibona, Gli scavi di Halaesa, « Sicilia », 76, 1975, pp. 89-96.Scibona 2008a = G. Scibona, in G. Scibona, G. Tigano, Alesa Archonidea. Guida all’Antiquarium,
Messina, 2008, pp. 13-33.Scibona 2008b = G. Scibona, La chiesa e il complesso edilizio postmedievale, Messina, 2008.Scibona 2008c = G. Scibona, Dalla riscoperta tardo rinascimentale agli scavi del xx secolo, Messina,
2008.Scibona 2008d = G. Scibona, Alesa Archonidea. L’agorà, Messina, 2008.Scibona 2009 = G. Scibona, L’Agorà (scavi 1970-2004), in Alaisa-Halaesa, a cura di G. Scibona, G.
Tigano, Messina, 2009, pp. 8-43.Stucchi – Bacchielli 1983 = S. Stucchi, L. Bacchielli, L’Agorà di Cirene ii, 4 : Il lato S della pla-
tea inferiore e il Lato N della terrazza superiore, Roma, 1983.von Thüngen 1994 = S. Freifrau von Thüngen, Die frei stehende griechische exedra, Mainz,
1994.Tigano 2008 = G. Tigano, Il sito archeologico, in G. Scibona, G. Tigano, Alesa Archonidea. Guida
all’Antiquarium, Messina, 2008, pp. 71-90.Tigano 2009 = G. Tigano, Brevi note sul cimitero bizantino nell’area dell’agorà, in Alaisa-Halaesa, a
cura di G. Scibona, G. Tigano, Messina, 2009, pp. 45-60.Tigano c.d.s. = G. Tigano, Alesa Arconidea : l’agora – foro, in Agora, foro e istituzioni politiche in Si-
cilia e nel Mediterraneo antico, Settime Giornate Internazionali di Studi sull’Area Elima e la Sicilia occidentale e nel contesto mediterraneo (Erice, 12-15 ottobre 2009), in corso di stampa.
Villa 1988 = A. Villa, I capitelli di Solunto, Roma, 1988.Wilson 1990 = R. J. A. Wilson, Sicily under the Roman Empire, Warminster, 1990.Wolf 2009 = M. Wolf, Nuove ricerche nell’agora di Solunto, in Agorai di Sicilia, agorai d’Occidente.
Atti del Seminario di Studio (Pisa, 30 giugno-2 luglio 2008), a cura di C. Ampolo, Pisa, Pre-print, 2009, pp. 117-123.