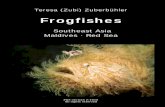Alvise Andreose, Lo sviluppo di IN-/ IM- latino in romeno: un caso di rule inversion, in: Per...
-
Upload
uniecampus -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of Alvise Andreose, Lo sviluppo di IN-/ IM- latino in romeno: un caso di rule inversion, in: Per...
PER TERESAOBIETTIVO ROMANIA
STUDI E RICERCHE
IN RICORDO DI
TERESA FERRO
21 A CURA DIGIAMPAOLO BORGHELLO
DANIELA LOMBARDIDANIELE PANTALEONI
FORUM
La presente pubblicazione è statarealizzata con il contributodell'Università degli Studi dì Udine
In copertinaII metropolita Grigore Ro§cae Daniil l'Eremita, facciata sud delMonastero di VoroneJ, Moldavia.
Progetto grafico di copertinacdm/ associati
1 Università degli Studi di Udine
© FORUM 2009Editrice Universitaria Udinese srlVia Palladio, 8 - 33100 UdineTei. 0432 26001 / Fax 0432 296756www.forumeditrice.it
ISBN 978-88-8420-538-4
LO SVILUPPO DI ÌN-/IM- LATINO IN ROMENO:
UN CASO DI RULE INVERSION
Alvise Andreose
1. B problema
Uno degli aspetti del fonetismo romeno su cui gli studiosi non hanno trovatofino ad oggi una visione unitaria è costituito dallo sviluppo di I- latina prima dinasale omosillabica ad inizio di parola, cioè nel contesto:
/ # I n l$
Le posizioni che si fronteggiano sono nella sostanza due: quella che sostie-ne che le vocali centrali a (= [a]) e i (= [è]) che le varietà romene (dacorome-no, istroromeno, meglenoromeno e, solo in parte, aromeno) presentano in que-sto contesto, sono delle vocali prostetiche, introdotte a seguito dell'aferesi delsuccedaneo di I- atona davanti a -N-/-M- + C; e quella che considera questi fo-nemi i diretti continuatori di I- latina davanti a -N-/-M- + C1. La prima ipotesi ri-sulta sicuramente più plausibile, anche se finora non ha trovato una formula-zione che dia conto dell'articolata situazione che si incontra nei dialetti rome-ni, antichi e moderni. Il presente saggio mira a superare questa impasse. Cer-cheremo di dimostrare che quella che era in origine una vocale centrale pro-stetica (r.c. a-) si è fonologizzata già nel romeno comune, in seguito a un feno-meno di 'inversione di regola' (mie inversion) che ha comportato la sostitu-zione dell'originaria legge di prostesi con una legge di aferesi. Successivamen-te, processi di attrazione analogica hanno condotto alla diffusione di questo fo-nema in contesti sintagmatici in cui non era ammessa l'aferesi. Mentre in da-coromeno e in meglenoromeno questa situazione si conserva, in istroromenoe, ancor più, in aromeno sono intervenuti ulteriori mutamenti fonologici che lihanno allontananti dallo stadio postulato nel romeno comune.
- Queste teorie saranno analizzate nel dettaglio nel par. 4.
126 ALVISE ANDEEOSE
2. Sviluppo di lat. volg. lei (< lai. i) nel romeno comune e nei dialetti romeni
Prima di esaminare il trattamento dei nessi IN-/IM- + C nei quattro dialetti ro-meni è necessario stabilire quale sia l'esito di I + -N-/-M- postulato nel romenocomune, cioè, in altre parole, quale sia il comune punto di partenza dei succes-sivi sviluppi in dacoromeno, istroromeno, meglenoromeno e aromeno. Anchesu questo punto gli orientamenti divergono. L'esito di lat. volg. /e/ (< I, È) toni-ca seguita da nasale omosillabica all'interno di parola - salvo che in alcuni ca-si di cui si dirà più avanti - è /i/ in tutte le varietà romene: ONGUAM > ar. dr. me-gl. limbà istr. limbo, ONGURAM > ar. dr. megl. lingurà istr. lingura, *(EX)ST!NGUO >dr. istr. megl. stìng ar. astìngu, LIMPIDUM > dr. limpede ar. limpide, PRENDERE(< PRÉHÈNDERE) > dr. istr. megl. prind ar. prìndu, ecc.2 Anche -È- latina evolvein HI in questo contesto, il che prova che essa era passata a lei abbastanza pre-cocemente3: ARGÈNTUM > dr. argini ar. istr. ar(d)zìnt megl. rizìnt(u), DÈNTEM >ar. dr. istr. dinte megl. dìnti, PARÈNTEM > dr. ar. pàrinte, ecc.4 Benché gli esempisiano pochi, sembra che anche /e/ atona abbia seguito lo stesso sviluppo: G!N-GIVA > dr. gingie/ginginà ar. dzindzìe istr. jinjire/jinjira, MÈNTIONEM > ar. dr. me-gl. minciunà, MENT(I)O > dr. istr. megl. mini5. Da rilevare che nelle varietà ro-mene l'innalzamento di /e/ avviene anche prima di m/ (ma non di /m/) etero-sillabica: PLENUM > ar. dr.plin isti.pl'ir megl. (qm)plin, VENENUM > dr. venin, ar.megl. virin istr. verìr, DOM!NICAM > ar. dr. megl. duminica6 istr. dumireca, ecc.
2 A. BYHAN, Die Entwickelung von e vor Nasalen in den lateinischen Elementen des Rumanischen,in «Jahresbericht des Instituts fiir Rimanisene Sprache». 3 (1896), pp. 1-70, in particolare pp. 33-39; O. DENSUSIANU, Histoire de la langue roumaine, editie critica si note de V. Rusu, prefata de B.Cazacu, Bucuresti, Orai si suflet-Cultura nationalà 1997 (la ed.: Paris 1901-1938), p. 396; A. PHI-LIPPIDE, Originea romìnilor, II, lasi, Tipografia Viata romìneasca 1927, pp. 37-38; O. NANDRIS,Phonétique historique du roumain, Paris, Librairie Klincksieck 1963, pp. 20-21,250-251; E. VASI-LIU, Fonologia isterica a dialectelor dacoromàne, Bucuresti, Academia Republicii SocialisteRomania 1968, pp. 72-73; M. SALA, Contributii la fonetica isterica a limbii romàne, Bucuresti, Edi-tura Academiei Republicii Socialiste Romania 1970, p. 132.3 Sicuramente prima del dittongamento di 6:1. IORDAN, Diftongarea lui e si o accentuati in pozitii-le a, e, lasi, Viata romàneascà 1921, p. 184; NANDRIS, Phonétique... cit, p. 250. Il passaggio di 6 pri-ma di nasale omosillabica a /e/ si riscontra del resto in molti altri idiomi romanzi, v. SALA, Con-tributii. .. cit., p. 125.4 DENSUSIANU, Histoire... cit., p. 395; PHILIPPIDE, Originea... cit., pp. 37-38; A. ROSETTI, Istoria lim-bii romàne de la origini pinà in secolul XVII-lea, Bucuresti, Editura pentru literaturà 1968 (l"ed.1941), p. 360; VASILIU, Fonologia... cit., p. 75; SALA, Contributii... cit., pp. 124-125.5 BYHAN, Die Entwickelung... cit., pp. 48-49; NANDRIS, Phonétique... cit.,p. 20.6 In aromeno è attestata anche la variante duminica, v. T. PAPAHAGI, Dictionarul dialectuluiaromàn generai si etimologie, Bucuresti, Academia Republicii Populare Romìne 1963, p. 419 s.v.duminica.
LO SVILUPPO DI iNVlM- LATINO IN ROMENO: UN CASO DI RULEINVERSION \21
(ma T!M(È)O > dr. tem istr. temu)1. In contesto atono, tuttavia, il fenomeno nonè sistematico, visto che in postonia si danno numerose oscillazioni tra IH e /e/(MARGINEM > dr. margine ar. mardzinà/mardzine megl. mardzini, PECTINEM > dr.pieptene ar. megl. keaptine istr. coprir, LEND!NEM > dr. lindinà/lindenà ar. lindinàistr. lindire), mentre in protonia tende a conservarsi /e/ (*C!NUS!AM > dr. cenusàistr. teruse, GÈNUCULUM > dr. genu(n)chi, megl. zànùd'u, istr. jerund'u; ma cfir.ar. cinuse, dzinùd'ìu, megl. cinùsa/cànùsa).
Partendo da queste evidenze, la maggior parte degli studiosi inclina a rite-nere che l'innalzamento di /e/ a IH davanti a /n/ e /mC/ sia avvenuta già nellafase del romeno comune8. Altri9 - probabilmente a ragione - considerano que-sto processo come un caso di svilluppo parallelo, avvenuto cioè contempora-neamente e indipendentemente nei quattro dialetti romeni. Questa secondaipotesi si fonda in primo luogo sulla constatazione che in dacoromeno /e/ pre-ceduta da consonante labiale (/f, v, p, b, m/) si centralizza sia in sillaba libera,sia prima di /n/ o /mC/. Abbiamo così MONUMÈNTUM > dr.a. *[mor'm3nt] (poi dr.mormànt [mor'mant] per il noto fenomeno di innalzamento di [a] a [i] davantia /n/), PAVIMENTUM > dr. a. *[p9'ni3nt] (> dr.pàmànt), VÉNDO > dr.a. *[vand] (>dr. vànd), VÈNTUM > dr. a. *[vant] (> dr. vani), lat. volg. *AMENDUI (o *AMENDOS) >dr.a. * [amandoj] (> dr. amàndoi)10, accanto a MÈLUM > dr. mar, P!RUM > dr. par,VID(È)O > dr. vàd. Questo fa pensare che il passaggio di /e/ a IH in posizione na-sale sìa posteriore a quello di /e/ a /a/ dopo labiale. Ma poiché quest'ultimoprocesso non si realizza in aromeno, istroromeno e meglenoromeno (cfr., peresempio, ar.: marmintu/mirmintu, pàmintu/pimintu, vendu, vimtu/vintu, amin-do(i)l'i; mer,per, ved; megl.: mormint,pimint, vind, vint;mer,per, ved; istr.: pemint,
1 BYHAN, Die Entwickelung... cit., pp. 6-12; DENSUSIANU, Histoire... cit, p. 396; PHILIPPIDE, Origi-nea... cit., pp. 37-38; ROSETTI, Istoria... cit., p. 360; NANDRIS, Phonétique... cit., pp. 20-21,248-251;SALA, Contributii... cit.,pp. 132-133.8 Per esempio H. MOSER, Der Ursprung der rumànischen Prapositionen, in «Jahresbericht des Insti-tuts fiir rumanische Sprache», 10 (1904), pp. 409-464, in particolare p. 428; NANDRIS, Phonétique... cit.,pp. 20-21,250-251 («phénomène protoroumain»); M. SALA, Romàna comano, I. Fonologia, in ACA-DEMIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, Istoria limbii romàne, I, Bucuresti, Editura Academiei Repu-blicii Socialiste Romania 1969, pp. 189-212, in particolare p. 199; Io., Contributii... cit., p. 132.9 H. TIKTIN, Der Vocalismus des Rumànischen, in «Zeitschrift fur romanische Philologie», 11(1887), pp. 56-84, in particolare p. 65; BYHAN, Die Entwickelung... cit., pp. 15-16; PHILIPPIDE, Orì-ginea... cit., p. 41; A. ROSETTI, Contributions a l'analyse physiologique et a l'histoire des voyellesroumaines a et i, in «Bullettin linguistique (Faculté des lettres de Bucarest. Laboratoire de phoné-tique expérimentale)», 3 (1935), pp. 85-112, in particolare p. 107; E. VASILIU, Some Remarks on thèChronology ofthe Change [en] > [in] in Romanian Dialects,m «Revue Roumanine de Linguisti-que»,ll (1966), pp. 255-257; lo., Fonologia... cit, pp. 72-73.10 Da affiancare all'it. a. e reg. amendue e all'engad. amenduos cfr. LEI (Lessico etimologico ita-liano), ed. da M. PFISTER, Wiesbaden, L. Reichert 1979-, II, coli. 583-586.
128 ALVISE ANDREOSE>REC\ vini, amindoi; per, ved(u))n, ne consegue che l'innalzamento di /e/ davanti
a /n/ e /mC/ deve essere successivo alla separazione del dacoromeno dagli altridialetti12. A sostegno di questa seconda ipotesi, in secondo luogo, depone la pre-senza di forme con <en> al posto di <in> nei documenti più antichi del dacoro-meno, che sembra provare che, nel secolo XVI, il processo di innalzamento di /e/non si fosse ancora imposto sistematicamente nella lingua: argentulu 'argint', ce-ne 'cine', credentà 'credintà', cuvente 'cuvinte', dentii 'dintii', densu (accanto a dr.a. dinsu) 'dànsuP, mene 'mine', mente 'minte', venim 'venin', ecc.13
In conclusione, dunque, vari elementi suggeriscono che, nel romeno comu-ne, il fonema lat. volg. /e/ davanti a nasale omosillabica (come anche davanti anasale eterosillabica) fosse continuato da /e/.
3. Esiti di IN-, IM- nei dialetti romeni
Vediamo ora brevemente quali fonemi iniziali si incontrino nei quattro dialet-ti del romeno in forme derivate da parole comincianti con IN-/IM- + C e nei con-tinuatori della preposizione (= P) IN e dei suoi composti.
11 Cfr. ROSETTI, Contributions... cit., p. 107; Io., Istoria... cit.,pp. 359,364; VASILIU, Fonologia... cit,pp. 45-46; SALA, Contributii... cit., p. 117; M. CARAGIU MARIOTEANU, Compendiu de dialectologieromàna, Bucuresti, Editura stiintificà si enciclopedica 1975, p. 224.12 Alcuni studiosi (per es. DENSUSIANU, Hìstoire... cit., pp. 395,396; S. PUSCARIU, Studii istroromà-ne, II: Introducere, gramaticà, caracterizarea dialectului istroromàn, in colaborare cu M. Bartoli, A.Belulovici si A. Byhan, Bucuresti, Cultura nationala 1926, p. 332) pensano che in forme comemormànt,pàmànt, vana, vànt, il fonema /i/ derivi non da un precedente I si ma da un IH che si sa-rebbe poi centralizzato per influsso della labiale: MONUMENTUM > dr. a. *[mormint] > rom.mormànt [mormènt], ecc. Come rileva VASILIU (Fonologia... cit., pp. 72-73) tale ipotesi, tuttavia,oltre ad essere antieconomica, urta con il fatto che, in dacoromeno, IH primaria (< i) dopo labia-le si mantiene inalterata: FILUM > rom. fìr, *MICCUM > rom. mie, PÌNUM > rom. .pài, VINUM > rom.vin. A quest'ultima obiezione ha cercato di replicare Marius Sala, che spiega il diverso tratta-mento di /e/ e IH dopo labiale ipotizzando che I latina fosse evoluta in romeno nel dittongo /ji/,che poi si sarebbe monottongato in /i/; PINUM > r. e. *[pjin] > rom.pin; cfr. M. SALA, Romania orien-tale et Romania occidentale. II. Sur la corrélation de quantìté consonantique, in «Revue Roumai-ne de Linguistique», 9, 4 (1964), pp. 445-459, in particolare pp. 453-454; Io., Romàna comunà...cit., pp. 199-200; In., Contributii... cit., pp. 63,106-108,133.13 Psaltirea Scheianà, comparata cu celelalte Psaltiri din sec. XVI si XVII traduse dinslavoneste, editiune critica de I.-A. Candrea, 2 voli., Bucuresti, SOCEC & C. 1916,1, p. CXXXII;DENSUSIANU, Histoire... cit., pp. 433-436; ROSETTI, Istoria... cit., pp. 493-496; NANDRIS, Phonéti-que... cit., p. 251; A. AVRAM, Contributii la interpretarea grafiei chirilice a primelor teste romìneqtì (II),in «Studii si cercetari lingvistice», 15,2 (1964), pp. 147-167, in particolare pp. 147-160; SALA, Romànacomunà... cit., p. 199; ID., Contributii... cit., p. 132. Ricordiamo che ROSETTI (Istoria... cit., pp. 493-494) e, prima di lui, BYHAN (Die Entwickelung... cit., pp. 16-18), distaccandosi dall'opinione preva-lente, interpretano tali forme come arcaismi grafici, dietro cui si celerebbe la pronuncia III.
LO SVILUPPO DI IN-/IM- LATINO IN ROMENO,: UN CASO DI RULE INVERSION 129
3.1. Dacoromeno
Nel dacoromeno attuale e in gran parte delle sue varietà dialettali, in questicontesti troviamo il fonema i (/i/), sia in sillaba tonica sia in sillaba atona. Sidanno alcuni casi sporadici di conservazione di / (il verbo a intra, il nome ins'individuo, persona'), che tuttavia nelle fasi più antiche della lingua (secc. XVI-XVII) presentavano anche la variante con z-14. Di norma, i iniziale atona da-vanti a consonante (P in, prefissi in-, ìm-) può essere elisa dopo parola termi-nante in vocale [ess. (la-d)]. In alcuni casi (in realtà abbastanza rari nella lin-gua d'oggi), la P in e il prefisso in- possono essere soggetti ad aferesi anche da-vanti a vocale [es. (le)]15. Riportiamo, per fornire degli esempi del fenomeno,alcuni versi tratti dal celebre poema Luceafàrul di Mihai Eminescu (1883):
(1) a. A fost odatà ca 'n poveri... (v. 1)b. ...si ochiul tàu ma 'nghiatà (v. 96)e. ...vrei cu crezàmànt / sa te 'ndràgesc pe tine... (v. 158)d. ...un paj ce poartà pas cu pas / a 'mparatesei rochii... (vv. 177-178)e. ...càci este sarà 'n asfintit... (v. 345), ecc.
Si tratta di un processo di fonologia postlessicale condiviso da istroromenoe meglenoromeno, che si incontra, in forme simili, anche nei dialetti italianicentromeridionali e nelle varietà toscane. Va ricordato che in alcuni dialetti ein alcune registri stilistici 'bassi' del romeno, dopo parola uscente in consonan-te e a inizio assoluto di frase è possibile che al posto di ìn-llm- + C si abbia unaconsonante nasale sillabica ([m, n, irj, rj]), analogamente a quanto avviene inaromeno (v. par. 3.3.)16.
3.2. Istroromeno
Ili istroromeno - dove manca la distinzione tra i/a (/i/) e a (/a/) - troviamo neicontesti in questione un fonema centrale, articolato verosimilmente in una po-
14 Academia Romana, Dictionarul limbii romàne (DiR), II/l, Bucuresti, Imprimerla nationalà1934, s.vv. Ins, intra. In genere queste 'anomalie' si spiegano ipotizzando che, in un primo tempo,la i- iniziale sia passata a i- per metafonesi nelle forme uscenti in -e/-i (per es. m. pi. ìn$i -* in$i,ind. pres. 2" sg. intri ~* intri, cong. pres. 3" sg./pl. intre) e che, successivamente, quest'ultima si siaestesa al resto del paradigma per analogia. Poiché, come mostreremo meglio più avanti (par. 5),in- in posizione tonica è analogico su in- atono, è possibile che ins e le voci verbali rizotoniche in-tru/intri/intrà ecc. conservino la i- etimologica (< /e/ < i) e che la i nelle voci arizotoniche di a in-tra sia dovuta a fenomeni di livellamento.15 A. LOMBARD, La prononciation du roumain, Uppsala, A.-B. Lundequistska Bokhandem 1935,pp. 150-151.16 S. PUSCARIU, Contribufiuni fonologice, in «Dacoromania», 3 (1922-23), pp. 378-397, in particola-re p. 392; LOMBARD, La prononciation... cit, p. 113; A. AVRAM, Interpretarea fonologica a lui [\]initial in limba ramina, in «Fonetica §i dialectologie», 4 (1962), pp. 7-23, in particolare p. 11.
130 ALVISE ANDEEOSE
sizione intermedia tra h/ e /i/, che può essere realizzato liberamente come [9]o come [è]17, e che nelle trascrizioni viene reso ora con <à> ora con <à>. Comein dacororneno, questo fonema può essere soggetto a cancellazione in contestopostvocalico, prima di consonante (2a-c) e - solo nel caso della P àn/àn 'in' edei suoi composti - prima di vocale (2d)18:
(2) a. Cu cànita se-ncinje ['Se incinge cu bràul']b. Omàrva và-nteleg [Tutin va ìnteleg']e. Nec-avem de prejivit, de poidf si de.-nvesti [= 'Sa avem de supravietuit, de mancai
si de imbracai']d. .. .ànla nunlru... ['aiti ìnaunlru']19
La presenza, in alcune trascrizioni studiate da Sextil Puscariu20, di sporadi-ci fenomeni di aferesi anche in contesto postconsonantico sarà da interpretarecome l'effetto di un ampliamento dei contesti di applicazione della regola dicancellazione succitata. Meno probabile, invece, che si tratti di spie di un inci-piente processo di lessicalizzazione delle forme aferetiche, analogo a quello av-venuto in aromeno (par. 3.3.) e in alcune varietà dialettali del dacororneno(par. 3.1.), dato che, almeno nelle testimonianze considerate, l'aferesi non ri-corre mai a inizio assoluto di frase o dopo pausa21.
3.3. Aromeno
In aromeno, negli sviluppi di IN e dei prefissi IN-/IM- + C, i suoni centrali /a/ (gra-fia <à>) presso i gruppi settentrionali (fàrseroti, moscopoleni, muzachearf), e/i/ (grafia <ì>) nei gruppi meridionali (pindeni, gramosteni) sono rari22. Il casopiù diffuso, soprattutto nelle varietà settentrionali, è l'assenza della vocale ini-
17 PUSCARIU, Studii istroromàne... cit, par. 13; A. KOVACEC, Descrierea istroromànei actuale, Bucu-resti, Editura Academiei Republicii socialiste Romania 1971, p. 33 («ceva mai deschisa decìt mol-dovenescul [a], ìnsà mai inclusa decìt [a] din limba romàna literara»); CARAGIU MARIOTEANU,Compendiu... cit., p. 192; A. KOVACEC, Istroromàna, in V. Rusu (coord.), Tratat de dialectologieromàneasca, Craiova, Scrisul Romànesc 1984, pp. 550-591, in particolare pp. 554-555; R. SÀRBU -V. FRÀJILÀ, Dialectul istroromàn. Texte si glosar, Amarcord, Timisoara 1998, pp. 9 e 19.18 Cfr. PUSCARIU, Studii istroromàne... cit., par. 25.19 Gli esempi e le traduzioni riportate in (2a-c) sono ricavati da SÀRBU e FRÀJILÀ, Dialectul... cit.,pp. 189-190; (2d) è ripreso da PUSCARIU, Studii istroromàne... cit., p. 82.20 PUSCARIU, Studii istroromàne... cit., par. 25.21 Ibidem.22 Nei dialetti pindean e gràmostean (parlati perlopiù nella Grecia settentrionale) si distinguonodue fonemi centrali, hi e /i/, come in dacororneno; in quelli fàrserot, moscopolean e muzachear(diffusi prevalentemente in Albania) esiste solo il fonema centrale hi, cfr. N. SARAMANDU,Aromàna, in Rusu, Tratat... cit., pp. 423-476, in particolare p. 428.
LO SVILUPPO DI IN-/IM- LATINO IN ROMENO: UN CASO DI RULE INVERSION 131
ziale (mpàrtu 'impari', ndrég/ntrég 'ìntreg', nsór 'ìnsor', ntrébu 'ìntreb', ecc.)23.Queste forme, diversamente da quanto succede in dacoromeno standard, pos-sono ricorrere anche dopo parola uscente in consonante (3a) e a inizio assolu-to di frase (3b). In questi contesti, /n/ viene realizzata come sillabica24.
(3) a. ...s'aita am ncàsàita si fàcà ràle... ['sì pe altii am ìndemnat sa facà relè']b. NKisim" la óra dati cu camion" ['Am pornit la ora zece cu camionul']25
Soprattutto nelle varietà meridionali (pindean, gràmostean), inoltre, si in-contrano frequentemente forme comincianti con a- (angróp 'ìngrop', ansór 'ìn-sor', ambùn 'ìmbunez', anvàrtéscu 'ìnvàrtesc', ecc.), che derivano da un proces-so di prostesi26, come prova il fatto che tale vocale di appoggio ricorre anchedavanti a altri incipit sillabici complessi (per esempio, prima di parole che ini-ziano con /sC/, [n] o [r])27 e - a seguito di estensione analogica - davanti a ter-mini comincianti con /n/ che in origine non presentavano I-: anóstru < NOSTRUM,ammirare < NUMERARE, anàpàdire 'a ìntàlni' < ant. si. napaditi, ecc.28
Il prefisso IN davanti a vocale sembra essere andato incontro alle stesse sor-ti di IN-/IM- + C, dato che si hanno casi di aferesi (naltu 'ìnalt', naùntru/nàùn-tru/naìntru 'ìnàuntru', nafoàrà/nàfàrà 'in + afarà', ecc.) e casi di prostesi (anàl-tu 'ìnalt').
Come in dacoromeno, le forme in cui IN-/IM- (+ C) si trovavano in posizio-ne tonica presentano /i/ o Isl (nàs/nas 'dànsul'< (CU)N *INSU) ma anche HI (ìn-tru 'intra', ìnsu($) 'ins', 'ìnsusi' < *INSU).
23 PAPAHAGI, Dictionarul... cit., p. 21 e p. 109 s.v. angustii; TH. CAPIDAN, Ammanii. Dialectularomàn: studiu lingvistìc, Bucuresti, Imprimeria Nationala 1932, pp. 246-247; CARAGIU MARIOTEANU,Compendii*... cit.,p. 226;T.FERRO, Concordanze dei dialetti italiano-meridionali con l'area balca-no-romanza: la protesi di a-, in EAD., Latino, romeno e romanzo. Studi linguistici, Cluj-Napoca,Dacia 2003, pp. 234-321 (già in «Siculorum Gymnasium», n.s., 44 (1991), n. 1-2, pp. 103-136; 47(1993-1994), n. 1-2, pp. 3-43), in particolare pp. 253,257.24 BYHAN, Die Entwickelung... cit., p. 53; CAPIDAN, Ammanii... cit., pp. 246-247.25 Ess. tratti rispettivamente da PAPAHAGI, Dictionarul... cit., p. 751 s.v. ngàsàìéscu, e da M. CARAGIUMARIOTEANU, Fano-morfologie aromànà. Studiu de dialectologie strutturala, Bucuresti, EdituraAcademiei Republicii Socialiste Romania 1968, p. 206.26 PAPAHAGI, Dictionarul... cit., p. 21 e p. 109 s.v. angùstu; CAPIDAN, Ammanii... cit., pp. 224-227 e344; ROSETTI, Istoria... cit., p. 394; CARAGIU MARIOTEANU, Compendiu... cit., p. 225; FERRO, Con-cordanze... cit., p. 251.27 CAPIDAN, Ammanii... cit., pp. 224-226; CARAGIU MARIOTEANU, Fano-morfologie... cit., p. 61;SALA, Contributii... cit., p. 23; FERRO, Concordanze... cit., pp. 240-248,270-271. Da rilevare che laFERRO (ivi, pp. 265-269) inclina a credere che, nelle forme comincianti con as- + C, la vocale a-non sia prostetica, ma rappresenti la regolare evoluzione di EX- latino.28 CAPIDAN, Aromànii... cit., pp. 226-227, 246-247; e soprattutto FERRO, Concordanze... cit., pp.250-253 e. passim, a cui si rimanda per l'analisi complessiva del fenomeno e per alcune ipotesi sul-la sua origine.
132 ALVISE ANDRE9SE
3.4. Meglenoromeno
In meglenoromeno troviamo un triplice esito: a, a, e fi29. Il primo corrispondea a del dacoromeno e dell'aromeno, cioè [a]; il secondo - stando alla descri-zione di Petar Atanasov - è una «vocala semidechisà din serie centrala, cea maideschisà dupà vocala [a]» (forse [B]), che «apare in graiul din L'umnità in pò-sitie initialà, ìnaintea nazalelor [m] si [n] acolo unde in graiurile din Urna siTàrnareca apare de regulà [a]» e che «apare, mai rar, si in celelalte graiuri ìnsàca si in L'umnità tinde a se identifica cu [a]»; il terzo è «cea mai deschisà vo-cala din seria posterioarà» (probabilmente [o]), che costituisce lo sviluppo di atonica in tutte le varietà meglenoromene, ad eccezione di quelle dei centri diUrna e Tàrnareca (cioè a L'umnità, Cupa, Osiri, Birislàv e Lundiri)30. Atanasovconsidera a come una variante posizionale di /a/ (= /a/) che ricorre solo nei pre-fissi àn- a am-31. Diverso è il giudizio di Matilda Caragiu Marioteanu, secondocui Q& a sarebbero allofoni del fonema /a/ (= /a/), che si realizzerebbe come pin posizione tonica, come a in posizione atona, come a all'inizio di parole chein dacoromeno presentano il prefisso in-32. Va detto, tuttavia, che Q e a/a non sitrovano propriamente in distribuzione complementare, perché Q può occorre-re, analogamente a a/a, in posizione iniziale e tonica davanti a -n: cfr. per esem-pio Qns 'ìns' e qntru/àntru 'intra', qmplu/àmplu 'umplu', qmflu/àmflu 'umflu'.Concordiamo, pertanto, con Atanasov33 sul fatto che Q e a debbano essere in-terpretati come fonemi distinti. In conclusione, possiamo dire che in gran par-te del dominio meglenoromeno (L'umnità, Cupa, Osiri, Birislàv e Lundin) nel-le forme derivate da parole latine comincianti con IN-/IM- + C si incontrano duefonemi: lai (cioè /a/), che in questo contesto viene realizzato come q (forse [B]),e /o/ (= /a/). Il primo può ricorrere sia in posizione tonica che atona, il secondosolo in posizione tonica. Nelle varietà più conservative di Urna e Tàrnareca -in cui non si da l'evoluzione /a/ > /$/ - troviamo solo /a/. È ragionevole, dun-que, pensare che, nella fase più antica del meglenoromeno, i continuatori del-le parole comincianti con IN-/IM- + C, della preposizione IN e dei suoi compostipresentassero proprio quest'ultimo fonema iniziale34.
29 TH. CAPIDAN, Meglenoromànii, I: Istoria §i graiul lor, Bucuresti, Cultura nationalà 1925, pp. 109,113; CARAGIU MARIOTEANU, Compendiu... cit., pp. 268-269; P. ATANASOV, Meglenoromàna, in Rusu,Tratat... cit., 476-550, in particolare pp. 486-487; Io., Meglenoromàna astazi, Editura AcademieiRomàne, Bucuresti 2002 [1* ed. in fr.: Le mégléno-roumain de nos jours: une approche linguisti-que, Hamburg, H. Buske 1990 (Balkan-Archiv. Beiheft)], pp. 46-47.30 ATANASOV, Meglenoromàna... cit., pp. 486-487; cfr. anche Io., Meglenoromàna astazi cit., pp. 46-47,150-151 e 153-154.31 Ibidem.32 CARAGIU MARIOTEANU, Compendiu... cit., pp. 268-269.33 ATANASOV, Meglenoromàna... cit., pp. 492-493; Io., Meglenoromàna astazi cit., p. 154.34 Di questa opinione sono anche ROSETTI, Istoria... cit., p. 396, e ATANASOV, Meglenoromàna
LO SVILUPPO DI IN-/ÌM- LATINO IN ROMENO: UN CASO DI RULEINVERSION 133
L'aferesi di lai atona prima di /{n, m}C/ è produttiva anche in meglenoro-meno, anche se - a giudicare dai testi forniti da Capidan e Atanasov - in mi-sura minore che in dacoromeno e istroromeno:
(4) a. ...na-ntribam ùnà-lànta cari ti tirém... ['ne ìntrebam unii pe altii cine ce vrea']b. ...canmi-nfertw... ['cànd ma cert']35
Una regola di cancellazione di lai atona prima di /{n, m}V/ - che oggi sem-bra assente - deve essere stata attiva in una fase linguistica precedente, vista lapresenza di forme aferetiche lessicalizzate come nàlbiri ('inalbi'), napói (ìna-poi'), nàltu ('ìnalt'), nàìntì (accanto a anàinti, 'ìnainte'), nàùntru ('ìnàuntru'),nàfoaralnàfàrà ('afara')36.
4. Ipotesi tradizionali
Sull'esito di IN-/IM- + C, della preposizione IN e dei suoi composti nelle varietàromene esistono molteplici ipotesi, tutte riportabili a due posizioni di fondo37:A) le vocali iniziali che si incontrano in questi contesti sono di origine prostetica;B) le vocali iniziali, laddove si conservano, sono la diretta continuazione di I la-
tina, o meglio - come abbiamo detto sopra - di /e/ del latino volgare e delromeno comune.Esaminiamo prima le spiegazioni inquadrabili in quest'ultimo orientamen-
to. Hans Moser pensa allo sviluppo di un fonema centrale (?) già nel romenocomune, secondo la trafila: lat.volg. en > r.c. \n > r.c. fn38. Alexandru Philippideriporta le vocali ? (= [i]) e a (= [9]) che si trovano in gran parte del dominio ro-
astàzi cit.,p. 154. Diversa è la ricostruzione proposta da CAPIDAN (Meglenoromànii... cit.,p. 98),secondo cui a sarebbe una variante di «un a protetic in locul sunetului ? din m (ìntocmai ca si indialectul aromàn)». Poche pagine più avanti (ivi, p. 109), tuttavia, per giustificare la succitata al-ternanza tra Q e a in contesto /# {n, mCj/, ipotizza la trafila I- > a > o > a/a (INTRO > *antru >*ontru > qntru/antru, ecc.), presupponendo così che o rappresenti uno stadio del fonetismo più ar-caico di q/à. Ma la presenza di a/a in posizione tonica iniziale (qntru, amplii, ecc.) andrà sicura-mente attribuita a fenomeni di attrazione analogica, come, per altro, suggerisce altrove CAPIDANstesso (Meglenoromànii... cit.,p. 98).35 ATANASOV, Meglenoromàna astàii cit, pp. 357-358.36 Ivi, pp. 123,207 e 254.37 Cfr. VASILIU, Fonologia... cit., pp. 63-64.38 MOSER, Der Ursprung... cit., p. 428. Anche in un nostro precedente saggio avevamo accoltoquesta ipotesi ricostruttiva: cfr. A. ANDREOSE, / continuatori romeni del latino ÌPSE, in «Annuariodell'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia», IX (2007), pp. 381-396, in par-ticolare pp. 388-392.
134 ALVISEANDREOS:
meno39 direttamente a /e/ o IH del latino volgare o del protoromeno40. AntonBalotà ritiene che, nel romeno comune, i (< I) davanti a nasale, per un feno-meno di «réduction», sia passata «a un son qui était tout près des valeurs del'échelle du e ferme [...], qui a pu évoluer vers a»: mentre aromeno e megle-noromeno avrebbero perso le tracce «de l'ancien i», in dacoromeno il «son ré-duit» si sarebbe conservato e sarebbe evoluto verso a41. Alexandru Rosetti, in-fine, considera il passaggio di I seguita da -N- e da M + C a i- in dacoromeno, aa- in meglenoromeno e istroromeno, a a o i in aromeno, come «ìnovatiile [...]care s-au desvoltat separat in ficcare dialect [...] potrivit unei tendinte comu-ne de a inova in aceeasi directie»42, tendenza comune che consisterebbe nelpassaggio delle vocali atone a a, e nell'innalzamento di a a i davanti a nasale43.
La debolezza di queste teorie, al di là delle loro differenze, risiede nel fattoche - come abbiamo mostrato al paragrafo 2 - in tutte le varietà romene, al-l'interno di parola, l'esito regolare di /e/ davanti a nasale omosillabica è /i/44. Sesi suppone che ci sia una continuità tra le attuali vocali ali e l'originaria /e/ bi-sogna ammettere che /e/ + /{n, m}C/ abbia avuto sviluppi diversi a seconda chesi trovasse all'inizio o all'interno di parola, e che nel primo contesto l'esito siafoneticamente 'più avanzato' che nel secondo. Il che sembra quantomeno ano-malo, visto che, come è noto, l'inizio di parola non solo costituisce un contestofoneticamente 'non-condizionato' ma anche, in quanto parte del lessema dota-ta di maggiore informatività, presenta di norma una certa resistenza al cam-biamento45.
Secondo l'ipotesi A - sostenuta dalla maggior parte degli studiosi (Can-drea, Densusianu, Schiirr, Puscariu, Capidan, Nandris, Petrovici, Caragiu Ma-
39 Per i dettagli v. sopra parr. 3.1-3.4.40 PHILIPPIDE, Originea... cit., pp. 71-72. Cfr. anche VASILIU, Fonologia... cit, p. 63, che però sem-bra orientarsi verso l'ipotesi dell'origine prostetica di alt. Si noti che PHILIPPIDE (ibidem) alludeanche alla possibilità che la vocale centrale rappresenti il regolare sviluppo di una a iniziale, ana-loga a quella che si incontra in forme come arici < ERICIUM o acel < ECCE ILLUM, arama <AERAMEN.
41 A.B.I. BALOTÀ, La nasalisation et le rothadsme dans les langues: roumaine et albanaise, Bucarest,SOCEC 1926, p. 72. Un'idea analoga si trova già in BYHAN (Die Entwickelung... cit., pp. 61-62), cheipotizza «im rumanischen» (in romeno comune?) l'evoluzione di lat. volg. Iti davanti a nasaleomosillabica a (, cioè a una i «das ursprunglich offener als altes vugarlat. i war» ['che era origi-nariamente più aperta dell'antica i del lat. volg.'].42 ROSETTI, Istoria... cit., p. 393.43 Ivi, pp. 395-396. Cfr. anche ROSETO, Contribiitìons... cit., pp. 99-100,105.44 Cfr. F. SCHÙRR, Zur rumanischen Lautlehre (Noch einmal stella, cubitum, m-, ìfm-j, in «Mittei-lungen des Rumanischen Instituts an der Università! Wien», 1 (1814), pp. 44-55, in particolare p.55. Cfr. anche le osservazioni dì NANDRIS, Phonétique... cit., p. 193.45 Per il romeno, cfr. SALA, Contribuii... cit., p. 21 ss.
LO SVILUPPO DI IN-/IM- LATINO IN ROMENO: UN CASO DI RULE INVERSION 135
rioteanu e altri ancora)46 - le vocali centrali à-/ì- non rappresentano la conti-nuazione di i-, ma sono suoni prostetici inseriti a seguito della caduta della vo-cale iniziale. Questa tesi si basa su due evidenze: in primo luogo sul fatto che,come abbiamo detto, in tutte le varietà romene forme con la vocale inizialecoesistono accanto a forme con aferesi47; in secondo luogo, sulla sistematicacorrispondenza, nei dialetti romeni, tra la vocale che si incontra nei continua-tori di IN, IN-/IM- + C e la vocale prostetica che compare in alcune forme pro-nominali atone (la-3a pers. del pron. personale dat, 3a pers. del pron. pers. acc.,e 3a pers. del pron. rifl. dat.): dr. imi, iti, ìi, il, i$i, istr. àm, àt, al', al, às, megl. àc,àt, ài, al, -, ar. ìc\, il'', il", is'4&. Ma ci sono anche altri dati complementari chepossono essere addotti a sostegno di questa ipotesi. L'aferesi della vocale ini-ziale atona in forme derivate da parole comincianti con IN-/IM- + C e nei conti-nuatori della P IN e dei suoi composti, si incontra anche nelle varietà italianetoscane e centro-meridionali49, cosa che farebbe pensare a una diffusione delfenomeno già nel latino volgare. Anzi, la presenza dell'aferesi nei prestiti lati-ni dell'albanese (mbret < IMPERATOREM, mxoj < INVIDIARE, ngènjej < INGANNA-RE, ngratè < INGRATUS, ndèjej, ndjej < INDULGERE ecc.)50 potrebbe suggerireche, nel latino dell'Europa sud-orientale, la vocale iniziale fosse precoce-mente caduta51. Un ultimo indizio, infine, viene dalla frequente assenza di tn-
461.-A. CANDREA - O. DENSUSIANU, Dictionarul etimologie al limbii romìne. Elementele latine (A-putea), Bucuresti, SOCEC 1907-1914,n. 833;DENSUSIANU,Hìstoire... cit., p. 405; SCHURR, Zur rumà-nischen... cit., p. 55; PUSCARIU, Contributiuni... cit., pp. 391-393; CAPIDAN, Aromànii... cit., pp. 246-247; Io., Meglenoromànii... cit., p. 113; E. PETROVICI, Influente slava asupra sistemului fonemelorlimbii romìne, Bucuresti, Societatea de Stiinte Istorice si Filologice 1956, p. 31; NANDRIS, Phonéti-que... cit., pp. 31,56,193-194; A. AVRAM, Contribuiti la interpretarea grafiei chirilice a primelor te-ste rommesti (V),ìn «Studii si cercetari lingvistice», 15,5 (1964), pp. 575-614, in particolare pp. 594-595; CARAGIU MARIOTEANU, Compendia... cit., p. 226.47 VASILIU, Fonologia... cit., pp. 62-63. Cfr. anche sopra, parr. 3.1-3.4.48 SCHURR, Zur mmànischen... cit., p. 55; PUSCARIU, Contributiuni... cit., p. 393; CAPIDAN, Megle-noromànii... cit., pp. 98-99; CARAGIU MARIOTEANU, Fano-morfologie aromànà... cit., p. 25; EAD.,Compendiu... cit., p. 269; ATANASOV, Meglenoromàna astazi cit., p. 46.49 BYHAN, Die Entwickelung... cit., p. 50; PUSCARIU, Contributiuni... cit., p. 391.50 G. MEYER, Etymologisches Wórterbuch der albanesischen Sprache, StraBburg, K.J. Trubner,1891, s.vv.; H. MIHÀESCU, La romanità dans le Sud-Est de l'Europe, Bucuresti, Editura Academieiromàne 1993, pp. 38,46,53,60; G. BONNET, Les mots latins de l'albanais, Paris, L'Harmattan 1998,pp. 380-381.51 PUSCARIU, Contributiuni... cit., p. 391. Va rilevato, tuttavia, che sulla validità del concetto di la-tinità 'balcanica', 'balcano-dacica', 'balcano-danubiana' diversi studiosi hanno espresso riserve (tracui MIHÀESCU, La romanità... cit., pp. 471-480), cfr. la sintesi di G. IVÀNESCU, Istoria limbii romàne, in-grijirea editici, indice de autori si indice de cuvinte: M. Paraschiv, lasi, Junimea 20002 (la ed. 1980), inparticolare pp. 107-115. Sulla questione si vedano inoltre le puntuali osservazioni di T. FERRO, // les-sico latino dell'albanese:problemi semantici, in EAD., Latino... cit., pp. 148-160 (già in Actes du XVIIPCongrès International de Linguistique et Philologie Romanes (Université de Trèves, 1986),tome I: Romania submersa, section I: Romania nova, Tubingen, Niemeyer 1992, pp. 260-270).
136 ALV1SE ANDREOSE
/im- dopo parola terminante con /n/ nei più antichi testi romeni (per es. dinceput 'din ìnceput', in tuneruc 'in ìntuneric', un pàrat 'un imparat', ecc.) cheviene in genere interpretata come l'effetto di una regola di degeminazione (odi assimilazione e degeminazione nel caso di m) di nasali a contatto a confi-ne di parola (/din nce'put/ -»• [din ce'put], /in ntu'neruc/ -» [in tu'neruc], /unmpa'rat/ -» [un pa'rat])52.
Benché, come si è detto, l'ipotesi A goda del favore della maggioranza de-gli studiosi, pochi hanno tentato di elaborare organicamente una teoria rico-struttiva capace di dare conto dell'articolata situazione che emerge dai dialet-ti romeni antichi e moderni. lon Aurei Candrea e Ovid Densusianu ipotizzanoper il dacoromeno un processo in cinque tappe: 1) la caduta di i- nella prep. in< IN e nei suffissi atoni in-lim- (< IN-, IM-) + C; 2) la generalizzazione dell'afe-resi anche ai casi di in + V; 3) lo sviluppo di una i- prostetica davanti a n-lm- +C; 4) l'estensione di i anche alle forme in cui n era seguita da vocale; 5) l'e-stensione analogica di i alle forme in cui in-, im- erano tonici53. Octavian Nan-dris, basandosi sulla fatto che - come si è detto - nei testi del secolo XVI sidanno forme prive non solo di i- ma anche di n- (ceput, pàrat, tuneruc, ecc.),suppone che, in una fase cronologica precedente, la vocale iniziale etimologicafosse caduta e che nelle sequenze n-/m- + C che si sarebbero formate consc-guentemente, le nasali fossero realizzate come «sonantes». Successivamente,vari fenomeni concomitanti - tra cui «l'amui'ssement du -u final» e «la perte ducaractères de sonante des consonnes nasales» - avrebbero portato alla forma-zione di gruppi consonantici «insolites», a cui la lingua avrebbe posto rimedioattraverso una duplice strategia: sviluppando «une voyelle prothétique», op-pure alleggerendo «le groupe [de consonnes] par la suppression de la conson-ne initiale». Gli antichi testi - in cui prostesi di i- e caduta di n- coesistono - ri-fletterebbero ancora questa duplice tendenza54. Solo in un secondo tempo laprostesi avrebbe prevalso. Anche forme come intru, ìmblu, ecc. si spieghereb-bero, secondo Nandris, tramite l'aferesi e la prostesi55. Più generiche sono lespiegazioni che si incontrano in altri contributi. Friedrich Schiirr ipotizza chegià nel romeno comune fosse produttiva l'aferesi di e- nei prefissi en-/em-(< IN-/IM-) in contesto postvocalico e che, sempre nella fase comune, le formeaferetiche si siano generalizzate56. Sextil Puscariu postula tre fasi: in romeno (co-
52 DENSUSIANU, Histoire... cit., p. 493; NANDRIS, Phonétique... cit., pp. 193-194. Ma sull'interpreta-zione di questo fenomeno si veda quanto detto al par. 5.53 CANDREA - DENSUSIANU, Dictionarul... cit., n. 833, per i punti 1-4); DENSUSIANU, Histoire... cit.,p. 405, per il punto 5).54NANDRIS,Phonétique... cit.,pp. 193-194.55 Ivi, p. 55.56 SCHURR, Zur mmànischen... cit., p. 55.
LO SVILUPPO DI IN-/IM- LATINO IN ROMENO': UN CASO DI RULE INVERSION 137
mune), come anche in albanese e nei dialetti italiani meridionali, la prep. in eil suffisso *in- derivati da IN(-) latino avrebbero perso precocemente la vocaleiniziale; successivamente, quando - soprattutto dopo l'indebolimento di u e ifinali - n-/m- incominciarono a trovarsi sempre più spesso in contesto post-consonantico, si sarebbe sviluppata una vocale iniziale di appoggio; infine, la«confusione» tra forme in cui i- era prostetico (ìncalt < *INCALCIO) e forme incui t- era etimologico (ingust < ANGUSTUM) avrebbe portato alla diffusione del-l'aferesi anche a queste ultime57. Theodor Capidan suppone che il fenomenodell'aferesi sia «stravechiu», in quanto si trova in tutti i dialetti, soprattutto nel-l'aromeno, e che la cancellazione della vocale iniziale davanti a n + V si sia pro-dotta «prin analogie cu formele in care IN era urmat de o consoanà»58. MatildaCaragiu Marioteanu, infine, riprendendo un'idea di Capidan, ritiene che la fre-quente assenza della vocale iniziale davanti a /{n, m}C/ in aromeno rispecchi lasituazione del romeno comune59.
Gran parte di queste affermazioni ci sembrano condivisibili. Appare inne-gabile infatti che:a) la cancellazione di /e/ (< i) in contesto /# {n, m}C/ deve risalire al rome-
no comune, se non addirittura al 'protoromeno' o al latino volgare (Can-drea-Densusianu, Schiirr, Puscariu, Nandris, Caragiu-Marioteanu);
b) il processo di prostesi deve essere anch'esso molto antico (Puscariu);e) la presenza di à/ì in forme che originariamente presentavano IN-, !M- toni-
ci è dovuta a fattori di attrazione analogica (Densusianu);d) l'aferesi nei tipi ingust, intài è 'secondaria', non 'primaria' (Puscariu).
Ci sono, tuttavia, anche alcuni aspetti da rettificare o da precisare. Li illu-striamo brevemente.i. Nel dacoromeno, nell'istroromeno e nel meglenoromeno moderni, non si
ha un processo fonologico di prostesi prima di parola cominciante con /{n,m} C/ e /nV/, ma, viceversa, una regola di cancellazione di ali iniziale da-vanti a /{n, m}C/ e /nV/. Bisogna chiarire, dunque, quando le forme afere-tiche sono state sostitutite nel lessico da forme inizianti con a. o con f.
ii. Candrea e Densusianu ipotizzano che, nella lingua antica, fosse attivo unfenomeno di prostesi nel contesto /# {n, m} C/, che poi sarebbe stato este-so al contesto /# nV/. Un processo del genere si configura come una re-gola fonologica post-lessicale. Ora poiché questo tipo di regole - secondoil modello teorico vigente - può avere accesso solo a informazioni sintat-tiche 'superficiali' e non a informazioni afferenti a componenti più 'astrat-
57 PUSCARIU, Contributiuni... cit.,pp. 391-393.58 CAPIDAN, Aromànii... cit, pp. 246-247; Io., Meglenoromànii... cit., p. 113.59 CARAGIU MARIOTEANU, Compendiu... cit., p. 226; cfr. anche nota 70.
138 ALVISE ANDREOSE
ti' della grammatica come lessico e morfologia, ci aspetteremmo che laprostesi si realizzasse in tutti i contesti del tipo /# nV/. In altre parole,per limitarci al solo dacoromeno, dovremmo avere oltre a (ì)nalt, (ì)napoi,(t)nainte (e (i)mpàrat, (i)ntreg, (ì)ncepe) - derivate da forme che in latinopresentavano I + -N-/-M— anche casi di *ìnas accanto a nas < NASUM,*ìnoapte < NOCTEM accanto a noapte, *ìnume accanto a nume < NOMEN, ecc.Questo, tuttavia, non si verifica mai. La presenza della vocale centrale pro-stetica nei tipi inali, ìnapoi, ìnainte, ecc., deve dunque essere spiegata inmodo diverso.
iii. La teoria di Capidan, secondo cui l'aferesi davanti a /nV7 si realizzerebbeper analogia a quella prima di /nC/ da conto (per altro approssimativa-mente) di forme come nalt, napoi, nainte, ecc. ma non di forme come ìnalt,ìnapoi, ìnainte, ecc.
iv. La teoria di Nandris, che postula che nel dacoromeno del XVI secolo fosseancora produttiva una regola di prostesi, non giustifica né le une, né le altre.
v. La presenza di una vocale centrale non etimologica in sillaba iniziale to-nica, cioè in un contesto in cui l'aferesi non era possibile (per es., dr. ìns,istr. àns, megl. onslàns, ar. nàs/nàs < *!N(p)suM60 (per IPSUM), dr.a. intrultn-trà megl. qntru/àntru 'intru/intrà' < INTRO/INTRAT, dr.a. ìmplu megl.qmplu/àmplu 'umplu' < IMPLO, istr. ànflu megl. qmflu/àmflu 'umflu' < IN-FLO, ecc.) si spiega solo postulando una sua precoce fonologizzazione. Nonè verosimile che, come vuole Nandris, essa sia stata inserita a seguito diaferesi, visto che esiste una tendenza generale delle lingue a evitare la can-cellazione di una sillaba tonica, soprattutto se iniziale61.
vi. Se, come ipotizzano alcuni studiosi, l'aromeno rispecchiasse la fase in cuinon si era ancora sviluppata una vocale prostetica, forme come ar. nel'ìnel', nàmal'ìtJnumal'u/ nimal'ù 'oaie', ntànù 'ìntai' sarebbero difficili dagiustificare. All'origine di questi termini, infatti, si postulano rispettiva-mente il r.c. */s'nel/ (< ANELLUM), */3n9'maA"u/ (< *ANIMALIUM o forse co-struito sul pi. */9n9'maA~e/ < *ANIMALIAE per AMMALIA)62, */3n't3jiu/ (< *AN-TANEUM), in cui /a/ iniziale rappresenta la regolare evoluzione di A latinadavanti a N. Il fatto che l'aferesi abbia toccato anche forme in cui la voca-le centrale iniziale è etimologica, dimostra che anticamente anche in aro-meno era produttiva una regola di cancellazione analoga a quelle che si in-contrano oggi in dacoromeno, istroromeno e meglenoromeno.
60 Sull'origine di queste forme si veda ANDREOSE, / continuatori... cit.61 Casi di aferesi delle P intra, ìntre non rappresentano un'eccezione a questa tendenza, perchévari paralleli con le varietà italiane toscane e centro-meridionali inducono a ritenere che già nellatino volgare le P INTRA, INTRO fossero diventate alone.62 Cfr. anche megl. nàmal'u e dr. dial. [Bànat] nomai.
LO SVILUPPO DI IN-/IM- LATINO IN ROMENA UN CASO DI RULE INVERSION 139
5. La fonologizzazione di a- come conseguenza di mie inversion
Un modo per sciogliere tutti i nodi problematici visti sopra, è quello di pensa-re che, già nel romeno comune, la vocale centrale prostetica inserita davanti aparole comincianti con /{n, m}C/ si fosse fonologizzata a seguito di un proces-so di 'inversione di regola' (ingl. rule inversion). Questo fenomeno, che - comeè emerso a partire dagli studi di Theo Venneman - è uno dei principali re-sponsabili del mutamento fonologico, comporta che, in presenza di una deter-minata regola fonologica, il rapporto tra forma sottostante e forma derivatavenga rianalizzato da una nuova generazione di parlanti, di modo che 1''outputsia reinterpretato come input e l'input come output63. Partiamo dall'assuntoche in una prima fase del romeno comune (fase A) fossero presenti delle for-me lessicali comincianti con i nessi consonantici /nC/, /mC/, diacronicamentederivate da parole che in latino cominciavano con IN-, IM- atoni (> lat. volg. /en-/,/em-/) + C: /nteeìeg/ < INTELLIGO, /mpa'rat/ < IMPERATOREM, ecc. Da queste for-me 'sottostanti' potevano essere ricavate, per un processo di inserzione vocali-ca (regola a) atto a ripristinare la corretta struttura sillabica iniziale, le forme'derivate' con [9] prostetica: /ntee'leg/ -> [antee'leg]; /mps'rat/ -* [ampa'rat]. Inuna seconda fase (fase B), queste ultime sono state reinterpretate come forme'sottostanti', da cui ricavare, per un processo di aferesi (regola b), le forme 'de-rivate' aferetiche: /sntee'leg/ -» [ntee'leg]; /smpa'rat/ -» [mpa'rat]. I contesti diapplicazione delle due regole sono opposti: la regola (a) si applica ad inizio difrase oppure quando la parola precedente non esce in vocale; viceversa, la re-gola (b) è bloccata a inizio di frase e si applica solo se la parola precedente escein vocale:
regola (a) /tu nteeìedji/ /el ntee'lec%e/ input- el sntee'lecfee regola di prostesi
[tu ntee'ledji] [el antee'ledje] output
regola (b) /tu antee'ledji/ /el antee'ledje/ inputtu ntee'lecfei - regola di aferesi[tu ntee'lec^i] [el antee'lecfee] output
63 T. VENNEMANN, Rule inversion, in «Lingua», 29 (1972), pp. 209-242; per una panoramica suglistudi sul fenomeno e per un suo inquadramento all'interno della 'teoria dell'ottimalità' si veda lasintesi di R. BERMUDEZ-OTERO - R.M. HOGG, The. actuation problem in Optimality Theory: pho-nologization, rule inversion, and rule loss, in D.E. HOLT (ed.), Optimality Theory and LanguageChange, Dordrecht - Boston, Kluwer Academic 2003 (Studies in Naturai Language and Lingui-stic Theory, 56), pp. 91-119, in particolare pp. 99-102.
140 ALVISE ANDREOSE
Anticipare la fonologizzazione della vocale prostetica già alla fase del ro-meno comune presenta tre notevoli vantaggi dal punto di vista esplicativo. Inprimo luogo, permette di spiegare agevolmente quei processi di attrazioneanalogica che, in un secondo periodo della fase B, hanno fatto sì che la vocalecentrale si diffondesse in forme che in origine non avevano subito l'aferesi,cioè in parole comincianti con IN-/IM- tonico (dr. ìns istr. àns megl. onslàns <*INSUM, ecc.). In secondo luogo, consente di giustificare l'applicazione della re-gola di aferesi anche a quelle forme in cui à/i non è di origine prostetica, marappresenta la regolare evoluzione di A + -N, -M (per es. dr. ìngust ar. ngust istr.àngust < ANGUSTUM, dr. ìntài ar. ntàriù < *ANTANEUM, ecc.): la 'nuova' regola diaferesi (regola 6), nel momento in cui venne introdotta, operò su tutte le for-me che presentavano un determinato contesto sintagmatico (cioè cominciava-no con /a/ atono + nasale omosillabica), non solo su quelle che erano prece-dentemente interessate dalla 'vecchia' regola di prostesi (regola a). Infine, l'i-potesi sopra esposta permette di spiegare economicamente il fatto che tutte levarietà romene - con l'apparente eccezione deh" aromeno, di cui parleremo trapoco - possiedono la stessa regola fonologica di aferesi: si tratta infatti di unprocesso produttivo già nella loro fase comune, che poi esse hanno ereditato.
Riassumiamo schematicamente le fasi evolutive che hanno portato da IN-,IM- latini alle forme attuali.
I. Fase a: latino volgare, protoromeno o romeno comuneÈ presente una regola di aferesi nelle forme comincianti con /enC/, /emC/(< IN-, IM- + C) e nella P /en/ (< IN) che prevede la cancellazione della vo-cale iniziale in contesto atono e postvocalico:
fmlc[- acc] In J
IL Fase A: romeno comuneLa regola di aferesi (a) cessa di essere produttiva; conseguentemente:a) le forme aferetiche vengono rianalizzate come forme lessicali sotto-stanti (per es. /ntee'leg/, /mps'rat/);b) viene introdotta una regola di prostesi volta a produrre strutture silla-biche canoniche ad inizio di frase e dopo parola uscente in consonante:(a) 0 ^ 3 / ( c # l _ Imi C
1## I [-acc] UJ
III. Fase B: romeno comunea) le forme comincianti con h/ vengono reinterpretate come forme lessi-cali sottostanti e si realizza un'inversione di regola:
LO SVILUPPO DI IN-/IM- LATINO IN ROMENO: UN CASO DI RULE INVERSION _ 141
m C[-acc]n
b) la regola di af eresi (regola b) viene applicata anche a la/ di origine non-prostetica: *ANTANEUM > re. */3n'tqriu/ (> dr. intdi, ar. ntànu) -» *[n't9jiu];ANGUSTUM > r.c. */9n'gustu/ (> dr. ìngust ar. ngust istr. àngust) -» *[n'gustu].e) per processi analogici hi iniziale si propaga a forme comincianti con IM-/IN tonico (*!NSUM > r.c. */ensu/ -» r.c. */9nsu/, INFLO > r.c. */emflu/ -»r.c.*/9mflu/, IMPLO > r.c. */emplu/ -» r.c.*/9mplu/, ecc.).
IV. Fase C: dialetti romenia) la regola (b) amplia il proprio ambito di applicazione, estendendosi an-che al contesto /V#_nV/:(c)s->0/V# _ m CJ
[- acc] *• n 'Per es. r.c. */9na'inte/ -» r.c. *[na'inte] (cfr. megl. nàìnti, dr.a. e dial. nainte, ar.nànte/ninte); ANELLUM > r.c. */9'nel/ -*• r.c. *[nel] (cfr. ar. e dr.a. nel), ecc.;b) in dacoromeno e nelle varietà aromene meridionali /a/ davanti a nasa-le si innalza a /i/ (grafia i).
V. Fase D: istromeno (aromeno antico?)La regola (e) amplia ulteriormente il proprio ambito di applicazione,estendendosi anche al contesto postconsonantico:(d) a -* 0 / # (m ci
- i f[- acc] l n >
V3'8. Fase Dbìs: Aromeno, alcuni dialetti dacoromeniLa regola (e) - o (d), v. avanti - cessa di essere produttiva; conseguentemente:a) le forme aferetiche vengono interpretate come forme lessicali sotto-stanti (per es. /ntee'leg/, /mpa'rat/);b) viene introdotta una regola fonologica che prevede che /n/ venga realizza-ta come sillabica in contesto postconsonantico e a inizio assoluto di frase:
#l _ C# J
VI. Fase E: aromeno meridionaleNelle varietà aromene meridionali (e solo in parte in quelle settentriona-li) viene introdotta una regola di prostesi (regola e) davanti a parole co-mincianti con consonante doppia o lunga (ICC/, /CJ):
142 ALVISE ANDR^OSE
CCÌ## j [-acc] lC: J
Prima di passare a considerare alcuni aspetti della nostra ipotesi che po-trebbero sembrare problematici, è opportuno spendere qualche parola sullecause che hanno determinato il passaggio dalla regola (b) alla regola (e) (fa-se C, n. IV, a). La presenza di à-/ì- nei composti formati da 'IN + tema comin-ciante in vocale', e la loro inclusione nella classe delle forme soggette a afere-si vengono attribuite da quasi tutti gli studiosi all'analogia64. Alcuni elementi,tuttavia, ci spingono a orientarci verso un'altra spiegazione. Va rilevato, in pri-mo luogo, che nel dacoromeno antico e in numerosi dialetti dacoromeni mo-derni, forme come inali, malta, ìnainte, ìnapoi, ìnapoia, ecc. figurano anche invarianti con n geminata65; in secondo luogo, che nel toscano e nelle varietà ita-liane centromeridionali è largamente documentato un fenomeno di allunga-mento di /n/ prevocalica a confine di morfema e di parola (cioè, più in genera-le, di 'parola fonologica': cfr., per esempio, it. innanzi < IN + ANTE o IN + *AN-TEIS, innalzare < IN + *AL,T!ARE, innamorare < IN + *AMORARE, it. a. inn alto; it. a.conn il...; it. a. nonn è, fior. mod. [un: e] 'non è', ecc.)66, che sembrerebbe avere
64 Data l'impossibilità di accettare le spiegazioni di Candrea-Densusianu e Capidan (v. sopra par.4, punti ii) e rii)), l'unico modo per giustificare su base analogica questi dati è quello di supporreche il comportamento dei composti del tipo 'IN + V si sia conformato a quello della P 'in'. Poi-ché, nella fase a, en (< IN) non occorreva nella frase necessariamente sempre prima di C, si puòipotizzare che coesistessero due allomorfi: /n/ in contesto preconsonantico, /en/ in contesto pre-vocalico; e che in un secondo momento, la prima forma abbia prevalso sulla seconda, come del re-sto suggerisce il fatto che, in tutte le varietà romene, l'esito di IN coincide con quello di IN-/IM- aloni+ C (dr. in, ar. àn, n, megl. qn, àn, istr. àn). Quando, nella fase A, fu introdotta la regola di prostesi, laforma 'sottostante' /n/ sarebbe slata realizzata come [sn] in contesto /{##, C#j CI, e come [n] neglialtri contesti, cioè /V# {V, C}/. Si può supporre che, nella fase B, in seguilo alla mie inversìon, en-Irambi gli outputs si siano lessicalizzali, dando luogo così a una coppia di varianti la cui distribuzio-ne era governata da una regola di allomorfia sintagmatica: [sn] in contesto /{##, C#) CI, [n] in con-testo /V# {V, C}/. Questa regola sarebbe passata anche ai composti di IN (r.c. */sn'alt/, */sna'poj/,*/3na'inte/, ecc.), e poi sarebbe slala estesa per analogia a forme in cui /an/ era etimologico (/a'nel/< ANELLUM), producendo così il Irapasso dalla regola (b) alla regola (e). Non si può escludere, tulta-via, che l'alternanza tra [n] e [sn] nella fase A sia stala rianalizzata già nella fase B come l'effetto diuna regola di aferesi che ammetteva la cancellazione della vocale iniziale anche prima di /nV7. Inquesto caso, verrebbe meno la distinzione Ira fase B e C e bisognerebbe ammettere che la regola(b) abbia assunto ab origine il contenuto descrittivo della regola (e).65 BALOTÀ, La nasalisation... cit, pp. 40-41; AVRAM, Interpretar'ea... cit, p. 15; ID., Contribuii... (V)cit, p. 598. Si vedano anche le voci rispettive del DLR cit., lili.66 Cfr. V. FORMENTIN, Un fenomeno di giuntura italo-romanzo: il rafforzamento prevocalico dellaconsonante finale nei monosillabi, in «Lingua nostra», 58 (1997), pp. 90-104. Secondo Formentin,il fenomeno avrebbe riguardato anticamente anche le varietà ilaliane settentrionali: cfr. Io., Uncaso di geminazione fonosintattica negli antichi e nei moderni dialetti settentrionali, in A. DANIELE(a cura di), Antichi testi Veneti, Padova, Esedra 2002 (Filologia venata, VI), pp. 25-40.
LO SVILUPPO DI IN-/IM- LATINO IN ROMENO: UN CASO DI RULE INVERSION 143
un'origine molto antica, databile probabilmente «a una fase pre- o protoro-manza»67. Si potrebbe pensare, pertanto, che questa regola fonologica esistes-se anche nel latino volgare dell'Europa sud-orientale e che, in seguito, sia sta-ta ereditata dal romeno comune. Naturalmente, essa doveva valere solo per ilmonosillabo IN, dato che la -n di CUN (< CUM) e di NON era caduta precocemen-te68. In quest'ottica, l'aferesi delle vocale iniziale e poi l'inserimento di una vo-cale centrale prostetica nei composti del tipo 'IN + V si spiegherebbero comeregolari prodotti delle regole (a) e (a): Fase a /en + alt/ -> /en'nalt/ -» [malt];Fase A /nalt/ -» [sn'nalt]; Fase B /an'nalt/ —> [rtalt], ecc. Successivamente, lacomparsa di altri cambiamenti fonologici - la cessazione della citata regola diallungamento di /n/ prevocalica e/o la defonologizzazione dell'opposizione tra/a/ e /n/69 - avrebbero fatto sì che forme aferetiche come (n)nalt, (n)nainte,(n)napoi, ecc. venissero reinterpretate come risultati di una regola fonologicache ammetteva la cancellazione della vocale iniziale anche in contesto prevo-calico, producendo così il passaggio dalla regola (fc) alla regola (e).
Una prima obiezione che si potrebbe muovere alla nostra ricostruzione è cheessa postula che l'aromeno sia passato per le fasi B e C, quando invece le fa-si Dbìs/E possono benissimo essere spiegate a partire dalla fase A10. Questoperò non è esatto. Nelle varietà aromene settentrionali, che sono le più con-servative, si incontrano, accanto a forme con prostesi di a-, anche parole co-mincianti con i-: i pronomi atoni in', ìf, il'' e, appunto, i composti col prefisso
67 FORMENTIN, Un caso... cit, p. 33; cfr. anche Io., Un fenomeno... cit, p. 100 e soprattutto p. 102(«l'origine della regola di risillabificazione fonosintattica [...] si dovrebbe ricondurre [...] al mo-mento della generale caduta delle consonanti finali latine nell'Italia centrale e meridionale, cioè,con ogni verosimiglianza, già al periodo del latino volgare»).68 In tutte e quattro le varietà romene si trovano nu (< NON) e cu (< CUN < CUM), cosicché apparelogico concludere che in queste forme la -n mancasse già nel romeno comune. Un parziale ri-scontro è fornito dai composti cuprinde (< CUM + PREHÉNDÈRE), cutremura (< CUM + *TREMOLÀRE),cuveni (< CUM + VENIRE), cuceri (< CUM + *QUERTRE) ecc., comuni a tutto il dominio romeno, chedevono essere stati creati a parire da cu e non da cun. Cfr. ROSETTI, Istoria... cit., p. 160; NANDRIS,Phonétìque... cit,pp. 118-119.69 L'opposizione tra /rt/ e /n/ - che sicuramente era presente in romeno comune - è stata neutra-lizzata abbastanza presto in aromeno e meglenoromeno, mentre si è conservata più a lungo in da-coromeno e istroromeno. Cfr. J.-A. CANDRÉA-HECHT, Les éléments latins de la langue roumaine: leconsonantisme, Paris, Emile Bouillon 1902, pp. 76-77; DENSUSIANU, Histoire... cit., p. 411-412,481-482; PHILIPPIDE, Originea... cit., pp. 15-16; ROSETTI, Istoria, pp. 127, 260; SALA, Contribuii..., pp.45-49,54-60.70 Come si è detto sopra, questa opinione è sostenuta, per esempio, da Matilda CARAGIUMARIOTEANU (Compendiu... cit., p. 226), che considera l'assenza di I- in aromeno come un «fe-nomen arhaic». Secondo la studiosa «faptul ca f nu poate fi distribuit la initialà» sarebbe «etimo-logie (situatie caracteristicà si pentru romàna comuna».
144 ALVISE ANDREOS:
m-11. Ora, poiché è improbabile che - dal punto di vista sincronico - si tratti diuna seconda vocale prostetica, utilizzata solo per alcuni lessemi, ci sembra piùverosimile che queste forme siano 'fossili' della fase B. Ma c'è un secondo in-dizio ancora più solido a conferma della nostra idea. Come abbiamo già anti-cipato alla fine del paragrafo 4 (punto v)), la presenza nell'aromeno di formecome ntànù 'ìntai', nel 'inel' e namal'u/numal'ù/ numal'ù presuppone che essosia passato per le fasi B & C.
Un altro dato che potrebbe sembrare in contrasto con la nostra ipotesi èrappresentato dai numerosi casi di 'caduta di in-lìm- dopo /n/ che si riscontra-no nei primi testi romeni: din ceput 'din ìnceput', un parai 'un imparai', in tu-neruc 'in ìntuneric', ecc.72 Il modo più economico di interpretare queste formeè certo quello di considerarle come casi di degemmazione (o, nel caso di m, diassimilazione e degemmazione) di due nasali a contatto davanti a C: /din nce'-put/ -» [dince'put], /in ntu'neruc/ -» [intu'neruc], /un mpa'rat/ -* /um mpa'rat/-» [umpa'rat], ecc.73 Ora, ipotizzare che, nel secolo XVI, le forme sottostantifossero /nce'put/, /ntu'nerec/, /mpa'rat/ come fanno alcuni studiosi74, appari-rebbe in contrasto con quanto abbiamo detto sopra, perché vorrebbe dire che,a questa altezza cronologica, il dacoromeno si trovava ancora nella fase A, incui era attiva una regola di prostesi (a), non di aferesi (b). Vari fenomeni pre-senti già nei testi antichi, tuttavia, ci portano a escludere categoricamente que-st'ultima eventualità: l'estensione analogica di /i/ a sillabe toniche (insù 'dan-sul', ìmplu 'umplu', ìntru 'intra' ecc.), la presenza di /i/ e la sua cancellazioneanche in contesto /#___nV/ (ìnalt/nalt, inainte/nainte, ecc.), la diffusione dell'a-feresi anche a /i/ di origine non-prostetica (nel < inel < ANELLUM, oggi 'inel',ecc.). Pertanto, sintagmi come din ceput, un parai, in tuneruc devono esserespiegati in altro modo. Il fatto che - come rileva Densusianu75 - questo feno-meno non si verifichi praticamente mai quando in è seguito da una vocale op-pure quando in rappresenta lo sviluppo di AN-, induce a ritenere che il dacoro-meno antico conservasse una particolarità fonologica arcaica, anteriore alla fa-se B. Si affaccia, dunque, l'ipotesi che la regola vista sopra, che prevedeva la
71 PAPAHAGI, Dicfionarul... cit., p. 584 («In aceste pozitii, aceastà vocalà constituie o caracteristicàa aromìnei nordice. In aromìna sudicà acest in- e, in generai, inexistent»). Cfr. anche CARAGIUMARIOTEANU, Fano-morfologie aromàna... cit., p. 25. Per le forme pronominali, v. CAPIDAN,Aromànii... cit., pp. 408-411, SARAMANDU, Aromàna... cit., pp. 442-443.72 DENSUSIANU, Histoire... cit., p. 493.73 Ibidem', NANDRIS, Phonétique... cit., pp. 193-194.74 NANDRIS, Phonétique... cit., pp. 193-194. Questa è in sostanza anche l'ipotesi di Andrei AVRAM(Contributiì... cit., pp. 594-595), secondo cui, nel romeno del secolo XVI, alla base dell'alternan-za tra ìn-/tm- (o àn-/àm-) e n-/m-, ci sarebbe stato un 'arcifonema' di tipo nasale /N/ che, a secon-da dei contesti, poteva essere realizzato come [n], [n], o come [in], [anj.75 DENSUSIANU, Histoire... cit., p. 493.
LO SVILUPPO DI IN-/IM- LATINO IN ROMENO: UN CASO DI RULE INVERSION 145
^geminazione di due nasali a contatto a confine di parola, fosse attiva già nel-la fase A del romeno comune e si applicasse prima della regola di prostesi (re-gola a), escludendo, in questo modo, la possibilità che l'inserzione della vocaledi appoggio avvenisse dopo nasale:
/din # nce'put/dince'put
[dince'put]
/## nce ' put/ /la nce ' put/
[lance'put]ance'put[ance'put]
inputregola dì degeminazioneregola dì prostesi (a)output
Partendo da tale assunto, la situazione del dacoromeno del secolo XVI puòessere spiegata in due modi diversi. Si può pensare anzitutto che, nella succe-siva fase B, la reinterpretazione di questi outputs abbia portato a includere trai contesti di applicazione della 'nuova' regola di aferesi (regola b) anche la po-sizione dopo /n/:
(b') a -* 0 / n # .[- acc] I n
m C
Naturalmente, se si accetta questa ipotesi, bisogna ammettere che, nel da-coromeno, la regola (b') a un certo punto abbia cessato di operare, e che, neglialtri dialetti romeni, essa non fosse già più produttiva al tempo delle prime te-stimonianze scritte (secolo XVIII per l'aromeno, secolo XIX per il megleno-romeno e l'istroromeno).
In alternativa, si può ipotizzare che tuneruc, ceput, pàrat, ecc. rappresentinodelle forme lessicalizzate, prodottesi per 'rianalisi' già nella fase A:
/din # nce'put/ /un # mpa'rat/ /in # ntu'neruc/ inputdince'put umpa'rat ìntu'neruc regola di degeminazione[dince'put] [umpa'rat] [intu'neruc] output
/din # ce'put/[dince'put]
/un # pa'rat/[umpa'rat]
rianalisi J,
/in # tu'1 nenie/[intu'neruc]
inputoutput
Due dati depongono a favore di quest'ultima ricostruzione: in primo luogo,la 'caduta' di in-lìm- riguarda una serie limitata di lessemi (pàrat, paratile, tune-ruc, ceput e pochi altri); in secondo luogo, essa ricorre talvolta in un contesto
146 ALVISE ANDREOS^
sintagmatico in cui né nella fase A, né nella fase B sarebbe stata giustificata,cioè dopo vocale: la paratiti, dintru tunerecu, ecc.76
6. Tendenze attuali
Secondo la nostra analisi, l'aromeno si trova in uno stadio più 'avanzato' (fasiDbis, E) rispetto alle altre varietà romene, in quanto ha perso la regola (e) e haacquisito nel lessico - come già era successo nella fase aurorale della lingua ro-mena (fase A) - le forme aferetiche. Questa situazione si riscontra anche in al-cuni dialetti dacoromeni77. La catena dei mutamenti fonologici, tuttavia, non siè fermata. Soprattutto nelle varietà aromene meridionali, che sono sicuramen-te le più innovative, la regola di prostesi (e) ha ampliato il proprio contesto diapplicazione, dato che la vocale d'appoggio si incontra, oltre che davanti a in-cipit sillabici 'irregolari' come /#{n, m}C/, f#rJ /#sC/, anche davanti a lessemi checominciano con /CV/: afum 'funi', ahimè 'lume', amare 'mare', anostru 'nostra',ecc.78
La fase D, che comporta l'estensione dell'aferesi anche al contesto post-consonantico, potrebbe essere l'anello di congiunzione tra la fase più antica C- conservata nel dacoromeno standard e in parte nel meglenoromeno - e le fa-si più 'avanzate' rappresentate dalParomeno (Dbis, E). Se così fosse, l'istroro-meno si troverebbe in uno stadio evolutivo 'intermedio' tra dacoromeno/me-glenoromeno e aromeno. Si tratta tuttavia solo di una ricostruzione ipotetica,visto che non abbiamo dati che ci permettano di stabilire se l'aromeno sia pas-sato realmente per la fase D.
Il meglenoromeno si trova sostanzialmente nella fase C, anche se oggi ap-pare orientato verso l'eliminazione (o comunque verso l'indebolimento) delprocesso di aferesi (regola e). Si noti che, diversamente che in aromeno (cfr. fa-se Dbis, punto a), questo fatto non sembra aver comportato la lessicalizzazionedelle forme aferetiche. Gli unici lessemi che si sono cristallizzati nella variantepriva della vocale iniziale sono quelli che presentano /n/ + V (nàlbiri, nàpói,nàltu, naùntru, nàfoàralnàfàrà, ecc.).
Il dacoromeno si presenta - limitatamente a questo aspetto - come la va-rietà romena più conservativa, in quanto è rimasto nella fase evolutiva più ar-
76 Questa è, nella sostanza, anche l'ipotesi di DENSUSIANU, Histoire... cit, p. 493.77 PUSCARIU, Contribufiuni... cit., p. 392; LOMBARD, La prononciation... cit., p. 113; AVRAM, Inter-pretarea... cit., p. 11.78 CAPIDAN, Aromànii... cit., pp. 224-225; v. anche FERRO, Concordanze... cit., pp. 250-251, e sopra 3.3.
LO SVILUPPO DI IN-/IM- LATINO IN ROMENO: UN CASO DI RULE INVERSION 147
caica. Ciò dipende senz'altro dal fatto che - a differenza di aromeno, istroro-meno, meglenoromeno (ma anche dei suoi dialetti) - esso è andato incontro,tra XVI e XX secolo, a un processo di codificazione e standardizzazione chene ha rallentato - o 'coperto' - certe tendenze di sviluppo. Quale sia il trend inatto, appare difficile da stabilire. Solo un'osservazione nel lungo periodo, in-fatti, ci permetterà di capire se questa situazione sia stabile, oppure se costi-tuisca soltanto una tappa in una plurisecolare catena di mutamenti fonologiciche ha preso avvio nella tarda latinità.