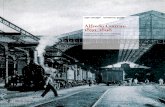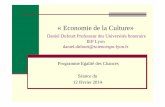2012 Economie a confronto nell'Italia centro-settentrionale
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of 2012 Economie a confronto nell'Italia centro-settentrionale
This license lets others distribute, remix, tweak, and build upon my work, even commercially, as long as they credit me for the original creation.
Ideato da
Roberto Dottarelli
In un lavoro di qualche anno fa (Cattani 2008), era stata proposta in via sperimentale la ricostruzione delle modalità del controllo del territorio che desse ampie garanzie di rendita del terreno. Era quindi stata definita una ripartizione del territorio in campi coltivati, all’interno di un raggio di 1200 metri (450 ha.), un’area intermedia destinata al pascolo, che poteva servire
Economia e gestione del territorio Maurizio Cattani e Marco Marchesini
anche da rotazione alle colture cerealicole tenute a riposo ed infine una zona periferica da lasciare a bosco. Il sistema di controllo delle risorse doveva essere più dinamico rispetto a questa ipotesi con temporanee e diverse destinazioni d’uso, come le espansioni del terreno coltivato con una sempre più consistente riduzione del bosco.
Il modello interpretativo presuppone che: 1) tutti i siti siano coevi, 2) che ogni villaggio sia tendenzialmente autosufficiente (“si sviluppa
un’eccezionale produzione artigianale locale rappresentata da abbondantissima ceramica, oggetti di osso e di corno, oggetti di metallo, strumenti in legno e in fibre vegetali … comunque destinata a soddisfare esigenze locali e difficilmente ad
Considerazioni sulle ipotesi di Maurizio Cattani e Marco Marchesini
essere trasformata come benedi scambio, se non per ambiti microregionali (Cardarelli 2009, p.46).”),
3) che ogni gruppo residen-ziale avesse a disposizione tutte le risorse necessarie per la propria sussistenza.
Ora, sebbene l’habitat sia privo di specificità, è difficile pensare che ogni gruppo riuscisse a procurarsi tutte le materie prime all’interno del territorio a disposizione, tanto più considerando le distanze tra gli abitati: da 2,5 a 3,5 km. cioè meno di mezz’ora di cammino.Anche nella ricostruzione dell’area d’influenza insediamentale elaborata col Gis si può notare una “svista” di notevole importanza: i cerchi intorno all’insediamento non tengono conto della presenza dei corsi d’acqua, che
Considerazioni sulle ipotesi di Maurizio Cattani e Marco Marchesini
potevano costituire un importante limite geogra-fico allo sfruttamento del territorio. Piuttosto gli Autori avrebbero dovuto ipotizzare areali che sfruttavano il territorio disponibile sul lato del fiume dove insisteva l’insediamento.
Approccio Comparativo
Alle supposizioni degli archeologi, proviamo ad accompagnare le ricostruzioni storiche relative ad altri periodi e, in particolare, al Medioevo.
Le origini dell’economia europea George Duby
L’aspetto del paesaggio riflette non solo la densità del popolamento e lo stato dell’attrezzatura, ma anche il sistema di coltivazione, che a sua volta dipende dalle tradizioni alimentari. (p.22)Questo paesaggio, il cui elemento base è il campo permanente, era stato inizialmente [durante l’impero romano] predisposto in funzione di un’agricoltura di pianura… In questo sistema la produzione del grano si basava su una rotazione biennale delle colture: la terra che in un determinato anno aveva fornito le messi veniva lasciata a riposo… sul maggese si seminavano soltanto pochi legumi… L’ager contrastava energicamente con il saltus, la zona lasciata al bestiame. (p.23)
VII-VIII sec. d.C.
Le origini dell’economia europea George Duby
Nel saltus, si conservavano forme primitive di insediamento anteriori alla conquista romana, piccoli villaggi di montagna collocati sul fianco di antichi sentieri. (p.26)Impercettibilmente, le zone basse dell’ager si spopolavano e cadevano nell’abbandono completo…La decadenza di Roma, così, si manifestava nel ripristino di tipi di villaggio e di pratiche colturali che si erano precedentemente affermate, non già in funzione dell’ager, ma del saltus… (p.27)
VII-VIII sec. d.C.
Alimentazione e cultura nel Medioevo Massimo Montanari
Relativamente all’Italia del Nord, i cereali perdono nell’alto Medioevo quella centralità produttiva e alimentare di cui avevano indubbiamente goduto in epoca romana; sia perché si assiste a un crollo clamoroso della produzione di frumento, surclassato nella nuova economia di sussistenza da una molteplicità di grani inferiori – di semina autunnale, come la segale, l’orzo, la spelta, o primaverile, come il miglio, il panico, il sorgo – di minori esigenze colturali e di maggiore rendimento unitario (p.124)
IX-X sec. D.C.
Alimentazione e cultura nel Medioevo Massimo Montanari
Nella Valle Padana, senza dubbio la zona d’Italia più «naturalmente vocata» alla cerealicoltura, nell’alto Medioevo, il diffondersi di un modello produttivo e mentale barbarico-continentale si accompagnò a forme d’uso di quel territorio fortemente improntate all’economia silvo-pastorale. (pp.125-6)
IX-X sec. D.C.
Le origini dell’economia europea George Duby
I paesaggi di tipo germanico [erano caratterizzati da piccole] tenuteagricole, atte a nutrire non più di una ventina di persone: eppure qui il terreno è particolarmente fertile e facile da lavorare…Gli archeologi descrivono gli arativi [intorno a ciascuna tenuta] come isole assai ristrette, non più estese di una decina di ettari… [ca. 300 x 330 metri piani] Questo coltivo di irrisoria estensione era coperto innanzitutto dagli orti situati nelle immediate vicinanze delle case. (p.28)
VII-VIII sec. d.C.
Le origini dell’economia europea George Duby
Al di là dello spazio vitale destinato all’orticoltura (a una coltura, cioè, che il concime e il lavoro manuale rendeva permanente), si stendeva una zona in cui al rothum [campi abbandonati] si affiancavano i nova, le terre recentemente rimesse a coltura. Appena su queste la semente cominciava a germogliare, erano innalzati dei «segnali» che vi proibivano l’accesso… (p. 29)
VII-VIII sec. d.C.
Le origini dell’economia europea George Duby
L’area entro la quale i singoli appezzamenti venivano di volta in volta messi a coltura era delimitata da siepi…Queste recinzioni avevano lo scopo di proteggere i campi coltivati dai danni degli animali selvaggi, ma soprattutto stavano a significare l’appropriazione del suolo da parte degli abitanti del casale.Al di là di questo limite si apriva un nuovo, più vasto mondo… il saltus.Qui le greggi pascolavano in primavera e in autunno; qui gli abitanti del villaggio praticavano la caccia e la raccolta dei frutti spontanei e tagliavano la legna per le case, per gli steccati, per gli attrezzi e per il fuoco. (p.29)
VII-VIII sec. d.C.
L’uomo e l’ambiente nel Medioevo Vito Fumagalli
Siepi vive, siepi morte, palizzate e steccati: il recinto di legno… caratterizzava l’insediamento rurale, accentrato e sparso: e corte significò a lungo, appunto, «recinto». (p.5)Le siepi –lamenta un documento del 1189- impediscono al bestiame di aggirarsi liberamente nel bosco, di muoversi lungo i fossati, per brucarne l’erba ai margini, di percorrere la strada pubblica nell’andata e nel ritorno dal pascolo. (p.43)
X-XII sec. D.C.
Le origini dell’economia europea George Duby
[La distinzione tra ager e saltus] andò progressivamente riducendosi nel corso dell’alto Medioevo. Questo perché, da una parte, il mondo romano stava nel suo insieme ritornando a uno stato di barbarie; mentre, dall’altra parte, il mondo barbarico si stava civilizzando. (p.31)Dell’allevamento sappiamo che era misto e che le proporzioni delle differenti specie animali variava secondo le attitudini naturali della zona.
VII-VIII sec. d.C.
L’uomo e l’ambiente nel Medioevo Vito Fumagalli
Le selve glandiferae o glandariae erano chiamate così perché valutate nella particolare angolazione di primaria importanza economica dell’allevamento suino (p.22)Nell’anno 1033, il vescovo di Modena, concedendo in affitto alcune terre boscate, prescrive che «i vecchi roveri siano salvati … ed i giovani vengano fatti crescere». (p.16) A testimonianza di uno stato di conservazione degli ambienti boschivi compromesso.
X-XII sec. D.C.
La campagna e le città (secoli XII-XV) Gabriella Piccinni
Le testimonianze di un attacco tutto sommato massiccio al bosco e all’incolto e di un progressivo addomesticamento della natura sono numerose: nell’area pedemontana, in Emilia e in Lombardia si protraggono dall’XI al XIII secolo… (p.139)Dato che la produzione cerealicola dei territori rimase di regola insufficiente … si sviluppò la coltura del castagneto, vera fonte di sussistenza che, oltre a fornire un ottimo legname per l’edilizia e per il riscaldamento e a consentire con i suoi frutti di allevare maiali su larga scala, favorendo anche l’attività di salatura delle carni, aiutava a integrare il pane nell’alimentazione delle popolazioni locali (p.140)
XI-XIII sec. d.C.
Alimentazione e cultura nel Medioevo Massimo Montanari
Il maiale era l’animale da carne per eccellenza… come il porcaro che lo conduceva. Il maiale costituiva la principale unità di riferimento della produzione silvo-pastorale, tanto da fungere da vera e propria unità di misura dei boschi, valutati in base al numero di capi che vi si potevano allevare ... Era una prassi caratteristica soprattutto dell’Europa continentale e, in Italia, dell’area Padana (p.37-38)
IX-X sec. D.C.
Alimentazione e cultura nel Medioevo Massimo Montanari
Dato il sistema di allevamento che puntava quasi esclusivamente sul pascolo brado riducendo al margine le tecniche stabulari e d’ingrassamento forzato. Il ritmo di crescita degli animali era normalmente assai lento e il loro peso, in rapporto all’età, assai più basso di oggi. Per il maiale sembra si potesse andare da un minimo di 30-40 kg a un massimo di 70-80, inferiore di almeno 3 volte ai pesi odierni. Il peso degli ovini poteva oscillare da un terzo alla metà di quello dei maiali. (p.44)
IX-X sec. D.C.
Alimentazione e cultura nel Medioevo Massimo Montanari
La lentezza dell’accrescimento è forse il motivo di fondo per cui gli animali godevano di un periodo di vita mediamente più lungo di ora. Il maiale assai di rado veniva ucciso entro il primo anno di vita...Per le pecore e le capre, allevate principalmente per il latte e la lana, l’età di macellazione era comunque assai avanzata, fino al terzo-quarto anno di vita, quando le loro capacità riproduttive andavano estinguendosi. A maggior ragione il discorso vale per bovini ed equini, uccisi di norma soltanto alla fine del ciclo lavorativo. (p.44)
IX-X sec. D.C.
L’uomo e l’ambiente nel Medioevo Vito Fumagalli
Se ci rivolgiamo a una odierna regione italiana, come l’Emilia Romagna … essa appare divisa in due zone: una montuosa collinare e una piana. Né l’una né l’altra raggiungono altitudini eccezionali, non superando l’Appennino, se non raramente i 2000 metri e i 100 la pianura, che per circa metà della sua estensione non tocca i 25 metri. (p.27)
Età del bronzo
L’uomo e l’ambiente nel Medioevo Vito Fumagalli
La pianura era una distesa paludosa. Lungo i fiumi e attorno agli stagni crescevano pioppi, ontani e salici. Nelle aree più asciutte crescevano querce, tigli e olmi e solo nell’età del bronzo fanno la loro comparsa faggi e castagni.I grandi boschi montani, quasi intatti, simili a selve nordiche, mescolavano le vastissime faggete e querceti alle formazioni di abete e di altre conifere. (p.30)
Età del bronzo
La campagna e le città (secoli XII-XV) Gabriella Piccinni
Dal Duecento in poi sono frequenti le descrizioni di alluvioni disastrose come conseguenza delle deforestazioni. I fiumi nella bassa pianura fra Parma e Reggio, ad esempio, uscirono dai loro letti, «le loro acque si unirono e tutto divenne un solo, grandissimo lago, del quale non si scorgevano le rive» come suggestivamente si esprime Vito Fumagalli (1976) … (pp.141-2)Dalla fine del XIII secolo si cominciò di nuovo a considerare il bosco come uno spazio prezioso … Prosciugare le paludi incanalandone le acque è già la premessa per esperienze d’irrigazione, di messa a coltura e di colonizzazione. Infatti non era stato solo il bosco ad arretrare, incalzato dalle coltivazioni: anche alcune aree acquitrinose erano state bonificate per creare nuovi spazi agricoli … Tuttavia anche il processo di bonifica degli acquitrini si realizzò in modo molto disomogeneo, anche perché i mezzi tecnici erano veramente modesti. (pp.143-4)
XI-XIII sec. d.C.
La campagna e le città (secoli XII-XV) Gabriella Piccinni
I lavoratori della terra, in una fase che si era protratta fino a buona parte del XIII secolo, erano stati in grado di rispondere alla domanda crescente di derrate alimentari proveniente dalle città… Tuttavia era stata una risposta limitata e imperfetta (sfruttamento estremo dei suoli votati alla cerealicoltura e messa a coltura anche di terreni inadatti, situati in alta e media montagna) (p.174)Fenomeni estesi di conversione di terre al pascolo accompagnarono l’abbandono di molti villaggi… In tutti questi casi, le aree di diffusione della transumanza furono quelle segnate da un più elevato spopolamento. (p.179)
XI-XIII sec. d.C.
La campagna e le città (secoli XII-XV) Gabriella Piccinni
Si tratta di aree che finirono per configurare modi di vita particolari e differenziati, dal momento che le pianure dei pascoli invernali restavano povere d’insediamenti stanziali, perché le famiglie dei pastori vivevano nei lontani castelli e nei villaggi, vicino ai pascoli estivi delle montagne, dalle quali solo gli uomini si spostavano stagionalmente con le greggi, coprendo grandi distanze… (p.179)
XI-XIII sec. d.C.
La campagna e le città (secoli XII-XV) Gabriella Piccinni
I villaggi abbandonati fra Trecento e Quattrocento sono un numero impressionante: un terzo nella Capitanata e nel Regno di Napoli, la metà di quelli della Sardegna…Nella Toscana delle colline centrali, nell’Umbria, nelle Marche, nella valle padana, nelle pianure del Piemonte fu invece l’insediamento sparso a riprendere presto a diffondersi, per motivi non demografici, ma di orga-
XI-XIII sec. d.C.
nizzazione della produzione e i contadini di nuovo si sparpa-gliarono nelle case poste sulle terre coltivate, rafforzando un habitat a maglia molto fitta. Un po’ ovunque furono costruite o ristrutturate, utilizzando edifici preesistenti, modeste case per i contadini con il loro corredo di capanne, fienili, stalle, pozzi . (p.182)
Percentuali ovi-bovi-suini nel bronzo medio x area
Insediamenti altoatesiniNossing - Albanbuhel – Sotciastel - Sonnenburg
Palafitte trentineFiavè - Ledro
Palafitte o altri insediamenti lombardi e venetiBarche – Lucone – Lagazzi – Isolone – Cisano – Peschiera - Ca' Nova di Cavaion
- Canar – Muraiola - Castellaro laguselloInsediamenti terramaricoli veneti e lombardi
Nogarole, I Camponi - Quarto del Tormine - Castellaro del VhòTerramare emiliane
Montale - Tabina di Magreta – Poviglio - Pilastri Bondeno - M. Leoni - Poggio Rusco - Noceto
Insediamenti emiliani non terramaricoliMonte Castellaccio - S.Giuliano -Valle Felici - Montirone di S.Agata Bolognese -
Crocetta di S.Agata Bolognese - Zenerigolo di San Giovanni in PersicetoInsediamenti appenninici
Riparo del Lauro - Riparo della Roberta - Grotta dell'Orso – Pitigliano - Grotta Bella (Terni) - Paludi di Celano - Grotta S. Angelo - Grotta dei Piccioni
Percentuali ovi-bovi-suini nel bronzo medio x area
Ovicaprini Bue Maiale
Insediamenti altoatesini 44 48 8
Palafitte trentine 61 31 8
Palafitte o altri insediamenti lombardi e veneti 40 37 24
Insediamenti terramaricoli veneti e lombardi 46 35 19
Terramare emiliane 44 21 35
Insediamenti emiliani non terramaricoli 39 33 28
Insediamenti appenninici centro Italia 38 31 31
Nel Medioevo i suini erano allevati allo stato brado e dato il lento accrescimento venivano macellati verso il secondo anno di vita.
La curva demografica evidenziata dai dati archeologici sembra coerente con quella di epoca medioevale; quindi possiamo desumere che l’allevamento dei suini avvenisse allo stato brado.
Il suino è un animale esclusivamente destinato al consumo carneo, mentre i caprovini, sempre nel Medioevo erano destinati soprattutto alle produzioni secondarie: lana e latte.
L’elevata percentuale di caprovini nelle palafitte trentine potrebbe suggerire un interesse elevato verso tali produzione secondarie, in quell’area (lavorazione della lana e dei tessuti in locale), con un’economia più sbilanciata verso la transumanza.
Alcune considerazioni
Non vi sono differenze significative nella distribuzione delle 3 specie animali nell’area considerata nel seminario (dall’Emilia Romagna alle regioni centrali), dove grosso modo, ciascuna specie vale circa un terzo del totale.
Con il che, si può escludere che le genti «appenniniche» praticassero nel corso del Bronzo Medio la transumanza così come la si è conosciuta in epoca moderna; mentre è probabile che le greggi e le mandrie pascolassero in area limitrofe all’insediamento (entro qualche decina di km).
Venendo meno l’ipotesi dell’esistenza di una simile specializzazione, viene anche meno la congettura relativa a una complementarietà tra le genti «appenniniche», produttrici di lana e quelle «terramaricole» produttrici di stoffe e tessuti.
Alcune considerazioni
Il paesaggio prima del bronzo medio era caratterizzato da boschi mesoigrofili di ampie dimensioni. Ben documentate le piante tipiche delle aree umide. (p.47)
BM1: Riduzione del bosco e delle aree umide (bonifica?). Tra i cereali spiccano avena e miglio (cereali minori). E’ presente la canapa ed è testimoniata l’orticultura: cicoria, aneto, finocchio, carota. (p.53)BM3-BR1: Ulteriore riduzione di bosco e aree umide. Presenze estranee di Pino e di Bosso. Tra i cereali: avena, orzo e miglio.Ancora orticoltura: cicoria, bietola, cavolo. (p.61)
Il paesaggio vegetale e l’ambiente nella pianura bolognese, Marchesini - Marvelli - Gobbo - Rizzoli
Nella bassa pianura veneta e nell’area lombarda è documentato un tasso d’afforestamento molto più elevato, con presenza di aree boscate o paludose più o meno estese tra i diversi villaggi dell’età del Bronzo. (p.74)
Il paesaggio vegetale e l’ambiente nella pianura bolognese, Marchesini - Marvelli - Gobbo - Rizzoli
OrzoL’orzo primaverile si distingue per il brevissimo ciclo vegetativo e per la sua resistenza al freddo. Per questa ragione la sua coltivazione si spinge molto al nord e nelle zone di alta montagna (Norvegia e 3000 m slm in zone sub-tropicali)L’orzo però non è molto resistente alle gelate, per cui l’invernale viene coltivato solo al sud nei paesi mediterranei e nel Vicino Oriente…L’orzo dà le migliori rese sui terreni fertili, porosi, ben dissodati, non troppo pesanti, ma non sabbiosi e non acidi (p.521)
Geografia dell’Agricoltura Jerzy Kostrowicki
AvenaL’avena ha come l’orzo primaverile un breve periodo vegetativo, ama il clima freddo e umido, sopporta bene le piogge abbondanti anche nella stagione della fioritura. Per questa ragione la sua coltivazione giunge molto a nord e fino in alta montagna, sebbene non tanto come l’orzo.Tollera meglio degli altri cereali i terreni acidi e per questo può essere coltivata anche in regioni di terreni podsolizzati. Non ama invece i terreni siccitosi calcarei o sabbiosi e neppure il clima torrido o troppo caldo. (p.523)
Geografia dell’Agricoltura Jerzy Kostrowicki
MiglioCon il termine miglio si definiscono varie graminacee dai chicchi minuti raccolti in pannocchie o ciuffi…Il più famoso è il Panicum Miliaceum coltivato per farne pappe e tritelli.
Un secondo gruppo è dato dai panichi (Setaria Italica) coltivati come foraggere.Appartiene ai migli anche il genere Pennisetum, nel quale troviamo il miglio africano o perlato (PennisetumSpicatum), che è molto resistente alla siccità e da cui si ricava farina e tritello. (p.525)
Geografia dell’Agricoltura Jerzy Kostrowicki
SegaleE’ oltre al frumento l’unico cereale adatto per fare il pane. Tuttavia la resa in farina del frumento è superiore a quella della segale…D’altra parte la segale è meno esigente nei confronti del suolo e del clima e tra i cereali invernali è il più resistente al gelo… Contemporaneamente la segale è anche resistente alla siccità. Non ama invece il clima caldo-umido. Pertanto nelle regioni meridionali viene coltivata solo in montagna…La segale fa buona riuscita su terreni leggeri e acidi. (p.519)
Geografia dell’Agricoltura Jerzy Kostrowicki
Frumento o GranoIl frumento può essere coltivato sia come cereale invernale che come cereale primaverile… Solo in clima caldo-umido non dà buone rese…Il frumento cresce bene su terreni fertili, polverosi o argillosi, soprattutto su quelli che contengono determinate quantità di calcio e di humus. (p.512)
Geografia dell’Agricoltura Jerzy Kostrowicki
Grano Tenero = triticum vulgare; Grano Duro = triticum durum; Grano Semiduro = triticum turgidum
Farro (triticum dicoccum) e Farricello (triticum monococcum)La predominanza della coltura del farro si spiega con il fatto che questo cereale, data la sua rusticità, era in grado di crescere bene in ogni condizione di terreno, compresi quelli molto umidi. (p.77)
Storia dell’Agricoltura Romana Arnaldo Marcone
Le condizioni materiali della produzione Carmine Ampolo
Il farro è consigliato dagli scrittori romani di agricoltura proprio per i terreni umidi (l’ager uliginosus) perché le cariossidi vestite resistono meglio all’acqua e all’umido. Ciò vale per tutte le specie e sottospecie vestite. Quindi triticum dicoccum, triticummonococcum e triticum spelta erano molto adatti alla coltivazione in zone soggette al ristagno dell’acqua.Quasi sempre varie specie di cereali sono associate nei rinvenimenti, talora anche assieme a leguminose…Montanari (1975) scrive «seminando grani di tipi diversi, ci si voleva senza dubbio difendere dalle conseguenze di un cattivo raccolto: se diversi erano i cereali seminati, con diverse caratteristiche di germinazione e di sviluppo, diversi dovevano risultare gli effetti degli agenti atmosferici sull’uno e sull’altro cereale: ne derivava un margine di sicurezza più ampio». I Latini chiamavano questo miscuglio di grani diversi Farrago. (p.18)
P P P T T T
Can
ar
Led
ro
Mo
lin
o d
i L
edro
Mo
nti
ron
e
Mo
nta
le
An
zola
panicum miliaceum Miglio X X X
setaria italica Panico X X X
avena sativa Avena X X X
hordeum vulgare Orzo X X X X X X
secale reale Segale X X
triticum spelta Spelta X X
triticum dicoccum Farro X X X X X
triticum monoccum Farricello X X X X X
triticum vulgare Frumento o Grano Tenero
triticum aestivum Frumento o Grano Tenero
triticum durum Frumento o Grano Duro
triticum turgidum Frumento o Grano Semiduro
Presenze di cereali documentate nei siti della media età del Bronzo
I cereali a cariossidi vestite richiedevano la brillatura, perché la battitura non riesce a togliere la gluma. La cottura consentiva di eliminare la gluma, toglieva l’umidità dai grani e quindi ne favoriva la conservazione.
Si vede chiaramente il valore nutritivo inferiore dei cereali a cariossidi vestite rispetto a quelli nudi. Ciò è evidente se si considera la % in fibre e ceneri e il contenuto in carboidrati. (p.20)
Le condizioni materiali della produzione Carmine Ampolo
Proteine Grassi Carboidrati Fibre Ceneri
Triticum dicoccum 13,28 1,91 69,42 11,31 4,07
Triticum monococcum 14,67 2,19 64,02 13,55 5,57
Hordeum L (nudo) 13,5 2,5 80,3 1,6 2,1
Triticum vulgare 13,3 2,3 80,4 2,0 2,0
Il modello economico della sussistenza diffuso indipendente-mente dal modello insediamentale, presenta caratteristiche simili a quelle del modello «barbarico-continentale» di epoca medievale.
La produzione di cereali a cariossidi nude non è documentata e si rafforza la convinzione che la cerealicoltura dovesse necessariamente essere integrata con l’orticoltura e con le attività di sfruttamento di un ambiente silvo-pastorale(allevamento, raccolta, caccia e pesca).
In un contesto produttivo siffatto, le attività artigianali e lo scambio di beni dovevano essere ben lungi dal rappresentare un meccanismo economico propulsivo, poiché le attività legate alla sussistenza dovevano occupare una parte considerevole del tempo a disposizione.
Alcune considerazioni
Nondimeno, nella documentazione prodotta durante il seminario sono emersi alcuni elementi d’interesse, che non confermano del tutto questo scenario.A livello metodologico avevamo suggerito di voler seguire l’approccio multiscalare delineato da Feinmann e Nicholas (2010).
Alcune considerazioni
Purtroppo, a livello del singolo insediamento non abbiamo dati che permettano di riconoscere una ripartizione delle attività produt-tive ed artigianali tra segmenti diversi della comunità.Fa eccezione lo studio di Paola Anna Elena Bianchi per la terra-mara di S. Rosa a Fodico di Poviglio (Riv. Sc. Preist. LIV 2004) riferibile però al BR.
In estrema sintesi, la studiosa scrive «le analogie riscontrate nella costruzione dello spazio domestico e nella sua organizzazione complessiva, insieme alla contiguità areale, suggeriscono che le capanne non siano solo sedi di simili e coeve esigenze produttive e di sussistenza, ma esse rap-
Capanne e spazi domestici del Bronzo Recente avanzato nel Villaggio grande della terramara di S. Rosa a Fodico di Poviglio
Paola Anna Elena Bianchi
presentano uno spazio con-dizionato da stretti legami (famigliari? sociali?), il cui riflesso è una comunanza di culto domestico, una deter-minata gestione delle risorse (stoccaggio e consu-mo) e una radicata attività di produzione tessile» (p.478)
La presenza di specializzazioni insediamentali invece è suggerita dalla ampia documentazione riferibile alla tessitura nelle terramare di Castione dei Marchesi e di Montale, rispetto alla scarsità rilevata ad Anzola, dove le attività artigianali sembrano per la maggior parte modeste (anche dal punto di vista qualitativo).
Alcune considerazioni
Castione dei Marchesi: l’attività di filatura e tessitura
L’alto numero di fusaiole rinvenuto a
Castione dei Marchesi documenta
l’importanza che l’attività di filatura
rivestiva nella cultura terramaricola
La grande quantità di fusaiole e pesi di telaio ritrovati nelle
terramare, la forte percentuale di resti ossei di pecore e la presenza, seppure scarsa , di semi di lino, fa
pensare che la produzione di tessuti in lana e lino rivestisse un ruolo
importante nell’economia terramaricola.
La terramara di Montale: l’attività tessile
Anzola: filatura e tessitura
A fronte dellagrande quantità di ceramica
vascolare restituita dagli scavi nell’insediamento,
colpisce lo scarso numero di fusaiole rinvenute.
Sono infatti solo sette
Fusaiole in argilla da vari settori dello scavo.
Solo una proviene da una buca di discarica in rapporto diretto
con probabili strutture di abitato, mentre le altre sono
state rinvenute in settori diversi
Poco numerosi anche i pesi da telaio, poco più di una dozzina fra integri e
frammentati
Altra testimonianza di una possibile specializzazione insediamentale è suggerita dalla ampia documentazione riferibile alla produzione di manufatti in legno a Ledro, dove non vi è una forte rappresentazione della produzione tessile; mentre nell’insediamento frontaliero di Molina di Ledro accade esattamente l’opposto e ad una ricchissima e documentatissima produzione tessile, si affianca una limitata presenza di manufatti in legno.
Alcune considerazioni
LEGNOFra i manufatti lignei meritano particolare menzione un aratro e una canoa monoxile oltre ai numerosi oggetti utilizzati sia in ambito domestico sia per altre attività: archi, mastelle, falcetti, frullini, mazze, martelli, manici per accette e asce, bastoni sagomati oltre a ciotole nei diversi stadi di lavorazione, fatto che ha permesso di ricostruirne la catena operativa
Ledro
PRODUZIONE TESSILEQuantità
REPERTI TESSILI
UTENSILI
300 500
Tessuto, gomitoli, filo, fibra.Fascia e cintura
Fuseruole, pesi da telaio, spole, punteruoli, spade da tessitore, pettini, fusi.Piccolo telaio
Qualità
SPECIALIZ.FILATO SOTTILE
ORNAMENTI
Fuseruolepiccole e leggere ed utilizzo di piccoli telai(Archeologia Sperimentale)
Cordicelle di piccoli semi inserite nei tessuti e motivi decorativigeometrici (facies Polada)
Il considerevole numero di reperti legati alla tessitura, lasciano supporre che l’attività tessile svolgesse un ruolo di primaria importanza nell’ambito del villaggio palafitticolo di Molina di Ledro, fatto questo che potrebbe lasciar pensare ad una produzione ben al di là dei reali bisogni di una comunità, destinata con ogni probabilità all’esportazione e allo scambio.
Molina di Ledro
Un altro esempio di specializzazione insediamentale può essere fornito dall’utilizzo di tecniche diverse nella lavorazione dei pettini in osso, i cui denti, nella maggior parte dei casi, sono realizzati con la tecnica della scanalatura, mentre a Olmo di Nogara e a Poviglio vengono prodotti con una seghetta di metallo, tecnica che riduce di molto l’usura.Un altro rinvenimento degno di nota sembra quello di Basilicanova (anche se riferibile forse al BR).Si tratta di una fornace per la cottura della ceramica, che però non si trova all’interno di un abitato, bensì a 2 km da quello più vicino. Questa collocazione fa pensare ad un utilizzo collettivo, forse non ristretto al singolo villaggio.
Alcune considerazioni
A livello regionale, costituiscono una prova dell’esistenza di scambi mercantili quei beni e/o quelle produzioni artigianali che utilizzavano materie prime alloctone.
Lavorazione delle carni: acqua, sale, lame litiche, lame metalliche, tessuti animaliLavorazione del latte: sale, oggetti ceramici, oggetti in legno, tessuti animali, vegetali, cesti ad intreccioLavorazione del legno: fuoco, strumenti litici, metalliciLavorazione della ceramica: acqua, argilla, strumenti lignei, in osso, in fibra (setacci), in ceramica, tessuti, fuocoLavorazione dei metalli: minerali, fuoco, strumenti ceramici, litici, vegetali, acqua
Alcune considerazioni
Lavorazione dell’osso e del corno : acqua, strumenti litici, metallici, cordameLavorazione della lana: acqua, lame litiche o metalliche, strumenti lignei, ceramici, in osso, calcariLavorazione del lino o della canapa: acqua, falcetti, battitori lignei, macine, cordame, pietre (pesi) [Ledro]Lavorazione delle pelli: acqua, vasche, strumenti lignei, litici, in osso, calcari, sale, vegetali, tessuti animali, pietre (pesi)Tessitura: telaio, strumenti ceramici, lignei, litici, metallici, in corno o ossoTintura: acqua, vasche, sale, vegetali, minerali, malacofauna
Alcune considerazioni
Come abbiamo evidenziato col colore giallo ci siamo imbattuti in alcune materie prime alloctone, rispetto alla maggior parte dei contesti presi in esame:
sale, selce, minerali metallici, pietra verde, calcari, arenarie, graniti, porfidi, quarzi, malacofauna.
Inoltre è stata evidenziata la presenza di prodotti plausibilmente importati:
ambra e perline di pasta vitrea o fayence.
La provenienza di tali materie prime sembra ipotizzabile.
Alcune considerazioni
Le provenienze più probabili per queste materie prime sono:Sale e Malacofauna = Costa adriatica
Selce = Monti LessiniMinerali metallici = Alpi e Appennino Tosco-Emiliano
Pietra verde = AlpiPietre calcaree = Appennino
Macine in arenaria = AppenninoMacine in porfido e granito = Alpi
Ambra e perline di pasta vitrea = Centro Europa.Quindi, a parte queste ultime, le materie prime provengono da contesti relativamente vicini, che dimostrano l’esistenza di una rete di scambi regionali.
Anche la diffusione dei modelli ceramici all’interno degli areali considerati non collima con l’ipotesi che si tratti di sole produzioni locali, suggerendo che anche in questo caso le ceramiche venissero scambiate all’interno di circuiti regionali.
Alcune considerazioni
I rinvenimenti della palafitta di Lagoni di Mercurago e soprat-tutto le ruote lignee (poiché le piroghe monossili sembrano tipiche della navigazione lacustre), testimoniano l’esistenza di una capacità di spostamento non più semplicemente pedestre (dato che i cavalli non sono ancora molto diffusi), suggerendo la possibilità di trasportare anche carichi ingombranti e pesanti attraverso il territorio.
Alcune considerazioni
Contrariamente a quanto si sarebbe potuto pensare l’attività metallurgica sembra documentata nella maggior parte dei siti, siano essi palafitticoli o terramaricoli.Questa notevole diffusione della conoscenza tecnologica tuttavia non ci fa pensare alla possibilità che tutti i segmenti sociali producessero i propri strumenti metallici. Quindi, malgrado la diffusione della conoscenza è probabile che ogni villaggio avesse uno o più specialisti che producevano oggetti di metallo per sé e per chi poteva permetterseli.
Alcune considerazioni
Affrontiamo l’ultimo argomento, riprendendo indicazioni che in più punti sono già stati evidenziati e che riguardano il popolamento.Riguardo al popolamento non abbiamo elementi significativi né per le palafitte, né per gli insediamenti appenninici.
Per questi ultimi appare ancora più centrata la descrizione delle comunità medievali che abbandonano l’ager tornando a cercare nel saltus le migliori condizioni per poter praticare un’economia mista, per metà produttiva e per metà acquisitiva.
Indubbiamente nel caso delle Terramare, appare una tendenza inversa, dal saltus all’ager, con la progressiva riduzione del bosco e dell’umido a favore del campo aperto. Tuttavia dal punto di vista della sussistenza non vi sono cambiamenti radicali.
Alcune considerazioni
Partendo dalle rese per ettaro (che sono state stimate con buona approssimazione in 5,25 q.li/ha per il farro e 4,76 q.li/ha per l’orzo), arrivando a calcolare i kg di farina che se ne potevano ricavare (da 315 a 367, a seconda della lavorazione e della ripartizione di cereali) e fissando in 327 gr di farro, che corrispondono all’incirca a una libbra di farina, la razione minima quotidiana di un individuo, Ampolo era arrivato al fabbisogno minimo di 120 kg di farina pro capite all’anno.
In questo modo era giunto a ipotizzare che ciascun ettaro di terreno coltivato potesse fornire alimentazione per un massimo di 3 individui adulti. Ma poiché queste rese si riferivano a una tecnica agricola di tipo intensivo, nella quale cioè veniva utilizzato l’aratro, dovendo far riposare il terreno coltivato l’anno prima, la disponibilità di terreno doveva essere doppia (2 ettari per 3 persone).
Le condizioni materiali della produzione Carmine Ampolo
Questo calcolo sembra abbastanza coerente con i dati descritti da Duby per il paesaggio germanico dell’alto Medioevo, dove una ventina di persone coltivavano un’areale di 300x300 m, cioè di 10 ettari, integrando la cerealicoltura con le altre forme di sussistenza.
Alcune considerazioni
La stima demografica proposta da Bernabò Brea, Cardarelli e Cremaschi (1997), invece, parte da altri due tipi di dati:
• l’estensione degli abitati terramaricoli
• la numerosità dei defunti nelle necropoli conosciute.
E in base a tali calcoli, nel BM3 si raggiungerebbe una popolazione terramaricola tra gli 80 e i 95 mila individui.
La densità abitativa stimata dagli autori, sulla base dei dati forniti dagli scavi di S. Rosa di Poviglio, dalla Montata e da Ca’ de’ Cessi è stata discretizzata in 4 fasce:
fino a 3 ettari di estensione dell’abitato = 150 ab. per ettaroda 4 a 9 ettari di estensione dell’abitato = 100 ab. per ettarodai 10 ai 15 ettari di estensione dell’abitato = 85 ab. per ettarooltre i 15 ettari di estensione dell’abitato = 75 ab. per ettaro
Ad avvalorare questa impostazione gli autori portano un computo del tempo necessario per la realizzazione del fossato e del terrapieno di una terramara di medie dimensioni (Savana).Per scavare 35.000/40.000 m3 di terra, sarebbero occorsi 185 giorni, con 300 persone all’opera, in grado di scavare 2 m3 al giorno pro-capite.
Il crollo del sistema terramaricolo Maria Bernabò Brea, Andrea Cardarelli, Mauro Cremaschi
Rispetto al primo argomento si potrebbe far notare che dunque avremmo le seguenti fasce di popolazione stimata.
Alcune considerazioni
Fascia di estensione
Ab. per ettaro Popolazione max Fabbisogno in ettari
fino a 3 ettari 150 450 150
da 4 a 9 100 900 300
da 10 a 15 85 1275 425
da 15 a 20 75 1500 500
Coerentemente, Cattani (2008) indica in 450 ettari l’area potenzialmente destinata alla coltivazione intorno ai villaggi.Tuttavia questa ipotesi non tiene abbastanza in conto che il paesaggio della pianura emiliano-romagnola era fortemente condizionato da corsi d’acqua, acquitrini, zone paludose, per la cui bonifica sarebbero occorsi sforzi ben superiori rispetto a quelli ipotizzati per la realizzazione dei fossati.
Rispetto al secondo argomento c’è un aspetto poco convincente che ogni tanto ritorna: la supposta autonomia, quasi autarchia delle popolazioni terramaricole.In contrasto con questa visione abbiamo diversi argomenti:
• esistenza di scambi alla media distanza• esistenza di specializzazioni artigianali alla breve distanza• ridotta distanza degli insediamenti (tra i 2 e i 5 km)
Inoltre la formazione socio-economica che diede vita alle Terramare è chiaramente riferibile alle società segmentarie ed è noto che queste società sviluppano una vasta trama di relazioni sociali, economiche e politiche, più o meno intense, in relazione alla distanza di parentela (vera o fittizia che fosse).Risultano quindi poco credibili tutte le ipotesi e le deduzioni che restringono i rapporti sociali e produttivi all’interno del singolo insediamento.
Alcune considerazioni
Un’ultima considerazione riguarda le testimonianze funerarie. Per l’area emiliano-romagnola si hanno informazioni incomplete e numeri inferiori rispetto a quelle della Lombardia orientale e del Veneto occidentale.In queste zone sono state rinvenute necropoli del BM3-BR che hanno restituito centinaia di individui.
Alcune considerazioni
Sito Deposizioni Periodo Anni Estensione villaggio
FranzineNuove
583 BM-BR 250 anni 6 ha
Olmo di Nogara
510 BM-BR 250 anni
Vallona di Ostiglia
369 BR 150 anni
Scalvinetto 243
Come ripetuto più volte la presenza stessa delle necropoli è indice di una condizione di sovrappopolamento o di forte competizione per l’accesso alle risorse strategiche per la riproduzione del gruppo.Se 80-95 mila abitanti è il valore medio per tutta la durata del BM3, valutando in 100 anni la durata del periodo, dovremmo ipotizzare l’alternanza di almeno 4-5 generazioni. Cosicché, il rapporto tra deposizioni nelle necropoli e numero di abitanti calcolato sulla base dell’estensione del villaggio dovrebbe essere 4 (o 5) a 1. Cioè per un villaggio di 6 ettari, quindi con ca. 600 abitanti dovremmo avere una necropoli di ca. 2400-3000 inumati. E questa, malgrado una perdita d’informazioni attribuibile alla incompletezza degli scavi non sembra proprio la situazione testimoniata archeologicamente.
Alcune considerazioni
In ultima analisi, forse le stime relative al popolamento del BM3 sono un po’ eccessive e dovrebbero essere tagliate di almeno un terzo.Quanto agli obiettivi di questo seminario, possiamo essere soddisfatti di aver compreso maggiormente le dinamiche presenti in alcuni processi di produzione.Abbiamo trovato sostanzialmente conferma dell’importanza della produzione tessile nella maggior parte degli insediamenti esaminati, avvalorando l’ipotesi che la scelta insediamentale in prossimità dell’acqua fosse richiesta dai processi produttivi svolti dalla comunità.E da ultimo rivolgiamo una richiesta a chi continuerà a studiare il fenomeno delle Terramare e dei vicini insediamenti palafitticoli, affinché venga dedicata maggiore attenzione alla rete di rapporti sociali ed economici che queste comunità dell’età del Bronzo intrattenevano.
Alcune considerazioni
Anche se è fuori tema rispetto al seminario, si può rinunciare a produrre l’ennesima ipotesi sulla scomparsa delle Terremare?
La fine delle Terramare
In estrema sintesi, abbiamo annotato che le Terramare avevano diverse estensioni (da 3 a oltre 15 ettari).La diversa estensione non può non essere collegata a una dimensione demografica rilevante (fino a diverse centinaia di persone nelle Terramare più ampie).Ora, queste dimensioni non ci permettono di pensare né a una società completamente egalitaria, né a una popolazione dedicata prevalentemente alle attività di sussistenza.Un fenomeno di sovrappopolazione e di competizione nell’accesso alle risorse primarie è documentato dalla comparsa delle necropoli, a partire dal BM3 e va probabilmente lievitando nel corso del BR.Non sarebbe quindi sorprendente pensare che queste popolazioni avessero quanto meno iniziato ad organizzarsi in modo gerarchico, secondo le modalità proprie delle società lignatiche.
La fine delle Terramare
economica perfettamente compatibile con il meccanismoereditario tipico dei lignaggi patrilineari, applicatosecondo una linea verticale (che dà luogo a unasuddivisione = riduzione dei diritti di proprietà collettivadel territorio); ma anche con il meccanismo dellasegmentazione del gruppo di parentela, che non subisceriflessi negativi quando s’interviene per ridurre lanumerosità dell’unità produttiva.
Se le condizioni di scarsità delle risorse primarie permangono o siaccentuano, dal punto di vista produttivo possono svilupparsi o essereadottate tecniche più avanzate di produzione, che risultano moltoimportanti in relazione al processo di segmentazione dei lignaggi.Infatti, l’adozione dell’aratro permette di aumentare la produzione,riducendo l’effort (dunque anche il numero dei lavoratori) e la necessitàdi terreno, che viene ad essere utilizzato in forma sempre più intensiva,piuttosto che estensiva. In questo modo, si favorisce una dinamica socio-
Conseguenze della scarsità
Seminario 2011
In effetti nella documentazione archeologica sono presenti numerosi esemplari di aratro, che quindi avvalorano l’ipotesi di un progressivo passaggio dall’agricoltura estensiva a quella intensiva.All’inizio, l’adozione dell’aratro deve aver permesso l’affranca-mento di un certo numero persone dalle attività di sussistenza.Ciò che non siamo riusciti a cogliere nel nostro seminario sono proprio i differenziali di produzione tra un insediamento e l’altro.Tuttavia possiamo facilmente immaginare che alcuni insediamenti meglio posizionati siano riusciti ad avere una produzione agricola migliore, altri una produzione pastorale superiore, altri le risorse selvatiche (caccia, pesca, frutti selvatici) e così via.
La fine delle Terramare
La liberazione di risorse dalle attività della sussistenza e le diverse fortune nell’economia alimentare sono forse state le opportunità che favorirono un (nuovo? maggiore?) sviluppo di alcune tecniche artigianali.Le specializzazioni di alcune produzioni artigianali riscontrate in alcuni insediamenti potrebbero aver avuto come pungolo, una condizione sfavorevole nel campo della produzione alimentare.Di conseguenza i prodotti artigianali sarebbero potuti servire sia per accedere attraverso lo scambio ai beni alimentari prodotti da villaggi vicini, che ai prodotti alloctoni (sale, minerali, etc.). Riguardo alle produzioni tessili nel BR, ad esempio, la Bianchi ha documentato a S. Rosa di Poviglio la presenza di almeno un telaio per capanna e, in almeno un caso, di ben due telai nella stessa capanna.Una simile numerosità non è ammissibile per una produzione domestica.
La fine delle Terramare
Dunque, possiamo ipotizzare che lo sviluppo degli scambi e una produzione agricola sempre più intensiva possa aver favorito uno spostamento incessante di persone dalle attività di sussistenza verso quelle artigianali.La riduzione della forza lavoro impegnata nella produzione alimentare è sempre una «scelta» rischiosa. Possiamo immaginare che l’esaurimento dei terreni coltivati a causa della lavorazione agricola intensiva, possa aver favorito, unitamente al fabbisogno di legname, un processo di disboscamento, che innescò, gradualmente, il restringimento delle aree adatte all’allevamento allo stato brado dei maiali, che costituivano una risorsa molto importante nell’alimentazione dei Terramaricoli.L’aumento delle persone non produttive e l’impoverimento della produzione alimentare potrebbero averli costretti a modificare, a poco a poco, il proprio modello produttivo.
La fine delle Terramare
Insomma, il problema della società Terramaricola potrebbe essere stato quello di aver intrapreso un modello economico, che in un momento avanzato del suo sviluppo potrebbe essersi dimostrato difficilmente sostenibile sul piano ambientale e di non aver avuto la possibilità, nonostante l’abilità raggiunta nelle attività artigianali, di convertirne la produzione,attraverso lo scambio, in beni alimentari, per la mancanza di partner commerciali nei territori circostanti che potessero sostenere il fabbisogno alimentare dei Terramaricoli.Quindi l’apparente scomparsa dei Terramaricoli potrebbe essere «letta» come il fallimento di un modello economico e l’abbandono di un territorio che non era più in grado di garan-tire la sopravvivenza di gruppi anche numerosi di persone, che presumibilmente migrarono, chiedendo ospitalità alle comuni-tà vicine o dando vita a nuove forme insediamentali.
La fine delle Terramare