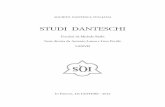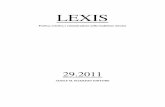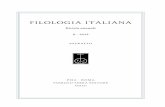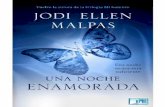1. Giurisprudenza. E' una commedia? E' una tragedia?
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of 1. Giurisprudenza. E' una commedia? E' una tragedia?
GIURISPRUDENZA.
E’ UNA COMMEDIA? E’ UNA TRAGEDIA?
di Raffaele De Giorgi
1.
I giuristi sono abituati ad occuparsi di casi. Di casi
concreti, come dicono. Di casi specifici. Strano,
perché tutti i casi sono concreti, così come ogni caso
è specifico. Forse quando fanno questa affermazione i
giuristi vogliono dire qualcos’altro. Per esempio
vogliono dire che un caso non si presenta mai come un
caso, come un brano di mondo, un pezzo di tempo, come
una apparizione che si manifesta e scompare. Tutto ciò
che viene detto, viene detto da un osservatore, ha
scritto Maturana. Noi potremmo dire: tutto ciò che
accade, accade perché un osservatore lo differenzia da
qualcos’altro. In altri termini se non si opera una
distinzione, non si interrompe la ininterrotta catena
del presente. E se non si fa differenza non c’è tempo.
E senza tempo non c’è passato, ma neppure futuro. E se
non c’è passato e futuro non ci sono casi, perché i
casi sono accaduti o accadranno. Diciamo allora che il
giurista si occupa di ciò che lui costruisce come caso.
1
Qui, per esempio, abbiamo un caso interessante. Che
dovremmo interpretare, del quale dovremmo cercare le
motivazioni, sul quale dovremmo decidere, dato che già
nel nome che è stato dato al del caso c’è
un’alternativa. E’ un breve racconto di Thomas
Bernhard. Il titolo è il seguente: E’ una commedia? E’ una
tragedia? Si tratta di questo: un uomo ha deciso di
andare a teatro. Mentre si incammina è preso da
pensieri, da dubbi, da tormentose incertezze. Arriva in
un parco, incontra qualcuno che gli parla. Questi gli
dice che anche lui per anni è andato a teatro, ma che
quella sera non lo avrebbe fatto. Lo sconosciuto si
chiede se quella sera a teatro ci sarebbe stata una
commedia o una tragedia. Egli invita l’uomo che
originariamente pensava di voler andare a teatro a fare
una passeggiata e gli assicura che parlando con lui
avrebbe scoperto dai caratteri della sua persona se
quella sera a teatro ci sarebbe stata una commedia o
una tragedia. E mentre camminano lo sconosciuto fa la
seguente affermazione: “il mondo è un mondo
completamente, profondamente giuridico, come Lei forse
non sa. Il mondo è una sola, grandiosa giurisprudenza”.
Più oltre aggiunge: “Il mondo intero è una sola
giurisprudenza”.
Di questo caso vorrei discutere con Voi.
2
2.
Giurisprudenza è un complesso universo di significati.
Essa descrive contesti di operazioni giuridiche,
risultati di quelle operazioni, riflessioni che
elaborano quei risultati. A loro volta, però, anche i
singoli significati di giurisprudenza nascondono nuclei
di problemi intorno ai quali si è condensata
l’evoluzione del diritto. Riteniamo opportuno discutere
alcuni aspetti di questa evoluzione e riflettere su
quelle rappresentazioni della giurisprudenza che
occultano il fatto che il diritto si fonda su se stesso
e che chiamiamo il paradosso costitutivo del diritto.
Riteniamo che in questo modo si renda possibile
acquisire conoscenze utili sulla struttura del diritto
della società moderna, sul suo rapporto con il tempo e
sul suo potenziale di costruzione del futuro. Riteniamo
anche che in questo modo si possa indicare con
chiarezza come si differenzia quel complesso semantico,
quella unitas multiplex che chiamiamo appunto
giurisprudenza.
Nel linguaggio comune dei giuristi giurisprudenza
designa l’attività dei tribunali. Quell’attività che
viene caratterizzata anch’essa in modi diversi: si dice
3
applicazione del diritto, ma si dice anche produzione
del diritto da parte dei giudici, oppure
concretizzazione del diritto, per riprendere
un’espressione cara al pensiero giuridico tedesco
dell’inizio del secolo scorso. Giurisprudenza è anche
l’insieme del sapere in relazione al quale si elaborano
le decisioni che costituiscono l’attività dei
tribunali. Giurisprudenza indica allo stesso tempo
insieme il contesto e le modalità di costruzione delle
argomentazioni espressamente richiamate nell’attività
del decidere. Essa però non è solo questa
autorappresentazione del giurista che opera con i
fatti, con le norme e con decisioni giuridiche già
prese, con percorsi argomentativi già seguiti.
Giurisprudenza è anche il complesso di significati
attraverso i quali un’osservatore qualifica i fatti, le
norme e le decisioni giuridiche già qualificati da un
altro osservatore. Giurisprudenza, allora, non è solo
costruzione di significati.
Giurisprudenza è costruzione di significati
attraverso i quali un osservatore osserva costruzioni
di significati di altri osservatori. E’ il complesso di
punti di vista di un osservatore attribuiti ad altri
osservatori. Ci si rende subito conto però che con il
contenuto semantico di un concetto come giurisprudenza
4
accade qualcosa di particolare. Questo contenuto non è
definito da una oggettualità differenziata. Il fatto
che si moltiplicano i livelli di osservazione della
giurisprudenza significa che la giurisprudenza
moltiplica le modalità di costruzione di se stessa. Si
produce giurisprudenza attraverso operazioni di
osservazione e attraverso livelli sempre più alti di
osservazioni di queste osservazioni. Giurisprudenza è
allora anche scienza del diritto. Fin dal secolo XVIII
giurisprudenza designa un sistema di elaborazione di
conoscenze del diritto e di organizzazione del sapere
sul diritto che viene utilizzato per la costruzione di
concetti i quali poi devono essere raccolti in un
sistema. Che, in questo caso, è risultato di
costruzione logica delle connessioni concettuali della
materia giuridica. Già Savigny pensava in questo modo.
E soggiungeva: ogni sistema porta alla filosofia. E
ancora: Jhering distingueva una giurisprudenza inferiore da
una giurisprudenza superiore. La prima sarebbe il risultato
di una rudimentale elaborazione della materia giuridica
alla quale è immanente il peso della immediatezza dei
rapporti sociali. La giurisprudenza superiore, invece,
sarebbe allo stesso tempo libera arte che costruisce,
forma, produce il diritto e scienza che eleva la
materia giuridica a un superiore stato di aggregazione.
5
Questa giurisprudenza, diceva Jhering, lascia
sviluppare il diritto liberamente a partire da se
stesso e, in virtù della universalità dei suoi
concetti, il diritto non si lascia più limitare dal
tempo. Lo spirito del tempo è anche spirito del
diritto. Una cosiffatta giurisprudenza, concludeva
Jhering, non si lascia più mettere in difficoltà dalla
storia. E infatti, in questa sua rappresentazione la
giurisprudenza resiste al tempo, è sensibile solo a se
stessa, si lascia irritare solo da se stessa, diciamo
noi.
Intesa come complesso semantico nel quale sono
compresenti significati e livelli di significato
differenti, giurisprudenza appare come una gerarchia
aggrovigliata nella quale si sono condensate le tracce, i
residui, i fossili che l’evoluzione del diritto ha
sedimentato lungo il suo percorso. Se il diritto
moderno, che è diritto pienamente positivo, ha
abbandonato ormai l’uso di vecchie distinzioni,
tuttavia, nell’autorappresentazione universalizzante
della giurisprudenza, molte di quelle distinzioni
continuano a celebrare la loro resistenza. Si pensi per
esempio a distinzioni come legge e diritto, natura e
ragione, natura e cultura, fatto e valore, essere e
dover essere, realtà e costruzione. La giurisprudenza è
6
la gerarchia aggrovigliata che le conserva e di volta
in volta le riattiva, anche se in modo chiaramente
controfattuale. In questa gerarchia aggrovigliata si
formano strani anelli: nel linguaggio di Hofstadter strano
anello indica “qualcosa che sta dentro il sistema esce
dal sistema e agisce sul sistema, come se fosse fuori
dal sistema”. L’evoluzione del diritto produce
mutazioni semantiche in virtù delle quali il paradosso
dell’autoproduzione del diritto si confonde con gli
strani anelli della giurisprudenza, si disperde nei
suoi grovigli. Le mutazioni recenti della
giurisprudenza si chiamano giurisprudenza dei concetti,
giurisprudenza degli interessi, giurisprudenza
realistica, dogmatica, progressista, conservatrice,
giurisprudenza liberale, critica, alternativa. Per
effetto di queste mutazioni si formano reticoli
concettuali che fungono da fossili guida
nell’orientamento dell’attività giurisprudenziale. La
quale consiste sempre nella produzione di concetti
sulla base di concetti, nella costruzione di
distinzioni in base a distinzioni, nella sedimentazione
di senso in base a senso. Nelle sue operazioni, però,
la stratificazione semantica che viene messa in azione
deve presentarsi in modo che la ricorsiva
attualizzazione delle sue distinzioni interrompa la
7
costruzione logica, oppure l’idea di interesse, oppure
la realistica valutazione delle condizioni sociali
nelle quali si producono gli eventi, oppure il fine,
cioè le conseguenze calcolabili della costruzione
giurisprudenziale. Punti di vista interni al sistema
vengono isolati attraverso l’uso di distinzioni e poi
vengono reintrodotti nel sistema come orientamento e
guida della costruzione di altre distinzioni con le
quali il sistema si assicura la sua capacità di
continuare ad operare.
3.
In principio non c’era l’illecito. L’illecito non
poteva esserci perché non c’era il lecito. L’illecito è
posto dal diritto, così come il lecito. Il diritto
infatti non è il lecito, è l’unità della differenza di
lecito e illecito. Quando l’unità si rompe, esce fuori,
emerge la differenza. Le due parti si contrappongono e
una di esse, il lecito, viene identificata con il
diritto. Il quale in realtà è l’unità della differenza
di ciò che è conforme al diritto e di ciò che non è
conforme al diritto. L’unità di questa differenza, per
noi, è un paradosso. Alle origini, però, essa fu un
nucleo esplosivo, un nucleo di senso fornito di un
8
dirompente, grandioso, potenziale tragico. E infatti lo
troviamo come condensato di senso che generò quella
grande costruzione del mondo che è la tragedia di
Eschilo, già prefigurata nelle rappresentazioni
dell’unità della differenza della vita e della morte
che si erano già affermate nei Balcani. Poi ci fu il
diritto, fu posto il diritto. Le norme produssero la
differenza, l’unità fu infranta, l’illecito si
contrappose al lecito e fu trattato come negazione del
diritto. La contraddizione sviluppava, apriva il
paradosso dell’autofondazione del diritto. Non lo
eliminava, s’intende, ma lo trasformava attraverso una
distinzione che ne rendeva possibile il trattamento.
Anche il tempo della tragedia si sarebbe concluso e
all’orizzonte si sarebbe profilato il secolare successo
della commedia come rappresentazione del mondo. Gli
strani anelli della giurisprudenza, le gerarchie
aggrovigliate che si sono stabilizzate, sono risultato
degli sforzi compiuti dal pensiero giuridico per
inibire il potenziale tragico del paradosso, per
occultare, come si diceva, gli arcana imperii. Vecchie
circolarità vengono interrotte da nuove distinzioni.
Vecchie unità si differenziano. Restano le
sedimentazioni, ma si produce evoluzione. Per esempio
il potere si civilizza. Si libera dell’autofondazione
9
antica nella natura, di quella che lo legava alla
divinità, e cerca di legittimarsi in senso moderno come
potere che ha diritto ad essere potere. Questo diritto
non è più di origine divina, ma temporale. Poi ci sarà
il ricorso al consenso e il potere diventerà triviale.
Prima, però, agirà il tempo. Quel potere, si dirà,
produce diritto e si sottomette il diritto che esso
stesso produce. La distinzione tra legislazione e
applicazione del diritto realizza questo presupposto.
Si tratta di un presuppostoche realizza la
civilizzazione del potere, che invisibilizza il
paradosso dell’autofondazione del diritto e attiva gli
strani anelli della giurisprudenza. La giurisprudenza
si specifica come applicazione del diritto. Essa dice
il diritto. Per poter dire il diritto la giurisprudenza
deve conoscere il diritto e decidere sul diritto.
L’idea della conoscenza scaturisce da una
secolarizzazione del sapere antico, da una
secolarizzazione dell’idea di verità. La decisione,
invece, si correla al fatto che anche sul piano della
sua produzione il diritto è legato ad una decisione. In
questo modo le due polarità del diritto, legislazione e
applicazione acquistano grande rilevanza. Esse si
attivano in modo autonomo nel senso che tra di esse
cresce simultaneamente reciproca dipendenza e
10
indipendenza. L’autonomia, però, interrompe la vecchia
circolarità. Questa condizione opera in modo che, ogni
volta che il sistema del diritto si chiude, si aprono
simultaneamente altre possibilità. Una decisione può
sempre essere diversa da come è stata. Avrebbe potuto
essere o potrà esserlo in futuro. Legislazione e
applicazione del diritto vincolano il futuro, ma
lasciano manifesto il fatto che quel vincolo avrebbe
potuto e potrà essere diverso. Il futuro, quindi, resta
aperto.
Questa duplice polarità della decisione che
caratterizza il diritto, che lo delimita, producendo
l’immagine di un diritto che comincia e finisce, per
così dire, di un diritto che viene posto e si realizza,
mette in azione una tecnica tipicamente moderna della
costruzione di stabilità. La legislazione realizza una
competenza specifica la quale si esercita in forma
continua e durevole, ma è legata all’evento. La
produzione di una norma è essa stessa un evento. Gli
eventi non hanno stabilità. Essi si caratterizzano per
la loro differenza. Il potere, attraverso la decisione,
isola una differenza e utilizza una rilevanza costruita
per produrre un vincolo del futuro. Diritto è questo
vincolo del futuro. A questo punto, però, il futuro si
riapre, perché il diritto deve essere applicato, come
11
si dice. Cioè deve essere costruita una situazione,
deve essere isolato un evento che deve essere
qualificato dal diritto, senza che si possa prevedere
se e come sarà qualificato. Anche qui una decisione. La
quale viene presentata come decisione del caso, ma in
realtà è una decisione sul caso, cioè sul fatto che
l’evento sia rilevante per il diritto e su quale
diritto renda possibile la costruzione di quella
rilevanza. Anche se in nessuno dei due casi si tratta
di decisione, la costruzione di alternative praticabili
può essere presentata come decisione. In realtà il
punto cieco della decisione, in entrambi i casi è il
presente, la presenza del sistema politico e quindi,
del sistema giuridico a se stesso. Le universalità di
significato presenti nelle costruzioni realizzano la
forma dell’accoppiamento tra i due sistemi, realizzano
cioè le condizioni della loro continua capacità
operativa nella simultaneità della differenza e della
indipendenza. Anche la competenza a decidere sul caso è
una competenza specifica che si esercita in forma
continua. E che costruisce continuamente vincoli del
futuro sia nella forma della attribuzione di garanzie
delle possibilità di azione, che nella forma del loro
impedimento. Le due polarità della decisione
distribuiscono però in modo asimmetrico il rischio del
12
decidere, cioè la esposizione del sistema alla
imprevedibilità della decisione. Il potere può non
decidere. Il tribunale, invece, deve decidere. Questo
significa che, mentre il potere può reperire i temi da
trattare come oggetti della decisione da un universo
ricco di varietà e capace di continua variazione, in
altri termini può contraddirsi senza instabilizzarsi,
la decisione giuridica invece deve rispettare altri
requisiti. Essa non può essere negata, deve essere
detta e può essere detta solo in modo da poter essere
riconosciuta nella rete di significati giuridici tra i
quali si colloca e tra i quali si qualifica o perché
giustifica la sua identità o perché giustifica la sua
differenza. Quella rete di significati giuridici è il
contesto semantico della giurisprudenza. La quale dice
il diritto nel senso che dà un nome agli eventi, li
indica attraverso il ricorso a distinzioni che si sono
stabilizzate nel suo universo semantico.
Le due polarità del decidere assorbono insicurezza e
praticano la costruzione di vincoli del futuro in modi
che possono essere tollerati. La società può affidarsi
al diritto nella costruzione del futuro. Può fare
affidamento nella libertà della legislazione e nella
necessità della applicazione del diritto. La libertà
della legislazione si chiama possibilità di costruire
13
futuri diversi; la coazione a decidere dei tribunali si
chiama divieto di negare giustizia. Da una parte il
sistema del diritto è aperto, esso apprende; dall’altra
esso è chiuso, non apprende. In entrambi i casi, il
diritto comincia comunque a partire da sé. Per questo
la giurisprudenza agisce come memoria del sistema, come
presenza del diritto a sé stesso. Ma come rappresenta
la giurisprudenza a se stessa il suo operare? In altri
termini come occulta a se stessa i suoi strani anelli?
Come linearizza la giurisprudenza le sue gerarchie
aggrovigliate?
4.
La decisione giurisprudenziale si presenta prima di
tutto come conoscenza del diritto. E’ questo il primo
aspetto della asimmetria, è il primo risultato della
contrapposizione. Fissato come testo, il diritto deve
essere citato, altrimenti non può fungere come elemento
della comunicazione giuridica. Ma la citazione del
diritto non rende il diritto oggetto di conoscenza, non
è risultato di un processo conoscitivo di qualcosa.
Neppure la costruzione della norma che fa al caso, come
si dice è risultato di un processo di conoscenza.
L’idea della conoscenza ha la funzione di conservare
14
lungo tutto il percorso decisionale del diritto la
distinzione di legislazione e applicazione del diritto.
E infatti, cosa si conosce, quando si conosce il
diritto? Cosa si vede quando si è davanti alla porta
della legge, quando ci si trova nelle condizioni
dell’uomo di campagna, come nel racconto di Kafka? Non
si vede certo l’ordine del mondo e neppure la verità.
Il diritto moderno si è emancipato dalla verità e non
riproduce più la necessità dell’ordine. La natura non
detta più i fini dell’azione e le sue regolarità non
indicano più irregolarità dell’azione. E poi: quale può
essere l’oggetto della conoscenza, se il diritto è
risultato di decisioni e se l’esperienza del diritto è
esperienza interiore di ciò che può essere altro e
avrebbe potuto essere altro? E se il diritto è come è
proprio perché non può dire di sé che ha diritto ad
essere diritto. Altri regimi del diritto, per esempio
il diritto naturale, o il diritto dei testi sacri,
rappresentavano la stessa produzione del diritto come
risultato di un processo conoscitivo. Anche la ricerca
del diritto, la sua pronunzia erano momenti di un
processo di conoscenza. Si trattava di conoscenza di
tipo deduttivo, di ricerca che permetteva di accostarsi
ai fondamenti del diritto. Conoscenza del diritto,
infatti era conoscenza dei fondamenti del diritto. Ma
15
il diritto positivo moderno rende grottesco il pensiero
della conoscenza dei fondamenti, così come l’idea che
un consenso sui fondamenti del diritto possa conferire
validità al diritto. I fondamenti legittimano ogni
diritto. I fondamenti di una decisione sono privi di
fondamenti, sono il punto cieco, la latenza della
decisione. E se si osserva la latenza le alternative
della decisione si bloccano sul paradosso della loro
costruzione. Sul fondamento del diritto universale alla
vita si può impiantare la pena di morte e la sua
negazione. Il ricorso ai fondamenti contribuisce a
rendere triviale il diritto. Così come l’idea della
conoscenza delle fonti del diritto. Esse sono tecniche
in virtù delle quali si introducono asimmetrie nella
circolarità del percorso secondo il quale il giudice
costruisce il diritto che applica. La asimmetria evita
il circolo, ma allo stesso tempo mantiene la chiusura
del sistema del diritto, protegge questo sistema dal
ricorso ad elementi esterni, in quanto la decisione
giurisprudenziale deve essere presa, non può essere
negata per mancanza di diritto, ma deve essere presa in
base al diritto. La giurisprudenza allora reperisce
nella sua memoria modalità riconosciute di elaborazione
del materiale decisionale, cioè modalità rese
plausibili dalla giurisprudenza stessa come tecniche di
16
costruzione del caso, come tecniche concettuali di
assorbimento dell’incertezza. In questo modo senso
giuridico già sedimentato può essere attualizzato.
Attraverso questo senso si qualifica il mondo, si dà un
nome alle cose, si delimitano gli eventi, si
determinano segmenti nella ininterrotta continuità
della comunicazione sociale e, poiché eventi così
isolati non possono circolare da soli, essi vengono
imputati. Possono essere imputati all’interno del
sistema ed essere trattati come azioni, oppure
all’esterno del sistema ed essere trattati come
esperienze interiori. I destinatari dell’imputazione si
chiamano soggetti.
Questa rete autocostruita di significati rende il
mondo accessibile alla decisione. Essa lo presenta come
la totalità dei fatti, come diceva Wittgenstein. Sui
fatti si deve decidere. E la decisione non può essere
negata. Ma una decisione usa alternative. Essa è
differenza delle alternative. Essa è l’unità della
differenza, in altri termini, essa è un paradosso. E
infatti solo ciò che è indecidibile può essere deciso.
Nei casi decidibili, la decisione è già stata decisa,
deve essere solo riconosciuta. Questa è un’opinione che
è formulata chiaramente da Heinz von Foerster, da
Luhmann, da Derida. Il decisore, come l’osservatore è
17
il punto cieco della decisione. In un suo meraviglioso
romanzo, Cecità, appunto, Saramago ci ha fornito
descrizioni meravigliose del non vedere, del mondo
costruito attraverso il non vedere. La giurisprudenza
si muove in modo particolarmente agevole in questo
mondo. Essa utilizza l’idea della conoscenza del
diritto e dei fatti come tecnica della costruzione di
senso e della imputazione degli eventi e utilizza in
particolare la rappresentazione del presente come unità
della distinzione di passato e futuro. Questi orizzonti
temporali della inattualità, come li chiama Luhmann,
vengono resi attuali come alternative. Tra di essi, in
quanto alternative, si delinea una situazione
decisionale. Su questo piano temporale si costruisce
l’operazione che viene chiamata decisione giuridica, ma
che in realtà è il processo attraverso al quale il
sistema del diritto, in questo senso la giurisprudenza,
costruisce ciò che usa come realtà. L’idea delle
conseguenze della decisione giustifica l’inattualità
delle previsioni, del calcolo, delle proiezioni e
lascia aperta la possibilità di prendere altre
decisioni quando l’attuale orizzonte futuro sarà
diventato un presente.
18
5.
Il concetto di giurisprudenza include due complessi di
operazioni che in tedesco vengono qualificate come
Reichtfindung e Rechtsprechung. L’attività giurisprudenziale
è costituita dalla ricerca del diritto, ma anche dalla
pronunzia del diritto. Il diritto deve essere cercato e
parlato. E chi parla il diritto esercita un potere sul
mondo. E’ il potere di costruire una distinzione. Alla
originaria in distinzione della parola, del pensiero e
della realtà, che era l’indistinzione del logos, il
diritto sostituisce la distinzione di ciò che è
conforme al diritto e ciò che non è conforme al
diritto. E poiché ogni distinzione è operata da un
osservatore, in questo caso l’osservatore è la ragione.
Che diventa ragion di stato, potere, politica,
monopolio, stato di necessità, interesse generale,
ordine, pubblico, privato, inclusione, esclusione. E
poiché le leggi non si obbediscono perché sono giuste,
ma perché sono poste, la parola che dice la legge deve
essere parola scritta, così come la decisione che dice
il diritto deve essere decisione scritta.
Il diritto parlato viene usato nella situazione
immediata, nel caso specifico. Nella parola inizio e
fine coincidono. La parola viene detta e si consuma
perché non ha durata, essa è legata all’evento. Il
19
testo viene fissato perché sia disponibile per usi
futuri. Come il caso singolo, come l’evento, la parola
parlata non può essere ritirata. Il testo, invece, può
essere trasformato, rivisto, riformulato. Il testo
esprime il diritto, ma non è il diritto. Con il testo
si pratica e si riconosce la differenza tra senso
testo. Da questa differenza scaturiscono altre
differenze: la differenza tra testo e contesto, tra
testo e interpretazione, tra senso e contesto, tra il
senso intenzionato e il senso espresso, tra il senso
del presente della produzione del testo e il senso dei
differenti presenti della interpretazione del testo. In
altri termini si fissa la differenza tra identità e
differenza. È chiaro che la testualizzazione del
diritto apre lo spazio di grandi possibilità evolutive
perché si presta al riconoscimento di imprevedibili
possibilità combinatorie che derivano non solo dalla
trasformabilità del testo, ma dalle continue,
imprevedibili forme di ricomposizione dell’unità delle
rispettive differenze tra testo e ciò che di volta in
volta si isola rispetto al testo. Queste differenze
riproducono il fondamento mistico dell’autorità che
pone il diritto, come diceva Motaigne, ma operano
indipendentemente dalla continua riattivazione di quel
fondamento. Il testo parla da sé anche se si espone
20
all’interpretazione e può essere interpretato in modi
differenti. Il fondamento mistico si laicizza e diventa
fonte del diritto e la fonte si legittima da sé perché
non può pronunziare l’illecito. Essa è fonte del
diritto. Solo l’interpretazione può porre limiti
all’interpretazione e la plausibilità degli argomenti
che si utilizzano nell’interpretazione dipende dal
fatto che nell’interpretazione essi vengano
riconosciuti come argomenti dell’interpretazione. Si
afferma così la separazione di diritto e verità, di
diritto e ordine del mondo e si fa strada la
corrispondenza tra ordine argomentativo, ordine del
linguaggio e ordine del mondo: da ultimo tra linguaggio
ed esperienza del diritto. Si condensa così nel diritto
attraverso la giurisprudenza una memoria collettiva
della società; il diritto condensa sapere sul mondo
come sapere sul diritto. E questo sapere, come ogni
sapere, si espande e si universalizza attraverso l’uso
ricorsivo della differenza tra ciò che è ammesso e ciò
che non è ammesso: nel caso specifico, attraverso l’uso
della distinzione tra ciò che è diritto e ciò che non è
diritto. E di conseguenza diventa chiaro che quanto più
si espande lo spazio del diritto, tanto più si espande
lo spazio di ciò che non è diritto. O, in altri
termini, quanto più si espande il sapere, tanto più si
21
espande il non-sapere. In particolare il non-sapere del
diritto. Il diritto espresso nei testi, raccolto nei
testi, diventa fondamento identico della costruzione di
opinioni differenti. Nella memoria sociale si possono
condensare i testi e le interpretazioni dei testi, fino
alla indistinzione degli uni e delle altre e alla
attivazione di tecniche che ristabilizzano la
differenza secondo una gerarchia interna. Ma si arriva
anche alla stabilizzazione di regimi del diritto per i
quali l’interpretazione utilizza come testo la ragione
che si considera fissata nello spazio universale di
alcuni principi e la differenza rilevante non è più la
differenza tra senso e testo, ma la differenza tra
identità e differenza dei casi singoli.
Ogni determinazione di senso riattiva le possibilità
rimosse, apre continui orizzonti di senso, include
proiezioni devianti, esclude come irrilevante senso
stabilizzato. La continua apertura del senso esclude
non solo la corrispondenza di diritto e verità, ma
anche ogni causalità; essa rende obsoleta la
circolarità di natura, ragione e diritto e crea i
presupposti evolutivi per la continua rigenerazione
della memoria del diritto.
Questo diritto utilizza e rende possibile una
continua espansione della dimensione temporale della
22
comunicazione sociale. Esso non ha necessità di una
conservazione stabilizzante del senso giuridico, del
sapere giuridico della società. Quel senso è un
orizzonte aperto all’improbabilità; una volta fissato
quel senso è proiettato verso il futuro, ma è disposto
nel futuro ad ammettere continue improbabili
determinazioni.
La stabilità del senso si rafforza perché nuovo senso
può essere determinato. Il diritto vale perché può non
valere. L’agire si orienta al diritto nella aspettativa
di ottenere il riconoscimento del proprio diritto. Il
diritto positivo acquista così il carattere di una
promessa, di una determinazione che si realizzerà solo
nel futuro; il diritto sta sempre per realizzarsi, in
ogni sua affermazione si produce la metafora dell’idea
cristiana di giustizia. La verità dopo la fine; il
giudizio dopo che la storia è già passata. La giustizia
del diritto dopo il riconoscimento giurisprudenziale
della sua violazione.
6.
Memoria di un sistema non è un deposito, non è ricordo
o trasmissione di dati o di ricordi. Memoria di un
sistema è una funzione che si sviluppa quando il
23
sistema osserva le relazioni tra le sue trasformazioni
interne e le correla. Attraverso questa funzione il
sistema è presente a se stesso e sa di essere un
sistema autodeterminato. Memoria è quindi una funzione
dei sistemi che temporalizzano operazioni ricorsive
simultanee. Anche il diritto, allora, ha una memoria.
Anche il diritto opera continuamente in una
atemporalità che gli eventi che il diritto usa come
realtà trasformano in presente. Il diritto conosce la
contingenza della sua attività e sa che ha assoluta
necessità di controllare la consistenza della sua
costruzione degli eventi, cioè del suo stato di
autoirritazione. Questo problema diventa sempre più
rilevante quanto più si estende l’ambito cognitivo del
diritto. Il diritto, allora, ha bisogno di essere
presente a se stesso in ogni sua operazione. La
presenza riguarda la possibilità di confrontare
costruzione e trattamento dei casi. In questo confronto
il diritto ricorda e dimentica. E’ un continuo
oscillare nel quale il diritto osserva i suoi artefatti
e attraverso questa sua osservazione tiene presente sé
a se stesso. E’ qui che è all’opera la funzione
memoria. Essa permette di considerare come oggetti
valori del sistema, stati del sistema, e quindi di
trattarli come concetti propri del sistema, come suoi
24
fossili, come tracce impresse nei suoi sedimenti. In
questo modo il diritto fa esperienza con se stesso.
Esso cioè ridetermina il suo passato e si costruisce
il suo presente come spazio di libertà, cioè come
estensione temporale che rende possibile retrospettiva
e prospettiva. Questa funzione memoria opera nella
costruzione del presente come realtà del diritto. La
giurisprudenza opera come questa funzione memoria del
sistema del diritto. E come diceva von Foerster, il
sistema è la sua memoria ed è allo stesso tempo
destinatario della sua memoria.
25