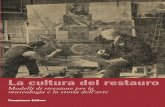Veleia a Parigi. La collezione di bronzi veleiati della Bibliothèque Nationale de France: un...
Transcript of Veleia a Parigi. La collezione di bronzi veleiati della Bibliothèque Nationale de France: un...
Atti del IV Convegno Internazionale di Studi VeleiatiVeleia-Lugagnano Val d’Arda, 20-21 Settembre 2013
a cura di Pier Luigi Dall’Aglio, Carlotta Franceschelli, Lauretta Maganzani
ESTRATTO
Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati
La pubblicazione di questo volume ha ricevuto, sulla base di una valutazione dei risultati della ricerca in essa espressa, il contri-buto finanziario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, del Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna, del Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia e di Centrufficio srl (Piacenza).
© 2014 Ante Quem
Ante Quem Via Senzanome 10, 40123 Bolognatel. / fax 051 4211109www.antequem.itISBN 978-88-7849-093-2
Finito di stampare nel mese di ottobre 2014 da Luoghinteriori, Città di Castello (Pg)
Enti organizzatori
In collaborazione con
Comune di Lugagnano Val d’Arda
Università di Bologna - DiSCi
Università di Padova - dBC
Centro interuniversitario di studi sullacenturiazione “Nereo Alfieri - Luciano Bosio”
Università Cattolica del Sacro Cuore - Istituto Giuridico
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’AmbienteUniversità di Pavia
Centre d’Histoire Espaces et CulturesUniversité Blaise Pascal - Clermont-Ferrand
MiBACT - Soprintendenza per i BeniArcheologici dell’Emilia Romagna
Associazione Culturale“Circolo Culturale Valtolla”
Associazione Culturale“Via dei Monasteri Regi”
Comune di Piacenza
Comitato scientifico
Helena Paula Abreu de CarvalhoDepartamento de História, Universidade do Minho, Portugal
Gino BandelliDipartimento di Studi Umanistici, Università di Trieste
Pier Luigi Dall’AglioDipartimento di Storia Culture Civiltà, Università di Bologna
Carlotta FranceschelliCentre d’Histoire « Espaces et Cultures », Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, France
Philippe LeveauCentre Camille Jullian, UMR 7299, Université Aix-Marseille, France
Lauretta MaganzaniIstituto Giuridico, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Guido RosadaDipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell’Arte, del Cinema e della Musica, Università di Padova
Domenico VeraDipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società, Università di Parma
Comitato organizzatore
Pier Luigi Dall’AglioDipartimento di Storia Culture Civiltà, Università di Bologna
Carlotta FranceschelliCentre d’Histoire « Espaces et Cultures », Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, France
Lauretta MaganzaniIstituto Giuridico, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Guido RosadaDipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell’Arte, del Cinema e della Musica, Università di Padova
Sergio EfosiPresidente Associazione Culturale “Via dei Monasteri Regi”
Fausto FerrariPresidente Circolo Culturale Valtolla
IndIce
Intervento dell’Assessore alla Cultura, Istruzione e Turismo del Comune di Lugagnano Val d’Arda 9
Saluto dell’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Piacenza 11
Presentazione del Direttore del Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna 13
Saluto del Soprintendente per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna 15
Il contributo delle associazioni localidi Sergio Efosi, Fausto Ferrari 17
Introduzione al volume. Attorno a Veleia romana: la Tabula Alimentaria e altre questioniPier Luigi Dall’Aglio, Carlotta Franceschelli, Lauretta Maganzani 19
Parte Prima
antichità veleiati
Le prime edizioni critiche dei Monumenta epigrafici di Veleia e di Eraclea. Polemiche culturali e ideologiche, criteri scientifici, formule ermeneutiche ed approcci epistemologiciFabio Martelli, Eleonora Tossani 29
Veleia a Parigi. La collezione di bronzi veleiati della Bibliothèque Nationale de France: un aggiornamento degli studi archeologico-antiquariMarco Cavalieri 41
Un’altra testimonianza su Veleia AugustaGiovanni Mennella 61
Parte seconda
attualità della ricerca archeologica nel territorio veleiate
Nuovi dati sull’architettura residenziale a Veleia: lo scavo della domus nel quartiere nord-orientaleMonica Miari, Cristian Tassinari, Martina Faedi 69
Dalla cartografia settecentesca alla computer grafica: proposta di rendering del Foro di VeleiaAnnamaria Carini, Manrico Bissi, Cristian Boiardi 79
La necropoli in località Pallastrelli di Castell’ArquatoRoberta Conversi, Cristina Mezzadri 85
Il sepolcreto prediale di Chiavenna Rocchetta (Piacenza) Annamaria Carini 99
Gentes veleiati nella stele di Valeria Nardis da Pianello Val Tidone Elena Grossetti 107
La schedatura elettronica delle iscrizioni veleiati per la banca dati EDR Petra Possidoni, Viviana Pettirossi 121
La produzione laterizia nei pagi veleiati occidentali. Conferme e novitàAnnamaria Carini 127
Parte terza
la Tabula alimenTaria
La Tabula Alimentaria veleiate e la sua rilevanza nel campo fisico-territoriale e di uso del suolo Pier Luigi Dall’Aglio, Giuseppe Marchetti 145
L’obligatio praediorum nella Tabula Alimentaria veleiate: profili tecnico-giuridiciLauretta Maganzani 157
Libertas restituta: de la politique agraire à la politique alimentaire de NervaElla Hermon 169
Struttura delle dichiarazioni ed evoluzione del territorio e della proprietà fondiaria nella Tavola di VeleiaGiorgio Petracco, Giulia Petracco Sicardi 179
Paesaggio ed uso del suolo a Veleia alla luce della Tabula Alimentaria: nuove ipotesi ricostruttiveIlaria Di Cocco 193
Per vada ad alluviones. Gli incrementi fluviali nella Tavola di Veleia Marco P. Pavese 209
Les professiones à l’origine de la Table de Veleia : quelques réflexions sur l’enregistrement des biens-fonds dans le monde romainBéatrice Le Teuff 223
Gli Alimenta di età traianea: un programma per le élites locali? Alessandro Roncaglia 233
Potere politico e infanzia disagiata: dalla Tabula Alimentaria di Veleia alla legislazione tardoanticaChiara Corbo 247
Parte quarta
il confronto con le altre realtà territoriali: l’italia
Dinamiche insediative della romanizzazione in Daunia: fra Dauni, Sanniti e Romani Maria Luisa Marchi 265
Il limes campano-sannita dei Monti Trebulani nella media valle del Volturno. Un esempio di sistema fortificato d’altura di età preromana in Campania settentrionale Claudio Calastri 279
Le aree interne della Basilicata meridionale tra mondo lucano e romanizzazione: l’alta valle dell’Agri Francesco Tarlano 285
Il territorio dei Vestini Cismontani: dagli insediamenti d’altura alle praefecturae Stéphane Bourdin 299
Piceno meridionale e Sannio vestino: gli insediamenti preromani e le opzioni di Roma Luisa Migliorati 313
La ricostruzione del paesaggio antico nell’Appennino centrale. Alcune considerazioni metodologichePaolo Campagnoli, Enrico Giorgi 331
Popolamento e geografia fisica nell’Appennino marchigiano: le valli di Misa e Cesano Pier Luigi Dall’Aglio, Enrico Giorgi, Michele Silani 345
Monumentalizzazione degli spazi pubblici e partecipazione alla vita politica nel municipium romano di Ostra (Ostra Vetere, Ancona)Pier Luigi Dall’Aglio, Carlotta Franceschelli, Cristian Tassinari 355
Transizioni. Aspetti delle campagne dell’entroterra maceratese tra tardoantico e altomedioevo Umberto Moscatelli 379
Economia e popolamento nelle aree montane di Umbria e Marche tra antichità e MedioevoMarco Destro 397
Parte quinta
il confronto con le altre realtà territoriali: le Province
El proceso previo a la fundación de las ciudades romanas en el NE de la Hispania Citerior: los ejemplos de Can Tacó y Puig CastellarEsther Rodrigo, Joaquim Pera, Cèsar Carreras, Núria Padrós, Núria Romaní, Josep Ros, Josep Guitart 405
Il processo di dissoluzione delle società iberiche nell’ambito della municipalizzazione romana nell’Indigezia (Hispania Citerior) Josep Burch, Alba Varenna, Jordi Vivo 419
Quel modèle de développement régional pour le Massif Central à l’époque romaine ? Essai d’application du modèle « centre/périphérie » au cas de la cité des ArvernesFrédéric Trément 433
Ocupación y explotación de espacios altimontanos pirenaicos en la antigüedad: visiones desde la arqueología del paisaje Josep M. Palet, Arnau Garcia, Hèctor A. Orengo, Santiago Riera, Yannick Miras, Ramon Julià 455
Occupation et modes d’exploitation de la montagne dans les cités romaines de Gaule Narbonnaise orientalePhilippe Leveau 471
Peuplement et organisation du paysage dans la partie occidentale du Conventus Bracarensis Helena Paula A. Carvalho, Mário da Cruz 487
Elenco degli autori 495
41
Antichità veleiati
Veleia A PArIgI. lA collezIone dI BronzI veleIAtI dellA BIBlIothèque nAtIonAle de frAnce: un AggIornAmento deglI studI ArcheologIco-AntIquArI
Marco Cavalieri1
IntroduzIone
È noto che il bronzo fosse tra i materiali più nobili della statuaria antica: per tal motivo ogni collezio-ne di Antichità acquisiva tanta più importanza quanto più numerosi erano gli oggetti enei in essa raccol-ti. Fin dal Rinascimento, infatti, la ricerca di bronzi si era diffusa tra i collezionisti di tutta Europa, tanto che, essendo rarissime le statue vere e proprie di bronzo provenienti da scavi, si ripiegò ben presto sulle statuette ed anche sulle copie, o su imitazioni di ogni sorta, talora scambiate per originali. Ne derivò una produzione di bronzetti ispirati all’antico per stile e soggetto, che la critica moderna talora a fatica riesce a stabilire se prodotti come imitazioni – realizzate per rivaleggiare con l’Antichità – o come falsi, con una deliberata intenzione di frode nei confronti dei possibili acquirenti o destinatari. Questa ambiguità, che caratterizza molte collezioni pubbliche e private, fa sì che tra i bronzetti conservati se ne celino alcuni ritenuti antichi, ma per i quali è quasi d’obbligo sospettare che siano moderni, senza talora poter essere sufficientemente tranchants sulla questione. Ne consegue che risulti difficile stabilire se i collezionisti fos-sero sempre capaci o coscienti nella distinzione tra originali, copie ed imitazioni, e se la loro conoscenza della materia fosse sufficiente per essere davvero degli esperti o semplicemente degli esteti; quand’anche non si trattasse di antiquari, in tal caso interessati, e per fini meno nobili, a diffondere sul mercato euro-peo collezioni d’Antichità che d’antico talvolta avevano solo l’aspetto, certo non la produzione.
Tali considerazioni possono valere anche per la collezione di bronzetti d’età romana provenienti dal municipium di Veleia, fin dal XVIII secolo conservati per la maggior parte presso il Ducale Museo di An-tichità di Parma, in minor numero esportati in Francia, per volontà stessa degli scavatori di allora e su consiglio del Governo ducale, all’attenzione di uno dei più famosi eruditi ed archeologi del tempo, Anne Claude Philippe de Turbières, conte di Caylus.
Proprio sui materiali ceduti al Caylus e dalle raccolte di questi, a seguito di alterne vicende, arrivati al Département des Monnaies, Médailles et Antiques (meglio noto come Cabinet des Médailles) della Bibliothèque nationale de France, si attesterà la nostra attenzione, con due obiettivi principali: riprendere ed aggiornare lo studio storico-stilistico dei pezzi e fornire qualche nuova considerazione in merito alla vicenda antiquaria di alcuni esemplari.
L’interesse per i bronzetti risale fin alla fondazione del Museo Archeologico Nazionale di Parma, nel 1760, che doveva, negli intenti del duca don Filippo di Borbone, rimediare al vuoto lasciato dal trasferi-mento della collezione Farnese a Napoli, al seguito del fratello Carlo.
Evidentemente al fine d’incrementare il più rapidamente possibile le collezioni ducali, la città di Ve-leia divenne al momento della scoperta una sorta di deposito ritenuto ben più ampio e ricco di quanto la realtà archeologica poi mostrò negli anni. Per tal motivo, illustri studiosi, pur non sempre chiarendo mo-dalità e tempi, pensarono ad un inserimento tra i materiali di falsi, alcuni dei quali inviati a Parigi presso il garante della scientificità degli scavi veleiati, il conte di Caylus. Oggi, dopo alcune più approfondite ricerche di carattere archivistico, stilistico e archeometallurgico sugli esemplari più dubbi di Parma2, possiamo ritenere che i materiali spuri siano da considerare in quantità ben più limitata, riattribuendo così il giusto valore alla collezione parmense.
Per quanto, invece, attiene ai bronzetti veleiati a Parigi, pur essendoci limitati ad un approccio esclu-sivamente stilistico-archivistico, si è giunti alla conclusione che, se un pezzo dubbio, anzi certamente
1 Le schede del catalogo nrr. 2-3 sono a cura di Debora Barbagli e l’Appendice è di Roberta Conversi.2 Ci riferiamo in primis al noto Hercules bibax per il quale si rimanda a cavalieri, conversi, giumlia-mair c.s.
42
Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati
falso (nel senso di non eseguito in età romana), compare nella collezione, il suo invio Oltralpe non deve essere considerato come un tentativo di frode intellettuale ai danni del destinatario, il conte di Caylus, tantomeno quale prova di una scarsa competenza degli archeologi ducali; è più probabile, invece, che l’oggetto sia spurio rispetto alla provenienza veleiate – non è mai citato nei giornali di scavo – verosimil-mente più per un passo falso politico che per volontà della direzione degli scavi.
veleIA ed Il conte dI cAylus
Lo studio dei disiecta membra enei di Veleia, conservati al Département des Monnaies, Médailles et Antiques della Bibliothèque nationale de France a Parigi, non può prescindere dalle ragioni storiche del loro espatrio e dalla personalità di colui cui furono destinati. Senza voler riprendere un tema ampiamente studiato anche di recente3, occorre ricordare che, dopo le deludenti esperienze di gestione degli scavi e dell’edizione della Tabula Alimentaria da parte del canonico Antonio Costa, conclusesi nell’ancor più con-troversa redazione del manoscritto (rimasto inedito) Raccolta dei monumenti di antichità che col mezzo dei R. Scavi si sono tratti dalle viscere della città dei Veleiati, I, 1760, II, 1761-1762 (Biblioteca Palatina di Parma, ms. 1246-1247), nel 1763 l’incarico di prefetto del Museo e direttore delle ricerche in situ fu attribuito al padre teatino Paolo Maria Paciaudi, amico e corrispondente del Caylus. Insieme essi si erano resi respon-sabili dinnanzi al Governo ducale, rappresentato dal suo primo Ministro, Guillaume-Léon du Tillot, della destituzione del Costa. Proprio il du Tillot era stato il tramite primo tra Caylus e Paciaudi da un lato e Costa dall’altro: il ministro, infatti, era preoccupato dal ristagno nell’avanzamento dei lavori d’edizione della Tabula, studio affidato al Costa, ma soprattutto vedeva scemare il rilancio politico che il piccolo ducato contava di poter sostenere anche mediante l’attività culturale di uno scavo, quello di Veleia, in qualche modo emulo dell’esperienza napoletana sia sotto il profilo culturale sia editoriale.
Nonostante il fatto che le indagini archeologiche riprese a Veleia dal Paciaudi non avessero conseguito risultati soddisfacenti, politicamente si era ottenuto il meglio sperato, cioè l’edizione di alcuni materia-li veleiati, in larga misura bronzetti, sul monumentale Recueil d’antiquités égyptiennes, étrusques, grecques, romaines et gauloises in sette volumi, pubblicato a Parigi dal Caylus tra il 1752 ed il 17654. In tal modo il ducato e la sua maggior impresa culturale avrebbero potuto godere di un’amplissima visibilità inter-nazionale, così come avevano orchestrato in primis lo stesso duca don Filippo ed il suo Governo, i quali erano riusciti a far dono al Caylus di diversi oggetti veleiati, affinché egli li studiasse, ma soprattutto li pubblicasse – dopo qualche insistenza mediata dall’abile diplomazia del Paciaudi5 – sul suo Recueil6. Ed in effetti, la diffusione delle ricerche veleiati non tardò, come riportano le pagine d’incipit nell’opera7:
« Une ville ancienne trouvée dans un lieu nommé aujourd’hui Macinisso, situé dans le voisinage de Plaisance, est une des curiosités de ce siècle. J’ai du moins le plaisir d’annoncer cette découverte au Monde curieux et de prouver la certitude de cet évènement par les figures de bronze dont cette planche est remplie. Ces monuments ont été trouvés dans le terrein (sic!) que cette ville occupoit autrefois, long-temps avant que l’on eût commencé la fouille entreprise depuis quelques mois, avec l’intelligence et les soins dont M. du Tillot est capable pour l’exécution des ordres et des désirs de l’Infant ».
E di seguito la promozione si fa anche più incisiva, toccando gli scavi, il ducato, il suo Governo e gli incaricati delle attività archeologiche:
« Ces fouilles magnifiques dans lesquelles on découvre des villes entières, semblent réservées pour les Princes de la Maison de France établis en Italie: les soins qu’ils daignent y donner, leur assurent une gloire durable, et non moins précieuse que les conquêtes. Nous n’avons rien à désirer sur les soins de la fouille, et nous pouvons être tranquilles sur l’histoire et les détails que nous sommes en droit d’espérer: l’étude
3 Parente 2007b, pp. 29-67.4 aghion 2002b, pp. 19-27.5 Il 15 luglio 1763 Paciaudi riporta all’illustre corrispondente quanto espresso dal duca di Parma, « Je voudrais bien trouver
quelque chose qui fît plaisir à M. De Caylus, pensez-y, je vous en charge » e oltre, ritornando sul tema, « Quoique [...] tout soit envoyé chez l’imprimeur, je parie que vous ferez la politesse à l’Infant d’ajouter une planche pour parler de Velleia »; BaBelon 1928, pp. 26-28.
6 Parente 2007a, pp. 19-21; alBasi, magnani 2010, pp. 1-44.7 Recueil, Antiquités romaines, IV, pp. 182-183.
43
Antichità veleiati
et les talents sont fêtés et caressés à Parme; ce bon goût nous répond de la capacité des sujets qui seront chargés du soin de transmettre aux siècles à venir ce grand monument de l’antiquité ».
Va sottolineato comunque che l’interesse del Caylus per i materiali veleiati non era teso a farne una collezione, bensì uno studio di carattere tecnico-archeologico, come egli stesso sottolinea in una famosa lettera al Paciaudi8:
« Je vous prie toujours de vous souvenir que je ne fais pas un cabinet, que la vanité n’étant pas mon objet, je ne me soucie point de morceaux d’apparat, mais que des guenilles d’agate, de pierre, de bronze, de terre, de vitre, qui peuvent servir en quoi que ce soit à retrouver un usage ou le passage d’un auteur, sont l’objet de mes désirs. Je ne fais point un cabinet, je fais un cours d’antiquité, et je cherche les usages, ce qui les prouve, les pratiques, ce qui les démontre ».
O ancora qualche anno più tardi9:« Mandez-moi s’il serait poli de vous les renvoyer. [...] Ces morceaux sont complets en leur genre ;
ils sont susceptibles d’explications, et le plus grand nombre peut non-seulement tenir sa place dans un cabinet, mais occuper des vignettes et des culs-de-lampe. Je vois donc jusqu’ici que vous avez mal fait ma commission, puisque, dans la vérité, je ne vous demandais que des matières rompues, inutiles, qui pouvaient me conduire à l’examen de leur procédé chimique ».
Gli studi del Caylus, dunque, non puntavano sull’oggetto esteticamente “bello”, ma sulle guenilles, sui rottami, sui piccoli bronzi anche informi: « N’oubliez pas, je vous prie, que les fragments et les morceaux cassés ne me déplaisent pas »10, o, come chiosa il Babelon, « La porte était close aux chefs-d’œuvre ». In altre parole, proprio nel periodo di passaggio dall’erudizione antiquaria all’Archeologia, egli concepisce la metodologia del riscontro autoptico al reperto archeologico, attribuendo tra i primi interesse alla cul-tura materiale, alla suo disegno e al contesto di rinvenimento, al fine di comprenderne la fabbricazione, la funzione e di costituire classi d’analisi utili alla formazione di un sapere tecnico-scientifico11.
Questo approccio contrastava diametralmente con la logica alla base della scelta dei doni inviati da Parma per il conte: materiali che dovevano dare lustro a Veleia e non manufatti modesti e “rotti”, come invece si richiedeva da Parigi per fini ben diversi. In quest’ottica si comprende perché Caylus rifiutò seccamente, rispedendoli al mittente, alcuni bronzetti12, anche di un certo rilievo: tra essi la Vittoria stephanofora (inv. 417, B 14) conservata al Museo di Parma, più adatti a figurare in una collezione di più alto profilo13. D’altro canto, l’interesse ed una certa deferenza nei confronti del duca don Filippo, mossero il conte a prodigarsi per la pubblicazione di altri materiali veleiati non proprio utili ai fini delle sue ri-cerche: è il caso delle tavole LIV-LV del VII volume che Caylus, come egli stesso ricorda sia nel Recueil sia nella sua corrispondenza con Paciaudi, avrebbe voluto inserire ancora nel VI ma senza riuscirvi, giacché gli oggetti, dono dell’Infante, arrivarono dall’Italia quando il volume era già in stampa14.
I mAterIAlI veleIAtI Al DéparTemenT Des monnaies, méDailles eT anTiques dI PArIgI
È proprio su questa dinamica di “scambio” di materiali che va a focalizzarsi la nostra attenzione per comprendere quali e quanti oggetti Caylus trattenne da Parma. In questa analisi si è rivelato strumento fondamentale la versione on line del Recueil, http://caylus-recueil.tge-adonis.fr/, il cui impiego è ripar-tito su tre assi: la consultazione del testo in formato digitale; lo studio della personalità del suo autore mediante una biografia e una copiosa bibliografia di riferimento; un accesso diretto al catalogo degli oggetti in esso repertoriati, presentati attraverso le descrizioni e i disegni dell’opera del Caylus posti a diretto confronto di foto e di analisi formali della più recente ricerca.
8 Lettera di Caylus a Paciaudi, data in Parigi, 12 febbraio 1758; nisard 1877, p. 4.9 Lettera di Caylus a Paciaudi, data in Parigi, 20 novembre 1763; nisard 1877, lXXiiI, p. 376.10 Lettera +di Caylus a Paciaudi, data in Parigi, 7 febbraio 1757; nisard 1877, I, p. 3.11 schnaPP 2002, pp. 53-63; queyrel 2012, pp. 231-239.12 Lettera di Caylus a Paciaudi, data in Parigi, 19 settembre 1763; nisard 1877, LXVIII, p. 348, come la successiva lettera
di Caylus a Paciaudi, data in 26 settembre 1763; nisard 1877, LXIX, p. 353.13 Parente 2007b, p. 57 con bibliografia archivistica di riferimento.14 Recueil, Antiquités romaines, VI, p. 307; Lettera di Caylus a Paciaudi, data in Parigi, 20 novembre 1763; nisard 1877, LX-
XIII, pp. 381-382.
44
Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati
I materiali di provenienza veleiate così recensiti computano ventisei occorrenze: si tratta di piccoli bronzi, terrecotte figurate, frammenti ceramici ed instrumenta, oggetti in alcuni casi non più rintrac-ciabili già da tempo, anche a seguito di alcune dispersioni probabilmente intercorse nella contesa tra il Cabinet du roi (l’attuale Département des MMA della BnF), cui Caylus ancora in vita aveva legato la collezione, e gli eredi che, una volta morto il conte, reclamarono la proprietà anche sulle collezioni d’antichità, ottenendone la restituzione, per poi riconsegnarla a distanza di anni ed in maniera definitiva alla Corona15.
In definitiva i materiali di cui si tratterà constano di dieci bronzetti, di cui, tuttavia, due oggi non più rintracciabili: ne restano le descrizioni del Recueil e, soltanto per uno, anche i relativi disegni16; i restanti otto, come già detto, sono ancora conservati al Département des MMA della BnF a Parigi. È inevitabile che le pagine di seguito prendano le mosse dall’opera ancor oggi incontournable, a più di quarant’anni di distanza, di F. D’Andria sulla collezione dei bronzi veleiati e parmensi17: l’obiettivo certamente non sarà una critica stilistica ai contenuti, piuttosto un loro aggiornamento ed una ripresa, per quanto possibile, dello spinoso dossier sull’autenticità del bronzetto nr. 3 di cui infra.
cAtAlogo
Nella redazione delle schede di catalogo si è scelta una presentazione dei singoli manufatti che ripren-da la successione e le descrizioni del Recueil, ponendole a confronto con quelle realizzate dagli autori: in tal modo si può chiaramente percepire la modernità ed il valore di alcune considerazioni del Caylus, nonché apprezzare il suo metodo, che associava descrizione, disegno e catalogazione funzionale del manufatto.
1. Applique: Vittoria alata (Figg. 1, 1a).Département MMA, BnF, nr. inv. 678.Dimensioni: h 13,3 cm; l. alle ali 11,1 cm.
15 La vicenda è riferita con dovizia di particolari in BaBelon 1928, pp. 5-8.16 Nel primo caso si tratta di « Bacchus enfant ou Amour du vin », Recueil, Antiquités romaines, IV, p. 185, tav. LIX, IV; nel
secondo, di una « Minerve casquée », Recueil, Antiquités romaines, IV, pp. 186-187.17 d’andria 1970, pp. 3-141; a questo testo si rimanda per tutta la bibliografia ad esso anteriore.
1. Applique: Vittoria alata; Département MMA, BnF, nr. inv. 6781a. Vittoria alata, disegno tratto da Recueil, Antiquités romaines, IV, pp. 183-184, tav. LIX, I-II
45
Antichità veleiati
18 Nr. inv. 1135, II sec. d.C., rinvenuto nel 1745 a Industria. Cfr. Bronzi da Industria 1998, pp. 103-105, nrr. 23, 25; Bolla 2007-2011, pp. 45-46, nr. 19.
19 hölscher 1967, pp. 6 ss.; Immagini divine 2007, p. 187.
Lega di rame, fusione cava, a cera persa con rifiniture a freddo mediante bulino. Patina verde.Stato di conservazione frammentario: il braccio destro è lacunoso all’altezza del gomito; il ramo di
palma che si conserva solo nella parte terminale e nella porzione vicina alla mano, persa; delle ali è con-servato solo il palco sinistro.
Data d’acquisizione: 1762.Babelon, Blanchet 1895, pp. 292-293, nr. 678; Babelon 1928, pp. 35-36, nr. 5, tav. III; D’Andria
1970, pp. 39-40, nr. 14, tav. IX.
Nisard 1877, LXVIII, p. 34 e, LXIX, p. 353.Recueil, Antiquités romaines, IV, pp. 183-184, tav. LIX, I-II.« Cette Victoire de bronze est représentée en l’air : l’Artiste qui l’a composé, a pris un moment pareil
à celui que l’on remarque dans les oiseaux lorsqu’ils joignent et étendent leurs pieds, en abattant leur vol pour arriver à terre […]. La Figure … ne pouvoit être placée dans le milieu d’un piédestal ; mais on voit … un tenon … placé au-dessous des reins ; il s’enclavoit dans le corps qui devoit porter le morceau […].
Le travail de ce morceau indique un siècle assez bas ; c’est-à-dire, qu’il est médiocre : sa conservation laisse également à désirer ; il manque une aile et les deux mains à cette Figure, et même une partie de la palme dont elle étoit chargée ».
Il bronzetto raffigura, secondo un’iconografia nota e diffusa, la Vittoria nell’atto di poggiarsi, con gambe unite, sulle punte dei piedi su un globo (non presente); reca un ramo di palma nella sinistra, men-tre il braccio destro è proteso nell’atto di deporre la corona sul capo del vincitore. Indossa un peplo cinto in vita, che fascia la parte posteriore del corpo e si allarga ai lati. In origine si caratterizzava per ampie ali aperte di cui si conserva soltanto il palco di sinistra, ove con profonde e incisioni è sommariamente indicata la scansione delle penne.
Il volto, definito sommariamente, presenta dei caratteri genericamente idealizzati: rotondo e paffuto, è segnato da abrasioni ed incorniciato da capelli scriminati al centro e ritorti a formare un’ampia corona; sulla nuca la scriminatura è accompagnata dalle incisioni ondulate dei capelli distribuiti ai due lati. Il panneggio della veste presenta ampie zone in movimento, secondo un’iconografia tradizionale (ad esem-pio da Industria, Monteu da Po), e nonostante le pieghe siano talora alquanto rigide, l’effetto risulta mi-tigato in taluni punti – il chitone sul ventre – da una certa plasticità; anche il trattamento dell’attributo del ramo di palma risulta alquanto sommario.
Sul retro, la superficie del bronzetto risulta grossolanamente sbozzata. La forma cava della schiena, tra l’attacco delle ali e la presenza, al di sotto, di un perno, dovevano probabilmente in origine servire per l’ancoraggio del pezzo (quindi l’eventuale asta sarebbe passata a qualche distanza dalla parte inferiore della figura).
Pur se abbastanza equilibrata nelle proporzioni, è chiaro che l’impostazione privilegi una visione frontale dell’oggetto che, sulla base di confronti da Industria e Baggiovara, poteva appartenere alla decorazione ad applique di un tripode pieghevole: la comparazione con l’esemplare di Monteu da Po sembra quella più vicina, trattandosi di un bronzo fuso in più parti, poi rifinito a freddo e decorato da figurine ottenute separatamente da matrici, rifinite a freddo e assemblate18.
Quanto all’iconografia, pur provenendo dal mondo greco, essa è ampiamente adottata in contesto ro-mano che, a partire da Augusto, la associa al nuovo corso della storia, la Victoria Augusti. Il tema, legato pertanto all’identità imperiale, risulta corrente nell’arte ufficiale divenendo un diffuso soggetto figurativo che nel tempo perde l’originario significato cultuale-politico, in favore di uno puramente decorativo, tipico delle appliques ornamentali di lusso del mobilio domestico (letti, tavoli, tripodi, bracieri etc.)19.
La qualità del bronzo appare piuttosto grossolana, rendendo piuttosto difficile una circostanziata col-locazione cronologica, che pare comunque potersi ascrivere genericamente al II sec. d.C. ed oltre.
46
Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati
2. Zeus (Figg. 2, 2a). (D. Barbagli).Département MMA, BnF, nr. inv. 59.Dimensioni: h 11,9 cm.Lega a base di rame fusa, cava, a cera persa, rifinita a freddo. Patina verde.Stato di conservazione abbastanza buono, fatta salva la perdita del braccio destro e una scalfittura sulla
fronte ed il piede sinistro restaurato.Data d’acquisizione: a partire dal 1762.Babelon, Blanchet 1895, pp. 27-28, nr. 59; D’Andria 1970, pp. 25-26, nr. 2, tav. I.Recueil, Antiquités romaines, IV, p. 184, tav. LIX, III.« J’ai débuté par le monument précédent, comme le plus singulier de ceux que j’ai pû (sic!) avoir de
Macinisso, et non comme le plus ancien ; je n’aurois pas même balancé à mettre ce Jupiter dans la classe Grecque, si j’avois voulu séparer les monumens (sic!) trouvés dans cette ancienne ville. Ce Bronze est de la plus grande finesse de trait et d’exécution ; la perte de ses deux bras, empêche absolument de lui choisir une épithète dans le nombre de celles que les Anciens ont données à ce Dieu. Le morceau de draperie placé sur son épaule, ne peut être mieux jetté ni mieux travaillé, et la tête est réparée avec autant de jus-tesse que de précision ».
Figura maschile stante, poggiante sulla gamba destra rigida, la sinistra in riposo leggermente flessa e spostata in avanti: alla gamba portante corrispondono il leggero inarcamento dell’anca e la contrazione del fianco. Nuda, fatta eccezione per una lunga clamide, poggiata sulla spalla sinistra, ricadente in ampie pieghe lungo il lato sinistro del corpo fino all’altezza del polpaccio; plasticamente modellate risultano le masse muscolari, soprattutto quelle delle cosce e quelle del torace, che mostra una vigorosa partizione anatomica di pettorali ed addominali, così come un passaggio marcato tra creste iliache e arcata ingui-nale. Posteriormente la schiena è segnata da un profondo solco.
Il braccio sinistro, flesso e coperto dal drappo, è model-lato fino all’avambraccio: nella veduta laterale è in realtà possibile riconoscere tra le pieghe del mantello un’ampia apertura ovale, che lascerebbe ipotizzare quanto già riscon-trato in numerosi bronzetti di divinità, in cui il braccio sinistro, interessato dalla presenza della clamide, doveva essere lavorato a parte20.
La statuetta è priva del braccio destro, in origine vero-similmente disteso lungo il corpo. Ai piedi indossa calzari aperti.
La testa, interessata da una profonda scalfittura al centro dell’arcata sopracciliare, è leggermente flessa a destra ed è incorniciata da una ricca chioma di capelli ondulati, desi-nenti in corti ricci sulla fronte e in più ampi boccoli sulla nuca; una folta barba scende sul collo, chiusa da due ciocche a forbice.
La figura, in cui è da riconoscere una rappresentazione di Zeus reso verosimilmente con il fulmine nella destra e con lo scettro nella sinistra, si inserisce in un cospicuo gruppo di bronzetti romani raffiguranti il dio, di qualità molto diversificata, il cui archetipo sarebbe stato indivi-duato dal Ber-ger nella statua colossale bronzea realizzata da Mirone per l’Heraion di Samo, trasferita a Roma da An-tonio e collocata da Augusto sul Campidoglio21.
20 Kent hill 1982, pp. 277-283.21 Berger 1969, pp. 66 ss.; M. Tiverios in LIMC, VII, pp. 330, 335.
2. Zeus; Département MMA, BnF, nr. inv. 592a. Zeus, disegno tratto dal Recueil, Anti-quités romaines, IV, p. 184, tav. LIX, III
47
Antichità veleiati
Già in precedenza statuette di Zeus erano state accostate ad opere della grande statuaria presenti a Roma in età imperiale: così L. Beschi aveva individuato il prototipo da cui sarebbero discese numerose varianti nella piccola bronzistica nello Iuppiter tonans del tempio capitolino, riferibile secondo Plinio allo scultore Leochares22. Da un lato, se è molto probabile un’eco della grande statuaria sulle produzioni di piccoli bronzi, e in particolare di quella che poteva essere apprezzata a Roma, d’altro canto non si può non sottolineare, come ampiamente evidenziato23, che l’eventuale riflesso mironiano in questo gruppo diversificato di bronzetti non possa che essere vario, se non a volte labile. Gli esemplari, infatti, appaiono diversi per datazione, eventuale area di produzione e caratteri stilistici24.
All’interno delle rappresentazioni del tipo dello Zeus nudo stante con clamide sulla spalla, il nostro esemplare si contraddistingue per la qualità della realizzazione: l’equilibrio della ponderazione policletea, la resa anatomica armoniosa e potente delle masse muscolari di torace, cosce e glutei, la contrazione e il solle-vamento dell’anca in corrispondenza della gamba portante, permettono in effetti di riconoscervi numerosi elementi della tradizione classica di V sec. a.C. Anche il volto presenta caratteri di derivazione protoclassica, nella stessa resa della capigliatura e, per quanto riconoscibile, nel modellato di naso e labbra.
Il bronzetto degli Staatliche Museen di Berlino (HZ 51.51), datato ad età adrianea, appare tra i più vicini al nostro esemplare per impianto generale della figura, ma differisce per una minore plasticità e, ancor più, per la resa di volto e capigliatura.
L’assenza di marcati effetti impressionistici, la levigatezza dei piani e la resa di volto e capelli rendono probabile una datazione del nostro esemplare ancora al I sec. d.C.
3. Vittoria (Figg. 3, 3a) (D. Barbagli).Département MMA, BnF, nr. inv. 681.Dimensioni: h 21,5 cm.Fusione in lega a base di rame, piena,
a cera persa, ampiamente rifinita a freddo. Patina brunastra.
Spezzato l’indice della mano destra, corrosioni al piede destro e all’orlo inferio-re del peplo; perduti ali ed attributi.
Data d’acquisizione: a partire dal 1762.Babelon, Blanchet 1895, p. 294, nr.
681; D’Andria 1970, p. 37, nr. 12, tav. VII; Marini Calvani 1979, p. 243, nr. 461.
Recueil, Antiquités romaines, T. IV, p. 186-187, pl. LIX, V. « Cette autre Victoire drapée à la Romaine, et représentée dans l’action de marcher avec assez de mouve-ment, a perdu ses deux ailes, ainsi que les attributs dont ses mains étoient chargées : sa coiffure formée par ses cheveux relevés et renoués sur le haut de la tête, est très bien disposée, et d’une façon peu commune. Cette Figure dont la conservation n’est pas mauvaise, est bien traitée; il faut cependant convenir qu’il y a trop de manière et trop d’affectation dans les plis de la draperie […]. On remarque sur cette Figure une espèce de gilet ample et qui n’a point de manches; il est arrêté par une ceinture placée au-dessous de la gorge […]. Ce bronze paraît être de la même époque que le précédent ».
3. Vittoria; Département MMA, BnF, nr. inv. 6813a. Vittoria, disegno tratto dal Recueil, Antiquités romaines, IV, pp. 186-187, tav. LIX, V
22 Beschi 1962, pp. 71-77.23 menzel 1994, p. 190; Canciani in LIMC, VII, p. 430.24 Si veda la statuetta da Pompei, nr. inv. 111022; Pompéi. Un art de vivre 2011, p. 79, nr. 33.
48
Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati
Il bronzetto rappresenta una figura femminile stante, in movimento verso destra. Indossa un peplo smanicato, cinto sotto il seno e con ampio apoptygma, che avvolge in pieghe aderenti le gambe e si allarga ai lati.
La figura, rappresentata in leggera torsione, insiste sulla gamba destra portante; la sinistra, piegata, è leggermente discosta ed arretrata. Il braccio destro è disteso in avanti e sollevato a formare un’ampia apertura; la mano doveva in origine sostenere un attributo, molto probabilmente una corona. Il braccio sinistro è piegato e avvicinato al corpo, la mano, socchiusa, doveva recare anch’essa un oggetto.
La testa, volta a destra, è incorniciata da una folta capigliatura a larghe ciocche, fissata in uno chignon sulla nuca; quattro riccioli scendono lungo il collo. Il volto, leggermente allungato, è fortemente marcato dalla linea arcata sopracciliare-naso che delimita le profonde cavità orbitali.
Sulle schiena, all’altezza delle scapole, sono due ganci frammentari, verosimilmente destinati all’inse-rimento delle ali, realizzate forse a parte. Indossa sandali ai piedi.
Nel bronzetto che si libra in aria e che verosimilmente doveva essere applicato ad un supporto, è da riconoscere una figura di Vittoria alata, come lasciano intendere anche i due “innesti” presenti sulla schiena per sostenere le ali.
La figura ripete in effetti un’iconografia ampiamente diffusa in età ellenistica, quella della Nike in volo, che trova il suo più ampio sviluppo in una serie di terrecotte prodotte tra inizi II e I sec. a.C. e rinvenute a partire dal 1878 a Myrina (Lemnos)25: in tale produzione, come più volte sottolineato26, si codificano pochi tipi che differiscono per singoli elementi, quali la posizione delle braccia, la resa della testa e gli attributi.
Proprio nelle figure femminili di questa produzione fittile il bronzetto sembrerebbe avere i confronti più stringenti per singoli aspetti della realizzazione, in particolare per l’impostazione, il tipo di veste, l’apertura delle ali (supposta nel pezzo), la presenza degli attributi, la resa della capigliatura. Inoltre, è possibile che il bronzetto mostrasse nella destra sollevata una corona, come ben attestato anche in altre terrecotte mirine (LIMC, VI, p. 884, tipo 1) e più in generale nelle rappresentazioni codificate della fi-gura nel mondo antico; la forma socchiusa della mano sinistra, invece, lascerebbe pensare ad un oggetto forse astato o ad un ramo di palma.
Pochi invece, per non dire assenti, i confronti stringenti con la piccola bronzistica.Ad un esame più analitico, in effetti, l’opera denuncia anche una serie di elementi anomali per un
bronzetto antico, tanto da certificarne la modernità da parte di D’Andria e della Marini Calvani27. Per-plessità sull’impostazione stilistica sono già adombrate nel Recueil, ove si parla di un drappeggio delle vesti «alla romana» e di una sua realizzazione, per così dire, leziosa; al commento, poi, si aggiunga il fatto che il Caylus, non indica una datazione del pezzo, affermando: « Ce bronze paraît être de la même époque que le précédent », senza però precisare di quale epoca si tratti.
In particolare, colpisce la resa del volto, con le grandi cavità orbitali e l’aspetto quasi di maschera dell’insieme; la capigliatura, inoltre, che sembra imitare malamente il tipo della Melonenfrisur.
Ancora, il ductus delle pieghe della veste, ripetute in sottili strisce che coprono tutta la superficie disponibile e quella della cintura che segna il punto vita risultano abbastanza anomale nella produzione antica: esse richiamano, amplificandole, in una traduzione quasi calligrafica, le ampie pieghe dell’himation che avvolge la celebre figura di danzatrice velata da Industria28.
Non ultimo il colore scuro del bronzo, la cui superficie è particolarmente levigata e la studiata distri-buzione di una “patina all’antica”, lasciano molti dubbi sull’autenticità del pezzo, o piuttosto, su una sua collocazione in epoca ellenistico-romana.
Il pezzo potrebbe trovare una collocazione stilistica in alcune formule espressive dell’arte francese del XVIII29 in cui, accanto a terrecotte e bronzi antichi, figuravano opere ritoccate e palesi falsificazioni. A questo proposito vorremmo ritornare sull’accostamento del pezzo alle terrecotte mirine: i confronti pro-posti presentano un’evidente discrepanza cronologica tra la presenza del bronzetto nella collezione del
25 Jeammet 2007b, p. 40.26 Grote in LIMC, VI, p. 903.27 d’andria 1970, p. 37, nr. 12; marini calvani 1979, p. 243, nr. 461.28 Bronzi da Industria 1998, pp. 95-96.29 mathieuX 2007.
49
Antichità veleiati
Caylus (morto nel 1765) e le scoperte delle tombe a Myrina che, come detto, datano tra 1870 e 188230. La difficoltà di poter riscontrare la presenza di eventuali sporadiche terrecotte in collezioni settecente-sche, per lo scarso interesse che a quella data tali oggetti suscitavano nei collezionisti (salvo in Caylus, ovviamente!)31, impone un’evidente cautela. Pur rimanendo la suggestione dell’accostamento, la Vittoria sarà da ricondurre più probabilmente, come già accennato, a quella temperie culturale di gusto francese, che tante opere ha prodotto ispirate all’antico e che soprattutto nella Parma di Filippo di Borbone trovò ampia diffusione.
4. Gancio in forma di dito (Figg. 4, 4a, 4b).Département MMA, BnF, nr. inv. 1080.Dimensioni: lungh. 11 cm.Fusione in lega a base di rame, da ottima matrice, rifinita a freddo e lucidata. Patina verde scuro.Stato di conservazione buono.Data d’acquisizione: 1765.Babelon, Blanchet 1895, p. 464, nr. 1080; D’Andria 1970, p. 95, nr. 140, tav. XXX.Recueil, Antiquités romaines, T. VI, pp. 306-307, pl. XCVIII, III.« Cette tête de clou dont le crochet est formé par un doigt ployé, n’est pas ordinaire à rencontrer. On
ne peut, ce me semble, attacher aucune idée de superstition à cet arrangement; et je crois qu’on ne le
30 EAA, V, p. 307. 31 mathieuX 2007, p. 45: « Avant 1870 en effet, les statuettes en terre cuite ne bénéficient pas d’un grand prestige et ne
peuvent donc pas faire l’objet d’un intérêt exclusif, elles n’existent que comme complément ou ajout à un ensemble dont la valeur est ailleurs... ».
4. Gancio in forma di dito; Département MMA, BnF, nr. inv. 1080
4a. Gancio in forma di dito, disegno trat-to dal Recueil, An-tiquités romaines, VI, pp. 306-307, tav. XCVIII, III
4b. Maniglia in for-ma di dito, disegno eseguito da G. Per-moli (MS 49 Costa 1760, tav. XII)
50
Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati
peut attribuer qu’à la seule fantaisie: du reste, le clou étoit assez fort pour porter un poids considérable. On voit encore derrière la plaque de la marque de la soudure qui lioit la tête à la queue, ou, si l’on veut, à la pointe du clou; cette dernière partie paroît avoir été de fer ».
L’oggetto è costituito da una robusta sbarra allungata, di forma trapezoidale, cui è saldato un disco bronzeo perpendicolare alla maniglia, che serviva evidentemente da fermo. L’impugnatura è configurata con la parte finale di un dito indice maschile, di dimensioni superiori al vero, modellato con cura, come si osserva dall’unghia e dalle caratteristiche anatomiche dell’arti-colazione. Oggetti molto simili, ancor-ché con dimensioni diverse, da mettere in relazione ad una loro funzione non univoca, sono ampiamente attestati nelle province occidentali ed in Italia settentrionale, dal Passo del Gran San Bernardo all’area veneta, così come ha compiutamente repertoriato M. Bolla32.
Tali manufatti sono stati associati ad usi diversi quali l’arredo domestico (porte e elementi lignei) e la struttura di carri, forse ammorsati nel legno delle estremità superiori della cassa, per sostenere tendaggi di chiusura33.
Interessante è notare che da Veleia, tra Parma e Parigi, provengono ben tre esemplari34.I-II sec. d.C.
5. Testa di mulo coronata di pampini (Figg. 5, 5a, 5b).Département MMA, BnF, nr. inv. 1156.Dimensioni: h 6,2 cm; lungh. 10,5 cm.Fusione in lega a base di rame, a cera persa, cava, rifinita a freddo mediante bulino con inserti agemi-
nati oggi persi. Patina verde acceso.Stato di conservazione altamente frammentario: spezzato alla base del collo, all’altezza del criniera e
dell’orecchio destro; abrasioni diffuse e un’ampia perforazione nella criniera.Data d’acquisizione: 1765.Babelon, Blanchet 1895, p. 478, nr. 1156; Babelon 1928, p. 50, nr. 28, tav. XVI; D’Andria 1970, pp.
96-97, nr. 144, tav. XXXI; Avisseaut-Broustet 2002, p. 143, nr. 58a.Recueil, Antiquités romaines, VII, p. 207, tav. LV, I.« La tête de cet âne, couronné de pampres, ne peut être plus belle, ni d’un plus beau travail. Cette pa-
rure doit persuader que ce fragment faisait partie d’une marche de Silène traitée de ronde bosse, et j’avoue que le savoir, le bon goût et l’exécution qui brillent dans cette tête, me donnent beaucoup de regrets pour le reste de la composition ».
In una possibile ricostruzione si tratterebbe di una parte decorativa di fulcrum, elemento della testata di un lectus tricliniare o, più probabilmente, funerario: un triclinium aeratum, cioè un letto con appliques di bronzo35, per seguire la terminologia di Plinio. La fonte, infatti, ci ricorda che nam triclinia aerata abacosque et monopodia Cn. Manlium Asia devicta primum invexisse triumpho suo, quel duxit anno urbis DLXVII [...]36, (ossia nel 187 a.C.), subito dopo la pace di Apamea37. Si tratta di mobili di lusso rivestiti di bron-zo, denominati, sempre da Plinio38 “letti deliaci”, provenienti da officine greche, come attesta il prezioso carico del relitto di Mahadia, davanti alla costa tunisina, che trasportava a Roma – verosimilmente nella prima metà del I sec. a.C. – un bottino di guerra dalla Grecia destinato ad una ricca domus romana. Tale mobilio, sontuoso e raffinato39, testimonia, come sostiene C. Parisi Presicce, «di una produzione ispirata alla toreutica tardoellenistica e dell’alto livello tecnico ed artistico raggiunto dal colto artigianato dedi-cato a soddisfare la domanda di mobili di lusso. Considerati il più insidioso veicolo della luxuria asiatica, contro la quale si scagliò la fazione conservatrice in Senato, capeggiata da Catone il Censore, questi ma-
32 Bolla 2010, pp. 151-155, cui va aggiunto anche l’esemplare da Industria: cfr. Bronzi da Industria 1998, p. 143, nr. 236.33 franKen 1996, pp. 168-169, nr. 227; Bolla 1999, pp. 207-210.34 d’andria 1970, pp. 95-96, nrr. 140-142, tavv. XXX-XXXI; Bolla 2010, pp. 154-155, nrr. 12-14.35 Isid., Orig., XIX, 26, 39: Fulcra sunt ornamenta lectorum, dicta quod in his fulcimur id est sustinemur, vel quod toros fulciant, sive
caput, quae reclinatoria vulnus appellat. hyg., Fab., 274: Antiqui autem nostri in lectis tricliniaribus, in fulcris, capita asello rum vite alligata habuerunt, significantes vini suavitatem invenisse. iuv., Sat., XI, 96-98: Sed nudo latere et pervis frons aerea lectis / vile coronati caput ostendebat aselli, / ad quod lascivi ludebant ruris alumni.
36 Plin., Nat. hist., XXXIV, 14.37 liv., XXXIX, 6, 7.38 Plin., Nat. hist., XXXIV, 9.39 talamo vattimo 1990, pp. 68-79; Luxus 2009, p. 480.
51
Antichità veleiati
nufatti mostrano il miglior esempio della nuova propensione dei Romani colti per l’otium e per l’ostenta-zione della propria ricchezza»40.
Del lectus ciò che rimane, perduta l’intelaiatura lignea (telaio, quattro zampe e spalliera) è, in funzione dei confronti41, la sola terminazione superiore della spalliera – una testa di mulo con ghirlanda d’edera – tema-ticamente forse da mettere in relazione con un medaglione (con busto di Sileno con nebris) a Parma42. Tali elementi della decorazione erano resi a tutto tondo, talora con agemine ed afferivano di sovente al mondo dionisiaco, come riflesso della toreutica del tardoellenismo.
La decorazione impostata sui motivi dionisiaci, diffusamente presenti nella vita quotidiana romana nei momenti conviviali e nei rituali funerari fondati su credenze religiose legate all’aspettativa di vita ultra-terrena, è, in effetti, ben documentata anche nella ricca società dell’Emilia romana, come documentano le scoperte di alcuni letti in osso43.
In funzione della seriazione stilistica delle appliques di questi bisellia, S. Faust classifica l’esemplare veleiate come un Fulcrumform III, databile alla metà del I sec. a.C.44
6. Piedi (Figg. 6, 6a, 6b).Département MMA, BnF, nr. inv. 1092.Dimensioni: h 4,5 cm; lungh. 10,5 cm.Lega a base di rame fusa, piena, a cera persa, rifinita a freddo. Patina verde.Stato di conservazione buo-
no; è presente un foro passante nella parte alta della linea lungo la quale sono accostati i piedi.Data d’acquisizione: 1765.Babelon, Blanchet 1895, p. 467, nr. 1092; D’Andria 1970, pp. 66-67, nr. 62, tav. XXI.
5. Testa di mulo coronata di pampini; Département MMA, BnF, nr. inv. 11565a. Testa di mulo coronata di pampini, disegno tratto dal Recueil, Antiquités romaines, VII, p. 207, tav. LV, I5b. Testa di mulo coronata di pampini, disegno eseguito da G. Permoli (MS 50 Costa 1761-1762, tav. LXVII p. 223)
40 I giorni di Roma 2010, p. 320.41 Bisellium da Amiternum (nr. inv. 2721, Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo, Chieti) ed il suo gemello, dalla stessa
località (nr. inv. 1074, Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Roma).42 d’andria 1970, pp. 54-55, nr. 32; Immagini divine 2007, p. 229, nr. 135.43 Bianchi 2010, pp. 58-63 con bibliografia precedente.44 faust 1989.
52
Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati
Recueil, Antiquités romaines, VII, p. 208, tav. LV, II.« Les parties de ces deux pieds de bronze gravés sous ce numéro, conservent encore la marque du clou
qui servait à les attacher dans le temple, ou dans la chapelle du dieu auquel ils étaient consacrés [...]. On trouve plus ordinairement l’offrande d’un seul pied [...] mais il est rare de trouver les deux pieds réunis comme on les voit ici. Au reste le travail du monument dont il est question sous ce numéro, est gras, et témoigne plus de sentiment de chair que de correction, ce qui n’est pas ordinaire à trouver dans les ouvrages des Anciens ».
Si tratta di una placchetta che rappresenta la parte anteriore (dalle dita al collo) di due piedi accostati, secondo il D’Andria con funzione di ex voto, da affiggere ad un supporto mediante un perno passante in un piccolo foro centrale.
Non è da scartare, tuttavia, l’ipotesi di un’applique facente parte della decorazione di un mobilio poli-materico, imitante, ad esempio, la struttura di un’erma con inserzioni enee nelle parti nude del corpo, tra queste i piedi talora rappresentati proprio applicati alla base del pilastrino.
Età imperiale.
7. Applique: bucranio (Figg. 7, 7a, 7b).Département MMA, BnF, nr. inv. 1181.Dimensioni: h 5,5 cm.Lega a base di rame fusa in cavo da una buona matrice con riprese a freddo. Patina verde bruno.Stato di conservazione buono, anche se frammentario nella parte inferiore sinistra del muso e all’altez-
za della mandibola.Data d’acquisizione: 1765.
6. Piedi; Département MMA, BnF, nr. inv. 10926a. Piedi, disegno tratto dal Recueil, Antiquités romaines, VII, p. 208, tav. LV, II6b. Piedi, disegno eseguito da G. Permoli (MS 50 Costa 1761-1762, tav. XXVI p. 139; descrizione reperto p. 10)
53
Antichità veleiati
Babelon, Blanchet 1895, p. 483, nr. 1181; D’Andria 1970, p. 66, nr. 61, tav. XXI.Nisard 1877, LXXIII, p. 376.Recueil, Antiquités romaines, VII, pp. 2008-209, tav. LV, III.« Ce petit bronze représente un massacre, c’est le nom que l’on donne aux têtes des victimes
placées dans les ornements, et principalement dans l’entablement de l’ordre dorique, celui-ci ne peut être de meilleur goût, d’un dessein plus exact, ni mieux travaillé, ces sortes de monumens (sic!) di un volume aussi médiocre ont servi d’un ex voto. On les appendait dans un Temple, ou pour conserver le souvenir d’un sacrifice offert, mais plus souvent encore les pauvres les attachaient pour suppléer à leur indigence [...] ».
Bucranio stilizzato con muso triangolare allungato in cui le indicazioni delle cavità orbitali, del naso e della bocca sono realizzate a rilievo. Rispetto agli esemplari provenienti da Industria, per altro assai simili, si nota un evidente maggiore naturalismo. Alla sommità del cranio si dipartono le corna, arcuate verso l’alto.
Dagli scavi di Veleia proviene un buon numero di cornici e decorazioni bronzee, alcune qualitativa-mente di alta fattura e di diversa funzione. Il tipo eneo del bucranio – noto in tre esemplari dal piccolo centro appenninico45 – è altresì presente ad Industria, Brescia, Luni ed Aquileia: tale dato da tempo ha
7. Applique: bucranio; Département MMA, BnF, nr. inv. 11817a. Applique: bucranio, disegno tratto dal Recueil, Antiquités romaines, T. VII, pp. 208-209, pl. LV, III7b. Applique: bucraino in un disegno di G. Permoli (MS 50 Costa 1761-1762, tav. XXIX)
45 d’andria 1970, pp. 65-66, nrr. 59-61.
54
Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati
attirato l’attenzione degli studiosi contribuendo a individuare nella Cisalpina un contesto privilegiato per quanto riguarda l’uso e la decorazione in bronzo.
Essa riproduceva, in forma miniaturistica e preziosa, i motivi della decorazione architettonica marmo-rea ed era finalizzata alla rifinitura di pannelli di porte, di specchiature di finestre, di basi e cimase di al-tari, come sembra comprovare il bucranio in oggetto. Pur se apparentemente legato al rito, il tema di per sé non è univoco al campo semantico religioso e potrebbe adattarsi anche a quello puramente decorativo per mobilia, così come M.P. Rossignani46 ha convincentemente sostenuto negli anni47. Inoltre l’abbon-danza di decorazioni enee induce ad ipotizzare la presenza di un centro di produzione locale, poiché le caratteristiche delle cornici esigevano un preciso adattamento di volta in volta ai vari supporti realizzati in materiali diversi.
È probabile una datazione alla prima età imperiale.
8. Satiro inginocchiato (Figg. 8, 8a, 8b).Département MMA, BnF, nr. inv. 422.Dimensioni: h 10,7 cm; lungh. 5,2 cm.Lega a base di rame fusa, piena, a cera persa, rifinita a freddo. Patina verde scuro.Stato di conservazione buono, anche se sono persi l’attributo della mano destra e l’oggetto che il brac-
cio sinistro sollevato appoggiava su spalle e nuca. Frammentario anche il lembo inferiore a terga della pelle ferina.
Data d’acquisizione: 1765.Babelon, Blanchet 1895, pp. 185-186, nr. 422; Babelon 1928, p. 45, nr. 18, tav. XI; D’Andria 1970,
pp. 41-42, nr. 17, tav. X; Avisseaut-Broustet 2002, p. 143, nr. 58b.Recueil, Antiquités romaines, VII, pp. 205-206, tav. LIV, I-III.« Cette petite figure de bronze très bien disposée, dont le dessin est correct et la conservation parfaite,
rappelle au premier coup d’œil l’idée d’Atlas ou d’Hercule [...]. On a lieu de soupçonner qu’elle servait de pied à quelque meuble d’usage [...] toute la figure et ses accessoires sont constamment d’un travail romain, mais la tête et la disposition de la barbe, ainsi que celle des cheveux, me paraissent [...] plus approchants enfin de la manière étrusque ».
Il bronzetto raffigura un satiro inginocchiato sulla gamba destra, barbuto e con una pelle di pantera annodata sul petto; il braccio destro, affiancato al busto, stringeva un pugnale (di cui rimane l’impu-gnatura), mentre il sinistro è alzato sopra la testa e, con la mano riversa, reggeva o tratteneva un oggetto oggi mancante. Movimento e torsione in avanti del corpo e del capo, mostrano lo sforzo proprio della funzione di “atlante” del pezzo, ove i muscoli del busto e l’articolazione delle braccia, studiati con no-tevole attenzione e cura al trattamento dell’anatomia umana, contrastano con i caratteri ferini del volto: occhi accigliati, fronte aggrottata nelle sopracciglia aggettanti, naso camuso ed orecchie appuntite. A completare l’aspetto demoniaco si pone anche una folta ed ampia barba, arrotondata sul petto (grafica-mente dettagliata da profonde ciocche serpentiformi realizzate a bulino) e dalla chioma caratterizzata da un lungo ciuffo centrale, stilizzato e da ampie stempiature laterali. Il corpo, inoltre, reca annodata al collo una pelle ferina, un cui lembo è avvolto all’avambraccio destro, mentre la parte restante ricopre il dorso in maniera piuttosto rigida, arrivando fino ai piedi.
Sotto il profilo tecnico, nonostante la qualità non disprezzabile del pezzo, numerosi sono i problemi di fusione, a partire dalla superficie posteriore del mantello, contraddistinta da ampie subbolliture e corro-sioni, che comunque ricorrono anche sull’esterno della coscia sinistra ed altrove anche se in modo meno marcato. Evidenti anche tasselli di piccoli dimensioni sulla coscia interna destra e sulla caviglia sinistra; una ricomposizione del ginocchio destro è assai probabile, mentre profonde scalfitture a punta tonda si evidenziano sull’esterno della coscia destra e dei corrispondenti muscoli peronei.
Come già proponeva il D’Andria, il pezzo, doveva costituire un’applique in forma d’appoggio di un mobile o di un recipiente, alla maniera dei sostegni di un piccolo alveus baccellato in marmo ai Musei Vaticani, in cui sono configurati tre satiri in ginocchio, portanti sulle spalle altrettante otri su cui appoggia il bacino. Per ricostruire l’ascendenza tipologica del bronzetto parigino/veleiate, quindi, occorre proprio procedere dal-
46 rossignani 1990, pp. 34 ss.47 Bronzi da Industria 1998, p. 124; cavalieri 2004, pp. 180-181.
55
Antichità veleiati
la sua funzione di sostegno, di “atlante”, ove confronti iconografici enei possono ravvisarsi in ben maggiori opere (per dimensione e qualità) quali il Sileno inginocchiato da Industria (Monteu da Po, Torino) e quello da Armento in Lucania (Potenza), oggi a Monaco di Baviera. Per la complessità del movimento il tipo è datato da Cl. Rolley alla seconda metà del IV sec. a.C., e con una esecuzione in ambiente magnogreco; con tali con-
8. Satiro inginocchiato; Département MMA, BnF, nr. inv. 4228a. Satiro inginocchiato, disegno eseguito da G. Permoli (MS 49 Costa 1760, tav. XLV)8b. Satiro inginocchiato, disegno tratto dal Recueil, Antiquités romaines, VII, pp. 205-206, tav. LIV, I-III
56
Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati
clusioni concorda L. Beschi che pone l’esecuzione del magnifico bronzo da Industria in piena età ellenistica (prima metà del II sec. a.C.), ipotizzando una provenienza da ambiente pergameno48.
Il bronzetto, pur di buona qualità, non è certamente un capolavoro e si può richiamare ai due confronti suddetti solo in termini iconografico-tipologici.
Ciononostante sorprendono, più che la tensione anatomica e l’impostazione spaziale, le singolari ca-ratteristiche del volto, dal ghigno demoniaco. Quanto alla destinazione, proprio la presenza di un perno (dietro la nuca, infisso nella schiena) previsto per l’attacco di un oggetto scomparso, fa ritenere che il sa-tiro inginocchiato reggesse, forse in pendant con altri esemplari un carico, un piccolo bacile (meno proba-bile un candelabro), cui l’articolazione della mano sinistra avrebbe potuto aderire al bordo esterno. Viste le dimensioni dell’oggetto, poco più di 10 cm, è ipotizzabile un treppiede di non grandi dimensioni. La datazione è probabilmente all’alta età imperiale.
note conclusIve
La provenienza delle Vittorie nrr. inv. 678 e 681 da Veleia è attestata, oltre che nelle pagine del Re-cueil, da una lettera, già più volte citata, di Caylus a Paciaudi del 19 settembre 1763. Nelle parole dello studioso francese si tratta di un accesso di collera – la cui causa però rimane ignota, anche se è probabile nei confronti del Paciaudi –, delle successive scuse e di tre bronzetti veleiati rappresentanti altrettante Vittorie. Un’ironia nemmeno troppo velata attraversa le parole del Caylus:
« En tout cas, j’en demande pardon à qui il appartiendra, et je vous prie, à tête reposée, d’obtenir que la boîte soit telle que vous l’aviez arrangée, vous souvenant, s’il vous plaît, de n’y point donner place à certaine belle Victoire haute d’un pied, que vous m’avez mandé, ce me semble, que l’Infant vous avait dit de m’envoyer. Que pourrais-je dire sur une Victoire? D’autant que j’en ai rapporté deux qui faisaient par-tie d’une petite emplette que M. du Tillot a eu la bonté de faire pour moi, il y a quelques années. Je ne pourrais me sauver que par une plaisanterie qui ne serait même pas trop bonne, en disant que Véleia était la ville la plus victorieuse du monde. Pensez-donc à mes intérêts et ne parlons plus de cela ».
Se l’esemplare alto un piede è certamente la Vittoria (inv. 417, B14; h 44 cm) ancora a Parma, negli altri due sono stati riconosciuti i pezzi riprodotti sul Recueil, ancorché un particolare della lettera non col-limi con i tempi d’acquisizione. Infatti i dati sembrerebbero provare che le due dee parigine furono spedite Oltralpe nel 1762, mente il Caylus, che scrive la lettera nel 1763, ricorda l’omaggio dei pezzi da parte del du Tillot avvenuto il y a quelques années. Perché il plurale nel complemento di tempo? Banale formula espressiva o puntuale precisione cronologica? È possibile che si tratti di un irrilevante dettaglio redaziona-le, ma il fatto insospettisce. Inoltre, mal si concilia con gli interessi dell’accorto du Tillot l’aver dapprima introdotto il Caylus nelle dinamiche politico-culturali del ducato parmense, per poi volerlo omaggiare di una partita di pezzi tra i quali uno spiccava per la sua “diversità”, come lo stesso conte sottolinea. Un bronzetto anomalo, in effetti, per stile, dimensioni – 21 cm rispetto ai 10-15 cm delle altre, per così dire, guenilles veleiati – e formule espressive, ma che comunque sarebbe stato riprodotto sulle pagine del Recueil e di conseguenza posto all’attenzione del mondo scientifico, e non solo, del tempo. È possibile, come sostiene velatamente il D’Andria, scagionando così implicitamente il Governo del duca, che il dolo sia da attribuire ad uno dei collaboratori del Costa, Ambrogio Martelli, su cui gravava l’onere dello scavo alla ricerca sempre di nuovi pezzi per le ambizioni della Corte. La Marini Calvani, invece, ritiene artefice della mistificazione la Corte stessa, preoccupata «di non impoverire il Museo che il Duca aveva fondato a Parma»49, ed in tal senso appoggiandosi sulla gelosia con cui du Tillot teneva sotto suo diretto controllo i materiali veleiati, ai tempi del Costa, incaricato di stendere un rapporto sulle scoperte, passandogli solo i disegni degli oggetti e non i manufatti.
La questione circa la vicenda antiquaria della Vittoria nr. inv. 681, in definitiva, ha avuto già un ampio dibattito e, in mancanza di nuovi dati50, è inutile riprenderla, salvo il fatto di esprimere qualche reticenza
48 Bronzi da Industria 1998, pp. 75-80.49 d’andria 1970, p. 6; marini calvani 1979, p. 243, nr. 461.50 È possibile che qualche ulteriore informazione possa emergere dal manoscritto di P. De Lama, Recueil de quelques monuments
antiques retrouvés dans les fouilles de Velleia avec quelques explications dédié à monsieur le conseiller Pothier, juge à la Cour criminelle de
57
Antichità veleiati
circa le modalità di riconoscimento del pezzo in base ai dati archivistici a disposizione e l’incongruenza cronologica su esposta. In ogni caso, stante la modernità del pezzo – di cui certamente non v’è notizia né nei giornali di scavo, né nei volumi del Costa e negli allegati disegni del pittore Giovanni Permoli – il passo falso commesso nell’invio da Parma si qualifica come un azzardo mal calcolato (e per questo poco in sintonia con l’acribia politica del du Tillot), per il quale riteniamo estranea la volontà del Paciaudi, se non altro per i vincoli di stima e devozione che lo legavano al Caylus.
APPendIce rIcerche Presso l’ArchIvIo storIco del museo ArcheologIco nAzIonAle dI PArmA
A partire dallo spoglio dei diari di scavo di Veleia (campagne dal 1760 al 1776), dall’analisi del mano-scritto del Costa sugli scavi della città51, e infine, dalla corrispondenza intercorsa tra Paciaudi e Caylus negli anni 1772 e 1773, si è tentato di ricostruire, pur con persistenti lacune, il contesto di rinvenimento e le vicende relative al trasferimento dei lotti di bronzetti veleiati che da Parma furono inviati al Caylus.
In effetti, non di tutti i bronzetti tuttora conservati presso Département MMA, e summenzionati, è stato possibile risalire al momento di rinvenimento; mentre di altre guenilles, riprese nel Recueil, ma oggi non più rintracciabili nelle collezioni parigine o non esposte, sono emerse le tracce nella documentazione archivistica.
Come sintesi generale, comunque, è emerso che tutti i materiali inviati al Caylus furono rinvenuti nelle campagne di scavo degli anni 1760, 1761 e 1762, quelle ancora dirette a distanza da Costa; inoltre si è confermato che tali “anticaglie” raggiunsero Parigi grazie ai contatti del Paciaudi con Caylus. È in-fatti in una nota del 1762 che Paciaudi anticipa al Caylus l’invio di alcuni bronzetti veleiati. Da parte sua Caylus, nel 1763, nella corrispondenza con il teatino, elogia una statuetta di Satiro, ricevuta, che avrebbe occhi d’argento52.
Materiali descritti nella documentazione dell’Archivio storico del Museo Archeologico Nazionale di Parma: 1. Il gancio di bronzo in forma di dito fu scoperto l’11 Maggio 1760 e viene descritto come «manubrio
di Bronzo», illustrato nelle tavole del Permoli, allegate al manoscritto del Costa (MS 49 Costa 1760, p. 101, tav. XII; descrizione reperto a p. 41, nr. 11.3 dove si legge «manubrio di bronzo»). Vedi nr. 4 supra.
2. La testa d’asino, elemento di fulcrum, fu rinvenuta il 13 Settembre 1762, descritta come «testa d’asi-no coronata d’edera di bronzo», illustrata nelle tavole del Permoli, allegate al manoscritto del Costa (MS 50 Costa 1761-1762, p. 223, tav. LXVII; descrizione reperto a p. 70 ). Vedi nr. 5 supra.
3. Le punte dei piedi di bronzo sono state rinvenute il 13 Maggio 1761, descritte come «due punte di piedi uniti di bronzo» e raffigurate nel disegno del Permoli (MS 50 Costa 1761-1762, p. 139, tav. XXVI; descrizione reperto a p. 10). Vedi nr. 6 supra.
4. Il bronzetto rappresentante un satiro inginocchiato, molto apprezzato dal Caylus che ringrazierà Paciaudi per il suo invio, fu scoperto proprio all’inizio della prima campagna di scavi, il 18 Aprile 1760, ed è descritto come «idoletto di bronzo rappresentante una Mida» e raffigurato in una tavola del Permoli (MS 49 Costa 1760 , tav. XLV; descrizione reperto nel MS 45 1760, p. 3; descrizione nel MS 44 1760 a p. 1). Vedi nr. 8 supra.
5. Infine il bucranio fu rinvenuto il 13 Maggio 1761. Descritto dal Costa come «piccolo teschio di bue di bronzo» e raffigurato dal Permoli (MS 50 Costa 1761-1762, p. 145, tav. XXIX, nr. 3; descrizione reperto a p. 10). Vedi nr. 7 supra.
Nei diari di scavo, fino al 1763 (momento del loro invio a Parigi), non sono state trovate notizie, in-vece, in merito al rinvenimento dei nrr. 1-3.
Parme, 1809, I, conservato presso il Département MMA della BnF, opera che, per mancanza di tempo, per ora non abbiamo avuto modo di consultare.
51 Documenti conservati presso l’Archivio storico del Museo Archeologico Nazionale di Parma. Si ringrazia Giulia Piana per la collaborazione nelle ricerche d’archivio.
52 Biblioteca Platina, MS PR 1586 Lettera di Paciaudi a Caylus del novembre 1763; Biblioteca Platina, Caylus a Paciaudi cart. Paciaudi, Cass. 72: lettera di Caylus a Paciaudi del 12 febbraio 1764.
58
Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati
Va sottolineato che nell’esame della copia del manoscritto del Costa MS 50, relativo agli scavi del 1761, 1762 e 1763, è stato possibile notare che tutti gli oggetti elencati sopra, sono stati riprodotti dal Permoli nelle tavole allegate al manoscritto del Costa e sono contrassegnati da un asterisco negli elen-chi, asterisco che accompagna anche altri oggetti, raffigurati anch’essi dal Permoli, non compresi tra quelli attualmente conservati a Parigi, ma sicuramente arrivati a Caylus, in quanto da lui stesso compresi nel Recuil e disegnati nelle relative tavole.
Si elencano di seguito gli oggetti annoverati dal Costa (MS 50) e disegnati dal Permoli, contraddistin-ti da asterisco ed in parte riprodotti nel Recueil.
Maggio 17611. «Un vasetto di metallo mancante di una parte», p. 10, tav. XVII. Recueil, Antiquités romaines, VII, p. 207, tav. LIV, V-VI.2. «Piccolo cimiero di metallo», p. 11, tav. XXXIV.Luglio 17613. «Metallo lavorato con vite nella parte inferiore», p. 18, tav. V.Agosto 17614. «Metallo lucido figurato», p. 23, tav. XXVII.5. «Coltello senza manico», p. 26, tav. IX.6. «Una forbice», p. 26, tav. X.Settembre 17617. «Una forchetta da tavola», p. 29, tav. IX.Ottobre 1761 8. «Lucerna di metallo rappresentante un rospo con due vipere», p. 37, tav. XXV, raffigurata anche
in P. M. Paciaudi, Monumenti antichi discoperti tra le ruine di Veleia, MS. Parm. 1245, Biblioteca Palatina.9. «Frammento di una zampa di metallo», p. 38, tav. XXXI. Luglio 176210. «Pezzo di metallo uncinato», p. 52, tav. LXV.11. «Fondo di una lucerna sulla quale sta scritto PROCLI», p. 54, tav. LXVI.Settembre 176212. «Una testina di Femina», p. 69, tav. LXXIII. Recueil, Antiquités romaines, VII, pp. 206-207, tav. LIV, IV.13. «Amuleto in forma di ghianda di metallo», p. 69, tav. LXVII.14. «Grosso pezzo di piombo pesante libbre sessantacinque con bassorilievo», p. 70, tav. LXVIII.
Roberta Conversi
BIBlIogrAfIA
aghion 2002a = i. aghion (dir.), Caylus, mécène du roi. Collectionner les antiquités au XVIIIe siècle, Paris 2002.aghion 2002b = I. aghion, Le comte de Caylus (1692-1765), gentilhomme et antiquaire, in aghion 2002a,
pp. 19-27.alBasi, magnani 2010 = T. alBasi, l. magnani, Dalla “Tabula alimentaria” al sito di Veleia: due secoli e
mezzo di studi e ricerche, in «AV» 5, 12, 2010, pp. 1-44.avisseaut-Broustet 2002 = M. avisseaut-Broustet, Catalogue, in aghion 2002a, p. 143, nr. 58a, b.BaBelon, Blanchet 1895 = J. BaBelon, J.-a. Blanchet, Catalogue des bronzes antiques de la Bibliothèque
Nationale, Paris 1895.BaBelon 1928 = J. BaBelon, Choix de bronzes de la collection Caylus donnée au Roi en 1762, Paris-Bruxelles
1928, pp. 26-28. Berger 1969 = E. Berger, Zum Samischen Zeus des Myron in Rom, in «RM» 76, 1969, pp. 66-92.Beschi 1962 = L. Beschi, I bronzetti romani di Montorio Veronese, Venezia 1962.Bianchi 2010 = C. Bianchi, I letti con rivestimento in avorio, in «LANX» 5, 2010, pp. 39-106.
59
Antichità veleiati
Bolla 1999 = M. Bolla, Bronzetti figurati romani del territorio veronese, in «RASMI» LXIII-LXIV, 1999, pp. 193-260.
Bolla 2007-2011 = M. Bolla, Bronzetti figurati romani dal territorio reggiano al Museo Chierici di Reggio Emilia, in «Pagine di Archeologia» 4, 2007-2011, pp. 1-93.
Bolla 2010 = M. Bolla, La decorazione bronzea per carri in Italia settentrionale, in «LANX» 5, 2010, pp. 107-167.
Bronzi da Industria 1998 = l. mercando, e. zanda (a c.), Bronzi da industria, Roma 1998.cavalieri 2004 = m. cavalieri, Ipotesi sulla produzione bronzea dell’Emilia occidentale in età romana, in s.
santoro (a c.), Artigianato e produzione nella Cisalpina, I. Proposte di metodo e prime applicazioni (Flos Ita-liae. Documenti di archeologia della Cisalpina Romana, 3), Firenze 2004, pp. 173-198.
cavalieri, conversi, giumlia-mair c.s. = M. cavalieri, r. conversi, a. giumlia-mair, Veleia’s Bronzes Collection: New Archaeological and Scientific Data and Interpretations, in 18th International Congress on Ancient Bronzes (Atti del Convegno di Studi, University of Zurich, 3-7 Settembre 2013), in corso di stampa.
d’andria 1970 = F. d’andria, I bronzi romani di Veleia, Parma e del territorio parmense, in «CIstAMilano» 3, 1970, pp. 3-141.
faust 1989 = S. faust, Fulcra: Figürlicher und ornamentaler Schmuck an antiken Betten («BIAG», suppl. 30), Mainz 1989.
franKen 1996 = N. franKen, Die antiken Bronzen im Römisch-Germanischen Museum Köln: Fragmente von Statuen, figürlicher Schmuck von architektonischen Monumenten und Inschriften, Hausausstattung, Möbel, Kult-geräte, Votive und verschiedene Geräte, in «KölnJbVFrühGesch» 29, 1996, pp. 7-203.
hölscher 1967 = T. hölscher, Victoria romana, Mainz-am-Rhein 1967.I giorni di Roma 2010 = e. la rocca, c. Parisi Presicce, a. lo monaco (a c.), I giorni di Roma. L’età della
conquista, Roma 2010.Immagini divine 2007 = J. ortalli, d. neri (a c.), Immagini divine. Devozioni e divinità nella vita quotidiana
dei Romani, testimonianze archeologiche dall’Emilia Romagna, Firenze 2007.Jeammet 2007a = J. Jeammet (dir.), Tanagras. De l’objet de collection à l’objet archéologique, Paris 2007.Jeammet 2007b = J. Jeammet, Un certain goût pour les Tanagras du XIXe siècle à l’Antiquité, in Jeammet
2007a, pp. 33-43.Kent hill 1982 = D. Kent hill, Note on the piecing of bronze statuettes, in «Hesperia» 51, 1982, pp. 277-283.Luxus 2009 = e. fontanella (a c.), Luxus. Il piacere della vita nella Roma imperiale, Roma 2009.marini calvani 1979 = M. marini calvani, Gli interessi del ducato di Parma e Piacenza, in L’arte a Parma
dai Farnese ai Borbone, Bologna 1979, pp. 231-237 e p. 243, nr. 461.mathieuX 2007 = N. mathieuX, Des Tanagras à l’encan: la salle des ventes come lieu de diffusion des objets
archéologiques et des connaissances à la fin du XIXe siècle, in Jeammet 2007a, pp. 45-57.menzel 1994 = H. menzel, Die Jupiterstatuetten von Brée, Evreux und Dalheim und verwandte Bronzen, in
Toreutik und figürliche Bronzen, Berlin 1994, pp. 186-196.nisard 1877 = ch. nisard, Correspondance inédite du Compte de Caylus avec le P. Paciaudi, théatin (1757-
1765) suivie de celles de l’abbé Barthélemy et de P. Mariette avec le même, Paris 1877.Parente 2007a = A.R. Parente, Caylus et l’archéologie en Italie au XVIIIe siècle. Herculanum et Veleia en per-
spective, in Dossier Archives de l’archéologie européenne (AREA) («Les Nouvelles de l’Archéologie», 110), Paris 2007, pp. 17-23.
Parente 2007b = A.R. Parente, Caylus e Paciaudi. La ricezione dell’antico tra archeologia e collezionismo a Parma, in r. Balzani (a c.), Collezioni, Musei, Identità fra XVIII e XIX secolo, Bologna 2007, pp. 29-67.
Pompéi. Un art de vivre 2011 = Pompéi. Un art de vivre, Catalogue de l’exposition, Parigi 2011.queyrel 2012 = F. queyrel, Caylus, de l’antiquaire à l’archéologie: une méthode différente de celle de Win-
ckelmann, in s. frommel, a. Brucculeri (dir.), L’idée du style dans l’historiographie artistique. Variantes nationales et transmissions, Roma 2012, pp. 231-239.
rossignani 1990 = M.P. rossignani, Le porte bronzee romane dell’Italia Settentrionale, in s. settis (a c.), Le porte in bronzo dall’antichità al secolo XIII, Roma 1990, pp. 29-40.
schnaPP 2002 = A. schnaPP, La méthode de Caylus, in aghion 2002a, pp. 53-63.talamo vattimo 1990 = E. talamo vattimo, Letti, in l. Pirzio Biroli stefanelli (a c.), Il bronzo dei Romani.
Arredo e suppellettile, Roma 1990, pp. 68-79.