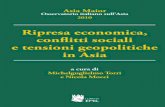EBP e Lavoro L'efficacia degli interventi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
Gli strumenti di orientamento e aggiornamento del Medico del Lavoro della Società Italiana di...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Gli strumenti di orientamento e aggiornamento del Medico del Lavoro della Società Italiana di...
G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4, 371-406 © PI-ME, Pavia 2009http://gimle.fsm.it
Gli strumenti di orientamento e aggiornamento del Medico del Lavorodella Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale(SIMLII): criteri e metodi di produzione
Pietro Apostoli, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Applicata, Sezione di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale Università degli Studi di Brescia (Coordinatore)
Ilenia Cortesi, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Applicata, Sezione di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale Università degli Studi di Brescia
Alberto Baldasseroni, Centro Regionale Infortuni e Malattie Professionali Regione Toscana, Firenze
Alfonso Cristaudo, Unità Operativa Complessa Medicina Preventiva del Lavoro, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Pisa
Marcello Imbriani, Dipartimento di Medicina Preventiva, Occupazionale e di Comunità, Università degli Studi di PaviaU.O.O.M.L., Fondazione S. Maugeri, IRCCS, Pavia
Andrea Magrini, Cattedra di Medicina del Lavoro, Università di Tor Vergata, Roma
Antonio Mutti, Laboratorio di Tossicologia Industriale, Dipartimento di Clinica Medica, Nefrologia e Scienze della Prevenzione, Università degli Studi di Parma
Giulia Candiani, Agenzia di comunicazione scientifica ZADIG, Milano
Raffaella Daghini, Agenzia di comunicazione scientifica ZADIG, Milano, Milano
Pier Alberto Bertazzi, Dipartimento di Medicina del Lavoro, Clinica del Lavoro, Università degli Studi di Milano
Lucia Isolani, Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro ASUR Marche - Macerata
Maurizio Manno, Dipartimento Scienze Mediche Preventive, Sezione di Medicina Preventiva, Università degli Studi di Napoli Federico II
Giovanni Mosconi, Istituto di Medicina del Lavoro Ospedali Riuniti di Bergamo, Bergamo
Adriano Ossicini, Settore Prevenzione Epidemiologia e Statistica SMG INAIL, Roma
Canzio Romano, Dipartimento di Ortopedia e Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Torino, Torino
Pietro Dri, Agenzia di comunicazione scientifica ZADIG, Milano, Milano
Giuseppe Abbritti, Sezione di Medicina del Lavoro Malattie Respiratorie e Tossicologia Professionale e Ambientale, Università degli Studi di Perugia, Perugia
RIASSUNTO. La problematica degli strumenti diaggiornamento ed orientamento tecnico scientifico (linee guida, consensus document, protocolli, norme di buona tecnica, buone prassi) in Medicina del Lavoro va analizzata considerando diversi aspetti:– quanto realizzato nel programma di produzione delle linee
guida in Medicina del Lavoro che SIMLII ha avviato nel2002 e che ha visto pubblicate, al 2009, 24 linee guida con 3 aggiornamenti e un consensus document;
– il D.Lgs. 81/2008, che per la prima volta nella nostralegislazione ha definito concetti quali linee guida, normatecnica e buone prassi, prevedendone entità di produzione,approvazione, validazione e diffusione;
– il Programma nazionale delle linee guida, ora inserito nelSistema nazionale per le linee guida (SNLG), avviatodall’Istituto superiore di sanità, imprescindibileriferimento per una disciplina appartenente all’areaMedica come la nostra.
Alla luce di quanto sopra sintetizzato è stato deciso di aggiornarela procedura di produzione delle linee guida e in questa sedeviene illustrato il documento messo a punto da uno specificogruppo di lavoro. Il documento definisce la metodologia dielaborazione degli strumenti di orientamento e aggiornamentodel Medico del Lavoro, ponendo in particolare rilievo:– la scelta degli argomenti;– la nomina del coordinatore e la formazione del gruppo
di lavoro;
– gli aspetti etici ed i conflitti di interesse;– la verifica dell’esistenza di riferimenti formalizzati;– la verifica della letteratura - metanalisi;– la valutazione del grading e dei vincoli di evidenza;– l’applicazione di un sistema di valutazione standardizzata
(AGREE);– modalità di verifica degli utenti, stampa e diffusione;– collegamento alla formazione tradizionale residenziale
e a distanza.Vengono discussi alcuni concetti centrali nella produzionedegli strumenti di aggiornamento ed orientamento, da cuitraggono fondamento, vincolo e ampiezza di applicazione, a partire dalla loro evidenza scientifica. Questo aspetto è ben evidenziato nel SNLG non solo nella distinzione tra LG,evidence e non evidence based, ma anche nella previsione di diversi strumenti a seconda del grado di evidenza e dicapacità di risposta (dai consensus document ai technologyassessment). La “qualità” degli strumenti è data dallapossibilità di dimostrarne efficacia o appropriatezza.Viene ribadito il ruolo decisivo delle Società scientifiche nella predisposizione degli strumenti di aggiornamento e qualificazione e la disponibilità di SIMLII nellacollaborazione con le istituzioni per l’applicazione dei contenuti del D.Lgs. 81/08 e 106/09.
Parole chiave: linee guida, evidenza scientifica, metodologia,medicina del lavoro.
372 G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4http://gimle.fsm.it
1. Introduzione
Le linee guida SIMLII: obiettivi e principi ispiratori Nel congresso di Sorrento del novembre 2000 la So-
cietà Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale(SIMLII) ha cominciato a trattare l’argomento delle lineeguida nell’ambito delle attività di formazione e di accredi-tamento del medico del lavoro- medico competente, in-quadrandole tra gli strumenti utili con altri (corsi, conve-gni, simposi, workshop) a garantire un innalzamento tec-nico scientifico costante e uniforme e, di conseguenza, al-la riaffermazione del nostro specifico ruolo professionale.
Nel corso del 64° Congresso nazionale SIMLII di Ro-ma del 2001 sono state ulteriormente approfondite le que-stioni riguardanti il significato e l’applicabilità delle lineeguida in Medicina del Lavoro, definendone il modello dielaborazione e il programma di stesura.
Le linee guida nascono con l’obiettivo di assicurare ilmassimo grado di appropriatezza degli interventi, riducen-do al minimo la variabilità nelle decisioni legate alla ca-renza di conoscenze e alla soggettività nella scelta dei cri-teri di intervento, con lo scopo di ottenere un migliora-mento nell’erogazione delle prestazioni. Sono prima ditutto strumenti utili a far progredire la competenza, intesacome la capacità di orientamento, l’abilità acquisita in undeterminato campo, o meglio ancora come la conoscenza,l’abilità, la perizia e l’attitudine a svolgere un compito o aricoprire un ruolo in modo da garantire i risultati attesi dalavoratori, datori di lavoro e organi di controllo.
Le linee guida SIMLII sono indicazioni che dovrebbe-ro favorire l’attività professionale del medico del lavoro eche questi segue volontariamente. Sono inoltre riferimen-ti essenziali per dimostrare l’aggiornamento e la qualifica-zione nei processi di accreditamento.
Si inquadrano nel disegno generale di pubblicazionianaloghe in altre discipline mediche, definite come “rac-comandazioni di comportamento clinico, elaborate me-diante un processo di revisione sistematica della letteratu-ra e delle opinioni di esperti e con lo scopo di assistere me-dici e pazienti nel decidere le modalità assistenziali più ap-propriate in specifiche situazioni cliniche; dovrebbero cor-rispondere a strumenti sistematicamente sviluppati per as-sistere le decisioni del medico in specifiche circostanze,che hanno come proprio fondamento l’evidenza scientifi-ca”(Field, 1992); o ancora, come “affermazioni sistemati-camente sviluppate per supportare le decisioni di medici epazienti in specifiche circostanze cliniche, per attuare unaterapia efficace “(Grimshaw, 1993).
Una delle caratteristiche fondamentali delle linee gui-da è il rispetto delle libertà e dell’autonomia del singolomedico, nella consapevolezza che la medicina non è scien-za dell’”esatto”, ma del “possibile”. Resta alla competen-za ed all’esperienza del singolo professionista decidere inche misura i comportamenti raccomandati dalle linee gui-da, pur rispondendo a standard qualitativi definiti sulla ba-se delle più aggiornate prove scientifiche, si possano ap-plicare nel caso specifico.
In medicina le linee guida si trovano quindi a cavallotra scienza ed arte: spesso il prevalere dell’una o dell’al-tra componente è stato oggetto di critica sia da parte dichi temeva che l’eccessivo peso della scienza schiaccias-se la relazione empatica tra medico e paziente sia di chiauspicava viceversa la messa in discussione di atti nonsupportati da valide giustificazioni scientifiche. Inoltre ènecessario ricordare l’influenza, spesso decisiva, delleaspettative dei “clienti” (nel caso specifico datori di la-voro, lavoratori, enti di controllo), aspettative legate allapercezione dei problemi su cui il medico è chiamato a in-tervenire.
ABSTRACT. THE NEW METHODOLOGY TO PRODUCE INSTRUMENTS
FOR UPDATING OCCUPATIONAL PHYSICIAN PROPOSED BY ITALIAN
SOCIETY OF OCCUPATIONAL MEDICINE AND INDUSTRIAL HYGIENE
(SIMLII). Starting from the experience of last five years, duringwhich 24 guide liens about the most important aspects of Occupational Physician activity have been produced, the Italian Society of Occupational Medicine and IndustrialHygiene (SIMLII) delegated a specific working group forupdating the methodology to be adopted for guide lines and other instruments for improving and standardizing the current activity in our professional field. SIMLII produced in the context of the specific Education andAccreditation Programme for occupational physicians preparedfrom 2002 25 guide lines or other informative instruments onthe most important and controversial themes in which ourdiscipline is involved. They were considered and treated to meetthe need to improve and standardise activities and to modify thecurrent approach of occupational physicians and aimed not onlyat improving the effectiveness of preventive actions but also at constantly adopting rigorous methodologies based wherepossible on evidence based or on consensus procedures.The Directive of SIMLII was firmly convinced about theopportunity-necessity to critically evaluate the experiencecarried out during the last years, at the light of the National
Program for Guide Lines edited By Italian National HealthInstitute since 2002 and which concerns preparation,dissemination, updating, implementation of guide lines inMedicine. The guide lines were defined as rational criticaleffective aid addressed to professionals and patients for healthservices organization. Relevant was the new Framework Act forthe occupational safety and health (Decreto legislativo 81/08)too signed by the President of the Italian Republic on April 9,2008, which for the first time includes and defines in a legislative act the different possible instruments (technical normative, good practices, guide lines).In this paper we present the new methodology defined by our Society for producing the different kind of instruments such as guide lines, consensus conference reports, technologyassessments, good practices statements guide lines focusing as the main aspects those related to definitions, argumentchoice, working group and coordinator identification, producing methods, evidence evaluation, grading, qualityevaluation using AGREE method, dissemination procedure, the conflict of interest and the possible use for distanceformation procedure focusing the recommendations that take a practical-applicative approach.
Key words: guide lines, occupational health, methodology.
G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4 373http://gimle.fsm.it
La modesta compliance che le linee guida hanno avu-to nel mondo medico, è stata spiegata con due tipi di ar-gomentazioni. Il primo nasce dalla constatazione che uncerto comportamento si modifica più chiaramente se esi-stono “rinforzi positivi” - come il monitoraggio dei risul-tati, il sostegno economico, la disincentivazione di com-portamenti negativi - eventualmente affiancati dalla rimo-zione dei “rinforzi negativi”.
Il secondo ha alla base il fatto che le convinzioni per-sonali, le attitudini e le intenzioni del singolo sono le de-terminanti del comportamento. In questo senso, gli inter-venti dovrebbero indirizzarsi a gruppi precisi di professio-nisti, individuando le variabili principali che condizionanoil comportamento e i relativi ostacoli da rimuovere.
Infine, è stato segnalato come le linee guida medicheattribuiscano enfasi eccessiva al peso statistico delle pro-ve rispetto a quello clinico, privilegiando di fatto i grandistudi multicentrici finanziati dalle multinazionali del far-maco, spesso più altamente significativi sul piano statisti-co ma non altrettanto sotto il profilo biologico e forse mar-ginali in termini di reali benefici per i pazienti.
Molte linee guida sono state criticate per i costi ine-renti la loro stessa produzione, frequentemente sostenutida generosi, ma non sempre disinteressati, sponsor o part-ner industriali.
Sotto questo profilo, le linee guida SIMLII si sono fi-no ad oggi caratterizzate per il contributo volontario deisoci, che mettono a disposizione dei colleghi le loro com-petenze, in un processo di reciproco aggiornamento e ar-ricchimento culturale.
La produzione di linee guida fino al 2008 SIMLII ha finora prodotto le proprie linee guida (Ap-
pendice 2) secondo il modello descritto nel riquadro Lametodologia di produzione adottata finora da SIMLII,sempre rispettata specie nella valutazione della letteraturae, di norma, anche esplicitata. I risultati non sono statiuniformi in tutte le linee guida pubblicate: a fare la diffe-renza sono stati il coordinatore, con il suo ruolo propositi-vo e di controllo, e l’impegno dei gruppi di redazione.
Un dato è certo: non esistono in Italia iniziative con-frontabili con quella di SIMLII sia come caratteristiche siacome numero di linee guida prodotte, a dimostrazione chenell’ambito della medicina del lavoro SIMLII è riuscita acoinvolgere chi si occupava (ed era esperto) dei diversi te-mi affrontati e a suscitare consenso, apprezzamento e atte-sa di nuove iniziative tra i fruitori. È così che per questainiziativa è stato possibile contare su centinaia di soci che,volontariamente e senza alcun compenso, hanno parteci-pato alle diverse fasi di stesura e diffusione delle linee gui-da; grazie a loro è stato conseguito un successo editorialea cui ha contribuito anche il collegamento con il program-ma di accreditamento di eccellenza.
Tale programma, varato all’inizio degli anni 2000, ne-cessita ora di essere aggiornato alla luce dell’evoluzionedegli strumenti informativi, delle loro procedure di produ-zione (in particolare per l’opportuno collegamento alleprove di efficacia di quanto proposto e raccomandato), diquanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 - D.Lgs. 106/09 e del-la scelta di continuare comunque a migliorare.
La metodologia di produzione adottata finora daSIMLII
Il modello con cui SIMLII ha finora prodotto leproprie linee guida è quello propositivo-formativo,che prevede una discussione ampia e dettagliata diciascun aspetto del tema in esame e che permette diottenere linee guida basate, ove possibile, sulla forzadelle prove o su quella del consenso tra i partecipan-ti alla loro stesura, riportando anche eventuali posi-zioni di dissenso. Consenso e dissenso devono essereindicati chiaramente, unitamente alla metodologiaapplicata.
Il gruppo di lavoro SIMLII sulle linee guida per imedici del lavoro ha messo a punto uno schema di ela-borazione delle linee guida tematiche che prevedeva:– definizione dell’argomento;– parole chiave;– razionale;– contributo del medico del lavoro alla valutazione
del rischio nell’identificazione di fattori di rischio(contributo alla programmazione e alla realizza-zione del monitoraggio ambientale, stima dell’e-sposizione senza misure strumentali, monitoraggiobiologico);
– interpretazione dei dati di monitoraggio (valori diriferimento, action level, valori limite);
– meccanismi fisiopatogenetici;– evidenze patologiche;– sorveglianza sanitaria (sintomi ed eventuali criteri
standardizzati per la loro registrazione, segni edeventuali modelli standardizzati di obiettivazione,esami strumentali, esami di laboratorio);
– visite specialistiche integrative;– scale di valutazione;– criteri (maggiori-minori);– indicazioni per il giudizio di idoneità;– aspetti normativi e medico legali;– interazione ambiente-lavoratore per la sorveglianza
sanitaria e per l’idoneità;– misure di prevenzione collettiva e individuale;– informazione e formazione;– necessità di ricerca;– opportunità di revisione;– bibliografia essenziale.
I tempi di lavoro sono stati di circa 9-12 mesi peruna linea guida su un tema complesso, di 6 mesi per te-mi più circoscritti.
Alla stesura della prima bozza si perveniva dall’as-semblaggio degli elaborati delle varie aree di lavoro. Labozza veniva passata al vaglio di tutti i componenti delgruppo di lavoro e, dopo le valutazioni finali, veniva re-datta una versione della linea guida nei formati previsti(testi e supporti informatici) inviata a revisori espertiesterni al gruppo di lavoro e a medici del lavoro, per lavalutazione dell’applicabilità.
Ricevute e valutate le osservazioni, viene redatto ildocumento per l’esame e l’approvazione del direttivodella società. Il testo approvato e classificato come
374 G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4http://gimle.fsm.it
Finora la stesura delle linee guida SIMLII è avve-nuta, come detto, a titolo gratuito, con il contributo vo-lontario del lavoro di gruppi di soci. In esperienze an-che italiane di altre discipline mediche, il gruppo che“istruisce” conta su una forza-lavoro esperta nelle ri-cerche di letteratura scientifica che vi si dedica, se nona tempo pieno, certamente in ampia misura del propriotempo-lavoro; il dettaglio è rilevante, soprattutto per-ché la fase di stesura del documento deve essere svoltanell’arco di 6-12 mesi e le problematiche trattate sonocomplesse. Per esempio, dall’esperienza personale diun autore di questo lavoro è risultato che in una lineaguida di sanità pubblica sulla lotta alla sedentarietà sisono dovute esaminare 13 linee guida già esistenti sul-l’argomento, e per limitarci a quelle evidence based188 raccomandazioni da classificare e sottoporre al pa-nel per riceverne indicazioni circa l’applicabilità allarealtà italiana.
È il caso di domandarsi, pensando alla qualità del pro-dotto, se tutto questo lavoro possa essere svolto a costozero o sfruttando giovani colleghi in fase di specializza-zione. Procedere “in economia” comporta rischi per quan-to riguarda il rispetto dei tempi e la qualità dei contenutidi cui bisogna essere coscienti e che vanno valutati nellaprospettiva di un continuo miglioramento.
Il metodo proposto prevede infatti la documentazio-ne e la formalizzazione dei diversi passaggi, la defini-zione della forza delle raccomandazioni (grading), ilcollegamento con la formazione a distanza (FAD) rea-lizzato in collaborazione con Zadig (unità operativa delSNLG), il monitoraggio dell’implementazione della li-nea guida, le attività di verifica, feed-back e diffusionedelle raccomandazioni.
È stato calcolato che una linea guida clinica costa me-diamente 30-40 mila euro, anche tenendo conto del fattoche la raccolta del consenso finale è un’operazione com-plessa e costosa (specie se si decide di invitare glistakeholders).
È questo un aspetto che deve essere affrontato e risol-to dagli organi dirigenti della società, che devono decide-re se procedere in questa direzione, stabilire entità e for-ma (gettone, rimborso spese, eccetera) di un riconosci-mento differenziato a seconda dei ruoli e quindi cercarefinanziamenti tenendo conto dei possibili aspetti etici edei conflitti di interesse.
Il gruppo di lavoro si è trovato d’accordo nel consi-gliare in ogni caso di garantire benefici tangibili ai soci ri-spetto ad altri possibili utenti.
Vanno considerati, infine, anche altri aspetti critici ri-levanti: – l’apparente esclusione, secondo quanto contenuto nel
D.Lgs. 81/08 e nel D.Lgs. 106/09, delle società scien-tifiche, delle università e di gruppi qualificati di ricer-catori dalla produzione degli strumenti di orientamen-to e aggiornamento;
– gli eventuali conflitti tra chi produce, raccoglie, validae controlla nel corso della fase applicativa;
– il ruolo delle linee guida non solo come strumento di-dattico dell’accreditamento ma come riferimento pro-fessionale dei soci e dei medici del lavoro;
bozza viene presentato ufficialmente in sede di conve-gni specifici, invitando i partecipanti a fare pervenire leproprie osservazioni entro tre mesi. Nel caso si fosseroregistrati commenti importanti, il gruppo di lavoro or-ganizzava una giornata di approfondimento con coloroche avevano proposto le modifiche più rilevanti.
Il testo definitivo riceveva l’approvazione forma-le della SIMLII ed era pubblicato, con l’indicazionedella data entro la quale doveva essere rivisto com-pletamente o in parte; era prevista anche la possibilitàdi un aggiornamento straordinario, nel caso in cui ilcostante monitoraggio dei dati della letteratura indi-cassero la necessità di segnalare tempestivamente va-riazioni importanti.
Per poter proporre una ipotesi organizzativa del nuo-vo programma di linee guida in medicina del lavoro si de-ve partire da un bilancio critico dell’esperienza 2003-2008, rispetto alla quale si propongono:– l’integrazione delle linee guida vere e proprie con al-
tri strumenti (per esempio documenti di consenso) chepossono trovare un impiego differente nelle attività diaggiornamento e orientamento;
– la creazione di un rapporto con le istituzioni e gli enti(ministeri, regioni, comitati paritetici, ISPESL,INAIL) identificati dal D.Lgs. 81/08 e 106/09, comeresponsabili della produzione, dell’approvazione e delcontrollo nell’applicazione dei diversi strumenti;
– l’inquadramento delle attività di SIMLII nell’ambitodel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG, exPNLG).
La nuova metodologia La proposta che viene illustrata nei capitoli seguen-
ti rappresenta una logica evoluzione di quanto fatto fi-nora e contempla una serie di passaggi metodologiciche comprendono l’utilizzo di una terminologia unifor-me (glossario), una migliore definizione di autorship econflitti di interesse, la definizione di nuovi criteri dielaborazione, la previsione di nuove procedure di revi-sione ed infine il loro impiego nella formazione resi-denziale tradizionale ed in quella già in fase sperimen-tale, a distanza.
L’obbiettivo principale è quello di una più chiara,uniforme e formale documentazione delle varie fasi cheportano alla produzione degli strumenti di orientamento equalificazione del medico del lavoro, avendo come prin-cipale riferimento il modello del SNLG-ISS e in partico-lare gli aspetti cruciali della ricerca, dell’applicazione,della documentazione dei livelli di prova e quindi del gra-do di vincolo atteso.
Bisogna, come spesso dibattuto, tenere presente che laricerca delle prove di efficacia in un ambito come quellodella medicina del lavoro è complessa sia in via teoricasia, soprattutto, nella sua “fattibilità pratica”. A questo ar-gomento è stato dedicato il convegno nazionale “Ricercae dimostrazione delle basi scientifiche delle prove di effi-cacia in medicina del lavoro”, che si è tenuto a Bergamonel dicembre 2005.
G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4 375http://gimle.fsm.it
– la definizione di una nuova politica editoriale, deiprezzi e della diffusione che ne favorisca una maggio-re circolazione anche via internet;
– la preparazione di sintesi in inglese in modo da poter-le eventualmente diffondere a livello internazionale.
Il coinvolgimento degli stakeholdersIl coinvolgimento delle diverse categorie di sogget-
ti interessati (lavoratori, datori di lavoro e loro sindaca-ti, istituzioni e organi di controllo) è un tema che ne-cessita di un particolare approfondimento. Anche se, indefinitiva, appare ragionevole che esso sia lasciato aconsiderazioni specifiche (relative alla singola lineaguida o a situazioni particolari come l’esperienza dellelinee guida sull’edilizia), dovrà essere valutato dagliorgani dirigenti, in base alla policy societaria e a consi-derazioni di tipo economico. Peraltro va ricordato cheuna verifica di questi aspetti è prevista nei nuovi sche-mi di revisione.
Non sempre, infatti, è chiaro se la partecipazione de-gli stakeholders nella produzione delle linee guida e nel-la valutazione della loro efficacia sia possibile e costrutti-va o se piuttosto non comporti il rischio di una sorta dicontrattazione sui contenuti dei documenti.
Nell’ambito più strettamente clinico un coinvolgi-mento degli utenti è ipotizzabile, per esempio, con le as-sociazione dei pazienti interessate all’argomento trattato,per stendere una linea guida che valuti l’efficacia di unnuovo trattamento e che consideri l’impatto che può ave-re la sua modalità di somministrazione nella vita quoti-diana. Per esempio se si stabilisce che il farmaco miglio-re va assunto solo in ospedale tutti i giorni forse non siconsidera adeguatamente la compliance dei pazienti. Nelcaso della medicina del lavoro c’è la necessità di stabilirese e in quale fase coinvolgere lavoratori e datori di lavo-ro (ad es. più che nella fase di stesura, potrebbe essereipotizzata la partecipazione delle parti sociali in quelladell’implementazione pratica della LG).
È assolutamente necessario, poi, tenere conto della ne-cessità che la metodologia di lavoro garantisca ai membridel gruppo che hanno meno esperienza nella stesura dellelinee guida (per esempio i rappresentanti dei lavoratori) lapossibilità e la capacità di esprimere il loro punto di vista.
A questo scopo, come suggerito anche dal SNLG sidovrebbero sviluppare e sperimentare modalità innovati-ve quali:– attività di informazione e di empowerment dei rappre-
sentanti degli utenti coinvolti nei gruppi di lavoro;– aumento del numero di rappresentanti per categoria
(se i rappresentanti sono due o tre invece di uno i ri-sultati possono essere migliori);
– maggiore articolazione del lavoro preparatorio utiliz-zando focus group di rappresentanti di categorie spe-cifiche;
– introduzione di sezioni specifiche del documento fina-le, contenenti le raccomandazioni, nelle quali siano ri-portati i giudizi e le aspettative delle altre categorie disoggetti rilevanti.Da questo punto di vista strumenti diversi dalle
classiche linee guida, come le conferenze di consenso -
almeno nei casi in cui questo aspetto è stato considera-to e valutato attentamente - sembrano aver offerto fi-nora maggiori possibilità di partecipazione e di consul-tazione.
BibliografiaAbbritti G, Apostoli P, Iavicoli S, Murgia N, Muzi G, Soleo L, Ambrosi
L. L’accreditamento di eccellenza della società italiana di medicinadel lavoro e igiene industriale. Med Lav 2003; 34: 413-20.
Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé. Les Confé-rences de consensus. Base méthodologique pour leur réalisation enFrance. ANAES, Paris, 1999.
American Society of Clinical Oncology. American Society of ClinicalOncology clinical practice guidelines for the use of chemotherapyand radiotherapy protectants. J Clin Oncol 1999; 17: 3333-55.
Apostoli P. Medicina del lavoro e qualità. G Ital Med Lav Ergon 1998;20: 211-7.
Apostoli P. La prevenzione occupazionale tra norme di legge, norme tec-niche e norme di buona prassi. Med Lav 2006,1: 7-12.
Apostoli P, Ambrosi L. Introduzione alle linee guida del programma diaggiornamento ed accreditamento per il medico del lavoro promos-so da SIMLII. In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Am-brosi L (eds). Linee guida per la formazione continua e l’accredita-mento del medico del lavoro, volume 1 (p. IV-XII), Tipografia PimeEditrice, Pavia, 2003.
Apostoli P, Signorini S, Sanna Randaccio F. Le LG nella formazione enell’accreditamento del medico del lavoro. G Ital Med Lav Ergon2001; 23(3): 224-9.
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell’articolo 1 dellalegge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutela della salute e della si-curezza nei luoghi di lavoro. Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30-04-2008 (supplemento ordinario n. 108).
Field MJ, Lohr KN (eds). Guidelines for clinical practice: from develop-ment to use. National Academy Press, Washington, 1992.
Grilli R, Magrini N, Penna A, et al. Practice guidelines developed by spe-cialty societies: the need for a critical appraisal. Lancet 2000; 355:103-6.
Grimshaw J, Russell I. Achieving health gain through clinical guidelines.I: Developing scientifically valid guidelines. Quality in Health Care1993; 2: 243-8.
Mosconi G, Cassina T, Catenacci G, Ditaranto D, Frigeri G, Imbriani M,Merluzzi F, Mutti A, Riboldi L, Roscelli F, Saretto G, Toffoletto F,Violante F, Apostoli P. Ricerca e dimostrazione formale della evi-denza ed efficacia in medicina del lavoro. G Ital Med Lav Ergon2006; 28(suppl 1): 135-48.
Mosconi G, Riva MM, Mangili A, Apostoli P (a cura di). Atti del Con-vegno nazionale “Ricerca e dimostrazione delle basi scientifichedelle prove di efficacia in medicina del lavoro”, Bergamo, dicembre2005. G Ital Med lav Ergon 2006; 28 (suppl 1): 129-215.
Shaneyfelt TM, Mayo-Smith MF, Rothwangl J. Are guidelines fol-lowing guidelines? The methodological quality of clinical practiceguidelines in the peer-reviewed medical literature. JAMA 1999;281: 1900-5.
Sistema nazionale per le linee guida-Istituto superiore di sanità. Manua-le metodologico. Come produrre, diffondere e aggiornare le racco-mandazioni per la pratica clinica. SNLG 2002 (disponibile all’indi-rizzo: http://www.snlg-iss.it/cms/files/Manuale_PNLG.pdf).
Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII).Atti del 62° Congresso nazionale. Genova, settembre-ottobre 1999.Lavoro e Medicina 1999; 1: 1-191.
Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII).Atti del 63° Congresso nazionale. Sorrento, novembre 2000. FoliaMedica 2000; 71: 1-108.
Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII).Atti del 64° Congresso nazionale. Roma, ottobre 2001. G It Med LavErgon 2001; 23: 199-230.
Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII).Atti del 68° Congresso nazionale. Parma, ottobre 2005. In: Mutti A,Goldoni M. Temi controversi in medicina del lavoro (p. 51-63),MUP Editore, Parma, 2005.
376 G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4http://gimle.fsm.it
2. Le linee guida nella medicina del lavoro
Gli strumenti proposti dal Sistema nazionale per lelinee guida
Il SNGL prevede nella sua attuale formulazionequattro possibili strumenti di orientamento tecnicoscientifico: – le linee guida quando il tema da trattare è vasto e
può essere suddiviso in quesiti principali e seconda-ri che non riguardano solo la dimensione clinica, maanche quella organizzativa e gestionale. Per realiz-zare una linea guida si deve disporre di una buonaquantità di dati a favore o contro determinate scelteed è necessario formulare raccomandazioni di com-portamento relative alle diverse dimensioni del pro-blema esaminato;
– le consensus conference quando il tema da trattare è li-mitato, può essere suddiviso in pochi quesiti specifici,presenta aspetti controversi soprattutto per quanto ri-guarda la dimensione scientifica (di qualità delle pro-ve) ed è necessario formulare sia raccomandazioni siaindirizzi per lo sviluppo della ricerca;
– la valutazione di appropriatezza quando il tema da trat-tare richiede un approfondimento clinico molto speci-fico e si vogliono produrre raccomandazioni dettaglia-te per un uso mirato al sigolo paziente. Le raccoman-dazioni riguardano procedure o interventi e non per-corsi complessi e possono venire utilizzate per produr-re criteri di audit;
– il technology assessment quando il problema riguar-da una tecnologia specifica di cui si devono valutarenon solo gli aspetti clinici ma anche quelli organizza-tivi, gestionali, economici e sociali. Lo strumento èvalido quando la tecnologia in esame è destinata adavere un impatto complesso sul sistema sanitario ed ènecessario sviluppare modelli in grado di prevederneutilizzo e gestione e se il problema in oggetto richie-de una valutazione da parte di competenze e profes-sionalità differenti.
Per dare ordine alla materia, il SNLG propone un pas-saggio, anch’esso pienamente condiviso e fondamentaleper i futuri programmi di SIMLII: distinguere tra le evi-dence-based guidelines, cioè le linee guida vere e proprie,basate sulle prove scientifiche e gli altri documenti che,per maggior chiarezza, potrebbero essere denominati di-versamente.
I tre aspetti che le differenziano sono:– la multidisciplinarietà del gruppo responsabile della
produzione della linea guida;– la valutazione sistematica delle prove scientifiche di-
sponibili come base per le raccomandazioni formulate;– la classificazione delle raccomandazioni in base alla
qualità delle prove scientifiche che le sostengono.Altri aspetti importanti per l’applicabilità delle linee
guida sono: la chiarezza, la flessibilità, la definizione diindicatori opportuni per monitorare e valutare l’efficienzae l’efficacia nel conseguimento degli obiettivi stabiliti.
Gli strumenti contemplati nel D.Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09Il D.Lgs. 81/08-106/09 riporta, nel Titolo 1, le seguen-
ti definizioni di alcuni tra gli strumenti di interesse nellapresente trattazione:– norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblica-
ta da un’organizzazione internazionale, da un organi-smo europeo o da un organismo nazionale di norma-lizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
– buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coe-renti con la normativa vigente e con le norme di buonatecnica, adottate volontariamente e finalizzate a pro-muovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attra-verso la riduzione dei rischi e il miglioramento dellecondizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni,dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezzadel Lavoro (ISPESL), dall’Istituto Nazionale per l’Assi-curazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e da-gli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validatedalla Commissione consultiva permanente di cui all’ar-ticolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, cheprovvede a assicurarne la più ampia diffusione;
– linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’appli-cazione della normativa in materia di salute e sicurezzapredisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’Istituto Su-periore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro(ISPESL) e dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazionecontro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e approvati in se-de di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.Nel testo non vengono riportate le definizione di altri
documenti poi citati in alcuni articoli, come norma tecni-ca non armonizzata, codici di condotta e codici di com-portamento.
Gli strumenti definiti sono poi richiamati in alcuni ar-ticoli del testo (vedi riquadro Gli articoli di riferimento)
Gli articoli di riferimentoEcco gli articoli del testo unico in cui sono richia-
mati gli strumenti di interesse.
Articolo 6 comma 8. La Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: d) validare le buone prassi in materia di salute e si-
curezza sul lavoro.
Articolo 9comma 2. L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA operano
in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla norma-tiva vigente, svolgendo in forma coordinata, per una mag-giore sinergia e complementarietà, le seguenti attività:
i) elaborazione, raccolta e diffusione delle buoneprassi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v);
l) predisposizione delle linee guida di cui all’arti-colo 2, comma 1, lettera z);
comma 6. L’ISPESL, nell’ambito delle sue attribu-zioni istituzionali, opera avvalendosi delle propriestrutture centrali e territoriali, garantendo unitarietàdella azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisci-plinari e svolge le seguenti attività:
G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4 377http://gimle.fsm.it
– lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurez-za sul lavoro;
– l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione de-gli adempimenti in materia;
– ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla leggeo dai contratti collettivi di riferimento. A nostro giudizio, affidare l’elaborazione e la raccolta
delle buone prassi agli organismi paritetici pone problemisulla scelta degli argomenti da trattare, sulla possibilità diproduzioni condizionate da elementi localistici o partico-lari, di conflitto con le buone prassi prodotte da realtà si-mili di altre aree, anche vicine, e infine sul possesso delleeffettive competenze.
Le linee guida, contrariamente alle definizioni più ac-creditate a livello internazionale e anche nazionale (si pen-si ad esempio alla definizione del SNLG), sono inquadra-te nel TU come atti di indirizzo e coordinamento per l’ap-plicazione della normativa in materia di salute e sicurezza.Sono cioè indicazioni generali (atti di indirizzo) e orga-nizzative (atti di coordinamento) verosimilmente centratesu come trattare gli argomenti previsti o come conformarei comportamenti di diverse figure circa l’applicazione del-la norma, cioè gli obblighi di legge.
Non si menzionano due caratteristiche fondamentalidelle linee guida: l’adesione tecnica del professionista al-le raccomandazioni sulla base di un convincimento e diuna scelta ragionata e libera e la formulazione delle racco-mandazioni riguardo a qualcosa su cui si è chiamati a in-tervenire sulla base di ciò che di meglio è disponibile dalpunto di vista scientifico e tecnico.
Gli elaboratori di questi strumenti in parte coincidonocon quelli delle buone prassi, essendo ministeri, regioni,ISPESL, INAIL.
Le linee guida non sono approvate dalla Commissioneconsultiva permanente ma in sede di Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province au-tonome di Trento e di Bolzano.
La specificità delle linee guida nella medicina del lavoroNella pratica, buona parte dell’attività del medico del
lavoro risulta essere ancora prevalentemente clinica e nonpuò quindi prescindere dal “ragionamento” sul singolosoggetto, secondo cui la decisione del medico procede perquesiti successivi o per algoritmi.
Questo processo si avvicina molto al percorso utiliz-zato nella produzione di linee guida che si occupano ditrattamenti terapeutici o di prove di efficacia di scree-ning, dove gli outcome e le metodologie sono definiti eprecisi. La metodologia utilizzata per i trial clinici valeappunto per i singoli quesiti (per esempio: la profilassiantibiotica prima dell’intervento è efficace? È più effica-ce un antibiotico o un altro nella terapia di una determi-nata patologia?) ma diventa eccessivamente complicatase applicata a un ambito più ampio e complesso comequello preventivo, in cui l’efficacia è determinata per de-finizione dall’assenza di eventi indesiderati. Tutto ciò ri-schia, talvolta, di paralizzare il processo, già difficoltoso,di produzione dei testi con un effetto che in altri contesti(come la valutazione del rischio) è stato chiamato “para-lisi attraverso l’analisi”.
m) partecipa alla elaborazione di norme di caratteregenerale e formula, pareri e proposte circa la congruitàdella norma tecnica non armonizzata ai requisiti di sicu-rezza previsti dalla legislazione nazionale vigente;
o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buoneprassi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v).
Articolo 35Riunione periodica.Possono essere individuati:a) codici di comportamento e buone prassi per pre-
venire i rischi di infortuni e di malattie professionali;b) obiettivi di miglioramento della sicurezza com-
plessiva sulla base delle linee guida per un sistema digestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Articolo 36Formazione, informazione e addestramento.Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavo-
ratore riceva una adeguata informazione:b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei
preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati disicurezza previste dalla normativa vigente e dalle nor-me di buona tecnica.
Articolo 181Valutazione dei rischi fisici.1. Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo
28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti daesposizione ad agenti fisici in modo da identificare eadottare le opportune misure di prevenzione e protezio-ne con particolare riferimento alle norme di buona tec-nica ed alle buone prassi.
Negli articoli 39 e 41, che definiscono le attività delmedico e i contenuti della sorveglianza sanitaria non sifa alcun riferimento agli strumenti sopra richiamati.
Vanno fatte alcune considerazioni sulla natura deglistrumenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e 106/09.
Le buone prassi corrispondono a soluzioni organizza-tive procedurali, coerenti con leggi e norme di buona tec-nica, adottate volontariamente e rivolte alla promozionedella salute (non si fa cenno alla prevenzione).
Queste norme sono elaborate e raccolte da regioni,ISPESL, INAIL e dagli organismi paritetici. Sono poi va-lidate dalla Commissione consultiva permanente, previaistruttoria tecnica dell’ISPESL (di cui non è chiaro il ruo-lo per quanto riguarda quelle elaborate dallo stesso ente),che provvede ad assicurarne la più ampia diffusione (manon si dice con quali modalità).
Si deve verificare se il processo di validazione preve-da un’azione di controllo del rispetto dei requisiti prefis-sati, per esempio raccomandazioni fondate sulle prove, so-stenibilità dei costi, eccetera.
Gli organismi paritetici sono definiti come organismicostituiti su iniziativa di una o più delle associazioni dei da-tori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul pianonazionale. Essi dovrebbero fungere da sedi privilegiate per:– la programmazione di attività formative e l’elaborazio-
ne e la raccolta di buone prassi a fini preventivi;
378 G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4http://gimle.fsm.it
Nella medicina del lavoro l’esigenza di avere una lineaguida nasce dal fatto che non è chiaro ai medici se un lo-ro atto sia davvero efficace di per sé o se sia attuato nelmodo più efficace e spesso ciò che viene richiesto va oltrei singoli quesiti.
La trattazione di documenti di più ampio respiro po-trebbe essere comunque mantenuta con valenza diversa daquella di una linea guida. Per esempio, si potrebbe conce-pire un documento generale, frutto di una revisione dellaletteratura, preparata anche con criteri meno rigidi, che po-trebbe precedere successive linee guida specifiche o lineeoperative sugli argomenti più interessanti e discussi.
Alla base del lavoro di produzione delle linee guidaresta comunque una sorta di “peccato originale”: è diffi-cile pensare che il medico del lavoro coinvolto nella ste-sura del documento non faccia parte del gruppo di con-sulenti del datore di lavoro e svolga esclusivamente l’at-to medico della visita. In tal senso, anche nel gruppo cheha cominciato a occuparsi della nuova linea guida sullapromozione della salute è stato sottolineato che due sonogli ambiti da considerare: la promozione della salute nelrapporto uno a uno tra medico competente e lavoratore invisita (per esempio counselling breve sulla cessazionedel fumo di sigaretta, in analogia con quanto si è dimo-strato efficace tra i medici di medicina generale) e la pro-mozione della salute nell’ambito della comunità di ap-partenenza del lavoratore (il gruppo dei dipendenti del-l’azienda, il territorio di localizzazione dell’azienda, ec-cetera). In questo secondo ambito, il medico competentegioca un ruolo del tutto diverso rispetto al primo conte-sto: si deve necessariamente rapportare con le azioni in-traprese sul tema nella sanità pubblica, ma anche nell’a-zienda (iniziative della direzione per il benessere dei pro-pri dipendenti, eccetera) interagendo adeguatamente (e sipuò dare indicazione su quale sia il modo migliore perfarlo) con gli altri attori.
È opportuno ribadire che l’atto medico clinico (che hasicuramente importanti campi di applicazione come la de-cisione sull’opportunità o meno di lasciar proseguire unlavoro a un soggetto affetto da problemi personali o iper-suscettibile all’ambiente di lavoro) non esaurisce le fun-zioni e i compiti del moderno medico del lavoro, renden-do il suo ruolo più complesso ma certamente anche piùutile e interessante e che, come detto, il successo dell’a-zione preventiva dipende dalla sua efficace interazionecon gli altri operatori della prevenzione.
Aspetti medico legaliLa giurisprudenza richiede al medico di agire con
“scrupolosa attenzione” e adeguata preparazione profes-sionale, con conseguente dovere di rispettare “tutte le re-gole e gli accorgimenti tecnici che nel loro insieme costi-tuiscono la conoscenza della professione medica”. Nelconcetto di adempimento diligente rientra anche la perizia,intesa “come conoscenza ed attuazione delle regole pro-prie di una determinata arte o professione”. Si può quindiaffermare che “le regole d’arte” - condivise e generalmen-te indicate in un determinato contesto storico - costitui-scono il criterio per valutare la correttezza tecnica dellacondotta del medico.
Il medico deve sempre rispondere in termini persona-li: infatti nel caso in cui sia necessario discostarsi dalle li-nee guida è la sua scienza che deve adattarne i contenuti.La diligenza peraltro deve essere valutata in relazione allecircostanze concrete nelle quali il medico si è trovato adoperare e, quindi, la giurisprudenza riconosce al sanitariouno spazio di discrezionalità tecnica nella scelta del medi-co, purché fondata su dati oggettivi.
La necessità di strumenti come le linee guida, che for-niscono indicazioni comportamentali, nasce spesso dal de-siderio di ottenere un punto di riferimento da far valere inun eventuale contenzioso per dimostrare la propria dili-genza, prudenza e perizia. In questo senso le linee guidavengono sollecitate dai medici nel convincimento di po-terne derivare una sorta di “copertura medico legale”, qua-si a dire che l’uniformarsi a certi indirizzi operativi possafornire una sorta di garanzia (impunità). Le linee guida de-vono caratterizzarsi per contenuti culturali e scientifici eper capacità di adeguamento nel tempo, potenzialità nonsempre presenti nelle leggi, che per loro natura sono frut-to di compromessi e inadeguate a seguire il “tempo reale”delle acquisizioni tecniche e scientifiche.
Nel nostro contesto è opportuno che le linee guida as-sumano una valenza “nazionale”, pena il rischio di doverprendere in considerazione altri riferimenti, fondati su mo-delli etico-culturali, assetti economici e sociali propri dipiù circoscritte realtà locali, proprio negli ambiti ove le li-nee guida possono fornire il miglior contributo di tutela,cioè nei contenziosi penali-amministrativi.
La dottrina medico legale, pur affermando che per valu-tare la condotta professionale dei medici si deve fare riferi-mento “anche” a questi documenti, nella stesura vigente econosciuta nel momento di realizzazione dell’atto diagno-stico o terapeutico incriminato, sottolinea correttamente “ilvalore relativo” delle linee guida per i “singoli casi”. Le li-nee guida devono quindi essere utilizzate ai fini medico le-gali con “prudenza ed equilibrio”, tenendo presente non so-lo la discrezionalità tecnica dell’agire del medico nel singo-lo caso, ma anche la coesistenza, in un determinato conte-sto storico, di più alternative scientificamente convalidate.
Richiami alle necessità di linee guida in ambito sanita-rio, sono rintracciabili in alcune norme del nostro Paese,quali il D.Lgs. 229/99 ed il PSN 1998-2000, che propon-gono l’adozione di linee guida per il pieno utilizzo delle ri-sorse disponibili e come miglioramento dell’appropriatez-za delle prestazioni (corretto uso delle risorse per rispon-dere in modo adeguato ad una specifica domanda di assi-stenza). In particolare il D.Lgs. 229/99 richiama le lineeguida ed i percorsi diagnostici-terapeutici “allo scopo difavorire all’interno di ciascuna struttura sanitaria, lo svi-luppo di modalità sistematiche di revisione e valutazionedella pratica clinica e assistenziale e di assicurare l’appli-cazione dei livelli essenziali di assistenza”.
BibliografiaApostoli P. La medicina del lavoro tra qualità e prove di efficacia. G Ital
Med Lav Ergon 2006; 28(suppl 1):131-4.Apostoli P, Catalani S. Strumenti per l’aggiornamento del medico del
lavoro. G Ital Med Lav Ergon 2008; 30(3): 254-7.Birrell L, Beach J. Developing evidence-based guidelines in occupational
health. Occup Med 2001; 51: 73-74.
G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4 379http://gimle.fsm.it
Carter T. The application of the methods of evidece-based practice to oc-cupational health. Occup Med 2000; 50: 231-236.
Fiori A. La medicina legale della responsabilità medica. Giuffrè Editore,1999.
Grilli R, Penna A, Liberati A. Migliorare la pratica clinica: come pro-muovere e implementare linee guida. Il Pensiero scientifico editore,Roma, 1995.
Sistema nazionale per le linee guida-Istituto superiore di sanità. Manua-le metodologico. Come produrre, diffondere e aggiornare le racco-mandazioni per la pratica clinica. SNLG 2002 (disponibile all’indi-rizzo: http://www.snlg-iss.it/cms/files/Manuale_PNLG.pdf).
Terrosi Vagnoli E. Le linee guida per la pratica clinica: valenze e problemimedico-legali. Riv It Med Leg 1999; 189-98.
3. Criteri e metodi di produzione delle linee guida
La metodologia proposta assume come modello quelloadottato dal SNLG cercando di adattarlo alle specificheesigenze della Medicina del Lavoro
Scelta dell’argomentoStoricamente SIMLII ha selezionato gli argomenti da
trattare nelle linee guida tra quelli che nel congresso diGenova del 1999 erano stati individuati come bisognosi diapprofondimento o di aggiornamento e che sono stati poiinseriti nel programma di accreditamento di eccellenza.
A questi si sono via via aggiunti argomenti che, porta-ti all’attenzione del Direttivo nazionale da sezioni regio-nali o gruppi di soci, sono stati giudicati meritevoli ditrattazione.
È stato dimostrato che la scelta degli argomenti può diper sé condizionare l’avvio di un corretto processo di pro-duzione di linee guida, potendo orientare le risorse econo-miche e umane verso determinati aspetti ed escluderne altri.
I criteri che possono essere utilizzati sono:– la rilevanza clinico-epidemiologica della malattia da
trattare, misurata sulla sua incidenza, morbilità e mor-talità, sulla disponibilità di interventi e sulla scarsità diprove di efficacia;
– il peso delle richieste espresse dagli stakeholders, uncriterio di successo che risponde a esigenze esplicite eimmediate, i cui limiti sono però legati alla possibiletransitorietà delle richieste stesse e all’influenza eser-citata dall’esterno (mezzi di comunicazione, portatoridi interessi economici);
– la presenza di prove di efficacia e di appropriatezzadegli interventi, derivate da dati scientifici e studi; unavariante di questo modello è detta anche modello del-la qualità delle prove e prevede, accanto alla disponi-bilità dei dati, anche la valutazione della loro qualità;
– l’impatto che il miglioramento dell’appropriatezza deicomportamenti professionali può avere sull’andamen-to della malattia e sulla percezione della qualità deiservizi erogati.Diverse indagini hanno messo in luce che le linee gui-
da sono spesso percepite da chi le applica come strumentiutili per il contenimento dei i costi più che per il migliora-mento dell’efficacia e dell’appropriatezza degli interventi.Al contrario le linee guida, promuovendo l’uso appropria-to degli interventi sanitari, possono essere non solo uno
strumento di contenimento dei costi inappropriati, ma an-che di identificazione e di soddisfacimento dei bisogni.
È opportuno prendere in considerazione almeno treaspetti economici: – il costo legato alla elaborazione, alla diffusione e alla
implementazione di una linea guida;– l’inserimento, nella fase di elaborazione delle raccoman-
dazioni, di riflessioni relative agli aspetti economici (ti-picamente di costo-efficacia) ma anche organizzativi;
– la valutazione dell’impatto economico per il sistemaAzienda in seguito all’implementazione di una lineaguida.È necessario definire un percorso, per il momento
identificabile nelle attività del Direttivo nazionale, in cuile proposte siano presentate, motivate con una documen-tazione scritta e infine approvate. In caso di approvazione,il Direttivo ha anche il compito di individuare un possibi-le coordinatore e un primo gruppo di coordinamento per laproduzione della linea guida.
Formazione del gruppo di lavoro
Criteri per la scelta degli autoriLe modalità più opportune da seguire per selezionare
gli autori di una linea guida sono state oggetto di riflessio-ne e dibattito nella comunità scientifica e una ricerca suGoogle di “authorship of scientific papers” richiama 205mila documenti, il più autorevole dei quali sembra quellodell’Associazione Internazionale degli Editori di RivisteMediche (http://www.icmje.org).
Il documento contiene alcune indicazioni importanti:– il coordinatore deve essere selezionato sulla base del
curriculum scientifico e non solo della posizione acca-demica e professionale o dell’esperienza nel campospecifico (se non documentata da pubblicazioni);
– il coordinatore deve motivare la scelta dei membri delgruppo di lavoro delle specifiche linee guida, definen-done chiaramente i compiti (per esempio: stesura dicapitoli su argomenti specifici, discussione dei temisenza impegno diretto nella stesura, semplice revisio-ne o correzione di bozze) e graduando i riconoscimen-ti e decidendone di conseguenza le forme di riconosci-mento (per esempio i ringraziamenti).Possono nascere problemi a seguito dell’esclusione di
soci che si sentono esperti dell’argomento trattato, o se so-no esclusi autori ritenuti autorevoli sulla tematica specifica.
La principale criticità nella creazione di un gruppo di la-voro, infatti, è la reale rappresentatività delle figure coinvol-te, sia per quanto riguarda le competenze tecniche e meto-dologiche sia per quel che concerne la loro rappresentativitàrispetto alle realtà professionali coinvolte. Inoltre nel gruppodeve essere creato e mantenuto un equilibrio per quanto ri-guarda le competenze dei singoli autori, la loro conoscenzadella metodologia da applicare e, infine, i ruoli affidati: è ne-cessario, infatti, evitare la monopolizzazione del gruppo daparte di personalità forti o di componenti particolarmenteesperti dell’argomento per consentire a tutti i partecipanti dicontribuire alla discussione in modo bilanciato.
Per costruire un gruppo di lavoro equilibrato ed effica-ce è importante considerare alcuni aspetti:
380 G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4http://gimle.fsm.it
– tutte le figure professionali coinvolte nella gestione delproblema trattato nella linea guida devono essere rap-presentate nel gruppo di lavoro. Oltre ai medici del la-voro, quindi, possono essere coinvolti esperti di disci-pline di base (fisici, chimici, biologi, psicologi), tecno-logi, esperti di organizzazione del lavoro. Per quantoriguarda gli aspetti medici si devono individuare tuttele professionalità coinvolte nella gestione dei variaspetti dell’argomento da trattare, scegliendole in mo-do equilibrato tra universitari, ospedalieri e operatoridel territorio con competenza riconosciuta nel campo.I rappresentanti delle diverse professionalità possonoessere concordati anche con le principali società scien-tifiche interessate;
– devono essere coinvolte tutte le figure professionaliche partecipano all’organizzazione dei vari livelli diintervento. Questo aspetto è particolarmente rilevanteper le linee guida in cui le implicazioni organizzativesiano molto importanti, soprattutto per quanto riguardai percorsi organizzativi e i rapporti tra i diversi opera-tori sanitari coinvolti;
– se lo si ritiene opportuno, potranno essere coinvoltinelle forme ritenute opportune di volta in volta dalgruppo di lavoro datori di lavoro e lavoratori, loro rap-presentanti o le loro associazioni, sia per il contributoche possono fornire, sia per contribuire ad una mag-giore partecipazione e trasparenza;
– se tra gli obiettivi della linea guida rientra la valuta-zione dell’impatto economico delle scelte proposte,può essere utile includere nel gruppo di lavoro unesperto in economia sanitaria.Per consentire una corretta dinamica di gruppo è op-
portuno che il numero di partecipanti non sia né troppoesiguo né troppo elevato: il numero ideale è compreso tra10 e 20 membri.
Conflitti di interesseProdurre raccomandazioni è diventato un percorso par-
ticolarmente sensibile e delicato e, per la credibilità e ilsuccesso di un programma di linee guida, è essenzialemantenere la massima trasparenza sia per quanto riguardala metodologia da seguire sia nella scelta degli attori coin-volti nel processo di produzione e del loro contributo (peresempio: coordinamento, contributi di diverso livello altesto, attività di revisione).
I potenziali conflitti di interesse, infatti, sono moltepli-ci e possono derivare:– da condizionamenti culturali e professionali, quando
la promozione di una certa tecnologia o interventopuò essere occasione di acquisizione di prestigio pro-fessionale e di categoria per gruppi o società scienti-fiche;
– da condizionamenti legati alla necessità di contenere icosti, quando l’interpretazione delle prove scientifichee le conseguenti raccomandazioni entrano in contrastocon le disponibilità economiche;
– da rapporti di consulenza o collaborazione da parte deimembri del gruppo di lavoro con enti, gruppi o istitu-zioni che potrebbero beneficiare o essere danneggiatidal contenuto delle raccomandazioni.
Per minimizzare i rischi derivanti dal conflitto di inte-ressi, quindi, è opportuno che tutti i membri di un gruppodi lavoro coinvolti nella produzione di una linea guida sot-toscrivano una dichiarazione per rendere esplicita la pro-pria posizione rispetto ai potenziali conflitti di interesse:eventuali incarichi o rapporti finanziari con organizzazionio enti con interessi economici (o in conflitto di interessi)nell’argomento oggetto della linea guida o nella documen-tazione discussa nella linea guida; eventuali attività di con-sulenza per aziende, lavoratori o autorità giudiziarie (peresempio nel caso dei consulenti dei Pubblici Ministeri).
Produzione ex novo o adattamentoIl numero di linee guida disponibili nelle varie aree
della medicina è in continua crescita; quindi, prima di ini-ziare la produzione di una nuova linea guida, è importan-te considerare le eventuali linee guida già disponibili sul-l’argomento (vedi riquadro Le banche dati di linee guida),valutandone la qualità e la pertinenza rispetto alle neces-sità generali e specifiche.
Le banche dati di linee guidaAllo scopo di rendere accessibili agli utilizzatori i do-
cumenti già prodotti, a livello internazionale sono statesviluppate diverse banche dati di linee guida. Comeesempio si può citare la National Guideline Clearinghou-se (NGC) statunitense (http://www.guideline.gov), realiz-zata dalla Agency for Healthcare Research and Quality(AHRQ) in collaborazione con l’American Medical As-sociation e l’American Association of Health Plans.
In ambito nazionale, invece, il Sistema nazionaleper le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità e il CeVEAS (Centro per la valutazione dell’efficacia del-l’assistenza sanitaria) dell’Azienda USL di Modena han-no realizzato una banca dati comparativa di linee guida initaliano (http://www.snlg-iss.it/banca_dati_comparativa),che raccoglie e valuta, dal punto di vista clinico e meto-dologico, i principali documenti prodotti a livello inter-nazionale. La banca dati fornisce una valutazione criticadelle linee guida esaminate e una sintesi conclusiva chemette a confronto le principali raccomandazioni conte-nute nelle linee guida pubblicate.
Data questa premessa, è comunque vero che un adatta-mento alla realtà alla quale la linea guida deve essere ap-plicata si rende quasi sempre necessaria.
Per questo motivo è utile raccomandare che anchenella fase di adattamento ad uno specifico tema-parte ditema si proceda secondo il processo definito per la pro-duzione ex novo, rispettando in particolare il principiodella interdisciplinarietà e i criteri utilizzati per il gra-ding, l’articolazione e la definizione delle raccomanda-zioni, in particolare se si decide di procedere all’adatta-mento locale di una linea guida di cui si riconosce la va-lidità metodologica originale.
È importante argomentare ed esplicitare sempre leragioni delle modifiche rispetto alle raccomandazionioriginarie.
G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4 381http://gimle.fsm.it
Definizione dei ruoli e metodo di lavoroUn punto critico per la gestione del gruppo è rappre-
sentato dalla definizione dei compiti, in quanto le compe-tenze nel gruppo dovrebbero essere tali da “validare” unarevisione sviluppata da un gruppo di esperti del settore.
Perché il gruppo di lavoro sia operativo e raggiungal’obiettivo richiesto è fondamentale nominare il coordina-tore e garantire durante l’intero processo di realizzazionedi una linea guida, la presenza di un nucleo di coordina-mento metodologico e organizzativo, formato dal coordi-natore e da altre 2-3 autori. Il nucleo di coordinamento de-ve prestare particolare attenzione alle dinamiche del grup-po nei vari aspetti (processi decisionali, scelte strategiche,interazione fra i membri, fenomeni di prevaricazione o disudditanza psicologica, eccetera) e favorire un sereno eproficuo scambio di opinioni fra i membri. Questo perchénon sempre all’interno di un gruppo le competenze e i pos-sibili ruoli si evidenziano in modo netto e spesso, anche sequesto accade, i membri del gruppo possono avere diffi-coltà a partecipare attivamente a causa della mancanza ditempo a disposizione o di carenze organizzative. In questosenso la capacità di gestire dinamiche di gruppo da partedel nucleo di coordinamento potrebbe influenzare favore-volmente il risultato finale in termini di coinvolgimentorapido e fattivo di tutti i partecipanti.
Una volta formato il gruppo di lavoro, il coordinatoreconvoca una prima riunione nella quale i membri del grup-po si conoscono e valutano la necessità di integrare even-tuali competenze mancanti.
È opportuno, ma non necessario, che il nucleo di coor-dinamento presenti le scelte metodologiche fatte in baseall’argomento da affrontare. Il gruppo nella sua prima riu-nione le approva.
Il nucleo di coordinamento dovrebbe:– condurre una ricerca delle linee guida esistenti sull’ar-
gomento ed effettuarne un’analisi comparativa me-diante l’utilizzo di una checklist per la comparazionedelle principali raccomandazioni (sull’esempio dellabanca dati comparativa SNLG: http://www.snlg-iss.it/banca_dati_comparativa)
– cercare prove di efficacia, sicurezza e impatto econo-mico dei possibili interventi all’interno di una revisio-ne sistematica o, in sua assenza, nei singoli studi - con-cordando, al fine di rendere il processo trasparente e ri-petibile, le parole chiave, le possibili fonti, i limititemporali della ricerca, eccetera - per i principali am-biti o quesiti specifici concordati col gruppo;
– diffondere i risultati della ricerca sotto forma di evidencetable (tabelle sinottiche di presentazione dei singoli stu-di) e attraverso forum di confronto aperti tutti i membri;
– diffondere le tavole sinottiche di valutazione delle li-nee guida al gruppo;
– identificare gli outcome da considerare e tutti i possi-bili trattamenti disponibili.Il gruppo di lavoro identifica le raccomandazioni e sta-
bilisce il livello di prova e la forza sulla base di definizionicondivise (in questa fase può essere necessario consultareanche esperti esterni al gruppo per risolvere quesiti specifi-ci e i membri del gruppo possono e devono raccogliere icontributi e i commenti delle categorie che rappresentano);
definisce gli indicatori da applicare nella fase di implemen-tazione; redige una prima bozza della linea guida.
Una volta definite le principali raccomandazioni, ilgruppo stabilisce il formato più adatto per la presentazio-ne definitiva, considerando i destinatari della linea guida.
La semplicità, la chiarezza e la facilità di consultazio-ne sono obiettivi indispensabili da raggiungere senza ri-nunciare però alla completezza dell’informazione. Se ilnumero e la complessità delle raccomandazioni rendonoimpossibile conciliare questi aspetti, si può scegliere didiffondere le raccomandazioni due versioni, una estesa euna sintetica (che contiene le raccomandazioni principalie quelle con la maggiore forza).
La bozza avanzata della linea guida viene poi inviata adalcuni esperti a livello nazionale e internazionale, esterni algruppo di lavoro e scelti dai membri in base alla compe-tenza sull’argomento trattato o su alcuni aspetti specifici.La bozza viene inviata anche alle società scientifiche even-tualmente coinvolte per un commento e un avvallo dellescelte fatte. Si può inoltre chiedere un commento motivatosui contenuti e sulla veste grafica della linea guida.
Il gruppo di lavoro esamina criticamente tutti i com-menti raccolti e decide caso per caso se accettare o menole osservazioni, includendole nella stesura definitiva deldocumento.
Al termine del processo il gruppo promotore decidecome presentare e diffondere la linea guida prodotta.
L’intero processo di realizzazione di una linea guida èdescritto in sintesi nel riquadro Il percorso da seguire.
Il percorso da seguireIl processo di elaborazione di una linea guida basa-
ta sulle prove di efficacia segue un protocollo operati-vo analogo a quelli utilizzati per la stesura di un pro-getto di ricerca o di una revisione sistematica.
Le fasi principali per la realizzazione di una lineaguida evidence based nell’ambito di un programma na-zionale o regionale sono le seguenti:– individuazione dei destinatari della linea guida;– definizione degli obiettivi;– definizione delle modalità di lavoro;– formalizzazione e organizzazione del gruppo di
lavoro;– definizione e condivisione delle metodologie da
seguire (ricerca delle fonti primarie e secondarie,criteri per le revisioni sistematiche, condivisionedello schema di grading scelto), se necessario an-che attraverso un breve processo di formazione peri membri del gruppo di lavoro;
– analisi delle prove disponibili sull’argomento (ri-cerca primaria o revisione sistematica);
– ricerca nelle banche dati delle linee guida basatesulle prove di efficacia già esistenti;
– stesura di una bozza della linea guida che contengale raccomandazioni e gli indicatori;
– invio della bozza a referee esterni;– redazione del documento finale.
382 G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4http://gimle.fsm.it
Tempi e necessità organizzativeÈ necessario definire i tempi e le responsabilità di rea-
lizzazione per ognuna delle fasi del processo descritto. Siail periodo necessario sia le modalità organizzative posso-no variare a seconda del tipo di lavoro da affrontare.
Se la linea guida riguarda un argomento totalmentenuovo, per il quale non esistono altri documenti di riferi-mento già pubblicati, il gruppo di lavoro deve affrontareun percorso articolato, che comprende la ricerca di tutte leprove esistenti sull’argomento, l’analisi del materiale re-perito, l’individuazione delle raccomandazioni e che ri-chiede tempi relativamente lunghi (12-18 mesi). In questocaso può essere necessario organizzare incontri di diversisottogruppi e definire tempi ad hoc per la realizzazione diparti specifiche del documento. Questo vale in particolareper la realizzazione ex novo di una revisione sistematica,che può essere complessa e richiedere un tempo relativa-mente lungo (6-12 mesi), risorse e competenze specifiche;in questo caso la programmazione del lavoro può risultarepiù difficoltosa.
La costruzione di una linea guida su un argomentoconsolidato, sul quale cioè siano state pubblicate numero-se linee guida di buona qualità, può invece risultare piùagevole in quanto, pur mantenendo invariato il rigore me-todologico, i membri del gruppo possono analizzare le li-nee guida esistenti e discutere le raccomandazioni già con-solidate. In questo caso il gruppo può valutare la metodo-logia impiegata nelle revisioni sistematiche della letteratu-ra condotte in occasione della stesura delle linee guidaprecedenti e, se lo ritiene opportuno, accettare il lavorosvolto. A questo punto la revisione della letteratura consi-ste semplicemente nell’integrazione o nell’aggiornamentoin base a quanto pubblicato dopo l’ultima revisione siste-matica considerata utilizzabile.
Infine, se si deve rivedere una linea guida basata sulleprove già disponibile, è sufficiente aggiornarla sulla basedelle nuove prove pubblicate, decidendo se e come modi-ficare le raccomandazioni esistenti.
BibliografiaAgency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). National Guide-
line Clearinghouse (NGC). http://www.guideline.govBatista RN, Hodge MJ. Setting priorities and selecting topics for clinical
practice guidelines. CMAJ 1995; 153: 1233-6.Burnand B. Clinical practice guidelines A public health perspective. Eur
J Public Health 1999; 9: 83-5.CeVEAS, Sistema nazionale per le linee guida-Istituto superiore di
sanità. Banca dati comparativa di linee guida. http://www.snlg-iss.it/banca_dati_comparativa
Cluzeau F, Littlejohns P, Grimshaw J, Feder G. Appraisal instrument forclinical guidelines. St George’s Hospital Medical School, London,1997 (disponibile online all’indirizzo: http://www.sghms.ac.uk/phs/hceu/form.htm).
Davidoff F, DeAngelis CD, Drazen JM, et al. Sponsorship, authorship,and accountability. Ann Intern Med 2001; 135: 463-6.
Formoso G. Liberati A, Magrini N. Practice guidelines: useful and“participative” method? Survey of italian physicians by professionalsetting. Arch Int Med 2001; 161: 2037-42.
Grilli R, Penna A, Zola P, Liberati A. Physician’s view of practice guide-lines. Soc Sci Med 1996; 43: 1283-7.
Henshall C, Oortwjiin W, Stevens A, et al. Priority setting for healthtechnology assessment. Theoretical considerations and practicalapproaches. Priority setting subgroup of the EUR-ASSESS project.Int J Technol Assess Health Care 1997; 13: 144-85.
Mason J, Eccles M, Freemantle N, Drummond M. A framework forincorporating cost-effectiveness in evidence-based clinical practiceguidelines. Health Policy 1999; 47: 37-52.
Morin K, Rakatansky H, Riddick FA Jr, et al. Managing conflicts ofinterest in the conduct of clinical trials. JAMA 2002; 287: 78-84.
Papanikolaou GN, Ioannidis JP. Declaring competing interests. Types ofcompeting interests would be of interest. BMJ 2001; 323: 1187-8.
Sistema nazionale per le linee guida-Istituto superiore di sanità. Manua-le metodologico. Come produrre, diffondere e aggiornare le racco-mandazioni per la pratica clinica. SNLG 2002 (disponibile online al-l’indirizzo: http://www.snlg-iss.it/cms/files/Manuale_PNLG.pdf)
Società italiana di medicina del lavoro ed igiene industriale (SIMLII).Atti del 62° congresso nazionale. Genova, settembre-ottobre 1999.Lavoro e Medicina 1999; 1: 1-191.
4. Requisiti metodologici di qualità
Come riportato nel manuale metodologico SNLG, i re-quisiti metodologici essenziali per la produzione di una li-nea guida sono:– la multidisciplinarietà;– le revisioni sistematiche della letteratura;– la graduazione delle raccomandazioni (grading);– gli indicatori di monitoraggio.
MultidisciplinarietàSul piano teorico la multidisciplinarietà è necessaria
per garantire:– la valutazione dei benefici e degli effetti avversi degli
interventi da parte di professionalità e punti di osser-vazione e valutazione diversi;
– l’integrazione della dimensione organizzativa, gestio-nale, etica ed economica accanto a quella dell’efficacia.È noto che gruppi multiprofessionali tendono a dare va-
lutazioni più conservative (ad esempio nell’uso di tecnolo-gie rispetto a gruppi monospecialistici o monodisciplinari.
Se la multiprofessionalità è in generale accettata in ter-mini di principio, assai più critica è una sua realizzazioneoperativa. Le difficoltà riguardano sia la definizione dellecompetenze da coinvolgere sia il rapporto (peso) relativoche esse devono avere. L’obbiettivo da raggiungere è cheogni componente sia in grado di dare uno specifico con-tributo (che altre componenti non sanno dare o sanno darein modo meno valido) da mettere poi in relazione o coor-dinare con gli altri. In questo senso da tempo si sostieneche più che interdisciplinarietà sarebbe più opportuno par-lare di poli (multi)disciplinarietà.
In linea generale questa può essere garantita da Medi-ci del Lavoro che per loro esperienze personali sono ingrado di “coprire” ambiti-aspetti specialistici (dalla audio-logia, alla fisiopatologia respiratoria, all’allergologia, allatossicologia) o da esperti provenienti dalle singole specia-lizzazioni. In questo caso sarà il gruppo di lavoro a valu-tare il coinvolgimento dell’esperto a titolo personale (so-luzione preferibile) o quello della corrispondente SocietàScientifica.
Revisioni sistematiche della letteraturaLa grande quantità di pubblicazioni prodotte su uno
stesso argomento, le carenze metodologiche di molte
G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4 383http://gimle.fsm.it
delle ricerche condotte, i limiti del processo di peer re-view (revisione tra pari), la tendenza a pubblicare più fre-quentemente gli studi positivi rispetto a quelli negativi(nota come publication bias o bias di pubblicazione), i li-miti del tradizionale processo di revisione della letteratu-ra affidata agli esperti (le cosiddette review narrative otradizionali) sono i motivi che hanno contribuito all’af-fermarsi del metodo e dei principi delle revisioni siste-matiche.
Negli ultimi dieci anni - in particolare grazie al contri-buto della Cochrane Collaboration - i metodi per realizza-re le revisioni sistematiche si sono affinati e si sono accu-mulate conoscenze importanti sulle loro potenzialità e suiloro limiti.
Una revisione sistematica può essere definita comeuna “valutazione delle conoscenze disponibili su un deter-minato argomento nella quale tutti gli studi rilevanti sonoidentificati e valutati criticamente”. (Bero, 1998).
Se la natura del quesito e la qualità dei dati lo consen-tono, a una revisione sistematica si può associare una me-tanalisi, ovvero una sintesi quantitativa dei risultati pre-senti in letteratura ottenuta utilizzando tecniche statisticheappropriate a quantificare il contributo dei singoli studisenza annullare l’unicità delle caratteristiche di ciascuno(Margolin, 1988).
Condizione essenziale per la realizzazione di una revi-sione sistematica è che essa venga pianificata e condottasulla base di un protocollo che preveda la definizione:– dei quesiti;– degli studi (cioè delle caratteristiche del loro disegno);– degli esiti sulla base dei quali deve essere misurata
l’efficacia degli interventi;– delle strategie di ricerca delle informazioni;– del modo in cui viene valutata la qualità metodologica
(validità interna) e la completezza delle informazioniriportate (validità esterna).La disponibilità di revisioni sistematiche ben condotte
è condizione necessaria per la produzione di raccomanda-zioni per la pratica clinica; è infatti un elemento che carat-terizza le linee guida basate sulle prove di efficacia, maanche un indicatore della validità delle raccomandazioniprodotte da una conferenza di consenso e del processo diproduzione di criteri di appropriatezza per una certa pro-cedura o intervento.
Graduazione delle raccomandazioni (grading)
Livello di prova e forza della raccomandazioneDefinire il grado di validità delle informazioni scienti-
fiche alla base delle raccomandazioni e chiarire quanta im-portanza si attribuisce alla loro applicazione costituisceuno dei caratteri distintivi del processo di produzione di li-nee guida basate sulle prove di efficacia.
In attesa che sia disponibile un sistema unificato e con-diviso di grading è utile indicare alcuni punti fermi da te-nere presenti nell’uso dei sistemi di classificazione, sia perquanto riguarda la qualità delle prove (indicata come li-vello di prova, dall’inglese levels of evidence) sia perquanto riguarda la forza delle raccomandazioni (dall’in-glese strength of recommendations) da esse derivate.
Il livello di prova indica la probabilità che un certo nu-mero di conoscenze sia derivato da studi pianificati e con-dotti in modo tale da produrre informazioni valide e privedi errori sistematici.
La forza della raccomandazione si riferisce invece allaprobabilità che l’applicazione nella pratica di una racco-mandazione determini un miglioramento dello stato di sa-lute della popolazione, obiettivo cui la raccomandazione èrivolta.
In altre parole, il livello di prova dipende dal grado dicertezza che si può avere riguardo l’esattezza e la preci-sione dell’effetto di un intervento, mentre la forza dellaraccomandazione riguarda il grado di convinzione concui si ritiene che una certa raccomandazione debba esse-re implementata. Quindi il livello di prova condiziona -con intensità variabile a seconda del tipo e della com-plessità del quesito - ma non determina completamente laforza della raccomandazione. Questa, a sua volta, dipen-de tanto più strettamente dal livello di prova quanto mag-giore è la specificità del quesito e l’applicabilità direttadel disegno dello studio controllato e randomizzato (cioèil tipo di studio con livello di prova più alto nei vari si-stemi di grading).
Complessivamente, quindi, si può affermare che il li-vello di prova dipende:– dall’appropriatezza del disegno di studio utilizzato
(qualità metodologica a priori);– dal rigore e dalla qualità di conduzione e analisi dello
studio (controllo dell’errore sistematico);– dalla dimensione dell’effetto clinico-epidemiologico
misurato (controllo dell’errore casuale);– dall’appropriatezza e dalla rilevanza degli indicatori di
esito utilizzati (rilevanza clinico-epidemiologica).La forza della raccomandazione dipende invece:
– dalla valutazione complessiva del livello di prova se-condo i criteri sopra definiti;
– dalla valutazione dell’applicabilità dello specificocomportamento contenuto nella raccomandazione;
– dalle difficoltà e dalle barriere previste nell’applica-zione della raccomandazione;
– dall’accettabilità culturale e sociale della specifica rac-comandazione.
Gli schemi di gradingLa maggior parte dei sistemi di classificazione dei li-
velli di prova - anche perché sviluppati per valutare quesi-ti relativi all’efficacia degli interventi - considera come li-vello di prova più alto quello che trae le informazioni dastudi controllati randomizzati (talvolta introducendo sotto-classi in base al numero e alla dimensione degli studi) ecome livello più basso quello in cui le prove sono basatesull’opinione di esperti in assenza di dati empirici. Il nu-mero di classi varia nei differenti sistemi con un rangecompreso tra 4 e 12.
Alcuni sistemi di classificazione fanno discendere inmodo rigido la forza delle raccomandazioni dal relativolivello di prova (è il caso delle linee guida scozzesi delSIGN - Scottish Intercollegiate Guideline Network;http://www.sign.ac.uk), mentre in altri, pur tenendo con-
384 G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4http://gimle.fsm.it
to del livello di prova, la determinazione della forza del-le raccomandazioni viene effettuata considerando lacomplessità del quesito, l’effettiva possibilità di condur-re studi randomizzati sull’argomento e la percezione so-cio-culturale del problema. Tra questi due estremi si tro-vano sistemi di grading che affiancano alla considera-zione della validità a priori del disegno di studio la valu-tazione della precisione dei risultati e della coerenza trai risultati di studi diversi.
Un esempio: il modello canadeseGli attuali schemi di grading derivano per successive
modificazioni e miglioramenti da quello messo a punto sindal 1979 dalla Canadian Task Force on the Periodic HealthExamination (http://www.ctfphc.org) e successivamente an-che dalla United States Preventive Services Task Force (c).
Lo schema attualmente utilizzato dalla Canadian TaskForce on the Periodic Health Examination attribuisce unpeso maggiore alle caratteristiche del disegno dello studioe dell’analisi che tendono a eliminare o minimizzare i ri-sultati distorti (biased) e produce raccomandazioni di for-za graduata senza un vincolo rigido tra forza delle racco-mandazioni e livello di prova.
Lo schema è così articolato:– buona evidenza a supporto della raccomandazione che
la condizione venga specificamente considerata in unoscreening periodico;
– discreta evidenza a supporto della raccomandazioneche la condizione venga specificamente considerata inuno screening periodico;
– scarsa evidenza a supporto dell’inclusione o dell’esclu-sione di una condizione in uno screening periodico; leraccomandazioni possono essere fatte su altre basi;
– discreta evidenza a supporto della raccomandazioneche la condizione venga specificamente esclusa in unoscreening periodico.
– buona evidenza a supporto della raccomandazione chela condizione venga specificamente esclusa in unoscreening periodico.Lo schema tiene conto solo di alcuni aspetti generali
del livello delle prove, valutando principalmente il dise-gno dello studio e solo parzialmente la sua qualità meto-dologica, mentre non prende in considerazione aspetti im-portanti come la rilevanza clinica o i benefici attesi (di-stinti chiaramente rispetto alla significatività statistica).
Inoltre tra i livelli di prova non viene previsto come li-vello ad hoc quello delle revisioni sistematiche o delle me-tanalisi. Molti schemi, al contrario, hanno definito la pre-senza di più studi con risultati tra loro omogenei o coeren-ti oppure la presenza di una revisione sistematica (edeventualmente anche di una metanalisi) come un livello diprova più elevato in quanto maggiormente affidabile.
Il modello adottato dal Sistema nazionale per le lineeguida
Lo schema utilizzato dal SNLG è stato sviluppato dalCentro per la valutazione dell’efficacia dell’assistenza sa-nitaria (CeVEAS) dell’Azienda USL di Modena. Secondoquesto sistema di grading la decisione di raccomandare omeno l’esecuzione di una determinata procedura può di-
pendere da diversi fattori, tra i quali la qualità delle provescientifiche a supporto o contrarie, l’importanza del pro-blema specifico dal punto di vista assistenziale, i costi,l’accettabilità e la praticabilità dell’intervento.
Il livello delle prove è classificato secondo lo schemaseguente:I - prove ottenute da più studi clinici controllati rando-
mizzati e/o da revisioni sistematiche di studi rando-mizzati;
II - prove ottenute da un solo studio randomizzato di di-segno adeguato;
III - prove ottenute da studi di coorte con controlli con-correnti o storici o loro metanalisi;
IV - prove ottenute da studi retrospettivi tipo caso-con-trollo o loro metanalisi;
V - prove ottenute da studi di casistica (“serie di casi”)senza gruppo di controllo;
VI - prove basate sull’opinione di esperti autorevoli o dicomitati di esperti come indicato in linee guida o inconsensus conference, o basate su opinioni dei mem-bri del gruppo di lavoro responsabile della specificalinee guida.
La classificazione della forza delle raccomandazionisegue invece questo schema:A - l’esecuzione della particolare procedura o test diagno-
stico è fortemente raccomandata (indica una racco-mandazione sostenuta da prove scientifiche di buonaqualità, anche se non necessariamente di tipo I o II);
B - si nutrono dei dubbi sul fatto che quella particolareprocedura/intervento debba sempre essere raccoman-data/o, ma si ritiene che la sua esecuzione debba es-sere attentamente considerata;
C - esiste una sostanziale incertezza a favore o contro laraccomandazione di eseguire la procedura o l’inter-vento;
D - l’esecuzione della procedura non è raccomandata;E - si sconsiglia fortemente l’esecuzione della procedura.
In questo modello la classificazione di una raccoman-dazione secondo la gradazione da A ad E non rispecchiasolo la qualità metodologica delle prove disponibili. In al-cuni casi infatti, anche in presenza di una prova di effica-cia di tipo I la raccomandazione può essere di tipo B o Cse esiste una reale incertezza sulla fattibilità e sull’impat-to della procedura. Analogamente, in alcuni casi, il grup-po di lavoro può assegnare alla raccomandazione il gradoA anche in assenza di prove di tipo I o II, quando il conte-nuto della raccomandazione riguarda questioni di solitonon affrontate con disegni di studio randomizzati (peresempio informazioni da fornire al paziente sulla diagno-si e sul trattamento).
Questo schema, quindi, differenzia chiaramente il li-vello di prova dalla forza delle raccomandazioni cercandodi utilizzare le due scale in modo relativamente indipen-dente pur rispettando i criteri alla base degli schemi digrading.
Indicatori di monitoraggioÈ importante verificare nel tempo se almeno le princi-
pali raccomandazioni siano state effettivamente imple-
G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4 385http://gimle.fsm.it
mentate, indipendentemente dall’approccio adottato perprodurle, in modo da valutarne l’impatto. Per questo essedevono essere accompagnate dalla specificazione dei be-nefici attesi e da indicatori appropriati che permettanoun’attività di audit clinico. Nel definire questi indicatori sideve tenere presente:– la loro rilevanza clinico-epidemiologica;– la rilevanza dell’indicatore per i professionisti che sa-
ranno chiamati ad applicare quella raccomandazione;– la fattibilità dei cambiamenti (di tipo comportamenta-
le, organizzativo eccetera) che sono richiesti per potermettere in atto il comportamento raccomandato;
– la disponibilità di dati (meglio se correnti) per misura-re l’indicatore prescelto.
BibliografiaBero LA, Grilli R, Grimshaw JM, et al. Getting research findings into
practice. Closing the gap between research and practice: anoverview of systematic reviews of interventions to promote theimplementation of research findings. BMJ 1998; 317: 465-8.
Canadian Medical Association (CMA). CMA infobase: Clinical PracticeGuidelines (CPGs). www.cma.ca/cpgs
Canadian Task Force on Preventive Health Care. Methodology.http://www.cma.ca/cpgs/handbook/index.htm
Canadian Task Force on the Periodic Health Examination. The periodichealth examination. CMAJ 1979; 121: 1193-254.
CeVEAS (a cura di). Linee guida per il trattamento del tumore dellamammella in provincia di Modena. Gruppo GLICO, Azienda Ospe-daliera e Azienda USL, Modena, 2000.
Der Simonian R, Laird N. Meta-analysis in clinical trials. Cont ClinTrials 1986; 7: 177-188.
Egger M, Davey Smith G, Altman DG. Systematic reviews in healthcare: meta-analysis in context. BMJ Books, London, 2001.
Haute Autorité de Santé (HAS). http://www.anaes.frJackson R, Feder G. Guidelines for clinical guidelines. BMJ 1998; 317:
427-8.Margolin BH. Statistical aspects of using biological markers. Stat Sci,
1988; 3: 351-7.North of England Evidence-based Guidelines Development Project.
Methods of developing guidelines for efficient drug use in primarycare. BMJ 1998; 316: 1232-5.
Scottish Intercollegiate Guideline Network (SIGN). http://www.sign.ac.ukShekelle PG, Woolf SH, Eccles M, Grimshaw J. Developing guidelines.
BMJ 1999; 318: 593-6.The Cochrane collaboration. http://www.cochrane.org
5. Valutazione della qualità metodologica di una linea guida
Il metodo AGREEUno degli strumenti più efficaci per valutare la qualità
metodologica di una linea guida clinica è rappresentatodallo schema Appraisal of Guidelines Research and Eva-luation in Europe (AGREE), ampiamente collaudato nelcampo delle linee guida in medicina del lavoro.
Questo strumento richiede la formulazione di giudizisui metodi adottati per l’elaborazione della linee guida, sulcontenuto delle raccomandazioni conclusive e sui fattoriinerenti la loro adozione nella pratica. Con il metodoAGREE è possibile valutare sia la qualità dei contenutidella linea guida, sia quella di alcuni aspetti delle racco-mandazioni, per ottenere un giudizio sulla validità del do-cumento in termini di probabilità che esso riesca effettiva-mente a ottenere gli obiettivi auspicati.
Lo strumento AGREE viene applicato sia alle lineeguida in fase di elaborazione sia agli aggiornamenti deidocumenti esistenti.
La descrizione delle caratteristiche del metodo è trattadal relativo documento elaborato dall’Agenzia sanitariaregionale dell’Emilia-Romagna, che ha partecipato al pro-getto europeo che ha sviluppato lo strumento e lo ha tra-dotto in italiano
Struttura e contenutoLo strumento AGREE è in pratica una checklist di 23
criteri (item) suddivisi in sei aree. Ogni area è dedicata aun aspetto specifico della qualità di una linea guida. Que-sti aspetti sono:– obiettivo e motivazione (item 1-3): riguarda gli
obiettivi generali della linea guida, gli specifici que-siti clinici affrontati e la popolazione di pazienti cuisi rivolge;
– coinvolgimento delle parti in causa (item 4-7): riguar-da la misura in cui la linea guida rappresenta le opi-nioni dei suoi potenziali utilizzatori;
– rigore dell’elaborazione (item 8-14): si riferisce al pro-cesso utilizzato per identificare e sintetizzare le infor-mazioni scientifiche, per formulare le raccomandazio-ni e per mantenerle aggiornate;
– chiarezza e presentazione (item 15-18): riguarda la for-mulazione e il formato della linea guida.
– applicabilità (item 19-21): si riferisce alle possibili im-plicazioni organizzative, economiche e relative aicomportamenti professionali attese dall’applicazionedella linea guida;
– indipendenza editoriale (item 22-23): riguarda l’indi-pendenza delle raccomandazioni e l’esplicito ricono-scimento di possibili conflitti di interesse da parte delgruppo che ha elaborato la linea guida.
DocumentazionePrima di procedere alla valutazione di una linea guida
è necessario cercare di identificare tutte le informazionirelative alle modalità della sua elaborazione. Questeinformazioni possono essere riportate nello stesso docu-mento in cui si trovano le raccomandazioni oppure pos-sono essere riassunte in una scheda tecnica a parte, inpubblicazioni scientifiche o in documenti programmaticigenerali (come accade, per esempio, nel caso dei pro-grammi nazionali di elaborazione di linee guida). È quin-di importante leggere per intero la linea guida e la sua do-cumentazione di accompagnamento prima di iniziare lavalutazione.
Numero di valutatoriOgni linea guida dovrebbe essere valutata da almeno
due (preferibilmente quattro) valutatori, per migliorare lariproducibilità della valutazione.
Scala delle risposteOgni item è valutato su una scala a quattro punti che
indica la misura in cui un criterio (item) è stato soddisfat-to. La scala è così costruita:
386 G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4http://gimle.fsm.it
– il valore 4 indica completo accordo: il valutatore asse-gna un punteggio 4 a un item se ritiene che sia statopienamente soddisfatto;
– i valori intermedi 3 e 2 indicano rispettivamente ac-cordo e disaccordo: sono utilizzati nel caso in cui il va-lutatore è incerto sul fatto che un item sia stato soddi-sfatto, per esempio perché le informazioni a disposi-zione non sono chiare oppure perché è stato soddisfat-to solo per alcune delle raccomandazioni; in questo ca-so il valutatore assegna un punteggio 3 o 2 a un item aseconda di quanto ritiene che sia stato adeguatamenteconsiderato;
– il valore 1 indica completo disaccordo: il valutatore as-segna un punteggio 1 a un item se ritiene che non siastato per nulla soddisfatto o non vi siano le informa-zioni necessarie per valutarlo.
Istruzioni pratiche per l’applicazioneLe indicazioni specifiche per la compilazione della
checklist di valutazione sono fornite nelle istruzioni cheaccompagnano ogni item. Queste informazioni hanno loscopo di aiutare a capire le questioni e i concetti ai qualiogni item si riferisce.
Il calcolo dei punteggi per area
Quattro valutatori attribuiscono i seguenti punteggi agli item dell’area 1 (obiettivo e motivazione della linea guida):
Item 1 Item 2 Item 3 TotaleValutatore 1 2 3 3 8Valutatore 2 3 3 4 10Valutatore 3 2 4 3 9Valutatore 4 2 3 4 9Totale 9 13 14 36
Si calcolano i punteggi massimo e minimo possibili:
punteggio massimo possibile = 4 (completo accordo) x 3 (item) x 4 (valutatori) = 48punteggio minimo possibile = 1 (completo disaccordo) x 3 (item) x 4 (valutatori) = 12
Il punteggio area-specifico standardizzato è:
punteggio ottenuto - punteggio minimo possibile 36 – 12 24–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = ––––––– = –––– = 0,67 x 100 = 67%punteggio massimo possibile - punteggio minimo possibile 48 – 12 36
CommentiPer ogni item è previsto uno spazio per i commenti, da
utilizzare per spiegare le ragioni delle risposte. Nella par-te finale della checklist è disponibile uno spazio per ulte-riori commenti.
Punteggi per areaPer ognuna delle sei aree in cui sono suddivisi gli item
possono essere calcolati dei punteggi area-specifici, som-mando quelli dei singoli item che la compongono e stan-dardizzando il totale come percentuale del punteggio mas-simo possibile per quell’area.
Un esempio è riportato nel riquadro Il calcolo dei pun-teggi per area.
Le sei aree sono tra loro indipendenti e i relativi pun-teggi non dovrebbero essere aggregati in un unico punteg-gio complessivo di qualità.
Anche se i punteggi area-specifici possono essereutili per confrontare tra loro le linee guida e possonofornire indicazioni per decidere se adottare o meno unalinea guida, non è possibile identificare un valore sogliadi punteggio che discrimini le “buone” dalle “cattive”linee guida.
Giudizio complessivoAl termine della checklist è presente una sezione dedi-
cata al giudizio complessivo sulla linea guida. Comprendele seguenti opzioni:– sì, fortemente raccomandata;– sì, raccomandata (con riserva);– non raccomandata;– non so.
La valutazione complessiva richiede un giudizio glo-bale sulla qualità della linea guida prendendo in conside-razione ciascuno dei criteri di valutazione.
BibliografiaAgenzia sanitaria regionale Emilia-Romagna. AGREE. Uno strumento
per la valutazione della qualità delle linee guida cliniche. Dossier60-2002 (disponibile online all’indirizzo: http://asr.regione.emilia-romagna.it/wcm/asr/collana_dossier/doss060.htm)
Cates JR, Young DN, Bowerman DS, Porter RC. An independent AGREEevaluation of the occupational medicine practice guidelines. Spine J.2006; 6(1): 72-7.
Cluzeau F. Littlejohns P, Grimshaw J, et al. Development and applicationof a generic methodology to assess the quality of clinical guidelines.Int J Qual Health Care 1999; 11: 21-8.
Grol R, Dalhuijzen J, Mokkink H, et al. Attributes of clinical guidelinesthat influence use of guidelines in general practice: observationalstudy. BMJ 1998; 317: 858-61.
G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4 387http://gimle.fsm.it
Hayward RS, Wilson MC, Tunis SR, et al. Users’ guides to the medicalliterature. VIII: How to use clinical practice guidelines. A: Are therecommendations valid? JAMA 1995; 274: 570-4.
Hulshof C, Hoenen J. Evidence-based practice guidelines in OHS: arethey Agree-able? Ind Health 2007; 45(1): 26-31.
Lohr KN. The quality of practice guidelines and the quality of healthcare. In: Selbmann HK. Guidelines in health care. Report of a WHOConference, January 1997. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1998.
Lohr KN, Field MJ. A provisional instrument for assessing clinicalpractice guidelines. In: Field MJ, Lohr KN (eds). Guidelines forclinical practice: from development to use. National Academy Press,Washington, 1992.
Manchikanti L, Singh V, Helm S, et al. A critical appraisal of 2007American College of Occupational and Environmental Medicine(ACOEM) practice guidelines for interventional pain management:An independent review utilizing AGREE, AMA, IOM, and othercriteria. Pain Physician 2008; 11: 291-310.
6. Formazione a distanza
SIMLII sta realizzando, in collaborazione con Zadig(unità operativa del Sistema nazionale per le linee guida)un programma di formazione a distanza (FAD), attivo al-l’interno di una piattaforma online specifica per la forma-zione a distanza e basato sul modello del caso clinico, chefavorisce l’acquisizione delle conoscenze e innesca unprocesso di apprendimento attivo.
Nella fase iniziale sarà messo a punto un prototipocon cinque casi destinati ai medici del lavoro iscritti allaSIMLII.
Caratteristiche del programmaIl programma di formazione prevede due possibili tipi
di percorso: un caso unico con i relativi quesiti oppure uncaso a scenari multipli. Per ogni caso sono indicati gliobiettivi formativi specifici e viene messa a disposizionela documentazione relativa al tema trattato.
Il caso singolo è una storia che segue diverse fasi, perognuna delle quali sono previste una o due domande a ri-sposta singola o multipla. La storia è costruita in modo dariprodurre fedelmente le condizioni reali che si incontranonella pratica clinica ed è resa più interessante e coinvol-gente da una sceneggiatura che prevede discorsi direttimedico-paziente o medico-medico e dall’eventuale pre-senza di immagini.
Ogni domanda ha cinque possibili risposte; quelle cor-rette hanno un riscontro preciso nella fonte, in modo che ilmedico che sta facendo il percorso possa valutare imme-diatamente la correttezza o meno della risposta fornitacliccando l’apposita voce Approfondimento. Al terminedel percorso è prevista una frase nella quale è contenuta laconclusione della storia.
Il caso a scenari multipli è una variante del modellodescritto in cui la storia non segue un filo unico e checonsente così di porre domande mirate. Il caso prevedeinfatti una serie di scenari differenti con 1, 2 o 3 doman-de, comunque collegate alla fonte, alla storia e alla situa-zione clinico-terapeutica del paziente. Come nel casoprecedente, ogni scenario è costruito con discorsi diretti
medico-paziente o medico-medico e prevede la frase diconclusione.
RealizzazioneIl coordinatore del gruppo di lavoro incaricato di ela-
borare la linea guida (o comunque il documento di riferi-mento) a cui si riferisce il percorso formativo ha il compi-to di curare la redazione della documentazione specificaper la formazione a distanza, in collaborazione con gliesperti indicati da Zadig. È previsto un processo di refe-raggio dei casi.
Il materiale viene poi sottoposto, a cura della redazio-ne, a tutte le lavorazioni necessarie per la pubblicazionenel sistema: editing, omogeneizzazione, lavorazione delleimmagini, preparazione per la messa online, inserimentoonline.
Viene anche messo a disposizione degli utenti un ser-vizio di supporto (help desk) per quanto riguarda difficoltàd’uso, informazioni e problemi sui contenuti.
Infine, per valutare il gradimento del programma daparte degli utenti, è disponibile un questionario ad hoc, de-finito da SIMLII e da Zadig.
Crediti ECMLa piattaforma prevede un sistema di erogazione dei
crediti ECM, con produzione della certificazione dei cre-diti acquisiti in formato pdf.
L’accreditamento verrà fatto al sistema ECM dellaRegione Lombardia e il provider sarà indicato da SIMLII.
BibliografiaCinquini M, Moja L, Moschetti I, et al Predictors of evidence-based
knowledge among italian doctors. Abstract al XVI CochraneColloquium, Friburgo, 3 ottobre 2008.
Cook DA, Levinson AJ, Garside S, et al. Internet-based learning in thehealth professions. A meta-analysis. JAMA 2008; 300: 1181-96.
Dri P, per il Gruppo di lavoro ECCE. Il progetto ECCE (Educazione Con-tinua basata su Clinical Evidence): i risultati di un modello di forma-zione a distanza orientato sul caso clinico. BIF 2006; 13(1): 10-6.
Dri P, per il Gruppo di lavoro ECCE. Il progetto ECCE tocca quota ottanta-mila: le esperienze di medici e infermieri in parallelo. BIF 2007; 1: 3-7.
Dri P. Il Progetto ECCE-Clinical Evidence: i risultati di due anni di spe-rimentazione. In: Agenzia sanitaria e sociale Regione Emilia-Roma-gna. Per un osservatorio nazionale sulla qualità nell’Educazionecontinua in medicina. Dossier 2008; 170: 83-4.
Fordis M, King J, Ballantyne C, et al. Comparison of the instructionalefficacy of internet-based CME with live interactive CME workshops.A randomized controlled trial. JAMA 2005; 294: 1043-51.
Moja L, Moschetti I, Cinquini M, et al. Clinical Evidence ContinuousMedical Education: a randomised educational trial of an openaccess e-learning program for transferring evidence-basedinformation - ICEKUBE (Italian Clinical Evidence KnowledgeUtilization Behaviour Evaluation) - Study protocol. ImplementSci 2008; 3: 37.
Moja L, Moschetti I, Liberati A, et al. Using Clinical Evidence in anational continuing medical education program in Italy. PlosMedicine 2007; 4(5): e113.
Naldi L, Manfrini R, Martin L, et al. Feasibility of a web-based conti-nuing medical education programme in dermatology. The Dermo-FAD experience in Italy. Dermatology 2006: 213: 6-11.
Scarpa N, di Giulio P, Manfrini R, et al. Il web come strumento per ren-dere accessibile a tutti gli infermieri la formazione evidence based.Abstract al XIV Congresso nzionale SIPEM (Società italiana di pe-dagogia medica), Rimini, 22 febbraio 2008.
388 G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4http://gimle.fsm.it
7. Conclusioni
Qualunque riflessione riguardo la scelta e l’applicabi-lità degli strumenti di orientamento e di aggiornamento inmedicina deve nascere dall’accordo sul ruolo che spetta almedico del lavoro in un nuovo, auspicabilmente vicino,approccio preventivo in cui alla legge siano attribuiti com-piti di indirizzo generale e alla normativa tecnica, emana-ta da entità specifiche, siano affidati gli aspetti attuativi
Si tratta quindi di essere d’accordo sulla valorizzazio-ne dei riferimenti tecnici nei quali il medico del lavoro haun ruolo preciso nel contribuire a individuare e applicarele norme di buona tecnica, che non sono obblighi sanzio-nabili in caso di non ottemperanza ma mezzi di orienta-mento ai quali il professionista aderisce liberamente,avendone colto le opportunità.
Il valore formativo delle linea guida non è stato finoraadeguatamente considerato; tuttavia questi strumenti pos-sono costituire un formidabile mezzo di aggiornamentoper il medico in quanto consentono la diffusione delle piùaggiornate, corrette e valide acquisizioni scientifiche nel-l’ambito della evidence based medicine.
In questo senso, l’inserimento delle linee guida neiprocessi di educazione permanente del medico è ritenutoda tutti fondamentale, insieme alla sensibilizzazione sullaqualità delle prestazioni, alla loro documentazione (attra-verso audit e feed-back) e al miglioramento del contestoculturale e operativo.
Un’azione altrettanto importante va condotta sui dato-ri di lavoro e sui lavoratori, per illustrare i vantaggi che de-rivano loro, in termini di qualità e di efficacia delle scelteoperative, dall’aderenza dei medici alle linee guida.
Le linee guida devono poter essere adattate alle situa-zioni specifiche, anche se difficilmente possono compren-dere e trattare tutta la complessità delle condizioni che sipresentano ogni giorno nella pratica medica: in questosenso è particolarmente utile per il medico poter indivi-duare facilmente i punti fondamentali che implicano scel-te critiche di percorso e di decisione. Per soddisfare que-sta necessità è importante che le linee guida abbiano unastruttura e un linguaggio chiari e comprensibili, che met-tano in evidenza i punti fondamentali che non devono pre-sentare imprecisioni o approssimazioni e che indichinocon altrettanta chiarezza gli aspetti per i quali non esisto-no dati sufficienti o univoci. A questo scopo frasi perento-rie come “è indicato” oppure “non è indicato” vanno pre-ferite ad altre non altrettanto precise.
La flessibilità diventa essenziale perché consente almedico di esercitare il suo giudizio nella situazione speci-fica, coinvolgendo lavoratori e datori di lavoro nelle deci-sioni da assumere. Ciò è particolarmente importante quan-do esistono diverse opzioni e la scelta tra esse si basa nonsolo sulle prove scientifiche, ma anche sui valori dei clien-ti. Il medico,quindi, deve essere considerato un interlocu-tore capace, in base alla sua esperienza, di utilizzare le li-nee guida e non un semplice esecutore di regole o indica-zioni da subire acriticamente.
Finora in Italia le società scientifiche non hanno dimo-strato grande interesse per attività come la produzione di
linee guida, l’accreditamento e il controllo di qualità, cioèper le espressioni più significative della scienza collettiva,mentre è generalmente accettato che l’osservanza delle li-nee guida, proprio nel significato e nel valore che a esse variservato - sia subordinata all’avvallo di una valida entitào istituzione emanante, quella scientificamente più rappre-sentativa in un determinato campo.
Nell’ambito della medicina del lavoro, l’introduzionedelle linee guida è stata accolta con favore dai medici (ve-di riquadro I medici del lavoro e le linee guida). In questocampo le linee guida devono comprendere la trattazione diuna varietà di aspetti che va dalla normativa specifica delsettore alla letteratura scientifica, alla tecnologia produtti-va, alla clinica, all’epidemiologia, allo scopo di aiutare ilmedico a prendere decisioni e a valutare la buona praticae il comportamento professionale.
In particolare è richiesto un impegno personale e co-stante del medico del lavoro nel coltivare la propria cre-scita professionale e nel curare la propria formazione con-tinua per viaggiare al passo con l’innovazione tecnologicae scientifica nel settore.
Le linee guida rappresentano un modello di riferimen-to per assicurare la qualificazione continua del medico dellavoro a partire dal conseguimento del titolo di specializ-zazione e contengono i meccanismi procedurali che ogniassociazione scientifica, in qualità di organo di autogover-no della professione, è tenuta a elaborare.
In conclusione si può affermare che una buona prati-ca in medicina del lavoro, senza essere ingabbiata inschemi rigidi che farebbero perdere la visione olisticadel lavoratore, deve essere finalizzata non solo all’effi-cacia preventiva in senso stretto, ma anche al costanteimpiego di metodologie rigorose basate sempre più sul-le prove e di procedure il più possibile uniformi su tuttoil territorio.
I medici del lavoro e le linee guidaSecondo un’indagine condotta tra i soci SIMLII
(Iavicoli, 2008) il 66% dei medici del lavoro intervi-stati ritiene l’introduzione delle linee guida molto uti-le, il 27% utile ma non necessaria, mentre una minimaparte del campione (1%) la giudica inutile o addirittu-ra pericolosa.
Secondo il 52% degli intervistati le linee guida do-vrebbero essere caratterizzate da un’impostazione pra-tico-applicativa, mentre il 10% ritiene che dovrebberocostituire soprattutto uno strumento di aggiornamentoscientifico e il restante 38% preferirebbe un’imposta-zione mista che comprenda entrambi gli aspetti.
Il 72% del campione, inoltre, ritiene che le linee gui-da dovrebbero riguardare tematiche specifiche e il 27%ritiene che dovrebbero essere di tipo metodologico.
Infine, l’introduzione della tematica delle linee gui-da in quella dell’accreditamento è pienamente condivi-sa dal 78% del campione.
BibliografiaIavicoli S, Rondinone BM, Abbritti G, et al. Formazione continua e
accreditamento di eccellenza della SIMLII: risultati di un’indagineconoscitiva tra i soci. Med Lav 2008: 99; 145-56.
G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4 389http://gimle.fsm.it
Appendice 1. Glossario
A
AccreditamentoProcesso che porta a riconoscere che un’organizzazione (sanita-ria e non) soddisfa determinati requisiti espliciti di buona orga-nizzazione. Si distinguono un accreditamento istituzionale, effet-tuato da o per conto dei governi, senza il quale un’organizzazio-ne sanitaria pubblica o privata non è autorizzata a operare nel si-stema pubblico, e un accreditamento volontario o di eccellenza,promosso da entità interne al mondo sanitario (in primo luogo lesocietà scientifiche) per la formazione e il miglioramento conti-nuo della qualità organizzativa.In entrambi i tipi di accreditamento si dà grande importanza al si-stema di qualità. L’ente italiano di accreditamento è il SINCERT (Sistema nazio-nale per l’accreditamento degli organi di certificazione). L’accreditamento istituzionale italiano ha come riferimento es-senziale il DPR del 14/01/1997. L’accreditamento volontario è di due tipi:– quello effettuato da grandi agenzie di accreditamento indi-
pendenti. La volontarietà di questo tipo di accreditamento èormai solo teorica, in quanto i governi hanno cominciato a ri-conoscere alle organizzazioni accreditate in questo modo al-cuni vantaggi, dalla possibilità di essere sede di insegnamen-to postuniversitario alla possibilità di ricevere fondi pubbliciper la ricerca o per l’assistenza;
– quello promosso da gruppi professionali e da società scienti-fiche, per lo più limitato a un settore specifico di interesse econdotto sulla base di manuali di accreditamento sviluppatiinternamente. Per questo motivo si parla anche di accredita-mento “tra pari” o di accreditamento “all’eccellenza”. In am-biente internazionale questo tipo di accreditamento è notocon il termine olandese visitatie.
AppropriatezzaSecondo la definizione condivisa a livello internazionale, è unaproprietà per la quale una prestazione, oltre a essere efficace, vie-ne erogata ai soggetti che ne possono realmente beneficiare, conla modalità assistenziale più idonea e con le caratteristiche (ditempestività, di continuità, eccetera) necessarie a garantirne l’ef-fettiva utilità. In altre parole, una prestazione appropriata do-vrebbe essere erogata rispettando il quadro clinico del paziente eseguendo le indicazioni per le quali si è dimostrata efficace, nelmomento giusto e secondo il regime organizzativo più adeguato.L’appropriatezza va dunque valutata sia rispetto alle modalità dierogazione della prestazione stessa sia rispetto alle esigenze disalute del paziente a cui è destinata, tenendo conto di una seriedi variabili che vanno oltre le caratteristiche cliniche del quadropatologico.I vari ambiti dell’appropriatezza vengono di solito ricondotti adue componenti fondamentali - appropriatezza clinica e organiz-zativa - e valutati mediante indicatori ad hoc per verificare se ilsistema sia rilevante rispetto ai bisogni di salute e se sia basatosu standard scientificamente validi e condivisi. Si tratta, nellamaggior parte dei casi, di indicatori che fanno parte di program-mi istituzionali di controllo della qualità globale dell’organizza-zione sanitaria. In ogni caso la misura dell’appropriatezza con-tribuisce a determinare la performance complessiva di un siste-ma sanitario e a valutarne gli eventuali cambiamenti nel tempo.Si tratta quindi di un elemento del sistema non scindibile daglialtri e valutabile a pieno solo con metodologie integrate.
In Italia esistono vari strumenti di valutazione, specie nel settoredei ricoveri ospedalieri. Dal punto di vista normativo, le indica-zioni del D.Lgs. 229/99 contengono espliciti riferimenti all’ap-propriatezza come condizione necessaria dei Livelli Essenziali diassistenza (LEA) erogati dal Servizio sanitario nazionale. Moltidegli indicatori prodotti sulla base delle Schede di dimissioneospedaliera (SDO) e alcuni di quelli inclusi nel sistema di garan-zie per il monitoraggio dei LEA (DM 12/12/2001) possono esse-re considerati indicatori di appropriatezza (per esempio il tassodi ospedalizzazione per particolari procedure chirurgiche, la per-centuale di ricoveri evitabili per patologie acute o croniche).Manca ancora, invece, una riorganizzazione del sistema infor-mativo esistente in funzione della misurazione dell’appropriatez-za o una sua eventuale implementazione per questo specificoobiettivo.
AuditNel sistema ISO 9000 il termine indica la valutazione formaledel rispetto delle procedure e viene tradotto con l’espressione ve-rifica ispettiva. In campo sanitario l’audit clinico è utilizzato pre-valentemente in Inghilterra, ma comincia a diffondersi anche inItalia.Si distinguono audit interni, svolti nell’ambito del singolo grup-po di lavoro e della singola organizzazione, e audit esterni mul-ticentrici. In Inghilterra, gli audit esterni sono spesso iniziativeche partono dall’alto e sono affidate a enti professionali in cuiverificatori esterni controllano se l’assistenza fornita corrispon-da a standard predefiniti e, in caso contrario, definiscono inter-venti di miglioramento. Talvolta il termine si riferisce anche a iniziative di accredita-mento volontario, in particolare alla fase di autovalutazione.
B
Buone prassiNel D.Lgs. 81/08 sono definite come soluzioni organizzative oprocedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme dibuona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a pro-muovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro attraversola riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di la-voro. Sono elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto Su-periore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL),dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortunisul Lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici e validate dal-la Commissione consultiva permanente, previa istruttoria tec-nica dell’ISPESL che provvede ad assicurarne la più ampia dif-fusione.
BiasIl termine comprende tutti i meccanismi di raccolta, analisi, in-terpretazione, pubblicazione o revisione dei dati che possonoportare a conclusioni che sono sistematicamente diverse dallaverità. Esistono diverse tipologie di bias:– bias di selezione (selection bias): bias nell’assegnazione o
nella selezione di pazienti per uno studio derivante dal di-segno dello studio anziché dal caso. Può presentarsi quan-do i gruppi di studio e di controllo sono scelti in modo dadifferire uno dall’altro per uno o più fattori che possono in-fluenzare l’esito dello studio. Il bias di selezione rende nonvalide le conclusioni e la generalizzabilità dei risultati del-lo studio;
– bias nell’accertamento: errore dovuto alle diverse modalitàdi accertamento degli esiti in studio che si applicano al grup-po di intervento rispetto a quello di controllo;
390 G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4http://gimle.fsm.it
– bias da osservatore (observer bias): bias che può presentarsiin uno studio nel quale la misurazione degli esiti o della gra-vità della malattia può essere soggetta a condizionamentopoiché gli osservatori conoscono le modalità di trattamentodei pazienti.
C
Conflitto di interessiContrasto tra gli interessi personali di un autore, di un direttoredi rivista, di un editore o di un referee, e la convenienza dell’i-stituzione o dell’ente da lui rappresentato o della comunità per laquale agisce.
CriterioPrincipio o parametro in base al quale si inquadra, si descrive, sistudia o si valuta un fenomeno. Il termine viene adoperato ancheper indicare i principi in base ai quali avviene il reclutamento deicasi in uno studio.
E
EfficaciaNell’ambito dei sistemi socio-sanitari, per efficacia (in ingleseeffectiveness) si intende la capacità di un intervento o di una pre-stazione di raggiungere gli obiettivi per i quali è stato effettuato,ma anche il beneficio e/o l’utilità che un individuo qualunque ouna popolazione non selezionata riceve dall’offerta di un servi-zio, trattamento o programma di intervento di cui sia stata preli-minarmente valutata l’efficacia clinica (in inglese efficacy) nellapopolazione target di uno studio clinico. L’efficacia clinica si va-luta nel contesto di studi sperimentali che mettono a confrontouna procedura diagnostica o una terapia con un’altra procedura otrattamento somministrato in un gruppo di controllo, nella situa-zione ideale in cui tutti i soggetti seguono il trattamento cui so-no stati assegnati casualmente secondo il protocollo dello studio.L’efficacia intesa come il raggiungimento della massima qualitàdei risultati viene spesso distinta (e a volte contrapposta) dall’ef-ficienza, intesa come raggiungimento dei risultati con la massi-mizzazione delle risorse impiegate (tempo, denaro, conoscenze,eccetera).
EfficienzaRapporto tra risorse impegnate e risultati ottenuti sotto tutti gliaspetti essenziali della qualità: appropriatezza, accessibilità, gradi-mento ma soprattutto efficacia. Questo concetto di efficienza nonva confuso con quello, derivato da ambiti diversi da quello sanita-rio, inteso come massimo numero di prestazioni erogate rispettoalle risorse impiegate. La pratica clinica più efficiente è quindiquella che migliora di più lo stato di salute della popolazione og-getto della prestazione in rapporto a un determinato budget.Di solito, l’efficienza viene analizzata verificando se i mezziutilizzati per raggiungere uno scopo avrebbero potuto essere im-piegati meglio investendoli in maniera diversa. Per esempio, icosti del rimborso pubblico di una terapia di disassuefazione alfumo potrebbero essere messi a confronto con i risultati di unacampagna informativa contro il tabacco o dell’applicazione diuna legge più restrittiva nei confronti dei fumatori.
Evidence based medicine (EBM; medicina basata sulle provedi efficacia)Può essere definita come “il coscienzioso, esplicito e accorto usodelle migliori prove disponibili per prendere decisioni sull’assi-
stenza sanitaria da fornire. La pratica dell’EBM implica l’inte-grazione dell’esperienza clinica individuale con le migliori pro-ve disponibili ricercate in modo sistematico”.Questo approccio, promosso in particolare dalla CochraneCollaboration, dà grosso peso agli studi controllati randomiz-zati e alle metanalisi per valutare l’efficacia degli interventiterapeutici. L’estensione di questo concetto anche a interven-ti sanitari non clinici e agli aspetti gestionali, ha dato originealla Evidence based health care (assistenza sanitaria basatasulle prove).
G
Governo clinico (clinical governance)Modalità di gestione dei servizi sanitari che attribuisce alla di-rezione generale anche la responsabilità della qualità clinicadei servizi. Questo approccio non va inteso come un’interfe-renza con l’autonomia professionale degli operatori sanitari,ma come un orientamento e una supervisione affinché realizzi-no attività sistematiche di valutazione e di miglioramento dellaqualità professionale.Il concetto di governo clinico è nato in Inghilterra alla fine de-gli anni novanta: in un documento del 1998 del Dipartimentodella salute britannico (A first class service) viene definito co-me il contesto all’interno del quale i servizi sanitari si rendonoresponsabili del miglioramento continuo della qualità delle lo-ro prestazioni e garantiscono elevati livelli di assistenza, graziealla creazione di un ambiente favorevole all’espressione del-l’eccellenza clinica.Il governo clinico è una politica sanitaria che si basa sull’atten-zione a come realmente vengono assistiti i pazienti; sull’impor-tanza della funzione clinico-assistenziale, dei servizi e delle di-verse figure professionali che ne sono responsabili; sull’esigen-za che l’efficacia e l’appropriatezza clinica diventino parte deicriteri operativi dei servizi, sulla valutazione della qualità delleprestazioni come parte integrante dell’attività istituzionale deiservizi; sull’esigenza di monitoraggio, indirizzo e regolazionedei processi assistenziali.Una politica sanitaria che abbia queste priorità dovrebbe preve-dere un intervento coordinato su diversi livelli di governo: a li-vello di governo regionale; nell’ambito decisionale inter e intraaziendale; a livello dei singoli gruppi di operatori.Per perseguire questa politica, all’interno delle aziende sanitariedevono essere avviate attività finalizzate a:– valutare l’efficacia e l’appropriatezza delle prestazioni
erogate attraverso iniziative di audit clinico e, più in gene-rale, a promuovere nella pratica clinica l’uso di interventila cui utilità clinica sia effettivamente dimostrata, riducen-do simmetricamente il ricorso a quelli di cui l’inefficaciasia conosciuta;
– a valutare le performance dei servizi, cioè i risultati cliniciottenuti;
– a utilizzare strumenti che consentano una gestione del rischioclinico e permettano quindi la sorveglianza costante deglieventi avversi, degli incidenti e degli errori che possono ca-ratterizzare l’attività sanitaria e la cui occorrenza mette a ri-schio la sicurezza dei pazienti.
I
Indicatori di attività-processoMisura dello svolgimento dei compiti del medico competente in-dividuati nel D.Lgs. 81/08. Questi compiti sono:
G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4 391http://gimle.fsm.it
– partecipazione alla valutazione del rischio (individuazionedei fattori di rischio attraverso una sorveglianza epidemiolo-gica, stima dell’esposizione, caratterizzazione del rischio an-che alla luce di condizioni di ipersuscettibilità) e alla predi-sposizione delle misure per la tutela della salute e dell’inte-grità psicofisica dei lavoratori;
– realizzazione delle attività di sorveglianza sanitaria (visitemediche, accertamenti integrativi, formulazione del giudiziodi idoneità);
– formazione e informazione (individuale, collettiva ed epide-miologica);
– collaborazione con il datore di lavoro per attività specifiche.
L
Linea guida (definizione generale)Secondo la definizione, comunemente accettata, dell’Institute ofMedicine statunitense, le linee guida sono raccomandazioni dicomportamento clinico, elaborate mediante un processo sistema-tico, con lo scopo di aiutare medici e pazienti nel decidere qualisiano le modalità assistenziali più appropriate in situazioni clini-che specifiche.Le linee guida vengono sviluppate da società di specialisti allaluce di tre criteri fondamentali: – presenza nel gruppo di lavoro incaricato dell’elaborazione di
professionisti di altre discipline, oltre a quella prevalente, odi rappresentanti dei pazienti;
– ricerca sistematica degli studi pubblicati sull’argomento; – definizione della forza delle prove scientifiche a sostegno di
ogni raccomandazione. I requisiti essenziali di una linea guida di buona qualità sono:– la chiara documentazione delle metodologie seguite per
l’identificazione degli esperti, per la ricerca delle fonti,per la sintesi e la valutazione critica delle informazioni ri-levanti;
– l’esplicita dichiarazione della forza di ogni raccomandazione(in base al livello di prova);
– la chiarezza espositiva e la comprensibilità;– l’indicazione delle modalità di implementazione;– l’aggiornamento periodico.Le raccomandazioni contenute in una linea guida non devono es-sere considerate vincolanti ed eccessivamente limitanti: la varia-bilità delle condizioni cliniche e delle situazioni psicologiche esociali dei pazienti, infatti, può rendere lecito o in alcuni casi ne-cessario un comportamento differente rispetto a quanto suggeri-to dalla linea guida professionale; in questo caso, però, è impor-tante specificare i motivi alla base della decisione. È difficile tro-vare un equilibrio tra linee guida intese come semplici racco-mandazioni, che rischiano di non essere applicate (con un impat-to minimo sull’assistenza), e linee guida vincolanti e intrusiveche pretendono eccessiva rigidità di comportamento da parte deiprofessionisti. Non va dimenticato che le raccomandazioni in sa-nità non possono che essere di tipo probabilistico e che, quindi,raramente possono riguardare tutti i pazienti e tutte le situazioni.Va comunque sottolineato che è particolarmente importante de-finire indicatori di applicazione.Per quanto riguarda l’adattamento locale di linee guida naziona-li o internazionali, è lecito cambiare le raccomandazioni basatesu prove deboli, ma d’altra parte è necessario motivare i cambia-menti delle raccomandazioni basate su prove forti.
Linea guida (definizione SIMLII, 2003)Acquisizione ed elaborazione di informazioni scientifiche (com-plete, condivise e aggiornate) e loro trasformazione in fonti di
aggiornamento e raccomandazioni sul modo più corretto di svol-gere determinati compiti professionali.
Linea guida (definizione del D.Lgs. 81/08)Nel D.Lgs. 81/08 è definita come un atto di indirizzo e coordi-namento per l’applicazione della normativa in materia di salute esicurezza predisposto dai ministeri, dalle regioni, dall’IstitutoSuperiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL)e dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortunisul Lavoro (INAIL) e approvato in sede di Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autono-me di Trento e di Bolzano.
M
MetanalisiValutazioni e sintesi sistematiche, organizzate e strutturate, basa-te sui risultati di molti studi indipendenti sullo stesso problemad’interesse (causa e comparsa della malattia, effetto del tratta-mento, metodo diagnostico, prognosi, eccetera).
MultidisciplinarietàPresenza nel gruppo di lavoro incaricato di elaborare una lineaguida di tutte le figure professionali interessate ai diversi aspet-ti e momenti della gestione el problema trattato. Oltre ai medi-ci del lavoro devono essere coinvolti nel gruppo di lavoro altrioperatori con competenza ed esperienza specifica sull’argo-mento. Inoltre una rappresentanza delle diverse professionalitàdeve essere concordata anche con le principali società scienti-fiche di riferimento e con le rappresentanze sindacali. Il grup-po di lavoro, infatti, non deve solo esprimere tutte le principa-li competenze tecniche, ma deve anche essere riconosciuto econsiderato rappresentativo da tutte le categorie professionalicoinvolte.
N
Norma tecnicaNel D.Lgs. 81/08 è definita come una specifica tecnica, appro-vata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un or-ganismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazio-ne, la cui osservanza non sia obbligatoria.
P
Peer reviewProcedura usata sia dalle riviste medico-scientifiche internazio-nali sia dagli enti erogatori di finanziamenti per valutare la qua-lità scientifica delle proposte ricevute.La peer review editoriale ha lo scopo di identificare le offerte dipubblicazione di buona qualità. Il metodo seguito dalle varie di-rezioni editoriali può essere differente, ma solitamente, dopo unavalutazione della coerenza formale e di contenuto del testo pro-posto, questo viene inviato a uno o più revisori esterni (referee).Gli esperti esaminano il lavoro ed esprimono un giudizio, for-mulato di solito secondo una griglia di valutazione definita dalladirezione editoriale alla quale il testo è destinato.Il sistema della peer review è oggetto di discussione all’internodella comunità scientifica internazionale, che ne mette in dubbiol’affidabilità e sottolinea il rischio di condizionamenti.Ciononostante, oggi non esistono alternative praticabili, anchese si sta diffondendo una nuova ipotesi che auspica un processo
392 G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4http://gimle.fsm.it
di peer review anticipato al momento del concepimento del di-segno dello studio sperimentale all’origine del lavoro scienti-fico. La direzione scientifica della rivista dovrebbe quindi va-lutare metodi e obiettivi della ricerca, interagendo in manieracostruttiva con gli autori sin dal momento dell’ideazione delprogetto.
ProvaIl termine indica qualsiasi dato o informazione, forte o debole,ottenuto attraverso l’esperienza, la ricerca osservazionale o il la-voro sperimentale (trial). Anche le prove derivate dalla ricercaclinica non hanno sempre lo stesso valore, dal momento che que-sto dipende in grande misura dalla metodologia utilizzata per lostudio, dal modo in cui è stato condotto, dalla coerenza con i ri-sultati di studi analoghi, dalla rilevanza e dalla trasferibilità nel-la pratica clinica. Negli ultimi anni diversi gruppi di studio hanno lavorato allosviluppo di sistemi capaci di graduare le prove di efficacia sul-la base della loro qualità, con l’obiettivo di stabilire una ge-rarchia in base alla quale definire le raccomandazioni clinicheaffidabili.Sebbene i risultati ai quali sono giunti i diversi gruppi sianospesso tra loro differenti, quasi sempre alla base della cosiddet-ta “piramide delle prove” si trovano le opinioni degli esperti, glistudi descrittivi di frequenza, i case report e i report di una se-rie di casi. Seguono gli studi non controllati, vale a dire quelliche, per esempio, valutano l’efficacia di una terapia senza con-frontarla con un altro trattamento somministrato a una popola-zione avente caratteristiche omogenee rispetto a quella trattata.A un livello di validità superiore si collocano gli studi clinicicontrollati non randomizzati: in questo caso, la terapia di cui sivuole verificare l’efficacia è assegnata a due o più gruppi di ma-lati in modo non casuale. Molto più attendibili sono gli studirandomizzati e controllati, che utilizzano gruppi di controllo eaffidano al caso l’assegnazione di un paziente alla terapia speri-mentale o meno.Le prove derivanti da studi originali sono raramente omogeneee gli operatori sanitari possono trovarsi di fronte a risultati con-traddittori. Per questo sono state sviluppate le metanalisi e le re-visioni sistematiche, che offrono sintesi ancora più affidabili erigorose.
Q
QualitàÈ l’insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodottoe/o di un servizio che gli conferiscono la capacità di soddisfare ibisogni espliciti e impliciti del fruitore. In sanità la qualità im-plica la valutazione dell’efficacia, dell’efficienza, della soddisfa-zione, dell’appropriatezza e di tutti gli altri aspetti rilevanti per ilpaziente.All’interno di un’organizzazione (sanitaria e non) le strategie disviluppo della qualità dovrebbero fondarsi sulle politiche istitu-zionali, sulla visione strategica interna, sulla struttura organizza-tiva (ruoli e responsabilità), sulle tecnologie, sulle persone che vilavorano (con competenze, attitudini, motivazioni, aspirazioni,impegno, eccetera), sulle risorse finanziarie. Più in dettaglio, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità(OMS), l’orientamento verso la qualità non dovrebbe prescinde-re da alcuni aspetti fondamentali:– l’adozione di politiche caratterizzate da obiettivi e piani di
azione chiari, in grado di armonizzare e soddisfare le aspet-tative dei diversi soggetti interessati;
– il diretto coinvolgimento di tutti gli stakeholders;
– il costo, in termini prettamente economici, che la realizza-zione e il mantenimento nel tempo di un qualsiasi standard diqualità comporta;
– il rapporto con la medicina basata sulle prove (EBM).Il sistema di indicatori che fornisce informazioni sulla qualità
dell’assistenza medica analizza la performance organizzati-va da diversi punti di vista:
– i processi sono analizzati alla luce di indicatori di accessibi-lità (per esempio i tempi di attesa per l’erogazione di presta-zioni specifiche), o di appropriatezza di determinati inter-venti;
– le risorse e le infrastrutture tecnologiche sono valutate attra-verso indicatori relativi alla disponibilità di tecnologie ade-guate;
– la percezione individuale si basa su indicatori che riportanola qualità percepita dal paziente e da tutti gli altri fruitori cheentrano in contatto con l’organizzazione sanitaria (per esem-pio i parenti del paziente);
– gli esiti/risultati sono valutati attraverso indicatori legati aglieventi avversi ricollegabili a determinate prestazioni o a ca-renze e malfunzionamenti del sistema.
Nelle situazioni concrete questi ambiti sono strettamente colle-gati e non facilmente scindibili. All’interno di un’organizzazionesanitaria si può parlare di valutazione e di miglioramento dellaqualità in modo pieno solo se questo processo ha una ricadutapositiva, visibile e misurabile sull’organizzazione interna e sulservizio offerto all’esterno (per esempio in termini di aumentodella soddisfazione dell’utente).
Qualità percepita Ambito fondamentale in cui si articola la qualità in sanità. Laqualità percepita (o relazionale) deriva dalla percezione dellasoddisfazione dei pazienti verso i servizi offerti dal sistema sani-tario. Le caratteristiche della qualità percepita sono legate a: – facilità di accesso alle prestazioni sanitarie; – tutela dei diritti; – comfort negli ospedali e negli ambulatori; – informazioni fornite sulla salute, sulle terapie e sui percorsi
assistenziali; – umanizzazione del rapporto con gli operatori sanitari; – assistenza in termini di appropriatezza ed efficacia clinica
delle cure ricevute. Solo di recente questi aspetti della qualità percepita sono stati ac-quisiti come parte essenziale della programmazione sanitaria atutti i livelli, grazie anche al riconoscimento della centralità delpaziente non solo come fruitore di servizi ma anche come attoredel sistema e come portatore di una propria identità e quindi dibisogni, esigenze, aspettative, eccetera. La diffusione di questanuova prospettiva ha contribuito all’affermazione del cosiddettoapproccio integrato tra management e cliente, cioè lo sviluppo diuna linea decisionale che non esclude il ruolo dell’utente finalema, al contrario, cerca di valorizzarlo. La qualità percepita si rileva attraverso metodi diretti (indaginisulla soddisfazione, reclami) o indiretti (comportamenti o indi-ci). Finora in Italia i principali strumenti organizzativi messi inatto dalle aziende private o dagli enti pubblici per monitorare emigliorare la qualità percepita dei servizi sono gli Uffici di Re-lazione con il Pubblico (URP), la carta dei servizi, le indagini disoddisfazione e gli uffici di qualità. In generale questi strumentiprendono in considerazione i diversi ambiti in cui si può manife-stare e quindi percepire la qualità: le caratteristiche strutturali(adeguatezza degli spazi, funzionalità delle attrezzature tecniche,dotazione e qualificazione del personale, eccetera), quelle orga-nizzative e di processo, gli aspetti più specificatamente relazio-nali (comunicazione medico-paziente, condivisione delle scelte,
G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4 393http://gimle.fsm.it
rispetto, empatia, eccetera) e quelli relativi allo stato di salute og-gettivo e percepito dal paziente stesso.Sul versante più strettamente relazionale l’innovazione più im-portante è forse rappresentata dalla possibilità di rendere la par-tecipazione del paziente non solo oggetto di valutazione, ma an-che risorsa aggiuntiva, un vero e proprio investimento nella qua-lità. Questa possibilità si realizza mediante lo strumento dell’au-dit civico che consiste in un’analisi critica e sistematica dell’at-tività delle aziende sanitarie promossa da organizzazioni esternecon la collaborazione delle stesse aziende. L’audit risponde al-l’esigenza di rendere trasparente e verificabile l’azione delle isti-tuzioni e di far sì che il confronto tra il cittadino e il fornitore diprestazioni sia strutturato in forme costruttive e utili per contri-buire al miglioramento della qualità dell’assistenza.
R
Referee (revisore)Persona incaricata di studiare i contenuti di un prodotto editoria-le e di esprimere una valutazione utile ai fini della decisione inmerito all’opportunità di pubblicarlo.
Revisione sistematicaStrumento adatto a riassumere in modo efficiente le informazio-ni su cui basare le decisioni cliniche. Ha l’obiettivo di fornire unquadro sintetico ma esauriente dello stato della ricerca su un in-tervento o su una strategia terapeutica, la valutazione dei metodiutilizzati negli studi primari e la misura dell’effetto di un tratta-mento in diversi contesti.Consente di valutare se siano disponibili prove sufficienti sul-l’efficacia di un intervento o se sia necessario condurre altri stu-di e quali aspetti debbano essere considerati. Le revisioni sistematiche si differenziano dalle tradizionali ras-segne della letteratura a carattere narrativo, che prevedono un’in-fluenza determinante dell’autore nella selezione degli studi, nel-la loro valutazione critica e nella sintesi dei risultati. Le revisio-ni sistematiche, al contrario, seguono protocolli standard i cuielementi fondamentali sono la completezza della ricerca deglistudi, la valutazione della qualità degli studi da includere e lapossibilità di sintetizzare quantitativamente i risultati attraversola metanalisi. L’uso di metodi espliciti e sistematici limita i biase riduce gli effetti casuali, fornendo risultati più affidabili daiquali è possibile trarre conclusioni e prendere decisioni.
RiproducibilitàCaratteristica dei risultati di un test o di una misura che si ri-scontra quando questi sono identici o fortemente simili ogni vol-ta che si esegue la misura.
S
Sistema nazionale per le linee guida (SNLG, ex PNLG)Programma nazionale coordinato dall’Istituto superiore di sanità(ISS) con il compito di:– produrre informazioni utili a guidare le decisioni degli ope-
ratori, clinici e non, verso una maggiore efficacia e appro-priatezza, oltre che verso una migliore efficienza nell’usodelle risorse;
– rendere queste informazioni facilmente accessibili;– favorire l’adozione delle raccomandazioni esaminando le
condizioni ottimali per la loro introduzione nella pratica;– valutare l’impatto delle raccomandazioni prodotte, in termi-
ni organizzativi e di risultato.
Gli strumenti utilizzati per perseguire questi fini sono le lineeguida clinico-organizzative, i documenti derivanti da consensusconference, le revisioni rapide di procedure e interventi, e i do-cumenti di implementazione e di valutazione dei servizi.Le linee guida sono lo strumento più indicato quando il temada trattare è vasto e può essere suddiviso in quesiti principalie secondari che non riguardano solo la dimensione clinica, maanche quella organizzativa e gestionale; inoltre sono utiliquando è necessario formulare raccomandazioni di comporta-mento relative alle diverse dimensioni del problema. Per pro-durre raccomandazioni attraverso una linea guida è necessariodisporre di una buona quantità di dati a favore o contro deter-minate scelte.La consensus conference è lo strumento indicato quando il te-ma da trattare è controverso, limitato e può essere suddiviso inpochi quesiti specifici. La controversia riguarda soprattutto ladimensione scientifica (di qualità delle prove). Questo stru-mento, inoltre, è utile quando è necessario formulare sia racco-mandazioni di comportamento clinico sia indirizzi per lo svi-luppo della ricerca.I criteri di appropriatezza clinica vengono considerati quando iltema da trattare richiede un approfondimento clinico molto spe-cifico e si vogliono produrre raccomandazioni dettagliate.Infine, il technology assessment è lo strumento da preferire quan-do il problema riguarda una tecnologia specifica di cui si devo-no valutare non solo degli aspetti clinici ma anche quelli orga-nizzativi, gestionali, economici e sociali.
StakeholderSoggetto o soggetti che hanno interessi nei confronti di una ini-ziativa, progetto o investimento. Con essi un’organizzazioneproduttrice di beni e/o servizi deve istituire rapporti e scambiarecomunicazioni.Per un’azienda sanitaria pubblica gli stakeholder sono i cittadini,i pazienti, i loro familiari, le associazioni di volontariato, i medi-ci, il governo nazionale e le istituzioni regionali, la direzioneaziendale, gli operatori, i fornitori. È comprensibile che glistakeholder possano sviluppare visioni diverse fra loro sul buonfunzionamento dell’organizzazione e differenziarsi anche dalleposizioni del vertice strategico e direzionale dell’azienda sanita-ria stessa.
Studio caso-controlloTipo di studio in cui vengono identificati i pazienti che presenta-no un disturbo o una condizione e viene confrontata la loro espo-sizione ai sospetti fattori di rischio con quella di soggetti che nonhanno il disturbo (controlli). Uno studio caso-controllo è utilequindi per identificare rischi e tendenze e suggerire alcune pos-sibili cause di malattia.I vantaggi di questo tipo di studi metodologia di studio sono larelativa rapidità di impostazione e di esecuzione, il costo conte-nuto e l’efficacia nell’applicazione allo studio di malattie rare odisturbi con un lungo intervallo tra l’esposizione e l’esito.Gli svantaggi consistono nella necessità di fare affidamento suidocumenti clinici per determinare l’esposizione, nella difficoltànella selezione dei gruppi di controllo e nella complessità del la-voro necessario per ridurre i bias.
Studio (trial) controllato randomizzatoDisegno di studio sperimentale nel quale il trattamento analizza-to è prescritto a una parte dei soggetti arruolati nell’indagine, se-lezionati casualmente (randomizzazione), secondo uno schemapredeterminato. Al gruppo di controllo dello studio viene pre-scritto un trattamento di cui si conosce l’effetto, oppure nessuntrattamento. Lo studio si definisce “in doppio cieco” quando né i
394 G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4http://gimle.fsm.it
partecipanti, né gli operatori che raccolgono i dati sanno se rice-vono o prescrivono il trattamento in studio o quello di controllo,fino al completamento della terapia prevista.Per questo motivo gli studi controllati randomizzati sono consi-derati al vertice della cosiddetta “gerarchia delle prove di effica-cia”, al di sotto solo delle revisioni sistematiche.
Studio di coorteStudio in cui vengono identificati e seguiti nel tempo pazientiesposti e non a fattori o interventi specifici per vedere se svilup-pano un esito previsto, consentendo così un confronto del rischio.I vantaggi di questa metodologia sono il costo contenuto, unmaggiore rigore rispetto agli studi caso-controllo nella scelta deicampioni da inserire negli studi e considerare nei risultati,la pos-sibilità di definire la distribuzione temporale e la sequenza deglieventi e la sicurezza dal punto di vista etico. Gli svantaggi inve-ce riguardano l’impossibilità di escludere fattori di confondi-mento sconosciuti, la difficoltà nel realizzare uno studio in ciecoe la criticità nell’identificazione di un gruppo di controllo ben as-sortito.
Studio di serie di casiDescrizione e analisi dettagliata di una serie di casi che spieganola dinamica, la patologia, la gestione e/o l’esito di una determi-nata malattia. In termini epidemiologici si riferisce allo studio didiversi individui
V
Valutazione dei costi economici degli interventi in sanità-pre-venzioneAnalisi in cui si rilevano tutti i costi interni a un’organizzazio-ne pubblica o privata, indipendentemente dal soggetto che lisopporta (pazienti, familiari, servizi sociali, datori di lavoro,eccetera). Alcuni metodi di valutazione dei costi economici degli interven-ti sono:– l’analisi di minimizzazione dei costi (cost-minimization
analysis), metodo nel quale si confrontano due o più tratta-menti per accertare quale abbia i costi più contenuti. Il me-todo può essere applicato solo se si presuppone che i tratta-menti in esame abbiano la stessa efficacia, una condizioneche si verifica molto raramente: spesso, infatti, anche in pre-senza di esiti clinici identici può essere diversa la qualità divita dei pazienti. Questo tipo di analisi viene ancora usata perle scelte gestionali in cui si valuta quali attività convengamantenere all’interno dell’organizzazione e quali invece af-fidare all’esterno;
– l’analisi costo-efficacia (cost-effectiveness analysis), metodoche mette a confronto i costi dei trattamenti e i loro esiti,espressi in termini reali (o termini fisici): anni di vita guada-gnati, casi di malattia evitati, casi di malattia diagnosticaticon accuratezza, eccetera.
BibliografiaBandolier. Glossary: http://www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/glossary.htmlGarcía AM, Checkoway H. A glossary for research in occupational
health. J Epidemiol Community Health 2003; 57(1): 7-10.Mindell J, Ison E, Joffe M. A glossary for health impact assessment. J
Epidemiol Community Health 2003; 57(9): 647-51.Oxford Centre for Evidence Based Medicine (CEBM). Glossary of EBM
terms: http://www.cebm.utoronto.ca/glossaryRychetnik L, Hawe P, Waters E, et al. A glossary for evidence based pu-
blic health. J Epidemiol Community Health 2004; 58(7): 538-45.
Appendice 2. Documenti pubblicati dalla SIMLII
Linee guida
Merluzzi F (coordinatore), Bartolucci GB, Bosio D, Di Credico N,Marazzi P, Marello G, Orsini S, Pira A, Pira E, Romano C, Sala E,Solero P, Sonnino A.Linee guida per la prevenzione dei danni uditivi da rumorein ambiente di lavoro.In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Ambrosi L (eds).Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento delmedico del lavoro, volume 1, Tipografia Pime Editrice, Pavia,2003.
Pira E (coordinatore), Detragiache E, Discalzi G, Mutti A, Ghigo D,Iavicoli S, Apostoli P.Linee guida per la sorveglianza sanitaria degli esposti adagenti cancerogeni e mutageni in ambiente di lavoro.In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Ambrosi L (eds).Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento delmedico del lavoro, volume 2, Tipografia Pime Editrice, Pavia,2003.
Romano C (coordinatore), Piccoli B, Bergamaschi A, Di Bari A,Gullino A, Iacovone T, Muzi G, Troiano P, Apostoli P.Linee guida per la sorveglianza sanitaria degli addetti adattività lavorativa con videoterminali.In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Ambrosi L (eds).Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento delmedico del lavoro, volume 3, Tipografia Pime Editrice, Pavia,2003.
Apostoli P (coordinatore), Bovenzi M, Occhipinti E, Romano C,Violante F, Cortesi I, Baracco A, Draicchio F, Mattioli S.Linee guida per la prevenzione dei disturbi e delle patologiemuscolo scheletriche dell’arto superiore correlati con illavoro (Upper Extremity Work-related MusculoskeletalDisorders - UE WMSDs).In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Ambrosi L (eds).Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento delmedico del lavoro, volume 4, Tipografia Pime Editrice, Pavia,2003.
Bovenzi M (coordinatore), Angotzi G, Apostoli P, Negro C,Versini W.Linee guida per la prevenzione dei disturbi e delle patologieda esposizione a vibrazioni meccaniche negli ambienti dilavoro.In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Ambrosi L (eds).Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento delmedico del lavoro, volume 5, Tipografia Pime Editrice, Pavia,2003.
De Rosa E (coordinatore), Bartolucci GB, Cottica D, Imbriani M,Malavolti DO, Mutti A, Perbellini L.Linee guida per la sorveglianza sanitaria degli esposti asolventi organici - Stirene.In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Ambrosi L (eds).Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento delmedico del lavoro, volume 6, Tipografia Pime Editrice, Pavia,2003.
G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4 395http://gimle.fsm.it
Ottenga F (coordinatore), Giovanazzi A, L’Abbate N, Righi E,Terrana T, Trenta G.Linee guida per la sorveglianza sanitaria degli esposti aradiazioni non ionizzanti.In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Ambrosi L (eds).Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento delmedico del lavoro, volume 7, Tipografia Pime Editrice, Pavia,2003.
Messineo A, Iacovone T (coordinatori), Bergamaschi A,Candura U, Costa G, Iavicoli S, Persechino B, Soleo L.Linee guida per la sorveglianza sanitaria degli addetti alavori atipici e a lavori a turni.In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Ambrosi L (eds).Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento delmedico del lavoro, volume 8, Tipografia Pime Editrice, Pavia,2004.
Bartolucci GB (coordinatore), Bovenzi M, Cassano F, Cortesi I,Cottica D, Giachino GM, Manno M, Mutti A, Nano G, Pira E,Scapellato ML, Selis L, Soleo L, Apostoli P.Linee guida per la valutazione del rischio.In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Ambrosi L (eds).Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento delmedico del lavoro, volume 9, Tipografia Pime Editrice, Pavia,2004.
Colombini D (coordinatore), Occhipinti E, Cairoli S, Menoni O,Ricci MG, Battevi N, Violante F, Mattioli S, Draicchio F.Linee guida per la prevenzione dei disturbi e delle patologiemuscolo-scheletriche del rachide da movimentazionemanuale di carichi.In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Ambrosi L (eds).Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento delmedico del lavoro, volume 10, Tipografia Pime Editrice, Pavia,2004.
Soleo L (coordinatore), Romano C, Abbritti G, Bartolucci GB,Basso A, Bergamaschi A, Bertazzi PA, Bianco P, Bovenzi M,Coggiola M, Cortesi I, Cristaudo A, Gelormini A, Giachino GM,Gigante MR, Iacovone MT, Imbriani M, Magrini A, Mosconi G,Murgia N, Mutti A, Negro C, Pira E, Riboldi L, Saia B, Apostoli P.Linee guida per la sorveglianza sanitaria.In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Ambrosi L (eds).Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento delmedico del lavoro, volume 11, Tipografia Pime Editrice, Pavia,2004.
Saia B (coordinatore), Carosso A, Marcer G, Moscato G,Romano C.Linee guida per la sorveglianza sanitaria degli esposti arischio da sensibilizzazione correlato all’esposizionelavorativa.In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Ambrosi L (eds).Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento delmedico del lavoro, volume 12, Tipografia Pime Editrice, Pavia,2004.
Sartorelli P (coordinatore), Angelini G, Ayala F, Bonamonte D,Crippa M, Fenga C, Flori L, Larese Filon F, Leghissa P, Lisi P,Papale A, Romano C, Valsecchi R.Linee guida per la prevenzione delle dermatiti da contattoprofessionali.In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Ambrosi L (eds).Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento delmedico del lavoro, volume 13, Tipografia Pime Editrice, Pavia,2005.
Apostoli P (coordinatore), Abbritti G, Alessio L, Bartolucci GB,Carta P, Foà V, Mutti A, Muzi G, Sannolo N, Soleo L, Trevisan A.Linee guida per la sorveglianza sanitaria degli esposti a: 1 - elementi metallici.Apostoli P (coordinatore), Abbritti G, Alessio L, Carta P, Flore C,Foà V, Sala E, Sannolo N, Soleo L, Muzi G, Mutti A.Linee guida per la sorveglianza sanitaria degli esposti a: 2 - piombo inorganico.In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Ambrosi L (eds).Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento delmedico del lavoro, volume 14, Tipografia Pime Editrice, Pavia,2005.
Maroni M (coordinatore), Aprea MC, Catenacci G, Colosio C,De Pasquale G, Moretto A, Musti M, Ronchin M, Tiramani M,Tommasini M.Linee guida per la sorveglianza sanitaria dell’esposizioneprofessionale a prodotti fitosanitari.In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Ambrosi L (eds).Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento delmedico del lavoro, volume 15, Tipografia Pime Editrice, Pavia,2005.
Trevisan A (coordinatore), Borella Venturini M, Di Marco L,Bartolucci GB, Bergamaschi E, Franchini I, Mutti A.Linee guida per la sorveglianza sanitaria degli esposti a: 1 - cadmio e suoi composti.Mutti A (coordinatore), Bergamaschi E, Cirla P, De Flora S, Foà V,Franchini I, Apostoli P.Linee guida per la sorveglianza sanitaria degli esposti a: 2 - cromo e suoi composti.Soleo L (coordinatore), Russo A, Elia G, Foà V.Linee guida per la sorveglianza sanitaria degli esposti a: 3 - mercurio inorganico.Apostoli P (coordinatore), Foà V, Mangili A, Di Scalzi G,Valsania MC, Mutti A, Pira E.Linee guida per la sorveglianza sanitaria degli esposti a: 4 - nichel e suoi composti.In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Ambrosi L (eds).Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento delmedico del lavoro, volume 16, Tipografia Pime Editrice, Pavia,2005.
Alessio L (coordinatore), Porru S, Aparo UL, Bassetti D,Beltrame A, Buzzi F, Cipolloni L, Germano T, Lombardi R,Longo F, Palmi S, Papaleo B, Patacchia L, Persechino B, Placidi D,Polato R, Puro V, Saia B, Signorini S, Sossai D, Verani P,Vonesch N, Zanetti C.Linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori dellasanità esposti a rischio biologico.In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Ambrosi L (eds).Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento delmedico del lavoro, volume 17, Tipografia Pime Editrice, Pavia,2005.
Mutti A (coordinatore), De Palma G, Manini P, Baccarelli A,Bartolucci GB, Carta P, Dell’Omo M, Foà V, Ghittori S, Iavicoli S,Imbriani M, Manno M, Perbellini L, Pira E, Apostoli P.Linee guida per il monitoraggio biologico.In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Ambrosi L (eds).Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento delmedico del lavoro, volume 18, Tipografia Pime Editrice, Pavia,2006.
396 G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4http://gimle.fsm.it
Bianco P (coordinatore), Anzelmo V, Abbate C, Bergamaschi A,Biggi N, Bovenzi M, Giorgianni M, Lacca G, Lasorsa G,Magrini A, Messineo A, Ossicini A, Porru S, Soleo L, Tomei F,Apostoli P, Castellino N.Linee guida: 1 - per il primo soccorso nei luoghi di lavoro(art. 15 D.Lgs. 626/94).Bianco P (coordinatore), Anzelmo V, Castellino N.Linee guida: 2 - per le vaccinazioni negli ambienti di lavoro.In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Ambrosi L (eds).Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento delmedico del lavoro, volume 19, Tipografia Pime Editrice, Pavia,2006.
Bergamaschi A (coordinatore), Bagnara S, Bolchin R, CiardielloL, Cunego A, Gallo V, Leocata G, Livigni L, Magnavita G,Magnavita N, Magrini A, Mennoia NV, Messori C, Piccoli B,Sed B, Sclip G, Stefanovichj S.Disabilità e lavoro.In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Ambrosi L (eds).Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento delmedico del lavoro, volume 20, Tipografia Pime Editrice, Pavia,2006.
Mosconi G (coordinatore), Assennato G, Battevi N, Carino M,Coato F, Consonni D, Cottica D, Cristaudo A, Di Camillo G,Giachino GM, Leocata G, Macchia C, Manfredini F, Nano G,Negro C, Peretti A, Prandi E, Ramenghi D, Riva MM, Rivolta G,Scarno G, Scopacasa L. Linee guida per la valutazione del rischio e la sorveglianzasanitaria in edilizia. In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Ambrosi L (Eds).Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento delmedico del lavoro, volume 22, Tipografia Pime Editrice, Pavia,2008.
Violante FS (coordinatore), Bonfiglioli R, Mattioli S,Baldasseroni A, Baratti A, Bazzini G, Calabrese M, Carta A,Draicchio F, Graziosi F, Liotti F, Merseburger A, Maso S, Negro C,Porru S, Zanardi F, Apostoli P. Linee guida per la prevenzione delle patologie correlate allamovimentazione manuale dei pazienti.In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Ambrosi L (eds).Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento delmedico del lavoro, volume 23, Tipografia Pime Editrice, Pavia,2008.
Tomei F (coordinatore), Amicarelli V, Anzelmo V, Baccolo TP,Boccalon P, Capellaro E, Caciari T, Capozzella A, Colombi A,Fenga C, Giubilati R, Grignani E, Grimaldi F, Miccio A,Ossicini A, Ottenga F, Panfili A, Piccoli B, Rosati MV, Tomao E,Verso MG. Agenti biologici in ambienti di lavoro non sanitari. In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Ambrosi L (eds).Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento delmedico del lavoro, volume 24, Tipografia Pime Editrice, Pavia,2008.
Linee guida - Aggiornamenti
Apostoli P (coordinatore), Bovenzi M, Occhipinti E, Romano C,Violante F, Cortesi I, Baracco A, Draicchio F, Mattioli S.Linee guida per la prevenzione dei disturbi e delle patologiemuscolo scheletriche dell’arto superiore correlati con illavoro (Upper Extremity Work-related MusculoskeletalDisorders - UE WMSDs).In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Ambrosi L (eds).Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento delmedico del lavoro, volume 4 (prima revisione); G It Med LavErgon 2006; allegato vol. XXVIII (n.3).
Bovenzi M (coordinatore), Angotzi G, Apostoli P, Negro C,Versini W.Linee guida per la prevenzione dei disturbi e delle patologieda esposizione a vibrazioni meccaniche negli ambienti dilavoro.In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Ambrosi L (eds).Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento delmedico del lavoro, volume 5 (prima revisione); G It Med LavErgon 2007; allegato vol. XXIX (n.2).
Pira E (coordinatore), Detragiache E, Discalzi G, Mutti A, GhigoD, Iavicoli S, Apostoli P.Linee guida per la sorveglianza sanitaria degli esposti adagenti cancerogeni e mutageni in ambiente di lavoro.In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Ambrosi L (eds).Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento delmedico del lavoro, volume 2 (prima revisione); G It Med LavErgon 2007; allegato vol. XXIX (n.3).
Linee guida - Riedizioni
Merluzzi F (coordinatore), Bartolucci GB, Bosio D, Di CredicoN, Marazzi P, Marello G, Orsini S, Peretti A, Pira A, Pira E,Romano C, Sala E, Solero P, Sonnino A.Linee guida per la prevenzione dei danni uditivi da rumorein ambiente di lavoro.In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Ambrosi L (eds).Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento delmedico del lavoro, volume 1 - Seconda edizione - TipografiaPime Editrice, Pavia, 2008.
Documenti di consenso
Cesana G (coordinatore), Albini E, Bagnara S, Benedetti L,Bergamaschi A, Camerino D, Cassitto MG, Costa G, Ferrario M,Gilioli R, Iavicoli S, Livigni L, Lucchini R, Magrin ME, Menni C,Monaco E, Persechino B, Petyx M, Riboldi L, Romano C, Sed B.Valutazione, prevenzione e correzione degli effetti nocividello stress da lavoro.In: Apostoli P, Imbriani M, Soleo L, Abbritti G, Ambrosi L (eds).Linee guida per la formazione continua e l’accreditamento delmedico del lavoro, volume 21, Tipografia Pime Editrice, Pavia,2006.
G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4 397http://gimle.fsm.it
Appendice 3 - Modulo per la valutazione secondo il metodo AGREE
ISTRUZIONIOBIETTIVO E MOTIVAZIONE DELLA LINEA GUIDA
1. Questo item riguarda il potenziale impatto sanitario di una linea guida sulla società o sulla popolazione di lavoratori diriferimento. L’obiettivo generale della linea guida dovrebbe essere descritto in dettaglio e i benefici attesi dovrebbero esserequelli relativi al problema considerato. Esempi di descrizioni degli obiettivi sufficientemente specifiche potrebbero essere:– partecipazione del medico del lavoro alla riduzione dei rischi considerati;– prevenzione delle principali patologie relative ai rischi del comparto interessato;– predisposizione di azioni preventive e valutazione in termini di costo-efficacia.
2. Dovrebbe essere fornita una dettagliata descrizione dei quesiti affrontati nella linea guida, in particolare per le raccomandazionipiù importanti (vedi item 15). Facendo riferimento agli esempi riportati relativamente al primo item:– quali attività del medico del lavoro si ritengono indispensabili per collaborare alla riduzione dei rischi considerati?– quali esami sono raccomandati per una valutazione sufficientemente accurata e appropriata dei possibili danni presenti nel
comparto?– l’utilizzo di esami ematici di routine è giustificato rispetto ai loro costi, ai risultati attesi– e alle indicazioni che questi possono fornire al medico del lavoro?
3. Dovrebbe essere fornita una chiara descrizione dei lavoratori potenzialmente implicati nelle indicazioni e nelle azioni che laLG propone. Se del caso dovrebbero essere indicati l’età di riferimento, il sesso, i rischi e le possibili patologie professionali.Per esempio:– una linea guida sulla gestione dei lavoratori esposti ai rischi della movimentazione manuale dei carichi pesanti che non
coinvolga altri rischi ergonomici (movimenti ripetuti arti superiori, posture incongrue ecc.);– una linea guida sulla gestione dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti che focalizzi le indicazioni sui soggetti esposti
a basse dosi (es. Lavoratori in Cat. B)
LINEA GUIDA SIMLII:
Barrare una casella
OBIETTIVO E MOTIVAZIONE DELLA LINEA GUIDA
1. L’obiettivo(i) generale della linea guida Commentiè (sono) descritto in modo specifico
completo completoaccordo disaccordo
2. La problematica/quesito trattata dalla linea guida Commentiè (sono) descritto in modo specifico
completo completoaccordo disaccordo
3. La tipologia dei lavoratori/ comparto/ rischi/patologia Commentia cui si riferisce la LG è descrittain modo specifico
completo completoaccordo disaccordo
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
398 G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4http://gimle.fsm.it
COINVOLGIMENTO DELLE PARTI IN CAUSA
4. Il gruppo che ha elaborato la linea guida include rappresentanti Commentidi tutte le componenti professionali rilevanti
completo completoaccordo disaccordo
5. Il punto di vista dei lavoratori (e/o altri stakeholders) e le loro Commentipreferenze sono state prese in considerazione
completo completoaccordo disaccordo
6. Gli utilizzatori finali della linea guida sono identificati Commenticon chiarezza
completo completoaccordo disaccordo
7. La linea-guida è stata provata dai potenziali utilizzatori finali Commenti
completo completoaccordo disaccordo
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
ISTRUZIONICOINVOLGIMENTO DELLE PARTI IN CAUSA
4. Questo item si riferisce alla descrizione di quali professionalità sono state coinvolte nella fase di elaborazione della linea guida.Tale elenco dovrebbe comprendere sia membri di un eventuale comitato direttivo, sia membri del gruppo di ricerca responsabilidella selezione, revisione e valutazione delle evidenze, sia le persone coinvolte nella formulazione delle raccomandazioni finali.Questo item non comprende gli individui che hanno partecipato alla fase di revisione esterna della linea guida (vedi item 11).Dovrebbero essere fornite informazioni riguardanti la composizione del gruppo di lavoro, definendone la disciplina di interessee l’esperienza professionale.
5. L’elaborazione della linea guida, quando può avere ripercussioni sociali di forte portata, potrebbe tenere in considerazione ipunti di vista dei lavoratori (e/o altri stakeholders). In particolari casi rappresentanti di queste categorie possono essere ancheinclusi nel gruppo che produce la linea guida, più spesso si possono ottenere i loro punti di vista successivamente alla stesuradi una bozza del documento. Dovrebbe essere documentato che questo aspetto, se ritenuto importante, è stato considerato.
6. Gli utilizzatori finali della linea guida dovrebbero essere definiti con chiarezza, così che possano capire immediatamente se lalinea guida è per loro rilevante. Per esempio, gli utilizzatori finali di una linea guida sulla valutazione del rischio stress lavorocorrelato possono essere i medici competenti, medici dei servizi pubblici di prevenzione, medici dell’Inail, dei patronati ecc.
7. Una linea guida dovrebbe essere pre-testata per un’ulteriore validazione tra i suoi utilizzatori finali prima di essere pubblicata.Per esempio, una linea guida potrebbe essere provata in uno o più ambiti territoriali. Questa fase pilota dovrebbe esseredescritta.
G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4 399http://gimle.fsm.it
RIGORE DELLA ELABORAZIONE
8. Sono stati utilizzati metodi sistematici per identificare Commentile informazioni scientifiche
completo completoaccordo disaccordo
9. I criteri utilizzati per selezionare le informazioni scientifiche Commentisono stati descritti con chiarezza
completo completoaccordo disaccordo
10. I metodi utilizzati per la formulazione delle raccomandazioni Commentisono descritti con chiarezza
completo completoaccordo disaccordo
11. Nella formulazione delle raccomandazioni sono stati presi Commentiin considerazione benefici, effetti collaterali e rischi derivanti dall’applicazione delle stesse
completo completoaccordo disaccordo
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
ISTRUZIONIRIGORE DELLA ELABORAZIONE
8. Dovrebbero essere riportati dettagli della strategia di ricerca impiegata per identificare le informazioni scientifiche, compresele parole chiave utilizzate, le fonti consultate e l’arco di tempo considerato. Le fonti possono comprendere banchedatielettroniche (es. MEDLINE, EMBASE, CINAHL), archivi di revisioni sistematiche (es. Cochrane Library, DARE), ricercamanuale su riviste scientifiche, atti congressuali e altre linee guida
9. Dovrebbero essere espressamente riportati i criteri utilizzati per includere/escludere le diverse tipologie di informazioniscientifiche. Questi criteri andrebbero descritti in modo esplicito e le ragioni di inclusione/esclusione devono essere dichiaratein modo chiaro. Per esempio, gli autori della linea guida possono decidere di includere soltanto le evidenze derivanti da studipubblicati su riviste indicizzate e di escludere articoli presenti su Atti di Convegni e non sottoposti a reviewer.
10. Dovrebbero essere descritti i metodi utilizzati per formulare le raccomandazioni e le modalità con le quali si è pervenuti alledecisioni finali. Esempi di possibili metodi includono la votazione o tecniche di formale identificazione del consenso (peresempio le tecniche Delfi e Glaser). Deve essere esplicitata la presenza di eventuali aree di disaccordo e i metodi utilizzati peraffrontarle.
11. La linea guida deve considerare i benefici, gli effetti collaterali, sanitari e sociali, e i rischi implicati dalle raccomandazioni. Peresempio può includere una discussione sugli effetti derivanti dai giudizi di idoneità proposti. Tra questi si possono annoverare:tutela dei lavoratori, incidenza di patologie professionali, rispondenza a norme specifiche, legami con riconoscimentiassicurativi.
(segue)
400 G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4http://gimle.fsm.it
12. Esiste un legame preciso tra le raccomandazioni Commentie le evidenze che le supportano
completo completoaccordo disaccordo
13. Prima di essere pubblicata, la linea guida è stata valutata Commentida esperti esterni al gruppo che l’ha prodotta
completo completoaccordo disaccordo
14. È descritta la procedura per l’aggiornamento della linea guida Commenti
completo completoaccordo disaccordo
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
ISTRUZIONI
12. Deve esserci un legame esplicito tra le raccomandazioni e le informazioni scientifiche su cui si basano. Ogni raccomandazionedeve essere supportata da referenze bibliografiche.
13. Una linea guida dovrebbe essere valutata da parte di esperti esterni prima di essere pubblicata. I revisori esterni non devonoessere stati coinvolti nell’elaborazione della linea guida e dovrebbero comprendere sia professionisti appartenenti all’areaclinica in oggetto, sia metodologi. Dovrebbe essere indicata la metodologia utilizzata per la conduzione della revisione esterna,includendo l’elenco dei revisori e la loro affiliazione.
14. Le linee guida devono rispecchiare le conoscenze scientifiche di volta in volta disponibili. Deve esserci una chiara descrizionedella procedura per l’aggiornamento della linea guida. Per esempio, si può stabilire una scadenza temporale definita, oppureprevedere che vi sia un gruppo di esperti incaricato di esaminare i risultati di periodiche ricerche bibliografiche, valutandol’opportunità di introdurre cambiamenti.
(segue)
RIGORE DELLA ELABORAZIONE
G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4 401http://gimle.fsm.it
CHIAREZZA E PRESENTAZIONE
15. Le raccomandazioni sono precise e non ambigue Commenti
completo completoaccordo disaccordo
16. Vengono presentate con chiarezza le possibili alternative Commentiper la gestione del problema considerato
completo completoaccordo disaccordo
17. Le raccomandazioni principali sono facilmente identificabili Commenti
completo completoaccordo disaccordo
18. La linea guida è supportata da strumenti per la sua Commentiimplementazione
completo completoaccordo disaccordo
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
ISTRUZIONICHIAREZZA E PRESENTAZIONE
15. Una raccomandazione dovrebbe fornire una descrizione concreta e specifica di quale modalità di assistenza sia appropriata peruna determinata circostanza clinica e tipologia di pazienti, per quanto reso possibile dalle evidenze scientifiche disponibili.– Un esempio di raccomandazione specifica è: deve essere valutato lo studio potenziali evocati del tronco encefalico nei
soggetti adulti non cooperanti qualora il tracciato, ripetuto 3 volte, non mostri concordanza dei risultati.– Un esempio di raccomandazione vaga è invece: deve essere valutato lo studio potenziali evocati del tronco encefalico nei
soggetti adulti non cooperanti.Tuttavia le evidenze scientifiche non sono sempre precise e ci può essere quindi incertezza in relazione a quale sia la modalitàdi assistenza più appropriata. In questi casi tale incertezza dovrebbe essere esplicitata nella raccomandazione.
16. Una linea guida deve prendere in considerazione le alternative possibili per la gestione della condizione in oggetto, sia che sitratti di valutazione di rischi, di prevenzione o di diagnosi. Queste possibili opzioni dovrebbero essere presentate con chiarezzanella linea guida. Per esempio, una raccomandazione per la diagnosi di asma bronchiale professionale dovrebbe considerare leseguenti alternative:
– test arresto-ripresa positivo con sensibilizzazione allergica dimostrata;– test di esposizione in cabina positivo con sostanza nota;– combinazione di positività al test arresto-ripresa e al test di esposizione in cabina.
17. Gli utilizzatori della linea guida devono poter identificare facilmente le raccomandazioni più rilevanti. Queste raccomandazionisono le risposte ai principali quesiti trattati dalla linea guida. Possono essere evidenziate in modi diversi: per esempio possonoessere riassunte in un riquadro, scritte in grassetto, sottolineate oppure presentate come diagrammi di flusso o algoritmi.
18. Una linea guida per essere efficace deve essere disseminata e implementata con specifici strumenti. Questi ultimi possonoincludere: un documento riassuntivo, un manuale di riferimento, strumenti educativi di supporto, opuscoli per medico, per ilavoratori o per le aziende, supporti informatici; questi mezzi dovrebbero accompagnare la linea guida.
402 G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4http://gimle.fsm.it
APPLICABILITÀ
19. Sono stati considerati i possibili ostacoli organizzativi Commentiall’applicazione delle raccomandazioni
completo completoaccordo disaccordo
20. Sono state prese in considerazione le potenziali Commentiimplicazioni in termini di costo derivanti dall’applicazione delle raccomandazioni
completo completoaccordo disaccordo
21. La linea guida presenta i principali criteri Commentiper il monitoraggio e l’audit clinico
completo completoaccordo disaccordo
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
ISTRUZIONIAPPLICABILITÀ
19. L’applicazione delle raccomandazioni può richiedere risorse che possono rappresentare un ostacolo all’uso dellaraccomandazione nella pratica quotidiana. I cambiamenti nell’organizzazione necessari per applicare le raccomandazionidovrebbero essere presi in considerazione. Per esempio:– una linea guida sul rischio ad un agente chimico può raccomandare l’esecuzione di particolari esami tossicologici non
ancora disponibili a livello di routine nel territorio.Può essere necessario indicare centri specialistici in grado di svolgere tali esami.
20. Le raccomandazioni possono richiedere risorse addizionali per poter essere applicate. Per esempio, potrebbe esserci la necessitàdi avere una équipe specializzata, nuovi strumenti o indagini costose. Questi aspetti possono avere delle implicazioni in terminidi costi.
21. Essere in grado di valutare il grado di adesione a una linea guida ne favorisce l’implementazione. Questo richiede di definirecon chiarezza i criteri di verifica che derivano dalle raccomandazioni principali. Questi ultimi devono essere presentati. Esempidi criteri sono:– l’indice di benessere termico PVM deve essere compreso fra –1 e +1;– il livello di HbCO non deve superare il 3,5%.
G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4 403http://gimle.fsm.it
INDIPENDENZA EDITORIALE
22. La redazione della linea guida è indipendente Commentida fonti di supporto economico
completo completoaccordo disaccordo
23. Sono stati segnalati possibili conflitti di interesse di coloro Commentiche hanno partecipato all’elaborazione della linea guida
completo completoaccordo disaccordo
4 3 2 1
4 3 2 1
ISTRUZIONIINDIPENDENZA EDITORIALE
22. Alcune linee guida possono essere state prodotte grazie a finanziamenti esterni (per esempio fondi governativi, fondazioni diricerca, case farmaceutiche). Questo genere di supporto può riguardare l’intero progetto o solo alcuni aspetti di esso (es. lastampa della linea guida). Dovrebbe essere dichiarato esplicitamente che le opinioni e gli interessi materiali del finanziatorenon hanno influenzato il contenuto delle raccomandazioni finali.Attenzione. Se è riportato che la linea guida non ha ricevuto alcun finanziamento esterno dovrete indicare “completoaccordo”.
23. Ci sono circostanze in cui i componenti del gruppo che ha elaborato la linea guida possono trovarsi in una posizione di conflittodi interesse. Per esempio, nel caso di un componente del gruppo il cui lavoro di ricerca sull’argomento affrontato nella lineaguida sia finanziato da una casa farmaceutica. Deve esserci una esplicita indicazione che tutti i membri del gruppo di lavorohanno dichiarato se si trovavano o meno in una posizione di conflitto di interesse.
404 G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4http://gimle.fsm.it
COMMENTI ULTERIORI
GIUDIZIO COMPLESSIVO
Raccomanderebbe l’utilizzo di questa linea guida nella pratica del medico del lavoro?
Sì, fortemente raccomandata
Sì, raccomandata (con riserva)
Non raccomandata
Non so
G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4 405http://gimle.fsm.it
Punteggio area specifica:
OBIETTIVO E MOTIVAZIONE DELLA LINEA GUIDA =
COINVOLGIMENTO DELLE PARTI IN CAUSA =
RIGORE DELLA ELABORAZIONE =
CHIAREZZA E PRESENTAZIONE =
APPLICABILITÀ =
INDIPENDENZA EDITORIALE =
ISTRUZIONI
Punteggi per singola areaPossono essere calcolati dei punteggi (score) per ogni singola area, sommando quelli dei singoli item che la compongono estandardizzando il totale come percentuale del punteggio massimo possibile per quell’area.
EsempioSe quattro valutatori danno i seguenti punteggi per gli item dell’area 1 (Obiettivo e motivazione della linea guida)
Item 1 Item 2 Item 3 TotaleValutatore 1 2 3 3 8Valutatore 2 3 3 4 10Valutatore 3 2 4 3 9Valutatore 4 2 3 4 9Totale 9 13 14 36
Punteggio massimo possibile = 4 (completo accordo) x 3 (item) x 4 (valutatori) = 48Punteggio minimo possibile = 1 (completo disaccordo) x 3 (item) x 4 (valutatori) = 12
Il punteggio area-specifico standardizzato è:
punteggio ottenuto - minimo punteggio possibile 36 – 12 24–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = ––––––– = –––– = 0.67 x 100 = 67%massimo punteggio possibile - minimo punteggio possibile 48 – 12 36
NotaLe sei dimensioni sono tra loro indipendenti e i relativi punteggi non dovrebbero essere aggregati in un unico score complessivo diqualità. Anche se i punteggi area-specifici possono essere utili per confrontare tra loro linee guida e possono guidare nel decidere seadottare o meno una linea guida, non è possibile identificare un valore soglia di punteggio che discrimini le “buone” dalle “cattive”linee guida.
VALUTAZIONE A CURA DI:
DATA
406 G Ital Med Lav Erg 2009; 31:4http://gimle.fsm.it
Altri riferimenti bibliografici di interesse
American Society of Clinical Oncology. American Society of ClinicalOncology clinical practice guidelines for the use of chemotherapyand radiotherapy protectants. J Clin Oncol 1999; 17: 3333-55.
Apolone G, Banfi F. Proposta di un modello e di una tassonomia utili avalutare le LG. Ricerca e pratica 1999; 15: 116-24.
Barnes DE, Bero LA. Why review articles on the health effects ofpassive smoking reach different conclusions. JAMA 1998; 279:1566-70.
Basinski ASK. Evaluation of clinical practice guidelines. CMAJ 1995;1575-81.
Beauchamps TL, Childress JF. Principles of biomedical ethics. OxfordUniversity Press, New York,1994.
Brook R, Chassin M, Fink A, et al. A method for the detailed assessmentof the appropriateness of medical technologies. Int J Technol AssHealth Care 1987; 2(1): 53-63.
Cook DJ, Guyatt GH, Laupacis A, et al. Clinical recommendations usinglevels of evidence for antithrombotic agents. Chest 1995; 108(suppl.4): 227-30.
Drummond MF, Jefferson TO. Guidelines for authors and peer reviewersof economic submissions to the BMJ. BMJ 1996; 313: 275-83.
Feder G, Eccles M, Grol R, et al. Using clinical guidelines. BMJ 1999;318: 728-30.
Fink A, Kosecoff J, Chassin M, Brook RH. Consensus methods:characteristics and guidelines for use. Am J Public Health 1984;74(9): 979-83.
Guyatt GH, Sackett DL, Sinclair JC, et al. User’s guides to the medicalliterature. IX: A method for grading health care recommendations.JAMA 1995; 274: 1800-4.
Huston P, Moher D. Redundancy, disaggregation, and the integrity ofmedical research. Lancet 1996; 347: 1024-6.
Liberati A, Sheldon TA, Banta HD. EUR-ASSESS Project subgroupreport on methodology. Methodological guidance for the conduct ofhealth technology assessment. Int J Technol Assess Health Care1997; 13: 186-219.
Oxford Centre for Evidence Based Medicine (CEBM). Levels ofevidence. http://www.cebm.net/index.aspx?o=1025
Penna A, Barazzoni F. Il progetto TRiPSS. Effective Health Care(edizione italiana) 1998; 2(1).
Portigliatti Barbos M. Le linee guida nell’esercizio della pratica clinica.Diritto penale e processo 1996; 7: 891.
Rennie D, Luft HS. Pharmacoeconomic analyses. Making themtransparent, making them credible. JAMA 2000; 283: 2158-60.
Sackett DL. Rules of evidence and clinical recommendations on use ofantithrombotic agents. Chest 1986; 89 (suppl.2): 2-3.
Stellfox HT, Chua G, O’Rourke K, Detsky AS. Conflicts of interests in thedebate over calcium channels blockers. N Engl J Med 1998; 338: 101-6.
Tramer MR, Reynolds DJ, Moore RA, McQuay HJ. Impact of covertduplicate publication on meta-analysis: a case study. BMJ 1997;315: 635-40.
Wortman PM, Smyth JM, Langenbrunner JC, Yeaton WH. Consensusamong experts and research synthesis. A comparison of methods. IntJ Technol Assess Health Care 1998; 14: 109-22.
Yusuf S, Cairns JA, Camm AJ, et al. Evidence-based cardiology. BMJPublishing Group, London, 1998.
Richiesta estratti: Pietro Apostoli - Institute of Occupational Medicine and Industrial Hygiene, University of Brescia, PiazzaleSpedali Civili 1, 25123 Brescia, Italy