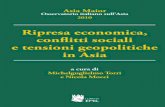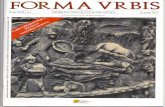Archeologia del lavoro
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Archeologia del lavoro
LA NUOVA QUA
Archeologia del lavoro
Alberto Baldasseroni e Francesco Carnevale
Archaeology is the past tense of anthropology and industrial archaeology is the past tense of
industriai workers.
(Hudson K., 2001),
Sono le domande che facciamo, non meno delle risposte che riceviamo, a consentirci di sviluppare un senso del passato senza il quale le ricerche più coscienziose e accademicamente rispettabili sareb-bero inutili e costituirebbero soltanto una perdita di tempo. Questo cotonificio veniva riscaldato
durante l'inverno? Come era riscaldato? Se non c'era riscaldamento, come poteva lavorare il perso-nale? Che genere di assistenza sanitaria era previsto? E dove veniva prestata quest'assistenza? Che genere di cibo e di bevande la mano d'opera L.] portava con sé al lavoro? Dove venivano consu-
mati i pasti? Quali erano gli incidenti più comuni? E, poiché il lavoro della tessitura era molto rumo-roso, gli operai non diventavano sordi? (Hudson K,, 1963).
A queste domande, tutt'altro che retoriche, Kenneth Hudson, uno dei padri dell'ar-cheologia industriale, proponeva risposte illuminanti:
Le risposte a tutte queste domande in qualche posto ci devono essere, ma è straordinario che siano ignorate dalle storie dell'industria esistenti. Il grande merito dell'archeologia industriale è quello di aver portato nel campo della storia un gran numero di persone dotate di mente prati-
ca e del gusto di affrontare le questioni di più difficile soluzione, Queste persone vogliono cono-scere cose che gli storici tradizionali legati alle biblioteche non hanno mai considerato interes-
santi o importanti; e a loro sembra ridicolo dividere la storia in compartimenti: storia politica, storia economica, storia sociale, storia della scienza e della tecnologia e così via. È, sempre storia, e l'archeologia industriale può essere utile alla persona che si interessa particolarmente alla mec-
canica e alla macchina a vapore, come allo studioso dei morbi e delle rivoluzioni. La storia riguar-da soprattutto gli uomini, non le cose; e l'archeologia industriale, che è uno degli strumenti di cui si serve lo storico, riguarda la parte che le miniere di carbone, i magli a vapore e le rimesse abbandonate delle aeronavi ebbero nella vita e nel pensiero di coloro che le idearono e se ne ser-virono (Hudson K., 1963).
La lunga citazione serve per introdurre le pagine che seguono scritte da "persone di mente pratica e dotate del gusto di affrontare le questioni di più difficile soluzione". Per-ché dunque due medici del lavoro possono e debbono interessarsi di archeologia indu-striale? Proveremo a sviluppare alcune argomentazioní che crediamo possano rispondere almeno in parte al quesito.
Le nostre considerazioni partiranno dai due ambiti professionali che più direttamente coinvolgono il rapporto tra medico e luogo di lavoro, quello della osservazione serneiotica,
90
GLI SPAZI DEL LAVORO
diagnosi, prognosi e "terapia" della patologia da lavoro e quello deí mezzi tecnici e cultu-rali per la sua "profilassi" o, più modernamente, prevenzione primaria. Clinica delle malat-tie del lavoro e igiene industriale rappresentano, in altre parole, il binomio inscindibile che fa del medico del lavoro un protagonista privilegiato delle vicende di fabbrica, vero testi-mone dei cambiamenti e dei conflitti che l'eterno scontro tra lavoro e capitale mette in scena tra le mura della fabbrica, nei locali di rappresentanza, tra le macchine in produzio-ne, in tutte le istituzioni di sostegno sociale alle maestranze che spesso caratterizzano vil-laggi operai e falansteri dell'industria.
Se l'Archeologia industriale vuole avere, come penso, una funzione di costruzione di una memo-ria collettiva del nostro recente passato, certamente la sua opera di metaforico scavo non potrà limitarsi alle superfici, ma sarà costretta ad andare nel profondo dei rapporti sociali su cui la fab-
brica si è costituita e che essa stessa ha contribuito a costruire (Bigazzi D., 1991).
Il contributo dei medici del lavoro a questo auspicato scavo dei rapporti sociali si rivele-rà perciò sostanziale.
La medicina del lavoro: dal letto del malato agli "antri del lavoro"
Se già Bernardino Ramazzini (Rarnazzini R., 2000) alla fine del Diciassettesimo secolo aveva rotto il diaframma fra medico e ambiente di lavoro, andando a visitare, oltre che il malato, anche la "causa" della sua malattia, per trarne ammaestramenti profilattici e tera-peutici, bisogna però attendere l'alba del Ventesimo secolo, almeno in Italia, per trovare di nuovo espressa l'esigenza per il medico di avvicinarsi ai luoghi del lavoro.
Luigi Devoto, animatore del primo nucleo di medici del lavoro nell'industre Milano, fondatore della prima Clinica delle malattie del lavoro, in un intervento del 1903 su "Il Lavoro", periodico dedicato ai problemi della salute dei lavoratori, echeggia l'ammae-stramento del sociologo belga Denis, allievo di Comte, che così si esprimeva:
Ma come? voi medici vi circoscrivete entro i limiti degli ospedali e delle cliniche, dei laboratori uni-versitari, e restate indifferenti a tutto quello che si svolge fuori delle pareti dei vostri ospedali e non vi accorgete che in mezzo alle professioni, in mezzo alle officine si svolge una vita fortunosa, tor-
mentosa che travolge migliaia e migliaia di persone? Scendete fra gli operai, affiatatevi coi lavorato-ri e farete opera utile, uscendo dagli ospedali, dalle cliniche, alla scienza e all'umanità, allargherete
il vostro ambiente di studi tra i lavoratori, che, lavorando, soffrono e ammalano (Carbonini A.,
1982).
E se Paolo Pini, medico ortopedico milanese, socialista, "figlio adottivo" di Filippo Tura-ti e di Anna Kuliscioff, rimproverava proprio al Devoto una contraddizione tra la teoria e la pratica e cioè di nuovo l'eccessiva attenzione agli aspetti clinici delle malattie da lavoro, a scapito dell'intervento diretto nei luoghi di lavoro, d'altra parte proprio uno degli assi-stenti di Devoto, Luigi Carozzi, portava a termine in quegli anni importanti ricerche "sul campo" in collaborazione con i sindacati dei tipografi, dei verniciatori, delle guantaie, delle operaie tessili della seta.
Anche a Firenze un pioniere di questo genere d'indagini, Gaetano Pieracciní, medico socialista, apostolo di una terapia sociale delle malattie del lavoro, interveniva direttamente nei luoghi di lavoro, indagando la salute e le condizioni di vita di cenciaioli, minatori di mer-curio, dí alabastro, fiammiferai, sigaraie, trecciaiole e impagliatrici, braccianti e mezzadri. Sul loro esempio si formò un esiguo, ma entusiasta manipolo di medici che scelsero di conosce-re le botteghe, le fabbriche, i processi produttivi, i macchinari, le sostanze adoperate, in una parola la materialità del lavoro per poter prevenire l'insorgere di malattie per tanti aspetti
9 I
LA NUOVA CITTA
Valperga (To), Santuario Madonna
Belmonte. Ex voto, 19 I 6.
Da Prevenzione e tutela del
lavoratore, Inali, Direzione
Regionale Piemonte 2000.
"inguaribili" come quelle dovute al lavoro nocivo. In realtà inguaribili apparivano a chi sí limitava a osservare il malato quando questi si presentava per l'ennesima ricaduta di malat-tie che vedevano nell'infausto connubio di carenze alimentari e di eccessivo sfruttamento fisico il terreno di sviluppo di avvelenamenti specifici (da piombo, da fosforo, da mercurio, ecc.), ma anche di malattie della consunzione e dello sfinimento (tubercolosi prima dí tutto, clorosi tra le donne, rachitismi e deformità invalídanti tra i bambini operai, pellagra tra i braccianti e i contadini delle pianure coltivate a mais, malaria tra i bonifícatori e i ferrovieri, ecc.). I traguardi della prima fase della medicina del lavoro, unanimemente riconosciuti anche a livello internazionale, cedettero però ben presto il passo a un nuovo modo di vede-re la professione di questi medici. L'ambiguità delle politiche sociali giolittiane in questo campo, col ritardato e comunque stentato avvio di un Ispettorato medico del lavoro, prima, e l'avvento del Fascismo, poi, fecero virare l'impostazione della disciplina verso la deriva di una professione funzionale al controllo e all'asservimento della manodopera nei confronti del progetto di "modernizzazione autoritaría" avviato durante gli anni del Fascismo. Il medi-co del lavoro si chiuse così di nuovo nelle cliniche universitarie a studiare gli aspetti fisiopa-tologici del lavoro moderno, oppure operò in fabbrica, ma segregato rispetto al processo produttivo, all'officina, al luogo del lavoro, spesso impedito anche fisicamente dal recarsi nei reparti di produzione, relegato negli ambulatori di fabbrica a selezionare gli idonei al lavoro e a escludere gli inidonei. Furono infine i lavoratori stessi a rompere questa innaturale situa-zione di separatezza, quando verso la fine degli anni Sessanta, proposero con forza a una nuova leva di medici del lavoro di tornare a confrontarsi direttamente con chi in fabbrica viveva e sopportava le condizioni di nocività. L'invito fu accolto da molti medici che si affian-carono alle iniziative di lotta per la difesa della salute operaia avviate in varie parti del paese. Di nuovo ci si confrontava con le condizioni reali di lavoro, con la modifica dei cicli pro-duttivi, sia nella loro componente chimico-fisica, sia in quella di tipo organizzativo.
È quindi chiaro l'intreccio inestricabile tra condizioni materiali del lavoro, condizioni di salute degli addetti, rilevazione di sintomi e segni fino alla configurazione di un quadro di sofferenza patologica nel quale il medico del lavoro si trova a operare quotidianamente.
92
Produzione di manufatti in
amianto in una azienda
piemontese, seconda metà degli
anni Trenta del Novecento.
A sinistra: misurazione della
concentrazione della polvere
nell'aria a livello della bocca di un
operaio addetto alla scarica del
mescolatore. Il fazzoletto attorno
alla bocca viene tenuto da molti
operai come protezione contro la
polvere.
A destra: misurazione della
polvere alla bocca dell'operaio
addetto alla carica del lupo
mescolatore.
In E.C.Vigliani, Studio sull'asbestosi
nelle manifatture di amianto, Enpi,
Torino 1940.
GLI SPAZI DEL LAVORO
I difficili esordi e gli stentati sviluppi dell'Igiene industriale in Italia
IlDeMorbis Artificum di Ramazzini aveva rappresentato per oltre un secolo l'unica trat-tazione scientifico-sociale in materia di danni alla salute e stigmate delle professioni. Su quel testo, con spiccate caratteristiche mediche, sono improntate opere successive comparse in altri paesi europei (Fourcroy M., 1777; Halfort A.C.L., 1845) e quindi anche in Italia (Lom-broso C., 1865), Questa branca della medicina, stante l'abbondanza di casistiche disponi-bili, è capace di perfezionare le sue capacità díagnostiche che diventano in molti casi ogget-to di denuncia. Valga per tutte, ma non è né la prima e neppure l'ultima nel corso del tempo, la sentenza di Loriga:
L'esercizio di una professione o di un mestiere [infatti] disciplina il lavoro, obbligando l'indivi-
duo a seguire uno speciale sistema di vita, a ripetere frequentemente una serie di atti uniformi, a esporsi a una quotidiana influenza dei medesimi agenti esterni. In questo modo accelera o ritar-da il ricambio materiale e la sanguificazione, favorisce lo sviluppo e l'attività funzionale di alcuni
organi, altri ne lascia inerti o poco sviluppati, iinprimendo al corpo intiero o a qualche sua parte speciali caratteri di robustezza o di debolezza, più o meno profondi. [...1 La professione è quin-di uno dei più potenti modificatori dell'organismo ed è capace di favorire o di aggravare alcune
condizioni proprie della costituzione individuale (Loriga G., 1910).
È sempre una testimonianza di Loriga, il miglior esempio di medico e igienista indu-striale, che ci illustra in maniera realistíca scenari industriali sorti in maniera "spontanea", a prescindere dalla applicazione di pur disponibili norme di prevenzione attiva a favore degli operai:
In molte operazioni [...l quali ad es. la bozzatura e la rama dei tessuti, la follatura dei cappelli, la saturazione e la cristallizzazione nelle fabbriche di prodotti chimici, la fusione dei grassi, la cot-
tura delle setole, la concentrazione dei liquidi cloacali nelle fabbriche di concimi, le sale di inu-midimento nelle manifatture dei tabacchi, ecc. si produce una elevazione notevole della tempe-ratura dell'ambiente accompagnata da sviluppo di vapori più o meno densi, i quali talvolta for-
mano vere nebbie diffuse o localizzate. La vera nebbia, detta comunemente 'l'umana', si forrna quasi esclusivamente nella stagione fredda ed è una calamità per queste industrie. In primo luogo gli operai, oltre ad avere la pelle e i capelli e gli abiti costantemente bagnati di acqua devono sop-
portare anche l'altissima temperatura dell'ambiente, e quindi non solo trovano nel lavoro le con-
93
LA NUOVA CITTA
Borgosesia (To). Manifattura lane,
la filatura.
In L. Lanzardo , Dalla bottega
artigiana alla fabbrica, Editori
Riuniti, Roma I 999 da cui è tratta
anche la foto di pagina seguente.
dizioni che lo rendono gravoso ed estenuante, ma sono colpiti facilmente da malattie reumatiche tosto che si espongono a una temperatura appena più bassa. Secondariamente la nebbia è causa frequente dí infortunio perché non permette di vedere né gli altri operai, né le macchine a pochi passi di distanza. Infine l'acqua di condensazione fa imputridire i legnami, irrugginire il ferro e
colando a gocce dai soffitti e dagli attrezzi sulle materie in lavorazione le macchia e le deteriora. In molti casi la nebbia è accompagnata da sviluppo di vapori nauseanti e irritanti e di sostanze volatili acide, o alcaline, o anche tossiche, le quali accrescono i danni che minaccia il caldo umido alla salute [...1. Ma tanto nelle sale di filatura quanto in quelle dei telai, e talvolta anche nelle sale di carderia e in quelle di preparazione (cioè quelle ove si compiono le operazioni immediata-mente precedenti la filatura: `étalage, étirage, banc à broches'), l'altezza dell'umidità e della tem-peratura dell'aria è ottenuta e mantenuta costantemente eziandio in modo artificiale, perché tale aumento costituísce una condizione tecnica necessaria per conservare l'elasticità e la flessibilità
delle fibre tessili e quindi per evitare la rottura del filo e per ottenere filati più fini e più unifor-mi. Per questa ragione si crede che la bontà dei filati inglesi sia dovuta alla costante forte umidi-tà dell'aria in quel paese (Loriga G., 1910),
12ígiene industriale, animata dall'inizio e per molti anni da medici igienisti, muoveva i suoi passi più decisivi nella seconda metà dell'Ottocento in Francia (a opera, tra gli altri di Cadet de Gassicourt, di Chevallier e di Vernois) e in Germania con Hirt (1872, 1878), Putsch (1883), Roth, Bluhm e Fraft (1894) e albrecht (1896), quest'ultimo tradotto anche in italiano con note di Camillo Terni (Carnevale E e Baldasseroni A., 1999). Come disci-plina essa segue, con un certo ritardo e complessivamente con una minore capacità di suc-cesso, l'esperienza ottocentesca dell'igiene finalizzata alla lotta delle malattie infettive che interessano la popolazione generale. Propone, nei confronti dei "poveri operai", interventi preventivi, anche se parziali, che solo in parte vengono accolti spontaneamente da alcuni industriali filantropici. Gli stessi igienisti industriali, come quelli che negli stessi anni si occupano principalmente dí microbiologia, non sfuggono alla tentazione dell'utopia: "A ragione dunque l'igiene — questa scienza di avanguardia e di moralízzazione per eccel-
94
GLI SPAZI DEL LAVORO
Rovereto (Tn). Il carro
vendemmiale allestito su progetto
di E Depero nel 1935 per la
Manifattura Tabacchi.
lenza — ha bisogno di estendere la sua cerchia d'azione sull'industria, in attesa che tutti i lavori penosi e nocivi sieno eseguiti dalle macchine, riservando all'uomo il vero lavoro ari-stocratico — permettetemi il termine — in tutti i generi" (Raddi A., 1893).
L'igiene industriale dei medici tende a essere giustamente superata da quella degli inge-gneri. "L'ingegnere deve essere il chirurgo rispetto all'igiene, come lo è il medico rispetto al corpo umano" scrive Arnerigo Raddi nel 1891 presentando i nuovi tecnici detentori di "saperi speciali" di cui i municipi e la sanità pubblica dovevano avere sempre più bisogno (Giuntini A., 1999). Vista l'impotenza "terapeutica" dei medici igienisti gli ingegneri si fanno interpreti della applicazione di soluzioni messe a disposizione dallo sviluppo della tecnologia; gli ingegneri detengono la capacità di definire con calcoli matematici le altezze degli edifici, i ricambi dell'aria il riscaldamento e la luce occorrenti e realizzabili. Si capisce subito che la filantropia di alcuni industriali non basta e l'esperienza della Germania lo aveva dimostrato già da qualche decennio: "una efficace igiene delle industrie e delle fab-briche non può esistere senza una conforme legislazione dello stato" (Albrecht N., 1898). Ciò che emerge con più forza a un certo punto in Italia è proprio la carenza di leggi capa-ci di disciplinare il lavoro dal punto di vista igienico, e meglio ancora la volontà di rinviar-ne la promulgazione pur considerata inevitabile. Le leggi di prevenzione degli infortuni e le leggi protettrici delle donne e dei fanciulli precederanno di molto le leggi che hanno per oggetto la salubrità del lavoro e così succederà per quelle sulle "industrie insalubri" ten-denti a proteggere il benessere pubblico. Il Consiglio superiore di sanità, durante la com-pilazione dell'elenco degli stabilimenti insalubri (nel 1892), aveva proclamato che il con-cetto supremo a cui deve ispirarsi tutta la procedura in proposito consiste "nel tutelare l'igiene, senza ledere i legittimi interessi dell'industria" (Revelli C.A., 1893).
così che si è potuta sviluppare e perpetuare una architettura industriale come maquil-lage facciale di un corpo più o meno informe, come "bella faccíata" con una sua caratteri-stica periodizzazione ben descritta da Raja: una fase preindustriale del "riuso", tra la metà Settecento e il primo Ottocento; l'espressione più tipica è quella di castelli, granai, fienili, stalle cascine rurali sommariamente ristrutturati con aggiunta una ciminiera, una "architet-
95
LA NUOVA CITTA
tura senza architetti" ma con alcune simbologie significative. In alternativa le industrie si mascherano dietro rispettabili facciate di dimore borghesi o castelli nobiliari (eliminando ogni problema di stile e di funzionalità). Segue il periodo aureo (paleoindustríale), verso la metà e la fine dell'Ottocento, con un linguaggio architettonico specifico, alla ricerca di uno stile, una preferenza per il neoromanico o neomedievale e cioè per un gusto del solido e del monumentale, con una notevole rigidità interna.
C'è poi la fase dí "maturità" dell'istituzione industriale che occupa il Novecento sin dai suoi inizi, una architettura industriale essenziale e priva di ornamenti e di simboli. Diventa più importante l'architettura interna, per facilitare diversificazioni organizzative del lavoro con spazi più flessibili. L'obiettivo è il funzionalismo e il razionalismo che ha corne obietti-vo praticamente esclusivo la produzione.
Questa tendenza sfocia nei modelli stereotipati del secondo dopoguerra, gli anonimi capannoni nei quali solo in alcuni casi, e più spesso a posteriori, si riescono a introdurre "nuove razionalità" basate sulla impíantistica e sulla strutturistica (Raja R., 1983).
Il decalogo per l'architetto industriale redatto da Pagano nel 1942 può essere letto come atto di denuncia per le carenze rilevabili nella pratica del passato e contemporaneamente per quelle che saranno perpetrate ancora neí decenni a venire:
1. Non considerare la fabbrica soltanto come uno strumento di lavoro iena come un'opera d'ar-te, una espressione di vita, una manifestazione dello spirito
2 . L'industriale moderno deve tendere a isolare nello spazio la fabbrica e a fonderla col paesag-gio, in modo da emanciparsi dall'urbanistica cittadina.
3. Non realizzare mai programmi parziali se non si possiede un programma generale del quale si è convinti e al quale si vuole tener fede nel più breve tempo possibile.
4. Ricordare che le costruzioni sporadiche o provvisorie e le migliorie parziali sono indice di incertezze e di debolezza
5 . Meglio disfarsi a tempo e con coraggio di una vecchia costruzione irrazionale e superata, piut-tosto che sacrificare l'estetica futura a una pericolosa avarizia iniziale. più grave errore veder troppo piccolo che troppo grande: chi è avaro negli impianti deve spendere nella gestione.
Apparecchio per aspirare la
polvere nella fabbrica di aghi di Leo
Lammertz in Aquisgrana. Sezione e
aspetto posteriore delle casse di
difesa.
N.Albrecht, Trattato pratico di igiene
industriale, traduzione in italiana di
C.Terni,Vallardi, Milano s.d.
(ma 1898); da cui è tratto anche il
disegno della pagina seguente,
9 6
GLI SPAZI DEL LAVORO
A sinistra: raccoglitore di polveri di
Unruk e Liebig a Lipsia. Sezioni.
A destra: Impianto di ventilazione
per una costruzione shed dello
stabilimento di filatura di stami in
Augusta. Sezioni.
6. L'intervento di un architetto in una costruzione industriale deve trovare il suo ideale piano di
collaborazione con la direzione tecnica della fabbrica ...
7. Una industria moderna veramente viva deve avere un carattere attuale ed esteticamente incon-fondibile, dalla fabbrica all'ufficio vendita, dal banco di lavoro alla vetrina pubblicitaria .„
8. Un vero industriale deve considerare con la massima attenzione gli ambienti in cui vivono gli
operai quando non lavorano. Dalle condizioni estetiche e igieniche degli ambienti in cui si
riposa e ci si svaga dipende in gran parte l'entusiasmo del lavoro. 9. Eindustriale ricordi che difficilmente, in fatto di estetica, potrà avere dai propri dipendenti
deí consigli disinteressati
10. L'espressione della estetica industriale non finisce con la fabbrica. Essa deve risolvere tutti i
problemi materiali e spirituali della nuova collettività, Questo deve essere il pensiero fisso e l'ambizione più alta di un industriale veramente vivo e di un architetto che voglia veramente
rendere completa la propria opera. E necessario ricordare che il denaro e la ricchezza e l'in-
telligenza organizzativa e la fantasia dell'arte devono giustificarsi in una sola aspirazione: il benessere collettivo e l'elevazione materiale e spirituale del prossimo (Pagano G., 1942).
Documenti per un'archeologia del lavoro:i musei dell'industria e del lavoro
Ancora una volta è dalla Gran Bretagna, culla dell'archeologia industriale, che vengono esempi di grande interesse in questo campo. Chi ha potuto visitare qualcuno dei numero-sissimi monumenti di archeologia dell'industria e musei dell'industria dei quali è punteg-giato quel paese, non avrà faticato a trovare traccia del connubio fra archeologia industria-le e testimonianze dei medici che in fabbrica operavano.
A Styal, piccolo borgo non lontano da Manchester, sorge il Quarry Bank Mill, fabbrica di cotone fondata da Samuel Greg nel 1784, ora trasformata in museo. Ampio spazio è dedicato all'archivio del medico che aveva in cura le maestranze di quel complesso, Peter Holland, oggetto di un ampio studio pubblicato sul "British Journal of Industrial Medici-ne" del 1992 (Murray R., 1992). Vi si descrivono le condizioni di lavoro e le malattie pre-valenti tra la manodopera, con speciale attenzione ai bambini al lavoro. Nel Museo dell'in-dustria di Sheffield, dove all'entrata si è accolti da un magnifico esempio di forno per l'ac-
97
LA NUOVA CITTA
A sinistra: aspirazione di polveri
nella pettinatura del lino.
Al centro: apparecchio fumivoro
H offmann.
A destra: apparecchio fumivoro
Keyling.
In G. Loriga, Igiene del lavoro,
Vallardi, Milano s.d. (ma I 9 O).
ciaio Bessmer, interi pannelli descrivono la malattia degli affilatori di coltelli, la silicosi, riportando le cronache dei primi ispettori del lavoro e dei medici che li affiancavano nelle loro ispezioni. A ironbridge, nell'ecomuseo dell'industria dello Shropshire, si trovano descrizioni dettagliate e approfondite delle condizioni di lavoro e di nocività che gli operai delle fonderie di acciaio, delle fabbriche per la produzione di ceramiche, degli altiforni, delle miniere, di quell'area subivano.
Ma anche a Lowell, Massachusetts, USA, "una città di fabbriche" dove in giganteschi opifici lavorarono tra la fine del Settecento e i primi trent'anni del secolo scorso decine di migliaia di operai e operaie alla produzione di cotone, accanto a un attento lavoro di archeologia industriale che ha portato al restauro conservativo di alcuni dei più importan-ti complessi produttivi, si nota una grande attenzione alla valorizzazione del "fattore umano" della produzione, considerato elemento di archeologia industriale, non meno del reperto fisico del luogo della produzione.
A Norrkóping, Svezia, ancora una volta, accanto al recupero attento e fllologicamente ineccepibile, del resto fisico di fabbrica, si assiste all'affiancarsi di uno studio e di una con-servazione anche del ricordo di chi in quegli opifici visse e lavorò. Al secondo piano della più antica e prestigiosa fabbrica del complesso che è stato restaurato e riconvertito a museo, ha sede una fondazione per la ricerca sul lavoro umano, co-gestito dalle Trade Unions loca-li. E gli esempi potrebbero continuare.
Si vuol dire che, forse, finora in Italia è mancato o non ha raggiunto sviluppi operativi adeguati quell'incontro cruciale tra discipline politecniche e discipline sociali che solo può ispirare nuova vita agli scheletri di edifici industriali che l'industria ha largamente dissemi-nato anche in Italia. Parziali eccezioni a questa regola possono essere considerate le espe-rienze della Fondazione Micheletti di Brescia e dell'istituendo Museo dell'industria e del lavoro di Sesto S. Giovanni.
La Fondazione Micheletti, ben nota ai cultori di archeologia industriale non solo italia-ni, sta cercando di organizzare una sede museale dedicata al lavoro industriale, con un'at-tenzione spiccata agli aspetti umani del lavoro (Fondazione Micheletti, 2002). Collaborano in varia misura a questo sforzo medici del lavoro della provincia di Brescia, tra i più attivi nel campo della tutela della salute dei lavoratori.
La seconda iniziativa, in fase di sviluppo sotto gli auspici dell'amministrazione comuna-le di Sesto S. Giovanili, vuole mantenere vivo il ricordo di ciò che fu il polo siderurgico e metalmeccanico dí quella città nella cintura milanese (Comune di Sesto S. Giovanni, 2002). In particolare è da sottolineare che nel comitato scientifico che sovrintende ai lavori siede una delle più prestigiose colleghe, medico del lavoro, che in questi anni hanno contribuito al rinnovamento della disciplina, Laura Bodini.
98
FATTORI NOCIVI
4°GRUPPO
RITMI ECCESSIVI MONOTONIA • RIPETMVITA'
POSIZIONI DISAGEVOLI
ALTRI EFFETTI STANCANTI
GRUPPO OPERAIO INTERESSATO E ORGANIZZAZIONE SINDACALE
r
registrazion ~dati non delega validazione conaexuniale
elaborazione dei dati soluzioni tecniche L soluzioni tecnologiche
studio epidemiologico L
coordinamento
rseinzioni legislative
GLI SPAZI DEL LAVORO
In Ambiente di lavoro, FIOM — Gli archivi delle imprese Torino, Editrice Sindacale Italiana,
Torino I 969. Negli ultimi anni anche in Italia ha trovato spazio quel fenomeno di salvaguardia della memoria d'impresa che consiste nella creazione e messa in sicurezza degli archivi azienda-li. Gli archivi rappresentano senza dubbio una fonte primaria per la comprensione del fenomeno industriale e si affiancano, come "reperti", a quelli fisici delle mura della fabbri-ca e degli ingranaggi delle macchine. In questo campo, tuttavia, è di grande importanza tener conto che il recupero di un archivio di fabbrica può rispondere a diversi intenti. Accanto a esempi dí lineare importanza (Ansaldo), se ne annoverano altri in cui l'intento encomiastico e autocelebrativo da parte di aziende tuttora vive e attive, sovrasta, quanto-meno per la scelta di privilegiare a parità di settore produttivo le realtà ancora sul mercato, gli intenti documentativi e storici.
Si parla molto di nuove forme della comunicazione aziendale, parallele a quelle tradi-zionali della pubblicità, che vogliono illustrare la linearità di percorsi d'azienda, attraverso l'"argenteria" di famiglia, rappresentata anche dalla storia aziendale, così come trasmessa dai documenti del proprio archivio. Esistono però anche casi in cui all'origine della salva-guardia e del recupero di archivi aziendali non c'è tale intento, ma motivi legati a vicende di salute dei lavoratori.
Il caso più famoso è quello dell'IPCA di Ciriè, tristemente nota fabbrica di coloranti sin-tetici, causa di una epidemia di morti per tumore alla vescica. La fabbrica chiuse alla fine degli anni Settanta, ma il suo archivio fu salvato dalla distruzione grazie all'intervento della magistratura che anche su quelle carte imbastì un processo rimasto storico, con la condan-na per omicidio colposo inflitta a carico dei titolari dell'azienda e del medico di fabbrica. La con-iunità di Ciriè ha deciso di non dimenticare quella vicenda e attualmente è in corso il recupero del manufatto, "insignificante" (da un punto di vista archítettonico) corpo di fabbrica a capannone, nel quale verranno sistemati i principali attrezzi per la produzione delle micidiali sostanze chimiche (tíni in legno, pale, tinozze per la decantazione, filtro-pres-se e quant'altro), i rudimentali mezzi di protezione usati dai lavoratori per difendersi dalle esalazioni tossiche (zoccoli in legno, grembiali e fazzoletti di stoffa, ecc.), nonché testimo-nianze scritte delle vicende poi documentate negli atti del processo contro i padroni del-l'IPCA (Carnevale F., 1999). Ě questo un concreto ed esemplare modo di ricordare il pas-sato visto dalla parte dei lavoratori, senza per questo nulla togliere all'importanza dell'ap-proccio descritto sopra.
Sempre grazie all'attività della magistratura piemontese e a quella di Torino in particola-re, sono stati, con analoghe motivazioni, raccolti e messi in sicurezza altri importanti archi-
99
;
E.900.0MUM rr JohmaJami I wergail 41141.111.411.111
.1.1111410.11.1111 411Fer ir
.11411.M.Ma i ireFfrilror
4
2
LA NUOVA CITTA
vi di fabbrica. Ě il caso della SIA (Società Italiana Amianto) di Grugliasco, azienda che operò nel campo della lavorazione di manufatti tessili in amianto (De Palma M.T., 2001), e della Società amiantifera di Balangero, azienda addetta all'estrazione del minerale presso la più grande cava europea (Carnevale E, 1994). In ognuno di questi casi la storia docunlen-tale, ma anche l'osservazione del reperto fisico della fabbrica o del luogo di lavoro hanno arricchito in maniera sostanziale il quadro che ha portato i giudici a decretare le responsa-bilità di chi aveva il dovere di salvaguardare la salute dei lavoratori, oltre che quello di crea-re profitto.
In altri casi gli archivi di azienda, già raccolti con altri fini, hanno offerto materiale utile alla ricostruzione dei livelli di esposizione a sostanze tossiche e nocive presenti nei cicli di lavoro. Lo studio epidemiologico condotto tra i lavoratori delle miniere di mercurio del-l'Amiata in Toscana ha attinto numerose stime di igiene industriale da documenti presenti in archivi salvati per fini di archeologia industriale (Bellander T. e altri, 1998).
Per lo studioso di civiltà industriale del futuro sarà di grande utilità consultare i docu-menti in possesso dei servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro nati nel corso degli anni Settanta a prefigurare la futura Riforma sanitaria del 1978. Si tratta di relazioni che descri-vono talvolta dettagliatamente le condizioni di lavoro nelle fabbriche di quel periodo, carat-terizzate, nel nostro paese, dal permanere di condizidni organizzative arretrate, legate a modelli di "Scientific Management", piuttosto che ai più aggiornatí schemi delle "Human Relations". Ma anche tutto il vasto materiale di origine sindacale, indagini in fabbrica con-dotte dai Consigli di fabbrica in seguito all'applicazione dell'art. 9 dello Statuto dei lavora-tori, arricchiranno e chiariranno a quello studioso il clima sociale e umano che si respirava tra le mura delle fabbriche, nei locali dove si riunivano le Commissioni interne sindacali, nelle mense dove si svolgevano infuocate assemblee, nelle infermerie di fabbrica dove i medici venivano contestati nel loro ruolo di contabili della nocività.
Restano da salvare gli archivi di tali istituzioni, disperse sul territorio, frammentate in mille luoghi e spesso confuse con la più ampia documentazione di sanità pubblica. Docu-
I 00
Gemona Manifattura di S.p.A.
E. Mattioni, Nuova filatura di
Piovega, I 976-77.Veduta zenitale
(I) e a volo d'uccello (2) del
plastico del layout definitivo delle
UP/1,2,3,4; plastico della sezione
tipo delle US (3); sezione tipo della
US (4).
Da: Casabella 433, feb. I 978.
GLI SPAZI DEL LAVORO
mentazioni fotografiche di condizioni di lavoro tutt'altro che ideali, talvolta ricavate nel corso di indagini per incidenti sul lavoro; risultati di misurazioni di igiene industriale; rile-vazione e registrazione della "soggettività operaia"; tutto questo attende di essere censito, catalogato, studiato e messo a disposizione della più ampia platea degli studiosi.
Insomma volendo ampliare il concetto da quello di "archeologia industriale" a quello di "Antropologia storica della civiltà Industriale" (Castellano A., 1982) o, se si vuole, a quel-lo di "Work Archeology" (Hudson K., 2001), non si potrà fare a meno del contributo di quanti tra i medici del lavoro, scelsero di affiancare e sostenere quel moto di riscatto dalle proprie condizioni di lavoro che i lavoratori italiani ebbero tra la fine degli anni Sessanta e i prinn Settanta. Ma non è detto che questo sia l'esito al quale l'archeologia industriale ita-liana perverrà. Se prevarranno le spinte a riscrivere quel periodo della nostra storia recen-te dalla parte dei "vincitori", allora anche queste preziose testimonianze saranno ignorate.
Conclusioni
"L'archeologia industriale deve andare oltre il suo tradizionale paradigma tecno-centri-co per considerare la dinamica sociale dei resti materiali" (Editorial, 2001). In questa recen-te affermazione dell'autorevole rivista inglese "Industrial Archeology Review", a commen-to dell'ultimo contributo di Kenneth Hudson, si concentra il significato di un necessario, rinnovato in-ipegno dell'archeologia industriale negli anni che ci aspettano. Della "dinami-ca sociale" del resto materiale debbono entrare a far parte tutti quegli interventi, quelle testimonianze, segno dell'attenzione posta via via nel tempo ai problemi dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori, così come debbono trovare attento esame i resti materiali delle isti-tuzioni a supporto del loro benessere e della loro sicurezza sociale. Acquistano così nuova luce da una parte tutti quegli apparati tecnologici imposti dallo sviluppo di una legislazio-ne sociale protettiva della sicurezza e della salute (apparecchiature di captazione degli inquinanti prodotti nei cicli produttivi, protezioni delle parti a rischio dei macchinari, pro-gettazione di uffici e officine "a misura d'uomo" o umanizzate dall'intervento dell'impren-ditore), ma anche le istituzioni "sociali" che lungo il tempo hanno supportato il benessere dei lavoratori fuori dalla fabbrica, come gli alloggi operai, gli asili e le scuole professionali per i loro figli, i centri di ricreazione e di svago (dopolavoro), le colonie elioterapiche. In tutto questo, ruolo non secondario spetterà anche alle fonti documentarie provenienti da chi, come i medici del lavoro, hanno per tanto tempo e in maniera tanto intensa interagito con il mondo del lavoro, spesso collocati nel punto cruciale di snodo della dialettica fra capitale e lavoro.
Riferimenti bibliografici
Bellander T., Merler E., Ceccarelli E, Boffetta P., 1998, Historical exposure to inorganic mercury at the smelter
works of Abbadia San Salvatore, in "Ann. Occup. Hyg,", XLII, Feb, 2, Italy, pp. 81-90.
Bigazzi D., 1991, Archivi d'impresa e archeologia industriale, in AA.VV., Archeologia industriale, ICMA /Il Col-
tello di Delfo, Roma, pp. 284-288.
Carbonini A., Luigi Devoto e la Clinica del Lavoro di Milano, in Betri MI., Gigli Marchetti A. (a cura di), Salu-
te e classi lavoratrici in Italia dall'Unità al Fascismo, Franco Angeli, Milano 1982.
Carnevale E, 1999, IPCA trent'anni dopo — La fabbrica ritorna alla città, "Bollettino SNOP", 50, luglio,
pp. 14-15.
Carnevale E, Baldasseroni A., 1999, Mal da lavoro, Storia della salute dei lavoratori, Laterza, Roma-Bari.
Carnevale E, Silvestri S., 1994, Lettura storica (IDossier della Direzione della Amiantifera di Balangero), in "Epi-
demiologia e Prevenzione", 18, pp. 191 - 193.
101
LA NUOVA CITTA
Castellano A., 1982, Per una antropologia storica della civiltà industriale, in Castellano A. (a cura di), La macchi-
na arrugginita —Materiali per un'archeologia dell'industria, Feltrinelli, Milano, pp. 75 - 173.
Comune di Sesto S. Giovanni <http://www.sestosg.net > accesso del 2/06/2002. Vedi anche: <www.
euroimopat,org>.
De Palma M.T., 2001, Una memoria recuperata; l'archivio della SIA. (Socz'età Italiana per l'Amianto) di Gruglia-
sco. Cenni storici, in "Epidemiologia e Prevenzione", 25, pp. 266-270.
Fondazione Micheletti, <http://www.fondazione-micheletti ,quipol/museo/home.html> accesso del 2/06/2002.
Fourcroy M., 1777, Introduction, in Essai sur le maladies des Artisnas, tracluit du latin de Ramassini, Ches Mou-
tard, Paris, pp, XVI-LIX.
Giuntini A., 1999, Gli ingegneri sanitari e l'utopia igienistica, in Giuntini A., Minesso M. (a cura di), Gli ingegneri in Italia tra '800 e '900, Franco Angeli, Milano, pp, 117-128,
Halfort A.C.L., 1845, Krankheiten der Kiinstel und Gewerbetreibenden, Berlin,
Hudson K., 1979, Archeologia dell'industria, ed. it. Newton-Compton, Roma, pp. 10-11; edizione originale, Indu-
strial Archeology, an introduction, John Baker, 1963.
Hudson K., 2001, Has Industriai Archeology lost its way?, "Industrial Archeology Review", XXIII, 1, pp. 6-9.
Lombroso C., 1865, Saggi di igiene tecnologica, in "L'Igea", 3, pp. 177-202, 209-21, 259-263, 289-294.
Loriga G., 1910, Igiene industriale, in "Sanità fisica" (diretta da Celli A.) del Trattato di medicina sociale (diret-
to da Celli A. e Tamburini A.), Dottor Francesco Vallardi, Milano s.d. (ma 1910).
Murray R., 1992, Peter Holland: a pioneer of occupational medicine, in "British Journal of Industrial Medicine",
49, pp. 337-386.
Pagano G., 1942, Decalogo di Giuseppe Pagano agli industriali, in "Casabella-costruzioni", 175.
Raddi A., 1893, L'Igiene del lavoro, in "Giornale della Reale Società Italiana d'Igiene", 3-4, pp. 114-119.
Raja R., 1983, Architettura industriale. Storia, significato e progetto, Dedalo, Bari.
Ramazzini R., 2000, Le malattie dei lavoratori (De morbis artil'icum diatriba), ed. it. a cura di E Carnevale, Libre-
ria Chiari, Firenze.
Revelli C.A., 1897, Igiene industriale — Polizia sanitaria, Unione Tipografico Editrice, Torino.
The Rolt Memorial Lecture 2000 — Editorial Note, in "Industriai Archeology Review", 2001, XXIII, 1, p. 5.
102