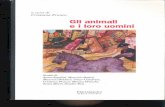Uomini e gentes nella prima metà del V secolo a.C.: Spurio Cassio
Transcript of Uomini e gentes nella prima metà del V secolo a.C.: Spurio Cassio
RIVISTA STORICA DELL’ANTICHITÀ
DIRETTORI
GIOVANNI BRIZZI – GABRIELLA POMA
ANNO XLIV / 2014
P À T R O N E D I T O R EB O L O G N A 2015
INDICE
SAGGI
Manuel TrösTer, Cimone come benefattore panellenico e campione di concordia. Una proiezione di Plutarco? .................................... pag. 9
Maria Federica PeTraccia, Uomini e gentes nella prima metà del V secolo a.C.: Spurio Cassio ......................................................... » 29
luca sansone di caMPobianco, Notes on Xenophon’s Vocabulary: a brief Enquiry on the Concepts of Courage and Discipline ........ » 47
cesare rossi, Some Examples of the Hellenistic Surprising Knowl-edge: its Possible Origin from the East and its Influence on Later Arab and European Engineers ...................................................... » 61
Miguel requena JiMénez, Commovisti terram, et conturbasti eam (Vulg. Psalm. 60, 4). Los terremotos en la antigüedad ................ » 85
TUCIDIDE E POLIBIO: L’ETÀ DELL’ORONELLA STRORIOGRAFIA GRECA
giovanni ParMeggiani, Anassimene di Lampsaco. Note sulla trasmissione del corpus ................................................................. » 109
sTeFan schorn, Historiographie, Biographie und Enkomion. Theorie der Biographie und Historiographie bei Diodor und Polybios .... » 137
MaTTeo zaccarini, La battaglia all’Eurimedonte in Diodoro e Plu-tarco: ricezione, modello e frammenti ‘cumulativi’ di storiografia di IV secolo .................................................................................... » 165
PieTro Maria liuzzo, Eforo, Teopompo e FGrHist 104 ................... » 185
4 Indice
NOTE E DISCUSSIONI
Paolo lePore, Gli homines militares fattori di ‘deformazione’ del l’assetto repubblicano .............................................................. pag. 225
beaTrice giroTTi, L’ambiguità del culto di Augusto tra fonti lettera-rie ed epigrafiche: un contributo dagli autori tardoantichi? ......... » 237
giacoMo Manganaro, Ricercatori di tesori nel mondo romano: a proposito di epigrammi di Gregorio di Nazianzo » 247
RECENSIONI
PhiliPPe akar, Concordia. Un idéal de la classe dirigeante romaine à la fin de la République, Publications de la Sorbonne, Paris 2013 (Gabriella Poma) ............................................................................ » 259
a. F. caballos ruFino (ed.), Del municipio a la corte - La reno-vación de las elites romanas, Universidad de Sevilla ed., Sevilla 2012, (Serena Zoia) ........................................................................ » 261
enrique Melchor gil, anTonio d. Pérez zuriTa, Juan Fco. ro-dríguez neila (eds.), Senados municipales y decuriones en el Occidente Romano, Sevilla 2013 (Gabriella Poma) ..................... » 263
MARIA FEDERICA PETRACCIA
UOMINI E GENTESNELLA PRIMA METÀ DEL V SECOLO A.C.:
SPURIO CASSIO
AbstractIn the construction of the fi gure of Spurius Cassius coexist positive and negati-ve aspects: the representation of the victorious commander who seeks peace and makes a deal with the Latins, the representation of the ambitious politician who was accused of aspiring to tyranny and for this reason was sentenced to death. His story is a long and tormented one, although not everyone is convinced that Spurius Cassius really existed.Keywords: Spurius Cassius, Rome, Foedus Cassianum, Adfectatio regni.
Ogni indagine sul V secolo a.C. implica, necessariamente, una presa di co-
scienza della esiguità e della problematicità delle fonti antiche utilizzate per la ricostruzione storica. Le indagini più recenti, svolte soprattutto negli ultimi de-cenni, anche con una rielaborazione più consapevole dei dati archeologici, epi-grafi ci e linguistici, consentono soltanto di dissipare alcune ombre di quell’età che è stata chiamata dal Piganiol “la notte del V secolo” 1. È un’epoca che, come ogni altra, trova i suoi presupposti nel periodo immediatamente precedente ma, forse più di altre, presenta delle caratteristiche particolari, che la pongono come un momento chiave della storia romana.
La tradizione ha lavorato in modo differente sui vari eventi e la molteplicità delle versioni indica chiaramente che i diversi episodi non vennero raccontati sot-to forma di una “storia” attestata e accettata dalla maggioranza degli scrittori. Il
1 A. PIGANIOL, Le conquiste dei romani. Fondazione e ascesa di una grande civiltà, Milano 2010, p. 95.
02_PETRACCIA.indd 2902_PETRACCIA.indd 29 04/02/2015 9.36.0704/02/2015 9.36.07
30 MARIA FEDERICA PETRACCIA
periodo successivo alle guerre puniche, specie quello compreso tra l’affermazio-ne dei Gracchi e quella di Silla, è stato un momento di elaborazione molto vivace di quanto accadde nei primi due secoli della repubblica, in particolare per quanto attiene ai conflitti interni. Livio e Dionigi d’Alicarnasso, per esempio, utilizzano come fonti l’annalistica media e recente, mentre Diodoro Siculo è generalmente accreditato come autore che fa riferimento alla storiografia greca o che scrive in greco e lo si considera, in genere, come conservatore di una tradizione meno manipolata. Non è semplice comprendere come potessero configurarsi, all’inter-no dello scenario politico generale, una plebe del V e del IV secolo a.C., tanto diversa dalla plebe della fine dell’età repubblicana, o il problema con i Latini e gli alleati, o la distribuzione delle terre e si possono avanzare diverse ipotesi in merito. Una posizione particolarmente radicale è quella di pensare ad una totale o molto ampia anticipazione dei problemi, un’altra più misurata cerca di vagliare la tradizione, tentando di individuare un nucleo di elementi solidi, una conservatrice segue, invece, molto da vicino la narrazione annalistica. Ci sono effettivamente tantissimi aspetti del periodo in cui visse Spurio Cassio che si prestano facil-mente ad una attualizzazione: il problema dei socii (si veda ad esempio la figura di Marco Livio Druso), la distribuzione delle terre (centrali a tale proposito due personaggi simbolo come Tiberio e Caio Gracco), l’accusa di aspirare al regno (significative in questo senso appaiono le ambizioni dei triumviri e i poteri ecce-zionali di cui erano dotati), il ripetersi di consecrationes honorum, infine le crisi annonarie. Per tutti questi motivi il personaggio Spurio Cassio diventa un facile terreno di narrazione amplificata.
La caduta della monarchia, variamente interpretata e cronologicamente e po-liticamente, sfocia, come primo risultato, in un conflitto interno che, tra alter-ne vicende, porta alla formazione di quella nobilitas patrizio-plebea destinata a reggere le sorti di Roma fino alle guerre civili. Gli storici antichi, alla luce di situazioni contingenti e di esperienze contemporanee, o secondo un’ottica di par-zialità, riducono il contrasto in termini di una mera contrapposizione tra patrizi e plebei, ignorando la realtà politico-sociale in cui il fenomeno si inquadra e a cui si rivolgono ora, soprattutto, gli studi più recenti. I rapporti dello stato romano col mondo esterno presentano, poi, a quell’epoca, essenzialmente due aspetti: uno è rappresentato dai continui conflitti con i popoli confinanti, che l’antica annalisti-ca riferisce con monotona insistenza, indugiando in una serie di resoconti tutti uguali e tutti improntati a spirito di parte, nel tentativo di dimostrare che i Romani combattevano solo per difendersi; l’altro è quello, ben più fecondo, dei contatti commerciali e culturali con l’Etruria, la Magna Grecia e con gli stessi Latini, in un arricchimento culturale pieno di sviluppi per il futuro di Roma, documentato in particolare dai resti archeologici.
Lo stato romano del V secolo a.C. presenta tuttavia una contraddizione di
Uomini e gentes nella prima metà del V secolo a.C.: Spurio Cassio 31
fondo: da una parte l’organizzazione statale sembra tendere al superamento degli antichi privilegi gentilizi, dall’altra resta come elemento costante la supremazia delle gentes che gestiscono, con alterni mezzi e fortune, il potere.
Spurio Cassio è l’unico personaggio della gens Cassia ad apparire nei Fasti del V secolo a.C.; a lui la tradizione attribuisce la ratifica del foedus Cassianum tra Roma e i Latini 2, la promulgazione di una legge agraria a favore della plebe (che gli valse l’accusa di adfectatio regni, aspirazione al regno, e la conseguen-te condanna a morte 3) e la dedica del tempio plebeo di Cerere, Libero e Libera sull’Aventino 4.
A proposito del foedus Cassianum, è abbastanza improbabile che, successiva-mente ad esso e sulla base di questo, si sia verificata «una reciproca ammissione di Romani e Latini (e successivamente degli Ernici) ai diritti politici delle varie città della lega: condizione per l’ammissione ai comizi romani dei Latini e degli Ernici, secondo il racconto di Dionigi. Ma l’equivoco con ogni probabilità, deriva dalla stessa terminologia dello storico greco che, a definire il rapporto intercor-rente tra questi vari soggetti, impiega il termine greco di isopoliteia. Ora il punto centrale è che tale termine, proprio in Dionigi, oltre che in altri autori coevi, tende ad assumere il valore di ‘piena cittadinanza politica’: quello espresso a rigore con politeia» 5. Un valore che Capogrossi Colognesi tenderebbe ad escludere, ritenendo che, nella Roma arcaica, questo termine voglia indicare un meccanismo di reciproco “riconoscimento” del cittadino straniero nell’ambito esclusivo del diritto privato (quello del commercium e del conubium). Quella che compare in Dionigi risulterebbe, quindi, una impropria semplificazione dei complessi rap-porti tra Romani e Latini che rischia di compromettere la corretta comprensione
2 g. FoRsyThE, A Critical History of Early Rome. From Prehistory to the First Punic War, Berkeley 2005; J. RussEll, R. Cohn, Foedus Cassianum, Edimburgh 2012. Cfr. l. CAPogRossI ColognEsI, Storia di Roma tra diritto e potere, Bologna 2014, p. 68.
3 E. gAbbA, Dionigi di Alicarnasso sul processo di Spurio Cassio, in Roma arcaica. Storia e storiografia, Roma 2000, p. 141. h.I. FlowER, The Art of Forgetting: Disgrace and Oblivion in Roman Political Culture, Chapel Hill, NC, 2006; CAPogRossI ColognEsI, Storia di Roma, cit., pp. 74-75.
4 Sulla figura di Spurio Cassio cfr. in particolare: gAbbA, Dionigi d’Alicarnasso, cit., p. 143; A. MoMIglIAno, Due punti di storia romana arcaica, in Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, Roma 1969, pp. 329-361; o. DE CAzEnovE, Spurius Cassius, Cérès et Tellus, «REL», 67, 1989, pp. 93-116; cfr. A. CARAnDInI, La villa dell’Auditorium interpretata, in A. CARAnDInI, M.T. D’AlEssIo, h. DI gIusEPPE (a cura di), La fattoria e la villa dell’Auditorium, Roma 2006, p. 586; A. AMoRoso, Il tempio di Tellus e il quartiere della praefectura urbana, in Workshop di archeologia classica. Paesaggi, costruzioni, reperti, Pisa 4, 2007, pp. 53-84.
5 l. CAPogRossI ColognEsI, Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della ‘civitas Romana’, Roma 2000, pp. 192-193.
32 MARIA FEDERICA PETRACCIA
degli articolati meccanismi che ruotarono attorno a una questione spinosa come quella delle contese per le terre pubbliche di Roma 6.
Stando alla narrazione liviana, comunque, Spurio Cassio risulta avere rive-stito il primo consolato nel 502 a.C. insieme a Opitere Verginio 7. La sua prima impresa fu l’assedio e la presa di Pomezia, colonia latina passata agli Aurunci 8. Il testo presenta qualche difficoltà di interpretazione, poiché da un passo sembre-rebbe che Pomezia, insieme a Cora, fosse stata conquistata l’anno prima dai due consoli precedenti 9: Menenio Agrippa e P. Postumio, mentre da un passo succes-sivo risulterebbe che Pomezia fosse stata lasciata in stato d’assedio 10. Le incertez-ze relative a questo episodio sembrano riflettersi anche nella notizia, che alcuni autori riportano, secondo la quale uno dei due consoli, non si sa quale, sarebbe rimasto gravemente ferito nell’assedio e, perciò, riportato in città 11. Al seguito del console, si sarebbe ritirato anche l’esercito 12. L’assedio sarebbe ripreso non molto tempo dopo e si sarebbe concluso con la resa degli Aurunci. Sarebbe seguito poi un massacro con conseguente vendita di schiavi e di territorio. Quindi i consoli avrebbero celebrato il trionfo 13.
La versione di Dionigi non riporta la battaglia contro Pomezia e assegna invece ai consoli Cassio e Verginio la guerra contro i Sabini 14. Cassio avrebbe combattuto e vinto nei pressi di Cures costringendo i Sabini ad inviare i loro am-basciatori per trattare la pace col console il quale, a sua volta, li avrebbe rimandati al Senato dove avrebbero ottenuto la conclusione della guerra seppur costretti a consegnare tanto grano quanto Cassio aveva ordinato, una certa somma di denaro a testa e 10.000 plettri di terreno coltivato 15. Fatta la pace con i Sabini, quindi, Cassio poté celebrare il trionfo 16.
Sempre secondo Dionigi, in quegli stessi frangenti, l’altro console si sarebbe
6 CAPogRossI ColognEsI, Cittadini e territorio, cit., p. 193.7 lIv. II, 17, 1.8 lIv. II, 16, 8.9 lIv. II, 16, 9.10 lIv. II, 17, 1; cfr. A. CARAnDInI, Res publica. Come Bruto cacciò l’ultimo re di Roma,
Milano 2011, p. 121.11 lIv. II, 17, 3.12 lIv. II, 17, 4.13 lIv. II, 17, 7; cfr. I. DEllA PoRTEllA (a cura di), Via Appia antica, San Giovanni Lupatoto
(VR) 2003, p. 106.14 DIon. hAl. V, 49, 1. Per le altre fonti sul consolato del 502 a.C. cfr. A. DEgRAssI, I.It.
XIII, 1, p. 350; T.R.s. bRoughTon, The magistrates of the Roman republic I, 509 B.C. 100 B.C., New York 1951, p. 8.
15 DIon. hAl. V, 49, 2. E. gAbbA, Studi su Dionigi d’Alicarnasso. III: la proposta di legge agraria di Spurio Cassio, in Roma arcaica. Storia e storiografia, Roma 2000, p. 129.
16 DIon. hAl. V, 49, 3; cfr. vAl. MAx. VI, 3, 1; zonAR. VII, 13; A. DEgRAssI, I.It., XIII, 1, p. 536.
Uomini e gentes nella prima metà del V secolo a.C.: Spurio Cassio 33
diretto verso la città di Cameria, che aveva defezionato dall’alleanza con i Ro-mani. Giunto presso le mura, avrebbe posto l’assedio, usando ogni mezzo a sua disposizione e, approfittando della confusione e dello scompiglio dei Camerini, si sarebbe impadronito della città, saccheggiandola, dopo avere mandato a morte gli ispiratori della rivolta e avere reso schiavi i superstiti 17.
Come si può vedere, dunque, Livio e Dionigi danno dei resoconti comple-tamente differenti del primo consolato di Spurio Cassio. I due autori attinsero quindi da fonti diverse; l’episodio dell’assedio di Pomezia, riportato da Livio, sembra ricalcare esattamente quello dell’assedio di Cameria da parte di Verginio: entrambi gli episodi mettono in rilievo i mezzi usati per l’assedio, in entrambi vi è il massacro degli ispiratori della rivolta, la vendita dei prigionieri come schiavi ed il saccheggio della città.
Dionigi afferma che celebrò il trionfo il solo Cassio, mentre Livio dice che lo fecero entrambi i consoli. L’episodio, riportato da Dionigi, in cui Cassio riman-dava gli ambasciatori sabini al Senato, sembra ricalcare invece quello analogo, relativo al suo terzo consolato, in cui lo stesso Cassio rimandò gli ambasciatori degli Ernici all’illustre consesso 18.
L’anno seguente il primo consolato di Spurio Cassio, furono eletti consoli Postumio Comino e Tito Larcio 19. Stando alla narrazione liviana, dopo un pic-colo incidente tra Romani e giovani Sabini, O. Mamilio istigò trenta città latine a riunirsi in una lega 20. Si aprì così una zona “calda” a sud dell’Etruria e i Latini rivendicarono la loro autonomia rispetto a Roma 21.
Nell’Urbe si decise allora di creare un dittatore 22. Livio riporta chiaramente che le sue fonti non sanno indicare con certezza chi fosse allora stato creato dit-tatore per la prima volta, anche perché non si conosceva quali tra gli ex consoli fossero di parte tarquiniana 23. Gli storici più antichi ricordavano, in effetti, come dictator Tito Larcio e come magister equitum lo stesso Spurio Cassio 24; altre fonti riportavano invece come dictator M. Valerio 25. Al di là dei dubbi sul nome del dictator, comunque, Spurio Cassio divenne sicuramente magister equitum 26.
17 DIon. hAl. V, 39, 3-5.18 DIon. hAl. VIII, 68, 3. Cfr. l. AIgnER FoREsTI, Il federalismo nell’Italia antica (fino
all’89 a.C.), in g. zECChInI (a cura di), Il federalismo nel mondo antico, Milano 2005, p. 91.19 lIv. II, 18, 1; DIon. hAl. V, 50, 1; A. DEgRAssI, I.It., XIII, 1, p. 350; bRoughTon, The
magistrates, cit., p. 9.20 CAPogRossI ColognEsI, Cittadini e territorio, cit., p. 73.21 lIv. II, 18, 2-3. Cfr. M. PAlloTTIno, Etruscologia, Milano 1984, p. 173.22 lIv. II, 18, 4.23 lIv. II, 18, 4.24 lIv. II, 18, 5. CARAnDInI, Res publica, cit., p. 136.25 lIv. II, 18, 6.26 F. MoRA, Fasti e schemi cronologici. La riorganizzazione annalistica del passato remoto
romano, Stuttgart 1999, p. 157.
34 MARIA FEDERICA PETRACCIA
I Sabini, quindi, appresa la notizia della creazione di un dittatore, mandarono ambasciatori per stipulare la pace e chiedere perdono per i loro giovani, rei di avere rapito delle meretrici. Il Senato rispose che si poteva perdonare ai giovani, ma non ai vecchi, con evidente allusione alla lega delle trenta città, e impose quindi ai Sabini di pagare le spese sostenute per la guerra 27. Costoro si rifiutarono e quindi scoppiò il conflitto.
Dionigi, nel 501 a.C., l’anno consolare di Postumio Cominio Aurunco e Tito Larcio Rufo 28, ricorda la riunione delle città latine sotto la guida di O. Mamilio, ma non parla della dittatura 29. Egli colloca quest’ultima al tempo del consolato di Quinto Clelio e Tito Larcio (498 a.C.) e ne attribuisce la causa più a problemi di politica interna che a problemi di politica estera 30. Secondo Dionigi poi, Tito Larcio fu nominato dictator e Spurio Cassio magister equitum 31 e si stipulò una tregua di un anno con i Latini 32. È evidente anche per questo episodio l’estrema confusione tra le varie fonti a disposizione di Livio e di Dionigi: entrambi at-tribuiscono la prima dittatura a Tito Larcio, ma la collocano in un diverso anno consolare; Livio, inoltre, per il consolato di Tito Larcio e di Quinto Clelio non ricorda alcun fatto 33.
Le discrepanze, comunque, non si esauriscono qui. La tradizione liviana ri-porta, infatti, che la battaglia del lago Regillo avvenne durante il consolato di T. Ebuzio e C. Veturio (499 a.C.) 34 e fu combattuta dal dictator A. Postumio e dal magister equitum T. Ebuzio 35, mentre Dionigi la attribuisce al consolato di A. Postumio e al magister equitum T. Ebuzio 36, e racconta di un intervento di Spu-rio Cassio all’assemblea che doveva decidere l’atteggiamento da assumere nei confronti dei Latini dopo la battaglia stessa 37. Sempre stando a Dionigi, Cassio propose di abbattere le loro città, annettere il territorio e dare la cittadinanza solo
27 lIv. II, 18, 9-11.28 DIon. hAl. V, 50, 1. C. AMPolo, Roma arcaica fra Latini ed Etruschi: aspetti politici e
sociali, in M. CRIsToFAnI (a cura di), Etruria e Lazio arcaico. Atti dell’incontro di studio (10-11 novembre 1986), Roma 1987, p. 122.
29 CARAnDInI, Res publica, cit., p. 103.30 gAbbA, Studi su Dionigi d’Alicarnasso. III, cit., p 136.31 DIon. hAl. V, 72-75.32 DIon. hAl. V, 76, 4.33 lIv. II, 21, 1.34 lIv. II, 19, 1. Cfr. M. soRDI, La leggenda dei Dioscuri nella battaglia della Sagra e del
lago Regillo, in CISA I, 1972, pp. 47-70; AIgnER FoREsTI, Il federalismo nell’Italia antica, cit., p. 90; g. uRso, Cassio Dione e i magistrati. Le origini della repubblica nei frammenti della Storia romana, Milano 2005, p. 46 e n. 22.
35 lIv. II, 19, 3.36 DIon. hAl. VI, 2, 1-3.37 DIon. hAl. VI, 20, 2-5.
Uomini e gentes nella prima metà del V secolo a.C.: Spurio Cassio 35
a quelli che avessero mostrato qualche benevolenza verso i Romani. Questo pas-so, che mal si accorda con la successiva linea politica adottata dal console, pare risentire dell’influsso di una propaganda a lui ostile e mira a dimostrare che la benevolenza che egli mostrò verso i Latini durante il secondo e il terzo consolato (con il foedus Cassianum e la rogatio agraria) fu solo un mezzo per arrivare al potere 38.
È interessante riferire di un passo di Livio 39 per appurare come già presso gli antichi ci fosse una estrema confusione circa la data della battaglia del Regillo e di conseguenza circa il nome del primo dittatore e del suo maestro di cavalleria, in quanto tali figure sono strettamente collegate proprio con la vicenda della bat-taglia avvenuta nei dintorni del lago 40.
Nel 493 a.C. Spurio Cassio fu nominato nuovamente console e suo collega fu Postumio Cominio 41. È da notare innanzitutto che Cassio fu eletto in un momento di particolare tensione interna. Subito dopo la battaglia del Regillo, infatti, ci furono diversi rifiuti della plebe a rispondere alla leva (rifiuti poi rientrati dopo lunghi patteggiamenti) ed era in corso allora la secessione sul monte Sacro 42. L’elezione quindi di Spurio Cassio, personaggio che mantenne sempre una certa linea politica filo-plebea, non fu forse casuale. A sostegno di questa ipotesi si potrebbe riportare anche il fatto che lo stesso Postumio Cominio era già stato col-lega di quel Tito Larcio, di cui le fonti sottolineano spesso l’atteggiamento filo-popolare 43, e di cui Cassio era stato magister equitum. Durante questo secondo consolato di Cassio fu stipulato proprio il patto con i Latini 44.
Livio precisa che esso fu siglato dal solo Cassio 45; infatti i due consoli si era-no divisi i compiti: Postumio Cominio era andato in guerra contro i Volsci e aveva
38 Cfr. gAbbA, Studi su Dionigi d’Alicarnasso. III, cit., p. 141.39 lIv. II, 21, 2-4.40 La combinazione delle fonti può indurre a credere che il primo dittatore fosse T. Larcio,
collega di Q. Clelio; tenendo ferma la data del foedus Cassianum (493 a.C.) e accettando la data proposta da Livio per la battaglia del lago Regillo (499 a.C.), si avrebbe il seguente schema:
– Battaglia del Regillo (499 a.C.)– T. Larcio primo dittatore (498 a.C.)– foedus Cassianum (493 a.C.).
Il periodo tra la battaglia e il foedus sarebbe quindi servito come una specie di banco di prova per una futura alleanza con i Latini e si sarebbero subito introdotte le magistrature federali per rendere questo vincolo più solido; in quegli anni i rapporti con i Latini furono, infatti, molto buoni: lIv. II, 22, 5; DIon. hAl. VI, 25, 4.
41 lIv. II, 33, 3; DIon. hAl. VI, 49, 1; cfr. A. DEgRAssI, I.It., XIII, 1, p. 352; bRoughTon, The magistrates, cit., p. 15.
42 Cfr. lIv. II, 24, 2; 27, 10; DIon. hAl. VI, 23, 2; 27, 2; 34, 2.43 Cfr. lIv. II, 29, 8; DIon. hAl. VI, 19, 1-4; 35, 1-2; 36, 1-3, 81, 2-4.44 CIC. balb., 23, 53; lIv. II, 33, 4; DIon. hAl. VI, 95, 2.45 lIv. II, 33, 9.
36 MARIA FEDERICA PETRACCIA
conquistato Longula, Polusca e Corioli 46, mentre Cassio era restato a Roma a pre-parare il foedus 47che implicava un sostanziale equilibrio tra Romani e Latini, che ben corrispondeva all’entità delle rispettive forze. Infine, sempre per iniziativa di Cassio, fu consacrato un tempio a Cerere, Libero e Libera 48.
Cassio, quindi, ricoprì per la terza volta il consolato nel 486 a.C. ed ebbe come collega Proculo Verginio 49. Sempre secondo la narrazione liviana, in que-sto anno fu concluso un patto con gli Ernici, che erano stati sconfitti dal console precedente, C. Aquilio, e che si videro sottrarre i due terzi del loro territorio 50. Spurio Cassio inoltre si fece promotore di una rogatio agraria in base alla quale si sarebbe dovuto dividere il suddetto territorio in parti uguali tra plebei e Latini; ad esso, poi, si sarebbe dovuta aggiungere anche una parte dell’ager publicus che si lamentava fosse posseduto da privati 51. L’iniziativa preoccupò il patriziato, sia per i suoi risvolti economici che politici, a tal punto da poter essere considerata il momento iniziale della crisi patrizio-plebea del V secolo a.C. 52. Alla proposta di Cassio si opposero l’altro console e buona parte della plebe, che non vedeva di buon occhio la spartizione delle terre con i Latini. Gli antichi sembrano concordi nel far risalire alla proposta di Spurio Cassio il momento iniziale ed acutissimo della crisi intorno all’ager publicus. La rogatio agraria resta un punto centrale nella oscura storia romana del V secolo a.C. e la vicenda di Cassio esprime in modo esemplare tutto il contenuto della lotta plebea per il possesso del territorio di proprietà dello stato, svoltasi all’interno di quel secolo 53. Il contenzioso tra patrizi e plebei in quel periodo appare ricondotto alla esclusione, di fatto più
46 lIv. II, 33, 4-5; DIon. hAl. VI, 91-92.47 lIv. II, 33, 4; DIon. hAl. VI, 91, 1.48 DIon. hAl. VI, 94, 3.49 lIv. II, 41, 1; DIon. hAl. VIII, 68, 1; cfr. A. DEgRAssI, I.It., XIII, 1, p. 354; bRoughTon,
The magistrates, cit., p. 20. La storiografia ha assunto posizioni diverse e articolate sui fatti del 486 a.C. e sulla stessa figura di Spurio Cassio, fino addirittura a negarne l’esistenza: A. MAnzo, La lex Licinia Sextia de modo agrorum: lotte e leggi agrarie tra il V e il IV secolo a. C., Napoli 2001, p. 53.
50 lIv. II, 40, 14. Cfr. g. FIRPo, Spurio Cassio e il «foedus Hernicum», «RIL», 135, 1, 2001, pp. 141-161. Riflessione critica sulla cronologia tradizionale (486 a.C.) del foedus Hernicum, sulle sue relazioni con il foedus Cassianum e sulle fonti storiche antiche a riguardo. Si propone una datazione del foedus Hernicum coincidente (o immediatamente posteriore) a quella del foedus Cassianum (493 a.C.). Il fatto che Livio e Dionigi di Alicarnasso collochino il foedus Hernicum durante l’ultimo consolato di Spurio Cassio (486 a.C.) ha il fine ideologico di utilizzare l’evento per illustrare la parabola involutiva del personaggio.
51 lIv. II, 41, 2. F. D’IPPolITo, La legge agraria di Spurio Cassio, «Labeo», 21, 1975, p. 198; F. sERRAo, Diritto privato, economia e società nella storia di Roma, Napoli 1999, p. 300. Cfr. A.M. bIRAsChI, L’uso dei documenti nella storiografia antica, Napoli 2003, p. 534.
52 lIv. II, 41, 2. Cfr. A. zIolkowskI, Storia di Roma, Milano 2000, p. 75.53 CAPogRossI ColognEsI, Storia di Roma, cit., p. 71 e n. 3.
Uomini e gentes nella prima metà del V secolo a.C.: Spurio Cassio 37
che di diritto, della plebe dalle terre pubbliche, come “consuetudinario divieto normativo” 54. Facevano presa sulla plebe anche le oscure previsioni di Verginio, secondo cui quel dono avrebbe avuto la conseguenza di restaurare la monarchia 55. In questo clima teso di scontri, i due consoli fecero a gara per accattivarsi il fa-vore della plebe; Verginio si dichiarò pronto ad aderire alle proposte di Cassio, a patto di escludere i Latini dalla donazione mentre Cassio propose di restituire al popolo il denaro ricavato dalla vendita del grano siciliano 56, denaro che la plebe rifiutò. Deposta la carica, Cassio fu quindi accusato di alto tradimento, condanna-to e ucciso 57... così narra Livio.
Più complesso, invece, è il racconto di Dionigi. Secondo quest’ultimo, Spurio Cassio sconfisse sia i Volsci sia gli Ernici. I Volsci si sottomisero subito mentre gli Ernici mandarono ambasciatori a trattare. Cassio impose quindi loro di conse-gnare viveri e denaro per poter trattare la pace e fissò un certo numero di giorni entro i quali dovevano essere soddisfatte le richieste. Gli Ernici consegnarono tutto in breve tempo e Cassio li inviò al Senato che stabilì di stipulare un patto di amicizia, incaricando lo stesso Cassio di fissarne i termini che sarebbero stati ratificati in seguito 58.
Dionigi riporta inoltre una serie di notizie che introducono il tema della pro-posta agraria e che tendono a porre in cattiva luce Cassio. Questi infatti avrebbe celebrato un trionfo ottenuto solo per mezzo di amici compiacenti, non avrebbe contraccambiato gli onori ricevuti dal Senato e addirittura avrebbe presentato un trattato con gli Ernici uguale a quello stipulato con i Latini. Avrebbe poi distribu-ito l’ager publicus in possesso dei ricchi tra la plebe e incluso nella ripartizione anche i Latini e gli Ernici. Dionigi spiega tali iniziative come dovute all’aspi-razione di Spurio Cassio di diventare re 59 e, a conferma di ciò, riporta anche un altro episodio secondo il quale, il giorno seguente il suo trionfo, Cassio avrebbe convocato un’assemblea pubblica nella quale, dopo aver enumerato i propri me-riti, avrebbe dichiarato di agire per il bene del popolo, al quale avrebbe chiesto di riporre in lui la massima fiducia. In Senato, il giorno successivo, avrebbe illustra-to la sua proposta di divisione dell’ager publicus e di restituzione ai poveri del
54 A. buRDEsE, Le vicende delle forme di appartenenza e sfruttamento della terra nelle loro implicazioni politiche fra IV e III secolo a.C., «BIDR», 88, 1985, p. 54; CAPogRossI ColognEsI, Cittadini e territorio, cit., p. 299.
55 lIv. II, 41, 4-6. E. CAnTAREllA, I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma, Milano 2011, p. 64.
56 Cfr. lIv. II, 34, 7-12.57 lIv. II, 41, 7-10.58 DIon. hAl. VIII, 68.59 DIon. hAl. VIII, 69. E. gAbbA, Dionigi e la storia di Roma arcaica, Bari 1996, p. 162.
38 MARIA FEDERICA PETRACCIA
denaro speso per il grano, che era stato inviato da Gerone tiranno di Siracusa 60.La disputa tra i due consoli si sarebbe protratta per qualche giorno. Contro
Cassio si sarebbero schierati anche i tribuni 61tanto che non si riuscì a trovare l’accordo, in particolare sull’inclusione dei Latini e degli Ernici nella spartizione dell’ager publicus 62. Un tribuno, C. Rabuleio, suggerì di approvare la proposta di dividere l’ager tra la plebe romana e di rimandare la questione di farne partecipi anche i Latini e gli Ernici. Cassio fece allora pervenire in città quanti più Latini ed Ernici fosse possibile, mentre Verginio cercò di far allontanare con un proclama i non residenti 63. Dopo un discorso di Appio Claudio che si oppose fortemente a Cassio 64, prese la parola A. Sempronio Atratino 65, che avanzò la proposta, subito approvata, di eleggere dei decemviri per fissare i confini della terra pubblica e stabilire quale parte si dovesse affittare e quale parte dividere tra il popolo. Si stabilì inoltre che i forestieri con cittadinanza e gli alleati potessero partecipare alla spartizione, in caso di territori conquistati in guerra assieme ai Romani. Tali operazioni furono demandate ai consoli successivi, poiché stava per scadere il mandato dei consoli in carica 66.
Come si può notare, quindi, vi sono alcune significative differenze anche tra questi due brani nei quali gli autori dimostrano di dissentire sulla natura stessa del patto con gli Ernici 67. Livio, pur non qualificandolo esplicitamente, sembra pensare ad un foedus iniquum, in quanto gli Ernici persero i due terzi del loro territorio 68. Dionigi, invece, parla semplicemente di un foedus simile a quello stipulato con i Latini 69.
Un’altra fondamentale differenza, poi, è quella che riguarda la rogatio agra-ria: secondo Livio, Spurio Cassio propose di dividere soprattutto il territorio er-nico e una parte dell’ager publicus, mentre Dionigi narra che la proposta del console era di dividere l’ager publicus tra la plebe romana, i Latini e gli Ernici.
A parte poi l’episodio della restituzione alla plebe del denaro pagato per il
60 DIon. hAl. VIII, 70.61 DIon. hAl. VIII, 71, 4.62 DIon. hAl. VIII, 71.63 DIon. hAl. VIII, 72.64 DIon. hAl. VIII, 73, 5. Cfr. l. PEREllI, Questioni graccane, «RFIC», 118, 1990, pp. 237-252.65 DIon. hAl. VIII, 74-75.66 DIon. hAl. VIII, 76.67 lIv. VI, 2, 2-3.68 FIRPo, Spurio Cassio, cit., pp. 141-161: Firpo propone una datazione del foedus Hernicum
coincidente, o immediatamente posteriore, con quella del foedus Latinum (493 a.C.). Il fatto che Livio e Dionigi collochino il foedus Hernicum durante l’ultimo consolato di Spurio Cassio (486 a.C.) ha il fine ideologico di utilizzare l’evento per illustrare la parabola involutiva del personaggio.
69 DIon. hAl. VIII, 69, 2. Cfr. D. CAPAnnEllI, Appunti sulla rogatio agraria di Spurio Cassio, in Legge e società nella repubblica romana, Napoli, 1981, pp. 16-32.
Uomini e gentes nella prima metà del V secolo a.C.: Spurio Cassio 39
grano siciliano, che si ritrova sia in Livio sia in Dionigi, quest’ultimo autore ri-porta anche una serie di notizie che non si ritrovano in Livio e che probabilmente sono modellate su racconti o esempi più recenti. In generale si può affermare che Dionigi sembra dipendere soprattutto da fonti contrarie a Spurio Cassio 70: attribu-isce infatti la rogatio al suo desiderio di diventare tiranno, mentre in Livio il tono è più pacato e vi è solo un breve cenno all’aspirazione alla tirannide 71. Si possono riscontrare inoltre in Dionigi varie incongruenze circa la posizione giuridica dei Latini e circa la definizione delle terre che Cassio voleva distribuire.
È necessario ricordare, infine, che, a parere di Cicerone, Cassio, console nel 486 a.C., aveva pensato a delle misure per la distribuzione della terra e del grano (tra cui delle concessioni ai Latini e agli Ernici) così radicali da essere sospettato di aspirare alla tirannide. Perciò vennero frapposti ostacoli alle sue proposte e l’anno successivo, stando a quanto narrato sia da Livio sia da Valerio Massimo, egli fu condannato e giustiziato da suo padre nell’ambito dell’esercizio della giu-stizia domestica 72. Dionigi, ancora una volta discordante, narra invece che nel 485 a.C. l’ex console sarebbe stato gettato dalla rupe Tarpea, secondo una delle forme di esecuzione pubblica riservata ai traditori, dai questori Cesone Fabio e Lucio Valerio che lo accusarono di ambire alla monarchia 73.
A prescindere dal fatto che la versione della esecuzione domestica è più an-tica e attendibile, l’esistenza delle due diverse tradizioni non può sorprendere: per un crimine pubblico come quello di cui era accusato Spurio Cassio, il potere paterno concorreva infatti con quello dello stato e la punizione del reo poteva es-sere sia privata sia pubblica. La tradizione raccolta da Livio, da Valerio Massimo e confermata da Plinio il Vecchio ci consente di conoscere la sorte riservata ai traditori quando la loro condanna veniva pronunciata in casa 74. L’esecuzione di Cassio appare dunque come una forma normale e quasi scontata della esecuzione domestica, decisa dal padre nella totale autonomia che il più antico diritto gli riconosceva: i giudizi domestici, infatti, erano sottratti al controllo pubblico 75.
Livio e Dionigi, quindi, presentano due differenti versioni anche circa il pro-cesso e la condanna a morte di Spurio Cassio. Secondo la prima, Spurio Cassio, nell’anno successivo al suo terzo consolato, fu accusato dai questori K. Fabio e
70 Cfr. A. boTTIglIERI, La storiografia anticassiana e la vicenda di Spurio Cassio, in Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana, Napoli 3, 1995, pp. 255-265.
71 lIv. II, 41, 5. Cfr. M. bAsIlE, Analisi e valore della tradizione sulla rogatio Cassia agraria del 486 a.C., «MGR», 6, 1978, p. 282.
72 lIv. II, 41; cfr. CIC. rep. II, 60.73 DIon. hAl. IX, 69-80.74 lIv. II, 41,10; vAl. MAx. V, 8, 2; PlIn. nat. XXXIV, 15.75 CAnTAREllA, I supplizi capitali, cit., p. 66.
40 MARIA FEDERICA PETRACCIA
L. Valerio di avere aspirato alla tirannide e, per questo, fu condannato e ucciso 76. Secondo l’altra versione, fu invece il padre di Cassio a scoprire il desiderio del figlio di instaurare la tirannide e a denunciarlo al Senato che lo condannò, mentre al padre spettò il compito ingrato di ucciderlo in base al suo ius vitae et necis. I suoi beni poi furono confiscati, la sua casa distrutta 77 e coi proventi si costruirono varie statue tra cui una dedicata a Cerere 78. Dionigi però dimostra di non credere a questa versione, poiché ritiene che se fosse stato il padre l’accusatore di Cassio, difficilmente poi lo stato ne avrebbe confiscato i beni 79. Livio aggiunge un dato importante alla questione e cioè che fu lo stesso padre di Cassio a consacrare i beni del figlio e che la statua a Cerere portava per questo l’iscrizione: ex Cassia familia datum 80.
Dionigi, quindi, non parla di distruzione della casa e di confisca dei beni, mentre Livio narra che dopo il processo fu abbattuta la dimora di Cassio; Dionigi attribuisce al padre l’accusa contro Cassio e la sua uccisione, ma afferma anche che la condanna fu decretata dal Senato, consesso davanti al quale si svolse il pro-cesso, mentre Livio sostiene che fu il padre ad accusare e a giustiziare Cassio e che il processo si svolse in casa sua. Il Patavino inoltre non ricollega direttamente il processo con la rogatio agraria, mentre Dionigi, nella versione in cui Cassio fu condannato dai questori, la menziona.
Le testimonianze fornite dalle altre fonti non fanno altro che complicare il problema, in quanto presentano diverse varianti. Cicerone, per esempio, dopo aver posto a confronto Spurio Cassio con Manlio Capitolino in quanto accumu-nati dal desiderio di aspirare alla tirannide 81, narra che Cassio fu accusato da un questore di voler ripristinare la monarchia e, dopo essere stato riconosciuto colpevole dal padre, fu condannato a morte. Il grande oratore sottolinea la doci-lità plebea, quando la plebe permise al padre di Spurio Cassio di ucciderlo, col pretesto che il figlio avesse cercato di instaurare la tirannide, nonostante fosse amato dal popolo 82.
76 lIv. II, 41, 11; DIon. hAl. VIII, 77-78. Cfr. sERRAo, Diritto privato, cit., p. 300.77 La demolizione delle case dei cittadini accusati di perduellio è un procedimento comune
nell’antica Roma. Capitò anche a Cicerone, il quale (dom. XXXVIII, 101) elenca altri personaggi che subirono queste misure punitive, tra cui Spurio Cassio.
78 DIon. hAl. VIII, 79, 1-3.79 DIon. hAl. VIII, 79, 4.80 lIv. II, 41, 10.81 CIC. rep., II, 49. CIC. rep., II, 49. Cfr. R. sCEvolA, L’adfectatio regni di M. Capitolino:
eliminazione sine iudicio o persecuzione criminale?, in L. gARoFAlo (a cura di), Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica, Napoli 2013, pp. 275-344.
82 CIC. rep. II, 60; cfr. A.w. lInToTT, La violenza nella lotta degli ordini, in Terror et pavor. Violenza, intimidazione, clandestinità nel mondo antico. Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 22-24 settembre 2005, Pisa 2006, pp. 14-16.
Uomini e gentes nella prima metà del V secolo a.C.: Spurio Cassio 41
Diodoro rileva invece che, l’anno successivo al suo consolato, Spurio Cassio fu accusato di avere aspirato alla tirannide e, dopo essere stato riconosciuto col-pevole, fu messo a morte 83. Anche Plinio si sofferma due volte sull’argomento: dapprima riferisce che a Cerere fu eretta una statua di bronzo col patrimonio di Cassio, che fu ucciso dal padre per aver aspirato al regno 84; poi riporta una notizia di Calpurnio Pisone, secondo il quale nel 158 a.C. i censori M. Popilio e Cornelio Scipione distrussero la casa che Cassio, aspirando al regno, si era fatto costruire 85. Il sito quindi venne reimpiegato per edificare il tempio di Tellus 86, come religio-sae severitatis monumentum 87, il quale, però, venne votato dal console P. Sempro-nius Sophus soltanto nel 268 a.C. in occasione di una battaglia contro i Piceni 88.
Valerio Massimo poi racconta che Cassio, come tribuno della plebe, propose la legge agraria e godette di grande popolarità ed affetto 89; una volta uscito di carica, fu processato ed ucciso dal padre, che donò il suo patrimonio a Cerere. In un altro passo, lo scrittore ricorda i tre consolati e i due trionfi di Cassio e ag-giunge che egli fu condannato a morte per sospetto che ambisse al regno e che la sua casa fu distrutta 90. Floro parla invece della legge agraria, come un espediente escogitato da Spurio Cassio per ottenere il regno e ricorda il supplizio ricevuto da parte del padre 91. Cassio Dione allude, infine, ai grandi meriti di Spurio Cassio nei confronti dei Romani e dichiara che egli fu messo a morte per l’ingratitudine del popolo; aggiunge che egli non compì alcuna azione malvagia e che fu ucciso per invidia 92.
Si nota innanzitutto come ritorni in tutti gli autori (ad eccezione di Cassio Dione) il motivo dell’adfectatio regni. Solamente tre fonti riportano invece la notizia della rogatio agraria: due di queste accolgono la tradizione, che faceva del padre di Cassio il suo uccisore, tradizione ritenuta, sia da Livio sia da Dionigi, come meno credibile di quella del processo questorio 93.
83 DIoD. XI, 37, 7. Cfr. A. zIolkowskI, Storia di Roma, Roma 2006, p. 76.84 lIv. II, 41,10; DIon. hAl. VIII, 79, 3; vAl. MAx. V, 8, 2; PlIn. nat. XXXIV, 15 (tuttavia
v. PlIn. nat. XXX, per un racconto diverso, secondo il quale una statua di Cassio stesso in questo sito venne fusa dai censori del 158 a.C.). Cfr. gAbbA, Dionigi di Alicarnasso, cit., p. 143. lInToTT, La violenza, cit., p. 15.
85 PlIn. nat., XXXIV, 30.86 E. PAPI, ad v. Domus: L. Cassius Vicellinus, «ITVR», 2, 1995, p. 78.87 vAl. MAx. VI, 3, 1.88 FloR. I, 14 (19). Cfr. AMoRoso, il tempio di Tellus, cit., p. 55.89 vAl. MAx. V, 8, 2.90 vAl. MAx. VI, 1, 19.91 FloR. I, 17. Cfr. l. bEssonE, Spurio Cassio e Spurio Melio in Floro e in Ampelio, «RFIC»,
111, 1983, pp. 435-445.92 DIo CAss. V, fr. 19, 1. uRso, Cassio Dione, cit., p. 83.93 Ritengono più fondata la tradizione sul giudizio domestico: F. MünzER, Cassius, PW III,
2 (1899), coll. 1749-1753; g. DE sAnCTIs, Storia dei Romani. La conquista del primato in Italia,
42 MARIA FEDERICA PETRACCIA
Altro motivo ricorrente è quello della statua dedicata a Cerere, costruita, a seconda delle versioni, o con i beni confiscati a Cassio oppure dedicata dal padre. Forse, in tale tradizione, può essere intervenuta la confusione con la notizia della dedica del tempio a Cerere, fatta da Spurio Cassio durante il suo terzo consolato e riportata da Dionigi 94, oppure con l’episodio narrato da Pisone e riportato da Plinio 95. Diodoro riporta la notizia più scarna 96.
La testimonianza più fondata sembra comunque essere quella di Dionigi, se-condo cui Cassio fu accusato dai questori di aver proposto la rogatio e di aver aspi-rato al regno e per questa ragione messo a morte, omettendo ogni menzione del padre, della confisca delle sue sostanze e della consacrazione dei beni a Cerere 97.
Nella vicenda di Spurio Cassio, sembrano dunque avere notevole incidenza le fonti a lui contrarie, ma resta anche qualche traccia di tradizioni non ostili: Ci-cerone e Valerio Massimo infatti raccontano che, quando fu condannato, Cassio godeva di grande popolarità tra il popolo 98; Cassio Dione, poi, lo loda e ne fa un benefattore dei Romani 99.
Per concludere, si può senz’altro affermare che Spurio Cassio si presenta come uno dei personaggi di maggiore spicco di questo primo periodo repubbli-cano. Due sono i momenti della sua carriera, di fondamentale interesse: il patto con i Latini e la proposta agraria. Sulla prima questione non sembrano sussistere dubbi: il foedus fu stipulato da Cassio durante il suo secondo consolato 100. Sulla rogatio agraria c’è invece una grande disparità di opinioni, basata sulla constata-zione che il racconto ad essa relativo sembra essere ricalcato anacronisticamente sulle ben più attuali vicende dei Gracchi e che quindi può porsi come una traspo-
Milano-Torino-Roma, II, 1907, p. 11 n. 1; gAbbA, Dionigi d’Alicarnasso, cit.; A.w. lInToTT, The tradition of violence in the annals of the early roman Republic, «Historia», 19, 1970, pp. 18-26. Ritengono invece più fondata la tradizione sul giudizio pubblico: Th. MoMMsEn, Sp. Cassius M. Manlius, Sp. Maelius, die drei Demagogen der alteren republikanischen Zeit, in Römische Forschungen, Berlin 2, 1879, p. 175; sERRAo, Diritto privato, cit., p. 300.
94 DIon. hAl. VI, 94, 3.95 PlIn. nat., XXXIV, 30. Pisone ricorda che i censori del 158 a.C. fecero abbattere statue
erette senza l’approvazione del senato o del popolo, e che anche una di Spurio Cassio presso l’aedes Telluris fu fatta fondere. L’abbattimento della statua sembra spiegare il collegamento con la notizia dell’esistenza della casa, poi distrutta, di Spurio Cassio là dove era il tempio di Tellus o presso di esso: cfr. gAbbA, Dionigi di Alicarnasso, cit., p. 143.
96 Il De Sanctis (Storia, cit., p. 10) ritiene Diodoro la fonte più fededegna; il Fraccaro (La storia romana arcaica, Opuscola, 1, 1956, p. 16), ritiene che in Diodoro sia riportata la tradizione più antica.
97 DIon. hAl. VIII, 77, 1.98 CIC. rep., II, 60; vAl. MAx. V, 8, 2.99 DIo CAss. V, fr. 19, 1.100 lIv. II, 33, 9; DIon. hAl. VI, 95, 1. Sullo stato della questione cfr. E. FEREnCzy, Zum
Problem des foedus Cassianum, «Revue internationale des Droits de l’Antiquité», 22, 1975, pp. 223-232; RussEll - Cohn, Foedus Cassianum, cit.
Uomini e gentes nella prima metà del V secolo a.C.: Spurio Cassio 43
sizione in tempi remoti di avvenimenti molto più recenti 101. Mentre Livio fornisce un racconto piuttosto scarno della vicenda, Dionigi invece incorrerebbe proprio in tale anticipazione. In realtà, già nella prima età repubblicana esistevano condi-zioni politiche ed economiche tali da far sentire l’esigenza di una rogatio agra-ria; l’instabilità costituzionale e politica, l’annosa diatriba patrizio-plebea intorno all’ager publicus apertasi appunto con quella proposta di legge 102, le minacce esterne, la scarsità di cereali e le carestie, dovevano sicuramente indurre la plebe a battersi per potere ottenere terre da cui trarre il proprio sostentamento 103. Non stupisce, poi, che una tale iniziativa dovesse partire proprio da Spurio Cassio.
È innanzitutto da rilevare che Cassio aveva un nomen plebeo 104. Il suo cogno-men è attestato anche nella forma Vitellinus 105; si potrebbe quindi pensare ad una origine latina della gens Cassia, dalla città di Vitellia 106: ciò potrebbe spiegare la particolare linea politica, seguita dal console, mirante a rendere il più possibile pacifici ed amichevoli i rapporti con i Latini. Non è forse una coincidenza il fatto che Cassio, durante il suo secondo consolato, rimanesse a Roma per stipulare il foedus, mentre il suo collega portava guerra contro i Volsci 107. È lo stesso Dionigi a ricordare le amicizie di Cassio con esponenti latini 108.
101 DE sAnCTIs, Storia, cit., pp. 8-12; gAbbA, Studi su Dionigi d’Alicarnasso. III, cit., pp. 120-134; bAsIlE, Analisi, cit., p. 296. Si veda invece D. CAPAnEllI (Appunti sulla rogatio agraria di Spurio Cassio, in Legge e società nella repubblica romana, 1,1981, pp. 3-50), secondo il quale sarebbe da rigettare la tesi secondo la quale l’episodio di Spurio Cassio sarebbe la proiezione nel passato di avvenimenti di alcuni secoli posteriori.
102 buRDEsE, Le vicende, cit., pp. 48-52; l. CAPogRossI ColognEsI, Cittadini e territorio, cit., p. 298.
103 Cfr. D’IPPolITo, La legge agraria, cit., pp. 197-210; F. DE MARTIno, Storia economica di Roma antica, Firenze 1979, pp. 14-31; s. TonDo, Profilo di storia costituzionale romana, Milano 1981, pp. 177-180; F. sERRAo, Lotte per la terra e per la casa a Roma dal 485 al 441 a.C., in Legge e società nella repubblica romana, Napoli 1981, pp. 51-57. La storicità della rogatio cassiana era già stata difesa da b.g. nIEbuhR, Römische Geschichte, Berlin 2, 1830, p. 189. Sulla questione dell’ager publicus vd.: l. zAnCAn, Ager publicus. Ricerche di storia e di diritto romano, Padova 1935; F. bozzA, La possessio dell’ager publicus, Milano 1939; g. TIbIlETTI, Il possesso dell’ager publicus e le norme de modo agrorum sino ai Gracchi, «Athenaeum», 26, 1948, pp. 173-236; A. buRDEsE, Studi sull’ager publicus, Torino 1952; F. DE MARTIno, Storia della costituzione romana, I, Napoli, 1972, pp. 250-262; l. CAPogRossI ColognEsI, Alcuni problemi di storia romana arcaica: ager publicus, gentes e clienti, «Bollettino dell’Istituto di Diritto Romano», 83, 1980, pp. 29-65.
104 Cfr. s. MAzzARIno, Dalla monarchia allo stato repubblicano. Ricerche di storia romana arcaica, Milano 1945, p. 197; A. bERnARDI, Patrizi e plebei nella primitiva costituzione repubblicana, «RIL», 79, 1945-46, pp. 3-17; A. MoMIglIAno, L’ascesa della plebe nella storia arcaica di Roma, «Rivista Storica Italiana», 79, 1967, pp. 297-305; D’IPPolITo, La legge agraria, cit., p. 200.
105 Cfr. bRoughTon, The magistrates, cit., pp. 8, 15, 20.106 D’IPPolITo, La legge agraria, cit., p. 204.107 In questo senso anche D’IPPolITo, La legge agraria, cit., p. 204.108 DIon. hAl. VIII, 78, 3.
44 MARIA FEDERICA PETRACCIA
Egli fu inoltre eletto in uno dei momenti di maggior tensione tra patrizi e plebei e, come accennato, fu vicino a quel Tito Larcio, che le fonti indicano come favorevole alla plebe.
Inserendo la vicenda di Cassio nella lotta tra i gruppi dominanti dell’epoca, non si può fare a meno di notare come dopo il processo e la condanna del 486 a.C. i Cassi sparissero dai Fasti sino al 171 a.C., anno del consolato di C. Cassio Longino 109; contemporaneamente alla loro scomparsa dai Fasti, si rileva l’ascesa del gruppo dei Fabi, di cui faceva parte anche uno dei due accusatori di Cassio e che dominò, a quanto pare, la scena politica fino alla battaglia del Cremera, perseguendo scopi diametralmente opposti a quelli dei Cassi e radicalizzando lo scontro con i plebei. Secondo Livio, infatti: Haud diuturna ira populi in Cassium fuit 110. Non si può escludere che sia stata proprio l’influenza della gens Fabia a contribuire al formarsi di una tradizione fortemente contraria a Spurio Cassio.
Se la maggior parte delle fonti genericamente riportano l’accusa di adfectatio regni contro di lui, potrebbe essere questo soltanto un pretesto per coprire ben più gravi timori e reazioni da parte dei conservatori romani 111, i quali dovevano scorgere un pericolo soprattutto nella rogatio agraria. Tale proposta si inquadra nella politica di Cassio, la cui figura si presenta assai inusuale in questo primo scorcio della repubblica romana, in un periodo di aspre lotte tra patrizi e plebei. Spurio Cassio, nell’ambito della sua politica filo-latina, può dunque aver presen-tato una proposta agraria che includeva anche i Latini: la violenta opposizione di altri gruppi, tra cui soprattutto i Fabi e, insieme, la scarsa collaborazione dei plebei, che non capivano e non condividevano il suo piano, condannarono al fal-limento tale iniziativa. Tutte le narrazioni riguardanti Spurio Cassio miravano a
109 C. Cassio Longino fa la sua comparsa nel 178 a.C. e percorre un lunghissimo cursus di trentaquattro anni, rivestendo magistrature rilevanti tra cui la pretura nel 174 a.C., il consolato nel 171 a.C. e la censura nel 154 a.C. Quest’ultimo è un anno cruciale per la storia edilizia del teatro a Roma dato che C. Cassio Longino, assieme al collega nella censura M. Valerio Messalla, inizia sul Palatino la costruzione di un teatro lapideo, fatto quasi subito demolire dal Senato per volere del console P. Cornelio Scipione Nasica perché opera inutile e nociva per la moralità pubblica: lIv. per, 48; vAl. MAx. 2, 4, 2; vEll. 1, 15, 3; APP. bc, 1, 28, 125; oRos. 4, 21, 4; TERT. spect., 10, 3; apol., 6, 2; AugusTIn. cd, 1, 31. Cfr. da ultimi bRoughTon, The magistrates, cit., p. 416; g. TosI, l. bACCEllE sCuDElER, Gli edifici per spettacoli nell’Italia romana, Roma 2003, p. 662; F. CoAREllI, Palatium: il Palatino dalle origini all’impero, Roma 2012, pp. 280-281.
110 lIv. II, 42, 1.111 b. lIou-gIllE, La sanction des leges sacratae et l’adfectatio regni: Spurius Cassius,
Spurius Maelius et Manlius Capitolinus, «PP», 51, 1996, pp. 161-197; A. vIgouRT, L’intention criminelle et son châtiment: les condamnations des aspirants à la tyrannie, in L’invention des grands hommes de la Rome antique. Actes du colloque du Collegium Beatus Rhenanus, Augst, 16-18 septembre 1999, Paris 2001, pp. 271-287; A. vIgouRT, Les «adfectores regni» et les normes sociales, ibidem, pp. 333-340; C.J. sMITh, «Adfectatio regni» in the Roman republic, in Ancient tyranny, s. lEwIs (ed.), Edinburgh 2006, pp. 49-64.
Uomini e gentes nella prima metà del V secolo a.C.: Spurio Cassio 45
giustificare, storicamente e politicamente, la condanna e l’uccisione (pubblica e non domestica) del “modello del demagogo” che, sostenuto dal favore popolare, avrebbe potuto compromettere l’ordine sociale dell’Urbe. L’accusa di ambire alla tirannide, infatti, indipendentemente dalla veridicità dell’imputazione, fu uno dei principali deterrenti all’ambizione personale dei grandi personaggi che, nel corso dei secoli, si affacciarono alla politica romana. Non è un caso che grandi oratori della tarda repubblica, come lo stesso Cicerone, fossero soliti accostare la vicen-da di Cassio a quella di demagoghi più recenti come i Gracchi e Saturnino 112.
Una vicenda lunga e tormentata quella di Spurio Cassio, della cui storicità non tutti sono convinti. Non vi sono dubbi che egli rivestì il duplice ruolo di garante del nuovo equilibrio romano-latino, realizzato successivamente agli anni oscuri e confusi seguiti alla caduta della monarchia, e di autore della “lotta agra-ria” che segnerà la prima storia repubblicana; la rovina di questo personaggio va associata senza dubbio alcuno all’offensiva condotta contro di lui dai patrizi a seguito della sua proposta di far partecipare anche i nuovi alleati, gli Ernici, alla divisione delle terre recentemente acquisite dai Romani. Quella di Spurio Cassio rimane comunque una storia decisamente oscura non solo per quanto riguarda le discordanti versioni delle fonti antiche in merito alla sua morte, ma anche per il contesto nel quale si deve collocare la sua ambiziosa azione politica. Diversa-mente da quanto si potrebbe credere, infatti, la concessione del foedus Cassianum si colloca in una fase di flessione del potere romano che, seppur riconosciuto dal-le etnie confinanti, era ancora lungi dall’essere percepito come dominante, consi-derate anche le frequenti (e non prive di conseguenze) rivendicazioni della plebe romana nei confronti dei territori di più recente conquista cui andava sempre più frequentemente incontro il potere costituito di Roma.
Non si può inoltre escludere che, per quanto riguarda la questione degli am-bigui rapporti tra Spurio Cassio e gli interessi romani, la figura del console del V secolo a.C. abbia risentito di una sorta di arbitraria “proiezione” su di lui dei successivi, ma altrettanto dibattuti, legami tra Caio Gracco e gli Italici 113.
Indipendentemente dal ritenere o meno che le vicende collegate a Spurio Cassio, specie quelle relative alla sua rogatio agraria e al suo assassinio, siano realmente accadute, resta il fatto che il V secolo a.C. fu per Roma un periodo di grandi cambiamenti e rivoluzioni e che in questa realtà la presenza di un simile personaggio, figura ambigua che sembra porsi in un discrimen tra patrizi e plebei e tra Romani e Latini, con tutte le sue luci ed ombre, non appare improbabile.
112 lInToTT, The tradition, cit., p. 16.113 l. CAPogRossI ColognEsI, La città e la sua terra, in Storia di Roma, 1, 1988, pp. 287-288.