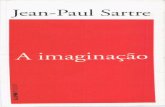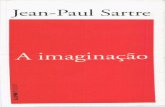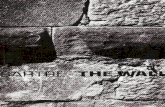Intellectuals (From Marx and Tolstoy to Sartre and Chomsky) by Paul Johnson
Tra alienazione e rivelazione. La critica al concetto hegeliano di «Begierde» nei «Cahiers pour...
-
Upload
izw-berlin -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Tra alienazione e rivelazione. La critica al concetto hegeliano di «Begierde» nei «Cahiers pour...
Tra alienazione e rivelazione 261
Tra alienazione e rivelazione La critica al concetto hegeliano di «Begierde» nei «Cahiers pour une morale» di Jean-Paul SartrePierfrancesco Biasetti
1. Un vertice della filosofia
In un appunto contenuto nei Quaderni per una morale1 Jean-Paul Sar-tre ricostruisce la storia della filosofia degli ultimi due secoli come una degenerazione a partire da Hegel, definito un «vertice» cui è seguito solo un «regresso»2. Considerate la sua giovanile adesione alla fenome-nologia husserliana, e la più tarda identificazione del marxismo come filosofia del nostro tempo, questo giudizio entusiastico verso Hegel può apparire sorprendente. È forse possibile collocarlo nel suo giusto conte-sto se si considera che Sartre si trovava all’epoca immerso in quello che era per lui il primo studio diretto delle opere di Hegel. È lo stesso Sartre a rivelarcelo in una testimonianza3 in cui racconta di non aver avuto altro che un contatto indiretto, attraverso la partecipazione a seminari e lezioni, con la filosofia hegeliana almeno fino al 1945. Il confronto col testo di Hegel, pur sempre filtrato dalle opere di Jean Hyppolite4 e Ale-xandre Kojève5, avvenne, quindi, dopo la stesura de L’essere e il nulla6, poco prima e in contemporanea alla composizione dei Quaderni7.
Com’è noto, i Quaderni costituiscono un insieme, variegato ed ete-rogeneo, di appunti preparatori per l’opera di filosofia morale annun-
1 J.-P. Sartre, Cahiers pour une morale, Paris, Gallimard, 1983, trad. it. Quaderni per una morale, Roma, Edizioni Associate, 1991.
2 Ibidem, p. 63. Marx, secondo Sartre, avrebbe portato a termine ciò che Hegel aveva solo cominciato, ovvero una trattazione filosofica della nozione di lavoro, mancando però di «molte delle grandi idee hegeliane». Il marxismo successivo è bollato come «degenera-zione». Husserl e Heidegger, invece, sono definiti «piccoli filosofi», e la filosofia francese post-hegeliana è giudicata «nulla».
3 Raccolta da Oreste Pucciani in P.A. Schilpp (a cura di), The Philosophy of Jean-Paul Sartre, LaSalle, Open Court, 1981, p. 9.
4 J. Hyppolite, Genesi e struttura della «Fenomenologia dello spirito» di Hegel (1946), Firenze, La Nuova Italia, 1972.
5 A. Kojève, La dialettica e l’idea della morte in Hegel (1947), Torino, Einaudi, 1948.6 J.-P. Sartre, L’essere e il nulla (1943), Milano, Il Saggiatore, 1997.7 La cui composizione è datata tra il 1947 e il 1948.
«Iride», a. XXVIII, n. 75, maggio-agosto 2015 / «Iride», v. 28, issue 75, May-August 2015
262 Pierfrancesco Biasetti
ciata nelle conclusioni de L’essere e il nulla e mai pubblicata8. Al loro interno il confronto con Hegel, se si escludono alcuni brevi cenni alla filosofia della storia, si gioca sulle tematiche aperte nel quarto capito-lo della Fenomenologia dello Spirito9, laddove è definita la «verità della certezza di se stesso». Ciò non dovrebbe sorprendere. Il punto di avvio dei Quaderni è l’ontologia de L’essere e il nulla, dove le questioni dell’in-tersoggettività e del rapporto tra le coscienze sono elaborate almeno in parte a partire da e in opposizione a queste pagine della Fenomenologia. Di fronte a una riconfigurazione pratico-morale dell’analisi ontologica svolta ne L’essere e il nulla, si ripresenta quindi la necessità di un con-fronto con Hegel.
Una categoria portante per seguire questo confronto è quella di deside-rio. Sebbene non trovi una collocazione specifica all’interno dei Quaderni, ma vada ricercata all’interno del «flusso di coscienza» filosofico custodito in queste pagine, la trattazione della categoria di desiderio permette di focalizzare l’importanza di cui godeva per Sartre, negli anni successivi alla composizione de L’essere e il nulla, l’interlocuzione con Hegel. A tal pro-posito, il mio obiettivo in queste pagine è quello di fornire alcuni elementi per mostrare come la categoria di desiderio sia costruita, nell’ambito li-mitato dei Quaderni, in costante confronto critico con la Fenomenologia dello spirito.
8 Gran parte di questo lavoro preparatorio, come racconta Sartre in un’intervista con Michel Sicard (apparsa su Obliques, 1979), andò perduta. In questa intervista Sar-tre prende le distanze da questo progetto, definendolo «individualista» e «astratto». In un’intervista precedente con Oreste Pucciani (apparsa sulla Tulane Drama Review del 1961) lo stesso tentativo era stato definito «morale da scrittore». Già nel 1949 Sartre aveva assunto un atteggiamento critico verso la teoria morale (definita come «un insieme di trucchi idealistici che aiutano a vivere ciò che è imposto dalla scarsità di risorse e dalla mancanza di tecniche»: vedi la testimonianza raccolta da S. Beauvoir, La forza delle cose, Torino, Einaudi, 1996, p. 196). Per un’efficace ricostruzione dei tentativi sartriani di costruire una morale vedi V. Franco, Etiche possibili. Il parados-so della morale dopo la morte di dio, Roma, Donzelli, 1996, pp. 97-103. Riguardo ai rapporto tra i Quaderni e i tentativi di morale successivi vedi invece S. Kruks, Sartre Cahiers pour une morale: Failed Attempt of New Trajectory in Ethics?, in «Social Text», n. 13-14 (1986). Ci si potrebbe chiedere che senso abbia fare riferimento a un’opera incompiuta e sulla quale pesano simili giudizi negativi da parte dello stesso autore. Da un lato, però, appare innegabile la qualità e la profondità delle analisi svolte da Sartre in questi quaderni – contro il suo stesso giudizio posteriore. Dall’altro lato, essi sono un documento imprescindibile per giungere a una valutazione complessiva del pensiero del filosofo nel periodo immediatamente successivo alla pubblicazione de L’essere e il nulla.
9 G.W.F. Hegel, La fenomenologia dello spirito, Firenze, La Nuova Italia, 1960. A differenza della traduzione di E. De Negri adopererò «desiderio» e non «appetito» per tradurre l’hegeliano Begierde, seguendo in questo modo la traduzione francese di Hyppo-lite che – da quanto testimoniano i passi riportati nei Quaderni – era quella adoperata da Sartre.
Tra alienazione e rivelazione 263
Un’analisi di questo tipo può inoltre dirci qualcosa di interessante su-gli ostacoli incontrati da Sartre nella stesura dei Quaderni. Il tema del desiderio rientra del nocciolo problematico di quest’opera incompiuta: come sia possibile, ovvero, concepire rapporti morali tra gli esseri umani a partire dalla «antropologia» ontologica elaborata ne L’essere e il nulla. Non avrò la pretesa di abbracciare l’intero problema. Mi limiterò, piutto-sto, a esaminare una singola questione di fondo: come è possibile, rima-nendo all’interno della struttura circolare del desiderio, spiegare la varietà dei mondi storici.
Nei primi paragrafi (2 e 3) del mio contributo riassumerò i caratteri centrali della critica a Hegel formulata ne L’essere e il nulla. Successi-vamente (da 4 a 6), analizzerò la figura del desiderio nei Quaderni, sof-fermandomi sulle relazioni tra desiderio e annientamento, desiderio e godimento, e desiderio e alienazione. In conclusione (7 e 8), esplorerò il nesso tra la tematizzazione del desiderio e la critica sartriana della natura dialettica della storia e del cambiamento sociale.
2. Filosofie della mancanza
Ne L’essere e il nulla la figura di Hegel compare nelle analisi della nega-zione e dell’intersoggettività. Una certa influenza generale di tematiche hegeliane traspare però nello stesso impianto dell’opera. Non dobbiamo esagerare troppo la portata di questa influenza: come ricordato, la cono-scenza sartriana di Hegel ai tempi de L’essere e il nulla non è diretta, ma laterale, filtrata dall’interpretazione più originale che fedele di Kojève10. Ciò nonostante, Sartre, come altri prima e dopo di lui, appartiene alla schiera di quanti sono rimasti filosoficamente affascinati dalla sezione sull’autocoscienza della Fenomenologia. In particolare, ciò che sembra colpire di più Sartre è la filosofia della mancanza che Hegel costruisce in queste pagine.
In un percorso che dalla definizione originaria dell’autocoscienza come «desiderio» culmina nella descrizione della «coscienza infelice», Hegel espone la dialettica dei diversi tentativi dell’essere umano di rag-giungere, a partire dalla propria individualità, una condizione di integri-tà totale: una condizione, ovvero, in cui il soggetto non è più limitato da alcunché, e la realtà esterna è diventata una sua completa espressione. In questo percorso, l’autocoscienza è sempre spinta oltre, in un progressi-vo riconoscimento dei vuoti che la compongono, e degli sforzi compiu-ti per colmare queste mancanze. Sforzi che, pur non arrestandosi mai,
10 Sull’influenza che questa lettura ha avuto nella ricezione sartriana di Hegel si veda J. Butler, Soggetti di desiderio, Roma - Bari, Laterza, 2009.
264 Pierfrancesco Biasetti
producono un costante raffinamento dell’autocoscienza e del desiderio, e che pertanto si inseriscono in un cammino di libertà11. Nonostante le ovvie differenze, la prospettiva hegeliana presenta delle affinità con l’im-pianto generale del pensiero sartriano di questo periodo. Limitandosi alla categoria del desiderio, se ne possono citare almeno tre.
La prima riguarda la struttura direzionale di questa categoria. Sia per Hegel, sia per Sartre – ma come si vedrà, in modi differenti – il desiderio possiede una struttura che è, al contempo, intenzionale, ovvero rivolta verso un’esteriorità, e riflessiva, poiché rivelativa di alcuni caratteri del soggetto. Secondariamente, Hegel e Sartre condividono l’idea che il desi-derio sia la causa genetica dell’individualità particolare, e non un insieme di tratti specifici che definiscono a posteriori le particolarità individuali12; per entrambi il desiderio è la struttura fondamentale e costituente della singola individualità: l’essere umano non è la somma dei suoi desideri particolari, ma è costituito dal desiderio in un senso profondo e generale. Sia Hegel, sia Sartre, infine, affermano la multiformità del fenomeno del desiderio, e, soprattutto, il suo situarsi in due diverse dimensioni: quella di un desiderio naturale, primigenio, e quella di un desiderio sociale, po-steriore e legato allo stabilirsi di gerarchie tra gli esseri umani.
Di là delle possibili affinità, rimane, però, la differenza insolubile tra gli esiti di queste due filosofie della mancanza. Hegel definisce l’autocoscien-za come desiderio, ma procede poi in un percorso diretto verso l’assoluto. Sartre, al contrario, una volta definito l’essere umano desiderio di essere13, rifiuta le possibilità che questo dato primigenio possa essere superato. La realtà umana, secondo quanto si legge ne L’essere e il nulla, è «per natura coscienza infelice senza possibile superamento dello stato di infelicità»14. Quali sono le ragioni del rifiuto della soluzione hegeliana?
11 Hegel riprenderà il tema del rapporto tra vita e mancanza nella trattazione dell’or-ganismo animale contenuta nell’Enciclopedia delle scienze filosofiche: G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830), in Gesammelte Werke, Hamburg, Meiner, 1992, vol. XX; le citazioni da quest’opera saranno prese dalla traduzione di V. Verra della Filosofia della natura, Torino, Utet, 2002; e di A. Bosi della Filosofia dello spirito, Torino, Utet, 2002. Riguardo alla questione menzionata vedi §359 A.
12 Secondo Sartre, i desideri non sono «piccole entità psichiche abitanti nella coscien-za», ma sono «la coscienza stessa nella sua struttura originale» (J.-P. Sartre, L’essere e il nulla, cit., p. 619). Le individualità particolari, in quanto «totalità», non sono il frutto di «un’addizione o un’organizzazione delle diverse tendenze che empiricamente abbiamo scoperte» in loro. L’individualità particolare, piuttosto, si esprime in ognuna di queste inclinazioni, «un po’ come la sostanza spinoziana si esprime interamente in ognuno dei suoi attributi» (ibidem, p. 626).
13 Ibidem, p. 628.14 Ibidem, p. 129.
Tra alienazione e rivelazione 265
3. L’«ottimismo» di Hegel
Queste ragioni sono esposte nel capitolo de L’essere e il nulla dedicato all’intersoggettività e al problema del solipsismo. Qui Sartre vaglia le po-sizioni realiste e idealiste, mostrandone i limiti rispetto al problema dell’e-sistenza degli Altri. Dopo di che, una volta scartate anche la soluzione di Husserl e la propria precedente posizione avanzata ne La trascendenza dell’Ego15, Sartre passa ad analizzare l’idea hegeliana «di farmi dipendere dall’altro nel mio essere»16.
Il filosofo francese appare dapprima entusiasta della soluzione, che giudica originale e innovativa. Secondo Sartre, l’idea originale di Hegel è che l’Altro non è più soltanto indispensabile «per la costituzione del mon-do e del mio “ego” empirico, ma per l’esistenza stessa della mia coscienza come coscienza di sé»17. Nonostante l’originalità, però, al fondo di questa idea si annida lo stesso errore compiuto da Kant e Husserl: identificare la relazione tra soggetto e Altri come una relazione di tipo conoscitivo18. Per Sartre, infatti, il solipsismo non può essere risolto su un piano epistemo-logico: la relazione tra coscienze è un rapporto ontologico negativo, e non un problematico rapporto conoscitivo da ricomporre.
Non ricostruirò qui le argomentazioni con cui Sartre difende l’idea di un rapporto ontologico tra coscienze, e il primato dell’ontologia sulle questioni epistemologiche19. Ciò che mi interessa analizzare è la ricostru-zione della soluzione hegeliana che Sartre fa in queste pagine, poiché da essa si può già notare la diffidenza provata nei confronti dell’idea di asso-luto – un tema che tornerà in seguito nei Quaderni.
La strategia di Hegel per risolvere il problema dell’Altro si fonda, secondo Sartre, su un duplice ottimismo ingenuo che pervade il suo sistema. Da una parte un «ottimismo epistemologico»: è un’ingenuità pensare che ci possa essere una «misura comune»20 tra l’io-soggetto e l’Altro concepito nel riconoscimento come oggetto, e lo è, quindi, anche pensare che sia possibile cogliere se stessi in un Altro concepito come oggetto, o cogliere in questo modo la sua soggettività. Dall’altra parte, un ottimismo «ontologico»: ponendosi dal punto di vista della totalità,
15 J.-P. Sartre, La trascendenza dell’ego (1936), Milano, Marinotti, 1992.16 J.-P. Sartre, L’essere e il nulla, cit., p. 282.17 Ibidem, p. 280.18 Ibidem, p. 283: per Hegel «la grande molla della lotta delle coscienze è lo sforzo di
ciascuna di esse teso a trasformare la sua certezza di sé in verità», e ciò significa che «la conoscenza è qui ancora misura dell’essere».
19 Alcuni spunti si trovano in S. Gardner, Sartre, Intersubjectivity, and German Idealism, in «Journal of the History of Philosophy», 43 (2005), n. 3, pp. 325-351, in cui sono sottolineati gli aspetti di similarità tra le idee di Sartre e quelle di Fichte.
20 J.-P. Sartre, L’essere e il nulla, cit., p. 288.
266 Pierfrancesco Biasetti
Hegel supera lo «scandalo» della pluralità delle coscienze soltanto per-ché ha già posto, implicitamente, la possibilità reale di questo supera-mento.
Come Hegel, anche Sartre – si potrebbe dire – accetta la realtà della contraddizione. Ma il filosofo francese pone i termini di questa come insanabili: soggetto e oggetto formano due categorie ontologiche sepa-rate e irriducibili. Questo punto è spesso citato per mostrare il carattere aprioristico della critica di Sartre a Hegel. Non c’è dubbio che a partire da qui si arrivi giocoforza a proclamare impossibile non solo un «io che è noi» e un «noi che è io», ma più in generale ogni dialettica e sintesi. In realtà, però, Sartre non fa sua questa premessa in modo apodittico. Essa è sorretta da tutta una serie di argomentazioni di supporto dispiegate lungo il percorso de L’essere e il nulla. Due degli argomenti sviluppati contro Hegel sembrano, in particolare, fare parte di questa armatura di sostegno.
Il primo argomento si può ricavare dalla critica alla concezione dia-lettica del nulla. Sartre sostiene che il passaggio dialettico dall’essere al nulla è reso possibile nella Logica hegeliana soltanto grazie all’introduzio-ne implicita della negazione nella definizione dell’essere21. Ciò potrebbe anche andare bene, a patto di non intendere questa negazione come una negazione di essere. Secondo Sartre, infatti, «la negazione non può coglie-re il nocciolo d’essere dell’essere, che è pienezza assoluta»22. Per questo motivo, contra Hegel, si deve accettare che l’essere sia al limite capace di «fondare» il nulla, essendogli logicamente antecedente, ma non che possa trapassare in esso. In questo modo, Sartre pone un primo tassello nella costituzione di una barriera tra in sé e per sé.
Il secondo argomento è ricavabile dalla discussione attorno alla no-zione di realtà. La coscienza, essendo intenzionale, non può sussistere senza l’in sé se non come vuota astrazione – come «un colore senza una forma»23. Questo legame è costitutivo di quell’articolazione tra per sé e in sé che costituisce l’essere, ciò che Sartre definisce la realtà. Adesso, l’idea di realtà presuppone l’idea di totalità, ovvero di una sintesi unita-ria generale delle cose. Dal momento che l’in sé è concepibile astratta-mente anche senza l’esistenza del per sé, ne risulta, secondo Sartre, che vi deve essere – affinché si dia una totalità sintetica delle cose – un le-game di tipo necessario che va dal per sé all’in sé, e non viceversa24. Ma l’unico modo per postulare un simile legame è quello di concepire l’in sé come qualcosa che riceve la sua esistenza dal per sé: come l’ens causa
21 Ibidem, p. 49.22 Ibidem, p. 50.23 Ibidem, p. 689.24 Vedi ibidem, pp. 690-691.
Tra alienazione e rivelazione 267
sui. Ciò non si può dare: per quanto si possa avere una comprensione pre-ontologica dell’ens causa sui, come concetto questo è «impossibile» e «implica una contraddizione». La condizione della realtà, secondo Sartre, è quindi quella di essere frantumata, sintesi arrestata. Contro Hegel, la cui idea di totalità è invece «la totalità prodotta mediante l’integrazione sintetica di tutti i momenti astratti che si superano in essa nell’esigere il loro compimento»25, Sartre propone una nozione di totalità detotalizzata.
L’esito paradossale del ragionamento, per cui le cose nel loro intero non formano un intero, deriva dal fatto che il per sé, essendo desiderio e pro-getto di farsi ens causa sui, può porsi nel punto di vista ideale della totalità – delle cose nel loro intero – per poi essere costretto a constatare che non si tratta di un intero. La realtà è necessariamente lacerata: l’impossibilità logica della nozione di ens causa sui prova la separazione e l’indipenden-za di per sé e in sé. In questo modo, almeno da una prospettiva interna a quella di Sartre, l’accusa di ottimismo portata contro Hegel non può essere considerata aprioristica.
Si vedrà in seguito quali siano le conseguenze che si possono trarre per la dialettica a partire dalla nozione di totalità detotalizzata. Rimane adesso da definire quali siano le conseguenze di questo ragionamento sul piano del rapporto tra le coscienze. Al fondo di questo rapporto vi è, secondo Sartre, un elemento inamovibile. Le coscienze, essendo libertà, si limitano tra loro: il conflitto è «il senso originario dell’essere-per-altri»26, e questo rapporto ontologico negativo che sta alla loro base non può essere ricomposto su un piano superiore, poiché la totalità del reale è una sintesi arrestata. Potrebbe sembrare, nuovamente, che la po-sizione sartriana sia aprioristica e discenda da premesse ingiustificate: concependo – forse ancora sulla scia di Kojève – la dialettica di signoria e servitù in chiave negativa, Sartre necessariamente arriva ad affermare come inamovibile e primigenio il conflitto tra le coscienze. La questione è più complessa, come si vedrà nell’ultima parte di questo lavoro. L’ana-lisi del desiderio porterà alla luce il fatto originario dell’alienazione – il suo essere un fatto esistenziale, e non storico. E in questo modo sarà possibile per Sartre isolare dal percorso dialettico l’aspetto conflittuale implicito nel riconoscimento.
Ma non corriamo. Prima di arrivare a questa conclusione è necessario esaminare altri aspetti della concezione del desiderio di Sartre. La prima riguarda la questione dell’annientamento.
25 Ibidem, p. 47.26 Ibidem, p. 414.
268 Pierfrancesco Biasetti
4. Desiderio e annientamento
In Un’idea fondamentale della fenomenologia di Husserl: l’intenzionalità27 Sartre accusava realismo e idealismo di identificare la conoscenza con l’as-similazione. Siamo qui agli albori della critica alla concezione conoscitiva del rapporto tra coscienza, mondo e altre coscienze. Stupisce però, non trovare citato nell’elenco delle filosofie «alimentari» l’hegelismo: è for-se Hegel, infatti, il filosofo che ha instaurato il parallelismo più forte tra conoscenza e assimilazione28. Il saggio fu composto tra il 1933 e il 1934, un’epoca in cui, come si è detto, la familiarità di Sartre con le opere di Hegel era ancora indiretta, e questo forse basta a spiegare l’omissione. La successiva critica del rapporto tra desiderio e annientamento istituito da Hegel interviene in ogni caso a colmare questa lacuna.
Nella prospettiva hegeliana il desiderio, nella sua forma originaria e naturale, trova il suo appagamento nell’annientamento dell’oggetto de-siderato. Questo rapporto di tipo negativo è proprio ciò che permette in seguito al desiderio di farsi sociale: di diventare, ovvero, desiderio di ri-conoscimento. È attraverso l’annientamento connesso con l’appagamen-to, infatti, che «l’autocoscienza fa esperienza dell’indipendenza del suo oggetto»29.
In origine l’oggetto del desiderio è in senso generale la vita stessa. L’in-dividualità particolare cui si rivolge il desiderio è, infatti, qualcosa di vi-vente, e in questo modo l’autocoscienza è in grado di fare un’esperienza ben più radicale di quella della propria particolare separazione dall’Altro. In un senso più elevato, infatti, essa fa esperienza di un’alterità radicale, poiché l’oggetto del desiderio, in quanto vivente, è inesauribile. Attraver-so il consumo, l’autocoscienza può sì annientare l’oggetto particolare del proprio desiderio, ma questo non farà altro che riproporsi sotto forma di un altro oggetto particolare desiderabile. Per Hegel, il mondo della vita naturale è quindi il mondo del riproducibile, dove a fianco della caducità dei singoli si trova la realtà perpetua del genere, come processo immortale di autoriproduzione30.
Se l’oggetto del desiderio non fosse la vita, l’autocoscienza sarebbe in grado di raggiungere la quiete consumando tutto la propria esteriorità. Essendo invece il desiderato qualcosa di vivente, l’autocoscienza si ritro-
27 J.-P. Sartre, Un’idea fondamentale della fenomenologia di Husserl: l’intenzionalità (1939), in F. Fergnani e P.A. Rovatti (a cura di), Materialismo e rivoluzione, Milano, Il Saggiatore, 1977, pp. 139-143.
28 Sull’argomento vedi per esempio R. Bodei, Sistema ed epoca in Hegel, Bologna, Il Mulino, 1975.
29 G.W.F. Hegel, La fenomenologia dello spirito, cit., p. 114.30 Cfr. G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse,
cit., §370.
Tra alienazione e rivelazione 269
va bloccata in un ciclo continuo di appetito e di consumo. Per trovare una via d’uscita da questo desiderio naturale l’autocoscienza deve quindi rivolgersi verso un’altra autocoscienza. Nel desiderio sociale di riconosci-mento l’annientamento vero e proprio dell’oggetto desiderato non c’è più – almeno per quanto riguarda il servo31 – ed è sostituito dall’asservimento, dall’inibizione del desiderio naturale, e della trasformazione del mondo. La realtà del desiderio naturale, invece, non può prescindere dalle neces-sità dell’annientamento – rivolto sempre nei confronti di un’individualità, e non della vita stessa.
Sartre, pur accettando la strutturazione circolare e frustrata del desi-derio – portando, anzi, la questione agli estremi – rigetta l’idea di una sua connessione essenziale con l’annientamento. Secondo il filosofo france-se, l’annientamento costituisce soltanto un esito particolare del desiderio naturale, connesso al possesso32. Per comprendere le necessità di questa ridefinizione è necessario uscire da una visione del desiderio naturale schiacciata sul consumo, e allargare la prospettiva verso i territori della sessualità.
Freud fa parte della galassia di autori con cui Sartre è stato in costante interlocuzione – e spesso anche in polemica – per tutta la sua carriera filosofica33. Questo può forse spiegare come mai all’interno della trattazio-ne sartriana del desiderio le questioni della sessualità e delle perversioni occupano un grande spazio. Il desiderio sessuale costituisce, in partico-lare, la forma originaria attraverso cui l’individuo cerca di impossessarsi dell’altro attraverso la sua «oggettività-per-me»34, ovvero il suo essere og-getto di fronte al mio sguardo, ed è per questo che esso, prima di essere un fenomeno fisiologico o psicologico, è una struttura originaria dell’on-tologia della coscienza.
Per Sartre il desiderio sessuale può essere qualificato come il deside-rio di un oggetto trascendente – la libertà altrui – che cerca di attuarsi attraverso la possessione del corpo dell’altro. Dal momento che ha per oggetto la fatticità dell’altro, ma mira in realtà alla sua libertà, la sua dinamica peculiare è quella di cercare di realizzare un’operazione im-possibile: far «rapprendere»35 la coscienza e la libertà dell’altro nel suo
31 Il signore, infatti, è di nuovo nella posizione di annientare l’oggetto desiderato, perché il suo ruolo è quello di consumare. Vedi G.W.F. Hegel, La fenomenologia dello spirito, cit., p. 121.
32 Secondo Sartre è semmai nel mondo del desiderio sociale che si ritrovano le basi per una generalizzazione della figura dell’annientamento come esito del desiderio. Vedi Quaderni per una morale, cit., p. 342.
33 Riguardo al tema del desiderio, alcuni spunti di interlocuzione con Freud si trovano in C. Correas, El deseo en Hegel y en Sartre. Curso breve, Buenos Aires, Atuel, 2002.
34 J.-P. Sartre, L’essere e il nulla, cit., p. 433.35 Ibidem, p. 445.
270 Pierfrancesco Biasetti
corpo – per possederle. Il compito è impossibile perché non si può ri-durre l’altro a una parte degli oggetti del mio mondo – a un mio oggetto – e avere allo stesso tempo anche la sua pura coscienza: quest’ultima, infatti, mai potrà essere un oggetto. Da questa dinamica risulta però chiaro che è il possesso l’obiettivo primario cui è indirizzato il desiderio sessuale – così come, più in generale, il desiderio naturale. E il posses-so non è l’annientamento. Possedere vuol dire piuttosto «essere il fine proprio dell’esistenza dell’oggetto» posseduto36. E l’annientamento è soltanto uno degli esiti possibili del possesso. Oltre all’annientamento, l’altro tipo di comportamento appropriativo è quello creativo: e la cre-azione sta alla distruzione come l’essere al nulla, e sembra godere della stessa priorità logica37.
Nei Quaderni per una morale Sartre riprende la questione, sottoline-ando esplicitamente come essa ponga un limite alla trattazione hegeliana del desiderio naturale. Il fatto che il desiderio per Hegel sia «desiderio di consumare, quindi di distruzione», secondo il filosofo francese fornisce una descrizione del fenomeno «solo parzialmente vera»38. Se il desiderio naturale fosse realmente strutturato in questo modo, l’essere umano sa-rebbe «un pieno che distrugge». Ma in realtà esso è, secondo l’ontologia sartriana della coscienza, soltanto «un essere minore che va ad incollarsi all’In-sé per prendergli in prestito il suo essere»39. Sartre è in questo modo in grado di inserire nel discorso sul desiderio delle dinamiche completa-mente avulse dal consumo dell’Altro: dinamiche che possono essere ca-ratterizzate come espressive – per esempio quelle che si ritrovano negli atteggiamenti chiamati «carezza» e «tenerezza». Sebbene queste dinami-che siano comunque condannate allo scacco, esse esulano da un rapporto negativo legato alla distruzione dell’Altro, e nei Quaderni per una mora-le Sartre sembra operare una timida apertura riguardo al loro carattere emancipante40.
Dopo questa ridefinizione risulta però difficile comprendere come pos-sa avvenire il passaggio dal desiderio naturale al mondo sociale. In Hegel il ponte dialettico è chiaro: dalla consapevolezza che nasce dal consumo,
36 Ibidem, p. 654.37 Cfr. ibidem, pp. 654-659.38 J.-P. Sartre, Quaderni per una morale, cit., p. 116.39 Ibidem, p. 116. Sartre, inoltre, sottolinea come le relazioni tra coscienze debbano
in ogni caso esplicitarsi attraverso «la nostra esistenza come corpo in mezzo al mondo» (J.-P. Sartre, L’essere e il nulla, cit., p. 411), e ciò ha nuovamente una ricaduta sul tema dell’annientamento: «quando desidero il corpo di una donna», si chiede infatti Sartre, significa forse «che io voglio sbarazzarmi di quel corpo»? (J.-P. Sartre, Quaderni per una morale, cit., p. 117).
40 Tenerezza e carezza sono due comportamenti in grado di dare luogo a «una morale propria del desiderio che è rivendicazione dell’umano nella sua totalità» (J.-P. Sartre, Quaderni per una morale, cit., p. 117).
Tra alienazione e rivelazione 271
si produce il desiderio di riconoscimento, quindi la lotta e l’asservimento. Senza i tasselli chiave dell’annientamento e del consumo non solo l’essere umano rischia di rimanere nel mondo «magico» del desiderio naturale, vi sembra addirittura condannato.
Ciò sarebbe un problema per Hegel, ma non per Sartre. Come gli schi-zofrenici in Immagine e coscienza41 rimangono catturati nel mondo magi-co della vita immaginativa, allo stesso modo le società primitive possono rimanere indefinitamente bloccate in una determinata situazione che per Hegel sarebbe pre-storica. Non si tratta però di una condanna, ma solo di una possibilità reale. Nondimeno ciò apre un secondo problema: alcune società sono uscite dal mondo magico del desiderio naturale, e questo è un fatto da spiegare. Ma come? Sartre è di fronte a un bivio: rinunciare definitivamente alla dialettica, oppure costruire un resoconto alternativo a quello offerto dalla Fenomenologia.
5. Desiderio e godimento
Il secondo punto contestato a Hegel ci permetterà di cominciare a com-prendere gli argomenti con cui Sartre scioglie il dilemma precedente. Ol-tre ad aver sovrastimato il ruolo dell’annientamento nel desiderio natu-rale, Hegel si è dimenticato, secondo Sartre, di un altro aspetto cruciale: avrebbe infatti trascurato «l’elemento propriamente detto del Lust o del Godimento» connesso con l’appagamento42. Apparentemente potrebbe sembrare un’osservazione banale: ma non lo è, se si considera che nei Quaderni Sartre attribuisce al godimento connesso alla soddisfazione del desiderio naturale la capacità di essere «rivelazione lussuriosa»43. Che cosa si intende, qui, per rivelazione?
41 J.-P. Sartre, Immagine e coscienza. Psicologia fenomenologica dell’immaginazione, Torino, Einaudi, 1946.
42 J.-P. Sartre, Quaderni per una morale, cit., p. 116. C’è da dire che l’accusa di Sartre va ridimensionata. Nella Fenomenologia dello spirito l’appropriazione del mondo esterno che caratterizza il desiderio, risorgendo come trasformazione di questo mondo per il trami-te del lavoro servile, permette al signore di elevare il proprio appagamento a godimento – e, in questo modo, di «esaurire la cosa» (G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, cit., p. 121). In ogni caso resta vero che, nell’ottica sartriana, una simile trattazione del godimento è insufficiente, poiché non ne individua la struttura riflessiva: il desiderio così concepito non rivela alcunché a chi ne fa esperienza.
43 J.-P. Sartre, Quaderni per una morale, cit., p. 342. La trattazione del desiderio ses-suale ne L’essere e il nulla, nonostante l’attenzione verso il lato carnale, non concede molto spazio alle questioni del godimento e del piacere. Qui Sartre si limita a osservare che attraverso il piacere si consuma il fallimento del progetto originario connesso al desiderio sessuale. È nei Quaderni che il tema del godimento acquisisce la dimensione più robusta della rivelazione.
272 Pierfrancesco Biasetti
In Immagine e coscienza Sartre aveva definito l’immagine come «lo stato in cui il desiderio sarebbe in pari tempo conoscenza», una possi-bile sintesi tra «affettività» e «sapere»44, assegnando in questo modo un contenuto epistemico ai prodotti dell’immaginazione e al desiderio che li sottende. Laddove il percepito ci restituisce la realtà nel suo traboccare inesauribile di dettagli, l’immagine è invece qualcosa di finito e delimitato, esauribile. L’immagine lavora quindi per sottrazione rispetto al reale, e il desiderio che la sottende ci permette di conoscere quali sono gli aspetti del mondo magico ricercati dal soggetto che la ha evocata. Ritroviamo qui la duplice struttura generale del desiderio: intenzionale, poiché rivolta a un contenuto esterno, e riflessiva, in quando conoscitiva rispetto alle ca-ratteristiche del soggetto. La riflessività del desiderio, definita a proposito dell’immagine come conoscitiva, nei Quaderni è riformulata come rivela-zione. La rivelazione è un fenomeno che può qui assumere due aspetti di-stinti, il primo connesso al desiderio naturale, il secondo a quello sociale. In questo paragrafo mi concentrerò sulla rivelazione connessa al desiderio naturale, rimandando al prossimo la trattazione della rivelazione nel de-siderio sociale.
Il desiderio naturale sfocia in una rivelazione che è definita, come si è visto, «lussuriosa», poiché opera attraverso il godimento. Il tema è affron-tato da Sartre nei Quaderni all’interno di una serie di riflessioni dedicate al mondo primitivo e ai suoi aspetti già alienati. Il filosofo francese sta qui cercando di dimostrare come l’alienazione dell’essere umano preceda la sua oppressione, e il desiderio naturale operante all’interno del mondo primitivo è la chiave per giungere a questa dimostrazione.
Secondo Sartre, il mondo primitivo si configura come un «mondo ma-gico» dove il rapporto con la natura è dominato dal desiderio naturale, al contrario del «mondo degli utensili», dove il rapporto tra essere umano e natura è mediato dal lavoro45. Nel mondo primitivo il desiderio assume i caratteri magici dell’azione a distanza46 e il rapporto con la natura un aspetto carnale. In questo modo l’Altro – inteso come limite alienante – è già da sempre presente all’interno dell’individuo stesso ancora prima della comparsa del mondo sociale del lavoro e delle dinamiche di signoria e servitù. È proprio il godimento connesso con l’appagamento del desi-
44 J.-P. Sartre, Immagine e coscienza. Psicologia fenomenologica dell’immaginazione, cit., p. 117.
45 La distinzione originaria tra mondo magico e mondo degli utensili è elaborata in J.-P. Sartre, Idee per una teoria delle emozioni (1939), Milano, Bompiani, 1962.
46 Sul rapporto tra desiderio e magia – nonché sull’importanza per comprendere i lavori giovanili di Sartre alla luce della categoria di mondo magico – ha giustamente insi-stito M. Meletti Bertolini, La conversione all’autenticità. Saggio sulla morale di J.-P. Sartre, Milano, Franco Angeli, 2000.
Tra alienazione e rivelazione 273
derio – quel godimento che Hegel, «non essendo sensuale»47, ha finito per dimenticare – a mostrarlo, attraverso una rivelazione. Così come nel desiderio sessuale l’appagamento passa attraverso la sensualità dell’odore e delle altre particolarità del corpo dell’Altro, nel desiderio magico attra-verso cui il primitivo si appropria della Natura per consumarla le qualità sensoriali dell’oggetto consumato rivelano la sua presenza reale. Il godi-mento ricorda alla coscienza, proprio nel momento del consumo, l’irri-ducibile presenza di un’alterità, che consumata «giunge al più alto grado di esistenza»48. Da una parte, se non ci fosse questo godimento a testimo-niare la realtà dell’oggetto consumato, allora avremmo soltanto un an-nientamento, una «scomparsa dell’oggetto, che apparirebbe come l’ines-senziale davanti alla coscienza colta da sé come l’essenziale»49. Dall’altra parte, facendosi rapire dalle proprietà sensoriali dell’oggetto consumato, il primitivo entra in comunione con la Natura. L’oggetto desiderato, che è come «consegnatoli» per magia, finisce per possedere la coscienza che lo desidera: da qui, Sartre conclude che l’essere umano è già da sempre alienato, giacché «il desiderio è un altro».
È da notare nuovamente il carattere ambiguo di questa descrizione del desiderio. Da una parte, infatti, la rivelazione lussuriosa è alla base della comunione tra l’essere umano e la natura, che si traduce nella pos-sessione, da parte dell’oggetto desiderato, della coscienza che lo desidera, e quindi, in ultima istanza, nella condizione di alienazione originaria che precede ogni forma storica di oppressione. Dall’altra, però, la rivelazione è rivelazione di alterità. La sensualità dell’oggetto consumato può anche ricordarci – a dispetto dei meccanismi magici che vorrebbero farcelo di-menticare – la separazione tra noi e la nostra esteriorità, e quindi la nostra indipendenza e libertà.
Si ripropone, però, il problema di comprendere quali siano le conse-guenze di questa rivelazione. Hegel, poiché sottovaluta il lato sensuale del godimento, può, nell’opinione di Sartre, tracciare un percorso lineare che dall’annientamento dell’oggetto consumato e dalla circolarità del de-siderio naturale porta al desiderio sociale del riconoscimento e quindi al mondo storico. Nella descrizione di Sartre, invece, il desiderio naturale – questa volta il desiderio magico del primitivo – non sempre è provvisto di un germe dialettico capace di maturare e condurre a una nuova figu-ra. Per comprendere quale sia la soluzione sartriana a questo problema è necessario esaminare la trattazione del rapporto tra desiderio e lavoro – nuovamente costruita in interlocuzione e contrasto con Hegel.
47 J.-P. Sartre, Quaderni per una morale, cit., p. 342.48 Ibidem.49 Ibidem.
274 Pierfrancesco Biasetti
6. Desiderio e lavoro
Se ne L’essere e il nulla la dialettica di signoria e servitù forniva uno dei modelli possibili per affrontare la questione dell’intersoggettività, nei Quaderni essa è analizzata come paradigma esplicativo del mondo degli utensili e del lavoro: di quel mondo storico, ovvero, che sorge dalle ceneri del mondo magico primitivo, e che vede il passaggio dal desiderio natura-le a quello sociale di riconoscimento. In alcuni passi dei Quaderni Sartre critica l’apparente linearità attraverso cui si svolge la dialettica di signoria e servitù. Secondo il filosofo francese alcuni aspetti, giudicati semplicisti-ci, della situazione descritta da Hegel ne minano la credibilità storica – e pertanto la sua capacità di essere modello universale per il mondo degli utensili.
Anzitutto, Hegel sembra fornire un quadro troppo schematico e uni-voco della figura del signore. Sartre, in particolare, contesta la radicale separazione del signore dalla sfera del lavoro – giudicata inconsistente da un punto di vista storico50. Questa separazione, necessaria per fare del servo l’unico motore dialettico della vicenda, è implicitamente confutata dalle stesse figure del pensiero evocate successivamente da Hegel. Sartre fa notare, infatti, che stoicismo e scetticismo furono filosofie inventate da padroni51, e che il progresso tecnico e scientifico è frutto di ceti sociali intermedi emancipati dalle necessità del lavoro manuale52.
Ma è attorno alla figura del servo che si concentrano le critiche più in-teressanti. Come si è detto in precedenza, Sartre sottolinea che le capacità trasformative connesse col lavoro non sono appannaggio esclusivo del ser-vo. Anzi, è quella classe intermedia (ma «signorile» in quanto svincolata dalle necessità di compiere lavori «servili») composta da tecnici, inventori e intellettuali a mettere in atto la reale trasformazione del mondo grazie alla produzione di tecniche. Il lavoro del servo, contra Hegel, è sprovvisto di caratteristiche autenticamente «formatrici». Esso si configura piuttosto come «ripetizione»53. E non è questo l’unico difetto rinvenuto da Sartre nella narrazione hegeliana. La servitù non deriva, se non per coloro che sono stati originariamente ridotti in questa condizione, dalla paura della morte e dalla scelta di accantonare il proprio desiderio di riconoscimento: la maggior parte dei servi nasce in una condizione che è già servile, e in questi casi, se si può parlare di scelta, lo si può fare soltanto nei termini di una scelta compiuta in malafede. I soggetti nati in condizione servile,
50 Ibidem, p. 376.51 Ibidem, p. 75. Appare curiosa in questo frangente l’inclusione tra i padroni di Epit-
teto. 52 Ibidem. Sartre sottolinea inoltre che oltre al rapporto pacifico e verticale tra servo e
signore, permangono rapporti orizzontali di guerra tra i vari signori.53 Ibidem, p. 449.
Tra alienazione e rivelazione 275
infatti, non hanno fatto esperienza della lotta e della paura della morte, hanno invece accettato la loro condizione così come si presentava – come se fosse un fatto naturale – e sono diventati complici dei loro stessi oppres-sori. Per questi motivi è erroneo pensare che la condizione del servo si rovesci dialetticamente aprendo le porte a una successiva determinazione di libertà. Tutt’altro: la condizione del servo non ha in sé alcun germe interno di sviluppo, ma è alienata e destinata a perpetuarsi senza un inter-vento di altro genere.
Per sostenere fino in fondo questa tesi Sartre deve però ancora smantel-lare un altro tassello della dialettica hegeliana di servitù e signoria. Kojève aveva fornito una spiegazione efficace del perché la prima comparsa della libertà avvenga nella figura del lavoro54. Nel fiume delle azioni umane, la libertà risplende attraverso atti di tipo negatorio: atti, ovvero, che sembra-no ledere i nostri interessi biologici in virtù di un qualche tipo di interesse più elevato. Il lavoro è uno di questi atti negatori, il primo in ordine logico e temporale, poiché è, secondo Hegel, desiderio «tenuto a freno»55. Per completare la propria critica, Sartre deve contestare quest’ultima idea. E lo fa, affermando che il lavoro del servo non è «desiderio trattenuto» ma «desiderio rifiutato»56. Questa osservazione conduce il filosofo francese a due conclusioni, una negativa, e l’altra positiva.
La prima conclusione è, per l’appunto, una conferma del mancato ca-rattere emancipante e, in ultima istanza, libero del lavoro servile. Nell’ela-borazione di questa conclusione interviene quello che è l’aspetto rivelante del desiderio sociale, che è negato per principio al servo. Scrive Sartre:
Nella misura in cui questo desiderio non si limita, come dice Hegel, a soppri-mere, ma rivela sopprimendo, in seno all’oggetto formato c’è una rivelazione per mezzo dell’uso e del consumo e che è per principio rifiutata allo schiavo. Quella tunica che egli tesse, è sul padrone che assumerà senso e valore. Così allo schiavo, come più tardi al proletario, viene rubato il senso del suo lavoro57.
Fin dal suo inizio, quindi, il lavoro è un’attività alienata, poiché avvie-ne in funzione di un Altro percepito come il destinatario naturale dell’atti-vità formatrice. Inoltre, pur lavorando, il servo non è in grado di acquisire da questa attività delle rivelazioni sul mondo, poiché il suo desiderio è per principio negato, e gli sono negate, quindi, anche l’appagamento e la «rivelazione lussuriosa». Il servo pertanto percepisce come naturale la propria condizione, e si presenta come un oppressore di se stesso.
54 Cfr. A. Kojève, La dialettica e l’idea della morte in Hegel, cit., pp. 103-105.55 G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, cit., p. 123.56 J.-P. Sartre, Quaderni per una morale, cit., p. 376.57 Ibidem.
276 Pierfrancesco Biasetti
La seconda conclusione tratta da Sartre è che a essere veramente eman-cipante è, piuttosto, il desiderio naturale ancora presente nel mondo so-ciale. Sono infatti la «miseria», la «dipendenza», la «fame» a far penetrare in modo autentico la libertà nel mondo del servo. Tramite queste figure il servo è in grado di avere una rivelazione che è tutto il contrario della «ri-velazione lussuriosa», poiché è una rivelazione per negazione. Nondime-no essa è capace di gettargli in faccia la sua libertà, svelando il falso carat-tere di naturalità nel rapporto tra signore e servo. «La fame è rivelazione del mondo»58, scrive Sartre, e il servo può reagire a essa tramite le diverse modalità comportamentali del furto, della rassegnazione, o della rivolta.
7. Desiderio, dialettica e storia
Torniamo al dilemma avanzato precedentemente: sia Sartre, sia Hegel, danno una grande importanza al desiderio nella spiegazione dello svilup-po pratico e storico dell’essere umano. Nella descrizione del desiderio data da Sartre, però, mancano quei caratteri in grado di garantire la fluidi-tà dei passaggi dialettici. Sembra quasi che le singole figure siano ripiegate su se stesse, e che non vi sia alcun germe capace di produrre il passaggio tra l’una all’altra. Per spiegare la questione, facciamo un altro passo indie-tro, per vedere come la questione è affrontata da Hegel.
Hegel distingue il desiderio (Begierde) che costituisce il carattere fon-damentale dell’autocoscienza dal semplice impulso (Triebe) che si pone come un moto istintuale verso l’esteriorità59. Si tratta sotto molti aspetti di un raffinamento dell’idea aristotelica secondo cui il movimento esiste a partire dall’appetito60. Desideri e impulsi si configurano infatti come sistemi di appropriazione del mondo esterno da parte di soggettività libere nella loro motilità. Ma il semplice impulso è qualcosa di prece-
58 Ibidem, p. 377.59 È da notare, a proposito della determinazione dell’Impulso, una certa confusione
semantica di Hegel. Oltre all’impulso inteso come manifestazione immediata e irriflessa di un appetito Hegel, infatti, adopera il termine Triebe anche per definire nella parte della Psicologia dedicata allo «Spirito Pratico» le inclinazioni caratteriali prodotte in noi dalla nostra volontà attraverso cui addomestichiamo i nostri sentimenti: una sorta di volontà na-turale in cui è possibile riconoscere la nozione aristotelica di disposizione. Questo tipo di impulso si distingue dal mero desiderio naturale poiché mentre quest’ultimo è «qualcosa di singolare, e cerca soltanto ciò che è singolare per una singolare, momentanea soddisfa-zione», il primo «abbraccia una serie di soddisfazioni: quindi qualcosa di totale, di univer-sale» (G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, cit., §473 Z). Questo tipo di inclinazione è connesso inoltre con l’interesse (che Hegel definisce in ibidem, §475), mentre il desiderio è un mero appetito egoistico (ibidem, §428 Z).
60 E l’appetito grazie all’immaginazione. Cfr. Aristotele, De Anima, III 433b 29.
Tra alienazione e rivelazione 277
dente all’essere umano stesso61. Il desiderio, al contrario, sebbene possa espletarsi attraverso degli impulsi, non è riconducibile univocamente alla sfera naturale. Come si è visto in precedenza, è proprio il desiderio che permette all’autocoscienza di cogliere la propria posizione peculiare all’interno della natura62: grazie ad esso, l’autocoscienza scopre la pro-pria eccedenza. Né il desiderio, né l’impulso, garantiscono la possibilità di aggirare immediatamente il circolo tra bisogno e soddisfazione. Ma mentre l’impulso – il quale è ancorato irrimediabilmente all’animalità, e quindi alla sfera naturale – può trovare soddisfazione soltanto nella per-petuazione del genere da parte dell’individuo naturale, il desiderio natu-rale sboccia poi nel desiderio di riconoscimento, e quindi nella socialità di stampo umano. È grazie alla figura generale del desiderio, quindi, che l’animale umano completa il suo distacco dalla naturalità, e la coscienza «raggiunge il suo punto di volta» entrando nel dominio dello spirito63.
Questo è possibile perché il desiderio immette nel discorso sulla co-scienza un elemento di tipo pratico64. Sartre ne L’essere e il nulla non sembra accettare la validità di questo punto, poiché riconduce l’intera vicenda del riconoscimento in Hegel a una questione epistemica – a una domanda di verità. Allo stesso tempo, però, non rinuncia nei Quaderni a compiere una dettagliata analisi dei presupposti del riconoscimento e dei suoi sviluppi pratici. È cambiato qualcosa?
È cambiato il punto di vista da cui Sartre espone la sua critica. Se ne L’essere e il nulla la questione centrale era la risoluzione dell’ontologia nell’epistemologia, nei Quaderni è il rapporto tra dialettica e libertà a decidere il taglio della critica e il piano su cui deve muoversi. Si tratta di due modi complementari per arrivare da direzioni diverse a una cri-tica generale del concetto di assoluto hegeliano. Nel terzo paragrafo si è visto come sia possibile accusare di apriorismo la critica che Sartre com-pie nei confronti dell’«ottimismo» conciliatore hegeliano: ponendo all’i-nizio del ragionamento la separazione tra soggetto e oggetto, va da sé che si arrivi a un esito critico nei confronti della possibilità di giungere a una misura comune tra le coscienze; ma, ragionando per assurdo, una
61 G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, cit., §360 Z. L’impulso «non è un fine consapevole», e chi opera attraverso esso appartiene alla «physis».
62 Come sottolineato, tra gli altri, da A. Honneth, Dal desiderio al riconoscimento. Hegel e la fondazione dell’autocoscienza, in «Iride», 20 (2007), n. 3, pp. 573-584.
63 G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, cit., p. 115.64 Come «atteggiamento che cerca di far conformare le cose alle nostre esigenze piut-
tosto che limitarsi a cercare di scoprire che lo fanno», il desiderio è una di quelle figure che mostrano come il lato teoretico e quello pratico siano sempre interconnessi all’interno del-la filosofia hegeliana: sull’argomento vedi J.N. Findlay, Hegel oggi (1957), Milano, Istituto Librario Internazionale, 1972, p. 93.
278 Pierfrancesco Biasetti
totalità concreta di soggetto e oggetto non potrebbe prendere altra for-ma che quella dell’ens causa sui, il quale è un concetto contraddittorio; questo implica che soggetto e oggetto sono separati, e la totalità del re-ale è una totalità detotalizzata. Nei Quaderni Sartre riprende la nozione di totalità detotalizzata e la applica alla nozione di storia con il chiaro in-tento di smontare la dialettica, e attacca in questo modo l’idea hegeliana di assoluto da un altro lato. La totalità sintetica in Hegel non è un dato di partenza, ma è un prodotto: la sua possibilità dipende dal mostrare la validità del processo dialettico. E per argomentarne l’impossibilità Sar-tre adopera questa volta una strategia diversa: quella di mostrare che i vari momenti inseriti nello sviluppo dialettico non contengono elementi per giustificare il loro successivo trapasso in una nuova figura.
La discussione precedente sulle due forme di desiderio prese in esame da Sartre, il desiderio naturale del primitivo, e quello sociale di riconosci-mento, sono casi emblematici di questa strategia: di entrambe le figure, infatti, si dimostra come non siano presenti ragioni affinché si produca un loro trapasso. Le condizioni del primitivo, così come quelle dell’essere umano stretto tra il ruolo di servo e quello di signore, formano dei mondi storici che sono in realtà delle modalità ontologiche fondamentali dell’e-sistenza umana – e non dei momenti di una totalità storica in cammino lungo un vettore ordinato. Come gli anelli liberati da una catena, i vari momenti vanno a isolarsi e a formare delle figure chiuse e ripiegate su se stesse. Prive di un reale germe interno che possa provocare il cambiamen-to dialettico, sia il mondo alienato del primitivo, che quello altrettanto alienato del servo e del padrone, si perpetuano indefinitamente nell’iner-zia, anteponendo l’entropia dell’alienazione originaria a ogni ottimismo della ragione.
Alla resa dei conti ciò equivale a spogliare di ogni connessione orga-nica lo sviluppo dialettico. Vi sono due teorie della negatività in Hegel, osserva Sartre. Una interna, frutto della «contraddizione», e una esterna ad «azione occulta», la quale è legata a un «tutto» che è già «dato»:
In questo modo la dialettica ha un aspetto di meccanicismo. Il senso di «lo spirito è inquietudine» è minimizzato dalla maniera in cui Hegel lo esplicita. Si tratta semplicemente dell’incompletezza di un processo che da un lato è in via di compimento e dall’altro pone se stesso come compiuto65.
65 J.-P. Sartre, Quaderni per una morale, cit., p. 347. Una critica analoga è mossa con-tro la dialettica di Engels. Qui Sartre ritrova la stessa circolarità propria della dialettica hegeliana, aggravata dal fatto che, ponendosi come una dialettica materialistica, quella di Engels non può fare appello ai caratteri assiologici dello Spirito (cfr. ibidem, pp. 329-339). Queste pagine sono utili per trovare altri elementi di rifiuto verso la dialettica hegeliana. Per giustificare quest’ultima, infatti, secondo Sartre è necessario credere nel progresso, anche in quei casi in cui – come nel passaggio dalla libertà originaria alla schiavitù – il
Tra alienazione e rivelazione 279
Il modo forzoso con cui avvengono i passaggi dialettici mostra che la dialettica, in realtà, non è un sistema attraverso cui l’assoluto produce, giustifica e conosce se stesso. È un trucco idealistico per giustificare que-sto stesso assoluto che è già dato.
Dal punto di vista della storia, ciò equivale alla scomposizione del vet-tore dialettico in una miriade di vettori particolari, ognuno concentrato nell’esistenza di un individuo. La storia è totalità detotalizzata, ed è priva di un punto di vista del tutto. Nel caso contrario saremmo di fronte a un «assoluto-soggetto» – quello della filosofia hegeliana. Ma questo, per Sar-tre, indica per l’appunto «un solo soggetto»66, quindi un’unica coscienza.
Si ripropone quindi il problema già incontrato: una volta rifiutata la dialettica come soluzione, come possiamo evitare di rimanere chiusi in uno dei vari mondi alla deriva nella condizione umana? Che cosa innesca il cambiamento sociale in un orizzonte in cui l’alienazione è il dato ori-ginario, e quale sarebbe, in fin dei conti, il significato ultimo di un muta-mento storico di condizioni?
8. Il desiderio come rivelazione di libertà
L’alienazione è un fatto ontologico originario della condizione umana. Nel progredire della storia ritroviamo quella stessa sintesi arrestata di coscienze individuali che costituisce il singolo momento presente. Il mondo in cui viviamo è refrattario alle possibilità di cambiamento e tende a mantenere la propria omeostasi per inerzia. Questo sembra es-sere il risultato cui giunge Sartre al termine della sua analisi. Non c’è nient’altro?
Nella struttura del desiderio Sartre, come si è visto, rinviene gli ele-menti chiave per quella che è un’ontologia originaria dell’alienazione. Pur mancando della figura di un «oppressore», la presenza di un de-siderio è sempre sintomo di una qualche forma di alienazione, poiché in esso l’oggetto desiderato è «posto come essenziale e l’uomo come inessenziale»67. E, come si è visto, il desiderio, nel suo senso più origina-rio, costituisce la struttura fondamentale dell’ontologia della coscienza, formandone la matrice originaria attraverso cui modellare ogni genere di rapporto. Ma non c’è soltanto questo nel desiderio. Quell’ambiguità che
momento successivo appare come una forma di negatività. Senza questa credenza nel progresso, che Sartre nega decisamente (vedi le pagine sull’«Ambivalenza della storia» – ibidem, pp. 25-49), il punto di vista a partire dal tutto non è giustificato. La credenza nel progresso implica poi una «presenza nascosta dei valori» che permette di misurare ogni cambiamento alla luce dei suoi effetti positivi.
66 Ibidem, p. 89.67 Ibidem, p. 346.
280 Pierfrancesco Biasetti
si era rilevata a proposito del desiderio sessuale e dell’aspetto rivelante che il desiderio ha nelle diverse società in cui è protagonista – quella magica del primitivo, e quella degli utensili fondata sul lavoro – è alla base dei cambiamenti storici che le coscienze possono portare in quella totalità detotalizzata che è la storia. Oltre che rivelazione dell’aliena-zione originaria del per sé, il desiderio è infatti capace di rivelare quella che è la libertà senza scampo dell’essere umano. Nel mondo stregato del primitivo, il desiderio grazie alla «rivelazione lussuriosa» fa sfavillare per un attimo, durante la comunione tra essere umano e Natura, il ri-flesso della libertà. E lo stesso accade nel mondo degli utensili, quando la negazione del desiderio pone lo schiavo di fronte alle possibilità di comprendere che la sua condizione non è naturale.
La storia, intesa come passaggio da un mondo a un altro, non è quin-di un processo lineare, ma è spinta in avanti da balzi quantici che si verificano allorquando lo squarcio sulla libertà aperto dal desiderio è accolto e assunto nella pratica dalle coscienze. Il cambiamento storico non è frutto di un qualche meccanismo dialettico occulto all’opera nel-la storia, ma della pura libertà degli esseri umani. Le unità particolari della totalità detotalizzata formano insiemi chiusi tra loro, nondimeno una comunicazione e un passaggio tra le varie forme di questi spazi ri-piegati è possibile. Ed è nel desiderio che Sartre rinviene le condizioni strutturali fondamentali che garantiscono l’espressione di questa libertà creatrice di varchi. Questa ambiguità del desiderio, tra alienazione e rivelazione di libertà, è ben visibile in un altro appunto dei Quaderni:
Un desiderio preso isolatamente è sempre vero, sempre puro, sempre morale, in quanto contiene in sé tutta la realtà umana: l’affermazione della trascendenza, il legame con il mondo nell’essere-nel-mondo, la libertà, il superamento della situazione, la ricerca rivelante della verità. Qualunque desiderio pone la libertà e la verità. Esso è illegittimo e impuro solo secondariamente, se viene avvelenato dalla volontà d’essere (In-sé per-sé) e dalla presenza in lui dell’Altro68.
Il cambiamento è quindi possibile. Resta insoluto il problema di qua-le sia il suo significato. La filosofia sartriana, da questo punto di vista, è molto più modesta di quella hegeliana, ma forse è, proprio per questo, più attenta alla realtà umana e a quella sua particolare manifestazione che è la filosofia. Dall’analisi operata in queste pagine dovrebbe essere emerso che, nell’ottica di Sartre, Hegel dipinge il desiderio come una tipologia di attività pratica nei confronti del mondo, la quale però si rovescia in figure astrattamente teoretiche. Hegel sembra dimenticarsi di alcuni aspetti reali dei soggetti desideranti, esaltando invece quelli
68 Ibidem, p. 404.
Tra alienazione e rivelazione 281
che sono gli aspetti più «idealistici» connessi coll’annientamento e col riconoscimento. Da una parte Hegel trascura le questioni sensuali del possesso e del godimento, dall’altro proietta una visione eccessivamente fiduciosa del lavoro facendone desiderio trattenuto e non negato. La concezione del desiderio di Sartre, pur partendo da un comune punto di vista sulla mancanza, sembra cercare di porre rimedio a queste dimen-ticanze – e nel farlo, incidentalmente, costruisce una radicale negazione dell’assoluto e della dialettica. Ma più in generale, la critica nei confron-ti di un desiderio capace di unire le coscienze in una totalità concreta – per quanto plurale questa sia – oltre a essere una critica complessiva del pensiero hegeliano, è anche una critica rivolta contro ogni declinazione puramente teoretica della filosofia. Privilegiare l’approccio teoretico – che si sia consapevoli o no di farlo – conduce all’adozione di un punto di vista assoluto sulle cose, e all’inazione. In uno dei passi dei Quaderni in cui Sartre si pone il problema di come affrontare da un punto di vista esistenzialistico la storia si ritrova questa affermazione:
È curioso che il sistema hegeliano, così attivo, così ricco di lavoro e di travagli si chiuda nella contemplazione. Se la contemplazione ne è la conclusione questo significa che ne era anche l’origine. Tutto il sistema sprofonda nella pura inattività contemplativa, come lo prova il fatto che tutti gli atteggiamenti esistenziali sono descritti da Hegel nella più totale indifferenza69.
Il predominio di un punto di vista teoretico equivale allo smantella-mento del nostro essere esseri umani, poiché esso fa venire meno quella che è la rivelazione della nostra libertà e della necessità di inventare noi stessi agendo nel mondo. Ma essere esseri umani è essere desideranti: e perciò, un simile punto di vista non può che smantellare i caratteri centra-li stessi del nostro desiderio.
Between Alienation and Revelation. The Critique of Hegel’s Notion of «Begierde» in Jean-Paul Sartre’s «Cahiers pour une morale»
In Sartre’s Cahiers pour une morale the category of Desire (Begierde) is built through a critical dialogue with Hegel’s Phänomenologie des Geistes devoted to the same theme. An analysis of Sartre’s account of Desire allows, on the one hand, to gather some elements for a general comparison between Sartre’s and Hegel’s philosophies and, on the other, for an investigation of the problematic core of the unfinished Cahiers – how it is possible to conceive moral relations between human beings within the ontology of L’être e le néant. Moreover, through this work of analysis it is possible to reconstruct the conception
69 Ibidem, p. 90.
282 Pierfrancesco Biasetti
elaborated by Sartre of the variety of historical worlds and of the possibility for human societies to go through them.
Keywords: Hegel, Sartre, Desire, Alienation, Revelation.
Pierfrancesco Biasetti, Università di Padova, Fi.S.P.P.A., Piazza del Capitaniato 3, 35121 Padova, [email protected].