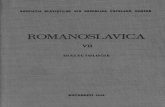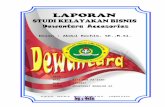Strumenti musicali Grecia-Etruria-Roma, in Enciclopedia dell'Arte Antica, Supplemento
Studi epigrafici su Aletrium antica
-
Upload
it-uniroma1 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Studi epigrafici su Aletrium antica
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO
FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN FILOLOGIA GRECA E LATINA
TESI DI LAUREA IN
STORIA ROMANA
STUDI EPIGRAFICI SU ALETRIUM ANTICA
RELATORE: CANDIDATO: Chiar.mo Prof.re Pietro Garofoli Ignazio Tantillo Matr. 0027555 CORRELATORE: Dott. Lucio Del Corso
ANNO ACCADEMICO 2009/2010
Studi epigrafici su Aletrium antica – Introduzione _____________________________________________________________________________________
1
I
1.1 Etimologia del toponimo Aletrium.
Lo studio più approfondito e attendibile sull’origine del nome della città è quello
condotto da L. Gasperini nel 1965 (pp. 11 sgg.), del quale vengono riproposte, in questa
sede, le argomentazioni principali.
La forma latina del nome – universalmente accettata – è Aletrium: la tramanda
un’iscrizione locale d’età imperiale (CIL X 5832, da Ferentinum), nella quale si legge
l’espressione municipio Aletri; lo stesso toponimo, nella forma greca Aλέτριον, è
riportato da Strabone (5, 3, 10). Ad esso risale l’etnico Aletrinas, -atis, largamente
attestato nei testi letterari1 ed epigrafici2. La variante Alatrium, prevalsa nel Medioevo e
all’origine del moderno toponimo Alatri, è documentata da Plauto (Capt. 883) e dal
Liber coloniarum3; essa riprodurrebbe l’antica pronuncia popolare.
Discussa è l’origine del nome Aletrium. Nella lingua di Roma la radice ale-/alet- si
ritrova solo nel raro aletudo, -inis4, termine derivante forse da alo ed esprimente l’idea
di “pinguedine, corpulenza”, che potrebbe al limite accordarsi con la forma
«mammellare»5 della collina su cui sorge la città. Ancor più incerto il confronto col
fitònimo alaternus di COLUM. 7, 6 e PLIN. nat. 16, 45, 16.
Il radicale ale-/alet- è meglio documentato nelle forme nominali etrusche – come ad
es. il gentilizio Aleθna (lat. Aletius) – ma richiama anche toponimi come Aletium 1 Cfr. CIC. Cluent. 16, 46; 17, 49; 20, 56; LIV. 9, 42, 11; 9, 43, 23; PLIN. nat. 3, 5, 63; PRISC. gramm. II p.
348, 20-21 ed. Keil. 2 CIL X 5808-5809 = nn. 3 e 4. Incerto è il caso dell’iscr. nr. 5 della presente raccolta (v. infra), poiché [-
- - A]letr[i - - -] potrebbe essere inteso sia come il nome della città sia come l’etnico Aletrinas. 3 Cfr. LIB. col. I p. 230, 7-9 ed. Lachmann. 4 Cfr. FEST. verb. sign. 27, ed. Lindsay. 5 GASPERINI 1965, p. 11, nt. 1. 6 Potrebbe aggiungersi, come ulteriore confronto, la radice greca *ειλω/αλ = “stringo, chiudo, serro” ecc.,
in rapporto alla presenza di una cinta muraria fortificata intorno alla città (così Suppl.It. 16, p. 17).
Studi epigrafici su Aletrium antica – Introduzione _____________________________________________________________________________________
2
(Aλέτιον) e *Aletrum/*Aletrium in Italia7, Aletum e pagus Aletanus in Gallia (risp.
Lugdunense e Narbonense), e forse anche Alesia (G. Lugdunense) e Aleria (Corsica)8.
L’etnico Aletrinas, -atis presenta una terminazione abbastanza diffusa in Italia,
soprattutto nell’area dell’Appennino centro-meridionale, dove si hanno diversi esempi
di –n– eufonica frapposta tra radicale e suffisso aggettivale (cfr. Asisi-n-as, etnico di
Asisium; Aesi-n-as, etnico di Aesis; Liri-n-as/Lire-n-as, derivato del vicino idronimo
Liris)9.
Alla luce di questi confronti è possibile ipotizzare un’origine preromana della forma
Aletrium, probabilmente ernico-etrusca: essa presenta infatti la stessa formazione di
Sutrium e Volaterrae, due toponimi – ricostruiti rispettivamente come *Suθri e *Velaθri
– molto simili all’originario *Aleθri. La presenza in questa regione di un toponimo
etruscheggiante non è affatto strana: la recente scoperta di bucchero e di ceramica
etrusco-corinzia in due stipi votive anagnine (risp. di VIII-V e di VII sec. a.C.), nonché i
modesti rinvenimenti di bucchero in contrada S. Quinziano ad Alatri, proverebbero, del
resto, che l’area era lambita dall’asse commerciale che collegava l’Etruria alla
Campania, e che, quindi, non era esente dall’influenza etrusca10.
1.2 Cenni storici sulla città alla luce delle fonti letterarie.
Gli autori antichi che ci forniscono notizie su Aletrium – già recensiti da Mommsen
in CIL X (p. 566) – non sono molti. Primo, in ordine di tempo, è Cicerone, che in tre
passi della Pro Cluentio (16, 46; 17, 49; 20, 56) ricorda gli Aletrinates: nel primo – il
più interessante dei tre – l’Arpinate menziona C. et L. Fabricii fratres gemini... ex
municipio Aletrinati. Da questa semplice citazione apprendiamo che – all’epoca di
Cicerone – Alatri era retta con ordinamento municipale e che vi esisteva una gens, la
7 Su questi due toponimi GASPERINI 1965, p. 12, nt. 5, riferisce: « Il primo, in vista del sinus Tarentinus e
presso la punta meridionale della Calabria, corrisponde all’odierna Alizza; il secondo, ricostruibile in
base all’etnico Aletrinus (cfr. PLIN. nat. 3, 105), è forse ubicabile nella Lucania settentrionale, lungo la
via Herculia». 8 Così GASPERINI 1965, p. 12. 9 Ibid. 10 Cfr. Suppl.It. 16, p. 17 (con ampia bibliografia circa i ritrovamenti ceramici); inoltre GASPERINI 1965,
p. 12, nt. 4, che cita altri esempi di toponimi etruscheggianti nella zona di Alatri.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Introduzione _____________________________________________________________________________________
3
Fabricia, che non compare mai nei testi epigrafici. Negli altri due passi Cicerone elogia
gli amici Aletrinates per il peso dei loro voti nell’esito delle sue ambizioni politiche.
Segue Livio – l’unico che ci tramandi notizie storiche sulla città – da cui sappiamo
dell’appartenenza di Aletrium al popolo ernico e della politica che, insieme alle città
vicine, essa condusse nei riguardi di Roma.
Popolazione di stirpe italica, probabile sottogruppo dei Sabini11, gli Ernici ebbero
quattro importanti centri (Anagnia, Ferentinum, Aletrium, Verulae), il primo dei quali si
distinse per prestigio e influenza sugli altri, ospitando la sede comune delle adunanze
politiche (cfr. LIV. 9, 42). Si ha notizia di rapporti con Roma già alla fine dell’età regia,
quando Tarquinio il Superbo inviò legati agli Ernici e ai Volsci per proporre loro
un’alleanza, da essi prontamente sottoscritta (cfr. DIONYS ant. 4, 49). I patti, però,
vennero ben presto disattesi dopo la cacciata di Tarquinio, nel 487 a.C., quando gli
Ernici insorsero contro i Romani (cfr. DIONYS. ant. 8, 64), generando la dura reazione di
quest’ultimi, che saccheggiarono il territorio ernico e imposero alle città condizioni di
pace a base di denaro e viveri (cfr. DIONYS. ant. 8, 68; LIV. 2, 41). Ciò nonostante il
Senato, allo scopo di isolare i bellicosi Equi e Volsci, offrì agli Ernici nuova alleanza e
parità di diritti, e questi, stando a Livio (6, 2-3), «mai furono di fedeltà dubbia
nell’amicizia del popolo romano». Queste relazioni pienamente amichevoli durarono
inalterate fino alla presa di Veio, in occasione della quale Camillo ringraziò in Senato
Latini ed Ernici per lo spontaneo contributo prestato alla guerra (cfr. LIV. 5, 19). Ma una
nuova rivolta ernica contro Roma si ebbe subito dopo l’invasione dei Galli: vinti
dapprima nel 386 e nel 385 a.C., gli Ernici piegarono gli eserciti romani nel 362 e solo
intorno al 357 – dopo aver subito a loro volta una dura sconfitta – rientrarono nella lega
(cfr. LIV. 7, 15). Forse qualche anno dopo (354?) – stando sempre a Livio (cfr. ibid.) –
ampie zone di suolo ernico furono confiscate dai Romani e inserite nella nuova tribù
rustica Publilia.
Nel 307 il proconsole Fabio, sconfitti i Sanniti al Volturno, catturò tra i numerosi
prigionieri una minoranza di Ernici: non essendo chiaro il carattere della loro
partecipazione, essi furono imprigionati in attesa di giudizio (cfr. LIV. 42, 11). Fu forse
questo episodio ad alimentare l’ultima fiammata autonomistica degli Ernici, con esito,
ancora una volta, sfavorevole: nel 306 il console Quinto Marcio Tremulo inflisse loro 11 Sabina, secondo Servio (Aen. 7, 684), sarebbe la parola herna = saxum, da cui deriverebbe l’«ethnos»
Ernici.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Introduzione _____________________________________________________________________________________
4
un’altra sconfitta, costringendoli alla resa. Molto dovette influire la grande disparità
delle forze in campo, determinata dal fatto che Aletrium, Ferentinum e Verulae – tre
delle più importanti città erniche – si mantennero fedeli a Roma. La loro fedeltà fu
ripagata al momento della concessione della pace e dello scioglimento della Lega
Ernica (304): mentre i centri ribelli furono costretti alla deditio e ottennero la civitas
sine suffragio, le tre città fedeli conservarono la loro autonomia, traendo anche il diritto
di conubium inter ipsos (cfr. LIV. 9, 43, 23-24). La stessa fedeltà a Roma dimostrò
ancora una volta Aletrium durante la guerra sociale; proprio per questo, in base alla lex
Iulia de civitate Latinis et sociis danda dell’anno 90 a.C., la città poté entrare nel novero
dei municipi.
1.3 Ordinamento amministrativo.
Notizie sull’organizzazione amministrativa di Aletrium nel periodo anteriore alla
guerra sociale (90 a.C.) ci provengono dall’iscrizione di Lucio Betilieno Varo (vd. infra,
nr. 1), contenente la prima menzione del senato locale, del quale ci rivela due delle sue
molteplici competenze. La prima è una deliberazione concernente la costruzione delle
numerose opere pubbliche ricordate nell’epigrafe; la seconda è un provvedimento
abbastanza interessante e raro, ovvero la concessione di un esonero dal servizio militare
per il figlio di un magistrato benemerito (Betilieno Varo). La stessa iscrizione ci
testimonia l’esistenza di un’importante magistratura, la censura, generalmente
considerata anteriore al quattuorvirato e forse abolita con l’avvento di questo. Dei due
censores che dovettero dividersi, come altrove12, le numerose incombenze, si ha
testimonianza del solo Betilieno Varo, che espletò la carica in maniera così convincente
da riscuotere il favore della cittadinanza e dell’ordine senatorio, ricevendo anche –
come segno di riconoscenza – l’onore di una statua e un secondo incarico che gli valse
l’appellativo di Censorinus.
Che la magistratura suprema nell’Aletrium del II-I sec. a.C. fosse stata la censura è
però una questione che divide gli studiosi. Sulla base del confronto con la vicina
Ferentinum, governata da una coppia di censori (cfr. iscr. cit. in nt. 12 e inoltre CIL X
5838-5840), L. Gasperini ed E. De Ruggiero la ritenevano tale13; altri invece, tra cui L.
12 Cfr. ad es. CIL X 5837, dalla vicina Ferentinum. 13 Cfr. risp. GASPERINI 1965, p. 83 e DE I, p. 396.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Introduzione _____________________________________________________________________________________
5
Galli e G. L. Gregori14, visto che questa carica è attestata da una sola iscrizione –
proprio quella di Betilieno Varo (infra, nr. 1) – ipotizzano invece che ad Alatri la
censura abbia avuto un carattere straordinario. Si potrebbe allora pensare a una coppia
di praetores a guida della città, eredi di precedenti meddices e affiancati dal senato
locale15. La documentazione epigrafica sulla pretura di Aletrium, però, è ancora più
scarsa: l’unica menzione riguarda un praetor sacrale in un’epigrafe della prima età
imperiale16. In mancanza di una documentazione più esaustiva, dunque, verrebbe da
considerare la censura come la più alta carica politica esistente in città prima
dell’acquisizione del nuovo status costituzionale, ma la questione rimane aperta.
In effetti, come precedentemente accennato, dopo la guerra sociale gli Aletrinates
divennero cives optimo iure e furono costituiti in municipium17. Il nuovo ordinamento
municipale appare presieduto da quattro magistrati supremi denominati quattuorviri
(cfr. nt. 17 e CIL X 5806), eletti annualmente tra i decuriones, ovvero tra i membri del
consiglio cittadino (vd. infra, iscr. nn. 3 e 14c). Per accedere a tale dignità i quattuorviri
dovevano possedere, oltre l’ingenuitas, vari altri requisiti morali, di età e di censo. Ad
essi erano affidati dall’ordo decurionum numerosi incarichi quali la costruzione a spese
della città di nuovi edifici od opere di pubblica utilità, come nel caso della già citata CIL
X 580618.
Gli abitanti del nuovo municipio vennero probabilmente ascritti alla tribù Publilia
(cfr. CIL X 5832; LIV. 7, 15), così come quelli di Anagnia e Ferentinum, anche se nel
territorio sono testimoniate pure l’Aniensis (CIL X 5817) e la Romilia (CIL X 5811).
14 Cfr. Suppl.It. 16, p. 18. 15 Ibid. 16 Trattasi della già citata CIL X 5832, iscrizione molto importante non solo dal punto di vista
toponomastico (cfr. supra), ma anche perché ci chiarisce quali fossero le magistrature municipali della
città. Vi trovano menzione, infatti, nell’ordine, le seguenti cariche: pretura, edilità e quattuorvirato iure
dicundo; dal momento che la sequela normale delle cariche del cursus honorum municipale esigerebbe
l’edilità prima della pretura, quest’ultima dignità dev’essere ritenuta più di carattere religioso che civile,
come già sostenuto da Mommsen nella sua introduzione storico-epigrafica su Aletrium (CIL X, p. 566):
«Praetor [...] sacerdotis locum videtur obtinuisse». Dello stesso avviso GASPERINI 1965, pp. 84-85 e
Suppl.It. 16, p. 18. 17 Cfr. CIC. Cluent. 16, 46; CIL X 5832 (cfr. nt. prec.); iscr. nr. 3 (infra); PRISCIAN. II p. 348, 20-21 ed.
Keil. 18 Su questa epigrafe vd. anche infra, iscr. nr. 1, in particolare nt. 17.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Introduzione _____________________________________________________________________________________
6
Quest’ultimi due casi potrebbero però riguardare persone oriunde da centri vicini
(incolae) o semplicemente di passaggio, provenienti da Capitulum Hernicum (Piglio) o
da Treba Augusta (Trevi nel Lazio) per quanto attiene all’Aniensis, da Sora per la
Romilia19.
In prosieguo di tempo non dovettero verificarsi significativi mutamenti costituzionali,
sebbene il Liber Coloniarum ricordi la deduzione di una colonia ad Alatrium20; questa
località, tuttavia, sembra non possa coincidere con la nostra Aletrium, ma piuttosto con
una città omonima – nota da Plinio (cfr. nt. 7) – situata nella Lucania settentrionale21.
1.4 Storia degli studi epigrafici su Aletrium.
Al XVI sec. risalgono le prime trascrizioni di epigrafi pertinenti Aletrium, contenute
nelle opere di Martin Smetius, Pirro Ligorio, Onofrio Panvinio e Aldo Manuzio il
giovane (= CIL X 5807, 5808, 5809, 5815, 5832).
Successivamente, solo agli inizi dell’Ottocento, Marianna Candida Dionigi,
richiamata dalla mole delle mura poligonali, dedica una sezione del suo Viaggj in
alcune città di Lazio (1809) alla cittadina ernica, riportandone anche alcuni tituli (= CIL
X 5807-5808). Non molto tempo dopo Giuseppe Marocco, nel quattordicesimo volume
dei suoi Monumenti dello Stato Pontificio e relazione topografica di ogni paese – editi a
Roma tra il 1828 e il 1837 – cura una prima edizione del materiale epigrafico locale (=
CIL X 5803-4-5, 5807, 5808, 5809, 5810, 5811, 5813, 5814, 5817, 5819).
Iscrizioni alatrensi autentiche, insieme a numerosi falsi e a monumenti di altre
località, sono contenute anche nei manoscritti di due storici locali: Cherubino Toti,
autore di una Storia dell’antichissima ed illustre città di Alatri, capitale un tempo degli
Ernici, e Salvatore Brocchetti, al quale si deve la redazione di una Cronaca Alatrina
(1871-1875).
Ma solo nel 1883 si giunge alla prima pubblicazione scientifica delle epigrafi di Alatri
e del suo agro, con l’uscita del X volume del Corpus Inscriptionum Latinarum (nn.
19 Così GASPERINI 1965, p. 84, che ritiene Anagnia ascritta alla Publilia prima di Aletrium e Ferentinum
(aggiunte alla stessa tribù dopo la guerra sociale), e Suppl.It. 16, pp. 18-19, che esprime minore certezza
circa l’assegnazione di Aletrium alla Publilia sulla base della provenienza, ferentinate e non alatrense, di
CIL X 5832. 20 Cfr. LIB. col. I p. 230, 7-9 ed. Lachmann. 21 Così GASPERINI 1965, p. 84, nt. 81; Suppl.It. 16, p. 19.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Introduzione _____________________________________________________________________________________
7
5800-5819), edito a cura di Th. Mommsen, che per la redazione delle schede si avvale
della collaborazione di De Rossi, Detlefsen, Zangemeister e, in un paio di casi, anche di
Stevensonn e Garrucci.
Non sostanziale in seguito il contributo della rivista Ephemeris Epigraphica (vol.
VIII, 1899), a cura di Maximilian Ihm, con il miglioramento della lettura di un testo già
pubblicato (CIL X 5800) e l’edizione di un nuovo frammento segnalato da Fiorelli nelle
Notizie degli Scavi di antichità del 1884 (vd. infra, nr. 11).
I lavori successivi sono approntati sul modello dell’edizione mommseniana: è questo
il caso delle opere di G. Pierleoni – autore de Le antichità di Alatri (1916) – di V.
Quattro Ciocchi (Gli Ernici ed il loro territorio, 1928) e di A. Sacchetti Sassetti (Storia
di Alatri, 1947); il contributo di quest’ultimo, nello specifico, merita una particolare
menzione per l’estesa descrizione, oltre che dei più importanti tituli di Alatri, anche dei
suoi principali resti archeologici di età romana.
A distanza di un ventennio (1965) L. Gasperini, nell’intento di realizzare un’edizione
rivista e aggiornata delle epigrafi alatrensi, ripubblica, per la prima volta con fotografie
e disegni, nei Quaderni dell’Istituto di Storia ed Arte del Lazio Meridionale, le
iscrizioni già edite nel CIL e quelle di posteriore rinvenimento, in parte già trattate dallo
stesso autore in un articolo della rivista Archeologia Classica (1960).
Gli ultimi lavori scientifici riguardanti le iscrizioni romane di Alatri risalgono agli anni
1997-1998, che si segnalano per la pubblicazione di due importanti contributi: il primo,
intitolato Le iscrizioni romane del Museo Civico di Alatri, redatto da L. Galli e incluso
nella rassegna Studi Ernici (curata da G. Manchia, precedente direttore del Museo22),
comprende 12 iscrizioni già pubblicate dagli editori del CIL, 12 edite successivamente e
un’epigrafe di recente acquisizione pubblicata dall’autore per la prima volta (= nr. 23,
pp. 68-69 dell’op. cit.). Il secondo lavoro, realizzato dallo stesso Galli in collaborazione
con G. L. Gregori, viene pubblicato all’interno del sedicesimo volume della collana
Supplementa Italica (pp. 13-90) e costituisce, insieme alla pregevole pubblicazione
gasperiniana del 1965, l’edizione a tutt’oggi più completa del materiale epigrafico
alatrense. Essa comprende, infatti, tutte le 75 epigrafi latine rinvenute o, comunque,
22 Il lavoro di Galli è stato successivamente (2002) riedito in un’altra pubblicazione curata dallo stesso G.
Manchia, intitolata Antichità Alatrensi; ad essa si farà riferimento nel prosieguo della presente trattazione,
attraverso l’abbreviazione bibliografica GALLI 2002.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Introduzione _____________________________________________________________________________________
8
riferibili ad Aletrium, corredate da un’ampia sezione introduttiva di carattere epigrafico,
storico-letterario e topografico-archeologico sulla città.
A tutti questi contributi si aggiungono le schede relative ad Aletrium inserite ne
L’Anneé Épigraphique – con un’ampia sezione nel volume dell’anno 1998 – o in
corpora epigrafici come le Inscriptiones Latinae Selectae di H. Dessau e le
Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae di A. De Grassi.
1.5 Premessa alla presente edizione.
Il piccolo corpus epigrafico che segue questa introduzione annovera 18 delle 75
iscrizioni romane riferibili ad Aletrium, ordinate secondo un criterio quanto più
possibile cronologico. La selezione delle 18 epigrafi è stata effettuata essenzialmente su
basi contenutistiche, privilegiando le iscrizioni onorarie (nn. 3, 6, 11, 12, 13, 14) e altre
considerate particolarmente interessanti sotto vari aspetti; altre ancora sono state scelte
in quanto ritenute suscettibili d’interpretazione più accurata.
Nella classe delle iscrizioni onorarie – senza ricorrere a ulteriori suddivisioni
tipologiche – si è pensato d’inserire anche le tre dediche imperiali (nn. 6, 13, 14)
presenti nella raccolta23. Attinenti alla vita “municipale” pubblica sono i tituli nn. 1 e 8,
con il primo di questi che mostra, al contempo, aspetti propri dell’iscrizione onoraria e
del titulus operum publicorum; quest’ultima categoria include anche l’epigrafe nr. 2.
Probabilmente di carattere sacro è la nr. 9. La nr. 10 è un instrumentum domesticum.
L’epigrafe nr. 17 è un carmen epigraphicum sepolcrale. Le restanti iscrizioni (nn. 4, 5,
7, 16, 18) – in prevalenza frustuli – sono d’incerta natura.
Il corpus abbraccia un arco cronologico che va dall’età repubblicana (nn. 1 e 2) al
tardo impero (nr. 16?); la maggioranza dei documenti si colloca in piena età imperiale
(nn. 3-14), mentre per alcuni (nn. 16 e 18) – irreperibili o estremamente frammentari –
non si è potuto stabilire una datazione certa.
I criteri adottati per la trascrizione dei testi epigrafici, così come i segni diacritici
impiegati, rispondono in pieno alle direttive che da tempo orientano l’usus scribendi
delle moderne edizioni epigrafiche, nello specifico a quelle teorizzate da S. Panciera
23 Complessivamente le iscrizioni onorarie per imperatori sono in realtà 5, poiché la nr. 14 è un palinsesto
epigrafico con tre dediche imperiali.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Introduzione _____________________________________________________________________________________
9
nell’ottavo volume dei Supplementa Italica24. Nella trascrizione dei tituli, tuttavia, si è
preferito omettere la punteggiatura interpretativa, poiché la struttura sintattica degli
stessi risulta chiaramente intelligibile dalla traduzione che li accompagna.
Ogni scheda del catalogo è strutturata secondo il seguente ordine:
a) bibliografia sintetica;
b) descrizione fisica del monumento;
c) luogo di rinvenimento e di conservazione;
d) fotografia;
e) trascrizione interpretativa;
f) apparato critico;
g) traduzione del testo;
h) commento paleografico;
i) particolarità linguistiche (laddove presenti);
j) esegesi;
k) datazione.
10 delle 18 iscrizioni della raccolta sono state viste e fotografate dall’autore (nn. 1, 2,
4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15); delle restanti 8, 6 epigrafi sono attualmente irreperibili (nn. 3,
8, 13, 16, 17, 18) e 2 non è stato possibile visionarle perché conservate in aree
inaccessibili di strutture museali (nr. 10) o in abitazioni private (nr. 9). Di queste, così
come dell’iscrizione nr. 8 – visibile ancora negli anni ’60 – viene riportata una
fotografia tratta da altre fonti.
Come strumenti esegetici accessori, si è ritenuto opportuno inserire, di seguito, una
tabella con la lista completa dei luoghi di rinvenimento e di conservazione delle
iscrizioni studiate e due immagini relative al territorio e alla topografia di Alatri.
Dopo il catalogo delle iscrizioni, due tabelle di conguaglio e alcuni indici epigrafici
avvieranno alla conclusione del presente lavoro.
24 S. Panciera, Struttura dei supplementi e segni diacritici dieci anni dopo, in Supplementa Italica, n. s. 8,
Roma 1991, pp. 9-21.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Introduzione _____________________________________________________________________________________
10
Tab. 1: Lista completa dei luoghi di rinvenimento e conservazione delle epigrafi studiate.
Nr.
Iscr.
Provenienza Luogo di conservazione
1 Alatri, Piazza S.
Maria Maggiore
Alatri, Museo Civico
2 Alatri, chiesa di S.
Maria Maggiore (?)
Alatri, chiesa di S. Maria Maggiore
3 Alatri, cattedrale di S.
Paolo
Perduta
4 Ignota Alatri, Museo Civico
5 Ignota Alatri, chiesa di S. Maria Maggiore
6 a: Alatri, cortile casa
Tagliaferri
b: ignota
a: perduta
b: Alatri, studio dell’avv. P. De Cesaris
7 Ignota Alatri, studio dell’avv. P. De Cesaris
8 Ignota Perduta
9 Guarcino, loc.
Porretta della Cisterna
Originale perduto; 2 ricostruzioni moderne
conservate a Guarcino (famiglia Ciavardini) e
Frosinone (Archivio di Stato).
10 Ignota Alatri, Museo Civico
11 a: Alatri, Abbadia di
S. Sebastiano
b: ignota
a: perduta
b: Alatri, Abbadia di S. Sebastiano
12 Fumone, loc. Monte
Drago
Fumone, Municipio
13 Ignota Perduta
14 Ignota Alatri, Museo Civico
15 Ignota Alatri, Abbadia di S. Sebastiano
16 Alatri, Abbadia di S.
Sebastiano (?)
Perduta
17 Ignota Perduta
18 Ignota Perduta
Studi epigrafici su Aletrium antica – Introduzione _____________________________________________________________________________________
11
Fig. 1: Pianta del centro storico di Alatri (fonte: Forma Urbis 6, 2008, p. 7).
Studi epigrafici su Aletrium antica – Introduzione _____________________________________________________________________________________
12
Fig. 2: Ricostruzione ipotetica dei confini del municipium di Aletrium. Scala 1:200.000 (fonte:
Suppl.It. 16, p. 30).
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
13
1. Bibliografia: STEVENSON, ms., ff. 83 v., 84 r., 84 v.; AJOSSA, ms., f. 50
v.; CIL I 1166 (ivi bibl. prec.); TOTI, ms., p. 31, nr. 2, p. 60, nr. 2;
BROCCHETTI, ms., p. 45; WILLMANNS 1873, nr. 706; CIL X 5807 (ivi bibl.
prec.); ILS 5348; DE RUGGIERO 1904, nr. 2004; DAMSTÉ 1910, p. 233;
ROSENBERG 1913, p. 34; P IERLEONI 1916, pp. 32-33; CIL I² 1529 ( ivi bibl.
prec.), cfr. pp. 730, 840, 1003, 1008; QUATTRO CIOCCHI 1928, pp. 79 sgg.;
VAN BUREN 1934, pp. 137-144; SACCHETTI SASSETTI 1947, pp. 5-8 e nt. 16;
WARMINGTON 1953², pp. 146-147, nr. 6; CARENA 1954, pp. 24-25, nr. 4;
WARD PERKINS 1955, p. 117, nt. 4; SACCHETTI SASSETTI 1957, p. 5 (con
foto); ILLRP 528; GASPERINI 1965, pp. 16-19, nr. 1 (con foto); FLORIDI
1971, pp. 13-15 e nt. 3; ZEVI 1976, p. 84; MANSUELLI 1976/77, pp. 121-
122; DEVIJVER-VAN WONTERGHEM 1981, p. 38, nr. 9; ID. 1984, p. 197, nr.
9; GERMONI 1987, pp. 6, 9, 11 e nt. 21; SOMMELLA 1988, p. 37; COARELLI
1993, pp. 196-197; DEVIJVER-VAN WONTERGHEM 1994, pp. 1038-1039, nr.
1, p. 1057, nt. 34; Suppl.It. 16, 1998, pp. 36-38, nr. 5807; GALLI 2002, pp.
41-45, nr. 4, p. 93, fig. 4 (foto); AE 2006, nr. 136.
Lastra rettangolare di pietra calcarea locale1 mancante in basso a destra,
scheggiata in più punt i lungo i margini inferiore e sinistro, con for i per
grappe sui fianchi e in alto. Dimensioni: 68 x 58,8 x 14,8 cm; alt. lett. 2,7-
2,5 cm. Rinvenuta nel XVIII sec. in Piazza S. Maria Maggiore insieme a
«un condotto di metallo fuso entro una fodera di piombo incassato in pietra
di grossa mole»2; g ià conservata nel palazzo comunale e poi nella
Biblioteca del locale Liceo-Ginnasio, si trova attualmente nel Museo
Civico di Alatri. Autopsia 2010.
1 GASPERINI 1965, p. 16, nt. 18, precisa: «Calcare risultante di detriti cementati naturalmente, di età
geologica relativamente recente (Pleistocene continentale)». 2 Cfr. introduzione di Mommsen in CIL X, cit., p. 567 = CIL I², cit., p. 630.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
14
L(ucius) Betil ienus L(uci) f( il ius) Vaarus
haec quae infera scripta
sont de senatu sententia
facienda coiravit semitas
5 in oppido omnis porticum qua
in arcem eitur campum ubei
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
15
ludunt horologium macelum
basil icam calecandam seedes
[l]a cum balinearium lacum ad
10 [p]ortam aquam in opidum adqu(e)
arduom pedes CCCXL fornicesq(ue)
fecit f istulas soledas fecit
ob hasce res censorem fecere ̀bis΄
senatus fil io stipendia mereta
15 ese iousit populsque statuam
donavit Censorino.
9 l a cum Gasperini; [ l]a cum Suppl.It. 16; 10 porta[nd]am Sacchetti
Sassetti; portam Pierleoni, Germoni; p ortam Gasperini; [p]ortam Suppl.It.
16; adqu(e) Warminghton, Ward Perkins, ILLRP, Mansuelli, Coarelli,
Sommella, Suppl.It. 16 et al. ; adque (scil. atque) Sacchetti Sassetti ; quasi
error pro adque (scil. et ad) CIL X, De Ruggiero, CIL I², Devijer-Van
Wonterghem; adou[- - -] Stevenson, Brocchetti, ILS, Pierleoni, Quattro
Ciocchi, Van Buren, Floridi, Germoni; adou[c(entem)] «con C dipinta sul
giunto di connessione con una lastra a destra» Gasperini, Zevi;
adou(cendam) [scil. aquam] Damsté; 12 Litterae erasae in margine dextro;
13 bis extra versum postea adiectum est.
“Lucio Bet ileno Varo, figlio di Lucio, su delibera del senato fece
costruire le opere di seguito elencate: tutte le vie entro l’abitato, il portico
di accesso alla rocca, il campo dove si esercitano (i soldat i), l’orologio
(solare), il mercato (coperto), la basilica (ancora) da intonacare, i sedili, la
piscina per i bagni, la cisterna presso la porta e l’acquedotto (che arriva) in
città, (superando) un dislivello di 340 piedi; fece inoltre (costruire) le
arcate e tubature rinforzate. Per queste opere (lo) elessero due volte
censore, il senato ordinò che (suo) figlio fosse esonerato dal servizio
militare e il popolo dedicò una statua, a (lui), (detto il) «Censorino»”.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
16
Lettere quadratae, incise in modo molto accurato; l’interpunzione,
cost ituita da due tratt ini incrociat i a forma di X, è usata con la massima
regolarità; il BIS di r. 13 è da tutti ritenuto un’aggiunta posteriore, per via
delle lettere di solco meno profondo e dello scarso rispetto dell’ordinatio;
dopo mereta (r. 14) segno d’interpunzione a croce di S. Andrea.
Forme arcaiche: Vaarus per Varus; infera per infra; sont per sunt; senatu
per senatus; coiravit per curavit; omnis per omnes; eitur per itur; ubei per
ubi; seedes per sedes; arduom per ardum; soledas per solidas; mereta per
merita; iousit per iussit.
Secondo Gasperini, la mancata geminazione in macelum, opidum, ese e
iousit sarebbe motivata dalla ristrettezza dello spazio a disposizione:
potrebbe dimostrarlo la variante oppido in r. 5, nonchè la piccola M finale
di macelum (r. 7) o la Q nana di fornicesq(ue) [r. 11], entrambe in fin di
riga3. L’espressione porticum qua in arcem eitur r icorre quasi nella stessa
forma in un’iscr izione da Frigento4.
L’epigrafe commemora la realizzazione di una serie di intervent i – volt i a
rinnovare profondamente l’edilizia pubblica e la stessa struttura urbanist ica
della città – ad opera di Lucio Bet ilieno Varo, l’esponente più illustre della
gens più ant ica e nobile di Aletrium.
Di origine probabilmente sabina 5, la gens dei Betilieni è attestata
soprattutto nella cittadina ernica, ma talvolta appare anche altrove, sempre
o quasi nell’ambito della I regio Augusta. Secondo una probabile
genealogia, nella pr ima metà del II sec. a.C. visse forse Lucius Betilienus,
primo personaggio a noi noto, padre del nostro Censorinus. Un Marcus
Betilienus è poi ricordato nell’iscrizione nr. 2 (vd. infra) come genitore dei
due fratelli Marco e Gaio, che attesero a un probabile restauro del tempio
di Giove; è verosimile che questo Marcus fosse fratello di Lucio padre e
3 Cfr. GASPERINI 1965, pp. 17- 18. 4 Cfr. ILLRP 599: ...fornic[em] / qua in foro eitu[r]. 5 Cfr. SHULZE 1904, pp. 403, 406, 440, che ritiene il gentilizio derivato da Betius attraverso
Betulius/Betilius; l’origine sabina sarebbe provata sia dalla supposta appartenenza degli Ernici allo stesso
ceppo Italico-orientale, sia dalla terminazione, di stampo sabellico, del gentilizio (così GALLI 2002, p.
44).
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
17
che i suoi figli fossero pertanto cugini di Varo. Con il quattuorviro Publius
Betilienus M(arci) f(ilius) Hap(alus)6 – probabile figlio del Marcus cugino
di Varo – abbiamo l’ult ima menzione dei Bet ilieni ad Aletrium. Fino alla
guerra sociale (90 a.C.) questa famiglia è fiorente e i suoi membri, «quasi
monopolizzatori del potere»7, si succedono nell’amministrazione della città.
Tale periodo coincide con l’apertura verso l’Urbe dei mercat i del
Mediterraneo orientale; sulla scia di questa nuova espansione commerciale
le aristocrazie italiche iniziarono ad accumulare ingent i capitali, operando
come publicani o negotiatores8. L’att ività “imprenditoriale” sembra
interessare anche i Bet ilieni, e ciò trova conferma in numerosi bolli di
anfore olearie e vinarie – in prevalenza brindisine, della pr ima metà del I
sec. a.C. – recant i il nome di alcuni schiavi di un Marco Bet ilieno 9, forse
fratello del IIIIvir, oppure appartenente alla generazione precedente. Un
[B]etil<i>enus Q(uinti) f(ilius) Marcel(lus) è probabilmente menzionato,
poi, in un’iscrizione tardo-repubblicana, frammentaria, di Delo 10 –
contenente la dedica di un portico ad Apollo e agli Italici – che attesterebbe
un ulter iore ramo di discendenza da un Quintus Betilienus altr iment i
ignoto.
Le tracce della gens si perdono poco dopo il 90 a.C.; la sua totale
scomparsa dall’onomast ica locale è forse da porre in relazione con le
proscrizioni sillane, essendo la famiglia – o almeno i suoi membri più in
6 Cfr. CIL X 5806 = CIL I² 1530 (cfr. p. 1003) = ILLRP 529. 7 GASPERINI 1965, p. 88. 8 Cfr. GALLI 2002, p. 44. 9 Cfr. CIL IX 6079 11, dall’agro brindisino: Lucr(rio?) Be[t]il(ieni) M(arci) s(ervus); CIL IX 6079 12,
stessa provenienza: Mar(cipor?) Betil(ieni) [scil. servus, NdA]; CIL IX 6079 13, stessa provenienza:
Metr(odorus) Be[t]il(ieni) / M(arci) s(ervus); CIL IX 6079 14, stessa provenienza (con cognome
grecanico): Pil.Betil(ieni) M(arci) [s(ervus)]; Eph. Epigr. V 1427 = CIL III 7309, da Delo (con cognome
grecanico): Pil.Betil(ieni) M(arci). Tuttavia, nel Mar. Be[t]il. di CIL IX 6079 12 si potrebbe vedere,
invece che un servo, anche un ingenuus rispondente al nome di Mar(aeus) Be[t]il(ienus) [cfr. GASPERINI
1965, p. 88, nt. 95]. Sul rinvenimento di anfore con timbri simili in numerosi altri centri dell’Occidente e
Oriente romani, cfr. PALAZZO 1990, pp. 150-151; PALAZZO 1992, pp. 116-117, 122-123; MANACORDA
1994, pp. 29-31 (con ampia bibliografia). 10 Cfr. CIL I² 2232 = III 7212 = ILLRP 750a.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
18
vista – tra quelle legate a Mar io, beniamino locale11. Le vicende storiche
successive, la nuova posizione giuridica di cives romani, il crescente
sviluppo di varie att ività economiche e l’attrattiva di inser irsi
vantaggiosamente nella vita polit ica della capitale, dovettero spingere
numerosi “provinciali”, soprattutto del Latium, a trasferirsi a Roma.
Proprio nell’Urbe, infatt i, la gens r iappare in età augustea con alcuni
senatori; pr imo fra quest i Publius Betilienus Bassus, menzionato come
triumviro monetale in un quadrante del 7/4 a.C.12, nipote di Publio Apalo
secondo Gasperini; non si può escludere, però, che fosse un discendente
diretto di Varo, che aveva almeno un figlio, come risulta dalla nostra
epigrafe. Figlio o fratello minore del monetale era quel Betilienus Capito
che, procuratore di Caligola, nel 40 a.C. fu condannato dallo stesso
imperatore ad assistere all’esecuzione del figlio Betilienus Bassus (questore
del princeps), e ucciso, a sua volta, subito dopo13. Proprio da quest’ult imo,
o da un suo figlio omonimo, fu manomesso quel P. Betilienus Synegdemus
sepolto all’Isola Sacra in una tomba di età traianea e menzionato in alcune
epigrafi dello stesso sepolcreto14. Numerosi altri libert i in relazione più o
meno diretta con Capito o Bassus sono attestat i in età imper iale a Roma,
nel Lazio e in Campania15. Al ramo alatrense della stessa famiglia sembra
11 Così COARELLI 1993, p. 197. 12 Cfr. LICORDARI 1982, p. 16; SALOMIES 1996, p. 30, che pone il monetale nel 4 a.C., ipotizzando che
fosse lo stesso Betilieno di un’iscrizione dell’anfiteatro di Siracusa (proconsole di Sicilia secondo
MANGANARO 1989, pp. 183-184 = AE 1989, nr. 342i), e concordando su questo punto con WILSON 1980,
pp. 2221, 2226, 2230, che però data il tresvirato di Bassus al 12 a.C.; d’altro avviso CÉBEILLAC
GERVASONI 1998, p. 152, nt. 46, che pure sostiene una datazione al 12 a.C., e BUONOCORE 1992, p. 119,
nr. 84, che data invece l’epigrafe siciliana tra la fine del II e l’inizio del III sec. per ragioni paleografiche. 13 Cfr. SENEC. de ira 3, 18; DIO CASS. 59, 25; SVET. Cal. 26, 3. Tuttavia, la differenza di rango fra il
monetale e Betilienus Capito (per il quale cfr. PIR², B 116; DEMOUGIN 1992, pp. 283-284) invita a
supporre l’esistenza a Roma di due rami familiari imparentati, ma distinti (così Suppl.It. 16, p. 22, con
ulteriore bibliografia). Il questore Betilienus Bassus fu tra i primi giovani con padre procuratore ad
accedere alla dignità senatoria grazie all’iniziale favore di Caligola (cfr. PIR², B 114; CÉBEILLAC 1972, p.
43, nr. 19). 14 Cfr. GASPERINI 1965, p. 89 (con ulteriore bibliografia). 15 A Roma ne sono testimonianza alcuni epitafi urbani, tre dei quali di sicura provenienza: Betilienus
Antiochus (CIL VI 7851a2, da vigna Amendola sull’Appia); P. Betilienus Cures (CIL VI 18468); M.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
19
invece appartenere il liberto Betil<i>enus Anthus elencato tra i dedicant i di
un’iscrizione della vicina Sora, posta in onore di Domiziano 16.
Da questa breve cronistoria della gens emerge chiaramente l’esistenza di
un nesso che lega i primi Betilieni all’impianto urbanist ico di Aletrium:
ognuno di essi, infatt i, trova menzione in iscrizioni relat ive a important i
opere pubbliche realizzate in città17. Grande iniziatore di quest’ampio
programma di rinnovamento edilizio fu, come si è detto, Bet ilieno Varo, la
cui epigrafe cost ituisce forse uno dei più ant ichi document i che r icordi
intervent i everget ici compiut i da privat i cittadini pecunia sua18 – sempre
nell’ipotesi che le due censure del personaggio non abbiano coinciso con la
realizzazione di tali beneficenze. D’altro canto, di fronte al gran numero di
evergesie promosse nello stesso periodo (fine II - inizi I sec. a.C., vd.
infra) da personaggi invest it i di una carica pubblica19 – e pur considerando
il caso di Bet ilieno isolato ed eccezionale per l’ent ità delle realizzazioni –
bisogna valutare anche l’eventualità che lo stesso Varo avesse agito in
qualità di censore20. Fra le competenze di questa magistratura municipale,
Betil(i)enus...Tigranes (CIL VI 6946, da vigna Acquari sulla v. Latina); Betil[i]ena A[- - -] (CIL VI
23374, da una vigna presso porta Capena); Betiliena Nice (CIL VI 13570). Un Publius Betilienus è inoltre
attestato ad Anzio (CIL X 6698) e una Philematium a Casapulla presso Capua; incerti infine i casi di
Atina campana (CIL X 5083), ove compare un L. Bet[- - -] / Pom[- - -], e CIL VI 38094: P. Bet[- - -]
Prim[- - -]. Per le restanti occorrenze di questo gentilizio cfr. CLAUSS – SLABY, visionato da ultimo in
data 2/12/2010. GASPERINI 1965, p. 89, nota come tutti i liberti dei Betilieni portino cognomi grecanici e
assumano, al momento della manomisssione, i prenomi Marcus o Publius, «portati per lunga tradizione
familiare da quasi tutti gli ingenui di questa gens». 16 Cfr Eph. Epigr. VIII 892. 17 Per le opere dei fratelli Marcus e Caius Betilieni vd. infra (iscr. nr. 2); al quattuorviro Publius
Betilienus Hapalus si deve la costruzione o il restauro di un murum non meglio localizzato (cfr. nt. 6). 18 Così PANCIERA 1997, p. 262, nt. 50, p. 265, nt. 61. 19 Vd. CÉBEILLAC GERVASONI 1998, in particolare p. 131; PANCIERA 1997, cit. (con ampia bibliografia e
dati statistici). 20 Così già GASPERINI 1965, pp. 83, 87; MANSUELLI 1976/77, p. 122 e nt. 7. Cfr. inoltre CALABI
LIMENTANI 1991, p. 253, che, a proposito della realizzazione di opere pubbliche nelle città italiane
(colonie e municipi) in età repubblicana, precisa: «Carattere proprio delle opere dei magistrati municipali
fu l’essere spesso pagate dai magistrati stessi, talora come sostituzione integrale o parziale della summa
honoraria, che essi erano normalmente tenuti a versare per adire alle cariche».
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
20
del resto, come di quelle della censura urbana, rientrava probabilmente
anche la vigilanza sul rifornimento idrico e sul corretto uso delle acque,
oltre al controllo sull’assegnazione degli appalt i, sulla costruzione e
manutenzione degli edifici e sulla gest ione delle r isorse economiche21 –
tutte funzioni ampiamente documentate nella nostra epigrafe. Ovviamente
questa interpretazione regge se si considera il BIS d i r. 13 un’aggiunta
coeva al testo, dovuta a un’iniziale omissione del lapicida: proprio a
seguito delle benemerenze acquisite durante la pr ima censura, allora,
Bet ilieno avrebbe ricevuto il secondo incarico dal senato, la statua dal
popolo e il cognomen ex virtute di Censorinus22. Sul piano onomast ico, uno
stringente confronto è cost ituito a Roma da C. Marcius Rutilus, che nel 265
a.C. ottenne il secondo cognome di Censorinus proprio per aver
eccezionalmente ricoperto la censura due volte23.
I l testo pone varie difficoltà interpretat ive. Senatu in r. 3 è
inequivocabilmente una forma arcaica di genit ivo in –u. Calecandam in r. 8
è stato generalmente ricondotto a calicandam (dal verbo calico) e
interpretato, secondo la spiegazione di Festo (quae calce polienda est)24,
nell’accezione di “intonacare”; altri lo riportano invece a calcandam (dal
verbo calco) = “da massicciare”. La prima interpretazione, generalmente
ritenuta più consona, ha indotto la maggioranza degli studiosi a ipot izzare
che Varo si fosse occupato della sola costruzione dell’intonaco della
basilica, che quindi sarebbe stata edificata a priori, c ioè pr ima che il
Censorino provvedesse alle sue ult ime r ifiniture; un’esegesi del genere
però, oltre a non accordarsi con l’ent ità delle realizzazioni menzionate,
sembra discostarsi anche da una corretta interpretazione del testo, poiché
col gerundivo si suole esprimere piuttosto la necessità di un’azione non
ancora compiuta (“la basilica che deve essere intonacata = ancora da
21 Cfr. SUOLAHTI 1963, pp. 57-66; sulla censura in età repubblicana: BRUUN 1975, pp. 435-505, in
particolare pp. 450-451. 22 Cosi Suppl.It. 16, p. 38. 23 Cfr. PANCIERA 1966, pp. 60-61. 24 FEST. verb. sign. 47, ed. Lindsay.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
21
intonacare”)25, ovvero, in questo caso, l’intonacatura di un edificio già
ult imato – dallo stesso Bet ilieno Varo – nelle sue principali component i
strutturali. Sembra improbabile, del resto, che tra le ingent i opere del
censore, l’epigrafe ricordasse solo un intervento di portata così modesta
(l’intonaco), e che non facesse menzione della costruzione dell’intera
struttura (la basilica).
In r. 10 Sacchett i Sassett i (cit.) credeva che [p]ortam fosse un errore del
lapicida per portandam, ma l’ipotesi non sembra necessar ia. Il punto più
controverso dell’epigrafe è rappresentato dalle ult ime quattro lettere della
stessa riga (vd. immagine seguente).
A giudicare dalla forma delle O e delle Q così come appaiono
nell’iscrizione, la penult ima lettera della parola sembra più vicina a una O,
anche se è possibile scorgere un piccolo segno (accidentale?) simile
all’inizio della coda di una Q nella sua parte infer iore. Lo stesso dubbio ha
coinvolto tutti gli studiosi di questa epigrafe, a cominciare da Mommsen,
che contemplava entrambe le letture senza esprimere un giudizio
definit ivo 26. Più categorico il parere di Gasperini (cit., p. 18), che rifiutava
la lettura adqu(e) in quanto contraria a «ogni evidenza grafica e... [a] ogni
logica sintatt ica e st ilist ica», aggiungendo: «Si tratta invece senza alcun
dubbio di adou = addu, da sciogliere ovviamente in una forma del verbo
adducere: la soluzione col part icipio adou(centem), accordato con lacum,
potrebbe anche preferirsi all’adou(xit) di alcuni, per la maggiore 25 Molti interpretano invece: “(...fece costruire...) la basilica (che era) da intonacare” (così ad es.
GASPERINI, cit., p. 16), interpretazione che suscita qualche imbarazzo esegetico. 26 Cfr. ad es. apparato in CIL X, cit., p. 567.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
22
scorrevolezza che assicura al testo». Di tutt’altro avviso Galli (cit, p. 42) –
che sulla pietra legge inconfutabilmente adqu(e), legandolo ad arduom – e
Sacchetti Sassett i (1957, p. 5), che interpreta adqu(e) nel significato di
atque. Tra i sostenitori della lettura adou, isolata è l’ipotesi di Damsté
(cit., p. 233), che integra adou(cendam) accordandolo con aquam {aquam...
adou(cendam) [coiravit] = “(fece) condurre l’acquedotto”}; ancor più
originale, infine, il punto di vista di Van Buren (cit., pp. 137 sgg.), che
rit iene le ult ime due lettere della riga OV, errore per QV e pert inent i
all’enclit ica del fornicesq(ue) sottostante: secondo lo studioso, la Q nana
terminale di r. 11 sarebbe stata ristuccata e il –que inciso nello spazio
rimasto libero nella riga soprastante.
Personalmente propenderei per una lettura adou, da interpretare – come
già sostenuto da Mommsen tra le diverse possibilità avanzate27 – come
errore dello scalpellino per adqu(e) [= et ad], ovviamente in associazione
ad arduom.
Ulterior i problemi interpretat ivi sono post i proprio dalla parola arduom,
intesa come attributo di lacum o di opidum dai sostenitori della lettura
adou[- - -], oppure, da altri, come sinonimo di arx28. Se però si accetta
l’ipotesi qui sostenuta (adou per adque) e si rit iene quindi l’aggett ivo
introdotto dalla preposizione ad, preferibile appare l’interpretazione
tecnico-sostant ivale dell’espressione ad arduom proposta da Van Buren
(cit., pp. 137 sgg.) [“verso l’alto, in su, in altezza”], da r iferire – come già
inteso da Gasperini (cit., p. 18) – alla «differenza di livello tra la quota
alt imetrica più bassa che l’acquedotto toccava al termine della sua discesa,
sopra gli archi del fosso del Purpùro, e la quota alt imetr ica a cui l’acqua
mirabilmente giungeva alla fine del suo risalire». Controversa è proprio
l’ident ificazione del punto di arrivo dell’acquedotto, con numerose ipotesi
avanzate, ricostruite e commentate con dovizia di dettagli archeologici e
topografici in CIL X (pp. 567-570); a tal riguardo, attenendomi alla tesi che
si è ormai imposta a communis opinio – e conformemente all’evidenza
27 Cfr. ibid. 28 Cfr. la spiegazione di A. Secchi in CIL X, cit., pp. 567 sgg., che rifiuta l’identificazione con l’arx.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
23
archeologica – individuerei anch’io questo punto nel lacus scoperto presso
porta S. Pietro (vd. infra).
L’acquedotto è senza dubbio la più importante opera ricordata
nell’epigrafe: si sviluppava per una lunghezza complessiva di circa 12 km e
richiese nell’ult imo tratto in ascesa l’impiego di una tecnologia
sperimentata intorno al 400 a.C. da Erone a Olinto (Calcidica), consistente
in due vasconi – di carico e scarico – comunicant i mediante delle condotte
forzate a sifone “rovescio”, progettate per resistere a una pressione di 100
metri circa (10 atmosfere)29. Nell’Italia del tempo lo stesso principio fisico
sembra sia stato sfruttato solo qui, ad Alba Fucens e a Roma per la salita al
Campidoglio delle aquae Marcia (144 a.C.) e Tepula (125 a.C.)30.
Quest’opera di alta ingegneria idraulica aveva origine dalle sorgent i di S.
Aniello sopra Guarcino; lungo il suo tracciato toccava le località Mola del
Comune e Vigiano, dove nell’Ottocento si vedevano ancora i rest i di un
serbatoio circolare31. Da questo punto, passando sotto Vico e presso il bivio
della Cona, scendeva entro massicce tubature32 fino alla confluenza del
fosso del Purpùro col fiume Cosa, attraversando la depressione su alte e
possent i arcate, di cui restano ancora oggi alcuni rest i. Superando poi un
dislivello di 340 piedi romani (= 100,64 m) risaliva – sempre entro
condotte in pressione – fino al grande bacino di distr ibuzione di porta S.
Pietro (in parte visibile ancora oggi), posto a una quota alt imetrica di poco
inferiore a quella della piscina limaria di Vigiano. Questo lacus ad portam
consisteva in un vascone rettangolare di metri 42,25 x 15,57 a cielo aperto,
col fondo spesso m 0,70 e coi muri perimetrali dello spessore di m 233; in
epoca posteriore vi fu aggiunta una copertura laterizia a triplice volta
29 Cfr. SECCHI in CIL X, cit., p. 569. 30 Cfr. Suppl.It 16, p. 24 (con ampia bibliografia). 31 Cfr. GASPERINI 1965, p. 80. 32 Cfr. Not. Sc. 1882, p. 418; vd. inoltre SECCHI e TUCCI in CIL X, cit., pp. 569, a proposito del
rinvenimento di tubi di piombo e terracotta nella valle del Cosa e del Purpùro. 33 Cfr. GASPERINI 1965, p. 80. Differenti le misure del lacus ad portam riportate da Secchi - cui si deve il
suo rinvenimento - in CIL X, cit., p. 570: 46,5 m di lunghezza x 15 m di larghezza.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
24
poggiante su due filari di pilastri paralleli ai lat i lunghi del serbatoio34. Da
esso, capace di contenere oltre 1.000 m³ d’acqua, si dipart iva la fitta rete
dei condott i che distr ibuivano l’acqua alla città bassa, in opidum; d i queste
fistole minori si conserva qualche frammento nel locale Museo Civico.
Le altre opere menzionate nell’epigrafe sono tutte di natura strettamente
civile: singolare è l’assenza di strutture difensive ed edifici sacr i. Seguendo
l’ordine di elencazione del testo, la prima di esse è la pavimentazione di
tutti i vicoli della città bassa; il termine semitae (= viuzze), del resto, non
può che rifer irsi alle strade secondarie della città, in contrapposizione alle
principali (cardo e decumanus); tratti d i selciato romano sono ancor oggi
visibili sotto alcune delle vie moderne interne all’abitato35. La seconda
opera è la costruzione di un port ico lungo la salita che conduce alla rocca
da settentrione, ident ificato da Winnefeld in alcuni rest i da lui scavat i nel
188936; d i esso è ancora visibile la canaletta di scolo. Segue il campo ubei
ludunt, individuato da Tucci e da Secchi in un prato presso la fontana detta
di Chiappitto, distante dalla città circa un chilometro; si trattava
probabilmente di un campo per esercitazioni militar i, ove i due archeologi
rinvennero grosse condutture fitt ili forse dest inate al drenaggio 37. Viene
34 Cfr. GASPERINI 1965, p. 80, in particolare nt. 71. A tal proposito SACCHETTI SASSETTI 1947, p. 7,
aggiunge: «Il serbatoio che, per venti secoli, s’era mantenuto ancora intatto, tranne le volte che sotto il
peso della terra eran crollate, fu, nel 1886, dissennatamente squarciato in due parti (l’una oggi
interamente scoperta, l’altra ancora interrata) dal Viale Principe di Udine. I tubi originari, di cui è giunto
sino a noi qualche piccolo frammento, erano formati di grosse lamine di piombo, ripiegate e fortemente
saldate. I vari tubi di ferro e di terracotta, rinvenuti in qualche scavo, ricordano probabilmente qualche
lavoro di riparazione o di trasformazione a cui l’acquedotto [...], con l’andare del tempo, andò
inevitabilmente soggetto. Un’iscrizione infatti, del primo secolo dopo Cristo ricorda un lavoro di qualche
importanza a cura di un tal Pegaso, liberto di Augusto». L’iscrizione in questione (per la quale si veda
GASPERINI 1965, p. 34, nr. 16; Suppl.It. 16, 1998, nr. 14; AE 1998, nr. 308) si riferisce probabilmente
all’aggiunta, in epoca imperiale, della copertura in laterizio (cfr. supra) del lacus ad portam di Betilieno
Varo (così GASPERINI, cit., p. 81). 35 Cfr. GASPERINI 1965, p. 79, nt. 66; GALLI 2002, p. 44; COARELLI 1993, p. 197, che precisa: «Forse a
questo intervento si deve attribuire la regolarizzazione di alcuni assi viari intorno al Foro, nella parte
settentrionale, che formano un reticolo abbastanza regolare». 36 Cfr. WINNEFELD 1889, pp. 143, 150 sgg. 37 Cfr. CIL X, cit., p. 570.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
25
r icordata poi una meridiana, che doveva collocarsi nel foro della città
(l’attuale piazza S. Maria Maggiore), nello stesso luogo in cui sorgeva la
basilica – tra le più ant iche in Italia38 – e dove furono sistemat i dei sedili,
forse dest inat i al senato locale o a qualche struttura di spettacolo. Non
molto distante da qui doveva essere ubicato anche il mercato alimentare.
Nell’immediato suburbio invece – forse tra i Rioni Valle e Scurano39 –
doveva situarsi il lacus balinearius, una piscina da ident ificarsi
probabilmente con un “bagno” che gli abitant i del luogo riut ilizzarono fino
al tardo Medioevo 40.
A tutte queste opere, inseribili nel quadro di un progetto di rinnovamento
urbanist ico secondo canoni monumentali ellenist ici41, si deve aggiungere
quella che ce le ha tramandate: il monumento eretto dai cittadini
riconoscent i in onore di Lucio Bet ilieno Varo, probabilmente nel foro.
Doveva consistere in una statua bronzea posta su una base quadrangolare
calcarea, nel cui rivest imento frontale doveva essere inser ita la lapide
commemorat iva42.
Questa, che è la più ant ica e nota iscrizione di Alatri, si data
tendenzialmente tra la seconda metà del II sec. a.C. e gli inizi del I sec.
a.C. Un preciso terminus ante quem è cost ituito dal part icolare
dell’esenzione dal servizio militare per il figlio di Bet ilieno Varo (cfr. r.
14), un dir itto concesso solo nel periodo anteriore alla guerra sociale (90
a.C.), e che dovette venir meno quando ad Aletrium – per effetto della lex
Iulia de civitate – fu concessa la cittadinanza romana (cfr. Introduzione).
38 Così GALLI 2002, p. 43, che cita a confronto i casi di Praeneste, Pompeii, Cosa e Ardea. 39 Cfr. GASPERINI 1965, p. 80. 40 Cfr. SACCHETTI SASSETTI 1947, p. 7, nt. 18. 41 Così Suppl.It. 16, p. 17. 42 GASPERINI 1965, pp. 18, 81.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
26
2. Bibliografia: CIL I² 3105; SACCHETTI SASSETTI 1947, p. 16, nt. 39;
ILLRP I 189; GASPERINI 1965, pp. 19-21, nr. 2 (con foto); BODEI GIGLIONI
1977, p. 48, nt. 76; SOLIN 1991, p. 177; COARELLI 1993, p. 197; PANCIERA
1997, p. 284, nr. 61; Suppl.It. 16, 1998, pp. 47-48, nr. 3 (con foto); AE
1998, pp. 117-118, nr. 297.
Blocco parallelepipedo di calcare locale ricomposto da tre frammenti
combaciant i, mancante a destra e profondamente scheggiato lungo i
margini. Dimensioni: 29,5 x 62,9 x 12 cm; alt. lett. 6-5,8 cm. Rinvenuto
nell’ottobre del 1938 durante lavori di restauro nella chiesa di S. Mar ia
Maggiore ad Alatri, è attualmente murato capovolto nel primo dei pilastri
che separano la navata centrale da quella sinistra della medesima chiesa, lì
stesso dove molto probabilmente fu ritrovato. Autopsia 2010.
M(arcus) C(aius) Betilienei M(arci) [f(ilii) - - -?]
pecunia Iovis [- - -?]
1 M. C. Bet ilienei M.[f. - - -?] Suppl.It. 16, AE 1998; al. alia.
“ Marco (e) Gaio Bet ileni, [figli] di Marco..., col denaro di Giove ...”.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
27
Lettere con solchi poco profondi e quasi prive di graffie; E con tratto
mediano molto corto e P con occhiello aperto e angolato; interpunzione
regolare con cerchiett i e quadrat ini43; se si eccettua una più debole
incisione delle lettere, il testo presenta analogie paleografiche – proprio
nella forma delle E e delle P – con quello dell’iscr izione di Lucio Bet ilieno
Varo (supra, iscr. nr. 1).
Forme arcaiche: Betilienei per Betilieni.
Secondo Degrassi, Bodei Giglioni, Solin e Coarelli, la r. 1 terminava con
f(ilii) in simmetria con r. 2; Gasperini, che non esclude questa possibilità,
ipot izza che il testo potesse svilupparsi anche a destra con la menzione
della carica dei due Betilieni, ma non coi loro cognomina. Coarelli pensa
che costoro, cugini o nipot i del grande Lucio44, fossero praetores della città
libera, ma che il t itolo fosse omesso; non si può escludere, però, che
agissero da censores45. L’espressione pecunia Iovis è simile a tante altre46
r iferent isi alla stips o pecunia deo collata , cioè al denaro sacro offerto a
una divinità e conservato nel suo tempio 47. L’iscr izione doveva prolungarsi
almeno altrettanto e chiudersi con una formula del t ipo d(e) s(enatus)
s(ententia) f(aciend-) c(oiravere) o simili48, r icorrente in contest i
analoghi49; non è da escludere, in alternat iva, che il testo si chiudesse con
fec(erunt)50. Nonostante l’altezza non monumentale delle lettere (6-5,8 cm),
è probabile che il blocco fosse inserito originariamente nella parete di
qualche edificio pubblico e che di esso ricordasse forse un restauro.
43 GASPERINI 1965, p. 20, ravvisa solo cerchietti. 44 Sulle vicende storiche della gens dei Betilieni e sui rapporti genealogici tra i vari esponenti vd. supra,
iscr. nr. 1. 45 Così Suppl.It 16, p. 48. 46 Cfr. p(ecunia) Venerus in CIL I² 2536; de stipe Iovi Iurario [- - - m]onimentom in CIL I² 990 = VI 379
= ILS 3386; d(e) stipe Aesculapi in CIL I² 800 = VI 7; pequn(ia) sacra in CIL 1506 = X 6505 = ILS 3386;
ecc. 47 Cfr. VARRO ling. 5, 182: Stips ab στοιβή fortasse, graeco verbo. id apparet, quod ut tum institutum
etiam nunc diis cum thesauris asses dant stipem dicunt, et qui pecuniam alligat, stipulari et restipulari. 48 Suppl.It. 16, p. 48: de s(enatus) s(ententia) fac(iundum) coerav(erunt). 49 Cfr. ad Alatri CIL X 5806. 50 CIL I², cit., p. 1003 (in apparato).
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
28
L’edificio in quest ione – data la natura dell’iscrizione – potrebbe essere il
tempio di Giove, ubicabile con probabilità nel sito stesso dell’attuale
chiesa di S. Maria Maggiore51.
In definit iva, l’iscrizione sembra commemorare un intervento di restauro
del tempio di Giove ad opera di due magistrat i cittadini provenient i dalla
medesima famiglia alatrense, che realizzarono tale intervento impiegando il
θησαυρός sacro del dio .
Datazione: tra la seconda metà del II sec. a.C. e gli inizi del I sec. a.C.
per ragioni prosopografiche, paleografiche ed element i linguist ici52.
3. Bibliografia: BROCCHETTI, ms., p. 84 (con diversa suddivisione in
righe); CIL X 5808; DE RUGGIERO 1904, nr. 2005; ILS 6267; P IERLEONI
1916, p. 46; GASPERINI 1965, pp. 33-34, nr. 15; FORBIS 1996, p. 106, nr. 3;
Suppl.It. 16, 1998, pp. 38-39, nr. 5808.
Iscrizione ora perduta, probabilmente su marmo, tramandata senza
indicazioni sulla forma del monumento. Fu rinvenuta nel pavimento della
chiesa di S. Paolo – la cattedrale di Alatri ubicata sulla rocca – e in
seguito collocata sotto il port ico della medesima chiesa53.
51 Di questo avviso SACCHETTI SASSETTI 1947, p. 16; COARELLI 1993, p. 197; GASPERINI 1965, p. 79, il
quale riferisce: «All’interno della città bassa, lungo il lato nord della chiesa di S. Maria Maggiore, resta
un piccolo allineamento di blocchi piuttosto rozzi, ricalcato da uno dei lati lunghi della chiesa. È
probabile che si tratti della parte più superficiale di un basamento di tempio, sottostante alla chiesa
medioevale, la quale potrebbe conservarne grosso modo la pianta e l’orientamento (est-ovest). Se
l’iscrizione [...] provenisse dal luogo stesso ove fu murata [cfr. supra], non si dovrebbe esitare a proporre
Giove come divinità venerata nel tempio». 52 Così Suppl.It. 16, p. 48; PANCIERA 1997, p. 284, la data invece al II sec. a.C.; SOLIN 1991, p. 177: a
cavallo tra II e I sec. a.C.; ILLRP I², cit.: I sec. a.C. 53 Cfr. CIL X, cit., p. 571.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
29
C(aio) Iulio Augusti l(iberto)
Heleno
ex decreto decur(ionum)
municipii Aletrinat(ium)
5 et pollicitatione sevir(um)
et municipum et incolar(um)
ob merita eius.
“A Gaio Giulio Eleno, liberto di Augusto, per decreto dei decurioni del
municipio di Alatri e in seguito a una promessa di sèviri, cittadini e
resident i, per i suoi merit i”.
Da questa e da altre iscrizioni (vd. infra, iscr. nr. 4)54 si ha test imonianza
della presenza di seviri o seviri Augustales ad Alatri sin dalla pr ima età
imperiale55. In ognuna di esse compaiono individui di condizione libert ina,
il medesimo status del nostro Caius Iulius Helenus, personaggio a cui la
città e il collegio dei sèvir i tributano onore e riconoscenza in virtù delle
sue benemerenze. Costui, liberto di Augusto piuttosto che di Caligo la56,
evidentemente si dist inse in opere di interesse pubblico, ma non è escluso
che, grazie alle sue preziose aderenze alla corte imper iale, avesse
beneficiato l’intera comunità di un intervento in denaro 57. D’altra parte – di
natura pecuniaria o profusi per l’arredo urbano che fossero – i munera di
questo illustre liberto, certamente cospicui, ottennero la grat itudine del
54 Alle due epigrafi sopracitate se ne aggiunge forse un’altra (CIL X 5810), sepolcrale, frammentaria,
nella quale un liberto di nome Thesmus sembra ricoprire la carica di quaestor Augustalium, di
amministratore cioè dell’arca del collegio degli Augustales (cfr. GASPERINI 1965, pp. 40, 86); cfr. inoltre
iscr. nr. 8 (in particolare r. 5), ove potrebbero essere menzionate uxores di sèviri. 55 Erano dei sacerdozi locali - più o meno differenziati tra loro - organizzati in collegi presieduti da un
comitato annuo di sei membri; nei municipi e nelle colonie essi erano originariamente addetti al culto dei
lares e del genius Augusti (e per estensione al culto di Roma), ma più tardi inclusero tutti gli imperatori
divinizzati (per una rassegna di iscrizioni relative a sevirato e Augustalità nella regio I vd. ABRAMENKO
1993, p. 33, nt. 91; sul tema più in generale cfr. DUTHOY 1978, pp. 1255-1309, e anche infra, p. 32). 56 Suppl.It. 16, p. 39. 57 Così GASPERINI 1965, p. 34.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
30
consiglio dei decurioni e dell’intera cittadinanza, tanto da sollevare la
necessità di un decreto e di una pollicitatio58 per la realizzazione di
un’epigrafe che ne celebrasse i merita .
I l testo offre poi un’ulteriore test imonianza (cfr. iscr. nr. 11) sulla
presenza degli incolae (r. 6) ad Alatri59. Avendo essi facoltà d’impegnarsi
in una stipulatio ad honorem (cfr. nt. 58) insieme a sèviri e cittadini, è
molto probabile che fossero ben integrat i nell’ordinamento amministrat ivo
municipale e che il loro status giuridico – vist i i diritt i di cui disponevano,
fatta eccezione per la cittadinanza – fosse quasi equiparabile a quello dei
municipes. Del resto, oltre questo documento, non sono note altre iscrizioni
relat ive a pollicitationes per civitates o municipii da parte di incolae.
Datazione: inizi I sec. d.C., in quanto l’epigrafe è dedicata a un liberto di
Augusto.
4. Bibliografia: MARINI, ms. b; TOTI, ms., p. 31, nr. 7, p. 61, nr. 7;
BROCCHETTI, ms., p. 85; AJOSSA, ms., f. 50 v. (p. 56); CIL X 5809; DE
RUGGIERO 1904, nr. 2006; LAUM 1914, p. 178, nr. 18; PIERLEONI 1916, p.
44; GASPERINI 1965, pp. 38-39, nr. 19 (con foto); MROZEK 1968, p. 162; ID.
1987, pp. 13, 25; Suppl.It. 16, 1998, pp. 39-40, nr. 5809; GALLI 2002, pp.
49-51, nr. 7, p. 95, fig. 7 (foto).
Lastra rettangolare di marmo bianco lunense ricomposta da tre framment i
combaciant i, mancante a destra e dell’angolo inferiore sinistro, fratturata
nel quadrante superiore destro; fronte e retro lisci, specchio epigrafico
58 La pollicitatio (r. 5) consisteva in una promessa unilaterale e non formale fatta da un cittadino alla
civitas (in questo caso da una congregazione di sèviri, municipes e incolae al municipium), avente ad
oggetto il compimento di un’opera di pubblica utilità (qui la dedica di un’epigrafe onoraria per un
benefattore), oppure altre prestazioni, quali ad es. l’effettuazione di un versamento; essa era considerata
una stipulatio ad honorem, ma se l’oggetto della promessa era già in corso d’opera, il promittente poteva
essere costretto a portarlo a termine mediante la cognitio extra ordinem (sulla natura della pollicitatio cfr.
da ultimo HAYASHI 1989, pp. 383-398). 59 Sugli incolae in Italia durante l’Impero vd. MROZEK 1984, p. 17; ampia trattazione del tema in senso
giuridico in GAGLIARDI 2006.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
31
r ibassato e inquadrato da una cornice modanata. Dimensioni: 70 x 97 x 10
cm; campo epigrafico: 52 x 88,5 cm; alt. lett. 4-6,5 cm. Epoca di
rinvenimento e provenienza ignote; conservata dapprima sotto l’altare della
chiesa di S. Gennaro ad Alatri60 e poi nel palazzo comunale, si trova adesso
nel locale Museo Civico. Autopsia 2010.
Q(uintus) Minucius Q(uinti) l(ibertus) Anteros VI v[ir]
Augustal(is)
hic seviris Augustal(ibus) Aletrin [at(ibus)]
legavit ((sestertium decem milia)) quoius ex re [dit(u)]
5 quod annis natali suo VI [k(alendas)?]
Febr(uarias) vescerentur.
60 In questo periodo venne aggiunta alla fine dell’epigrafe, al centro, una croce cristiana maldestramente
graffita (cfr. GASPERINI 1965, p. 39, nt. 40; Suppl.It 16, p. 39).
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
32
5 natali suo VI CIL, De Ruggiero, Pierleoni, Laum; natali suo Marini,
Brocchetti; natali suo [· ·] Gasperini; natali suo V[I] Mrozek; natali suo VI
[k(alendas)] Suppl.It. 16; 6 febr(uari-) Gasperini; febr(uarias) Suppl.It. 16.
“Quinto Minucio Anterote, liberto di Quinto, sèviro Augustale. Quest i ha
fatto un lascito di diecimila sesterzi ai sèviri Augustali di Alatri, con [la
rendita] del quale ogni anno, alla ricorrenza del suo giorno natale – il 27
gennaio (?) – possano fare un banchetto”.
Lettere elegant i, finemente incise; T montante in ogni occorrenza tranne
che nelle r ighe 2 e 5; I montante nelle desinenze dat ivali e ablat ivali; Q con
coda molto allungata; sesterzi indicat i con il simbolo IIS, con sbarretta a
metà segno e primo numerale montante anch’esso; numerale cardinale
espresso dal simbolo ( (I ) ); interpunzione regolare a triangolini.
Forme arcaiche: quoius per cuius.
Sul margine destro della r. 5 sono cadute delle lettere, non più di tre in
base al calcolo degli spazi; alcuni autori precedent i al CIL hanno trascritto
due di esse (VI)61, r iferent isi molto probabilmente al giorno stabilito da
Anteros per il banchetto. Se questa tradizione è corretta, l’unica
integrazione possibile – secondo gli usi del calendario romano – sarebbe
quella proposta, cioè il 27 gennaio, sesto giorno prima delle calende di
febbraio 62.
Quod annis per quotannis r iccore frequentemente in epigrafi di contenuto
simile e spesso anche di frasario simile 63, così come ex reditu
...vescerentur64.
61 Cfr. CIL X, cit., p. 571 (in apparato). 62 Così GALLI 2002, p. 50; d’altro avviso GASPERINI 1965, p. 39, secondo cui le lettere da supplire prima
di Febr(- - -) non sarebbero più di due; egli propone perciò di integrare V K(alendas) o in alternativa
Id(ibus). Tuttavia, prendendo in considerazione anche il testo tràdito dal CIL, lo stesso Gasperini propone
come terza possibilità un V Id(us), stabilendo grossomodo la data del compleanno di Anteros in un giorno
compreso tra il 15 gennaio e il 13 febbraio. 63 Cfr. CIL XIV 367 e 431. 64 Cfr. ad es. CIL V 4203 e 4410, VI 1872 e 9626, XII 530; ILS 7215, ecc.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
33
I seviri Augustales65, menzionat i anche in altre iscrizioni alatrensi (cfr.
supra, iscr. nr. 3), erano personaggi ricchi, ma di bassa estrazione sociale:
si trattava per lo più di libert i, commerciant i o art igiani che, limitat i nei
loro diritt i polit ici da disposizioni di legge e pregiudizi sociali, avevano
ottenuto il permesso di cost ituire un collegio dedito al culto imperiale. La
nostra epigrafe ci consente di chiar ire quale fosse l’ent ità patrimoniale di
quest i individui, che aspiravano a riscattare la propria inferiorità sociale
ostentando il loro potere economico; non a caso, nella classifica dei fautori
di distribuzioni di denaro e di cibo nei municipi, i sèviri Augustali
occupano il secondo posto subito dopo i decurioni66. Anterote ist ituì
peraltro una fondazione perpetua dotandola di un capitale di 10.000
sesterzi, i cui interessi erano dest inat i alla celebrazione della sua memoria
da parte dei colleghi; tenendo conto dei valori corrent i del tasso d’interesse
prat icato in Italia (5-6%) e dell’ammontare medio delle sportulae spettant i
ai sèvir i Augustali di altre città in occasione di distribuzioni di denaro da
parte di munifici benefattori (generalmente 8, 12 o 20 sesterzi pro capite),
si è dedotto che il collegio alatrense doveva annoverare dai 25 ai 75
membri67. Da studi stat ist ici condotti sull’argomento68 è emerso inoltre che
il lascito di Anterote rispecchia il valore medio st imato per liberalità di
questo tipo, diffuse, soprattutto nel II sec. d.C., nell’Italia centrale.
La gens Minucia, considerando anche l’omologa forma Minicia, è
attestata in altre otto iscrizioni di centri vicini69, due delle quali (Fundi e
Frusino) relat ive, come la nostra, a libert i con prenome Quintus e cognome
grecanico.
Secondo Gasperini la lapide ornava la sede del collegio dei sevir i
Augustali di Alatri; tuttavia, visto anche il riferimento alle disposizioni
65 Per riferimenti bibliografici cfr. supra, nt. 55. 66 Cfr. MROZEK 1987, pp. 70 sg.; ABRAMENKO 1993, p. 111; Suppl.It 16, pp. 39-40 (per ulteriore
bibliografia sull’argomento). 67 Cfr. DUNCAN JONES 1982, p. 286. 68 Cfr. DUNCAN JONES 1965, pp. 215, 251, nr. 687. 69 Cfr. CIL X 5666 Frusino (due occorrenze), 5688 Isola di Sora, 6167 Formiae (due occorrenze), 6260
Fundi, 6736 Antium (due occorrenze, con grafia grecizzante Mynucius).
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
34
testamentarie, non è da escludere una sua pert inenza al sepolcro del
personaggio 70.
Datazione: sulla base della paleografia e delle forme linguist iche (quoius
per cuius), l’epigrafe potrebbe collocarsi nella prima metà del I sec. d.C.,
in un periodo, cioè, di ancora non grande diffusione del fenomeno delle
distribuzioni (cfr. supra)71.
5. Bibliografia: GASPERINI 1960, p. 221, nr. 23 (con foto); GASPERINI
1965, p. 63, nr. 45; Suppl.It. 16, 1998, pp. 55-56, nr. 10 (con foto); AE
1998, pp. 120-121, nr. 304.
Lastra frammentaria di marmo bianco e granuloso, mancante su tutti i lat i
e liscia in superficie. Dimensioni: 31,5 x 23,5 x 8,5 cm; alt. lett. 8,2-6,5
cm. Non sono not i epoca e luogo di rinvenimento; attualmente è fissata a
parete nella prima cappella della navata sinistra della chiesa di S. Maria
Maggiore ad Alatri. Autopsia 2010.
70 Così Suppl.It. 16, p. 39. 71 Così GASPERINI 1965, p. 39; Suppl.It. 16, p. 40; GALLI 2002, p. 51; d’altro avviso MROZEK 1987, p. 25,
che propone una datazione a cavallo tra I e II sec. d.C.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
35
- - - - - -
[- - -]+[- - -]
[- - -?] A[- - -]
[- - - A]letr[i - - -]
- - - - - -
1 omisit Gasperini; 2 [- - -] A [- - -] Gasperini 1960; [- - - ]A[- - -] Gasperini 1965.
Lettere elegant i e apicate; la traversa della A ha un solco molto leggero.
In r. 3 appare certa la menzione del nome della città o dell’etnico
Aletrinas72. Molto probabile, perciò, la natura pubblica od onoraria
dell’iscrizione, data anche la considerevole altezza delle lettere e
l’accuratezza della grafia.
Datazione: I sec. d.C.?73.
6. Bibliografia: Framm. a: CIL X 5818; PIERLEONI 1916, p. 47. a + b :
GASPERINI 1960, pp. 218-219, nr. 14; GASPERINI 1965, pp. 29-30, nr. 10;
Suppl.It. 16, 1998, p. 50, nr. 5 (con foto); AE 1998, p. 118, nr. 299.
Due frustuli (a, b) forse ricongiungibili: a) piccolo frammento di lastra
marmorea con lettere di grandi dimensioni visto da Stevenson (per conto
del CIL) nel 1878, all’interno del cort ile di casa Tagliaferri ad Alatri;
attualmente irreperibile. b) frammento di lastra marmorea grigia mancante
su tutt i i lat i tranne che a destra, dove si conserva un margine. Dimensioni:
18 x 15,5 cm ( lo spessore non è misurabile vista la collocazione del
documento); alt. lett. 4,5 cm. Non sono noti epoca e luogo di rinvenimento;
è ora conservato ad Alatri, murato a parete nello studio dell’avv. P. De
Cesaris, in via G. Matteotti nr. 22. Autopsia 2010.
72 Cfr. GASPERINI 1965, p. 63. 73 Così, su basi paleografiche, Suppl.It. 16, p. 56.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
36
a:
- - - - - -?
[- - -]RAI[- - -]
- - - - - -
b:
[- - -]++[·]
[- - -]ano
[- - - Da]cico
[- - - t]rib (unicia)
5 [pot(estate) - - -]
- - - - - -
a + b (?)
[- - -]++[·]
[- - - T]raiano
[- - - Da]cico
[- - - pont(ifici) max(imo) t]r ib (unicia)
5 [pot(estate) - - -]
- - - - - -
1 omisit Gasperini; «resta la parte inferiore di due aste verticali» Suppl.It. 16.
“... a Traiano... Dacico..., [pontefice massimo], invest ito della (sua...)
[potestà] tribunizia...”.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
37
Lettere fornite di graffie ed incise entro linee-guida binarie.
Gasperini prospetta due possibilità di ricongiunzione del framm. a: la
prima con CIL X 580174, la seconda col framm. b. Quest’ult ima sembra
prefer ibile in quanto permetterebbe di conservare la lettura T]rai[an-] –
riportata dal CIL – del framm. a. Non è escluso, però, che le lettere in esso
incise siano state lette male: potrebbe trattarsi, ad es., invece che del piede
posteriore di una R, della parte infer iore di una C, e, invece che una I,
dell’asta vert icale di una E, i cui tratt i orizzontali non sarebbero visibili per
una frattura subito a destra della lettera. Si avrebbe allora come esito una
lettura Cae[sar-] che ben si accorderebbe con la prima r. di CIL X 5801
(cfr. nt. 74), la quale, per di più, presenta analogie paleografiche col
framm. a, soprattutto per il part icolare affatto trascurabile delle litterae
magnae in comune.
Ad ogni modo, quali che siano le possibilità d’interpretazione e di
ricongiunzione del framm. a, è certo che in entrambi i casi si tratta di
iscrizioni imperiali, che potrebbero riguardare sia Traiano che Adriano e
collocarsi in un qualsiasi anno del principato dei due imperatori (98-138
d.C.). Se però si accetta la ricongiunzione col framm. b, la presenza in esso
dell’appellat ivo Dacicus induce ad attribuire l’iscr izione a Traiano e
consente, inoltre, di stabilire il terminus post quem del 102 d.C., anno in
cui tale epiteto fu conferito a questo imperatore. Meno convincente, d’altro
canto, la proposta d’attribuzione della dedica ad Adriano sulla base delle
attestazioni del cognomen Dacicus anche per questo imperatore, poiché tali
74 Lastra frammentaria di marmo bianco su cui sono incise grandi lettere (alt.: 12,5-9,5 cm) di ottima
fattura; è ora conservata nel Museo Civico di Alatri. Sulla base del rapporto tra altezza dei caratteri
superstiti e possibile titolatura imperiale da anteporre ad essi – la prima r. del testo termina infatti con
Tra[ian-] – Gasperini ricostruiva una sequenza di almeno 33 lettere perdute e ipotizzava che quest’unico
frammento conservato costituisse la parte iniziale dell’ultima lastra di un’iscrizione che doveva misurare
più di 4,5 metri di lunghezza, incisa probabilmente su almeno cinque lastre congiunte e pertinente a un
edificio pubblico di primaria importanza (secondo Galli fatto costruire o restaurare da Adriano – che di
Traiano aveva ereditato anche il cognome – nella prima metà del II sec. d.C.). Questa la trascrizione di
ciò che ne resta: [- - -] Tra[ian(-)- - -] / [- - - po]nt(if-) max(im-) / - - - - - - . Oltre a CIL X, cit., p. 566, cfr.
PIERLEONI 1916, p. 44; GASPERINI 1960, p. 218, nt. 4; GASPERINI 1965, pp. 28-29, nr. 9, p. 30, nt. 33
Suppl.It. 16, 1998, pp. 34-35, nr. 5801; GALLI 2002, pp. 37-38, nr. 2.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
38
attestazioni sono in realtà rar issime, sporadiche e quindi non
significat ive75.
I l framm. a fu rinvenuto in un’area termale: per tale ragione Gasperini
ipot izzava che l’imperatore dest inatario della dedica avesse fatto restaurare
il lacus balinearius d i Bet ilieno Varo (cfr. supra, iscr. nr. 1) e che
originariamente l’epigrafe fosse lì posta; tuttavia, una nuova iscr izione
sembra rivelare l’esistenza ad Alatri di almeno un altro impianto termale
fornito di laconicum76.
Datazione: vd. supra.
7. Bibliografia: GASPERINI 1960, p. 219, nr. 17; GASPERINI 1965, pp. 64-
65, nr. 48; Suppl.It. 16, 1998, p. 79, nr. 45 (con foto).
Lastrina frammentaria di marmo bianco mancante su tutti i lat i.
Dimensioni: 12 x 4,7 cm (spessore non misurabile vista la collocazione del
documento); alt. lett. 3,8-4 cm. Non sono noti epoca e luogo di
rinvenimento; conservata prima nel cort ile di casa De Cesaris ad Alatri, è
adesso fissata a parete nello studio legale di proprietà della stessa famiglia,
in via G. Matteott i nr. 22, sempre ad Alatri. Autopsia 2010.
75 Cfr. Suppl.It 16, p. 50; GASPERINI 1965, p. 30, che riporta alcuni esempi di restituzione della titolatura
completa per ciascuno dei due imperatori (cfr. ibid., nt. 34). Sulle occorrenze dell’appellativo Dacicus cfr.
CLAUSS - SLABY, visionato da ultimo in data 26/2/2011; vd. inoltre KIENAST 1990, pp. 123 sgg. 76 Questa epigrafe commemora un episodio di evergetismo da parte di un personaggio di cui si è perso il
nome, il quale donò alla città un laconicum (ambiente per saune), insieme forse ad altre strutture destinate
a un impianto termale, sulla cui collocazione, però, non si hanno notizie (incerta sembra l’identificazione
con il sopracitato lacus balinearius di Betilieno Varo). Cfr. LONGO 1996, pp. 63-65; Suppl.It. 16, 1998,
pp. 57-58; AE 1998, pp. 121-122, nr. 307.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
39
- - - - - -
[- - -]OC[- - -]
[- - -]ORIV[- - -]
[- - -]VS[- - -]
- - - - - -
1 [- - -]OC[- - -] Gasperini; [- - -]+O[- - -] Suppl.It. 16; 2 [- - -]ORIU [- -
-] Gasperini; [- - -]OR[- - -] Suppl.It. 16; 3 [- - -]V S [- - -] Gasperini; [- - -
]V S [- - -] Suppl.It. 16.
Lettere capitali rust iche apicate, allungate e con tracce di rubricatura.
Gasperini visionò il frammento in un migliore stato di conservazione,
segnalandone infatt i una larghezza maggiore (7,5 cm) rispetto all’attuale e
una diversa lettura, comprensiva di tre lettere successivamente cadute.
Accettando il testo tràdito dallo studioso, in r. 1 si potrebbero avanzare
integrazioni quali [h]oc, [ l]oc[-], [Di]oc[letian-], Oc[tobr-] ecc., senza
tuttavia poter stabilire i rispettivi contest i di appartenenza. In r. 2 si
potrebbe pensare a un nomen in –orius o anche a un [ux]ori seguito da una
parola cominciante per V (vocale o consonante) o per N77; non priva di
fondamento anche una lettura oriu[nd-], termine attestato soprattutto in
iscrizioni sepolcrali78. Nella prima di queste ipotesi (–orius), l’US di r. 3 –
più che parte del corpo o inizio di altra parola – cost ituirebbe la desinenza
di un nominat ivo maschile da correlarsi al nomen della r iga precedente. 77 GASPERINI 1965, p. 65. 78 Cfr. le occorrenze del termine in CLAUSS – SLABY, visionato da ultimo in data 8/11/2010.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
40
Datazione: non prima dell’inizio del II sec. d.C. su basi paleografiche
(capitale rust ica).
8. Bibliografia: GASPERINI 1960, p. 216, nr. 11 (pars.); GASPERINI 1965,
pp. 41-43, nr. 21 (con foto); Suppl.It. 16, 1998, pp. 54-55, nr. 9 (con foto);
AE 1998, p. 120, nr. 303.
Lastra di marmo bianco mancante su tutti i lat i e ricomposta da due
frammenti combaciant i, alquanto corrosa e incrostata in superficie, levigata
sul retro. Dimensioni: 40,5 x 20 x 3,5 cm; alt. lett. 2,5-3,9 cm. Non sono
not i epoca e luogo di r invenimento; fu donata nel 1932 da Don A. De
Cesaris al Museo Civico di Alatri, dove fu vista da Gasperini, che r iporta la
data del 7/11/1964 come giorno del ritrovamento, nel medesimo Museo, del
frammento minore79; attualmente irreperibile.
Fonte: GASPERINI 1965, p. 42.
79 GASPERINI 1965, p. 41.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
41
- - - - - -?
[- - -]+?[- - -]
[- - -]M S+[- - -]
[ob - - - dedicatio]nem da[ti sunt?]
[- - - uxo]rib(us) ((denarii)) V +[- - -]
5 [- - - u]xorib(us) ((denarii)) II[- - -]
[- - -] panis et v[inum]
[- - - popu]lo ((denarius)) sin[g(ulus)]
[- - -] K(alend-) Oct(obr-)
[Marco Civica] Barbar[o]
10 [Marco Metilio] Regul[o]
[co(n)s(ulibus)].
1 omisit Gasperini ; 2 [- - -] M SP (?)[- - -] Gasperini 1965; 3 [- - -]NEM
DA[- - -] Gasperini 1965; 4 [- - -]O X V M [- - -] Gasperini 1960; [- - -
]rib(us) ((denar i-)) V X [- - -] Gasperini 1965; 5 [- - - u]xorib(us) X II [- - -
] Gasperini 1960; [- - - u]xorib(us) ((denarios)) II[- - -] Gasperini 1965; 6
[- - -] panis et v[in(-) - - -] Gasperini 1965; 7 [- - -]LO A SIN[- - -]
Gasperini 1960; [- - -]LO X sin[g(ul-) - - -] Gasperini 1965; 8 [- - -] K
Oct(obr-?) [- - -] Gasperini 1960; 9 [- - -] Barbar [- - -] Gasperini 1960; 10
[- - -] Regul [- - -] Gasperini 1960.
“ ...per [l’inaugurazione] (del/dei)... [sono stat i?] assegnat i cinque denarii
alle mogli (dei)..., (due?) denarii alle mogli (dei)..., pane e [vino] (a?)...,
un denario a ciascun membro del popolo. Il giorno... delle calende di
ottobre, [sotto il consolato di Marco Civica] Barbaro e [Marco Metilio]
Regolo”.
Le lettere, regolari e ben curate, presentano alle loro estremità delle
graffie; il denario è indicato con il simbolo X barrato; interpunzione
regolare a triangolini con il vert ice in basso; probabile impaginazione a
simmetria centrale.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
42
Trattandosi di un documento estremamente frammentario, incertezze di
lettura sussistono per quasi tutte le r ighe: in part icolare alla seconda, alla
quarta e alla quinta per l’ult ima lettera; alla ottava invece il carattere
iniziale è sicuramente un K; assai difficoltosa è pertanto la rest ituzione
sicura del testo. Alcuni indizi farebbero pensare che si tratti di un
frammento di una qualche lex collegi80: si parla, infatt i, di uxores (dei
membri del collegio?), di panis et vinum (da darsi in qualche misura?) e di
una data precisa. In tal senso numerosi sono i confront i possibili81, ma il
più stringente appare quello con la lex collegii Aesculapi et Hygiae82, di
tutte la più vicina cronologicamente (153 d.C.) al nostro frammento.
Tuttavia, ipot izzando che l’inizio del testo si estendesse per un numero di
righe di poco superiore alle superst it i – cosa assai probabile già per
Gasperini, in considerazione della forma e dell’aspetto paleografico del
frammento minore – si avrebbe come conseguenza un’ampiezza troppo
limitata per una lex collegii. Sembra quindi più verosimile ritenere il
documento come una delle tante dedicationes83, che presentano, in alcune
part i, un frasario vicino a quello delle leges collegiorum84.
Verrebbero così a delinearsi i tratti dist int ivi di un’iscrizione
commemorat iva di un episodio di munificenza civica ver ificatosi in
occasione di una dedicatio. Del resto, le maggiori dimensioni delle prime
lettere superst it i e la standardizzazione del formulario lasciano presumere 80 Lex collegii vel sodalicii: veniva così definito l’accordo (generalmente redatto in forma scritta) che
disciplinava dettagliatamente l’organizzazione e il funzionamento dei collegia e delle sodalitates (sui
collegia vd. DE II¹, pp. 340 sgg., sv. Collegium). 81 GASPERINI 1965, pp. 41-43, ne cita alcuni: CIL XIV 2112 = ILS 7212 e 7214. 82 CIL VI 10234 = ILS 7213 83 Una in particolare, da Ferentino, offre dei confronti piuttosto interessanti con l’iscrizione alatrense: cfr.
CIL X 5849 = ILS 6269. La dedicatio può essere intesa in una duplice accezione: come cerimonia solenne
– propria del diritto sacro – che accompagna la consecratio di un tempio, di un sacello, di un’ara (e
simili), da parte di un magistrato incaricato dallo Stato, oppure – più genericamente – con valore di
offerta, inaugurazione. Specialmente in quest’ultima accezione ricorre spessissimo nelle iscrizioni, come
atto compiuto indifferentemente da magistrati (romani e/o municipali) a nome proprio, da sacerdoti, da
rappresentanti di corporazioni o da semplici privati, e relativo sia a cose sacre che profane (cfr. DE II², p.
1553, s.v Dedicatio [numerosi i riferimenti epigrafici]; più recentemente MROZEK 2004, pp. 119-134). 84 Esempi di frasario nelle dedicationes in GASPERINI 1965, p. 43, nt. 43.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
43
che il testo si aprisse con il nome di una benefattrice e con l’indicazione
della circostanza della distribuzione [ad es. s(ua) p(ecunia) o st[atuam in r.
2]85. Nelle divisiones promosse da donne si tendeva in genere a privilegiare
o a convocare solamente altre donne86: la nostra epirafe sembra
riconducibile al pr imo di quest i due contest i. Sulla base dei dat i relat ivi
all’ent ità delle somme elargite in rapporto al rango sociale delle
beneficiarie87, nelle pr ime (r. 4) – nonostante rest ino tracce di segni poco
dist inguibili in frattura a destra – si potrebbero vedere le decurionum
uxores con 5 denarii, e nelle seconde (r. 5) le VIvirorum Augustalium
uxores con almeno due denarii. In r. 6 il dono di panis et vinum, prevalso
dall’età di Adriano su quello di crustulum et mulsum, era dest inato forse a
un collegio 88. In r. 7 il populus appare remunerato con un solo denario, e la
cifra viene indicata a parole.
Notevolissima è la seconda parte del testo, con la data consolare, che fa
di questa iscr izione il documento epigrafico alatrense più precisamente
datato. I due consoli sono quelli ordinar i del 157 d.C. (M. Ceionius Civica
Barbarus e M. Metilius Aquillius Regulus Nepos Volusius Torquatus
Fronto89); la data cade tra il 14 e il 30 settembre di quell’anno, o forse il
primo ottobre, qualora si sia persa la sigla ded( icata) a sinistra di
K(alend-)90.
85 Cfr. Suppl.It. 16, p. 55 (con ulteriore bibliografia sull’argomento) 86 Cfr. CIL IX 3171 Corfinium, XI 3811 Veii. 87 Vd. DUNCAN JONES 1965, pp. 214 sgg.; MROZEK 1972, pp. 36 sgg. 88 Così Suppl.It. 16, p. 55. 89 Cfr. DEGRASSI 1952, p. 44. 90 Suppl.It 16, p. 55, propende per la data del primo ottobre; GASPERINI 1965, p. 43, opta per l’altra
possibilità, «per una questione di simmetria compositiva del testo», pensando cioè che l’impaginato
richieda, a sinistra di K(alend), un elemento simmetrico rispetto a Oct(obr-).
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
44
9. Bibliografia: CECCACCI CASALE 1902, p. 12; FLORIDI 1971, pp. 15-19 e
tav. VII (foto ricostruzione Ciavardini); Suppl.It. 16, 1998, p. 48, nr. 4 (con
foto, ricostruzione Ciavardini); AE 1998, p. 118, nr. 298; SOLIN 2006, pp.
355- 362 (con foto, ricostruzione Ciavardini).
Iscrizione frammentaria, ora irreperibile, rinvenuta nel corso di scavi
condott i alla fine dell’Ottocento in località Porretta della Cisterna, sulla
strada da Guarcino a Subiaco, tra i resti di una villa romana detta di
Calpurnio. Di essa esistono tre diversi apografi (vd. infra) e due
ricostruzioni moderne su pietra: la prima, già conservata nella chiesa di S.
Nicola di Guarcino, è adesso custodita presso privat i (famiglia Ciavardini);
la seconda si trova nella sezione “Guarcino” dell’Archivio di Stato di
Frosinone. Ult ima autopsia H. Solin 1989 (primo esemplare)91; entrambe
inaccessibili all’autore (2010).
Ricostruzione moderna custodita presso famiglia Ciavardini (fonte: FLORIDI 1971, tav. VII).
91 Nell’ambito dei lavori per la nuova edizione del volume X del CIL, H. Solin ha effettuato la prima
schedatura, il controllo autoptico e le fotografie di molte iscrizioni alatrensi poi confluite nei Supplementa
Italica (vol. 16), sorta di “redazione proecdotica” del nuovo CIL X; in determinati casi - come per questa
ricostruzione - l’unica documentazione fotografica disponibile è proprio quella di H. Solin, i cui negativi
si conservano nell’Archivio dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma (Neg. Ist. Arch. Germ. Roma
89. 884 = Suppl.It. 16, p. 49). La foto riportata in FLORIDI 1971 (tav. VII), qui riproposta, risale invece al
periodo in cui la stessa ricostruzione era conservata nella chiesa di S. Nicola di Guarcino
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
45
In hoc luco stipit ibus crebro Nimphis (! )
sacro aliquando modo ut sane viveret
atque ut caperetur salus debilis rus
aedificavit refertum arboribus et
5 fr igidis ac excellenter sit is aquis
ut l imphis eius limpidis ac dulcibus
leventur magnae molestiae et curae
Calphurnius L(ucii) F( il ius).
1 [- - -] HO [- - -] PITIBVS Nunphis Fonteanive; [- - -] hospit ibus
Nimphis Ceccacci Casale; [- - -] hospit ibus? Ninphis Descriptio Archivio
S.A.L.; 2 [- - -] aliquando sane vivere Ceccacci Casale; [- - -] aliena [- - -]
D [- - -] SA [- - -] E VIV [- - -] E Fonteanive; [- - -] aliena AD [- - -] SA [-
- -] E VIV [- - -] E Descriptio Archivio S.A.L.; sacro aliquas domos do ut
sana viveretur Recens restitutio (Frusino), Floridi; 3 [- - -] CAP [- - -]
SAL [- - -] D [- - -] Ceccacci Casale; CAPE [- - -] E SAL [- - -]
Fonteanive; vita et caperetur aliis debilis rus aedificavi Recens restitutio
(Frusino), Floridi; 4 [- - -] arboribus Ceccacci Casale, Descriptio Archivio
S.A.L; 5 [- - -] FRIG [- - -] A [- - -] cerat is [- - -] aquis Fonteanive; [- - -]
FRIG [- - -] AC ERSITIS aquis [- - -] Ceccacci Casale; [- - -] FRIG [- - -]
accersit is? aquis Descriptio Archivio S.A.L. ; 6 [- - -] DVLCI [- - -] S [- - -]
Fonteanive, Descriptio Archivio S.A.L ; [- - -] dulcibus S [- - -] Ceccacci
Casale; 7 [- - -] HVMAN [- - -] / [- - -] MOLE [- - -] curae [- - -]
Fonteanive, Descriptio Archivio S.A.L. ; [- - -] molest iae curae [- - -]
Ceccacci Casale.
I l primo a vedere il testo dell’originale è stato probabilmente L. Celani,
uno studioso locale che aveva intrapreso, a proprie spese, gli scavi della
villa; di quest i diede not izia D. Marchett i in una relazione pubblicata nel
1891, nella quale si datava l’impianto alla prima metà del II sec. d.C.92.
92 Cfr. Not. Sc. 1891, pp. 317-320. Dalla stessa relazione risulta che Marchetti ebbe notizia di un apografo
di Celani, che probabilmente non vide, altrimenti ne avrebbe riportato il testo; dallo stesso Celani, però,
venne sicuramente informato del contenuto dell’iscrizione, poiché egli riferisce di un testo che fa
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
46
Ancora oggi se ne conservano, pur notevolmente copert i da vegetazione,
rest i murari in opera ret icolata e in calcestruzzo di selce. Purtroppo non si
conosce l’esatto luogo di r invenimento dell’epigrafe; Marchett i riferisce
soltanto che i suoi frammenti «dicevansi adoperat i nella costruzione delle
macerie prossime alla descritta località»93; in una lettera di R. Fonteanive
inviata nel 1890 al Ministero – contenente anche una trascrizione del testo
fatta «da persona del luogo»94 – essa si dice già frantumata, e sembra che
nessuno l’abbia più vista, se non L. Culla e G. Ceccacci-Casale, cui si
devono altre due trascrizioni dell’epigrafe, una delle quali perduta95. Un
sopralluogo sul posto effettuato il 24 ottobre 1993 da H. Solin non recava
nuovi element i per le vicende dell’iscr izione, di cui sono svanite tutte le
tracce. Oltre alle trascr izioni menzionate, si conosce un terzo apografo
custodito nell’archivio dalla Soprintendenza Archeologica del Lazio 96.
Per rest ituire il testo dell’iscrizione perduta, del tutto fuorviant i e pr ive
di valore scient ifico appaiono le due ricostruzioni moderne, frutto di un
arbitrario tentat ivo di imitazione compiuto da erudit i locali97. Gli apografi
menzione di «certe acque allacciate», che, dai dati in nostro possesso, non è possibile stabilire cosa
fossero. Notizie più esaustive sul sito archeologico e sui materiali ivi rinvenuti sono contenute infra. 93 Cfr. ibid. 94 Questa lettera, scritta a Roma l’11 marzo 1890, si trova nell’Archivio di Stato, AA.BB.AA. II
versamento, I serie, fasc. 4514. In essa viene riferito del ritrovamento dei ruderi; inoltre vi si dice: «Fu
copiata da persona del luogo l’iscrizione, la cui lastra fu frantumata da quei villani per far materiale da
macerie di confine» (cfr. SOLIN 2006, p. 356, nt. 5). 95 Nel 1902 G. Ceccacci-Casale pubblicò dell’epigrafe una trascrizione, contenuta nell’opera citata in
bibliografia. La trascrizione di L. Culla era presente in un ms. autografo, ora irreperibile, del sec. XIX,
già conservato nell’Archivio Storico della Collegiata di S. Nicola di Guarcino, dal titolo: Discorso
intorno alla venuta di S. Agnello nelle montagne di Guarcino. Un ampio passo di questo ms., relativo alla
“villa di Calpurnio”, è citato in FLORIDI 1971, pp. 15-18, il quale riferisce che il testo dell’iscrizione
doveva trovarsi a p. 36 dello stesso ms. (così anche SOLIN 2006, p. 357). 96 Questo apografo è citato in apparato con la dicitura Descriptio Archivio S.A.L.; stando a SOLIN 2006, p.
357, di esso non si hanno più tracce nell’Archivio della Soprintendenza; lo stesso autore riferisce di
averne ottenuto una copia da un membro dell’Archeoclub di Alatri (cfr. SOLIN, cit., pp. 357-358 e nt. 10). 97 Così Suppl.It. 16, p. 49; SOLIN, cit., p. 359, il quale aggiunge (p. 361): «A mio parere, anche il fatto che
le due copie moderne hanno un tenore completamente diverso dalle trascrizioni a noi giunte, depone
contro l’idea che le trascrizioni esistenti riproducessero un’epigrafe falsa: quel poco che si capiva dal
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
47
disponibili invece, pur lacunosi e talvolta scorretti (cfr. apparato), possono
riavvicinarci all’or iginale, poiché tramandano lezioni scaturite da
rilevament i autopt ici, le quali, peraltro, spesso coincidono. Nella pr ima
riga, ad es., ciascuno di essi trascrive una lacuna iniziale seguita da
hospitibus Nymphis, con quest’ult ima parola in forme leggermente diverse,
ma pressoché equivalent i; è pertanto corretto ritenere tale iunctura
autent ica, a dispetto di stipitibus Nimphis certamente corrotto. Sospett i di
intervent i arbitrari sul testo emergono anche a proposito della
concentrazione pleonast ica di avverbi (crebro, aliquando, modo) nelle
prime due righe della r icostruzione Ciavardini, con il solo aliquando
probabilmente autent ico, essendo l’unico riportato dagli apografi98. Anche
in r. 5 la sequenza originaria delle lettere si ricava dalla collatio delle
trascrizioni dirette: l’apparentemente incomprensibile AC ERSITIS di
Ceccacci Casale o il quasi omologo accersitis della descriptio
dell’Archivio S.A.L. consentono infatti di rest ituire un accersitis
aquis...dulcibus in grado di fugare ogni dubbio sulla presunta autent icità
dell’espressione ac excellenter sitis aquis. Di difficile interpretazione e
sicuramente corrotta è anche la riga 6, caratterizzata da una sequenza di
ablat ivi interrotta dal solo eius (sintatticamente pendens), che – ad
eccezione di dulcibus – non trovano riscontri nelle varie trascrizioni.
Nella forma tramandata dagli apografi – che abbiamo visto essere molto
diversa da quella delle due ricostruzioni moderne – l’epigrafe presenta
sorprendent i analogie con un documento settecentesco: l’iscrizione posta
sul portale d’ingresso della residenza del principe d’Elbeuf a Port ici
(Napoli), che potrebbe cost ituire una test imonianza indiretta della perduta
epigrafe di Guarcino. Essa fu redatta nel 1711 da Matteo Egizio (Napoli,
1674-1745), regio bibliotecario di Carlo di Borbone, e pubblicata postuma
(1751) nei suoi Opuscoli volgari e latini (p. 252), una raccolta di scritt i di
varia erudizione compilat i dall'autore nel corso della sua vita e riguardant i
testo era meno comprensibile agli umanisti locali, che perciò videro preferibile creare un nuovo testo
quando si misero a comporre il loro prodotto». 98 Cfr. la lezione di Ceccacci Casale in apparato (r. 2).
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
48
prevalentemente l'ant iquaria99. Tra i molteplici interessi di questo dotto
interprete della cultura napoletana del Settecento, ampio risalto fu
attribuito anche all’epigrafia, trattata a più riprese in numerosi carteggi
edit i e inedit i, spesso sotto forma di iscrizioni autografe per lo più redatte a
imitazione di modelli ant ichi. Qualcosa di simile dovette avvenire anche
con l’epigrafe guarcinese, che, tuttavia, sembra non trovare traccia esplicita
in nessuno degli scritt i (pubblicat i) dell’Egizio; l’iscrizione composta per il
principe d’Elbeuf presuppone però la sua conoscenza, ed è probabile che
essa sia avvenuta per via indiretta, ovvero attraverso la comunicazione o la
richiesta di consulto di qualche ant iquario in contatto con l’erudito
napoletano che ebbe modo di visionarla. In alternat iva e in via ancor più
ipotet ica, si può supporre che lo stesso Egizio fosse transitato nel territorio
di Guarcino nel corso di qualche suo viaggio e che avesse visto il
documento personalmente.
A conferma di quanto finora ipot izzato, e per agevolare il confronto fra le
due iscrizioni, si riporta il testo dell’epigrafe settecentesca, evidenziando le
lezioni probabilmente riprese e/o riadattate dall’iscr izione guarcinese
autent ica, nella forma, cioè, tramandata dagli apografi.
Loci genio
amoeniq(ue) littoris hospitib(us) Nymph(is)
ut liceat aliquando bene beateq(ue) vivere
atq(ue) inter honesta ocia (!) sive studia
5 solidam cum amicis capere voluptatem
Emman(uel) Maur(itius) a Lotaringia
Elbovianor(um) princeps
complanato solo satis arboribus
dulcibusq(ue) accersitis aquis
10 hunc secessum sibi paravit ann(o) Dom(ini) MDCCXI
abite hinc urbanae molestaeq(ue) curae.
99 Per biografia e opere dell’Egizio vd. DBI, vol. 42, s.v. Egizio [M. CERESA].
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
49
Al di là dei necessari adattament i dovut i alla diversa funzione e
collocazione dell’epigrafe – inserit i anche per cautelarsi da eventuali
sospetti di plagio – alquanto evident i appaiono alcuni prest it i dal
documento più ant ico: anzitutto hospitib(us) Nymph(is) in r. 2, che non
trova nessun’altra attestazione epigrafica100, il che sarebbe già sufficiente
per confermare l’assunto di partenza, ovvero la probabile dipendenza di
questa iscrizione da quella guarcinese; e ancora: aliquando bene... vivere
(r. 3) richiama direttamente aliquando sane vivere tràdito da Ceccacci
Casale, così come capere voluptatem (r. 5) il cape[re] sal[utem?]
ricostruibile dagli apografi guarcinesi. Ma la prova più evidente della
derivazione dell’epigrafe settecentesca dal modello ant ico è cost ituita dalla
somiglianza lessicale riscontrabile nelle sezioni relat ive all’aspetto
“paesaggist ico” dei luoghi descritt i, luoghi «in cui il bello naturale era, con
grazioso intreccio, congiunto all’art ist ico»101: in entrambe si accenna infatt i
alla presenza di alberi (cfr. r. 8: arboribus, r icorrente anche negli apografi
guarcinesi) e di acque fatte scaturire per mezzo della sapienza tecnica
dell’uomo [cfr. r. 9: dulcibusq(ue) accersitis aquis < frigidis accersitis
aquis negli apografi]. A conferma della tesi di fondo, decisivo è proprio il
comune ricorso ad accersitis – variante del più frequente arcesso – che in
quest’accezione non ricorre mai in altre iscrizioni102; a meno che – cosa a
mio avviso improbabile viste le numerose altre analogie tra i due test i –
non lo si voglia considerare mutuato da Front ino, che in un passo usa lo
stesso verbo nel medesimo significato (“far venire, chiamare”)103, sempre in
associazione alle acque. Anche urbanae molestaeq(ue) curae (r. 12), infine,
richiama molto da vicino human[ae] molestiae curae[que] dell’iscr izione di
100 Cfr. le ca. 735 occorrenze di Nymph- in CLAUSS – SLABY, ove non compare mai in associazione a
hospit- (sito visionato da ultimo in data 15/12/2010). Anche la iunctura hospes-nome di una divinità è
molto rara: cfr. ThLL VI, col. 3030, 46-52. 101 CULLA, cit., in FLORIDI 1971, p. 17. 102 Per accers- si registrano soltanto 3 occorrenze in CLAUSS – SLABY, tutte relative a iscrizioni cristiane
(cfr. ...accersitus ab angelis... in ICUR III 9155 = ILCV 3354; ...in pace accersitus... in ILAlg I 1174 =
ILCV 1230 = AE 1920, 40, ecc.); 11, nello stesso database, le occorenze di arcess-, nessuna delle quali in
associazione ad aqua (sito visionato da ultimo in data 15/12/2010). 103 FRONTIN. aq. 91, 4.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
50
Guarcino, mentre per la parte iniziale della stessa riga (abite hinc) pare che
l’Egizio si sia ispirato soprattutto a Marziale (epigr. 11, 6, 6: pallentes
procul hinc abite curae).
Presumibilmente, riprese e adattament i interessarono anche le part i
dell’iscrizione ant ica che gli apografi non poterono più leggere perché
distrutte, ma che, all’epoca dell’Egizio, forse si conservavano ancora. Ciò
consente di avanzare – sempre sulla base del confronto – una serie di
integrazioni, le quali, combinate alle lezioni tràdite, rest ituirebbero il
seguente testo:
[Huius loci?] hospitibus Nimphis (! )
[l iceat mihi?] aliquando sane vivere
[atque] cape[re] sal[utem corpus]
[positis satis?] arboribus [et]
5 frig[idis] accersitis aquis
[- - -?] dulcibus[que]
[procul hinc?] human[ae]
[- - -?] molestiae curae[que]
Calphurnius L(uci) f(ilius).
“Alle ospitali Ninfe [di questo luogo]: [avendo (io) piantato numerosi]
alberi e fatto scaturire fresche e... dolci acque, [mi sia concesso] di vivere
finalmente in modo sano e di ottenere una (buona) salute. [(Tenetevi)
lontani da qui]... fast idi e affanni dell’umana specie.
Calpurnio figlio di Lucio”.
L’iscrizione così ricostruita si pone in stretta corrispondenza con gli
altri rest i archeologici ritrovat i insieme a essa. In contrada Porretta della
Cisterna, a tre km da Guarcino, a dest ra della strada che conduce a
Subiaco104, scavi condott i nel 1889 riportarono alla luce un complesso di
104 Il sito in questione e la stessa città di Guarcino sorgono lungo la via Sublacense, strada romana rifatta
interamente da Nerone per agevolare l’accesso alla villa privata fatta costruire dall’imperatore presso
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
51
bagni alimentato da un acquedotto scavato nella roccia viva, che portava
l’acqua da una sorgente, ormai scomparsa, a questa località; di esso rimane
il tracciato, poi diventato una mulatt iera che va da Colle Vedetta a Capo
Cosa105. Nello stesso sito furono rinvenut i anche rest i di pavimento a
mosaico bianco e nero (conservat i nella Collegiata di S. Nicola di Guarcino
fino al XIX sec.), intonaci dipint i, numerosi framment i marmorei, oltre ad
alcuni mur i di opera ret icolata in pietra locale pert inent i a un imponente
edificio termale dist into in sette ambient i e occupante una superficie di
1200 mq106. Quest i balnea – che nell’immaginario degli abitant i del luogo
venivano attribuit i addir ittura a Nerone107 – sorgevano all’interno di una
sontuosa villa forse di proprietà dello stesso Calphurnius, l’autore, non
meglio ident ificabile, della nostra iscrizione. Sull’ident ità di questo
personaggio, una sola considerazione appare certa: a giudicare
dall’ampiezza della domus – e ammettendo che costui ne fosse realmente in
possesso, il che non sembra potersi mettere in discussione visto il tenore
del testo – egli dovette raggiungere (a Roma?) una posizione elevata e un
cospicuo censo 108. Il gent ilizio Calphurnius potrebbe ricondursi al più
usuale Calpurnius attestato ad Anagnia (CIL X 5947) e ad Aquinum (CIL X
Subiaco; questa arteria si distacca dalla Tiburtina Valeria nei pressi di Rubianum (od. Roviano, Roma) e,
superata Guarcino, si ricongiunge alla Prenestina poco prima di Alatri. 105 Cfr. FLORIDI, cit., p. 15. Guarcino è da sempre famosa per le sue acque sorgive; l’acqua minerale
alcalina della sorgente Filette è a tutt’oggi usata per la cura delle malattie. Proprio in virtù
dell’abbondanza di acque del territorio guarcinese, gli storici locali, da ultimo FLORIDI, cit., p. 15,
ritenevano che la città fosse nota agli autori antichi; ma tale credenza, come fa notare SOLIN, cit., pp. 359-
360, nt. 15, deriva da un’errata interpretazione di un passo di Columella (1, 5, 2), nel quale viene
celebrata la località di Guarceno Campaniae per la purezza delle sue acque; questo nome infatti,
associato a “Guarcino di campagna” dagli eruditi locali, altro non è che l’esito di una corruttela presente
nei codici recenziori di Columella, solitamente emendata in Guarano Campaniae (sulla correttezza di
questo emendamento, però, lo stesso Solin esprime dei dubbi: cfr. ibid.). 106 Cfr. Not. Sc. 1891, pp. 317-318; FLORIDI, cit., p. 19, che riferisce: «Della villa di Calpurnio, oggi
[1971, NdA] rimangono alcuni avanzi dei muri in ‘opus reticolatum’ e, tutt’intorno, si rinvengono resti di
condutture in terracotta e tessere di mosaico». 107 Cfr. CULLA, cit., in FLORIDI 1971, p. 16. 108 Così FLORIDI, cit., p. 18.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
52
5395); con labiale aspirata lo si ritrova in poche altre iscrizioni incerte,
false o tarde109.
Verrebbero così a delinearsi i caratteri di una dedica alle Ninfe pro
salute, composta in st ile solenne dal proprietario della villa e collocata
probabilmente in un sacello consacrato a queste figure divine minor i,
ubicabile all’interno dello stabilimento termale. In effett i gli impiant i
termali, sia quelli che avevano scopi terapeut ici, sia gli altri, i bagni d’uso
comune, potevano avere al loro interno (o nelle immediate adiacenze) un
luogo di culto dedicato alle Nymphae110: «Ciò si spiegherebbe considerando
che, secondo le credenze degli ant ichi, anche in quelle acque, incanalate in
apposite condotte, si manifestava il loro nume e quindi poteva essere
adorato, tanto più che a queste divinità minori del pantheon romano, come
è noto, non venivano in genere consacrati templi nelle città, ma altar i,
erett i in aperta campagna o in grotte, nei pressi delle font i, di cui erano
signore»111.
Nelle dediche di questo tipo i fedeli invocavano le Ninfe come divinità
salutari, in genere per ottenere da esse la guarigione da qualche malatt ia
oppure per conservare la buona salute, eventualmente minacciata da
epidemie o da altri per icoli112; la nostra epigrafe sembra riconducibile alla
prima t ipologia di invocazione.
Nonostante il carattere vagamente poet ico del testo, a giudicare dalle
poche porzioni giunteci integralmente (hospitibus Nimphis in r. 1 e
109 Cfr. Suppl.It 16, p. 49 (con ulteriori riferimenti epigrafici e bibliografici). Per Calfurnius, gentilizio
distinto da Calpurnius, cfr. invece SCHULZE 1904, pp. 137-138. 110 Cfr. in ARNALDI 2006, pp. 55 sgg., i casi di Centumcellae, Bagno Vignoni (regio VII), Ostia e Roma
(Terme Eleniane). 111 ARNALDI, cit., p. 83. 112 Cfr. ARNALDI, cit., p. 73. Numerose iscrizioni di questo tipo sono state rinvenute in ambito provinciale
(cfr. ad es. CIL II 168, 2530; III 1397, 1957, 4119, 4423, 4556, 8569, 134000; XIII 391 ecc.), mentre, per
l’Italia romana, se ne conoscono due soli esempi: il primo è un’epigrafe offerta in dono alle Nymphae pro
salute sua et suorum da un servo imperiale, Eutyches, che fu ritrovata nel 1955 in Via Eleniana, a Roma;
il secondo è un titulus di Ancona, che un T(itus) Fl(avius) Optatus consacrò in voto pro salute sua et
suorum et collegarum alle Nymphae, qualificate con l’usuale epiteto di Augustae (su entrambi cfr.
ARNALDI, cit., pp. 74 sgg.).
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
53
accersitis aquis in r. 5) sembra che l’iscrizione non avesse una veste
metrica: la prima iunctura, ad es., è certamente a chiusura della prima riga,
ma essa non può finire né un esametro né un pentametro113.
Quanto alla datazione dell’epigrafe, la si potrebbe collocare alla prima
metà del II sec. d.C., poiché a questo periodo risalgono gli altri rest i
archeologici rinvenut i in situ (cfr. supra).
10. Bibliografia: GASPERINI 1960, pp. 216-217, nr. 12; GASPERINI 1965,
pp. 69-70, nr. 58; AE 1997, p. 108, nr. 275; GALLI 2002, pp. 70-71, nr. 24,
p. 103, fig. 24 (foto).
Frammento di laterizio di argilla rossastra mancante su ogni lato, ma con
retro ancora intatto. Dimensioni: 17,5 x 19 x 3,5 cm; alt. lett. 1,9 cm. Di
provenienza ignota, è attualmente conservato nel Museo Civico di Alatri.
Non mi è stato possibile procedere all’autopsia in quanto il reperto giace in
un’area inaccessibile del suddetto Museo; ult ima autopsia L. Galli (1997).
Fonte: GALLI 2002, p. 103, fig. 24
Comm(odi) Aug(usti) [- - -?]
113 Così già SOLIN, cit., p. 361.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
54
“(Dalle officine dell’imperatore) Commodo Augusto...”.
Le lettere, stampigliate a incavo nell’argilla ancora molle, compongono
una scritta lineare sormontata da una barra rett ilinea (l’impronta del
margine superiore della matrice), anch’essa incavata e leggermente obliqua;
la A è priva di tratto orizzontale.
Ad Alatri è conservato un altro bollo laterizio 114 con impresso il nome
dell’imperatore Commodo (177-192 d.C)115, pressoché ident ico a questo: in
entrambi i casi, mancando dei confront i, è da escludere che si tratti di parte
di una datazione consolare. La forma dei due bolli alatrini si differenzia da
quella, più frequente, dei bolli d i produzione urbana: le lettere non sono
disposte concentricamente entro un limitato campo epigrafico circolare116,
ma si collocano - senza uno spazio ben definito - su una linea orizzontale,
essendo, peraltro, incavate invece che a rilievo 117. Bolli rettangolar i,
databili tra la fine della Repubblica e i primi secoli dell’Impero, ricorrono
spesso in laterizi del Latium vetus (Roma compresa) e dei centri
limitrofi118. È probabile che i due mattoni o tegole, cui i framment i
appartengono, siano stat i importat i da Roma119; se così non fosse, essi
documenterebbero l’esistenza di una figlina di proprietà imperiale nel
territorio di Alatri, dove, peraltro, si ha test imonianza di libert i imperiali
(cfr. iscr. nr. 3).
114 Cfr. GASPERINI 1965, p. 70, nr. 59.
115 Per la titolatura cfr. CIL VI 1540, 31675 (cfr. p. 3805) = VI 41145 (cfr. p. 4948) = ILS 1112.
116 Cfr. ad es. CIL XV 162, 402, 541 a-b, 742, 743, 847 ecc.; inoltre BLOCH 1968, p. 23. 117 Cfr. CIL XV, pp. 1-2. 118 Per Latium vetus e centri vicini cfr. CIL XV 2164, 2193, 2232 ecc.; per Roma: CIL XV 776, 777, 779
ecc. 119 Cfr. ad es. i due bolli rinvenuti nell’Italia settentrionale, uno su anfora da Asolo e l’altro su mattoncino
dal bellunese; il primo reca la scritta Imp(eratoris) Nervae Aug(usti), il secondo Imp(eratoris) Anto(nini)
Aug(usti); cfr. rispettivamente PAIS 1884, nn. 1077 e 1075.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
55
Datazione: 177-192 d.C.
11. Bibliografia: Framm. a: FIORELLI 1884, p. 86; Eph. Epigr. VIII, 1899,
p. 154, nr. 621; QUATTRO CIOCCHI 1928, p. 107. Framm. b: SCACCIA
SCARAFONI 1916, p. 12. a + b: GASPERINI 1965, pp. 37-38, nr. 18; Suppl.It.
16, 1998, pp. 53-54, nr. 8 (con foto); AE 1998, pp. 119-120, nr. 302.
Due frustuli (a, b) forse ricongiungibili, il pr imo dei quali (a) visto e
copiato da P. Orsi «in pavimento abbatiae S. Agnetis (detta più
comunemente di S. Sebast iano) sul monte ad oriente di Alatri»120; ad oggi
risulta perduto e di esso non si conosce né forma, né materia, né
dimensioni; unico part icolare, ricavabile dalla versione t ipografica della
riproduzione di Orsi, la minore altezza delle lettere in r. 4121.
Sulla base di possibili integrazioni quali trib(unicia?) [pot(estate?)] in r.
2, bono [r(ei) p(ublicae) nat-?] in r. 3 e [municipes et i?]ncol(a)e in r. 4 –
monottongato per di più alla maniera tardo imperiale (infra) – Gasperini
ipot izzava che il frammento fosse parte di una dedica imper iale di IV sec.
d.C.; in alternat iva proponeva un’«assai più probabile» ricongiunzione –
adottata anche qui – con un altro frammento della medesima Abbazia, di
seguito descritto.
b: frammento di lastra marmorea bianca, di forma trapezoidale, levigato
nel prospetto e scalpellato nei margini inferiore e superiore, mancante su
tre lat i fuorché superiormente, dove si conserva una cornice di 3,5 cm. di
altezza. Dimensioni: 29,5 x 37,5 x 6,5 cm; alt. lett. 5-2,3 cm. Attualmente è
fissato a parete nel vest ibolo del refettorio dell’Abbadia di S. Sebast iano.
Autopsia 2010.
120 Eph. Epigr. VIII, cit., p. 154 (a presentazione dell’iscrizione). 121 Cfr. ibid.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
56
a (Eph. Epigr. VIII): b (Scaccia Scarafoni):
F VARRONI
TRIB MILITVM
BONO
NCOLE OSTAIORTE
a + b (?)
[- - -] f(ilio?) Varroni [- - -?]
[- - -] trib(uno) militum [- - -]
[- - -] bono [- - -]
[- - - i]ncole (!) [p]ost ⌐m¬ortem [- - -?]
- - - - - -?
4 OSTAIORTE Scaccia Scarafoni ; OST A IORTE Quattro Ciocchi ; [- - -
]ncole OSTAIORTEM[- - -] Gasperini; «AI sulla pietra» Suppl.It. 16.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
57
“A ...Varrone (figlio di?)..., ...tribuno militare..., buon..., ...(e) i resident i,
dopo la morte”.
Lettere ben incise con altezza decrescente verso il basso; interpunzione
assente; montante la prima I di militum.
È probabile che la F di r. 1 sia l’abbreviazione di f(ilio), e non di
[Ou]f(entina) [entrambe le possibilità in Gasperini], poichè la copia di Orsi
non r iporta alcun segno di frattura subito a sinistra della lettera; segue il
cognomen del personaggio onorato: Varro o Varronianus122; per Gasperini,
che esclude una lacuna a destra, non può che trattarsi di Varro. In r. 2 il
tribunato militare doveva far parte di un cursus più esteso. In r. 3, accanto
al testo tràdito (integrabile per es. con [civi] bono o con [viro] bono123), una
correzione di B in R darebbe come esito un [pat]rono centrato nella riga124.
In r. 4, pr ima di incol(a)e monottongato – rarissimo in ambito epigrafico125
– si può ipot izzare la menzione dei municipes126.
L’iscrizione, onoraria, celebrava post mortem un benefattore,
probabilmente di rango equestre; Gasperini non esclude che potesse
trattarsi anche di un personaggio di rango senatorio. La lastra doveva
essere visibile in un luogo pubblico, forse incassata nella base di una
statua127.
Datazione: II sec. d.C. su basi paleografiche128. 122 Per il primo: CIL X 8043, 87-88 da Ferentino; per il secondo: 6280, da Fundi. 123 Per la prima integrazione cfr. Suppl.It. 16, pp. 53-54 (con rimando errato a CIL X 7200 = ILS 5905,
dove non è presente alcun vir bonus); la seconda è proposta da GASPERINI 1965, p. 37. 124 Cfr. Suppl.It. 16, p. 54, dove - proprio sulla base di questa integrazione - si ipotizza che questo Varro
potesse essere un patronus della città. 125 GASPERINI 1965, p. 37, ritiene giustamente che il monottongo sia da associare a un usus linguistico
tardo imperiale (cfr. supra); resta il fatto che la forma incole - in iscrizioni - è quasi un unicum; trova
infatti un solo confronto in CIL III 352 (p. 1268) = CIL III 7000, che però appartiene a tutt’altro contesto
geografico (Orcistus, Asia). Sulla presenza degli incolae ad Alatri cfr. supra, iscr. nr. 3. 126 Così Suppl.It. 16, p. 54 e GASPERINI 1965, p. 36; ulteriore confronto possibile con un altro documento
sempre da Alatri (supra, iscr. nr. 3). 127 Cfr. Suppl.It. 16, p. 54 (con dettagliata bibliografia sul tema). 128 GASPERINI 1965, p. 37, data l’iscrizione con larghezza ai primi due secoli dell’impero; dello stesso
avviso DEVIJVER 1977, p. 887.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
58
12. Bibliografia: Suppl.It. 16, 1998, pp. 52-53, nr. 7 (con foto); AE 1998,
p. 119, nr. 301.
Frammento di lastra marmorea scabro in superficie, mancante su tutti i
lat i, lesionato e scheggiato in più punt i, r iut ilizzato sul retro forse come
stemma araldico 129. Dimensioni: 40 x 34 x 16 cm; alt. lett. 4,5-5,5 cm.
Rinvenuto in data imprecisabile a Monte Drago, nel territorio di Fumone, è
ora conservato nel municipio della stessa città. Autopsia 2010.
- - - - - -?
[- - -] [-c. 4-]
[- - -]miae
[- - -?] c(larissimae?) f(eminae?)
129 Così Suppl.It. 16, p. 52.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
59
[domin?]ae praest=
5 [anti]ssimae
[- - -] acto[r]
- - - - - -
4/5 praest/[anti]ssimae Suppl.It. 16, AE 1998.
“A ..., (donna illustrissima?), insigne [padrona?], il sovrintendente ...”.
Lettere con solco poco profondo e grosse apicature; alcune A presentano
le aste oblique congiunte in alto da un trattino; E con tratti orizzontali cort i
e uncinat i; interpunzione punt iforme regolare; grossa hedera cuoriforme in
r. 2.
I l MIAE di r. 2 è probabilmente la terminazione, al dat ivo, di un gent ilizio
quale Decumia130, Memmia, Postumia, Septimia131 o di un cognomen t ipo
Ammia, Artemia, Cosmia, Euphemia132. In r. 3, in luogo di un patronimico,
è preferibile leggere l’indicazione di appartenenza della dedicataria al
rango delle clarissimae. L’integrazione dominae in r. 4 è suffragata dalla
condizione servile del dedicante in r. 6 e dal registro chiaramente
subalterno del superlat ivo praest[anti]ssimae di r. 4/5.
La figura dell’actor, l’amministratore-sovrintendente preposto alla
gest ione dei latifundia delle famiglie ricche (ed eventualmente delle villae
ad essi annesse)133, ha pochissime attestazioni epigrafiche nell’Italia centro-
meridionale, dove predominava un’economia di t ipo pastorale134; proprio
per questa ragione non appare del tutto certa la pert inenza del frammento
all’agro alatrino. Forse questo schiavo aveva posto una dedica alla padrona
o a qualche divinità per la salute della stessa domina.
Datazione: tra la fine del II e il III sec. d.C. su basi paleografiche135.
130 Cfr. ad Alatri CIL X 5814. 131 Così Suppl.It. 16, p. 52. 132 Ibid. 133 Cfr. DE I, pp. 66 sgg., s. v. Actor. 134 Cfr. Suppl.It. 16, p. 53 (con dettagliata bibliografia a riguardo). 135 Ibid.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
60
13. Bibliografia: BROCCHETTI, ms., p. 114; CIL X 5802; P IERLEONI 1916,
p. 45; SACCHETTI SASSETTI 1947, p. 17; GASPERINI 1965, pp. 30-31, nr. 11;
Suppl.It. 16, 1998, p. 35, nr. 5802.
Iscrizione perduta, tramandata senza alcuna nota sulla forma e sulla
località di rinvenimento del monumento. Alle righe 2 e 3 interpunzione a
hederae distinguentes136.
[Magno e]t Invicto
[Imp(eratori) Caes(ari) M(arco)] Aurel(io) Anto=
[nino Pio F]elici Aug(usto)
[Arabico A]diabenic[o]
- - - - - -
“ [Al grande] e invitto [imperatore Cesare Marco] Aurelio Anto[nino, Pio,
F]elice, Augusto, [Arabico, A]diabenic[o], ...”.
Brocchett i, a differenza del CIL, r iporta il testo completo, con una
diversa suddivisione in righe e con l’appellat ivo Parthicus in luogo di
Arabicus137; dal confronto con CIL X 5803-5805 (vd. infra, iscr. nr. 14) e
con altre iscrizioni alatrensi r itenute false138, emerge però il sospetto che
Brocchett i o la sua fonte tramandino un documento parzialmente
136 Cfr. CIL X, cit., p. 566. 137 Questo il testo tramandato da Brocchetti: MAGNO ET INVICTO / IMP. CAES. M. AVRELIO
ANTONINO PIO / FELICI AVG. PARTHICO ADIABENICO / PONT. MAX. TRIB. POT. XIX / COS IV P.
P. / SENATVS P. Q. ALETRINAS. 138 In particolare tre: CIL X 731, 737 e 738. Cfr. anche, per la prima: TOTI, ms., p. 33, nr. 32, p. 67, nr. 31;
BROCCHETTI, ms., p. 117; GASPERINI 1965, p. 72, nr. 3*; Suppl.It. 16, p. 33, nr. 731*. Per la seconda:
TOTI, ms., p. 33, nr. 29, p. 66, nr. 28; GASPERINI 1965, p. 72, nr. 8*; Suppl.It. 16, p. 33, nr. 737*. Per la
terza: TOTI, ms., p. 33, nr. 30, p. 66, nr. 29; GASPERINI 1965, p. 73, nr. 9*; Suppl.It. 16, p. 33, nr. 738*. Si
ha notizia, inoltre, di una quarta iscrizione di natura imprecisabile tramandata da fonte manoscritta e della
quale non sono noti epoca e luogo di rinvenimento: cfr. TOTI, ms., p. 33, nr. 31, p. 67, nr. 30;
BROCCHETTI, ms., p. 114; Suppl.It. 16, p. 44, nr. 3*.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
61
interpolato. L’imperatore cui è rivolta la dedica è Caracalla 139: ne sono
sicura conferma gli attribut i Felix e Invictus, o ltre al cognomen ex virtute
Adiabenicus, entrat i in uso dopo Marco Aurelio, il primo con Commodo, gli
altri due con i Severi. Per l’integrazione dell’inizio si confront i CIL VI
1067; per la parte finale CIL VIII 1855 e 1857 (del 214 d.C.), le quali
fanno aggiungere alla t itolatura superstite i seguent i altri epitet i di
Caracalla: Parth( icus) max( imus), Brit(annicus) max( imus), Germ(anicus)
max(imus).
Datazione: dopo il febbraio 211 d.C. per la presenza di Adiabenicus; la
XIX potestà tribunizia – qualora effett ivamente tràdita dal testo originario
(cfr. nt. 137) – consent irebbe inoltre di restringere la datazione tra il 10
dicembre 215 e il 9 dicembre 216140.
14. Bibliografia: TOTI, ms., p. 33, nn. 28, 33; p. 67, nn. 32 (a-b-c), 34
(c); CIL X 5803-5805; DE RUGGIERO 1904, nr. 1358; P IERLEONI 1916, p. 45;
GASPERINI 1965, pp. 31-33, nn. 12-14 (con foto); Suppl.It 16, 1998, pp. 50-
52, nn. 6 a-c (con foto); AE 1998, pp. 118-119, nn. 300 a-c; GALLI 2002,
pp. 38-40, nr. 3, p. 92, fig. 3 (foto).
Grosso lastrone di calcare locale mancante in basso a destra (dove è
visibile una frattura ad angolo retto, a mo’ di taglio) e probabilmente a
sinistra, scheggiato in più part i, molto corroso in superficie e sbozzato sul
retro, fornito di incassi per grappe sui fianchi e in alto. Dimensioni: 97,5 x
110 x 17-18 cm; alt. lett. a: 9,5-12,5 cm; b: 5-7,7 cm; c: 6-6,5 cm. Non
sono not i epoca e luogo di rinvenimento; già conservato nell’archivio
notarile del Comune di Alatri, si trova attualmente nel locale Museo
Civico. Autopsia 2010.
139 Sacchetti Sassetti attribuisce erroneamente la titolatura a Marco Aurelio. 140 Così Suppl.It. 16, p. 35; GASPERINI 1965, p. 31: non anteriormente al 213-14 d.C.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
62
a) (in alto a destra):
[[Imp(eratori) Caesari]]
[[P(ublio) Licinio Gal]]=
[[lieno Pio Felic[i]]]
[[Aug(usto) imp(eratori) VIII]]
5 [[co(n)s(uli) III p(atri) p(atriae)]].
2/3 [[p. licinio gal/lieno fel]] CIL, De Ruggiero, Pierleoni; 4 [[[a]ug. f.]] CIL, De
Ruggiero, Pierleoni; 6 [[[s(enatus) p(opulus)q(ue) A(letrinas)]]] Gasperini.
“[[All’imperatore Cesare Publio Licinio Gallieno, Pio, Felice, Augusto,
imperatore per otto volte, console per tre volte, padre della patria]]”.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
63
b) (in alto a sinistra):
[Imp(eratori) Di]o cletiano
[Invicto] Aug(usto) et Imp (eratori) Ma =
[[[ximiano invicto Aug(usto)]]]
[devot]us numini
5 [mai]estati(que)
[eorum s(enatus) p(opulus)q(ue) A(letrinas)].
1 [Di]oclet iano CIL, Pierleoni; 2 AVG ET IMP MA/ CIL, Pierleoni; 4
omisit CIL, Pierleoni; 6 omisit CIL, Pierleoni.
“[All’Imperatore] Diocleziano, [invitto], Augusto e all’Imperatore
[Massimiano, invitto, Augusto], [il senato e il popolo di Alatri, devo]to al
nume e alla maestà [loro]”.
c) (in basso al centro):
Divo Maximiano
s(enatus) p(opulus)q(ue) A(letrinas).
1 Divo Maximian[o] CIL, De Ruggiero, Pierleoni; 2 S.P.Q.A. CIL.
“Al divo Massimiano, il senato e il popolo di Alatri”.
La lettura di queste tre dediche imperiali incise in tempi diversi risulta
piuttosto difficoltosa, sia perché la superficie scrittoria – a tratti erasa già
in ant ico – si presenta oggi ulteriormente consumata e diminuita in più
punt i, sia perché i test i sono in parte sovrappost i; è sicuramente per questa
ragione che nel ms. di Toti le epigrafi sono accostate confusamente come se
cost ituissero un unico testo. La trascr izione adottata è quella proposta da
Gasperini, che in genere conferma e talvolta modifica o integra quella di
Mommsen.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
64
L’iscrizione per l’imperatore Gallieno (a) [253-268 d.C.] – minoribus et
elegantioribus litteris scripta141 – è la più ant ica; forse era stata posta, al
pari delle altre, dal senato e dal popolo di Alatri, ed è pertanto probabile
che si chiudesse con la medesima formula S.P.Q.A. Si data, in base alla
titolatura142, al 257-259 d.C., prima della sconfitta e della cattura di suo
padre Valeriano nei pressi di Edessa per mano di Sapore I re di Persia (260
d.C.).
La dedica agli imperatori Diocleziano e Massimiano Erculio (iscr. b)
potrebbe collocarsi in un qualsiasi anno del regno dei due august i (286-305
d.C.), ma, se l’omissione dei cesar i Costanzo Cloro e Massimiano Galer io
non è casuale, più verosimilmente tra il 286 (nomina di Massimiano
Erculio) e il 293 (nomina dei cesari)143. Testi molto simili, con dediche ai
due august i insieme, si ritrovano in miliari della via Herculea, la strada che
percorreva le valli del beneventano 144.
I l testo più tardo (iscr. c), dedicato a Massimiano Erculio divinizzato145,
può essere interpretato come una dimostrazione di lealismo polit ico e forse
con valore di test imonianza ant icr ist iana146. L’iscrizione, posteriore alla
morte e alla consacrazione di quest’ult imo (310 d.C.), potrebbe essere stata
incisa o sotto Massenzio, che ridiede onore alla memoria del padre prima
che Costant ino ne decretasse la damnatio (311?), oppure sotto lo stesso
Costant ino, che intorno al 317 r iabilitò a sua volta la memoria del suocero
riconoscendolo nuovamente come Divus.
L’irremovibilità della lastra, incassata probabilmente nella base di
qualche monumento pubblico – forse di una tribuna – ha probabilmente
determinato la realizzazione di questo palinsesto epigrafico; la materia
piuttosto rozza, l’uso di una pietra locale e le sue dimensioni, del resto, si
141 CIL X, cit., p. 567. 142 Ricorre identica in ILS 532 e 540, CIL XI 3576, AE 1983, nr. 902, ecc. Sulla titolatura di Gallieno cfr.
KIENAST 1990, p. 216. 143 Così GALLI 2002, p. 40. 144 Cfr. CIL X 6969 e 6975. 145 Sulle titolature dei divi cfr. CHASTAGNOL 1984, pp. 275-287. 146 Così AZEVEDO 1978, p. 20.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
65
addicono meglio a una tribuna che a una base per statua o gruppo
equestre147.
Datazione: vd. supra.
15. Bibliografia: GASPERINI 1965, pp. 67-68, nr. 54; Suppl.It. 16, 1998, p.
70, nr. 30; AE 1998, p. 124, nr. 317.
Frammento di lastra in marmo bianco mancante su tutti i lat i fuorché
superiormente, dove – pur molto scheggiato – si conserva un tratto di
cornice modanata. Dimensioni: 14 x 17 x 6,5 cm; alt. lett. 5,5 cm. Non sono
not i epoca e luogo di rinvenimento; attualmente è murato a parete nel
vest ibolo del refettorio dell’Abbadia di S. Sebast iano ad Alatri. Autopsia
2010.
[- - -?] C(ai-) To[- - -]
- - - - - -
1 [- - -?]C. TO[- - -] Gasperini; [- - -?] C. TO[- - -] Suppl.It. 16, AE 1998.
Lettere con graffie alle estremità e divise da interpunzione; ampia
interlinea.
È molto probabile che la C, separata dal seguente TO da interpunzione,
sia l’abbreviazione del prenome Gaius e che vada pertanto seguita dal
147 Cfr. GASPERINI 1965, p. 33.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
66
gent ilizio To[mius?], To[ndius?], To[ssius?], ecc.148; nel qual caso,
trattandosi dell’inizio del testo, non bisogna segnare una lacuna prima della
C (Gasperini). Da scartare l’ipotesi secondo cui la stessa C appartenesse a
Maec( ia) - la tribù di Neapolis e Paestum - e che fosse seguita da un
cognome quale Toneianus, Torquat(i)us, Tossianus149.
Datazione: età imperiale, per paleografia e uso del marmo 150.
16. Bibliografia: SCACCIA SCARAFONI 1916, pp. 12 sg.; QUATTRO
CIOCCHI 1928, p. 108; GASPERINI 1965, p. 67, nr. 53; Suppl.It 16, 1998, p.
56, nr. 11; AE 1998, p. 121, nr. 305.
Grosso blocco frammentato di marmo bianco, adattato prima ad
acquasant iera nella chiesa inferiore dell’Abbadia di S. Sebast iano ad Alatri
e poi riadoperato nella fontana all’interno del chiostro. Di esso, come
dell’iscrizione scopertavi da Scaccia Scarafoni, non è data alcuna misura; si
sa invece che l’epigrafe, «quasi abrasa e mut ila alla periferia, è interrotta
anche nel centro da un lungo foro per il pernio che sorreggeva
l’acquasant iera sulla colonnina di sostegno»151. Attualmente irreperibile.
Scaccia Scarafoni: Suppl.It. 16:
- - - - - -?
IA [- - -]IA[- - -]
ITERNV [- - -]iternu[- - -]
ATI/////TIV [- - -]ATI[- - -]TIV[- - -]
- - - - - -?
148 Così GASPERINI 1965, p. 68. Altre integrazioni possibili: Toedius (cfr. CIL X 6278 Fundi), Tonneius
(cfr. CIL X 8043, 86 Ferentinum). 149 Dello stesso avviso Suppl.It. 16, p. 70. 150 Cfr. ibid. 151 GASPERINI 1965, p. 67.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
67
Scaccia Scarafoni r iteneva il blocco marmoreo pert inente a un edificio o
monumento di dimensioni notevoli. In r. 2 Gasperini propone di isolare
alcune sequenze (ter, iter) o di integrare [- - -semp] iternu[m - - -] o [- - -
Vel]iternu[s - - -]; una correzione in O della V permetterebbe di rest ituire
anche [- - - Vel]iterno[rum - - -]152. In r. 3, nella lacuna centrale prodotta
dal perno dell’acquasant iera, si potrebbe supplire l’etnico Ati[na]tiu[m - - -
], nel qual caso l’iscrizione ricorderebbe un personaggio legato in qualche
modo ad Atina; è probabile però che lo stesso personaggio fosse legato a
Velitrae o anche ad Alatri (patronus, curator?)153. L’integrazione con
sempiternum, invece, sarebbe riconducibile secondo Gasperini a un
contesto crist iano, pur trovando tale termine diverse attestazioni anche in
contest i diversi154.
Datazione: età imperiale non precisabile per la perdita del documento155.
17. Bibliogafia: MARINI, ms. a; TOTI, ms., p. 33, nr. 34, p. 67, nr. 33;
CIL X 5819; CLE 641; CHOLODNIAK 1904, pp. 91-92, nr. 262; PIERLEONI
1916, p. 47; LISSBERGER 1934, p. 72; LATTIMORE 1942, p. 94, nr. 59.
GASPERINI 1965, pp. 56-58, nr. 36; MARMORALE 1965, p. 97; Suppl.It. 16,
1998, p. 43, nr. 5819.
Rilievo in marmo bianco a forma di conchiglia, con – in alto a sinistra –
figura virile in abito consolare e – in alto a destra – figura muliebre;
attualmente irreperibile.
152 Cfr. Suppl. It. 16, p. 56. 153 Ibid. 154 In ambito cristiano cfr. ad es. ILCV 846 ...luctum sempiternum..., 2366 ...miserere mei in
sempiternum...; in ambito pagano cfr. invece i casi in cui il termine compare in associazione a gloria,
memoria, immortalitas ecc. (risp. AE 1961, nr. 191 = AE 1967, nr. 478 = AE 1973, nr. 525; AE 1934, nr.
172 = AE 1948, nr. 37; AE 1993, nr. 339a ecc.). 155 Suppl. It. 16, p. 56.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
68
Rupe cava Manes feci nunc coniugi Paulle
inque pari requie Viatorinus eli[g]o sedem
sed et Viatorino nepoti eorum qui vixit annis IIII.
1 Paule Brocchetti; Paulae Toti; Paull(a)e Cholodniak; Paulle Gasperini,
Suppl.It. 16; 2 [- - -] elico sedem Brocchetti; «interpretor quasi requiem
sede» Buecheler in CLE ; 3 sed et omisit in hiatu Marini ; Viatorino T. f.
nepot i Marini; post IIII addunt [- - -] consul[- - -] Toti, Brocchetti et
Marocco.
“Nell’antro ho appena dato sepoltura a (mia) moglie Paola
e io (stesso), Viatorino, in tale riposo mi scelgo dimora;
ma (appart iene) anche a Viatorino, loro nipote, vissuto 4 anni”.
Le prime due righe dell’epigrafe contengono ciascuna un esametro
datt ilico, il cui andamento – per quant ità sillabica – non appare del tutto
regolare. Il primo, che vorrebbe avere una struttura di t ipo - / - - / - - /
- - / - / - - , è caratterizzato dalla presenza dello pseudo-dattilo coniugi
in quinta sede, ricorrente, secondo Gasperini, solamente in altri due
carmina sepolcrali, uno da Subiaco e l’altro da Capua156. A spiegazione di
questo errore prosodico – data la grande frequenza dell’ablat ivo coniuge in
quinta sede in epitafi simili al nostro157 – è ipot izzabile un fenomeno
fonet ico ben altriment i attestato, ovvero la fusione, specialmente in fine di
parola sdrucciola, della /i/ lunga della desinenza dat ivale con la /e/ breve
dell’ablat ivo 158, ver ificatasi, secondo Gasperini, a part ire dal I-II sec. d.C.
anche nella lingua parlata dalle popolazioni della regione montana situata
156 Subiaco: Sancte Vitoriae Restutae coniugi Taurus (cfr. GASPERINI 1960b, pp. 109-113); Capua:
Amplifice ut dolui monumentum hoc coniugi dono (cfr. PANCIERA 1960, p. 35). 157 Cfr. CLE 317, 387, 452, 490, 493, 516, 719, 2193, ecc. Per la derivazione di simili clausole metriche
dalla poesia elegiaca latina vd. LISSBERGER 1934, p. 108. 158 Nel caso della nostra epigrafe, come conseguenza della con-fusione tra le vocali finali delle due
desinenze, è probabile che il lapicida (o l’antigrafo) scrivesse coniugi ma pronunciasse coniuge, e che
l’errore prosodico sia dovuto proprio a questo.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
69
tra l’alta valle dell’Aniene (Subiaco) e quella del Cosa (Alatri)159. Nel
secondo esametro, il cui andamento vorrebbe essere - / - / - / -
/ - / - Viatorinus richiederebbe la penult ima breve e
l’abbreviamento della seconda sillaba, oppure la sinizesi delle prime due:
trattasi dunque di una evidente forzatura del verso, a meno che non si
voglia considerare Viatorinus (= Viatorinum) eliso per sinalefe.
I l praenomen Paull(a)e presenta, oltre alla geminazione della L160, la
monottongazione del dittongo finale; il cognome Viatorinus, molto raro, è
attestato solamente in altre 5 occorrenze: due volte a Potaissa in Dacia e
una ad Aquincum (Budapest), Colonia e Roma161.
I l lessico del carme combina element i di derivazione letteraria e formule
del linguaggio epigrafico sepolcrale. Manes nella stessa sede metrica
ritorna in Properzio (2, 13, 32; 4, 7, 1), Ovidio (Fast. 2, 609 e 842),
Ausonio (183, 3), nonché in CLE 1057, 1269, 1329, 1468, 1497, ecc.;
mentre per la metonimia, linguist icamente notevole, di Manes = tumulus,
sepulcrum, il confronto più stringente si ravvisa in un verso dei Fasti di
Ovidio (2, 609)162. Inque in posizione iniziale r icorre ancora in Ovidio
(Fast. 2, 539; 5, 98; Her. 13, 102) e in CLE 1187; in...requie può
avvicinarsi a in pace di CLE 640; requie nella stessa sede si ritrova
nuovamente in Ovidio (Met. 10, 377; 13, 317) e in CLE 490, 2092. Per
159 Tale fenomeno è presente anche in molti dialetti centro-meridionali moderni, nei quali tutte le vocali
finali, tranne la /a/, si fondono nell’unica vocale indistinta /ə/ (cfr. DARDANO 2005, pp. 266-267); a tal
proposito GASPERINI 1965, p. 57, nt. 53, aggiunge: «Si pensi, per analogia, alla odierna pronunzia della i
finale [scil. /ə/, NdA] nel Viterbese e alle tante rime popolari ottenute in tal modo (gazzelle-coltelle,
terrazze-palazze, ecc.)». Relativamente alla lingua latina, il collasso del sistema delle desinenze e la
perdita della quantità vocalica sono fenomeni tipici del “volgare”, sulle cui innovazioni linguistiche
rispetto al latino classico vd. SERIANNI 1998, pp. 27 sgg. 160 La forma con consonante doppia (Paulla) è attestata in ca. 109 occorrenze; quella parallela con
consonante semplice (Paula) in ca. 191 (cfr. CLAUSS - SLABY, visionato da ultimo in data 18/11/2010). 161 Cfr. CIL III 919, 7688 = ILD 483 = AE 2007, 1194; AE 1934, 118 = AE 1944, 129 = AE 1955, 13;
CIL XIII 8274 = RSK 205 = ILS 2784 = SFGKoeln 12 = AE 1889, 65 = AE 1953, 273;
ICUR IX 24009. 162 Per lo stesso significato cfr. anche ThLL VIII, s.v. Manes. L’espressione Manes feci equivale alla ben
più frequente sepulcrum feci (GASPERINI 1965, p. 58).
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
70
sedem in clausola esametrica si confront i ancora una volta Ovidio (Met. 4,
433) e CLE 640. Anche la presenza del verbo alla prima persona e il nome
del dedicante sono riconducibili a formule abbastanza stereot ipate,
ricorrent i, ad es., nel sopracitato epitafio sublacense.
La terza riga dell’iscrizione è indubbiamente un’aggiunta posteriore fuori
metro163. Secondo Tot i e Brocchett i l’epigrafe doveva prolungarsi per altre
due righe e contenere, nell’ult ima, una tarda datazione consolare del t ipo
post consulatum o consulatu illius/illorum164, opinione, però, ritenuta
erronea da Mommsen165.
Datazione: sulla base di alcune part icolarità linguist iche (Paulle per
Paulae, coniugi per coniuge), l’epigrafe potrebbe collocarsi in epoca tardo
imperiale, difficilmente precisabile, però, per la perdita del documento166.
18. Bibliografia: GASPERINI 1960, p. 221, nr. 24; GASPERINI 1965, p. 69,
nr. 57; Suppl.It. 16, 1998, pp. 79-80, nr. 46.
Due framment i (a, b) probabilmente appartenent i ad un’unica grossa
lastra di calcare locale, entrambi mancant i su tutt i i lat i. Alt. lett. 5,5 cm
(Gasperini). Non sono not i epoca e luogo di rinvenimento; rimpiegat i
dapprima nella gradinata del vicolo di S. Giusta ad Alatri – dove li vide
Gasperini – sono attualmente irreperibili.
a:
- - - - - -?
[- - -]O[- - -]
[- - -]v it [- - -?]
163 Tutti gli studiosi concordano su questo punto: cfr. ad es. Büecheler in CLE, cit. (in apparato). 164 Cfr. CIL X, cit., p. 571 (in apparato), a proposito di un’analoga proposta di integrazione formulata da
Marocco. 165 Cfr. ibid. 166 Sulla datazione dell’epigrafe nessuno esprime pareri, nemmeno approssimativi: cfr. ad es.
COLAFRANCESCO -MASSARO 1986, p. 709.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Catalogo delle iscrizioni _____________________________________________________________________________________
71
- - - - - -
b:
- - - - - -
[- - -]ORIO [- - -?]
- - - - - -?
2(a) [- - -]V it Gasperini; 1(b) ORIO[- - -] Gasperini; [- - -?] ORIO[- - -]
Suppl.It. 16.
Lettere regolar i e ben curate; segno d’interpunzione triangoliforme dopo
la O del framm. a (Gasperini).
Essendo i due frammenti dello stesso materiale e riut ilizzat i nello stesso
luogo, Gasper ini ne ipot izzava una ricongiunzione, accolta negli studi
successivi (Suppl.It. 16) e qui riproposta. È probabile che il VIT del framm.
a sia la terminazione di un perfetto come curavit (Gasperini), militavit o
del presente vivit167; non è da escludere, in alternat iva, che possa
ricongiungersi con l’ORIO del framm. b, dando come esito il gent ilizio
dat ivale-ablat ivale Vitorio; in tal caso l’iscr izione potrebbe ricordare un
personaggio legato a Roma – dove la gens Vitoria trova il maggior numero
di attestazioni168 – o anche ad Aquinum169.
Datazione imprecisabile per la perdita del documento.
167 Così Suppl.It. 16, p. 80; su vivit cfr. CIL X 5812. 168 Sulle occorrenze di questo gentilizio cfr. CLAUSS – SLABY, visionato da ultimo in data 9/11/2010. 169 Cfr. AE 1978, nr. 106.
Studi epigrafici su Aletrium antica – Concordanze e indici _____________________________________________________________________________________
72
TABELLE DI CONGUAGLIO CON LE EDIZIONI PIÙ FREQUENTEMENTE CITATE NEL TESTO
Nr. Iscr.
CIL X ILS Eph. Epigr. VIII
DE RUGGIERO
1904
CIL I² GASPERINI 1960
1 5807 5348 2004 1529 2 3105 3 5808 6267 2005 4 5809 2006 5 6 5818 14 7 17 8 11 9 10 12 11 621 12 13 5802 14 5803-5 1358 15 16 17 5819 18 24
Nr. Iscr.
ILLRP GASPERINI 1965
Suppl.It. 16 AE 1998 GALLI 2002
1 528 1 5807 4 2 189 2 3 297 3 15 5808 4 19 5809 7 5 45 10 304 6 10 5 299 7 48 45 8 21 9 303 9 4 298
10 58 24 11 18 8 302 12 7 301 13 11 5802 14 12-14 6 300 3 15 54 30 317 16 53 11 305 17 36 5819 18 57 46
Studi epigrafici su Aletrium antica – Concordanze e indici _____________________________________________________________________________________
73
INDICI EPIGRAFICI
1) Nomi C(ai-) To[- - -] 15
C(aius) Iulius Augusti l(ibertus) Helenus 3
Calphurnius L(uci) f(ilius) 9
L(ucius) Betilienus L(uci) f(ilius) Vaarus (= Varus) 1
M(arcus), C(aius) Betilienei (= Betilieni) M(arci?) [f(ilii)?] 2
Paulla (= Paula) 17
Q(uintus) Minucius Q(uinti) l(ibertus) Anteros 4
[- - -] f(ilius?) Varro (?) 11
Viatorinus 17
Viatorinus (nipote del precedente) 17
2) Imperatori e loro titoli
Divus Maximianus 14c
Comm(odus) Aug(ustus) 10
[[Imp(erator) Caesar P(ublius) Licinius Gallienus Pius Felix Aug(ustus) imp(erator)
VIII co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae)]] 14a
[Imp(erator) Di]ocletianus [Invictus] Aug(ustus) et Imp(erator) Ma[[[ximianus Invictus
Aug(ustus)]]] 14b
[Magnus e]t Invictus [Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aurel(ius) Antoninus Pius F]elix
Aug(ustus) [Arabicus A]diabenic[us] 13
[- - - T]raianus [- - - Da]cicus [- - - pont(ifex) max(imus) t]rib(unicia) [pot(estate) - - -]
6
Studi epigrafici su Aletrium antica – Concordanze e indici _____________________________________________________________________________________
74
3) Datazioni consolari; giorni del mese; ricorrenze
K(alend-) Oct(obr-) 8
Marcus Ceionius Civica Barbarus, Marcus Metilius Aquillius Regulus Nepos Volusius
Torquatus Fronto consules (157 d.C) 8
natalis (scil. dies) 4
VI [k(alendas)?] Febr(uarias?) 4
4) Divinità e sacerdozi municipali
Manes 17
Nimphae (= Nymphae) 9
Iuppiter (pecunia Iovis) 2
seviri 3
seviri Augustales 4
5) Istituzioni civiche
censor 1
decur(iones) municipii Aletrinat(ium) 3
municipes et incolae 3
senatus (due occorrenze) 1
[s(enatus)] 14b
s(enatus) 14c
6) Riferimenti geografici; etnici
Aletrinates 3, 4, 5?
Aletrinas 14b-c
Studi epigrafici su Aletrium antica – Concordanze e indici _____________________________________________________________________________________
75
aqua 1, 9
arbor 9
arx 1
basilica 1
campus 1
fistulae 1
fornices 1
horologium 1
lacus ad portam 1
lacus balinearius 1
macelum (= macellum) 1
oppidum 1
porta 1
porticus 1
rupis 17
seedes (= sedes) 1
semitae 1
statua 1
7) Misure e somme
((denarii)) II 8
((denarii)) V 8
((denarius)) sin[g(ulus)] 8
((sestertium decem milia)) 4
pedes CCCXL 1
Studi epigrafici su Aletrium antica – Concordanze e indici _____________________________________________________________________________________
76
8) Sigle e formule notevoli
C.F. = clarissima femina 12
S.P.Q.A. = senatus populusque Aletrinas 14b-c
9) Arcaismi; particolarità linguistiche e incisorie
arduom (= ardum) 1
Betilienei (= Betilieni) 2
bis (aggiunta epigrafica) 1
Calphurnius (= Calpurnius) 9
coiravit (= curavit) 1
eitur (= itur) 1
ese (= esse) 1
infera (= infra) 1
iousit (= iussit) 1
macelum (= macellum) 1
mereta (= merita) 1
omnis (= omnes) 1
opidum (= oppidum) 1
OSTAIORTE (= post mortem) 11
Paulle (= Paulae) 17
quod annis (= quotannis) 4
quoius (= cuius) 4
sed et Viatorino nepoti eorum qui vixit annis IIII (aggiunta epigrafica) 17
seedes (= sedes) 1
senatu (= senatus, gen.) 1
Studi epigrafici su Aletrium antica – Concordanze e indici _____________________________________________________________________________________
77
soledas (= solidas) 1
sont (= sunt) 1
ubei (= ubi) 1
Vaarus (= Varus) 1
10) Interpunzione
A cerchietti e quadratini: 2
A forma di X: 1
A triangolini: 4, 8
Hederae distinguentes: 12, 13
Puntiforme: 12, 15
78
BIBLIOGRAFIA
Nel citare gli autori antichi sono state utilizzate le convenzioni adottate nel Thesaurus
Linguae Latinae. Tranne che in pochi casi, le abbreviazioni per le raccolte epigrafiche
sono le stesse del database di Clauss – Slaby (vd. sitografia). Nelle note gli articoli sono
stati citati attraverso il criterio nome dell’autore + anno di pubblicazione; l’unica
eccezione è costituita dal periodico Notizie degli Scavi di antichità, citato in nota con
l’abbreviazione Not. Sc.
1) Principali corpora epigrafici (e simili):
AE = L’Année épigraphique. Revue des publications épigraphiques relatives à
l’antiquité romaine. Paris 1888- .
CIL = Corpus Iscriptionum Latinarum, Berolini 1862- .
CLE = F. Bücheler, Carmina Latina epigraphica, I, Lipsiae 1895.
DE RUGGIERO 1904 = Sylloge epigraphica orbis Romani, I-II, Roma 1904.
Eph. Epigr. = Ephemeris epigraphica (Corporis inscriptionum Latinarum
Supplementum, edita iussu Instituti archaeologici Romani), Berolini 1872-1914.
ICUR = Inscriptiones christianae urbis Romae, Nova series, Roma 1922- .
ILCV = E. Diehl, Inscriptiones Latinae Christianae Veteres, Berlin 1925-1967.
ILLRP = A. Degrassi, Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae, I-II, Firenze
1957-1963. Editio altera aucta et emendata, Firenze 1965.
ILS = H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, Berolini 1892-1916.
Suppl.It. 16, 1998 = L. Galli – G. L. Gregori, Regio I. Latium et Campania.
Aletrium, in Supplementa Italica, n. s. 16, Roma 1998, pp. 13-90.
79
2) Raccolte epigrafiche minori, monografie, manoscritti, atti di convegni,
articoli di riviste, prosopografie, collane, lessici, biografie e pubblicazioni di altro
genere:
ABRAMENKO 1993 = A. Abramenko, Die munizipale Mittelschicht im
kaiserzeitlichen Italien. Zu einem neuen Verständis von Sevirat un Augustalität,
Frankfurt am Mein-Berlin-Bern-NewYork-Paris-Wien 1993.
AJOSSA, ms. = S. Ajossa, in Cod. Vat. Lat. 10593, f. 50 v.
ARNALDI 2006 = A. Arnaldi, La valenza ‘salutare’ del culto delle ‘Nymphae’
nell’Italia romana, in L. Gasperini (a cura di), Usus veneratioque fontium, Atti del
Convegno Internazionale di Studio su «Fruizione e Culto delle Acque Salutari in
Italia», (Roma-Viterbo 29-31 ottobre 1993), Tivoli 2006, pp. 55-83.
AZEVEDO 1978 = M. Cagiano de Azevedo, in AA. VV., Il Paleocristiano in
Ciociaria, Roma 1978, p. 20.
BLOCH 1968 = H. Bloch, I bolli laterizi e la storia edilizia romana, Roma 1968.
BODEI GIGLIONI 1977 = G. Bodei Giglioni, Pecunia fanatica. L’incidenza
economica dei templi laziali, in Rivista Storica Italiana, 89, 1, 1977, pp. 33-76.
BROCCHETTI, ms. = S. Brocchetti, Cronaca Alatrina, manoscritto datato 1871-1875
conservato presso la biblioteca privata di casa Molella ad Alatri (R. II, 1).
BRUUN 1975 = P. Bruun, in AA. VV., Studies in the Romanization of Etruria, Roma
1975, pp. 435- 505.
BUONOCORE 1992 = M. Buonocore, Epigrafia anfiteatrale dell’Occidente romano,
III. Regiones II – V, Sicilia, Sardinia et Corsica, Roma 1992.
CALABI LIMENTANI 1991 = I. Calabi Limentani, Epigrafia latina, IV ed., Milano
1991.
CARENA 1954 = C. Carena, Iscrizioni latine arcaiche, Firenze 1954.
CÉBEILLAC 1972 = Les “quaestores principis et candidati”aux I et II siécle de
l’Empire, Milan 1972.
CÉBEILLAC GERVASONI 1998 = M. Cébeillac Gervasoni, Les magistrats des cités
italiennes de la seconde guerre punique à Auguste: le Latium et la Campanie, Rome
1998.
CECCACCI CASALE 1902 = G. Ceccacci Casale, Leonardo Cardinal Petrassi de
Guarcino, Frosinone 1902.
80
CHASTAGNOL 1984 = A. Chastagnol, Un chapitre négligé de l’épigraphie latine: la
titulature des empereurs morts, in Revue des Etudes Latines, 62, 1984, pp. 275-287.
CHOLODNIAK 1904 = J. Cholodniak, Carmina Sepulcralia Latina Epigraphica,
Petropoli 1904.
COARELLI 1993 = F. Coarelli, Lazio, III ed., Roma-Bari 1993.
COLAFRANCESCO - MASSARO 1986 = P. Colafrancesco, M. Massaro, Concordanze
dei CLE, Bari 1986.
DAMSTÉ 1910 = P. H. Damsté, De telo quodam, in Mnemosyne, 38, 1910, p. 233.
DARDANO 2005 = M. Dardano, Nuovo manualetto di linguistica italiana, Bologna
2005.
DBI = Dizionario biografico degli italiani, Roma 1960- .
DE = E. De Ruggiero, Dizionario epigrafico di antichità romane, Roma 1895- .
DEGRASSI 1952 = A. Degrassi, I fasti consolari dell’Impero Romano, Roma 1952.
DEMOUGIN 1992 = S. Demougin, Prosopographie des chevaliers romains Julio-
Claudiens (43 a.C.-70 d. C.), (Collection de l’Ecole Française de Rome, 153), Rome
1992.
DEVIJVER 1977 = H. Devijver, Prosopographia militarium equestrium quae fuerunt
ab Augusto ad Gallienum, II, Leuven 1977.
DEVIJVER-VAN WONTERGHEM 1981 = H. Devijver – F. Van Wonterghem, Il campus
nell’impianto urbanistico delle città romane: testimonianze epigrafiche e resti
archeologici, in Acta Archaeologica Lovaniensia, 20, 1981, pp. 33-68.
DEVIJVER-VAN WONTERGHEM 1984 = H. Devijver – F. Van Wonterghem, Der
Campus der Römischen Städte in Italia und im Westen, in Zeitschrift für
Papyrologie und Epigraphik, 54, 1984, pp. 195-206.
DEVIJVER-VAN WONTERGHEM 1994 = H. Devijver – F. Van Wonterghem, in AA.
VV., L’Africa romana, X, Sassari 1994, pp. 10038-10039, nr. 1, p. 1057 e nt. 34.
DUNCAN JONES 1965 = R. Duncan Jones, An epigraphic survey of costs in Roman
Italy, in Papers of the British School at Rome, 33, 1965, pp. 188-306.
DUNCAN JONES 1982 = R. Duncan Jones, The economy of the Roman Empire.
Quantitative studies, II ed., Cambridge 1982.
DUTHOY 1978 = R. Duthoy, Les *Augustales, in Aufstieg und Niedergang der
Römischen Welt, II, 16, 2, Berlin-New York 1978, pp. 1254-1309.
FIORELLI 1884 = G. Fiorelli, Alatri, in Notizie degli Scavi di Antichità, 1884, p. 86.
81
FLORIDI 1971 = G. Floridi, Storia di Guarcino, Guarcino 1971.
Forma Urbis 2008 = Forma Urbis, Itinerari nascosti di Roma antica, Aletrium, 6,
2008, p. 7.
GAGLIARDI 2006 = L. Gagliardi, Mobilità e integrazione delle persone nei centri
cittadini romani - Aspetti giuridici - I - La classificazione degli incolae, Milano
2006.
GALLI 2002 = L. Galli, Le iscrizioni romane del Museo Civico di Alatri, in G.
Manchia (a cura di), Antichità Alatrensi, (Comune di Alatri - Assessorato alla
Cultura), Alatri 2002, pp. 31-104.
GASPERINI 1960 = L. Gasperini, Epigrafi inedite di Aletrium, in Archeologia
Classica, 12, 1960, pp. 212-221.
GASPERINI 1960b = L. Gasperini, in Giornale Italiano di Filologia, 13, 1960, pp.
109-113.
GASPERINI 1965 = L. Gasperini, Aletrium I – I documenti epigrafici (Quaderni
dell’Istituto di Storia ed Arte del Lazio Meridionale – Centro di Alatri – serie II, n.
I), Alatri 1965.
GERMONI 1987 = P. Germoni – E. De Minicis, Alatri: permanenze archeologiche e
continuità d’uso delle mura urbane, in Storia della Città, 43, 1987, pp. 5-42.
GÜNDEL 1953 = H. G. Gündel, Devotus numini maiestatique eius, in Epigraphica,
15, 1953, pp. 128-150.
HAYASHI 1989 = S. Hayashi, in Klio, 71, 1989, pp. 383-398.
ILAlg = Inscriptions latines d'Algérie, Paris 1922- .
ILD = C. C. Petolescu, Inscriptiones latinae Daciae, Bucarest 2005.
KIENAST 1990 = D. Kienast, Römische Kaisertabelle Grundzüge einer römischen
Kaiserchronologie, Damstad 1990.
LATTIMORE 1942 = R. Lattimore, Themes in Greek and Latin Epitaphs, Urbana
1942.
LAUM 1914 = B. Laum, Stiftungen in der griechischen und römischen Antike, I-II,
Berlin 1914.
LICORDARI 1982 = A. Licordari, Italia: Regio I (Latium), in Tituli, 5 (Epigrafia e
ordine senatorio, II. Atti del Colloquio AEIGL, Roma 14-20 maggio 1981), a cura di
S. Panciera, Roma 1982, pp. 9-57.
82
LISSBERGER 1934 = E. Lissberger, Das Fortleben der römischen Elegiker in den
Carmina Epigraphica, Tübingen 1934.
LONGO 1996 = P. Longo, Su alcune iscrizioni inedite conservate ad Alatri, in Terra
dei Volsci, Miscellanea 2, 1996, pp. 63-67.
MANACORDA 1994 = D. Manacorda, Produzione agricola, produzione ceramica e
proprietà della terra nella Calabria romana tra Repubblica e Impero, in Epigrafia
della produzione e della distribuzione. Actes de la VII Rencontre franco-italienne
sur l’epigraphie du monde romain (Collection de l’Ecole Française de Rome, 193),
Rome 1994, pp. 3-59.
MANGANARO 1989 = G. Manganaro, Iscrizioni latine nuove e vecchie della Sicilia,
in Epigraphica, 51, 1989, pp. 183-184.
MANSUELLI 1976/77 = G. A. Mansuelli, Su alcune testimonianze epigrafiche per lo
studio dell’architettura romana, in Rivista Storica dell’Antichità, 6-7, 1976/77, pp.
119-128.
MARINI, ms. a = G. Marini, in Cod. Vat. Lat. 9122, f. 25 r.
MARINI, ms. b = G. Marini, in Cod. Vat. Lat. 9127, f. 173 r.
MARMORALE 1965 = E. V. Marmorale, Pegasus Augus, in Giornale Italiano di
Filologia, 18, 1965, pp. 97-106.
MROZEK 1968 = S. Mrozek, Quelques remarques sur les inscriptions relatives aux
distributions privées de l'argent et de la nourriture dans les municipes italiens aux I,
II et IIIe siècle d.n., in Epigraphica, 30, 1968, pp. 156 sgg.
MROZEK 1972 = S. Mrozek, Les Bénéficiaires des distributions privées d'argent et
de nourriture dans les villes italiennes à l'époque du Haut-Empire, in Epigraphica,
34, 1972, pp. 36 sgg.
MROZEK 1984 = S. Mrozek, Quelques observations sur les incolae en Italie, in
Epigraphica, 46, 1984, pp. 17 sgg.
MROZEK 1987 = S. Mrozek, Les distributions d’argent et de nourriture dans les
villes italiennes de Haut-Empire romain (Collection Latomus, 198), Bruxelles 1987.
MROZEK 2004 = S. Mrozek, Sur la dedicatio, la consecratio et les dédicants dans
les inscriptions du Haut-Empire romain, in Epigraphica, 66, 2004, pp. 119-134.
Not. Sc. = Notizie degli Scavi di antichità, comunicate all’Accademia Nazionale dei
Lincei dal Ministero della Pubblica Istruzione, Roma 1876- .
83
PAIS 1884 = E. Pais, Corporis Inscriptionum Latinarum Supplementa Italica,
consilio et auctoritate Academiae regiae Lynceorum edita, Romae 1884.
PALAZZO 1992 = P. Palazzo, Nuovi rinvenimenti in località La Rosa, Brindisi, in
Taras, 12, 1, 1992, pp. 115-130.
PANCIERA 1960 = S. Panciera, Miscellanea storico-epigrafica I, in Epigraphica, 22,
1960, p. 35.
PANCIERA 1966 = S. Panciera, in Archeologia Classica, 18, 1966, pp. 60-61.
PANCIERA 1997 = S. Panciera, L’evergetismo civico nelle iscrizioni latine d’età
repubblicana, in Actes du X Congres International d’Epigraphie Grecque et Latine,
Nîmes 4-10 Octobre 1992, Paris 1997, pp. 262-284.
PIERLEONI 1916 = G. Pierleoni, Le antichità di Alatri, Alatri 1916.
PIR² = Prosopographia Imperii Romani, editio altera, Berolini-Lipsiae 1933- .
QUATTRO CIOCCHI 1928 = V. Quattro Ciocchi, Gli Ernici ed il loro territorio,
Veroli 1928.
ROSENBERG 1913 = A. Rosenberg, Der Staat der Alten Italiker, Berlin 1913.
RSK = Die Römischen Steininschriften aus Köln, Köln 1975.
SACCHETTI SASSETTI 1947 = A. Sacchetti Sassetti, Storia di Alatri, Frosinone 1947.
SACCHETTI SASSETTI 1957 = A. Sacchetti Sassetti, L’iscrizione aletrinate di L.
Betilieno Varo, (Quaderni dell’Istituto di Storia ed Arte del Lazio Meridionale –
Centro di Alatri – serie I, n. 4), Alatri 1957.
SALOMIES 1996 = O. Salomies, Senatori oriundi del Lazio, in AA. VV., Studi
storico-epigrafici sul Lazio antico, a cura di H. Solin, Roma 1996, pp. 23-127.
SCACCIA SCARAFONI 1916 = C. Scaccia Scarafoni, Memorie storiche della Badia di
S. Sebastiano nel territorio alatrino, in Archivio della Regia Società Romana di
Storia Patria, 39, 1916, pp. 5-52.
SCHULZE 1904 = W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Berlin 1904
(rist. 1991).
SERIANNI 1998 = L. Serianni, Lezioni di grammatica storica italiana, Nuova
edizione, Roma 1998.
SFGKoeln = W. Schmitz, Die spätantiken und frühmittelalterlichen Grabinschriften
in Köln, in Kölner Jahrbuch, 28, 1995, pp. 643-776.
84
SOLIN 1991 = H. Solin, Sul consolidarsi del cognome nell’età repubblicana al di
fuori della classe sanatoria e dei liberti, in Actes du Colloque en mémoire de A.
Degrassi (Collection de l’Ecole Française de Rome, 143), Rome 1991, pp. 153-187.
SOLIN 2006 = H. Solin, La misteriosa dedica alle Ninfe da Guarcino, in L.
Gasperini (a cura di), Usus veneratioque fontium, Atti del Convegno Internazionale
di Studio su «Fruizione e Culto delle Acque Salutari in Italia», (Roma-Viterbo 29-
31 ottobre 1993), Tivoli 2006, pp. 355-362.
SOMMELLA 1988 = P. Sommella, L’Italia antica: l’urbanistica romana, Roma 1988.
STEVENSON, ms. = H. Stevenson, in Cod. Vat. Lat. 10587, ff. 79 r., 83 v., 84 r. e v.
SUOLAHTI 1963 = J. Suolahti, The Roman Censors. A Study on Social Structure,
Helsinki 1963.
Th.L.L. = Thesaurus Linguae Latinae, Lipsiae 1900- .
TOTI, ms. = C. Toti, Storia dell’antichissima ed illustre città di Alatri, capitale un
tempo degli Ernici, manoscritto senza data conservato presso la biblioteca privata di
casa Molella ad Alatri (R. II, 2).
VAN BUREN 1934 = A. W. Van Buren, L’iscrizione di Lucio Betilieno Varo ad
Alatri, in Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, 9, 1934,
pp. 137-144.
WARD PERKINS 1955 = J. B. Ward Perkins, The Aqueduct of Aspendos, in Papers of
the Brithish School at Rome, 13, 1955, pp. 115-123.
WARMINGTON 1953² = E. H. Warmington, Remains of Old Latin, London 1953².
WILMANNS 1873 = G. Wilmanns, Exempla Iscriptionum Latinarum, Berlin 1873.
WILSON 1980 = R. J. A. Wilson, in Miscellanea di Studi classici in onore di E.
Manni, VI, Roma 1980, pp. 2221-2230.
WINNEFELD 1889 = H. Winnefeld, in Mitt(h)eilungen des deutsches
archäologischen Instituts, Römische Abteilung, IV, 1889, pp. 143 sgg.
ZEVI 1976 = F. Zevi, Alatri, in Hellenismus in Mittelitalien (Kolloquium in
Göttingen vom 5 bis 9 juni 1974), Göttingen 1976, pp. 84-96.
3) Sitografia:
CLAUSS – SLABY = Epigraphik-Datenbank Clauss-Slaby:
http://www.manfredclauss.de/it/index.html (home page in italiano).
85
INDICE PARTE PRIMA: Introduzione 1.1) Etimologia del toponimo Aletrium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1
1.2) Cenni storici sulla città alla luce delle fonti letterarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2
1.3) Ordinamento amministrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4
1.4) Storia degli studi epigrafici su Aletrium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6
1.5) Premessa alla presente edizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8
PARTE SECONDA: Catalogo delle iscrizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 13 CONCORDANZE E INDICI Tabelle di conguaglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 72 Indici epigrafici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 73 BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 78