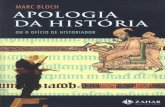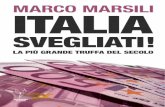Excerptum dalla più antica apologia araba cristiana
Transcript of Excerptum dalla più antica apologia araba cristiana
QUADERNI DI STUDI ARABI
NUOVA SERIE 9 2014
The Language(s) of Arabic Literature Un omaggio a Lidia Bettini
a cura di L. Casini, P. La Spisa, A.R. Suriano
QSA n.s. 9 (2014), pp. 33-56 © Istituto per l’Oriente C.A. Nallino, Roma
EXCERPTUM DALLA PIÙ ANTICA APOLOGIA ARABA CRISTIANA
PAOLO LA SPISA
(UNIVERSITÀ DI GENOVA)
���
Introduzione
Questo lavoro è l’esito più immediato di una riflessione che ha avuto inizio durante l’estate del 2012, quando cioè chi scrive ha collaborato strettamente con Lidia Bettini all’edizione del volume collettaneo dal titolo Au-de là de l’arabe standard. Moyen arabe et arabe mixte dans les sources médiévales, modernes et contemporaines.1
In questo contributo sarà offerta l’edizione di un capitolo della oramai celebre e adespota apologia arabo-cristiana di origine palestinese, già nota al pubblico italiano grazie alla traduzione di Maria Gallo.2 Il testo arabo fu edito per la prima volta da M.D. Gibson nel 1899 (G) con una traduzione inglese, dove il trattato di cui ci occuperemo si presenta col titolo Treatise of the Triune Nature of God.3 Per l’edizione del brano qui scelto tuttavia, mi sono avvalso dell’unico e più antico testimone ancora oggi conservato: il Sinaitico Arabo 154 (VIII sec. d.C.; d’ora in avanti S). È stato tuttavia ritenuto utile registrare in apparato le varianti più significative dell’editio princeps in rapporto a S, poiché alcune importanti omissioni o aggiunte di G rimangono ancora oggi inesplicabili. Va da sé che le problematiche qui succintamente accennate meritano un più approfondito studio che sia basato anzi tutto sull’edizione del testo integrale qui presentato solo in excerpta per ovvi motivi di spazio, nonché di un corpus di fonti manoscritte più ricco e culturalmente variegato.4 Caratteristiche codicologiche e paleografiche
S è un codice pergamenaceo le cui dimensioni sono 180 × 125 mm; contiene 20 righe per foglio. I ff. sono raggruppati in quaderni di 8 ff. ciascuno, numerati con lettere greche poste al piede del recto del primo f. e del verso dell’ultimo f. di ogni quaderno. Dall’analisi della copia microfilmata, è facile evincere che il codice
————— 1 Bettini – La Spisa (eds.), Au-delà de l’arabe standard, pp. VIII-XII. 2 Gallo (ed.), Omelia arabo-cristiana. 3 Gibson (ed.), An Arabic Version. 4 Si veda nella fattispecie Lentin, “Normes orthographiques en moyen arabe”, in cui si fa uso
di una metodologia comparativa tra numerose fonti di natura letteraria, culturale e religiosa assai eclettica.
34
è un compòsito che consta di due distinte unità codicologiche (S1, S2).5
D’altronde la stessa Gibson, che analizzò il codice in originale, non mancò di segnalarlo.6 L’ultimo quaderno di S1 ha il numero 16 (ιζ) corrispondente agli odierni ff. 94r-98v; il quaderno è però mutilo. Tuttavia Déroche ne ha individuato un frammento alla Nazionale di Parigi, che oggi costituisce la sesta unità codicologica del Parigino Arabo 6725 (P).7 Quest’ultimo è quindi anch’esso un compòsito dove l’unità di nostro interesse oggi si trova ai ff. 28r-35v, che qui chiameremo P6. Questo frammento contiene i capitoli 7, 37 – 9, 41 degli Atti degli Apostoli. Tuttavia va specificato che P6 non rappresenta la continuazione di S2 bensì è la parte immediatamente precedente S1.
8 Infatti la seconda metà del versetto At 9, 41 – la cui prima parte rappresenta il desinit di P6 – costituisce l’incipit di S1:
حيهودعا القديسين والارامل فدفعها اليهم وهي [Pietro] mandò a chiamare i santi e le vedove e la presentò loro viva.
Il punto della narrazione è esattamente il miracolo compiuto da Pietro quando resuscita la donna di Giaffa. Possiamo quindi affermare che l’unità codicologica che in origine conteneva gli Atti degli Apostoli e le sette Epistole Cattoliche, è oggi dispersa tra P6 e S1 e che S1 è la diretta continuazione di P6. In ultima analisi S1 contiene gli Atti degli Apostoli (9, 41 - 28, 31) [S1 ff. 1r-57r], le sette Epistole cattoliche [S1 ff. 57r-97r] e un dialogo tra un monaco e un laico che comincia ex abrupto [S1 ff. 97v-98r]. Al f. 99r ha inizio la numerazione di S2, come si evince dal numero 1 (α) in calce al primo foglio del primo quaderno. S2 contiene unicamente il Trattato sull’Apologia della fede cristiana che è anch’esso mutilo.
La caratteristica codicologica della composizione di S in due distinte unità codicologiche (S1 + S2), pur essendo di fondamentale importanza ai fini della
————— 5 Per unità codicologica si intende un “Volume, parte di un volume o insieme di volumi la cui
esecuzione può essere considerata come un’operazione unica, realizzata nelle stesse condizioni di tecnica, di luogo e di tempo”: Maniaci, Terminologia del libro manoscritto, p. 76.
6 Gibson (ed.), An Arabic Version, p. VII. 7 Troupeau, Catalogue des manuscrits arabes, p. 107; Déroche offre una descrizione delle
principali caratteristiche codicologiche del frammento in Déroche, “Les manuscrits arabes datés”, pp. 354-355.
8 Samir in uno dei due articoli dedicati al Trattato scrive: “Today, our manuscript is incomplete. Some parts of it can be found elsewhere. An accurate research has to be made in order to reconstruct the complete manuscript, if possible. I have identified a part of it at the Bibliothèque Nationale of Paris: it is part of Arabic Ms no. 6725. I copied it, and I hope to be able to publish a reconstitution of some sections. Other parts of the manuscript are spread around the world. Even so, our Apology is incomplete”: Samir, “The Earliest Arab Apology for Christianity”, p. 59; tuttavia senza un’accurata descrizione dei contenuti testuali né di certe caratteristiche codicologiche, si potrebbe erroneamente evincere che il frammento parigino copiato da Samir contenga una parte del Trattato.
35
comprensione della storia della tradizione dei testi contenuti oggi in S, è stata tuttavia ignorata dagli studiosi che si sono occupati del Trattato di cui si darà esposizione più avanti. La ben visibile rigatura orizzontale dello specchio scrittorio infine, denota una cura nella mise ne page del testo, segno evidente che anche nei codici di ambiente monastico sud-palestinese il lavoro della copia non era lasciato all’improvvisazione ma aveva raggiunto una raffinata tecnica preparatoria ed esecutoria. Vergato in grafia cufi di area palestino-sinaitica, conserva la partico-larità, già segnalata da Samir, della qāf col punto sottoscritto, vale a dire allo stesso modo in cui la scrittura cosiddetta magrebina segnala la lettera fāʾ.9 In realtà, come è già stato dimostrato, questa caratteristica paleografica non è un caso isolato, non solo all’interno degli scriptoria monastici palestinesi, ma più in generale nei manoscritti e papiri risalenti all’VIII-IX secolo.10 Attribuzione e datazione
Si tratta di uno dei più antichi manoscritti arabo-cristiani la cui datazione è stata oggetto di dibattito tra gli studiosi. Il testo di cui qui si edita solo il primo capitolo, è quello del Trattato [S2 ff. 99r-139v]; secondo Griffith, si tratta del più antico scritto apologetico sulla Trinità e Unicità divine, scritto in lingua araba ed esplicitamente rivolto ai musulmani.11 È fondamentale sottolineare che la diversità di contenuto testuale di S, corrisponde esattamente alla sua eterogeneità codicologica. Ovvero, mentre S1 contiene una selezione acefala del Nuovo Testamento, S2 attesta il Trattato apologetico. Questa caratteristica, come accennato precedentemente, è stata ignorata da studiosi come Griffith, Samir e Swanson che, considerando S un volume omogeneo e miscellaneo, sono arrivati a conclusioni che necessitano di essere riviste.
Una prima questione riguarda l’attribuzione della copia del Trattato (S2) al monaco Mūsā, come sostenuto da Swanson,12 grazie al colofone di f. 97r, dove si legge:
كملت رساله يهودا السليح وكتب الخاطي موسى الراهب الابركسيس والرسايل السبع ]يستجيب؟[الدى اعان ووالعز ] الجلال[ولله السبح و
È stata ultimata l’Epistola dell’Apostolo Giuda. Il monaco peccatore Mūsā ha scritto gli Atti e le sette Epistole, a Dio va lode, gloria e potenza, il quale assiste ed esaudisce.
Ora, come Gibson ebbe già modo di osservare,13 il colofone, trovandosi alla fine di S1, concerne esclusivamente la prima parte del manoscritto oggi compòsito,
————— 9 Cfr. Samir, “Une apologie arabe du christianisme d’époque umayyade?”, p. 88 e Samir,
“The Earliest Arab Apology for Christianity”, p. 60. 10 Cfr. Monferrer Sala, “Once Again on the Earliest Christian Arabic Apology”; Abbot,
Studies in Arabic Literary Papyri, p. 208; si veda anche il più recente Déroche – Sagaria Rossi, I manoscritti in caratteri arabi, p. 181 e nota 92.
11 Griffith, “The Gospel in Arabic”, p. 133. 12 Swanson, “Some Considerations”, p. 117 e nota 7.
36
ovvero quella relativa alla silloge del Nuovo Testamento. Dobbiamo concludere quindi che il monaco Mūsā è di per certo il copista degli Atti degli Apostoli e delle sette Epistole cattoliche ma non del Trattato. Quest’ultimo infatti doveva far parte di un altro codice oggi mutilo, di cui manca qualsiasi informazione su data, luogo e autore della copia. Questa situazione deve essere tenuta presente anche quando si voglia riflettere intorno alla funzione liturgica e apologetica delle più antiche traduzioni arabe del Nuovo Testamento, come ha fatto ad esempio Griffith.14 Secondo questo studioso infatti, le prime traduzioni della Bibbia prodotte in seno alla chiesa melchita palestinese, risponderebbero ad una doppia necessità: da una parte la veloce arabizzazione imponeva una traduzione del canone liturgico e quindi necessariamente anche della liturgia della parola, dall’altra tradurre brani scelti dall’Antico e Nuovo Testamento aveva un fine prettamente apologetico, dal momento che fin dagli inizi della polemica islamo-cristiana, gli ʾahl al-kitāb erano accusati di falsificazione delle proprie scritture rivelate (taḥrīf). La presenza di un trattato in difesa del dogma trinitario in coda ad una traduzione del Nuovo Testamento, avallerebbe questa ipotesi.15 Tuttavia è necessario a nostro avviso corroborare quanto afferma Griffith con un esaustivo e capillare esame codicologico dei manoscritti sinaitici da lui citati. La storia del libro manoscritto infatti è ricca di preziose informazioni sulle committenze e sulle precise funzioni culturali e religiose rivestite da ogni codice, che ogni filologo e storico della letteratura araba cristiana non può permettersi di ignorare.16 Il fatto che S oggi contenga sia una traduzione araba, benché parziale, del Nuovo Testamento, che un Trattato apologetico della fede cristiana, deve far riflettere non tanto sui principi in base ai quali tali testi furono scelti e copiati da un medesimo copista o scriptorium, quanto piuttosto sui criteri con cui si assemblavano quaderni appartenenti a codici diversi che erano già dispersi e smembrati.
Anche per quanto riguarda la datazione è necessario tenere conto della natura eterogenea di S. Le ipotesi sino ad oggi formulate dagli studiosi che si sono occupati del Trattato, debbono quindi rapportarsi esclusivamente a S2. Samir è stato il primo ad aver individuato una datazione relativa inserita nel testo del
————— 13 Cfr. Gibson (ed.), An Arabic Version, p. VI, dove si legge: “This distinctly proves the
Treatise to be a different MS. from all that precedes it”. 14 Griffith, inconsapevole della natura codicologica di S, scrive: “In addition to Arabic
versions of the Acts of the Apostles and Catholic Epistles, the scribe has included an anonymous treatise in defence of the doctrine of the Trinity”: Griffith, “The Gospel in Arabic”, p. 133. Questa possibilità non può essere esclusa a priori, tuttavia il fatto deve essere corroborato dalla documentazione che ad oggi resta ancora lacunosa.
15 Griffith, “The Gospel in Arabic”, pp. 128-131. Sul concetto di taḥrīf già in Qur. 2, 75. 16 Per i manoscritti citati da Griffith si veda sempre “The Gospel in Arabic”. Circa l’uso della
codicologia per la ricostruzione della storia dei fondi e della circolazione dei testi, si veda Déroche (ed.), Manuel de codicologie del manuscrits en écriture arabe, pp. 366-382.
37
Trattato, in cui si afferma che la religione cristiana “esiste da 746 anni”.17 Da questa datazione Samir ha formulato due ipotesi di datazione assoluta: una a partire dalla data dell’Incarnazione in uso presso la chiesa melchita, che farebbe datare la copia al 738, l’altra a partire dalla crocifissione, morte e Resurrezione di Cristo, da cui si evincerebbe una datazione più bassa (771).18 Tuttavia oggi sembra più plausibile la datazione proposta da Swanson, ovvero il 788 d.C. Swanson si sarebbe avvalso del calendario adottato nella chiesa melchita della Resurrezione a Gerusalemme, ovvero la data alessandrina di Annianos, che indica nel 25 Marzo del 5492 a.C. la data della creazione del mondo.19 Tuttavia è utile ribadire che queste ipotesi vanno riferite solo ed esclusivamente alla seconda unità codicologica (S2), per quanto riguarda la prima (S1), una data precisa è ancora oggi mancante. Un’altra questione che è stata sollevata da Samir riguarda l’originalità del Trattato, ovvero se si tratta di un autografo o di una copia eseguita su un modello ben più antico. Basandosi su un errore di lettura rinvenuto nel testo, Samir conclude per la seconda ipotesi.20 Se questa fosse vera, la data di composizione del Trattato si potrebbe realmente avvicinare alla metà dell’VIII secolo, ovvero all’epoca omayyade. Ma analizzando più da vicino l’errore “guida” individuato da Samir, sorge qualche dubbio sulla giustezza delle sue conclusioni. L’errore si troverebbe al f. 107v riga 19 dove si legge che non dà alcun senso. Gibson nella من عباده الشيطان) ؟(وفكر قابنا sua edizione emenda leggendo قلبنا من عبادة الشيطانوفطر ha separato il nostro cuore dall’adorazione di Satana; secondo Samir invece la genesi dell’errore si baserebbe sulla cattiva interpretazione e lettura dell’antigrafo da parte del copista di S. Secondo Samir nel modello utilizzato dal copista di S, nelle prime due parole del sintagma in questione, la lettera rāʾ sarebbe attaccata erroneamente alla kāf. La lezione originale dunque sarebbe ovvero: ha liberato le وفّك رقابنا من عبادة الشيطان nostre nuche dall’adorazione di Satana. Samir, riferendosi al copista di S, aggiunge: “En revanche, lui-même ne prolonge pas son K final sur la ligne et ne le colle pas à ce qui suit”.21 In effetti analizzando la copia del manoscritto a mia disposizione, ho potuto constatare che ogni kāf in posizione finale di parola termina con un uncino sporgente dall’asta posata sul rigo di scrittura, cosa che non si osserva nelle altre posizioni della medesima lettera. Come ammesso da Samir stesso, anche in questo punto sembra che si tratti di una kāf munita dell’uncino finale, a cui il copista ha, intenzionalmente o meno, attaccato la prima lettera della parola ————— 17 Cfr. S f. 110v., il testo del passo in questione è stato edito e tradotto più volte da Samir in
“Une apologie arabe”, p. 89-90, e in “The Earliest Arab Apology for Christianity (c. 750)”, pp. 61-62.
18 Cfr. Samir, “Une apologie arabe du christianisme d’époque umayyade?”, p. 89-91. 19 Swanson, “Some Considerations”, pp. 130 e 140. 20 “Cette petite erreur de lecture fait remonter notre copie d’une ou de plusieurs décades
probablement”, cfr. Samir, “Une apologie arabe du christianisme d’époque umayyade?”, p. 89. 21 Samir, “Une apologie arabe du christianisme d’époque umayyade?”, pp. 88-89.
38
successiva. È quindi possibile concludere che più che di errore di lettura, si tratti di un esempio di una prassi scrittoria assai diffusa nei testi antichi. È infatti noto che nei codici risalenti fino a tutto il IX secolo e oltre, la divisione sintattica tra le parole non era condizione cogente del lavoro di copiatura; si imponeva invece la necessità di guadagnare più spazio possibile all’interno dello specchio scrittorio.22 In ultima analisi da quanto detto, non è da escludere che il testo del Trattato sia un autografo. Contenuto e importanza del trattato
Come già suaccennato, l’opera di cui qui ci limitiamo a proporre un breve saggio, è la più antica testimonianza fino ad oggi nota della letteratura apologetica arabo-cristiana rivolta a interlocutori musulmani. Se adottassimo la data proposta da Swanson, S2 risalirebbe al 788 d.C., che è comunque una data molto alta per uno scritto originale della letteratura apologetica cristiana in lingua araba, inoltre sarebbe un’ulteriore prova della rapida arabizzazione della chiesa melchita di Palestina.23 Il testo qui edito corrisponde al primo capitolo dell’intera apologia, ovvero alla parte riguardante la Trinità e l’Unità divine. Questa prima parte è stata ritenuta particolarmente interessante per l’ampio uso che l’autore ha fatto delle analogie trinitarie, che molto successo saranno destinate a riscuotere nella letteratura apologetica successiva.24 Samir negli anni novanta del secolo scorso ne dette già un primo saggio, tuttavia ho ritenuto utile rioffrirne qui alcuni stralci cercando di rispettare il più possibile quelle caratteristiche linguistiche non più individuabili nel testo edito da Samir. Si offrono qui di seguito i fenomeni linguistici più rilevanti appartenenti a quella congerie di registri chiamati medio arabo o arabo misto. Fonetica e ortografia
Prolungamento della vocale breve del prefisso del futuro sā- وسانبين :3,2 § Scripto plaena della particella restrittiva 4,3 § : لكن: ولاكن
Affievolimento e caduta della hamza:
————— 22 Déroche – Sagaria Rossi, I manoscritti in caratteri arabi, pp. 193-194. 23 Sulla Palestina come culla della letteratura araba cristiana già si espresse Guidi, “Le
traduzioni dei Vangeli in arabo e in etiopico”, p. 7; si veda anche lo studio più recente di Griffith, “The Church of Jerusalem and the ‘Melkites’”.
24 In ambiente melchita palestinese l’autore che fece scuola in questo tipo di analogie fu Giovanni Damasceno, La fede ortodossa I, 8, pp. 60-74. Per uno studio sul dogma trinitario nella letteratura araba cristiana si veda Haddad, La Trinité divine chez les théologiens arabes, per le analogie trinitarie soprattutto pp. 118-127.
39
hamza finale o caduta della hamza dopo vocale lunga o matres lectionis شي (§1,1); caduta della hamza mediana: (§1,4): نسلك “ti chiediamo”; § 3,5: من يسل يعطا ومن
يجديلتمس “A chi domanda gli sarà dato, chi cerca trova”.
Passaggio della hamza finale in wāw: § 3,7: .”In principio Dio creò il cielo e la terra“ بدوا خلق الله السما والارض
Alif mamdūda in luogo di alif maqṣūra تقوا :5,2 § in luogo di الله تبارك وتعالا :timor di Dio”; § 3,14“ = تقوى «Iddio benedetto ed eccelso»; § 6,6 : تنزله روح القدس من ربك رحمه وهدا “Lo ha rivelato lo Spirito di santità dal tuo Signore come misericordia e guida”.
Tāʾ marbūṭa in luogo di tāʾ mabsūṭa جبروه :5,13§ in luogo di جبروت
Affievolimento dell’enfasi dell’occlusiva dentale sonora § 1,9 تضرع in luogo di تدرع . È interessante osservare che questo stesso fenomeno è stato già rilevato da Blau basandosi sulla medesima fonte S2.
25
Scambio sīn / šīn § 1,10: in luogo di واسرح صدورنا . اشرح
Occlusione dell’interdentale sorda e sonora تمتال :3,12 § per دلكوك... وتعالا دكره :6-5 ,5 § ; تمثال ; § 5, 11: مند قط
Morfologia
Verbo all’indicativo incompiuto (muḍāriʿ marfūʿ) dopo la negazione lam : ولم يقول الله تبارك اسمه :6,1 § Sintassi
Uso di laysa come negazione verbale: وكلمته وروحه اله واحدولسنا نقول تلته الهة معاذ الله ولاكن نقول ان الله :3,16-17 § «Non diciamo tre dèi, Dio mi gardi!, ma diciamo che Dio, la sua Parola e il suo Spirito sono un solo Dio». § 4,3: اسما ثلثه ليس يفترق بعضهم من بعضولاكن شمس واحده فيها «...ma un unico sole, in cui vi sono tre nomi che non si disgiungono l’uno dall’altro». 26
————— 25 Blau, A Grammar of Christian Arabic, § 16.1. p. 108. 26 Si noti che qui laysa è accordato col verbo che segue, spesso tuttavia si presenta in forma
invariabile alla 3a persona maschile singolare in tutti i casi sintattici; cfr. Blau, A Grammar of Christian Arabic, § 204.1. p. 305.
40
Alcune osservazioni conclusive
Come si sarà potuto osservare, i fenomeni qui riportati sono stati già ampiamente descritti nella vasta letteratura specialistica dedicata ai registri linguistici dell’arabo misto o medio arabo, sia antico che moderno.27 Ciò che qui interessa particolarmente sottolineare è l’uso di questi registri in un testo arabo cristiano così antico. Una delle questioni che gli specialisti si sono posti è infatti quella che riguarda ad un tempo sia la storia del medio arabo che l’ambito sociolinguistico in cui esso è comparso. Recentemente den Heijer ha sottolineato la necessità di esaminare i dati linguistici in un’ottica comparativa tra contesti religiosi e sociolinguistici differenti, nel tentativo di sostenere la tesi secondo cui una “confessionalizzazione” dello studio del medio arabo sarebbe fuorviante, poiché impedirebbe di riconoscere quei fenomeni trasversali comuni a tutta la letteratura araba del periodo pre-moderno.28 Per una valutazione dei dati linguistici qui sommariamente riportati è necessario anzitutto tenere presente che i monasteri di Palestina erano caratterizzati, fin dal IV secolo, da una “fisionomia cosmopolita” a causa della presenza dei luoghi santi.29 Non solo quindi i monaci di Mar Saba e Mar Caritone provenivano da tutto il Levante, ma lo stesso si potrebbe affermare dei manoscritti stessi oggi conservati al monastero di Santa Caterina, almeno per il periodo compreso tra VIII e X secolo.30 Come ha giustamente sottolineato den Heijer, è quindi ambiguo e rischioso attribuire alla lingua dei manoscritti sinaitici la definizione di medio arabo sud palestinese, vista l’eterogenea provenienza dei codici.31 Altro dato inconfutabile è l’antichità di S e della copia del Trattato. La seconda metà dell’VIII secolo è un periodo particolarmente alto per una produzione originale di un trattato apologetico cristiano. Dal punto di vista della storia della lingua, siamo in un’epoca precedente all’attività di normalizzazione linguistica dei filologi iracheni. Potremmo quindi trarre le medesime conclusioni addotte da Samir Arbache, sostenendo che almeno fino al IX secolo è possibile pensare che questi
————— 27 Il testo di riferimento per lo studio della lingua dei mss. oggi conservati al monastero di
Santa Caterina in Egitto rimane il già citato Blau, A Grammar of Christian Arabic; per uno studio sulla lingua dei papiri si veda Hopkins, Studies in the grammar of early Arabic.; sul medio arabo dei testi di epoca moderna dell’area levantina rimane indispensabile lo studio di Lentin, Recherches sur l’histoire de la langue arabe au Proche-Orient à l’époque moderne. Per una bibliografia più esauriente degli studi sul medio arabo si vedano: Lentin, “Moyen arabe et variétés mixtes de l’arabe”; Lentin, “Supplément N° 1”; Lentin, “Supplement N° 2”.
28 den Heijer, “On language and religious identity”, pp. 66 e 80-81. 29 Perrone, “All’ombra dei Luoghi Santi”, p. 27. 30 Lafontaine-Dosogne, “Le monastère du Sinaï creuset de culture chrétienne”; Géhin, “La
bibliothèque de Sainte-Catherine du Sinaï”; sulle committenze e provenienze dei manoscritti e icone oggi conservati nel monastero di Santa Caterina, si veda tra gli altri Ševčenko, “Manuscript Production on Mount Sinai”.
31 den Heijer, “On language and religious identity”, p. 65.
41
fenomeni fossero comuni a tutti gli scriventi arabo, indipendentemente dalla loro confessione di appartenenza.32 Solo successivamente per ragioni di identità religiosa, il medio arabo avrebbe rivestito la funzione di lingua franca in seno alla comunità greco-ortodossa arabofona. Basti pensare all’opera di un Sulaymān al-Ġazzī,33 e, in epoca moderna, a quella di un Makarius Ibn al-Zaʿīm.34 Autori entrambi di testi di elevato livello teologico e culturale, scritti in un medio arabo che è difficile considerare il semplice frutto di lapsus calami di copisti insipienti. La stessa cosa non può essere sostenuta per la letteratura araba musulmana strictu sensu, ovvero per i commentari coranici, le opere di diritto e per la letteratura colta in genere, dove l’influenza della lingua sacra è troppo forte per poter far trapelare fenomeni di devianza dal registro alto della lingua. Tuttavia è bene precisare che per dirimere la questione è indispensabile condurre inchieste sistematiche e puntuali sulle fonti manoscritte.35 Un’ultima osservazione sulle edizioni dei testi. Come risaputo gli editori nel mondo arabo e occidentale hanno spesso la tendenza a correggere i testi per garantirne una migliore leggibilità e quindi una maggior diffusione. Per questo motivo purtroppo niente di ciò che è stato edito delle opere dei primi apologeti arabo cristiani ci può aiutare a sostenere l’ipotesi secondo cui i cristiani della prima età abbaside avrebbero scritto in arabo classico per mostrare ai loro detrattori musulmani di padroneggiare la ʿarabiyya. Il caso di ʿAmmār al-Baṣrī (prima metà del IX secolo) ad esempio è indicativo non solo perché l’editore che ne ha curato l’opera apologetica dichiara esplicitamente di aver corretto il testo dei “fautes grammaticales” ritenuti essere dovuti all’imperizia del copista,36 ma soprattutto perché l’unico manoscritto che ci ha trasmesso l’Apologia di al-Baṣrī è un codice copto-egiziano, risalente al XIII-XIV secolo.37 Un’analisi linguistica condotta sull’unico manoscritto pervenutoci, ci informerebbe quindi non tanto sull’arabo del IX secolo, quanto su quello in uso in Egitto durante l’età dell’oro della letteratura copto-araba.38
————— 32 Arbache, “Le texte du Sinaï arabe 72”, p. 19. 33 La Spisa, “L’oeuvre théologique de Sulaymān al-Ġazzī”; La Spisa (ed.), I trattati teologici di
Sulaymān al-Ġazzī. 34 Per un rapido esame delle opere di Makarius si veda Nasrallah, Histoire du mouvement
littéraire dans l’église melchite, vol. 4, pp. 87-205 e Kilpatrick, “Makāriyūs ibn al-Zaʿīm (ca. 1600 – 1672)”.
35 Bettini – La Spisa (eds.), Au-delà de l’arabe standard, p. X. A mia conoscenza un caso recente è rappresentato dallo studio linguistico che Bruno Halflants ha condotto sul manoscritto Istanbul, Atif Efendi n. 1681 del 1182; cfr. Halflants, “Considérations ecdotiques”, pp. 213-217.
36 Hayek (ed.), ʿAmmār al-Baṣrī, p. 49. 37 Hayek (ed.), ʿAmmār al-Baṣrī, p. 47. 38 Atiya, “Literature, Copto-Arabic”.
42
Edizione e traduzione
L’edizione che qui presentiamo è corredata di due apparati critici: la prima fascia contiene i testi paralleli e le citazioni; la seconda fascia contiene le varianti formali e sostanziali contenute in S e in G. Le parentesi quadre [ ] indicano un intervento dell’editore/traduttore: nel caso del testo edito racchiudono un emendamento per congettura di una lacuna, nel caso del testo tradotto racchiudono un’aggiunta tesa a chiarire meglio il senso dell’originale e a renderne più scorrevole la lettura in traduzione. Abbreviazioni usate in apparato e in nota bis = bis Lett. = alla lettera om. = omittit sup. lin. = supra lineam vac. = vacuum ABSTRACT
The MS. Sinai Arabic 154 is a codex in parchment dating back to the 8th century. This manuscript is divided into two sections: the first section contains an Arabic version of some parts of the New Testament; the second section contains what is still considered as the oldest apology of Christianity originally written in Arabic. This text was edited and translated by Gibson with the title The Triune Nature of God (Gibson 1899). After a codicological exam of the original codex, Gibson argued that both the sections that constitute the extant Sinai Arabic codex, originally belonged to two different manuscripts (Gibson 1899, VI). The present essay starts from these codicological considerations, in order to discuss some conclusions, which had been the outcome of previous studies mainly carried out on the Apology. Here is also proposed a critical edition of the Arabic text of the first paragraph of the Apology with its Italian translation.
BIBLIOGRAFIA Fonti
Gallo M. (ed.), Omelia arabo-cristiana dell’VIII secolo, Roma: Città Nuova, 1994. Gibson M. D. (ed.), An Arabic Version of the Acts of the Apostles and the Seven
Catholic Epistles from an Eighth or Ninth Century Ms. in the Convent of St. Catherine on Mount Sinai: with a Treatise of the Triune Nature of God. London: C. J. Clay and Sons, 1899.
43
Giovanni Damasceno, La fede ortodossa, V. Fazzo (ed.), Roma: Città Nuova, 1998. Hayek M. (ed.), ʿAmmār al-Baṣrī, Apologie et controverses, Beyrouth: Dar el-
Machreq, 1986. La Spisa P. (ed.), I trattati teologici di Sulaymān Ibn Ḥasan al-Ġazzī, Lovanii:
Peeters, 2013, 2 vols. Studi Abbot N., Studies in Arabic Literary Papyri: III Language and Literature, Chicago –
London: the University of Chicago Press, 1972. Arbache S., “Le texte du Sinaï arabe 72: éléments de morphologie verbale”, in J.
Lentin – J. Grand’Henry (eds.), Moyen arabe et variétés mixtes de l’arabe à travers l’histoire. Actes du Premier Colloque International (Louvain-la-Neuve, 10-14 mai 2004), Louvain-la-Neuve: Peeters, 2008, pp. 1-20.
Atiya A. S., “Literature, Copto-Arabic”, in Coptic Encyclopedia 5 (1991), pp. 1460a-1467b.
Bettini L. – La Spisa P. (eds.) Au-delà de l’arabe standard. Moyen arabe et arabe mixte dans les sources médié-
vales, modernes et contemporaines, Firenze: Dipartimento di Scienze dell’Anti-chità, Medioevo e Rinascimento e Linguistica – Univ. di Firenze, 2012.
Blau J., A Grammar of Christian Arabic, based mainly on South-Palestinian texts from the first millennium, Lovanii: Secrétariat du CorpusSCO, 1966-1967, 3 vols.
den Heijer J., “On language and religious identity: the case of Middle Arabic, with special reference to the Christian Arab communities in the medieval Middle East”, in G. Mejdell – L. Edzard (eds.), High vs. Low and Mixed Varieties. Status, Norms and Functions across Time and Languages, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2012, pp. 53-87.
Déroche F., “Les manuscrits arabes datés du IIIe/IXe siècle”, Revue des Études Islamiques (REI), 55-57 (1987-1989), pp. 343-348.
— (ed.), Manuel de codicologie des manuscrits en écriture arabe, Paris: Bibliothèque nationale de France, 2000.
Déroche F. – Sagaria Rossi V., I manoscritti in caratteri arabi, Roma: Viella, 2012. Edwards M., “The First Council of Nicea”, in M. M. Mitchell – F. M. Young
(eds), The Cambridge History of Christianity. Origins to Constantine, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, vol. 1, pp. 552-567.
Géhin P., “La bibliothèque de Sainte-Catherine du Sinaï. Fonds anciens et nouvelles découvertes”, in D. Valbelle – C. Bonnet (eds.), Le Sinaï durant l’antiquité et le Moyen Âge. 4000 ans d’histoire pour un désert, Paris: Editions Errance, 1998, pp. 157-164.
Griffith S. H., “The Gospel in Arabic: An Inquiry into its Appearance in the First Abbasid Century”, Oriens Christianus, 69 (1980), pp. 126-167.
44
Griffith S. H., “The Church of Jerusalem and the ‘Melkites’: the making of an ‘Arab Orthodox’ Christian identity in the World of Islam (750-1050 CE)”, in O. Limor – G. G. Stroumsa (eds.), Christians and Christianity in the Holy Land: from the Origin to the Latin Kingdoms, Turnhout: Brepols, 2006, pp. 175-204.
Guidi I., “Le traduzioni dei Vangeli in arabo e in etiopico”, Atti della Reale Accademia dei Lincei. Anno cclxxxv: serie 4a Memorie della Classe di scienze morali, storiche e filologiche, Roma: R. Accademia dei Lincei, 1888, pp. 5-37.
Haddad R., La Trinité divine chez les théologiens arabes (750-1050), Paris: Beauchesne, 1985.
Halflants B., “Considérations ecdotiques et linguistiques à propos de quelques manuscrits de Rasā’il Ikhwān al-Ṣafā’”, in J. den Heijer – P. La Spisa – L. Tuerlinckx (eds.), Autour de la langue arabe. Études présentées à Jacques Grand’Henry à l’occasion de son 70e anniversaire, Louvain-la-Neuve: Université catholique de Louvain – Institut Orientaliste, 2012, pp. 207-218.
Hopkins S., Studies in the Grammar of Early Arabic. Based upon Papyri Datable to before 300 A.H./912 A.D., Oxford: Oxford University Press, 1984.
Kilpatrick, H., “Makāriyūs ibn al-Zaʿīm (ca. 1600 – 1672) and Būlus ibn al-Zaʿīm (1627 – 1669)”, in J. E. Lowry – D. J. Stewart (eds.), Essays in Arabic Literary Biography 1350 – 1850, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2009, pp. 262-272.
La Spisa P., “L’oeuvre théologique de Sulaymān al-Ġazzī: un autre exemple de moyen arabe standard?”, in L. Bettini – P. La Spisa (eds.), Au-delà de l’arabe standard, pp. 209-225.
Lafontaine-Dosogne J., “Le monastère du Sinaï creuset de culture chrétienne (Xe – XIIIe siècle)”, in K. Ciggaar – A. Davids – H. Teule (eds.), East and West in the Crusader States. Context-Contacts-Confrontations. Acta of the congress held at Hernen Castle in May 1993, Orientalia Lovaniensia Analecta 75 (1996), pp. 103-129.
Lentin J., Recherches sur l’histoire de la langue arabe au Proche-Orient à l’époque moderne, Thèse de doctorat d’État, Paris : Université de la Sorbonne Nouvelle III 1997.
—, “Moyen arabe et variétés mixtes de l’arabe : premier essai de bibliographie”, in J. Lentin – J. Grand’Henry (eds.), Moyen arabe et variétés mixtes de l’arabe à travers l’histoire. Actes du Premier Colloque International (Louvain-la-Neuve, 10-14 mai 2004), Louvain-la-Neuve: Peeters, 2008, pp. XXV-LXXXVII.
—, “Moyen arabe et variétés mixtes de l’arabe : premier essai de bibliographie. Supplément N° 1”, in L. Zack – A. Schippers (eds.), Middle Arabic and Mixed Arabic. Diachrony and Synchrony, Boston – Leiden: Brill, 2012, pp. 27-49.
—, “Moyen arabe et variétés mixtes de l’arabe : premier essai de bibliographie. Supplément N° 2”, in Bettini L. – La Spisa P. (eds.), Au-delà de l’arabe standard. Moyen arabe et arabe mixte dans les sources médiévales, modernes et contemporaines, Quaderni di Semitistica 28, Firenze: Dipartimento di Scienze
45
dell’Antichità, Medioevo e Rinascimento e Linguistica – Univ. di Firenze, 2012, pp. XXV-XLV.
—, “Normes orthographiques en moyen arabe: sur la notion du vocalisme bref”, in L. Zack – A. Schippers (eds.), Middle Arabic and Mixed Arabic. Diachrony and Synchrony, Boston – Leiden: Brill, 2012, pp. 209-234.
Maniaci M., Terminologia del libro manoscritto, Roma: Istituto centrale per la patologia del libro, 1996.
Monferrer Sala J. P., “Once Again on the Earliest Christian Arabic Apology: Remarks on a Palaeographic Singularity”, Journal of Near Eastern Studies, 69 (2010), pp. 195-197.
Nasrallah J., Histoire du mouvement littéraire dans l’église melchite du Ve au XXe siècle. Contribution à l’étude de la littérature arabe chrétienne. Époque ottomane 1516-1900, Louvain – Paris: Peeters – chez l’Auteur, 1989, 4 vols.
Perrone L., “All’ombra dei Luoghi Santi: il monachesimo di Palestina in epoca bizantina e l’esperienza di Gaza”. Il deserto di Gaza: Barsanufio, Giovanni e Doroteo. Atti dell’XI Convegno internazionale di spiritualità ortodossa. Sezione bizantina (Comunità di Bose, 14-16 settembre 2003), Mangano (Biella): Edizioni Qiqajon, 2004, pp. 23-50.
Samir Kh., “Une apologie arabe du christianisme d’époque umayyade?”, Parole de l’Orient, 16 (1990-1991), pp. 85-106.
—, “The Earliest Arab Apology for Christianity (c. 750)”, in Kh. Samir – J. Nielsen (eds.), Christian Arabic Apologetics during the Abbasid Period 750-1258, Leiden – Boston – New York: Brill, 1994, pp. 57-114.
Ševčenko P., “Manuscript Production on Mount Sinai from the Tenth to the Thirteen Century”, in Sh. E. J. Gerstel – R. S. Nelson (eds.), Approaching the Holy Mountain. Art and Liturgy at St. Catherine’s Monastery in the Sinai, Turnhout: Brepols, 2010, pp. 233-258.
Simonetti M., La crisi ariana del IV secolo, Roma: Istituto Patristico Augustinianum, 1975.
Swanson M., “Some Considerations for the dating of Fī taṯlīṯ Allāh al-wāḥid (Sin. Ar. 154) and al-Ǧāmiʿ wuǧūh al-īmān (London, British Library or. 4950)”, Parole de l’Orient, 18 (1993), pp. 115-141.
Troupeau G., Catalogue des manuscrits arabes. Ière partie: manuscrits chrétiens, Paris: Bibliothèque Nationale, 1974, vol. 2.
46
ه وا س ا ب وا وروح ا /S 99r/ ا
ن ي : و اب ا ا ق وا 1 ا ي . ا . وا ه و وارث ي . ا . وا ي ا ا . ا . و ا و . ف ان ر و ا . ا ا ا . ا و ا و و ك رو و : ش ا و ا ا ا ا ر : و : و ا د : [ ه [و ع ا ا رب : وا ك و دور ا ا ا ح ا وا ا و وا : ا اك : ا ا : وا س ا و ا رك ا ا ا
. . و رض /S 99v/ و ورو وات وا 2 و ا ا اس. ا ا . ا ا وح وا ا و ر ا ا ا وس . ون و . ر ن و ا ون وا . ا رض وا وات ا ا ي ا ب ا ا وس. وس ه ن و ورو : ا س ان ا . ا ب وا ن و. وا ا . ر وا ورو وا ورب وا
ك 1,7 …د ه [ al-Ġazzī T3 §1a, 1-2.
| vac. G [و 1,5 ت [ا | G ا om. G [و G ا [ا 6 ر 7 ر [ G 8 ع رع [و ح S 9 و ح [وا S G وا
47
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un solo Dio. 1 O mio Dio, grazie alla tua misericordia abbiamo raggiunto ciò che è probo e
giusto. Lode a Dio prima del quale nulla esiste, egli è prima di ogni cosa, dopo di lui nulla esiste. Lui è l’erede di ogni cosa, a lui è destinata ogni cosa, lui che con la sua scienza ha custodito la scienza di ogni cosa, ciò è consentito solo alla sua opera. Tutto conduce alla sua scienza, con la sua scienza tutto include. Ti domandiamo o Dio nostro per la tua misericordia e potenza, di renderci tra coloro che conoscono la tua verità, seguono la tua benevolenza, evitano il tuo sdegno, rendono lode con i tuoi nomi più belli1 e parlano con i tuoi esempi più elevati. Tu sei il compassionevole, il misericordioso, il clemente; sul trono ti sei assiso, sulle creature ti sei innalzato, ogni cosa hai riempito.2 Tu eleggi e [niente] è preferibile a te, giudichi e non sei giudicato, puoi fare a meno di noi, ma noi abbiamo bisogno di te. Sei vicino a colui che a te si è avvicinato, rispondi a colui che t’invoca e ti supplica. O Dio, tu sei Signore di tutto, Dio di tutto, creatore di tutto. Apri le nostre bocche, sciogli le nostre lingue, ammorbidisci i nostri cuori e apri i nostri animi alla lode del tuo nome nobile, elevato, magnifico, benedetto e santo. Non v’è dio prima di te né dio dopo di te, a te [tutto] ritorna, tu sei l’onnipotente.3
2 A te la lode, o Dio, creatore dei cieli e della terra e di ciò che è in essi,4 con la tua parola e il tuo spirito. A te la lode o Dio, tu che dimori nella luce, che sei il creatore degli angeli e dello spirito, affinché diano lode al tuo nome, il tuo santo nome, affiché annuncino il tuo nome e diano autorità alla tua potenza. Mentre loro non smettono di magnificarti e santificarti dicendo: «Santo, Santo, Santo, il Signore possente della cui nobiltà5 sono colmi i cieli e la terra». Per tre volte ti rendono lode e pongono il sigillo in un solo Signore, affinché gli uomini sappiano che gli angeli rendono lode a Dio, alla sua Parola e al suo Spirito, un solo Dio e un solo Signore. Te noi adoriamo, Signore nostro e Dio nostro, con la tua Parola e col tuo Spirito. Tu o Dio con la tua Parola hai creato i cieli e la terra e ciò che è in
1 Dall’uso di questa espressione è possibile evincere che il principale destinatario dell’apologia fosse un musulmano, c . Qur. 7: 180; 17: 110; 20: 8; 59: 2⒋
2 Dio che “riempie tutte le cose” è un’espressione che risale a Giovanni Damasceno, c . Giovanni Damasceno, La fede ortodossa, I, 8, p. 6⒈ Sul debito culturale e spirituale della letteratura araba cristiana delle origini per l’opera del Damasceno, si veda Samir, “Une apologie arabe du christianisme d’époque umayyade?”, p. 106 e La Spisa, “Fonti indirette e nuove fonti manoscritte”.
3 C . Qur. 16: 7⒎4 C . Qur. 25: 59; 32: ⒋5 In Gallo ــــة ــ ـــ ــ ,”è tradotto con “gloria”, mentre qui si preferisce tradurlo con “onore كرامــ
“dignità”, “nobiltà”; c . Gallo (ed.), Omelia arabo-cristiana, p. 5⒊ Con “gloria” qui si preferisce tradurre il termine جمد , si veda anche il “ti glorifichiamo” di § 2,⒏
48
ك ــ . ا د ا س ا وح و . و رض وا وات ا. ورب . ا وا س ا و ا ك. ا و ا و و. و ا و ورو ا ق ا ورو . . و وا وا
. ار وا ان ا و ورو ا . وا راه. وا ره ا ه و س ا ا 3 وا ا ا ه . ا ان د و . وا ورب . وال ا ره و ح ف ا و ر و و /S 100r/ ال ا و . و ا ه ا ون ا ون ا . اراه ا ا ا ب ا راس ا : و ون . ل : روح ا رض : وا ا ا وا . ر و ر ن ر ن ل : ر ن ر ن : ل : ه اج و د : و دا ه و رض ا ل ا : ا ج ل و . ن واب ع وا م وا ش وا رض ا اوا : ا . ا و ا : دا ذات ه اب ا ن و ا اول ل ا ن : رك و : . وان ا ان ا و ورو ا وا
. G 3,2 [و 2,9 | S و [1وا ح G 3 ا [ا ح [و S G وG و ,G 8 ] S ر [2ر | G ر [1ر 7
49
essi, e con lo Spirito Santo hai vivificato le schiere degli angeli. Noi ti lodiamo o Dio, ti esaltiamo e ti glorifichiamo con la tua Parola creatrice e col tuo Spirito Santo vivificante; un solo Dio, un solo Signore, un solo creatore. Non separiamo Dio dalla sua Parola e dal suo Spirito,6 né adoriamo insieme a Dio, alla sua Parola e al suo Spirito un altro dio.
3 Dio ha santificato il suo comandamento7 e la sua luce nella Torah, nei Profeti, nei Salmi e nel Vangelo, cioè che Dio, la sua Parola e il suo Spirito sono un solo Dio e un solo Signore. Lo spiegheremo, a Dio piacendo, in queste Scritture rivelate, a chi ha sete di conoscenza, comprende i fatti, conosce la verità e apre il suo cuore alla fede in Dio e alle sue Scritture. Come ha detto Cristo nel Vangelo: « Meditate le Scritture poiché in esse troverete la vita eterna ».8 Ha detto anche: « A chi chiede sarà dato, chi cerca trova, a chi bussa sarà aperto ».9 È anche scritto all’inizio della Torah che Dio rivelò a Mosè suo profeta sul monte Sinai: « In principio Dio creò il cielo e la terra »;10 poi disse: « Lo spirito di Dio era sulle acque »;11 poi disse con la sua parola: « Sia la luce e la luce fu »;12 poi disse: « Sia elevato e così fu, ed era il cielo del mondo ».13 Poi disse: « La terra faccia germogliare erba, verdure, alberi da utto e altre cose simili;14 la terra produca esseri animati come bestie feroci, armenti, fiere e rettili, e così fu ».15 Poi disse: « Escano dall’acqua ogni [sorta di] animale, ed ogni uccello che voli nel cielo secondo la sua categoria e genere, e così fu ».16 Quindi disse: « Creiamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza ».17 Così Dio nel primo libro che ha rivelato al suo profeta Mosè, ha manifestato che Dio, la sua Parola e il suo Spirito sono un solo
6 Qui si postula una velata condanna dell’eresia ariana. La dottrina di Ario prevedeva una gerarchizzazione all’interno dell’economia trinitaria, contro cui si espresse il primo concilio ecumenico di Nicea (325): c . Simonetti, La crisi ariana del IV secolo; Edwards, “The First Council of Nicea”.
7 In Gallo ـــره ــــ ـــ ــــ è tradotto con “il suo prestabilito disegno”; c امــــ . Gallo (ed.), Omelia arabo-cristiana, p. 5⒋
8 Gv 5, 3⒐9 Lc 11, ⒑10 Gen 1, ⒈11 Gen 1, ⒉12 Gen 1, ⒊13 C . Gen 1, ⒏ In Gallo ــع ــــ ـــ è tradotto con “firmamento” : «Sia il firmamento, e fu il رفيـ
firmamento…»: c . Gallo (ed.), Omelia arabo-cristiana, p. 5⒌14 Gen 1, ⒒15 Gen 1, 2⒋16 Gen 1, ⒛17 Gen 1, 2⒍
50
ا ان ل و ا ذ ا ل و : ورو . وا . و ورو /S 100v/ ا وا و وا
ج ا : وا ي ع ا 4 ود ا ا ا واس : و ل ا ق] ]. ن ا ا . و ا و ا ق ه ا وا. و ه ا ل ا و وا ي ا ر ا وان وا س و ا ل ا ق وح ا وا وال ه. ه و ا ع ا ه و . و ا ا ا واس و و ن ه : وان ه وا ات و . و ا ا ه اذا و ان ان د اق ه. ان ن ا و ا ي ا ا . وا و ه ل ا ن وان ن و وا ا ق. و روح /S 101r/ ا ه اذا ا واذا ا وا واوح ا وا ا و : : واي ا ن ا ف. و ا وا و او ق و وا ا س. ا ب وا وروح ا ن. ا ج ا وا ا ف س. رب وا ب وا وروح ا ن ا ا . ب ا ا وس ه. و ان ا . و ا ورو و ا ورو
.و ل م و ا و ا رك ا ان 5 و رك س ر ان ن ا ن وح. ه ا ا و ا وذ ن و ل : و
| G ا [ا 13 ذ ا ] om. G ج 4,1 ج [ G س 2 S G ا [اG و [ 3 | G اذ [اذا 8 G ا [ 9 ] sup. lin. S G ا [و 10 ف. om. G 13 [اذا…روح 11 ف [او ه G 5,2 و ة [وذ G | 1] bis. S G وز
51
Dio,18 e che Dio, benedetto ed eccelso, ha creato ogni cosa ed ha vivificato ogni cosa con la sua Parola e il suo Spirito. Non diciamo tre dèi – che Dio mi guardi! – bensì diciamo che Dio, la sua Parola e il suo Spirito sono un solo Dio e un solo creatore.19
4 Quanto detto è come il disco solare che è in cielo, i raggi che escono dal sole e il calore che emana dal sole. Non disgiungiamo20 l’uno dall’altro, non diciamo che sono tre soli, ma un unico sole, in cui vi sono tre nomi che non si disgiungono l’uno dall’altro. Come l’occhio, la pupilla dell’occhio e la luce che sta nell’occhio; non diciamo che sono tre occhi, ma un solo occhio in cui vi sono tre nomi. Come l’anima, il corpo e lo spirito non li disgiungiamo l’uno dall’altro, non diciamo che sono tre uomini, ma un solo uomo, tre nomi per una sola persona.21 Come la radice dell’albero, i suoi rami e i suoi utti, non diciamo che sono tre alberi, ma un albero solo, [poiché] una parte deriva dall’altra. Non appena appare e si manifesta agli uomini a suo tempo, sappiamo che tutto ciò sta nell’albero, sia quando appare che prima che appaia. Come la fonte d’acqua che sgorga dalla fonte da cui scorre un fiume; l’acqua del fiume si accumula e forma un lago, non puoi distinguere un’acqua dall’altra; sebbene i suoi nomi siano diversi, non diciamo tre acque ma un’acqua sola, per la fonte, il fiume e il lago; sia quando si riunisce che quando si separa. Come lo spirito dell’uomo, il suo intelletto e la parola che scaturisce dal suo intelletto, l’una procede dall’altro. Lo spirito è nell’intelletto e la parola ha origine dall’intelletto, l’uno deriva dall’altro. Noi non facciamo distinzione tra di essi, ognuno deriva dall’altro che sia esso manifesto o risaputo. Come la bocca, la lingua che si trova nella bocca e la parola che esce dalla lingua. Similmente quando parliamo del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo tramite il quale i profeti hanno profetizzato quando hanno detto: « La bocca del padre ha parlato ».22 Tutto questo è prova evidente della nostra fede nel Padre, Figlio e Spirito Santo, un solo Signore. Conosciamo Iddio grazie alla sua Parola e al suo Spirito; la Parola e lo Spirito di Dio glorifichiamo ed esaltiamo, così è necessario che gli uomini credano in lui.
5 Tuttavia è necessario che sappiamo che non comprendiamo niente di tutto ciò che riguarda Iddio e la sua magnificienza, né con i detti, né con gli esempi, né a
18 Gallo traduce: «Così, fin dall’inizio del Libro rivelato al suo profeta Mosè, Dio manifestò che…», c . Gallo (ed.), Omelia arabo-cristiana, p. 56; in nota 34 si legge: «Testo illeggibile, corretto da p. Samir».
19 Qui si riconosce chiaramente una risposta all’accusa di associazionismo politeista (širk), lanciata ai cristiani dalla tradizione apologetica musulmana in base a Qur. 4: 17⒈
20 Qui si postula una evidente lacuna emendata per congettura tramite il senso interno al testo.21 Lett. « per un volto solo ».22 C . Is 1, 20; 40, ⒌
52
ا. و ا ر ا ى ا : اه رك ا و د ن ا ر ان ا : ر ا : رك. و ى ر. ا ل او ا ر ا ا وا ان ا ا . ا ا ن ورو و /S 101v/ ا ا ا ان ل و ا : ذ س : ا ا و ا ان ل و ر ــ ا و ا : ا و ع ا ا و ب ارك ا دون . و ا ى و و ا ا : وروح. و ا ورو و ورو ا و وه ن ا ا و ن د : ل ان ا : و رك رك ا ا ان س ان و ا ا
. ا ورورك ل ا ن و : و راه ا ل ا ا 6 و ــ ا ان س ا ن ا ا ل و ن ا ا ا ان ا و ا . و ق ا ورو وا و ااول ادى ل ا اب ن وا ا اس س روح ا ا و : وا روح ا ل /S 102r/ ا ه و : ر ــ وا ــ وا راه. ا ر وا ه ا دا ا و ر ر ان ان ا و ورو ا وا ورب وا : و و ا وا : وا
3 ] G 4 ] G 5 ان ] om. G | ر. ر [او ا | G وا ى [اارك ل | G و [و om. G 11 [ا G 6 ا ل [ G 12 ا] om. G 6,1 ]
G
53
parole, ma solo con la fede, l’essere pii e timorati di Dio e la saggezza23 di Spirito. Se tra gli uomini vi fosse una speranza di comprendere qualcosa della magnificenza di Dio, allora si ricercherebbe la sua ombra che è impossibile comprendere. Chiunque pensi di conoscere perfettamente la potenza di Dio, allora ha già potuto misurare l’acqua del mare con il palmo [della mano].24 Invero Dio, benedetto sia il suo nome e altissima la sua menzione, è troppo glorioso e magnifico da poter essere compreso dagli intelletti e dagli ingegni! Egli è l’inconoscibile. Così è necessario a Dio l’altissimo e il nobile, alla sua Parola e al suo Spirito. Tutto ciò che appartiene a Dio è meraviglioso portento. Non diciamo che Dio ha generato la sua Parola come si genera presso gli esseri umani, che Iddio mi guardi! Piuttosto diciamo che Dio ha generato la sua Parola come il sole genera i raggi, l’intelletto genera la parola e il fuoco genera il calore. Di tutte queste cose non esisteva niente prima di ciò da cui sono state generate. Dio, benedetto il suo nome, non è mai stato senza Parola e Spirito, ma da sempre è con la sua Parola e il suo Spirito; la sua Parola e il suo Spirito erano presso Dio e in Dio prima che creasse le creature. Non dire: « Come è possibile ciò? », poiché tutto ciò che appartiene a Dio è magnificienza e potenza. Come nessun uomo può comprendere niente di ciò che riguarda Dio, così non può nemmeno comprendere la sua Parola e il suo Spirito.
6 Così Dio ha detto nella Torah: « Noi creiamo l’uomo a nostra somiglianza e fattura ». Dio, benedetto il suo nome, non ha detto: « Io ho creato l’uomo », ma ha detto: « Noi abbiamo creato l’uomo », affinché gli uomini sapessero che con la sua Parola e il suo Spirito ha creato ogni cosa e ha dato vita ad ogni cosa. Egli è il creatore e il sapiente. Lo troverete nel Corano: « Invero noi abbiamo creato l’uomo nella miseria »,25 « abbiamo aperto le porte del cielo con acqua torrenziale ».26 Ha detto : « Siete venuti a noi uno alla volta come vi abbiamo creato la prima volta ».27 Ha detto: «Credete in Dio e nella sua Parola».28 E poi circa lo Spirito Santo: «Ma lo Spirito Santo è disceso dal Signore come misericordia e guida».29 Cos’è più chiaro e luminoso di tutto ciò, dal momento che tu lo trovi nella Torah, nei profeti, nei Salmi e nel Vangelo, e voi trovate nel Corano che Iddio la sua Parola e
23 In Gallo (ed.), Omelia arabo-cristiana, p. 58: «purità».24 In Gallo: «ha già potuto pesare l’acqua dell’oceano nel cavo della sua mano»; l’espressione è
un calco da Is 40, 12 dove tuttavia si legge: «Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare» (trad. CEI La Bibbia di Gerusalemme, Bologna: Edizioni Dehoniane 2009).
25 Qur. 90: ⒋26 Qur. 54: ⒒27 C . Qur. 6: 9⒋28 Qur. 7: 15⒏29 Qur. 16: 10⒉
54
ان س ا ا ا : س ا وروح و ا ان ا . وا و ورو : و ا ورو : ا وا : ورب وا و واا . ى ود ا ا ان ا د اس ان ردن ا ا ب ا ا . و ا وروح : ا ه ا ي ا ا ا ا ل. و ا ب اس ان ا و ورو ا وا ورب وا ل ا و ا س ا
. و وا : ال ان ا . ذ ا ن دون ل ان ا او 7 و ا ا ا ن. ا م م ا : و م ا و م ل وا ود وا . ا ا و ا ر ا ا /S 102v/ و . ن ن. و ن ا ق و ر. وا. و داود ا ا و و ا ه ذا ا . د ار ا ا ا ب ا ا ا ت ا ل. وس ن ا وروح ا ب ا وا ه. ا ان ا او د و ا ا . وا ن و وا ه ا ود . ل
. س. ا وا ورب وا ب وا وروح ا ورو : ا
10 ] G 12 ا [ا S 7,1 ل ل [ S G 3 ] om. G
55
il suo Spirito sono un solo Dio e un solo Signore? Avete infatti ordinato30 di credere in Dio nella sua Parola e nello Spirito Santo; non ci biasimate allora, se crediamo in Dio, nella sua Parola e nel suo Spirito e adoriamo Dio nella sua Parola e nel suo Spirito, un solo Dio, un solo Signore, un solo creatore. Riguardo a questo argomento, Dio ha manifestato in tutte le Scritture la retta via e la vera credenza.31 Chi dissente non [si fonda] su niente.32 Nel Vangelo è scritto che allorché il Messia fu battezzato nel santo fiume Giordano, il Padre ne fu testimone dal cielo e disse: «Questo è il mio Figlio prediletto che ho desiderato, ascoltate[lo]!».33 Allora lo Spirito Santo discese dal cielo e si posò su di lui affinché la gente sapesse che Dio, la sua Parola e il suo Spirito sono un solo Dio e un solo Signore, sia per i primi [a cui fu rivelato] che per gli ultimi.
7 Non diciamo che Dio si sposta dal suo luogo o che da lui derivi qualcosa di imperfetto, Iddio mi guardi! Ma diciamo che Dio è tutto perfetto nel cielo, tutto perfetto in Cristo e tutto perfetto in ogni luogo. Non hai forse visto il sole che Dio ha creato come splendore e luce per gli abitanti di questo mondo? Invero esso è in cielo, nelle valli, sui monti, sulle colline e nei mari. Non si divide e non si sposta da un luogo ad un altro, ma si trova dove vuole e come vuole. La sua grandezza e signoria riempiono ogni cosa e niente è più glorioso di lui. Così ha profetizzato il profeta Davide sul battesimo di Cristo dicendo: «La voce del Signore è sopra l’acqua, Dio il lodato ha tuonato, Iddio è sulla copiosa acqua».34 Cos’è più evidente di questa profezia sul battesimo di Cristo? Invero il Padre ha testimoniato dal cielo, il Figlio era nell’acqua e lo Spirito Santo è disceso su di lui; tutto ciò è un solo Dio e un solo sovrano. Questa è la nostra fede e testimonianza in Dio, nella sua Parola e nel suo Spirito, che sono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, un solo Dio e un solo Signore.
30 In Gallo: «vi è stato ordinato».31 In Gallo: «In tutte le Scritture Dio ha dichiarato che ordina questo nella guida, nel giudizio,
nel vero», c . Gallo (ed.), Omelia arabo-cristiana, p. 6⒈32 C . Gallo (ed.), Omelia arabo-cristiana, p. 61 e nota 50: «Chi lo contraddice è
completamente nell’errore». Sebbene la traduzione possa rendere l’idea del senso del testo, qui si opta per una resa più letterale. Para asando, Dio ha manifestato il vero nelle sue Scritture rivelate, mentre chi lo contraddice non si basa su nessun tipo di rivelazione. È dunque possibile supporre, contrariamente a quanto ritiene Gallo, che il nostro autore a fini apologetici comprendesse tra le Scritture anche il Corano, qui evocato più volte a sostegno del proprio ragionamento.
33 C . Mt 3, ⒘34 C . Sal 29,⒊
QSA N.S. 9 (2014), pp. 351-352 © ISTITUTO PER L’ORIENTE C.A. NALLINO, ROMA
QUADERNI DI STUDI ARABI N.S. 9 (2014)
THE LANGUAGE(S) OF ARABIC LITERATURE UN OMAGGIO A LIDIA BETTINI
a cura di L. Casini, P. La Spisa, A.R. Suriano
Un omaggio a Lidia Bettini 3-10
Chamito-Semitic Studies
David COHEN, L’hypothèse d’une laryngale dans la morphogenèse du système verbal des langues chamito-sémitiques 11-20
Arabic Linguistics
Jacques GRAND’HENRY, Le moyen arabe de la version arabe du discours 11 de Grégoire de Nazianze 21-32
Paolo LA SPISA, Excerptum dalla più antica apologia arabo-cristiana 33-56 Andrzej ZABORSKI, Remarks on the Maltese Translations of the Koran 57-66 Marie-Claude SIMEONE-SENELLE, Le chat borgne. Un conte en arabe
véhiculaire des Îles Dahlak (Erythrée) 67-80 Catherine TAINE-CHEIKH, Les nasales dans les suffixes verbaux de l’arabe.
Tendances dominantes, faits particuliers et relation avec l’élément post-verbal –n(n)- 81-98
Judith ROSENHOUSE, Vocabulary Changes in an Eastern Arabic Dialect Region in the 20th Century 99-114
Classical and Pre-Modern Arabic Literature
Pierre LARCHER, Rhétoriques « grecque » et « hellénisante » vues par Ḍiyā’ al-dīn Ibn al-Aṯīr (VII
e/XIIIe siècle) 115-130
Nasser Ahmed ISMAIL, Rhetorical Devices in Mamlūk Poetry: The Case of Paronomasia 131-143
Antonella GHERSETTI, The Language(s) of the Arabs in al-Maqrīzī’s al-Ḫabar ‘an al-bašar 145-160
Francesca BELLINO, The Classification of Sciences in an Ottoman Arabic Encyclopaedia: Ṭāshköprüzāda’s Miftāḥ al-Sa‘āda 161-180
Mirella CASSARINO, Interpreting Two Stories of the Kitāb al-Aġānī: A Gender-Based Approach 181-193
Giovanni CANOVA, Sinnawr, hirr, qiṭṭ: il gatto nella tradizione arabo- islamica 195-214
Roberto TOTTOLI, Inna Allāh yubghiḍu al-balīgh min al-nās. A Study of an Early ḥadīth 215-227
Modern and Contemporary Arabic Literature
Clive HOLES, ‘Azīz ‘Alī, Iraqi “monologist” 229-237 Lorenzo CASINI, Verses (in a) Changing Discursive Order: Egyptian
Poetry in Colloquial Arabic and the Unaccomplished Revolution 239-256 Lucy LADIKOFF, La poesia popolare palestinese : al-ši‘r al-ša‘bī o al-zaǧal
al-filisṭīnī 257-271 Paolo BRANCA, “Come Pilato nel credo”? Muḥammad Aḥmad Ḫalafallāh
pioniere di una narratologia coranica 273-282 Alba Rosa SURIANO, Usi delle varietà linguistiche nella produzione teatrale
egiziana contemporanea 283-294 Maria Elena PANICONI, Scrivere di sé. Esperienze di modernità culturale
in Muḏakkirāt al-šabāb (Memorie di gioventù) di Muḥammad Ḥusayn Haykal 295-313
* * * NOTE E RECENSIONI
Antonio PERRI, Le lingue del Medio Oriente e la rivoluzione della stampa: La colonizzazione inavvertita 315-322
Mariangela MASULLO, Una mu‘āraḍa di Warda al-Yāziǧī 323-332 M. SHAWĀRBAH, A grammar of Negev Arabic. Comparative studies, texts and glossary in the Bedouin dialect of the cAzāzmih tribe, Wiesbaden: Harrassowitz, 2012 (R. Contini); R. HASSELBACH, Case in Semitic. Roles, Relations, and Reconstruction, Oxford, Oxford U.P., 2013 (F. Grande); Classical Arabic Literature. A Library of Arabic Literature Anthology, selected and translated by G.J. VAN GELDER, New York – London: New York U.P., 2013 (F. Bellino); F. DÉROCHE e V. SAGARIA ROSSI, I manoscritti in caratteri arabi. Al-maḫṭūṭāt bi-l-ḥarf al-ʿarabī, Roma: Viella, 2012 (E. Franssen); K. HIRSCHLER, The Written Word in the Medieval Arabic Lands. A Social and Cultural History of Reading Practices, Edinburgh: Edinburgh U.P., 2012 (C. Bori); Ḥātim b. Ibrāhīm AL-ḤĀMIDĪ, Tuḥfat al-qulūb wa furjat al-makrūb, ed. A. Hamdani, Bayrūt: Dār al-Sāqī – Institute of Ismaili Studies, 2012 (C. la Martire); AL-KINDI, Histoire des cadis égyptiens. Aḫbār quḍāt Miṣr, trad. M. Tillier, Le Caire : I.F.A.O., 2012 (A. Cilardo) ; Khalid SINDAWI, Temporary Marriage in Sunni and Shiʿite Islam. A Comparative Study, Wiesbaden: Harrassowitz, 2013 (A. Cilardo); M. BANO & H. KALMBACH (eds.), Women, Leadership, and Mosques. Changes in contemporary Islamic Authority, Leiden – Boston: Brill, 2012 (I. Zilio Grandi); S. TOLINO, Atti omosessuali e omosessualità fra diritto islamico e diritto positivo. Il caso egiziano con alcuni cenni all’esperienza libanese, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2013 (D. Cantini); I. TAHA, Arabic Minimalist Story. Genre, Politics and Poetics in the Self-colonial Era, Wiesbaden: Reichert Verlag, 2009 (O. Capezio); S. SIBILIO, Nakba. La memoria letteraria della catastrofe palestinese, Roma: Edizioni Q, 2013 (M.E. Paniconi); I. ORMOS, Max Herz Pasha (1856-1919). His Life and Career, Le Caire: I.F.A.O., 2009 (G. Canova). 333-350