Strade e confini
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Strade e confini
1. Confini
Fra i luoghi più stimolanti per chi si dedica allo
studio delle tradizioni popolari delle culture alpine, la
Valle di Susa occupa sicuramente un posto speciale. E non
solo per l’eccezionalità e la quantità delle
testimonianze vive che punteggiano ancora oggi il tessuto
sociale e il tempo calendariale delle comunità valsusine,
ma anche, a mio avviso, per la specificità del
territorio, quella specificità geografica che ne ha
condizionato la storia e il vissuto antropologico. La
lunga valle che si dipana lungo il corso della Dora tra
borghi, castelli e monasteri conducendo ai passi del
Monginevro e del Moncenisio, deve alla sua conformazione
naturale il privilegio di aver mantenuto un’importanza
millenaria anzitutto come strada, come ininterrotto
percorso verso l’altrove lontano: Roma o Santiago di
Compostella, Lione o Milano, i luoghi del Graal o la
Terrasanta.
La Valle di Susa come “porta” dell’Italia fa ormai
parte di quelle idées reçues che ogni storiografo di
invasori, pellegrini e viaggiatori, dalla discesa di
Annibale in poi, non ha mancato di addurre. Una porta
richiede tuttavia una soglia da varcare, un limes da
oltrepassare. Ma sono mai state, le Alpi, un vero limite?
2
Certo, i numerosi viaggiatori nordeuropei che nei secoli
scorsi hanno valicato il Moncenisio, magari lungo il
corso del Grand Tour tanto di moda nel Sei-Settecento,
imbevuti di cultura classica e di tanto entusiasmo per
il Bel Paese prima ancora d’averlo visto, sentivano di
aver posato il piede sul suolo italico non appena
realizzavano di trovarsi al di qua dello spartiacque.
Inalavano profondamente l’aria che spirava dal
fondovalle, immaginandola la stessa respirata da Cesare e
Virgilio; poi, novelli Carli Magni, calando dall’alto dei
monti provavano a spingere lo sguardo oltre le “chiuse”
del monte Pirchiriano sovrastato dalla Sacra di San
Michele, verso la pianura “lombarda”, la vallis aurea di
antica memoria, terra di delizie, di infinita dolcezza e,
perché no, ancora di conquista. L’ultimo e più famoso di
costoro si chiamava Bonaparte e si era agli esordi
dell’Ottocento.
Queste sensazioni, caratteristiche di un certo
spirito europeo colto o semi-colto, di estrazione
fondamentalmente urbana, si conciliavano con il nuovo
modo di vivere il viaggio in epoca moderna. Non più
pellegrinaggi penitenziali, non più perigliosi trasbordi
con carovane di muli o con altri mezzi di fortuna
attraverso luoghi selvaggi e semisconosciuti per il fine
esclusivo di compiere qualche buon affare, non più belve
3
in agguato - lupi ed orsi dietro ogni masso o cespuglio!
- ma, allo stato nascente, ecco affacciarsi nel costume
europeo il turismo, ovvero l’idea di una nuova ragione,
pura e non pratica, per viaggiare.
Il viaggiatore-turista colto, di allora come di oggi,
cerca esperienze formative inseguendo il mito del viaggio
di conoscenza e di perfezionamento, e usa la propria
erudizione come il bordone del pellegrino, appoggiandosi
ad essa per interpretare la realtà che gli viene
incontro. Il turista viaggia attraverso un universo per
lui del tutto nuovo di segni, che gli risultano sovente
indecifrabili, e si appiglia agli strumenti culturali di
cui si ritrova quanto più o quanto meno dotato per
suggerirsi rappresentazioni mentali e spiegazioni. Spesso
le idee sono già precostituite ma il turista è lieto,
almeno inconsciamente, di vederle confermate. Egli
procede sospinto da grandi aspettative già maturate alla
partenza e attribuisce enorme valore ai simboli, ovvero
ai luoghi simbolici e agli atti simbolici: palazzi e
monumenti assolutamente da vedere, località amene e piatti
regionali imperdibili, gesti rituali da compiere.
Uno di questi, il primo importante atto di ingresso
nel paese da visitare, è il passaggio del confine, che
acquista tanto maggior rilievo, e suggestione, quanto più
esso è marcato da evidenti segni materiali e da eventi
4
caratterizzanti l’ufficialità del momento: pietre
miliari, terre-di-nessuno (perfetti non luoghi), barriere
che si alzano, soldati che salutano militarmente,
bandiere che garriscono, pratiche burocratiche, ostacoli
imprevisti, tempi di attesa, opposizioni e accomodamenti.
L’attraversamento di una frontiera, così efficacemente
denotato, si connota anche come un rito di passaggio
corredato di tutti gli elementi della prova iniziatica da
superare. È dunque l’attraversamento della linea di
confine che fa sentire chi la oltrepassa come di essere
arrivato “in un altro mondo”. Di là, il sole, la luce,
l’aria, le piante, le rocce, gli uomini, tutto è diverso,
anche se si sa in fondo che sono sempre lo stesso sole,
aria, piante e gente, perché il confine spesso altro non
è che una convenzione, un tratto d’inchiostro su una
carta che può essere cancellato e spostato un po’ più in
qua, un po’ più in là.
Oggi, nell’Europa che ha pressoché annullato le
frontiere, la sensazione dell’essere catapultati altrove
forse la percepiamo solo dopo una lunga trasvolata verso
climi e terre più lontane ed esotiche, ma il viaggiatore
dei secoli scorsi, almeno fino alla prima metà del
Novecento, viaggiava lentamente, e di continuo incappava
in una gran quantità di confini, dazi, dogane, ponti a
pedaggio, eccetera; pagava balzelli, rischiava parte del
5
suo bagaglio e subiva le angherie dei doganieri. Si pensi
per esempio all’Italia prima dell’unificazione,
frammentata in stati e staterelli.
Un passo di montagna, invece, di per sé non ha mai
rappresentato una reale barriera, essendo, semmai, una
via di transito e quindi di comunicazione. Le difficoltà
del valico alpino, prima che si costruissero le comode
strade napoleoniche, erano tali solo per gli inesperti di
pianura che dovevano affidarsi alle guide del posto per
essere condotti sani e salvi dall’altra parte. Peraltro,
vi era consapevolezza di dover affrontare territori
variegati, a tratti anche aspri, e tale ipotesi entrava
normalmente in preventivo a molti viaggi, come il
rischio del brigantaggio o la rottura delle ruote dei
carri. Ogni europeo, già da bambino sapeva bene come
viaggiavano gli eroi delle fiabe. Per mezzo di locuzioni
del tipo “cammina cammina…”, “per boschi e foreste…”,
“traversati mari e monti…”, la fiaba popolare fin
dall’infanzia rendeva normale l’idea del viaggio come di
un non sempre facile, anzi, sovente piuttosto
accidentato, tragitto del corpo e dello spirito. Oltre
che sulle Alpi, si attraversavano montagne dalla Francia
alla Spagna, dalla Polonia all’Ungheria, da Firenze a
Bologna, dal Piemonte alla Liguria. I viaggiatori
seguivano percorsi millenari, come i passi di
6
Roncisvalle, del Sempione, del Monginevro, del
Moncenisio; non sempre la linea di confine è passata
sulla cresta di quei monti e non sempre le differenze tra
i popoli hanno coinciso con i sistemi geopolitici.
La cartografia linguistica, nata ai primi del
Novecento su impulso di Jean Gilliéron, ha potuto
mostrare con tutta evidenza come le lingue non conoscano
i limiti territoriali che i regimi politici impongono. Le
parole valicano i fiumi, i deserti e le montagne, altre
volte si fermano inspiegabilmente sul poggio a fianco del
nostro villaggio e quel dato oggetto a un certo punto
viene chiamato con un altro nome. Un viaggiatore del
Seicento notava come un confine linguistico passasse
addirittura all’interno della città di Trento, e non si
trattava di sole differenze idiomatiche, ma anche di usi
e costumi. Infatti, nemmeno la sola lingua può dirsi una
sicura spia della diversità. Recenti ricerche
scientifiche sulle cosiddette barriere genetiche in Europa,
ossia quelle particolari varianti dei confini che non
sono disegnate sulle carte ma per l’appunto nei nostri
geni, hanno dimostrato che su 33 barriere genetiche
individuate, queste coincidono in 31 casi con variazioni
linguistiche o dialettali, ma solo in 22 casi anche con
barriere fisiche (mari, fiumi, catene montuose).
7
Le differenze tra i popoli perciò si misurano anche
in atti culturali, confrontando i sistemi di vita, di
credenze magico-religiose, di miti, di tradizioni, e
spesso succede che attraverso usanze apparentemente
eterogenee trapeli un lascito comune riconoscibile
risalendo poche generazioni. Un pastore delle Alpi è
tale, con minime differenze rispetto a un altro,
indipendentemente dal versante sul quale si trova la sua
grangia. Non sempre le varianti del suo dialetto si
accompagnano ad un radicalmente diverso modo di vestire
(l’abito folklorico è un abito mentale, veicola identità
culturale), a inconsuete particolarità culinarie, ad
altri specifici rituali della vita quotidiana. La cultura
materiale, condizionata dall’ambiente e dal clima, è
quasi sempre la stessa e di norma quel montanaro svolge
altresì funzione di cerniera, è veicolo della
divulgazione orale di lingue, storie, ballate,
costumanze, credenze.
Un viaggiatore scozzese sul finire del Settecento,
durante il tragitto da Novalesa a Lansleburg, si
sorprende nel constatare come la sua guida, un giovane
marron di Novalesa, analfabeta, parlasse ben quattro
lingue: il dialetto piemontese, il patois della Savoia,
l’italiano e il francese. Non era un caso raro in
montagna, e non lo sarebbe nemmeno in tempi a noi più
8
vicini. Penso a individui come il compianto Robert
Tagliero di Torre Pellice, meglio noto come Robert “Le
Diable”, classe 1909, ben conosciuto da ricercatori ed
etnomusicologi, formidabile portatore di un enorme
patrimonio orale di canti francesi, italiani, piemontesi
e nel patois provenzale delle sue valli. Robert, pur
essendo sicuramente dotato di una personalità
eccezionale, non poteva non affondare le proprie radici
in un ricco humus popolare, avendo attinto la sua
conoscenza da un vasto repertorio familiare (il padre e
la madre, da lui definite vere “enciclopedie di
canzoni”), costantemente accresciuto da nuovi apporti (i
fratelli, lo zio che lavorava a Gap…), in una valle dove
le comunità valdesi hanno per secoli attribuito estrema
importanza agli strumenti della parola, del canto e della
perpetuazione del ricordo. A sua volta Robert “Le Diable”
ha trasmesso i dati della sua inesauribile memoria ad un
erede, oltre che ai numerosi ricercatori che l’hanno
conosciuto ed apprezzato per decenni, ed è uno degli
ultimi epigoni di un’epoca in cui un ampio sapere,
proprio una “enciclopedia”, come amava dire Robert, si
conservava e si diffondeva per canali non scritti ed
attraverso le vie tortuose disegnate dai sentieri di
montagna. Appunto, le vie: si è mai riflettuto abbastanza
sulla valenza antropologica delle strade?
9
2. Le strade
Gli abitati vengono collegati dalle strade o, invece,
sorgono lungo le strade? Nel caso della Valle di Susa
(come per molte altre valli alpine) pare più evidente la
seconda tesi. Una valle è una strada naturale lungo la
quale si edificano insediamenti umani che restano in
contatto costante tra loro. Nell’incavo della valle
scorre l’acqua per le necessità vitali dell’uomo e del
suo bestiame, mentre la strada viene percorsa per il
lavoro quotidiano nelle campagne, per le transumanze
stagionali, ma anche per raggiungere fiere e mercati,
cioè per lo scambio materiale di beni ed oggetti oltre
che per lo scambio di informazione. Lungo una via di gran
traffico sorgono, poi, stazioni di posta, locande,
botteghe di fabbri: la popolazione locale mette a
disposizione tutti i servizi di cui possono necessitare i
viandanti che transitano da/verso la frontiera. È dunque
la geografia del luogo a determinare il suo vissuto. Non
si costruisce la prosperità di una comunità vivendo
isolati: il sito abitato può collocarsi su una posizione
elevata e meglio difendibile, può essere anche
fortificato, ma allo stesso tempo deve essere facilmente
10
raggiungibile e deve potersi aprire al mondo. E in Valle
di Susa il mondo passava.
Una storiella inglese raccontava di un villico
ignorante che, interrogato circa il nome di un fiume che
scorreva attraverso il suo villaggio, aveva risposto di
non aver mai sentito il bisogno di chiamarlo per nome
perché, tanto, il fiume sarebbe passato lo stesso. Si è
osservato che qualcosa di simile poteva avvenire anche
per le grandi strade di collegamento che intersecavano i
paesi di campagna: secondo un principio che potremmo
definire relativistico, nella duplice accezione sia
culturale che spazio-temporale, un mondo veloce di
veicoli, cavalli e passeggeri poteva transitare per la
strada senza all’apparenza lasciare tracce nella vita
lenta e consuetudinaria che si conduceva ai suoi bordi.
In realtà, un certo scambio tra i due mondi doveva per
forza di cose avvenire, solo che il primo, poco
interessato all’osservazione di un contesto giudicato
poco attraente rispetto a quanto lo attendeva alla sua
meta, si contentava di soddisfare con la maggiore
rapidità le necessità dettate dal viaggio (il cambio dei
cavalli o la ferratura, un pasto leggero, un
pernottamento), il secondo, invece, assimilava lentamente
grumi di informazioni la cui metabolizzazione impiegava
anni, se non decenni, prima che ne fosse ravvisabile una
11
sedimentazione nel corpo sociale. Già Levi-Strauss ci ha
insegnato che quando due culture vengono messe a
confronto possono dare luogo ad equivoci in seguito ai
quali una delle due, la più “primitiva”, può apparire
priva di storia e sempre uguale a se stessa. In realtà
esse hanno semplicemente velocità diverse e, aggiungerei,
il più delle volte anche diverso indirizzo.
Come si è detto, lungo le grandi vie di transito si
organizzava un complesso di attività che andava
intensificandosi laddove si era nei pressi di un confine
territoriale, di un passo. Gli ultimi avamposti di
frontiera somigliano sempre ad un porto di mare.
Edward Gibbon riferisce che nel 1764 si contavano
centoventi portatori a Lansleburg e centocinquanta a
Novalesa, e che questo era il mestiere preferito dai
contadini. I portantini affrontavano le “scale” del
Moncenisio con il passo rapido dei montanari abituati
alle transumanze d’alta quota, e pare che questo fosse il
mezzo privilegiato da tutti. Non mancavano ovviamente le
bestie da soma incaricate del trasporto del bagaglio e
delle carrozze che venivano smontate prima di affrontare
il valico. Montesquieu dice che occorrevano tre muli per
trasportare una carrozza: uno portava le stanghe, uno il
corpo, un altro le ruote. Novalesa possedeva ampi
12
stallaggi per cavalli e muli, oltre ad arrivare a contare
ben settantotto locande per i viandanti ed un ospizio-
ospedale sul colle con trecento posti letto. Dopo la
costruzione della strada napoleonica, sul tracciato per
Giaglione che eliminava le “scale”, andò in declino il
mestiere di portantino ma non certo quello di mulattiere
che perdurò almeno fino alla costruzione della prima
ferrovia nel 1868. Si calcola che nel 1810 transitassero
sulla strada 17.000 veicoli trainati da ben 37.000
quadrupedi. Per far inerpicare una carrozza dalla salita
di Lansleburg al colle occorreva apprestare un tiro di
almeno quattordici cavalli. La Guida del Viaggiatore in Italia,
edita per i tipi di Artaria nel 1845, ci informa che il
percorso da Torino a Chambery conta in quel periodo una
trentina di stazioni di posta e che la strada del
Moncenisio “quantunque tortuosa, è comoda ed accessibile
a qualsiasi sorta di vetture”. Rari nella Guida sono i
cenni sugli abitanti. Di Lansleburg, scesi nella Val
d’Arc, si apprende che essi “traggono la principal loro
sussistenza dal trasporto delle mercanzie e dei
viaggiatori sul monte Cenisio”; di Saint Jean de
Maurienne che ne annovera circa tremila, “i quali in
generale sono malfatti e gozzuti, imperfezioni che
regnano in quasi tutta questa vallata”, il che fa pensare
ad una popolazione fortemente stanziale, ad alto tasso di
13
endogamia e dall’alimentazione povera e poco variata. Il
taglio della Guida, seppur sintetico, è tuttavia non
dissimile dalle moderne guide turistiche in cui si
indicano gli edifici notevoli, i paesaggi pittoreschi, le
sottili maniere per rendere più piacevole il viaggio. Che
ci si trovi su un percorso ad alta frequentazione è
sempre abbastanza esplicito.
Dunque i contatti di questi montanari con il mondo
esterno sono stati per secoli costanti e assidui,
cionondimeno in Valle di Susa si osserva ancora oggi una
rara tenacia nella conservazione di antiche tradizioni
popolari: penso alla danza delle spade di Giaglione e
Venaus (a un passo da Novalesa, senza trascurare San
Giorio sulla strada della sponda destra non distante da
Bussoleno) o all’arcaica maschera dell’orso di Mompantero
nei pressi di Susa.
Vengono alla mente altre valli e altri passi di
montagna in Piemonte legati da circostanze analoghe.
Ancora oggi a Vernante, centro della Val Vermenagna sorto
lungo la strada del Colle di Tenda che congiunge il
cuneese con il territorio di Nizza, si perpetua nel mese
di luglio la celebrazione della baìa dei carrettieri,
l’antico mestiere dei vernantini, che un tempo fornivano
la loro fondamentale prestazione su una delle più
importanti vie del sale. Gli scarsi muli rimasti vengono
14
bardati a festa e fatti sfilare per il paese per la
benedizione di rito, seguono poi le musiche e le danze
tradizionali di area occitana: principalmente curente e
balèt che la popolazione esegue da sempre con
partecipazione e rinnovato entusiasmo. È significativo,
inoltre, come in Val Vermenagna, segnatamente nei centri
di Robilante, Vernante e Limone, si collochi la più alta
percentuale di musicisti popolari di tutta la regione con
almeno un’ottantina tra suonatori di clarino, fisarmonica
cromatica e semitùn, gli strumenti entrati in uso nella
tradizione locale di musica da ballo.
Anche il passaggio verso il mare, il viaggio al sud
dei piemontesi e dei lombardi, che avvenisse sulle alpi
marittime o sull’appennino ligure, ha rappresentato in
passato una sorta di confine da superare, e talvolta lo è
stato pure politicamente. Lungo un itinerario
determinante per i collegamenti tra Lombardia e Genova si
trova il territorio di Ovada, là dove finisce la pianura
padana e hanno inizio i primi contrafforti appenninici
per i quali si accede alla Liguria superando il passo
del Turchino. Già confine amministrativo romano e
bizantino, la zona si è sempre sentita un avamposto di
frontiera ed ha sviluppato una sua vocazione naturale al
trasporto e al commercio. A metà Ottocento il Casalis
riferisce che per le relazioni commerciali tra Ovada e
15
Genova sono impiegati più di duecento muli oltre a
numerosi carri per i trasporti verso la Lombardia.
Nelle immediate vicinanze di Ovada sorge il borgo di
Rocca Grimalda, posto strategicamente a dominare un
restringimento della valle dell’Orba lungo la quale passa
obbligatoriamente la strada per la Liguria, dal quale
diverse famiglie hanno fornito esperti mulattieri fino a
tempi non lontani, principalmente per il trasporto
dell’ottimo vino Dolcetto prodotto in zona. Come in altri
luoghi, anche a Rocca Grimalda, ancora alla fine
dell’Ottocento, i carrettieri celebravano la propria
festa conducendo alla benedizione nel giorno di S.
Antonio abate i muli abbelliti con i migliori finimenti e
ornati di collane d’arance. Finita l’epoca dei carri e
dei muli, resta oggi l’interessante sfilata della Lachera,
il carnevale di Rocca Grimalda, con i Lachè a far da
scorta armati di spade e la maschera dei Trapulin, quattro
uomini muniti di una lungo staffile da carrettiere, il
cui compito è di sopravanzare e chiudere il “corteo
nuziale”, aprendo e delimitando lo spazio scenico con
schiocchi di frustate sonore come petardi. Qui, come in
Val Vermenagna e in Valle di Susa, troviamo ancora quella
stessa tenacia di un popolo, secolarmente aperto a tutti
i traffici e a tutte le migrazioni, nell’aggrapparsi a
cerimonie e valori che sono retaggio di un’antica
16
tradizione, risultata da una lunga opera di
stratificazione culturale, le cui origini lontane e
complesse difficilmente potranno essere mai ricostruite
storicamente con esattezza.
E qui sta il punto. Vediamo comunità aperte che
conservano più di altre. Pare un’incongruenza. Ma
torniamo al concetto di doppia velocità già espresso: non
solo in vallate isolate di montagna, ma perfino ai bordi
di strade a grande percorrenza, la vita sembra svolgersi
anno dopo anno senza sussulti in virtù del fatto che la
popolazione ha propri parametri di riferimento che
divergono dallo spazio-tempo lineare di chi viaggia. Il
viaggiatore ragiona pressappoco in questi termini: arrivo
da X avendo impiegato N giorni, proseguo per Y prevedendo
di impiegare ulteriori N1 giorni; in totale dunque devo
metterci un tempo T=N+N1 in funzione del tragitto XY. Il
suo tempo è una linea orizzontale come il suo percorso,
una sequenza in progressione di attimi e di passi (o di
altre unità di misura: oggi valutiamo i nostri
spostamenti in chilometri orari). Il tempo della tradizione
popolare è invece un tempo circolare, determinato dai
cicli naturali stagionali, lunari, solari, specifico
della cultura stanziale contadina. Per le popolazioni di
montagna, alle stagioni erano inoltre legati i tempi
della transumanza in alpeggio, dell’accoppiamento del
17
bestiame - affinchè nessuna mucca si trovasse a partorire
mentre si era ad un pascolo d’alta quota - e persino di
quella emigrazione periodica (oggi diremmo “pendolare”)
verso la Francia o verso le pianure del Piemonte per la
prestazione di lavori di manovalanza temporanea. È
evidente che l’evoluzione di una società a tempo
circolare debba essere inevitabilmente più lenta di una a
tempo lineare. Cionondimeno il prestito culturale avviene
grazie proprio a quell’incessante scambio con l’esterno.
È noto che le danze delle spade e le mascherate con
l’orso non sono fenomeni isolati esistenti solo in
Italia in Valle di Susa, ma si ha conoscenza o memoria di
cerimonie analoghe in tutta Europa. La maschera
carnevalesca dell’orso ha rivestito grande importanza in
passato per la cultura contadina, sia con l’aspetto di
indicatore calendariale, sia con l’assunzione del ruolo
di simbolo rappresentativo della comunità. Assieme ai
componenti delle badìe, o abbazie dei folli, un uomo
mascherato con pelli o frasche usciva selvaggiamente ad
annunciare il carnevale e il prossimo avvento della buona
stagione. Con funzione propiziatoria quasi analoga, era
talvolta la medesima maschera ad incaricarsi di dare il
benvenuto alle autorità di passaggio alle soglie dei
villaggi. È ricordato che nel 1550, a Saint Jean de
Maurienne, ben cento uomini travestiti da orso accolgono
18
l’ingresso del Re di Francia Enrico II e, imitando le
goffe movenze dell’animale, rivolgono questo allegro e
singolare saluto all’ospite per suscitare l’ilarità sua
e del suo seguito. Non lontano da qui, sull’Isére nel
Delfinato, durante il ribollente carnevale di Romans del
1580 in cui avviene di tutto in un clima semi-
insurrezionale, dalle danze delle spade ai più svariati
cortei mascherati cui partecipano in contrapposizione
ceti alti e ceti bassi, un certo Paumier, postosi a capo
della protesta popolare, indossa emblematicamente il
costume da orso. L’evento ha un epilogo cruento, tuttavia
sempre in qualche modo compreso nel solco della
tradizione folklorica, concludendonsi con una sorta di
caccia e uccisione del ribelle.
Ancora oggi in Valle di Susa, nella frazione Urbiano
di Mompantero, nel giorno di santa Brigida (2 febbraio)
viene “catturato” l’orso da alcuni “cacciatori” che lo
conducono per il paese a suon di legnate e bevute di vino
per addomesticare i suoi istinti belluini. L’orso, tenuto
a stento con corde e catene, si dimena, lancia ruggiti
feroci attraverso un imbuto che ne amplifica il suono, si
slancia contro la folla per aggredirla. Alla fine
riuscirà ad ammansirlo solo una fanciulla del paese che
la sera lo farà ballare.
19
In Savoia e Delfinato è diffuso il culto di San
Biagio (la cui ricorrenza cade significativamente il 3
febbraio: lo stesso periodo dell’uscita dell’orso),
martire cui furono straziate le carni con pettini di
ferro, ragione per la quale è divenuto patrono dei
cardatori di lana. Nell’occasione della sua festa si
svolgono a Venaus le evoluzioni degli spadonari, i quali
affermano esservi alcune figure della loro danza che
richiamano direttamente il martirio del santo. Un
viaggiatore francese dei primi dell’Ottocento che ha modo
di assistere alla danza delle spade a Salbertrand,
sostiene che gli spadonari sono un relitto di forme più
antiche di teatro sacro e che in particolare essi
avrebbero a lungo composto la scorta armata del drappello
che si incaricava di rappresentare la decapitazione di
San Giovanni Battista.
Come si vede, culto dei santi e feste carnevalesche
sono sovente intrecciati nelle tradizioni popolari e non
è sempre facile distinguere il motore principale di
cerimonie così stratificate. Quel che è certo, è che non
sembra esservi un “al di qua” o un “al di là” dell’arco
alpino dal punto di vista della trasmissione culturale, e
che i popoli di montagna hanno sempre condiviso
largamente costumi e tradizioni.
20
3. Confini mobili
Storicamente in Valle di Susa sono stati tracciati
molti confini. Al tempo di Augusto era situata una
stazione doganale presso Avigliana (ad fines qudragesima
galliarum) che segnava il confine tra l’Italia e la Gallia
e dove le merci in transito erano soggette ad un dazio
pari a un quarantesimo del loro valore. Qui, per i
Romani, aveva inizio la strada per le Gallie. Una
conferma tarda ci viene dall’Itinerario di Gerusalemme del
terzo secolo dopo Cristo che fornisce informazioni ai
primi pellegrini sulle distanze da percorrere per chi
scende da Briançon: a Cesana, 10 milia; a Oulx, 9 milia;
a Susa, per Salbertrand, Exilles, Chiomonte, 16 milia; ad
Avigliana, 12 milia; “inde incipit Italia”. Poi comincia
l’Italia.
Un importante confine naturale era costituito dalla
strettoia prodotta dal Monte Pirchiriano e dal Monte
Caprasio all’altezza dell’attuale borgo di Chiusa, il cui
nome, risalente al termine militare claustra, sta a
indicare per l’appunto una chiusura, un luogo stretto tra
un fiume e una montagna dove è difficoltoso il passaggio
e sul quale è più vantaggioso esercitare un presidio
21
difensivo. In questa zona i Longobardi avevano posto le
loro fortificazioni a difesa del regno minacciato dai
Franchi. Nell’estate del 773 Carlo Magno valica il
Moncenisio e si trova di fronte ad un poderoso
sbarramento. Narra la Cronaca di Novalesa che un giullare
traditore offrì al re Carlo di condurre le truppe
attraverso quello che ancor oggi è chiamato “sentiero dei
Franchi” per aggirare le difese Longobarde e prenderle di
sorpresa. L’impresa segnò la fine del regno Longobardo e
anche il declino strategico di quel confine. Diviene
molto più importante, dopo Carlo Magno, il controllo del
Moncenisio.
Nel secolo XI prendono forma i possedimenti di alcune
nuove potenti casate feudali, gli Arduinici a Torino, i
Savoia sul versante nord occidentale delle Alpi, i
Delfini più a sud, e nuovi confini si instaurano. Tra
Gravere e Chiomonte passerà per lungo tempo la linea di
demarcazione tra Savoia e Delfinato. Quest’ultimo, sul
versante italiano, comprende tutta l’alta Valle di Susa e
la Val Chisone: il Colle di Sestriéres, Cesana,
Bardonecchia, Oulx, Exilles. Più tardi, l’annessione del
Piemonte alla Savoia invece annullerà per qualche tempo
tutti i confini tra Chambery e Torino.
Poi verranno i lunghi anni delle guerre di
successione e dell’interminabile scontro tra stato
22
sabaudo e Francia. Il Piemonte è terra dove passano tutti
gli eserciti e dove le città cambiano padrone
rapidamente. I confini si spostano di conseguenza con la
medesima celerità. Oggi un territorio è piemontese,
domani non più. Il generale Catinat lascerà una triste
memoria di scorrerie e devastazioni: i castelli di San
Giorio e di Avigliana saranno incendiati e semi-distrutti
dai suoi guastatori. Le valli alpine si rivelano quanto
mai di vitale importanza strategica e vi sorgono
imponenti opere di difesa come i forti di Fenestrelle e
di Exilles. Per tale ragione, nel 1747, dopo avere
superato il Monginevro, l’esercito francese tenterà, e
fallirà, una manovra di penetrazione sul crinale del
colle dell’Assietta, tra le valli del Chisone e della
Dora. All’epoca della rivoluzione francese, nel 1794, i
Francesi strappano il valico del Moncenisio ai Piemontesi
che lo riconquistano nel 1800 con l’aiuto austriaco. Sarà
poi nuovamente ripreso da Napoleone Bonaparte, e il
Piemonte annesso alla Francia. Napoleone sa qual’è la
rilevanza strategica del passaggio sul Moncenisio e lo
renderà più agevole costruendo la strada carrozzabile, il
cui tracciato è quello sostanzialmente ancora in uso
oggi.
23
Napoleone conosceva bene l’importanza di un confine ma
ancor di più quella di una strada, e non solo a fini
militari.
Si inferisce dalle vicende storiche che la vita
quotidiana delle popolazioni poteva essere in certi
periodi quanto mai precaria e difficile, esposta com’era
ad ogni tipo di violenze ed abusi. Tuttavia, dobbiamo
pensare che i devastanti passaggi degli eserciti e i
repentini rivolgimenti politici, seppure potenziali
portatori nel medio termine di profondi mutamenti socio-
economici e culturali, lasciavano localmente spazio a
periodi di relativa tranquillità nel corso dei quali la
vita poteva scorrere pacificamente secondo abitudini
consolidate. Ho potuto personalmente verificare
attraverso uno studio sull’andamento dei matrimoni e
delle nascite di una comunità piemontese del Settecento,
che neppure in periodi di intensa attività bellica, come
ad esempio durante la campagna iniziata nel 1704 e
culminata con l’assedio di Torino da parte dei Francesi
del 1706, si può riscontrare una qualche significativa
flessione numerica nei registri parrocchiali da me
consultati, almeno per una popolazione che si fosse
trovata in quel periodo marginalmente coinvolta dagli
eventi.
24
Ciò può farci teorizzare una sorta di principio di priorità
locale secondo il quale le condizioni date dal contesto
particolare, costituite da un impasto formato da elementi
della tradizione e circostanze geo-socio-ambientali siano
risultate prevalenti in più occasioni sui cambiamenti
politici generali. È la micro-storia che prende il
sopravvento sulla Storia. Osservava già Montesquieu come
i lazzari di Napoli, fossero ancora come i liberti
dell’antica Roma la “plebe più plebe delle altre”,
nonostante in quel periodo il dominio sulla città fosse
passato dal regno di Spagna all’Imperatore d’Austria. La
gente del popolo, impegnata nella dura lotta quotidiana
per la sopravvivenza, sa che la politica fa e disfa le
regole emanando nuove leggi, inventando balzelli e
stabilendo frontiere, ma conosce altrettanto la caducità
dei regimi, delle leggi, dei balzelli e degli
“inviolabili sacri confini”.
Le strade, come i valori forti e reali, tendono a
restare. Esse, seguendo il loro corso naturale, penetrano
i confini, li oltrepassano, li ignorano. I confini sono
mobili, sovente effimeri, le strade durano nel tempo. I
percorsi millenari, i sentieri del contrabbando del sale
e delle transumanze ai pascoli d’altura non conoscono
frontiere e sono il carsico sistema venoso di una
comunicazione culturale “altra”. Questa non si può
25
interrompere se non con la forza ottusa di una brutale
imposizione dall’alto.
Gli etnologi ben conoscono i danni inflitti alle
popolazioni di pastori nomadi dalle arbitrarie
delimitazioni politiche post-coloniali di certi stati
africani.
Solo il tema retorico di fine Ottocento della
sacralità del suolo patrio poteva far scrivere alla
novellista torinese Maria Savi Lopez che “i petti dei
nostri soldati sono un baluardo più forte ancora che
tutte le rupi accumulate sui colossi alpini... e quando
nei secoli che verranno, ogni memoria delle fate, dei
folletti o delle processioni dei morti sarà forse perduta
sulle nostre montagne, l’Italia tutta ricorderebbe ancora
la gloria dei soldati delle Alpi, divenuti gli eroi
leggendari di epici racconti ed i geni tutelari della
patria, fra le nevi eterne e lo splendore degli immensi
ghiacciai”. Non più lo spartiacque della catena alpina ma
“i petti dei nostri soldati” erano divenuti, in questa
visione, la nuova linea di confine, anch’essa nondimeno
destinata a spezzarsi, come le altre, insieme alla
retorica che l’accompagnava, mentre la sensibilità
odierna ci fa riflettere sul fatto che, forse, è valsa la
pena continuare a prodigarsi perché ancora qualche
26
































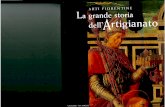










![E]E!DH - RERO DOC](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63233b14f3cd44b80906ba12/eedh-rero-doc.jpg)





