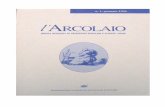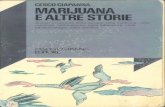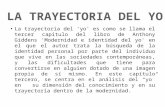STORIE DI ORDINARIE ANOMALIE: MAURO COVACICH CONTRO E SOTTOSOPRA
Transcript of STORIE DI ORDINARIE ANOMALIE: MAURO COVACICH CONTRO E SOTTOSOPRA
Nato a Trieste nel 1965, dopo la lau-
rea in Filosofia (con una tesi su Gil- les Deleuze), Mauro Covacich si trasferisce a Pordenone dove inse- gna nei licei pubblici e, poco più tardi, entra in ruolo. Nel 2000 abbandona l’insegnamento per dedicarsi interamente alla scrittura.
Nel 2005 lascia Pordenone per trasfe-
rirsi a Roma. Dal 1998 collabora con
il «Corriere della sera». Per la Rai rea-
lizza radiodocumentari e il radio-
dramma Safari. Nel 1999 l’Univer-
sità di Vienna gli conferisce l’A-
braham Woursell Prize, una borsa di
studio triennale che gli consentirà di
effettuare periodi di «writer in resi-
dence» in numerose università euro-
pee e statunitensi. Esordisce nel 1993
con Storie di pazzi e di normali, al
quale seguono Colpo di Lama (Neri
Pozza, 1995), Mal d’autobus (Tropea,
1997), Anomalie (Mondadori, 1998,
2001) e La poetica dell’Unabomber (Theoria, 1999) che è una raccolta di
reportage. Il romanzo successivo, L’a- more contro (Mondadori, 2001) viene
poi ripubblicato da Einaudi. Con A perdifiato (Einaudi, 2003), inizia il
cosiddetto ‘ciclo delle stelle’. Si tratta
di una pentalogia, composta da altri tre
romanzi: Fiona (Einaudi, 2005),
Prima di sparire (Einaudi, 2008) e A nome tuo (Einau di, 2011), intercalati
dalla videoinstallazione L’umiliazione delle stelle, realizzata da Covacich
nel 2010 e prodotta da Buziol,
Einaudi e Magaz zino d’arte
moderna. Con Laterza pubblica
inoltre i tre saggi narrativi: Storia di pazzi e di normali (1993, 2007),
Trieste sottosopra (2006) L’arte contemporanea spiegata a tuo marito (2011) e L’esperimento (2013).
80
STORIE DI ORDINARIE ANOMALIE: MAURO COVACICH CONTRO E SOTTOSOPRA di Hanna Serkowska
Nel presente saggio, che si propone di tracciare un profilo del-
l’opera di Mauro Covacich, si cercherà di individuare alcune
ricorrenze tematiche che fanno emergere la presenza ossessiva di
quelle che sono le anomalie contemporanee, il carattere globale
o universale dei disturbi e mali descritti nei suoi testi, nonché la
preferenza per un debenedettiano personaggio-uomo le cui idio-
sincrasie sono connesse con o determinate dal contesto dei suoi
scritti. Al contempo si cercherà di presentare le scelte compiute
a livello stilistico-formale, manifeste nel ricorso al genere di
autofiction, in particolare, e alla categoria di ‘storie vere’, in
generale. Scelte atte a confermare l’importanza, per lo scrittore
triestino, dei riferimenti alla realtà extraestetica, e quindi della
vita e vitalità, nonché del rapporto tra la finzione e la verità su
cui egli costantemente si sofferma. Si presenterà infine anche la
riflessione dell’autore – presente soprattutto in Trieste sottosopra – sulla triestinità. Tale riflessione si rivelerà cifra dell’intera opera in disamina che è una scrittura di re-azione e di r(e)sistenza.
Sembra che Covacich segua la strada indicata dal grande criti- co a partire dalla constatazione del deprecato sciopero dei per-
sonaggi (e della serrata dei narratori che considerarono il roman-
zo con personaggi non fantocci, personaggi non particelle, come appartenente al passato), verso un rilancio del romanzo e un recupero del personaggio-uomo.
Qualche anno fa Gianluigi Simonetti affermava: «[u]n ruolo di
assoluto rilievo nel romanzo italiano contemporaneo lo svolge la
televisione» (70), come fulcro dell’esperienza e del sapere, come
81
Hanna Serkowska
tempio in cui si celebra l’incontro tra consumismo e assoluto, tra immagine e corpo. Essendo il dominio dell’inautentico, nella letteratura degli anni Novanta la televisione è diventata anche bersaglio che si è cercato di colpire con un gesto teatrale, sarca- stico e antimimetico. Gli scrittori ‘cannibali’, infatti, hanno rap- presentato in modo caricaturale gli effetti della videodipenden- za, della violenza del mezzo televisivo, e insieme denunciato il falso realismo, ovvero il realismo senza verità, con «sempre die- tro l’angolo il rischio della falsificazione mediatica». Più tardi, negli anni zero si assisterebbe, sempre secondo Simonetti, a un confronto più sottile tra opposti ‘realismi’, quello del romanzo e quello dei media (64 e 72). Covacich tuttavia, sin dall’inizio libe- ro delle tinte caricaturali e sobriamente realistico, non ricorre mai a modi di espressione caricati, al sarcasmo, al gesto teatrale caratteristico, al contrario di opere come Woobinda di Aldo Nove. Ha ragione pertanto Donnarumma quando afferma che la scrittura di Covacich esprime «una protesta senza garanzie di riuscita contro la falsificazione mediatica dell’esistente» (“Nuovi realismi…” 53), anche se, precisiamo, è una protesta che non sfrutta la parodia, mezzo prediletto della parabola postmoderna, d a cui il triestino è del tutto avulso. La riflessione dello scrittore sulla prima anomalia del mondo contemporaneo – un’ennesima mutazione antropologica che ha generato l’homo videns – è legata ad un’ossessiva caccia all’inau- tentico e all’artificio, ad una guerra dichiarata alla finzione che si annida – a dir dello scrittore – in ogni nostro gesto quotidiano e che ci rende non persone ma personaggi. La falsificazione media- tica porterà lo scrittore a sviluppare la sua riflessione (soprattut- to nella pentalogia delle stelle) sul rapporto tra finzione e realtà. In Fiona, che racconta gli abusi dell’impero del ‘visibilio’ ai danni della realtà e della nostra percezione di ciò che è unico e reale, Covacich entra in dialogo con il Nove di Woobinda: alla TV viene imputato il reato di creare immagini che eclissano o fanno scomparire il mondo vero sostituendo ad esso un mondo ipersemplificato, livellato. Sandro, il protagonista, abbandona nei supermercati degli ordigni esplosivi per lanciare una sfida
82
Storie di ordinarie anomalie: Mauro Covacich contro e sottosopra
all’immagine, impegnandosi in una scommessa con il mondo dell’immagine che egli contribuisce a creare nella sua veste di regista del noto reality show Habitat. L’esplosione distrugge la telecamera e nebulizza la visione, sabotando il sistema di cui egli è in parte autore. Il fastidio nei confronti del mezzo televisivo deriva anche dal fatto che la televisione, fingendo di trasmettere fatti reali, in effetti sdoppia il reale e lo falsa secondo un suo preciso disegno o scenario. Allo stesso modo i concorrenti di Habitat si indu- striano a ‘vivere’ in diretta, davanti agli occhi degli spettatori, mentre gli autori del programma prendono appunti «per i ven- tiquattro minuti di montato della puntata in chiaro di domani e passandosi continuamente il regista al telefono» (Fiona 13). Convocano inoltre i concorrenti nello stanzino detto confessio- nale per passare loro suggerimenti che possano incrementare l’audience. Fingono insomma di rimuovere ogni filtro e media- zione, mentre in realtà tutto è pilotato e montato. Non essendoci più oasi non monitorate dai video, le persone sono continuamente riprese dall’occhio panottico delle teleca- mere commerciali. La nostra immagine riflessa, trasmessa sui monitor circostanti finisce per essere più importante della nostra vera presenza e identità. Alla domanda su come siano padre e figlia, protagonisti del romanzo, Covacich risponde che essi sono ripresi e trasmessi, offerti in chiaro, sgranati, saturi, un po’ schiacciati (5). Il mondo dell’immagine, responsabile dell’odier- na perdita dell’esperienza e dell’identità, è perciò scelto come meccanismo da smontare, nemico da disarmare. Anche il perso-
naggio di un altro romanzo di Covacich, Prima di sparire, non vive, ma si osserva mentre vive: guarda il display del cellulare su cui vede «[r]iflesso nel vetro […] un uomo di quarant’anni che muove frenetico il pollice sulla tastiera» (11). L’uomo gli asso- miglia in modo impressionante: «La nostra somiglianza, dopo mesi e mesi di confronti, mi fa cedere un po’ le ginocchia. Sono davvero io questo tizio che mi guarda con la bocca semiaperta?» (12) A questa domanda ne segue un’altra, al protagonista che si interroga: «Non potevo tentare di fare diversamente?», risponde
83
Hanna Serkowska
la sua immagine: «No, non potevi, mi risponde la mia faccia rifles- sa sulla vetrata» (60). Nessuno stupore se il personaggio della sto- ria immaginata da Mauro, costretto agli arresti domiciliari per la sua attività di bombarolo (il personaggio si chiama Sandro, è auto- re di reality show e al contempo bombarolo, come il protagonista di Fiona), sia convinto di dover piuttosto «scontare una pena per il lavoro che facev[a], non per le bombe che mettev[a] nei super- mercati» (120). Il lavoro che faceva, vale a dire la sua attività di artefice dell’impero dell’immagine, e la televisione insieme al suo format preferito (reality show) sono il vero crimine. Infine, in L’amore contro, quasi come nel primo racconto di Woo- binda di Nove, “Il bagnoschiuma”, una visita in casa dei genito- ri che il protagonista Sergio detesta, perché quando li va a trova- re guardano sempre la TV («osservavo i riflessi della TV sulle loro facce» 145), finisce con una lite tra padre e figlio. In con- clusione del romanzo, un’identificazione tra Adriano (l’anziano compagno di Ester, la donna amata da Sergio), seduto sul sofà a guardare la TV, e il padre di Sergio, porta il protagonista ad ucci- dere entrambi, Adriano e Ester perché: «[s]embrano mia madre e mio padre» (247). La televisione si rende colpevole anche della corsa allo scoop, alle notizie sensazionali, come vediamo nelle pagine di A perdifiato. Le puntate che vanno in diretta dalla zona calamitata, dove il cianuro ha avvelenato le acque del fiume, scompaiono alla fine della catastrofe. «La Bbc World ha smesso di occuparsi di Sze- ged. In attesa che […] accada una qualsiasi altra catastrofe ambientale, lo spazio Nature ha ritrovato la sua programmazio- ne abituale» (275). La re-azione di Covacich ai meccanismi e agli effetti della video- crazia conferma il fatto che nella sua opera non si ha dunque un ritorno alla realtà, in quanto i suoi racconti, che la guardano come ipnotizzati, non se ne sono mai allontanati e non hanno peccato di una carenza d’esperienza (osservata da La Porta, Scu- rati e Giglioli), ma invece hanno rilevato la crisi di quell’espe- rienza nel mondo e nella cultura di oggi. Anche i personaggi di Covacich non sono di carta, ma piuttosto stracciano il velo di
84
Storie di ordinarie anomalie: Mauro Covacich contro e sottosopra
quell’illusione che la sua scrittura non ha mai voluto essere, tenendo a «far scendere i lettori nella sala macchine», mettere in gioco se stesso nell’oscenità e nel dolore, far vedere le viscere pro- prie e della scrittura (Mariagiovanna Italia). Lo confermano quelle pagine in cui si presenta la magia come funzionale alla videocrazia. Nel dominio dell’immagine (teso a ingannare in vari modi, si veda L’amore contro) incontriamo un’impressionante galleria di personalità della televisione (Telesanto, Amelior) che si specializzano in questa arte di turlupinare i telespettatori, vendendo talismani e predicando il futuro in cambio di denaro. La letteratura non poteva certamente restare indifferente al for- mat dominante della nostra epoca: quello del reality show, il pro- gramma che trasforma la realtà in spettacolo, e Covacich repli- cando apparentemente quel format, ha iniziato a ispirarsi alla realtà non per spettacolarizzare il vissuto (al contrario di Walter Siti della trilogia: Scuola di nudo, Troppi paradisi, Il canto del dia- volo e Aldo Nove in La vita oscena), ma invece per distorcere e per sovvertire la finzione attraverso il coinvolgimento di se stes- so e del proprio vissuto. Mentre il reality show inganna, perché in esso la finzione si presenta come vera anche quando mente (rimuove il dolore, la depressione, la morte, il tragico dell’esi- stenza) il reality book o autofiction si prende la rivincita sulla TV di cui stravolge la filosofia e la legge, mostrando quel che non riesce a diventare spettacolo o merce. È una ‘menzogna’ che dice la verità. Quello che Covacich sembra cercare di strappare all’ir- rilevanza e alla fantasmizzazione mediatica e visiva in generale è proprio la vita. Bizzarra, caotica, accidentale o precaria che sia.
Molti romanzi, una vita
L’arma con cui la letteratura combatte il reality show è il vissuto autentico di chi scrive, in presa diretta, come sostiene Filippo La Porta. La narrativa di Covacich, che rientra nel «frastagliato arci- pelago della non-fiction» (Meno letteratura 14), nella «vasta galassia della non fiction, nebulosa dai confini incerti» (Giglioli 53), dispone infatti di molto di più rispetto all’immagine per
85
Hanna Serkowska
poter vincere la scommessa contro la televisione. La posta in gioco è il coinvolgimento dell’autore nella narrazione, come fa Covacich che mette se stesso in scena come protagonista, tradu- cendo in scrittura le proprie, autentiche esperienze. I suoi sono racconti di un fallimento (narrativo e/o affettivo), di un’oscenità (di quel che è fuori dalla scena, quindi di quel che appartiene alla vita), di un dolore. Anche gli altri personaggi di Covacich non sembrano avere lati positivi; egli ne presenta la marginalità, la stranezza (bulimia, onanismo, teledipendenza), le ossessioni (la corsa, l’ascetismo, la magrezza, il sesso, le droghe), l’impotenza o la quasi inesistenza, quando per esempio cercano, senza riuscir- vi, di sostituirsi all’altro uomo nella testa della donna amata.
In Prima di sparire «si parla, ci si espone, ci si rappresenta pro- prio a partire dal timore di non essere» (Giglioli 55-56), non per narcisismo, ma per esibizionismo finalizzato all’inseguimento della realtà. Come sostiene Giglioli, le parole paiono veridiche quando il testo rivela fatti imbarazzanti del personaggio chiama- to con lo stesso nome dell’autore (77). Mentre si raccontano le cose più meschine, vergognose, come l’errore, lo scandalo, la bugia, lo squallore, ci si espone direttamente, ci si offre come vit- tima, perché chi è sconfitto, inetto, chi subisce, appare più cre- dibile. Mettere se stesso nel ruolo di protagonista di fatti osceni e vergognosi potrebbe essere un modo di risolvere la crisi del per- sonaggio che affligge, secondo Debenedetti (19), il romanzo ita-
liano: «l’atout del vecchio personaggio di romanzo proveniva dalla possibilità o libertà di duellare, perdente o vittorioso, con- tro la minaccia delle situazioni estreme». L’autobiografismo da autofinzione deve quindi diventare il vac- cino contro il morbo della finzione (reality) diffuso dalla TV, e una delle più efficaci forme della protesta, o re-azione all’assen-
za del personaggio corposo, reale. La autofiction forgia tale per- sonaggio e comunica un senso di autenticità, seppur in forme narrative mediate, poiché i romanzi del triestino sono «costruiti con più accortezza», (Donnarumma. “Nuovi realismi” 52). Essa sottolinea la funzione soggettiva tipica delle ipermoderne scrit- ture dell’io (l’ipermodernità sarebbe la fase successiva alla post-
86
Storie di ordinarie anomalie: Mauro Covacich contro e sottosopra
modernità, v. Donnarumma. “Ipermodernità” 18-23), come reazione alla pervasiva finzionalizzazione – dominio dei media ma anche, aggiungiamo, della letteratura postmoderna. Ridurre la scrittura di Covacich a un’unica storia raccontata più volte (come, infatti, potrebbe sembrare) è quanto hanno fatto diversi altri critici, indicando la circolarità di quella scrittura come una sua tessera di riconoscimento. Vediamo tornare perso- naggi divisi tra due relazioni «in desiderata ma impossibile com- presenza», vediamo «esplorate le possibilità genitoriali dall’ado- zione all’abbandono», vari esperimenti dell’autocontrollo del corpo (Olmas 19). Il leitmotiv è la sterilità del protagonista che non sopporta che di lui resti qualcosa, le modificazioni fisiche
cui il doping sottopone il corpo, la catastrofe ecologica, l’incapa- cità della figlia adottiva di reggere all’abbandono dell’orfanotro- fio (Donnarumma. “Nuovi realismi” 52). Costanti sono: la pre- senza delle merci e dei media, la denuncia della reificazione che si manifesta con la sostituzione dell’erotismo con la pornografia, l’enfasi sul corpo e sulla materialità.
Video ergo sum? No, soffro perciò sono, e altre anomalie
Nella scrittura di Covacich il corpo è l’inizio e il limite ultimo di ogni esperienza, ed è pertanto l’unico luogo della nostra espe- rienza. Ogni affezione dunque (e la sfera delle affezioni appare molto dilatata), insieme a tutto quello che essa comporta, si ripercuote sul corpo del protagonista. Appena si parla della mente, l’attenzione si sposta subito sul «corpo che lo ospita» (Trieste sottospra 7). Il rapporto con il corpo è tuttavia irrisolto. Da una parte, visto che il protagonista afferma di essere il suo stesso corpo, di fare quello che fa e sentire quel che sente il suo corpo, si ha a dispo- sizione una sola via per rispondere alla domanda ‘chi sono’. La ricerca d’identità passa per le vie materiche, per così dire; non si conosce che con/attraverso/sul corpo. Tutto quello che il perso- naggio prova fisicamente parla quindi dello stesso disordine del mondo che colpisce il corpo – una situazione tanto più tragica
87
Hanna Serkowska
poiché non vi è, nei personaggi di Covacich, nessuna fede o spe- ranza di trascendenza, ma, semmai, un generico desiderio di essere – nella piena immanenza – un uomo migliore, o un’em- patia panteistica verso ogni forma di vita tra cui per esempio, le agavi «piante suicide» (A nome tuo 267). Per Ester, che prova un senso di nausea per le pratiche religiose, quella della benedizio- ne e della comunione è «un’altra lingua»; per Sergio la coscienza è «un’invenzione piuttosto ridicola» (L’amore contro 98, 246). Dario a sua volta confida che tutte le cose vive cominciano e finiscono, e che egli crede solo all’eternità di questo processo (A perdifiato 109). Dall’altra parte, il corpo soffre perché è umiliato dalle affezioni e spinge verso un’indefinita ricerca dell’ascesi, presente nel ten- tativo di liberarsi delle ‘tuniche di pelle’, delle passioni carnali che umiliano («Nessuna cosa […] vale quanto la pace dei sensi», Prima di sparire 43) e la castità è una forma di trascendimento della materia. Il corpo, la vita materiale, possono essere poi mar- cati anche dalla malattia, dalla imperfezione o malformazione. Immorale, infetto e sporco è il corpo giovane e sodo di Agota (A perdifiato), ma con un’esplosione di herpes sul labbro, le unghie nere e i piedi rovinati. La malattia della materia spesso si mani- festa con il vomito, con un dolore acuto come fiamme di napalm, con spasimi intestinali; con un dolore che spacca lo sto- maco, rosicchia le ossa e paralizza (32, 35, 47, 50, 54, 193). La nostra condizione è doppiamente umiliante, perché ridotta alla ‘matericità’ e perché siamo sempre – come gli astri diventati mate- ria – straziati dai desideri: «essere soggetto alle affezioni è sempre umiliante» (A nome tuo 19). L’enfasi sul corpo fatto soffrire rivela il volto spirituale e moralista di Covacich. Un perentorio assillo morale sembra caratterizzare non solo la sua opera ma, come disse nel 1930 Pietro Pancrazi, tutta la letteratura triestina (206- 207). Lo conferma Fulvio Senardi secondo cui il tormento mora- le continua a contraddistinguere questa letteratura (233). Quello che l’uomo avverte è la stanchezza unita al dolore fisico, e anche l’idea è non in testa, bensì «sparsa per il corpo, da senti- re con le mani» (Mal d’autobus 128). Il male di vivere è materi-
88
Storie di ordinarie anomalie: Mauro Covacich contro e sottosopra
co: «stai talmente male che ti pare di morire, quando il cuore ti scoppia e il male dilaga dappertutto, […] pensi che lo scricchio- lio che senti è il tuo cervello che si spacca» (Prima di sparire 57). L’attività fisica (la corsa, e più tardi il ciclismo e il nuoto), lungi dall’essere uno sport nell’accezione tradizionale, aiuta a svuotare la testa, riempiendola di fatica. Correre significa «bruciare mitocon- dri nella glassa spumosa delle cosce, spingere il miocardio sopra la soglia anaerobica, risentire l’affanno» (ivi 221). Un maratoneta pensa con il corpo che vede come un avversario: sconfiggersi è il suo chiodo fisso (A perdifiato 173), e corre perché così consuma il corpo fino quasi alla decomposizione (ivi 133). Desidera sparire per sempre, senza lasciare tracce di sé sulla terra. Nessuna discen- denza, ma sterilità e suicidio genetico (ivi 142). L’elenco delle anomalie su cui ci fa sostare lo scrittore si allunga con ogni nuova opera. All’emergenza dell’ecologismo, presente sin dall’inizio (l’attività dell’uomo nel mondo gli si ritorce con- tro, danneggia l’ambiente naturale, inquina l’acqua), si è presto unito il problema della dipendenza da varie sostanze, ma anche l’immigrazione con l’annessa xenofobia, e da ultime la vecchiaia e l’eutanasia. Il problema del suicidio assistito si lega curiosame- nte alla realtà del mondo lavorativo di oggi. Alle nuove profes- sioni (o meglio, dati gli esiti deludenti della ricerca di lavoro, le
nuove occupazioni, v. A nome tuo 203) si aggiunge quella di Angela – procuratrice della morte pietosa. Del fatto che oggi non sia lecito ‘smettere di vivere’ Covacich riesce a parlare in modo libero da toni polemici, lontano dalle ragioni dei discorsi politici o religiosi. Eppure egli mette in rilievo il diritto, quan- tunque complesso (come fa vedere il caso di Grimaldi che chie- de ad Angela di essere aiutato a morire perché semplicemente stanco di vivere), di accelerare la fine da parte di un malato ter- minale con cui «prende a giocare una morte non clemente, ma
beffarda e feroce» (A nome tuo 192-193). Essere ‘contro’ non basta, come ha dimostrato la storia di Eluana Englaro, e la società di oggi, rispetto all’antica Grecia, ha fatto un passo indie- tro. Secondo gli stoici: «la relazione tra l’uomo e l’universo è la stessa di un cane legato a un carro. […] Quando non sarà più in
89
Hanna Serkowskaautore
grado di stare al passo col carro, piuttosto che farsi trascinare nella polvere potrà gettarsi tra le ruote» (ivi 263). Tra i fenomeni e i comportamenti che Covacich ci prospetta e che sono delle anomalie dell’Italia e del mondo di oggi piuttosto recenti (di recente sovraesposizione mediatica e culturale), spic- cano – soprattutto in L’amore contro – i comportamenti sessuali patologici: l’onanismo, l’incesto, lo stupro, l’abuso sui minori. Lo zio Adriano (di fatto il cognato di Ester) ha abusato di Ester ancora in culla. La protagonista perciò «è finita a fare marchette pur di non veder[lo]» (11), e ora vive con dentro gli occhi «una crepa, uno strappo, una cicatrice a maglie larghe» (8). Il vecchio Berny, per eccitarsi, paga per sentire le registrazioni delle scene di quell’abuso (137-138). E Sergio, che a Ester pare un angelo- bambino, ha abusato anche lui della sorellina allora cinquenne fino a farla impazzire (67, 145). Ester accetta di vivere con il mostro che «si è portato via subito tutto quello che c’era di buono in [lei], prima che crescess[e]» (68), non sa respingerlo, come anni prima Angela non lo aveva denunciato e non aveva protestato contro l’abuso della sorellina. Poiché Ester non sa cosa sia l’amore, e conosce solo «il linguaggio della mano» (100), l’a- more è ridotto al suo opposto: diventa un anomalo ‘amore con- tro’. Contro la sorella, contro lo stupratore, contro se stessa. Spiega Covacich, che «l’amore non viene su sempre bene. Altre volte prende strane pieghe. Chi lo produce si spaventa. Comin- cia ad usarlo contro» (159). Amando si genera distruzione, morte, cenere, siccità (205), oppure si finge di amare. Agota di A perdifiato cerca di far credere a Dario di essere il padre di suo figlio per irretirlo; Dario cerca di convincersi di amarla perché in fuga da una difficile situazione familiare e da una moglie che smania per avere un figlio. Intrappolato, incapace di decidere se abbandonare la moglie o l’amante, il protagonista vagheggia la morte di una delle due donne (102, 112).
La famiglia, raggiunta l’ultima fase di crisi, è vista come un nucleo inutile, i bambini non nascono più, semmai vengono
90
Storie di ordinarie anomalie: Mauro Covacich contro e sottosopra
adottati dalle coppie di DINK (double income no kids), o se nascono sono affetti da malattie tremende, come la paralisi cere- brale. Covacich si sottrae alla tendenza di appesantire il raccon- to con la riflessione o renderlo dimostrativo rispetto a un’argo- mentazione o a una tesi (Donnarumma “Nuovi realismi” 52), e riesce a non scivolare nel didascalismo. Il presente diventa l’uni- co tempo a cui l’umanità naufragata appare inchiodata: «un pre- sente senza varchi di trascendenza, senza mete da raggiungere, senza utopie da realizzare» (Senardi 229). Il passato è un conto alla rovescia. “Meno settantasette, meno settantasei” si intitola- no i capitoli di L’amore contro. «Meno cinque, meno quattro…», il protagonista di Fiona conta i secondi che lo separano dal momento in cui darà un bacio alla figlia. Quando in Prima di sparire finisce il tempo della corsa, il perso- naggio al tempo stesso si separa dalla moglie Anna e smette di scrivere. Non scriverà più il romanzo sull’ex maratoneta Dario Rensich nella cui vita la corsa era già diventata un reperto da museo. La corsa, la fuga da se stesso (o la «fuga da niente e da nessuno», Trieste sottosopra 44), finisce qua; l’ex uomo-stella dovrà accettare la sua materialità, smettere di aggredire il proprio corpo, imparare ad esistere senza delegare il compito di vivere ad altri, come i viaggiatori per procura che fanno un viaggio lonta- no e forse pericoloso al posto di qualcun altro (Prima di sparire 268-270). Nelle storie di Covacich troviamo inoltre diversi disturbi ali- mentari. La magrezza è una delle ossessioni dei suoi personaggi che assoggettano il corpo a una serie di pratiche che oscillano tra l’ascetismo, l’uso di diverse sostanze chimiche (la passione per la chimica in genere), l’alimentazione sregolata, la bulimia. In L’a- more contro, Sergio, per riprendersi dal lavoro, e per tenersi sve- glio non fa altro che bere e mangiare: «Avevo finito due sacchet- ti di patatine e adesso era la volta del primo tubetto di maione- se. Lo succhiavo a tutto pugno subito dopo ogni bevuta. […] mescolavo il latte e lo sciroppo direttamente in bocca» (89). Non pago di averci nauseati con le descrizioni del regime ali- mentare di Sergio, Covacich approda a una scatologia (presente
91
Hanna Serkowska
già in Kamikaze d’occidente di Tiziano Scarpa e in I cani del nulla di Emanule Trevi) che rende la materia fecale e la relativa fun- zione una metonimia del mondo di oggi: nasciamo, viviamo e moriamo tra le feci, e questa consapevolezza stessa fa cadere tutte le illusioni. L’amore contro inizia in medias res, ovvero in mezzo agli escrementi. Nella prima scena del romanzo si riversa sul pro- tagonista il contenuto della cisterna-liquami. In questo romanzo ‘imbrattato’ molto spazio viene dato alle feci e alle funzioni fisio- logiche correlate. I rapporti umani ne risultano insudiciati: «Non è un segno, forse, che lui abbia avuto addosso la mia merda prima ancora di avere addosso me?» (68) – si domanda Ester, dopo aver fatto l’amore con Sergio. E poi, non si fa l’a- more, ma ci «si scarica» (51). Il padre del protagonista accon- sente di acquistare l’enciclopedia, accettando «di farsi risucchia- re […] nella cloaca dei pagamenti rateali» (144). Oltreché un campo semantico privilegiato, la materia fecale diventa il fonda-
mento della singolare Weltanschauung del ‘merdaiolo’ Bernet che ha «trasformato anche gli struzzi in uccelli merdosi, […] ha fatto delle fogne le proprie casseforti, […] e ritiene la merda unica fonte di lavoro inesauribile perché “finché si mangia si caga e quando non si mangia più si muore”» (88) e che confessa di cre- dere «solo alla merda che [gli] dà da mangiare» (182). Il basso pare tuttavia convocato in scena come reazione contro il mondo e i suoi mali, e non si ha qui il caso di un elogio della merda alla Rabelais – in funzione del topos del mondo a rovescia.
Un’altra Trieste
L’azione dei romanzi in disamina si svolge al Nord e Nordest. I luoghi sono: Udine, Padova, Pordenone, Milano, ma soprattut- to Trieste. A Trieste si vive, o se ne sente la mancanza, ed entram- be le situazioni sono difficili. Viverci significa dover fare i conti con il passato, un passato grandioso che mette soggezione, rac- contato da molti che hanno celebrato quel passato e contribuito a creare quella patina attempata e consunta della città-mecca Svevo-Joyce-Saba. Significa trovare un modo per liberarsi del
92
Storie di ordinarie anomalie: Mauro Covacich contro e sottosopra
topos letterario di una Trieste cosmopolita e sovranazionale che rende la città un «montaggio di citazioni» (Ara e Magris 190), per esempio capovolgendone l’immagine corrente, cercando dei luoghi o volti inediti. Per questo Filippo La Porta, quando parla di Trieste, liquida con una frase Svevo e Saba, scarta Magris e sce- glie il Covacich di Trieste sottosopra. Quindici passeggiate nella città del vento proprio perché Covacich va contro l’immagine edulcorata della città e, invece di riproporne le immagini miti- che, ne palesa un volto reale, attuale (Uno sguardo 99).
Sin da Mal d’autobus l’autore va contro le immagini malinconi-
co-sentimentali che siamo soliti attribuire alla città di scostante grazia. La sua Trieste è soprattutto un luogo di sbigottimento, ansia, tormento, ed infine esilio. Nei libri scritti dopo il 2000 comincia a prevalere il protagonista che si allontana dalla città e l’immagine rielaborata dalla memoria di una Trieste biografica:
«se siamo a Trieste e questa è casa mia» (A perdifiato 116); «[i]n quelle dune di lana vedo Trieste. Il boschetto di Basovizza, il muretto a secco dello stretching» (179). Trieste diventa più vici- na quando il protagonista parla con la moglie che vi è rimasta (217), o è imminente l’arrivo della figlia adottiva Fiona (227). Il ricordo personale idealizzante, nostalgico, determinato dalla
lontananza dalla città, è però assente in Trieste sottosopra che rap- presenta una costellazione di abbozzi dedicati ad elementi per lo più periferici, omaggio alla città che Covacich «am[a] di più al
mondo» (A perdifiato 278). Oltre ai palazzi neoclassici e ai caffè
letterari, egli fa vedere il ventre caldo della città edonistica, abi-
tata da «gente patita del corpo» (La Porta. Uno sguardo 99), gente che ama godersi la vita, uscire sul lungomare per abbronzarsi da marzo a novembre. Senza negare l’usurata doppia impronta periferica della città: di un porto remoto dell’Impero asburgico e al contempo una città italiana accerchiata dagli slavi così temuti e invisi da queste parti, Covacich è dell’avviso che il cliché non dà conto della «com- plessità della città vera» (5) e riformula la contraddittorietà della metropoli in termini odierni. Il personaggio che, a suo dire, rende meglio l’anima incongruente di Trieste, la sua ricchezza e
93
Hanna Serkowska
polimorfia, è Sissi («Ha ancora le dita affusolate della principes- sa, ma si mangia le unghie» 8), tatuata, fissata per l’esercitazione fisica e per la dieta. «Trieste è […] crogiuolo di razze, pluriglottismo e soprattutto una tradizione letteraria di grande respiro e fortemente connotata in senso europeo» (7), ma nell’opera di Covacich quello spazio non si tramuta più in un luogo simbolico interiorizzato e atto a definire la natura dei personaggi e dell’intreccio. L’autore vive e scrive con gli occhi ben puntati sul presente: è il suo vissuto, la sua Trieste, dove egli, Covacich, è cresciuto, dove la mamma lo ha portato nel parco, dove ha studiato e corso. Lo scrittore va contro la letterarietà (esal- tata da Ara e Magris secondo i quali Trieste è la sua letteratura,
15) che ha intrappolato l’immaginario senza renderne appieno l’immagine e tralasciato le componenti dell’identità triestina che non hanno mai fatto letteratura. Componenti come il fatto che Trieste è per molti versi la città più meridionale del Nord dell’Eu-
ropa, «la Napoli del Nord» (Trieste sottosopra 9), che in essa si mani- festano problemi e fenomeni di diffusione pandemica, planetaria e che ne demoliscono lo stereotipo lusinghiero. Fa parte del progetto di mettere a soqquadro le immagini pre- confezionate, di svecchiarle, anche l’idea di separare il caffè dalla letteratura. Non è dei caffè letterari che racconta Covacich
(Magris in Microcosmi ne ha scritto esaurientemente, constata Covacich), bensì del caffè stesso. Dopo essere stati ammoniti di «non prende[r]e troppo sul serio i locali che hanno nomi di scrit- tori» (29), veniamo a sapere che grazie al porto è una capitale del caffè, è notevole a Trieste non solo la quantità di modi in cui si può ordinare un caffè, ma anche uno specifico gergo o idioletto. Tale gergo, ancorché passibile di generare equivoci se confronta- to con la terminologia standard, esprime meglio l’anomalia della città che, come conclude con un punto interrogativo lo scritto- re, «è una città di scrittori perché qui si è portati a giocare sui nomi delle cose – caffè compreso – oppure qui si gioca sui nomi delle cose perché siamo in una città di scrittori?» (33). Trieste, oggi riproposta dalle autorità che si sono accorte che la cultura è un prodotto che tira, scopre il volto segnato da un
94
Storie di ordinarie anomalie: Mauro Covacich contro e sottosopra
«eclettismo kitsch della provincia occidentale», come un «parco tematico, imbellettato e gonfio di stereotipi» (64). Anche le stra- de che percorrevano Zeno e Alfonso sono tutte ristrutturate, con le facciate a tinte pastello come a Salisburgo, gelaterie e botteghe, una confezione artefatta (63). Conviene pensare invece che i luoghi, seppur memorabili, con il tempo possono cambiare fisio- nomia o destinazione d’uso. Di tale cambiamento testimonia il rione San Giovanni, l’ex ospedale psichiatrico, oggi diventato un parco di cui la città si è ‘riappropriata’: «Trieste ci è riuscita»; «ce l’ha fatta, è entrata», è riuscita a riassorbire San Giovanni, a entrare nel manicomio. Oggi vi si organizzano seminari con le testimonianze dei pazienti, degli operatori, degli ex degenti, destinati «a chi voglia capire» (55-57). Siamo portati a riflettere sul fatto che esista nella vita della città una «polifunzionalità dei luoghi» (62) del tutto casuale. Un esempio ne è la doppia vita, diurna e serale-notturna del Teatro Verdi, sugli scalini del quale di giorno si avvicendano acquirenti mitteleuropei per fare lo shopping, alla sera la vecchia borghesia triestina e qualche stu- dente melomane. Anche la Risiera di San Sabba (originariamen- te uno stabilimento per la pilatura del riso) divenne prima l’uni- co campo di sterminio in territorio italiano, successivamente un campo di prigionia per i soldati italiani catturati dopo l’8 set- tembre, poi un campo di detenzione destinato allo smistamento degli ebrei deportati in Germania e in Polonia, infine un vero e proprio campo di sterminio di partigiani e detenuti politici ita- liani, sloveni e croati. Nel cortile, dove una volta c’era il forno crematorio, oggi rimane quel che Covacich definisce una «assen- za presente che sgomenta», ovvero l’impronta della canna fuma- ria, ricalcata con lastroni di acciaio (38). Ha cambiato fisionomia anche Basovizza. Quel piccolo paese dell’altopiano carsico, noto per le foibe titine omonime, oggi è diventato di giorno una palestra naturale per la corsa e un campo di atletica, di notte «guado della speranza» (44) della gente in fuga. Teatro di un doppio turno, in virtù di quella che viene defi- nita una «sovrapposizione involontariamente oscena, qualcosa di simile ai boat people cubani sulle spiagge dei bronzei surfisti
95
Hanna Serkowska
della Florida» (44-45). Gli ultimi otto kosovari sono stati presi a ridosso del muretto dello stretching al ‘Percorso Vita’. Non più concentrata sulle contraddizioni intestine che la agita(va)no, sulla sua identità incerta, instabile, di cui tanto si è scritto, e neanche più nostalgica della nobile multietnicità della tradizione mitteleuropea, Trieste pur essendo destinata (dal corso della storia e dalla posizione geografica) «a rimanere terra di passaggio, corridoio, dove i flussi continuano a transitare, a
mescolarsi, a confligere» (41-42), non è più attenta, come una volta, alle modalità di assimilazione di ebrei, croati, sloveni, tedeschi. La Trieste di Covacich appare «vessillo della cultura laica» (22), abitata da gente dotata di «una mentalità libera da pregiudizi, tendenzialmente aperta, sempre pronta ad amare la vita senza inibizioni e falsi pudori» (23), è una città che si spac- cia per cosmopolita profittando dei tempi postideologici. Riassumendo, si avverte nella scrittura di Mauro Covacich una carica di vitalità difficilmente smorzabile, pasolinianamente ‘disperata’ in quanto resistente alla consapevolezza delle stranez- ze, patologie o anomalie emblematiche della nostra condizione di oggi. Una vitalità che ci fa cercare la spiegazione e il senso della vita proprio in queste anomalie. L’estensione della funzio-
ne soggettiva, palese nelle autofiction, unitamente al carattere performativo della scrittura che non si limita a rappresentare, ma vorrebbe fare, porre in essere (per cui il reale non è solo una fonte, ma il fine cui si tende) riescono a dare insieme nuova vita al romanzo sfibrato dagli anni del postmoderno. Le forme di attenzione al reale (il moralismo non solo triestino?) – anche se il mondo in disordine invita piuttosto al rifiuto o alla narcoles- sia – fanno vedere come nei romanzi di Covacich il vero possa essere un effetto generato dalla finzione, che sostiene il coinvol- gimento emotivo del lettore (nessuna anemia emotiva, nessun sarcasmo autodifensivo, quindi, di cui parlava Simonetti a pro- posito della letteratura contemporanea, 67), e sollecitano la responsabilità dell’artista nei confronti della realtà di oggi.
S e di moralismo si può parlare, è un moralismo di chi preferisce passare per
96
Storie di ordinarie anomalie: Mauro Covacich contro e sottosopra
scandalista piuttosto che per rigorista, passa attraverso le funzio- ni non ideologiche e fa sì che la sua opera sembri una lunga esi- bizione oltranzistica dell’immoralismo.
Opere consultate Scritti di Mauro Covacich Covacich, Mauro. Storia di pazzi e di normali. 1993. Roma - Bari: Later-
za, 2007.
––––. Colpo di Lama. Vicenza: Neri Pozza, 1995. ––––. Mal d’autobus. Milano: Tropea, 1997. ––––. Anomalie. 1998. Milano: Mondadori, 2001. ––––. La poetica dell’Unabomber. Roma - Napoli: Theoria, 1999. ––––. * A perdifiato. 2003. Einaudi: Torino, 2005 (* La pentalogia delle stelle). ––––. Safari. Pordenone: Associazione provinciale per la prosa, 2003. ––––. “La mia corsa con la fiaccola di Atene”. Corriere della sera, 24 giu-
gno 2004. 20.
––––. “Ho le vertigini da fiction”. L’Espresso, 2 (2004): 98. ––––. “La città bambina”. La qualità dell’aria. Storie di questo tempo. Eds. Nico-
la Lagioia e Christian Raimo. Roma: minimium fax, 2004. 336-341.
––––. * Fiona. Torino: Einaudi, 2005. ––––. Trieste sottosopra. Quindici passeggiate nella città del vento. Roma:
Laterza, 2006.
––––. * Prima di sparire. Torino: Einaudi, 2008. ––––. L’amore contro. Torino: Einaudi, 2009. ––––. * L’umiliazione delle stelle (video-romanzo). Roma: Fondazione
Buziol - Einaudi - Magazzino d’arte moderna, 2010.
––––. * A nome tuo. Torino: Einaudi, 2011. ––––. L’arte contemporanea spiegata a tuo marito. Roma - Bari: Laterza, 2011.
––––. L’esperimento. Torino: Einaudi, 2013.
Scritti critici su Mauro Covacich e di interesse generale Ara, Angelo e Claudio Magris. Trieste. Un’identità di frontiera. Torino:
Einaudi, 1987. Barilli, Renato. È arrivata la terza ondata. Dalla neo alla neo-neoavanguar-
dia. Torino: Testo e Immagine, 2000.
Conti, Paolo. “Io difendo la follia”. Corriere della sera, 19 settembre 1993: 21. Di Mauro, Enzo. “Il becchino e la prostituta, ovvero l’amore nel Nordest
al tempo dei mostri”, Corriere della sera, 24 febbraio 2001: 33.
Dalmas, Davide. “Onde, spiaggia, cielo”. L’Indice, 5201. 19. Chemotti, Saveria. Il “limes” e la casa degli specchi. Nuova narrativa veneta.
Padova: Il poligrafo, 1999.
97
Hanna Serkowska
Debenedetti, Giacomo. “Commemorazione provvisoria del personaggio- uomo”. Paragone letteratura, 190.10 (1965): 3-36.
Donnarumma, Raffaele. “Nuovi realismi e persistenze postmoderne: nar- ratori italiani di oggi”. Allegoria, 57 (2008): 26-54.
––––. “Esercizi di esproprio e di riappropriazione. «A nome tuo» di Cova- cich”. Arabeschi, 1 (2013). www.arabeschi.it.
––––. “Ipermodernità: ipotesi per un congedo dal postmoderno”. Allego- ria, 64 (2011): 15-50.
Giglioli, Daniele. Senza trauma. Scrittura dell’estremo e narrativa nel nuovo millennio. Macerata: Quodlibet, 2011.
Intervista a Mauro Covacich di Mariagiovanna Italia, 26 maggio 2013. Arabeschi, 1 (2013). www.arabeschi.it
La Porta, Filippo. La nuova narrativa italiana (nuova edizione ampliata). Torino: Bollati Boringhieri, 2003.
––––. L’autoreverse dell’esperienza. Torino: Bollati Boringhieri 2004. ––––. Meno letteratura, per favore! Torino: Bollati Boringhieri, 2010. ––––. Uno sguardo sulla città. Gli scrittori contemporanei e i loro luoghi.
Roma: Donzelli, 2010. Mondello, Elisabetta. In principio fu Tondelli. Letteratura, merci, televisio-
ne nella narrativa italiana degli anni Novanta. Milano: Saggiatore, 2007.
Pancrazi, Pietro. Scrittori italiani del Novecento. Bari: Laterza, 1934. Pent, Sergio. “In autobus agli inferi”. Tuttolibri. La stampa, 12 giugno
1997. Senardi, Fulvio. Gli specchi di Narciso. Aspetti della narrativa italiana di
fine millennio. Roma: Vecchiarelli, 2002.
Scarpa, Tiziano. “Su Fiona di Mauro Covacich”. Nazione indiana, 20 gen- naio 2005. http://www.nazioneindiana.com/2005/01/20/su-fiona-di- mauro-covacich
Serkowska, Hanna. “La letteratura versus la televisione: il caso di Nove e Covacich”. Cahiers d’études italiennes, 11 (2010): 215-223.
Simonetti, Gianluigi. “Sul romanzo italiano di oggi. Nuclei tematici e costanti figurali”. Contemporanea. Rivista di studi sulla letteratura e sulla comunicazione, 4 (2006): 56-81.
Scurati, Antonio. La letteratura dell’inesperienza. Scrivere romanzi al tempo della televisione. Milano: Bompiani, 2006.
Film e spettacoli Marco Bellocchio. Bella addormentata, 2012. Valeria Golino. Miele, 2013.
Il Teatro PimOff di Milano ha messo in scena la pièce A nome tuo (adat- tamento di Cinzia Spanò, regia di Roberto Recchia).
98
INTERVISTA A MAURO COVACICH di Hanna Serkowska
Hanna Serkowska. In passato il Nordest era l’ultimo avampo- sto prima della cortina di ferro, mentre ora costituisce un impor- tante corridoio commerciale tra l’Europa orientale e quella occi- dentale. Che ruolo ha avuto questo mutamento nella sua vita e nella sua scrittura?
Mauro Covacich. Sono cresciuto a Trieste, corpo vivo del Nove- cento. Negli anni Settanta si attraversava il confine per andare a fare il pieno di benzina e a comprare carne, entrambi più a buon mercato che in Italia. Fino agli anni Ottanta i fascisti irrompe- vano nelle manifestazioni studentesche a favore del bilinguismo italo-sloveno picchiando la gente. Negli anni Novanta tutto si è trasformato in una melassa informe di centri commerciali e cor- dialità di plastica, dove l’unico vero nemico è diventato la povertà. Credo che sia stato questo lo choc più grande, comin- ciare a scrivere elaborando una forma di antagonismo in un mondo senza più nemici.
Hanna Serkowska. Che rapporto c’è tra la sua scrittura in ita- liano e il sostrato linguistico veneto (o friulano) presente nel luogo in cui abita? In che modo il dialetto e altre lingue influi- scono sulla sua narrativa? Il suo cognome indica un’ascendenza croata (kovac in sloveno vuol dire ‘fabbro’)?
Mauro Covacich. Il dialetto triestino viene parlato ancora in tutte le classi sociali, spesso anche in ambienti colti, come forma di affrancamento dalla lingua nazionale. Questo attiene alla natura profondamente eccentrica della mia città. Italo Svevo e James Joyce chiacchieravano in triestino. E tutti noi triestini,
99
Hanna Serkowska
Italo Svevo compreso, abbiamo imparato la lingua italiana sui libri di scuola. Facciamo un uso minoritario, eversivo, della lin- gua maggiore, la utilizziamo come se si trattasse di una lingua straniera. Come il boemo Kafka con il tedesco, come l’irlandese Beckett con il francese. Quanto al mio cognome, non è altro che il tatuaggio della storia. Ogni triestino basta che risalga di tre generazioni per scoprirsi sloveno, o croato, o austriaco, o greco, o ungherese. In A nome tuo ho lavorato molto sul mio rapporto con il ‘rimosso’ (piuttosto che ‘ricordo’) della mia storia fami- gliare. Non a caso, il mio alter-ego nel romanzo si chiama Del Fabbro, ovvero la traduzione esatta del mio cognome.
Hanna Serkowska. Gli scrittori possono rivestire un ruolo fon- damentale nella vita politica e culturale di una regione. In che modo la sua scrittura influenza e/o riflette la realtà culturale e sociale del Nordest?
Mauro Covacich. Io mi ritengo una terminazione nervosa della società, o forse meglio, una centralina meteo. I miei libri sono attraversati dalle questioni di attualità che caratterizzano il posto in cui vivo perché so scrivere solo di ciò che conosco e di cui ho esperienza diretta, ma non mi sono mai ‘occupato’ di temi o argo- menti nel modo in cui lo farebbe un giornalista o un sociologo. Registro le onde nervose, la temperatura emotiva, elaboro dati utili (credo) estratti dalla mia vita e da quella delle persone vicine. Nei miei romanzi spesso ci si trova di fronte a una contraddizione tra l’agiatezza socioeconomica dei protagonisti e i loro dilemmi esistenziali. Gente benestante che la sera telefona alle trasmissioni televisive dei maghi per conoscere il suo futuro. Gente disperata per il proprio benessere, se così si può dire. Questo è stato il Nor- dest, almeno fino alla crisi finanziaria degli ultimissimi anni.
Hanna Serkowska. Cosa pensa di fenomeni letterari che si pon- gono come mescolanza di due generi, quali per esempio la nar- rativa e il reportage? Hanno essi in qualche modo influenzato la sua scrittura?
Mauro Covacich. Diventando sempre più impercettibile la dif- ferenza tra realtà e finzione anche nella vita quotidiana, i due
100
Intervista a Mauro Covacic
generi si mescolano da soli, senza quasi intenzione. In modo par- ticolare se si opera sul filo dell’autobiografia, che è ciò che faccio più o meno da dieci anni.
Hanna Serkowska. Il critico Gianluigi Simonetti nel saggio Sul romanzo italiano di oggi, in cui dedica molto spazio ai suoi libri, definisce cinema, televisione, pubblicità, musica di consumo, giornalismo-spettacolo «serbatoi ideologici privilegiati del romanzo d’oggi» (59), «grande codice culturale e simbolico di riferimento, deposito di immaginario intorno al quale scrittori e pubblico possono riconoscersi come una comunità» (p. 59). Potrebbe parlare delle sue fonti e dei suoi modelli letterari? Pare ispirarsi più a scrittori americani che non ai suoi connazionali (Raymond Carver, Ian McEwan, Don DeLillo). Forse l’idea di chiamare la protagonista di Prima di sparire Agota (e altrove un personaggio legge Agota Kristof ) le è venuta dalla scrittrice ungherese? Quali sono gli autori non americani nei cui confronti potrebbe aver contratto un debito?
Mauro Covacich. Come ha giustamente notato, Agota è un omaggio alla Kristof, ma la scrittrice ungherese si inserisce come ultima in un filone freddo, di ‘freddezza pietosa’, che ha in Peter Handke e Max Frisch gli esempi che più ho ammirato nella prima parte del mio percorso letterario (con Kafka all’origine di tutto). Poi nel 1991 mi sono imbattuto in Rumore bianco di Don DeLillo e la mia vita non è stata più la stessa. DeLillo è l’unico autore per il quale faccio lo sforzo di affrontare la versione origi- nale (dopo aver letto la traduzione). Ma sono tanti gli autori non americani del mio empireo, basti nominare, dei non citati: Win- fried Sebald, John Maxwell Coetzee, Goffredo Parise. Ai quali vanno aggiunti i modelli che non vengono dalla letteratura, come: Krzysztof Kieslowski, Lars von Trier, Joseph Beuys, Mari- na Abramovic.
Hanna Serkowska. Si è assistito negli ultimi due decenni a un recupero della memoria, fenomeno che ha investito, con moda- lità diverse, tutto l’Occidente. È importante il lavoro sulla memoria per la sua narrativa?
101
Hanna Serkowska
Mauro Covacich. Solo in minima parte. La mia è una scrittura decisamente più orientata al presente, fatta di percezione e pen- siero, anziché memoria.
Hanna Serkowska. Prima del cosiddetto ‘miracolo del Nordest’ la regione aveva attraversato periodi economicamente e umana- mente difficili, ma forse più umani dell’omologazione attuale. Unitamente alla memoria, vi è posto per una certa nostalgia di quel mondo nella sua scrittura?
Mauro Covacich. Detesto ogni forma nostalgica di letteratura per l’effetto troppo facilmente lirico che ottiene spesso anche con mezzi mediocri. Vagheggiare i bei tempi andati è troppo facile, è una scorciatoia. Io sono troppo interessato al baratro del presente, dal cui ciglio tento di capire cosa seguirà. Sono fiero di appartenere alla mia epoca, con tutte le contraddizioni che com- porta. È una sfida più interessante per me cercare un alfabeto con cui provare a dire il mondo odierno.
Hanna Serkowska. Eppure, non solo le storie vere rischiano di passare per fittizie, ma c’era chi sosteneva che in quello che si vede per la prima volta non vi sia nulla di vero, occorre ricor-
darlo… In Trieste sottosopra lei dice di aver letto molto Proust quando era all’università, e la realtà per Proust non si forma che nella memoria. In più, in arte, non si può riprodurre la verità, ma solo – ricorrendo alle tecniche della finzione – la percezione della verità. È d’accordo?
Mauro Covacich. Sono un proustiano di ferro, la questione della memoria ha un suo particolare legame con la scrittura. La scrittura rivela qualcosa di te che ancora non sai, in questo senso ogni esperienza del mondo diventa vera solo quando ritorna in luce metabolizzata dalla scrittura. In questo senso è la scrittura stessa a rivelarti quello che stai per dire.
Hanna Serkowska. Fino a che punto la sua ‘formazione’ filoso- fica ha influito sulle sue letture e sulla sua scrittura?
Mauro Covacich. Io appartengo a quella generazione di stu-
102
Intervista a Mauro Covacic
denti (esplosa con il pensiero debole) che ha amato quel parti- colare genere di filosofia in cui balugina una scintilla di follia, una filosofia fortemente compromessa con elementi irrazionali, la filosofia meno filosofia che ci sia. Di Deleuze ad esempio, amavo i deliri, le scorrazzate ribelli per le praterie della letteratu- ra e dell’arte, amavo il linguaggio, i corpi desideranti, i rizomi, la schizoanalisi, non il retaggio alla fin fine hegeliano della sua guerra alla dialettica. Se avessi studiato lettere non mi sarei mai messo a scrivere.
Hanna Serkowska. È lontano (almeno la sua scrittura lo pare) dalla politica? Le interessa la vita quando da privata diventa pub- blica?
Mauro Covacich. Vado a votare, sono un cittadino modello. In realtà vorrei potermene non occupare, ma come si fa? Solo negli stati modello, dove la società civile è solida e funziona, ci si può abbandonare serenamente all’indifferenza. Vivessi in Svezia o in Inghilterra, anch’io non mi interesserei di politica. Ma l’Italia è ancora a un livello precivile, è impossibile vivere distratti.
Hanna Serkowska. C’è in Prima di sparire uno stagista spaval- do di Radio Nuova Coma, con il registratore digitale, che domanda al protagonista a bruciapelo: «i libri aiutano ad abbattere le barriere o a costruirne di nuove?» (189); e Mauro, stanco, perché ha guidato per l’intera giornata sotto la pioggia, ha rispo- sto «Ad abbatterle». Avrebbe potuto invece, leggiamo più avan- ti, «spiegargli che cosa significa scrivere in un mondo dove i libri vengono proposti in maxiofferte per erigere scaffalature intelli- genti, pareti divisorie di open space, che cosa significa scrivere in un mondo dove i libri, in effetti, aiutano a costruire nuove bar- riere» (189). Ora come risponderebbe a quella domanda?
Mauro Covacich. È questo il punto: nei libri cerco proprio di togliere quel velo di ipocrisia ben pensante che copre inevitabil- mente ogni intervista. Nelle interviste cerchi la scorciatoia, spes- so vai incontro all’interlocutore – soprattutto quando si tratta di un interlocutore superficiale o impreparato – dici quello che si
103