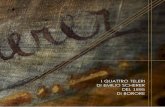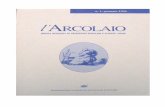Giovan Mauro della Rovere disegnatore: quattro schede varallesi, in «de Valle Sicida», XXI,...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Giovan Mauro della Rovere disegnatore: quattro schede varallesi, in «de Valle Sicida», XXI,...
Non sono un’esperta monomaniaca del più giovane dei due Della Rovere,Giovan Mauro (1575-1640)1, detto ‘il Fiammenghino’, ma una serie di incursioniall’interno della collezione grafica della Pinacoteca di Varallo Sesia mi ha permes-so d’individuare un piccolo gruppo di fogli inediti di mano del pittore che consen-tono di affinare il (vastissimo) catalogo delle prove grafiche del petit maître.
A oggi non è stata pubblicata una monografia che ripercorra integralmentele vicende dei Della Rovere: il più anziano Giovan Battista (1561 - ante 1633)2 eGiovan Mauro, ai quali le fonti documentarie affiancano un terzo fratello, Marco,il cui apporto all’interno dell’équipe risulta ancor più difficile da mettere a fuoco.
La responsabilità di questa sorta di oblio è forse in parte attribuibile al giu-dizio formulato da Luigi Lanzi che sull’ultimo scorcio del Settecento, nella suaStoria pittorica dell’Italia (1795-1796), li definisce «scorretti ma spiritosi». I duehanno conosciuto una rivalutazione critica solo a partire dal 1950, anno in cui Mi-na Gregori nel ripercorrere I ricordi figurativi del Manzoni – Sacro Monte di Ortain testa – non mancherà di segnalare la «scioltezza di racconto» propria dei Del-la Rovere, alleviandone almeno in parte la secolare nomea3.
Tra i tanti fogli attribuiti a questa coppia di disegnatori straordinariamenteprolifici – che Nancy Ward Neilson ha opportunamente definito «tireless», infati-cabili4, e che si rendono protagonisti di una fortunata carriera che tra fine Cin-que e inizio Seicento coinvolge Milano e «raggiunge tutti i territori lombardi»5 –molti sono ancora in attesa di essere riconosciuti come preparatori per una qual-che impresa tra le numerose portate a termine.
È il caso di due studi oggi al Metropolitan Museum di New York (inv. n.50.65.22-50.65.23; fig. 1, 2)6, raffiguranti alcuni Putti, e che un tempo vantava-
115
Elena Rame
Giovan Mauro Della Rovere disegnatore:quattro schede varallesi*
* Questo articolo è frutto delle ricerche effettuate in occasione della mia tesi di laurea (I disegnipiù antichi della Pinacoteca di Varallo, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filo-sofia, a.a. 2007-2008, relatore Giovanni Agosti) e durante la redazione del volume Arti figurativein Valsesia. I disegni della Pinacoteca di Varallo, a cura di Carla Falcone, Candelo 2008. Vi sonoinoltre registrate alcune idee emerse durante la schedatura dei disegni della collezione – ancoraampiamente in fieri – eseguita con Donata Minonzio e Paola Angeleri. Ringrazio Giovanni Agosti,Rossana Sacchi, Jacopo Stoppa e Carla Falcone, sulla cui più totale disponibilità ho potuto con-tare oggi come in passato.
no un’attribuzione, decisamente lusinghiera, in direzione di Polidoro da Caravag-gio, attestata dalla scritta di mano antica vergata sui passepartout. Penso che idue studi – che a partire dal 1965 grazie ad alcune illuminanti riflessioni di PhilipPouncey sono stati restituiti a Giovan Mauro – andrebbero collegati all’impresadecorativa per la chiesa di San Pietro al Rosario a Novara, commissionata al pit-tore nel 1630, vera e propria «supplica cittadina»7 voluta per scongiurare la pe-ste; in particolare si tratterebbe dei bozzetti relativi ai due scomparti eseguiti sul-l’intradosso dell’arco trionfale.
Va inoltre segnalato che un disegno conservato presso il British Museum diLondra (inv. n. SL,5226.16; fig. 3) – un tempo parte della collezione di Sir HansSloane8 – è da ritenersi preparatorio per una delle scene che ornano le paretidella terza cappella del Sacro Monte di Orta, personalmente commissionata daCarlo Bascapè, «che ne seguì assiduamente i lavori, prodigo di istruzioni e con-sigli»9. La cappella – «che rappresenta il vescovo di Assisi mentre il patrocinio etutela si prese del santo, nella general rinuncia ch’egli fece dei beni paterni»10 –conosce un monitoraggio capillare da parte del vicario, che nelle proprie letterenon manca di segnalare ciò «che sono obbligati a fare i pittori Fiamenghini»11.
Dei suggerimenti relativi a questa porzione di affresco però pare non soprav-viva alcun ricordo preciso nelle missive del Bascapè, già ampiamente indagate
da Elena De Filippis all’inizio degli anni No-vanta del secolo scorso12. Sarebbe statocurioso poter ripercorrere una qualche indi-cazione (certamente ineludibile), fornita dalcommittente ai due fratelli circa il fondalearchitettonico classicheggiante presentenel foglio londinese, che nella redazione fi-nale lascia invece spazio a una chiesa –quella di San Damiano – in rovina, ingab-biata nei ponteggi e alla quale si aggrappauna carrucola (fig. 4).
Il confronto tra questo foglio e l’opera fi-nita aiuta inoltre a mettere in luce un ulterio-re aspetto dell’attività dei due fratelli: esisteun indiscutibile scarto qualitativo tra la viva-cità e lo sperimentalismo dei disegni e leopere dipinte, decisamente più cristallizzate,contraddistinte da maggiore pacatezza.
L’esordio di Giovan Mauro – almenostando ai documenti sopravvissuti fino a noi– pare sia avvenuto a Varallo, a fianco deifratelli, nel cantiere della ‘Nuova Gerusa-lemme’. La presenza dell’équipe presso ilSacro Monte si scala tra il 1588 ed il 1590,ed è scandita dall’esecuzione delle cappel-
116 Elena Rame
Figg. 1-2 - Giovan Mauro Della Rove-re, Putti, New York, Metropolitan Mu-seum of Art (© Foto Archivio Scala)
le dell’Ingresso di Cristo in Gerusalemme (XIX)13 e della Strage degli Innocenti(XI). Un nucleo di bozzetti, sparsi tra gli Uffizi (inv. n. 7278 F)14, il British Museumdi Londra (inv. n. 248-5214; fig. 5), il Louvre di Parigi (inv. n. 11280) e il Metropo-litan Museum di New York (inv. n. 63.149), ci aiuta a ricostruire le fasi progettua-li e l’attenta regia che hanno condotto all’esecuzione di quest’ultima impresa,commissionata dal Duca di Savoia Carlo Emanuele I15. Con prudenza si potreb-be ipotizzare che possa essere proprio l’attività dei Della Rovere presso il SacroMonte, l’iniziale contatto con l’ambiente valsesiano, a rendere ragione della pre-senza di un primo foglio: un Santo Stefano in cui, adottando quel «tratto estrema-mente rapido» utilizzato per «composizioni schizzate con vivace prontezza e bre-vità»16, Giovan Mauro mostra d’utilizzare soluzioni che sono in stretta dipenden-za dallo stile grafico di Giovan Battista, facilmente rintracciabile in studi quali laVittoria di Costantino oggi al Nationalmuseum di Stoccolma (inv. n. NM A2/1978)17, nell’affollato bozzetto raffigurante la Processione di San Carlo conser-vato all’Ambrosiana di Milano (inv. n. Cod. F 235 Inf. 1012)18, o, ancora, nel Mi-racolo del paralitico, parte dello sterminato fondo San Celso, ora presso il Gabi-netto dei Disegni del Castello di Milano (inv. n. 1075/5 B 395/3)19.
117Giovan Mauro Della Rovere disegnatore: quattro schede varallesi
Fig. 3 - Giovan Battista Della Rovere, San Francesco e un religioso, Londra, British Museum
Fig. 4 - Giovan Battista e Giovan Mauro Della Rovere, San Francesco presta la propria operaper il restauro della chiesa di San Damiano, Orta San Giulio, Sacro Monte di San Francesco,cappella III (foto G. Rame)
118 Elena Rame
Fig. 5 - Giovan Battista Della Rovere, La strage degli innocenti, Londra, British Museum
Fig. 6 - GiovanMauro Della Rovere,Santo Stefano,Varallo, Pinacoteca
Fig. 7 - GiovanMauro Della Rovere,Santo Stefano(verso), Varallo,Pinacoteca
Il foglio (inv. n. 1112; 214 x 102 mm; tracce di matita nera, penna, acquerel-lo seppia su carta beige; fig. 6) è citato negli inventari più antichi quale opera delMorazzone20, e come tale è ricordato nei tardi anni Cinquanta del secolo scorsoin un articolo dedicato al Mazzucchelli da Marco Rosci, che lo pone in relazioneal San Lorenzo diacono affrescato dal pittore varesino nella cappella di San Roc-co all’interno della collegiata di San Bartolomeo a Borgomanero21. Poco dopo,sarà lo stesso Rosci a ricredersi, e ad assegnare il Santo Stefano ad un anonimoartista genovese della seconda metà del sedicesimo secolo22. Le convinzioni at-tributive dello studioso sono state riprese e ribadite in tempi più recenti da Ste-fania Stefani Perrone all’interno dell’ultimo inventario delle collezioni23.
L’attribuzione in questo caso è agevolata dalla consuetudine, già adottatadal fratello maggiore Giovan Battista e precocemente resa nota da Philip Poun-cey24: il pittore sigla il verso del foglio con le proprie iniziali e la data d’esecuzio-ne (fig. 7). Tale prassi – di «ascendenza nordica e in particolare fiamminga»25 –consente di seguire da vicino e, nei casi più fortunati, ripercorrere ad annum l’in-tensa attività artistica dell’équipe, soprattutto nei due decenni a cavallo tra Cin-que e Seicento, e rende questo foglio un punto fermo nella cronologia di Gio-van Mauro. Il Santo Stefano conservato a Varallo – siglato sul verso «J M R 1593[…]» – risulta essere tra i disegni più antichi di mano del nostro finora rinvenutinelle raccolte: allo stesso periodo risale un numero limitatissimo di fogli, quali loSchizzo di decorazione parietale del Museo Puskin di Mosca (inv. n. 13398), si-glato «J M R 1593 Nov»26, e Le Marie al Sepolcro della Staatliche GraphischeSammlung di Monaco di Baviera (inv. n. 1929:40), di poco più tardo, marcato sulverso «J.M.R. 1594 magio»27. Purtroppo, l’iscrizione è pervenuta mutila, ed èquindi impossibile stabilire se si collochi appena prima o in coda rispetto al fo-glio moscovita.
Questo modello, messo a punto nella prima fase della carriera, non manche-rà di riaffiorare qualche anno più tardi, come dimostra l’innegabile somiglianzache lega la figura varallese al San Lorenzo presente nell’imponente Madonna conBambino e Santi licenziata dal pittore per la parrocchiale di Campello Monti28.
Il disegno rappresenta inoltre un’esemplare sintesi del vivace panorama col-lezionistico locale che ha contribuito a creare quella «trama di rapporti, scritturee sovrascritture»29 che sta alla base del ‘tesoro grafico’ valsesiano. Si tratta infat-ti di un’opera certamente inclusa nella collezione del pittore Lorenzo Peracino(1710-1789), una parte della quale è transitata nella seconda metà degli anni Set-tanta sul mercato antiquario milanese, presso la Galleria “La Portantina”, che inoccasione della vendita aveva dato alle stampe un catalogo, ormai difficilmentereperibile.
Il volumetto, alla cui redazione ha collaborato Giovanni Testori, raccoglievauna trentina di disegni, venticinque dei quali certamente appartenuti a Lorenzoed ai suoi discendenti30. Oltre alle consuete derivazioni ispirate alle cappelle delSacro Monte, vi erano compresi anche progetti di mano del pittore (e plastica-tore) di Cellio, quali la Vergine parte di uno dei gruppi scultorei approntati per ilSantuario del Varallino di Galliate31. Della quasi totalità delle opere s’ignora l’u-
119Giovan Mauro Della Rovere disegnatore: quattro schede varallesi
bicazione attuale, ma è curioso segnalare che uno Studio di uomo inginocchiato– forse un confratello – incluso nel fondo e allora assegnato alla scuola del Cera-no sia approdato, dopo un passaggio sul mercato antiquario bostoniano, al J.Paul Getty Museum di Los Angeles (inv. n. 83.GB.268), e sia stato pubblicato nelcatalogo delle collezioni di disegni europei, con un’attribuzione fuorviante all’o-landese Pieter Lastman (1583-1633)32.
La firma apposta sul verso del Santo Stefano – che recita «di Lorenzo P co-sta soldi 2» – è senza dubbio da attribuirsi all’artista, che manifesta a più ripre-
se l’abitudine di lasciare una qualchetraccia, spesso anche della spesa affron-tata, su fogli e libri di sua proprietà: neè un esempio il frontespizio di un’edizio-ne della Vita di San Filippo Neri, da luiacquistata a Roma e oggi custodita dadon Angelo Porzio, parroco di Cellio33.Il Santo Stefano che nel 1783 il pittoreaffresca sulla volta della sacrestia nellachiesa parrocchiale del proprio paesed’origine, un pochino arcaicizzante, èfortemente debitore nei confronti delfoglio di Giovan Mauro, certamente uti-lizzato come fonte d’ispirazione.
Un terzo, fondamentale passaggiodella ‘catena di trasmissione’ dell’opera èvisibile sul recto, ove Giuseppe Avondo(1801-1878) ribadisce di essere proprie-tario del foglio.
L’idea che oggi possiamo farci dellacollezione Avondo è interamente affida-ta al «Cofano di lamiera contenente 317disegni a penna» che nel 1915 Bartolo-meo (1833-1916), ultimo discendentedella dinastia di pittori ed erede dellostraordinario patrimonio grafico di fami-
glia, donerà alla Società per la Conservazione delle Opere d’Arte e dei Monu-menti in Valsesia34.
Il nucleo di fogli donati – cui fece seguito una seconda tranche di «altri 36 di-segni attribuiti al Tanzio»35 – contribuisce a fornirci un’istantanea parziale dellasituazione delle presenze all’interno del fondo, e a delineare solo in parte le pas-sioni collezionistiche coltivate da intere generazioni.
La raccolta doveva certamente essere più estesa e complessa di quantonon si riesca a ricostruire oggi, se è vero che la famiglia viene ricordata dallefonti anche in veste di mercanti di stampe36. Tale tassello è sufficiente a ren-der conto della presenza delle trentacinque xilografie de La Piccola Passione
120 Elena Rame
Fig. 8 - Giuseppe Antonio o LorenzoAvondo, Imposizione del nome delBattista, Varallo, Pinacoteca (ArchivioE20Progetti, ph. Fabrizio Lava)
di Albrecht Dürer, do-nate dagli eredi di Bar-tolomeo nel 1919 37,ma a mio avviso contri-buisce anche a spiegareperché l’affresco dellaparrocchiale di Alagna(1843) – raffigurantel’Imposizione del nomedel Battista ed eseguitoda Giuseppe Antonio eLorenzo Avondo – siauna fedele ripresa dellascena affrescata da An-drea del Sarto nel 1526sulle pareti del Chiostrodello Scalzo a Firenze.Dopo aver studiato da vicino il ‘primo pensiero’ per la porzione destra dellacomposizione, oggi conservato in pinacoteca (non inventariato; fig. 8), ed es-
sermi soffermata sul panneggio della ve-ste della figura, così accartocciato e rigi-do, ritengo plausibile che l’ispirazionenon sia da far risalire direttamente allascena affrescata, quanto piuttosto adun’incisione tratta dalla stessa 38. Unesemplare che non doveva essere poimolto diverso da quello posseduto dal-l’Archivio di Stato di Novara, copia d’a-près incisa sull’ultimo scorcio del Sette-cento da Camillo Tinti39 (fig. 9).
Un’affinità dal punto di vista tecnico èrintracciabile tra il Santo Stefano ed unsecondo bozzetto inedito raffigurante laDisputa di Gesù fra i Dottori nel Tempio(inv. n. 1113; 222 x 142 mm; tracce di ma-tita, penna, acquerello seppia su cartaocra chiaro; fig. 10). Il foglio – che ha co-nosciuto una fortuna critica davvero limi-tata – si riconosce all’interno di uno degliinventari compilati da Emilio Contini all’i-nizio degli anni Quaranta del secolo scor-so, in un gruppo di quattro disegni credu-ti del Morazzone40. Il numero tracciato apenna in alto a sinistra è forse attribuibile
121Giovan Mauro Della Rovere disegnatore: quattro schede varallesi
Fig. 9 - Camillo Tinti, Imposizione del nome del Battista(da Andrea del Sarto), incisione, Novara, Archivio di Stato
Fig. 10 - Giovan Mauro Della Rovere,Disputa di Gesù fra i Dottori nel Tem-pio, Varallo, Pinacoteca
proprio al primo conservatore della pinacoteca, a causa della «grafia minutaconfrontabile ad esempio con l’Inventario del 1941»41. Della Disputa sembranon vi sia traccia nelle fonti successive, se non nell’ultimo inventario delle col-lezioni compilato da Stefania Stefani Perrone, che segnala il foglio e lo asse-gna ad un anonimo del XVII secolo42.
Sul verso non è rintracciabile il tradizionale monogramma – forse andato per-duto con la controfondatura cui è stato sottoposto il foglio durante i restauri deiprimi anni Settanta – ma l’attribuzione è confortata dai dati di stile: si tratta diun’opera che mostra un’ineludibile somiglianza con lo scomparto centrale di un‘trittico’ di mano di Giovan Mauro conservato all’Ambrosiana di Milano (inv. n. F253 inf. N. 1249b; fig. 11)43, cui sono stati collegati altri due fogli (Milano, Ambro-siana, inv. n. F 253 inf. N. 1249b, ed il secondo presso l’Accademia Carrara diBergamo, inv. n. 2389/90), del tutto simili per dimensioni e tecnica, caratterizza-ti dal segno abbreviato, stenografico, che ancora una volta ricorda le soluzionimesse a punto dal fratello maggiore. Le varianti rilevate tra il foglio varallese e laDisputa dell’Ambrosiana sono davvero minime: cambiano leggermente le posedei Dottori, e il fondale architettonico ha un’impaginazione più compiuta ed ela-borata. Il disegno della Pinacoteca è inoltre di dimensioni maggiori, e si presen-ta come opera a sé.
La datazione proposta da Giulio Bora per il ‘trittico’ dell’Ambrosiana sembraessere pertinente anche per l’esemplare conservato a Varallo: si tratterebbe diun’opera ascrivibile alla maturità dell’artista, tra la fine del secondo e del terzodecennio del Seicento.
La circolazione d’idee all’interno dell’équipe è verificabile anche in questocaso, grazie a un foglio transitato nei primi anni Novanta sul mercato antiquarioparigino: si tratta di una Disputa eseguita da Giovan Battista e monogrammata
122 Elena Rame
Fig. 11 - Giovan Mauro Della Rovere, Circoncisione, Disputa di Gesù fra i Dottori nel Tempio,Orazione nell’orto, Milano, Pinacoteca Ambrosiana
«JBR 1591» (ubicazione ignota, già Parigi,Galerie Delvaille; fig. 12), che sembra davve-ro essere il modello cui il disegno varallese èispirato.
Un secondo nucleo di fogli presenti incollezione dimostra l’adozione da parte diGiovan Mauro di quella «tecnica a dense ac-querellature di biacca e seppia su carta scu-ra» (spesso cerulea), utilizzata sovente dal pit-tore sulla scorta dell’esempio fornito decen-ni prima da Bramantino e da Gaudenzio Fer-rari, e mai venuto meno nella tradizione lom-barda successiva44.
Un foglio raffigurante La visione dei set-te candelabri d’oro (inv. n. 1806; 275 x 270mm; tracce di matita nera, penna, acquerelloseppia e biacca su carta grigio-azzurra; fig.13), proveniente dalla collezione Avondo, èsegnalato dagli inventari più antichi come dimano del Morazzone45. Tale attribuzione èstata rivista da Stefania Stefani Perrone, chenell’inventario del 1987 preferisce assegnar-lo ad un anonimo del XVIII secolo46. La sigla apposta a inchiostro nero sul ver-so, che recita «GMR 1609 Magio», ci permette di attribuire con certezza il dise-gno e di collocarlo in un periodo non lontano dalle prime imprese per il Sacro
Monte di Orta (1607-1608) e daquelle per Gravedona (1608). Lascena rappresenta la visione narra-ta nel primo capitolo dell’Apocalis-se dall’apostolo Giovanni (Ap, I, 1-17), in esilio sull’isola di Patmos ericonoscibile nella figura stesa aterra. L’impaginazione è fortemen-te debitrice nei confronti di unadelle tavole incluse nella serie DieApokalypse, incisa ed edita da Al-brecht Dürer nel 1498, che insiemealle altre opere dell’artista tedescoandrà a costituire un repertorio distraordinaria fortuna nell’Europa diCinque e Seicento47.
Un secondo foglio è accostabi-le a questa Visione, sia per sceltestilistiche che per il registro teatra-
123Giovan Mauro Della Rovere disegnatore: quattro schede varallesi
Fig. 12 - Giovan Battista Della Ro-vere, Disputa di Gesù fra i Dotto-ri nel Tempio, ubicazione ignota(già Parigi, mercato antiquario)
Fig. 13 - Giovan Mauro Della Rovere, Visionedei sette candelabri d’oro, Varallo, Pinacoteca
le che contraddistingue la scena: si tratta di un’Orazione nell’orto (inv. n. 1804;234 x 405 mm; tracce di matita nera, penna, inchiostro seppia e acquerello sep-pia, biacca su carta grigio azzurra, quadrettata a matita nera; fig. 14), un pochinosofferente, che ha conosciuto una fortuna critica davvero limitata.
Probabilmente il disegno, al momento dell’ingresso in collezione, è erro-neamente attribuito al Morazzone, e come tale viene ricordato negli inventaricompilati da Emilio Contini tra gli anni Quaranta e Cinquanta del secolo scor-so48. Un primo ripensamento circa la paternità del foglio è formulato da Mar-co Rosci nelle Schede non datate, ma da lui redatte sul primissimo scorcio de-gli anni Sessanta, in concomitanza con i lavori per il nuovo catalogo delle col-lezioni: prendendo le distanze dall’antica attribuzione, egli propone – non sen-za qualche perplessità – i nomi del fiammingo naturalizzato valsesiano Giovan-ni Antonio De Groot o di Cristoforo Martinolio detto ‘il Rocca’49. Più cauta lapresa di posizione di Stefania Stefani Perrone50 che, a quasi trent’anni di di-stanza, nel redigere l’ultimo inventario delle collezioni segnala il foglio e lo as-segna ad un anonimo del XVII secolo.
In realtà si tratta di un’opera attribuibile con un buon margine di certezza aGiovan Mauro. L’Orazione nell’orto è un bozzetto molto rifinito, per il quale nonsono stata purtroppo in grado di rintracciare un corrispondente pittorico, e che,per certi versi, rappresenta un esempio meno fortunato rispetto ad altri fogli dimano del pittore pervenuti in collezione, siglati e datati; in questo caso l’attribu-zione è confortata unicamente dai dati di stile. Uno studio che mostra innegabi-li punti di contatto con quello della Pinacoteca è il gruppo di Angeli musicanticonservato presso le Gallerie dell’Accademia di Venezia (inv. n. 790), segnalatoda Giulio Bora51, e in un secondo tempo da Ugo Ruggeri52, messo in relazione
124 Elena Rame
Fig. 14 - Giovan Mauro Della Rovere, Orazione nell’orto, Varallo, Pinacoteca
con gli affreschi che Giovan Mauro esegue nella Basilica del Sacro Monte di Va-rese nel 1637. Gli angeli che popolano il foglio dell’Accademia sono accomuna-ti al Cristo varallese dall’espressione un pochino sbigottita e dalle dita affusolatee nodose, come pure dalla cura estrema nella resa dei particolari, ottenuta gra-zie alle lumeggiature a biacca che garantiscono una modulazione davvero impec-cabile di luci ed ombre.
Una tecnica che peraltro il Della Rovere utilizza anche in numerosissimi al-tri fogli, quali l’Allegoria di Roma e l’Interno di una taverna, oggi entrambi alNationalmuseum di Stoccolma (inv. n. NM 1310/1863, NM 2224/1863)53; o, an-cora, nelle due figure maschili – forse identificabili con David e Saul – conser-vate presso il Musée des Beaux-Arts di Orléans (inv. n. 1557.B), di «datazionepiuttosto tarda»54.
Vi sarebbero dunque elementi sufficienti ad assegnare il foglio ad un qual-che momento compreso tra gli anni Venti e Trenta del Seicento, periodo che ve-de Giovan Mauro sempre più coinvolto in numerose «imprese autonome di nar-ratore di talento»55 a Milano e nell’alto Lario, nel Bresciano e nel Varesotto.
Note1 L. Caviglioli, ad vocem della Rovere, Giovan Mauro, in Dizionario Biografico degli Ita-
liani, Roma 1989, vol. XXXVII, pp. 343-347.2 Idem, ad vocem della Rovere, Giovan Mauro, in Dizionario… 1989, vol. XXXVII, pp.
340-342.3 La vicenda critica qui brevemente delineata è stata ripercorsa in maniera più compiu-
ta da F. M. Ferro, Uno sconosciuto ciclo di teleri: la storia di San Gaudenzio vescovo diNovara per la regia del Fiammenghino, in “Paragone”, XXII (1971), 261, pp. 3-14. Il te-sto è stato ripubblicato di recente – a cura dello stesso autore ed arricchito di alcuniaggiornamenti bibliografici – nel volume L’anima dipinta. Scritti d’arte lombarda e pie-montese da Gaudenzio Ferrari a Ranzoni, Novara 2010, pp. 138-147.
4 N. Ward Neilson, Disegni lombardi secenteschi dell’Accademia Carrara di Bergamo byUgo Ruggeri, in “Master drawings”, XIV, 3 (1976), p. 312.
5 M. Dell’Omo - F. M. Ferro, Pittura del Sei e Settecento nel Novarese, Novara 1996, p.124.
6 J. Bean - L. Turcic, 15th and 16th century Italian Drawings in the Metropolitan Museumof Art, New York 1982, p. 232, n. 232-233.
7 M. Perotti, Millenaria presenza di un luogo di culto, in San Pietro al Rosario in Novara,a cura di A. M. Malosso, M. Perotti, Novara 1998, pp. 29-31.
8 Il foglio – mai pubblicato a stampa – è comunque presente nell’inventario informatiz-zato del British Museum, con la corretta attribuzione a Giovan Battista Della Rovere.Ringrazio il Curatore del Department of Prints and Drawings, Hugo Chapman, per l’en-tusiasmo dimostrato verso gli esiti delle mie ricerche e la disponibilità nel fornirmi l’im-magine che qui pubblico.
9 E. De Filippis - F. Mattioli Carcano, Guida al Sacro Monte di Orta, Omegna 2001, pp.17-19.
125Giovan Mauro Della Rovere disegnatore: quattro schede varallesi
10 I. Chiesa, Vita di Carlo Bascapè Barnabita e vescovo di Novara (1550-1615), a cura diS. Pagano, Firenze 1993, p. 352.
11 C. Bascapè, Lettere episcopali, vol. XXV, n. 20. La lettera citata – consultata trami-te la copia dattiloscritta presente presso l’Archivio Storico Diocesano di Novara –fu inviata il 22 giugno del 1603 dal vescovo al Castellano dell’Isola di San Giulio.Ringrazio don Mario Perotti per la consulenza prestata durante la consultazione delvolume.
12 E. De Filippis, Il vescovo Bascapè e il Sacro Monte di Orta, in Sacri Monti. Devozione,arte e cultura della Controriforma, a cura di L. Vaccaro, F. Riccardi, Milano 1992, pp.385-395; Eadem, Alcuni episodi artistici della committenza artistica del vescovo CarloBascapè, in “Barnabiti Studi”, X (1994), pp. 247-268.
13 La cappella relativa all’Ingresso di Cristo in Gerusalemme da alcuni è stata attribuita aGian Giacomo Testa (cfr. S. Stefani Perrone, Guida al Sacro Monte di Varallo, Torino1995, pp. 54-55). Si veda, da ultimo, E. De Filippis, Guida del Sacro Monte di Varallo,Borgosesia 2009, pp. 78-79.
14 Per i fogli conservati agli Uffizi si veda G. Agosti, Testori a Varallo, in Testori a Varallo.Sacro Monte, Santa Maria delle Grazie, Pinacoteca e Roccapietra, Cinisello Balsamo2005, p. 158.
15 E. De Filippis, Guida…, 2009, pp. 60-61. Per un’indicazione circa la bibliografia com-plessiva relativa ai fogli citati si veda C. Falcone, Per uno studio delle collezioni grafichedella Pinacoteca di Varallo, in Arti figurative in Valsesia. I disegni della Pinacoteca diVarallo, a cura di C. Falcone, Candelo 2008, p. 15.
16 G. Bora, in Giovanni Morelli collezionista di disegni. La donazione al Castello Sforze-sco, catalogo della mostra (Milano, 8 novembre 1994 - 8 gennaio 1995), a cura di G.Bora, Cinisello Balsamo 1994, p. 138, n. III.35.
17 P. Bjurstr ´om, Drawings in Swedish Public Collections. III. Italian Drawings. Venice, Bre-scia, Parma, Milan, Genoa, Stoccolma 1979, p. n. n., n. 288.
18 G. Bora, Disegni di figura, in Il Seicento lombardo. Catalogo dei disegni, libri, stampe,catalogo della mostra, Milano 1973, vol. III, p. 33, n. 138.
19 Ringrazio Francesca Rossi e Maria Rita D’Amato per l’aiuto fornito durante le mie ri-cerche in merito al Fondo San Celso, tuttora in svolgimento.
20 sASV, Società di Conservazione, Catalogo della Pinacoteca compilato da Emilio Con-tini, Ottobre-Novembre 1941-XX, m. 1, p. 29, n. 32; sASV, Società di Conservazione,[E. Contini], Pinacoteca di Varallo. Inventario 1 ottobre 1957, m. 1, sala 2, n. 26.
21 M. Rosci, Contributi al Morazzone, in “Bollettino d’arte”, XLIV (1959), 1, pp. 151-157.22 M. Rosci, Pinacoteca di Varallo Sesia, Varallo Sesia 1960, pp. 136-137, n. 127; sASV, So-
cietà di Conservazione, Schede delle opere d’arte conservate presso la Pinacoteca diVarallo, s.d. (ma post 1960), n. 258.
23 ASC, S. Stefani Perrone, Inventario della Pinacoteca di Varallo, Varallo 1987, p. 113, n.1112.
24 P. Pouncey, I disegni italiani della Biblioteca Reale di Torino, in “The Burlington Maga-zine”, CI (1959), p. 297. In tempi più recenti l’intervento è stato pubblicato nel volumePhilip Pouncey. Raccolta di scritti (1937-1985), a cura di M. Di Giampaolo, Rimini 1994,pp. 263-265.
25 G. Bora, in Giovanni Morelli …, 1994, pp. 137-138, n. III.35.
126 Elena Rame
26 M. Maiskaja, I grandi disegni italiani del Museo Pusˇ kin di Mosca, Milano 1986, p. n. n.,n. 32.
27 G. Bora, Disegni …, 1973, p. 34, n. 144.28 M. Dell’Omo - F. M. Ferro, Pittura …, 1996, p. n. n., tav. 48.29 G. Testori, Palinsesto valsesiano, Milano 1964, p. 8. 30 Trenta disegni di antichi maestri. Con una nota di Giovanni Testori, catalogo della mo-
stra (Galleria La Portantina, 18 dicembre 1976 - 9 gennaio 1977), Milano 1976. La col-lezione è stata segnalata di recente anche da Giulia Lazzari in G. Lazzari, Pier France-sco Gianoli ai Sacri Monti di Varallo e Orta. Studi preparatori per gli affreschi della cap-pella di Gesù Ricondotto a Pilato e dell’oratorio dell’Addolorata, in “Sacri Monti”, II(2010); in particolare pp. 82-84.
31 Un foglio raffigurante l’Educazione della Vergine conservato in Pinacoteca (inv. n.1764) mostra una somiglianza profonda con i disegni del Peracino, e lascia suppor-re che altre prove grafiche di mano del pittore siano approdate nella raccolta va-rallese.
32 G. R. Goldner, European Drawings. I. Catalogue of the Collections, Malibu 1988, pp.246-247, n. 109.
33 La foto del frontespizio è riprodotta in S. Brustio, Lorenzo Peracino (1710-1789): pitto-re, scultore e architetto valsesiano. Catalogo delle opere, tesi di laurea, Università de-gli Studi di Parma, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 2001-2002, relatore A. Mazza, pp.17-18, 277.
34 sASV, Società di Conservazione delle Opere d’Arte e dei Monumenti in Valsesia, Inven-tario Generale della Pinacoteca compilato dal Canonico GIULIO ROMERIO per l’Assi-curazione contro gli incendi, s.d. [ma 1914-1915], m. 1. La donazione è stata indagatada M. Maestroni, Il Lascito Avondo nella Pinacoteca di Varallo Sesia, dissertazione fina-le, Università degli studi di Torino, Facoltà di Scienze della Formazione, relatore G. C.Sciolla, a.a. 2003-2004.
35 S. Stefani Perrone, La collezione grafica della Pinacoteca. Lineamenti per una storia deldisegno in Valsesia, in Pinacoteca di Varallo. Disegni e corali miniati. Contributo peruno studio dei materiali, catalogo della mostra (Varallo, 22-23 marzo 1997), a cura di S.Stefani Perrone, Borgosesia 1997, p.15.
36 M. Rosci, Nota sui disegni della Pinacoteca di Varallo, in Borsetti e gli Orgiazzi. Deco-razione rococò in Valsesia, a cura di M. Rosci e S. Stefani Perrone, Borgosesia 1983,pp. 95-96.
37 M. Maestroni, Il Lascito Avondo …, 2003-2004, p. 13. 38 Per le vicende legate all’impresa si veda, da ultimo, A. O’Brien, Andrea del Sarto and
the Compagnia dello Scalzo, in “Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Flo-renz”, 48 (2005), pp. 258-267.
39 ASNO, Fondo Stampe Prandina, inv. 80, cass. 1, b. 3. Ringrazio lMaria Marcella Valla-scas e Susanna Borlandelli per avermi permesso di conoscere e di pubblicare questoesemplare presente nel «nucleo di oltre trecento carte incise» acquisite dall’Archiviodi Stato di Novara alla fine degli anni Settanta del secolo scorso. Per una prima, parzia-le diesamina del corpus si veda il volume Stampe dall’Archivio di Stato di Novara, ca-talogo della mostra (16-30 aprile 2010), a cura di S. Borlandelli, E. Mongiat, M. M. Val-lascas, Novara 2010.
127Giovan Mauro Della Rovere disegnatore: quattro schede varallesi
40 sASV, Società di Conservarzione, [E. Contini], Pinacoteca. Inventario Agosto 1943, m.1, sala 18, n. 29.
41 E. Grupallo, Pinacoteca di Varallo. Disegni per la grande decorazione tardo barocca inValsesia, tesi di laurea, Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Lettere e Filosofia, re-latore L. Giordano, p. 56.
42 ASC, S. Stefani Perrone, Inventario …, 1987, p. 113, n. 1113.43 G. Bora, Disegni…, 1973, p. 34, nn. 147-148.44 Ibidem, p. 34, n. 149.45 sASV, Società di Conservazione, [E. Contini], Catalogo …, Ottobre-Novembre 1941-
XX, m. 1, p. 30, n.65; sASV, Società di Conservarzione, [E. Contini], Pinacoteca. Inven-tario Agosto 1943, m. 1, sala 18, n 67; sASV, Società di Conservazione, [E. Contini], Pi-nacoteca di Varallo. Inventario 1 ottobre 1957, m. 1, sala 2, n. 36; sASV, Società di Con-servazione, Schede delle opere d’arte conservate presso la Pinacoteca di Varallo, s.d.(ma post 1960), n. 765.
46 ASC, S. Stefani Perrone, Inventario …, 1987, p. 176, n. 1806.47 G. Bartrum, Dürer and his legacy. The Graphic Work of a Renaissance Artist, catalogo
della mostra (5 dicembre 2002 - 23 marzo 2003), Londra 2002, pp. 239-265. Per uncontributo più recente relativo all’ambito fiorentino si veda G. M. Fara, La fortuna diAlbrecht Dürer nell’arte fiorentina del XVI secolo, in Metodo della ricerca e ricerca delmetodo: storia, arte, musica a confronto, atti del convegno, a cura di B. Vetere e D.Caracciolo, Galatina 2009, pp. 185-201.
48 sASV, Società di Conservazione, [E. Contini], Catalogo …, Ottobre-Novembre 1941-XX, m. 1, p. 29, n.30; sASV, Società di Conservarzione, [E. Contini], Pinacoteca. Inven-tario Agosto 1943, m. 1, sala 18, n. 29; sASV, Società di Conservazione, [E. Contini], Pi-nacoteca di Varallo. Inventario 1 ottobre 1957, m. 1, sala 2, n. 30.
49 sASV, Società di Conservazione, Schede delle opere d’arte conservate presso la Pina-coteca di Varallo, s.d. (ma post 1960), n. 683.
50 ASC, S. Stefani Perrone, Inventario …, 1987, p. 176, n. 1042.51 G. Bora, Disegni…, 1973, p. 35, n. 153.52 U. Ruggeri, Disegni lombardi secenteschi dell’Accademia Carrara di Bergamo, Berga-
mo 1982, p. 108, n. 94.53 P. Bjurstr ´om, Drawings…, 1979, p. n. n., n. 290, 292.54 E. Pagliano, Dessins italiens du Musée des Beaux-Arts d’Orléans, catalogo della mo-
stra (Orléans, 14 novembre 2003-15 febbraio 2004), Parigi 2003, p. 299, n. 182. 55 M. Dell’Omo - F. M. Ferro, Pittura…, 1996, p. 124.
128 Elena Rame