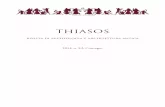Statue regali, sovrani e templi del Protodinastico: I dati epigrafici e testuali
Transcript of Statue regali, sovrani e templi del Protodinastico: I dati epigrafici e testuali
ATTI DELLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
A N N O CDÍIÍ - 2006
CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE
MEMORIE
SERIE IX - V O L U M E XXI - FASCICOLO 1
NICOLÒ MARCHETTI
LA STATUARIA REGALE NELLA MESOPOTAMIA PRO TO DINASTI CA
Con un'Appendice di G I A N N I M A R C H E S I
ROMA 2006 BARDI EDITORE
EDITORE COMMERCIALE
© by Accademia Nazionale dei Lincei
Si ringrazia ¡.'«Associazione Amici dell'Accademia dei Lincei» per la collaborazione o f f e r t a alla edizione del presente volume
ISSN: 0391-8149 ISBN: 88-218-0958-7
FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI 2006
Azienda Grafica Eredi dott. G. Bardi S.r.l. - 00186 Roma, Piazza delle Cinque Lune, 113
Azienda con Sistema Qiialità certificato da BVQ1
R E L A Z I O N E
Letta ed approvata nell'adunanza del 13 maggio 2005 sulla Memoria di N I C O L Ò M A R C H E T T I , L Ì statuaria regale nella Mesopotamia protodinastica, presentata nell'adunanza dell'11 marzo 2005 dal Socio Corrispondente P. M A T T M A E .
Questo studio, che consiste in un'analisi minuziosa, puntuale e originale di carattere archeologico e sto rico-artistico di N. Marchetti, corredata da una preziosa appendice su importanti problemi epigrafici di G. Marchesi, affronta ili ima prospettiva rinnovata un tema centrale e classico dell'archeologia della Mesopotamia antica, oggetto negli ultimi sessanta anni di fondamentali indagini ad opera dei maggiori studiosi di archeologia orientale, da H. Frankfort e A. Moortgat, fino a E. Strommenger, a W Orthmann, a E. Porada e E. Holzhiger Braun. A fondamento dello studio è il riesame diretto della larga maggioranza delle opere oggetto della ricerca, compiuto soprattutto su materiali dei Musei di Londra, Parigi, Oxford, Istanbul, Damasco, Chicago, New Haven e Philadel-phia.
Il nucleo del lavoro è la ricostruzione del processo di costituzione nella sta-tuaria proto dina s fica di un'iconografia specificamente regale, processo dal quale, sulla base di un'analisi critica, viene esptmta l'immagine del cosiddetto "re-sa-cerdote" dell'età protostorica. Un'accuratissima riconsiderazione critica dei con-testi archeologici di ritrovamento della statuaria proto dina s fica, un riesame della correlazione tra ceramica, glittica e altre produzioni minori in rapporto alla sta-tuaria nelle stratigrafie templari, tura nuova valutazione delle iscrizioni votive che compaiono su alcune delle opere hanno consentito di porre in tura luce comple-tamente nuova la problematica della statuaria regale protodinastica della Meso-potamia. In particolare, queste revisioni liaimo portato a risultati del tutto nuovi per quanto concerne sopratutto le ricostruzioni stratigrafiche di siti tra i primi scavati della Mesopotamia meridionale, come Adab e Girsu, hi questo ultimo caso con attribuzioni delle opere artistiche a sei fasi distinte, dal Pi otodinastico II al Protodinastico Illb, per le quali si sono potute ricostruire piante di fase con la localizzazione dei reperti. Tra i contributi di maggiore significato dipendenti dalla revisione delle principali sequenze stratigrafiche sono di particolare inte-resse le conclusioni che la statuaria, come la glittica, del Protodinastico II abbia continuato ad essere prodotta nel Protodinastico Illa e che, di conseguenza, il Protodinastico Illa sia da considerare tm periodo hi cui convivono stili diversi.
4
Il complesso della statuaria regale protodinastica, che è stato suddiviso in documenti artistici identificati epigrafìe ame lite e in opere anepigrafe individuate su base comparativa, è valutato nel contesto storico, giovandosi, in particolare, del fatto che vengono proposte numerose nuove letture delle epigrafi regali. In non pochi casi, soprattutto nelle serie arcaiche, queste epigrafi non erano mai state analizzate precedentemente, mentre si sono anche potute aggitmgere diverse nuove iscrizioni che non erario state finora riconosciute come regali: è questo il caso di KHAR.TU, di Urlammarak, di Ur-AN.SI e del cosiddetto "Tagge", da leggersi in realtà Shumba'li. Inoltre, è di particolare rilievo che sia stato riconosciuto il carattere regale di due statue di Lagasli I e di tre altre statue di Tutub, di Susa e di Gebelet el-Beyda, che 11011 erario considerate regali negli studi precedenti.
Dalla ricerca emerge un nuovo quadro dei sovrani protodinastici attestati epigraficamente e ili essa sono discusse le principali tipologie di dediche votive su statua. L'integrazione assai notevole tra le analisi archeologiche e filologiche permette di proporre, del tutto fondatamente, nuove identificazioni di alctme divinità titolari di importanti santuari proto dinastici: è questo il caso dell'attri-buzione a 'Iluma'tim del Tempio cosiddetto di Sitara a Teli Agrab e a Basurat del cosiddetto Tempio di Ishtarat a Mari, mentre il titolare del Tempio di Sin a Tutub sarebbe in realtà Samush e i nomi di tempio della città di Adab, E-SAR e Emakh, non sarebbero che due differenti e successivi nomi dello stesso com-plesso templare.
Anche al di là del tema principale dello studio, l'articolazione delle revisioni critiche intraprese è tale che ne discendono interpretazioni nuove anche ili pro-blematiche diverse, ma fortemente coimesse al soggetto principale, dalla rilettura di certe classi della glittica protodinastica fino alla datazione di alcune importanti tombe del cosiddetto Cimitero Reale di Ur.
Per il notevole valore dello studio, la centralità del soggetto e soprattutto la forte originalità dei risultati, la commissione ritiene unanimemente lo studio di N. Marchetti e G. Marchesi del tutto meritevole della pubblicazione nelle Me-morie dell'Accademia Nazionale dei Lincei.
ANTONIO GIULIANO
M A M O LTVERANI
PAOLO MATTHIAE
APPENDICE
GIANNI MARCHESI
STATUE REGALI, SOVRANI E TEMPLI DEL PROTO DINASTICO
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI«
A . 1 . L E ISCRIZIONI DELLA STATUARIA REGALE
Nelle pagine che seguono sono piesentate e discusse le iscrizioni su statue protodinastiche di presumibile committenza regale. Alcune di queste erano note già da tempo, altre sono state identificate nel corso del pre-sente lavoro (Cat. 1, 3, 6, 8 e 12a), dopo un riesame di tutto il materiale
(+) Il presente lavoro — concepito insieme ed elaborato parallelamente alla ricerca del-l'amico e collega Nicolò Marchetti — si inserisce in un programma di ricerca diretto dal Prof. Carlo Zaccagnini presso l'Università di Napoli "L'Orientale" con il co finanziamento del MIUR. Al Prof. Carlo Zaccagnini vanno i miei più sinceri ringraziamenti per aver letto e discusso con me l'intero manoscritto, fornendomi osservazioni, critiche e suggerimenti. Ringrazio inoltre i Proff. Francesco Pomponio, Piotr Steinkeller e Aage Westenholz, che mi hanno fornito preziose informazioni; i Proff. Alfonso Ardii , Maria Giovanna Biga e Walther Sallaberger per aver messo a mia disposizione alcuni loro lavori inediti; la Dott. ssa Ulla Kasten (Yale University), il Dott. Raymond Tindel e il Prof. Christopher Woods (Oriental Institute, Chicago) per l'assistenza prestatami durante le mie visite alla Yale Ba-bylonian Collection e all'Orientai Institute di Chicago; i Proff. Barry Eichler, Erle Leichty e Steve Tinney per l'amichevole e preziosa accoglienza riservatami allo University Museum of the University of Pennsylvania durante la stesura di questo studio. Un profondo ringra-ziamento va al Prof. Fabio Alberto Roversi Monaco, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, per il suo costante incoraggiamento e il generoso, decisivo sostegno finanziario.
206 APPENDICE
statuario iscritto. In un caso (Cat. 9) si è corretta la precedente attribuzione di una statila ad un sovrano (En'annâbtum® I), piuttosto che ad un altro
(1) Per tale, più precisa, lettura di questo nome comunemente letto "Enanatum" o "Enannaturn", cf. MARCHESI 2004, p. 191 con n. 216; e ID. in stampa, n. 7. Il segno ' nella trascrizione dei nomi propri sumerici indica uno iato o una consonante "debole'7 occultata dal sistema di traslitterazione comunemente impiegato. La lingua parlata in epoca proto-dinastica aveva una serie di fonemi andati perduti nel sumerico più tardo. Le parole che iniziano per vocale nelle nostre trascrizioni incominciavano in realtà o con una cosiddetta "semiconsonante" (/y/ o /w/), o con una laringale. Originariamente il sumerico aveva due laringali, una fricativa (/h/) e tuia occlusiva (/'/; cf. la coppia minima E = /hay/, "casa", ed A = /'ay/, "acqua"). Alla fine del periodo protodinastico queste erano forse già ridotte ad un unico fonema, come suggerisce la variante A-gil-sa del NP E-gil-sa nei testi presargonici di Lagas (cf. Gebhard SELZ 1993, p. 234 ad 8:4). La laringale occlusiva (Alef) si conserva solo in alcuni contesti fonologici. Quando è preceduta da un'altra consonante si assimila a questa; ad esempio: {'an.'a} > /'arma/, "in cielo" (cf. diversamente {'an.ak} > /'ana(k)/, "del cielo"). Nei nomi propri ciò avviene anche tra suoni contigui di morfemi indipendenti; cf. lugal-hiamia-ra-túm = /lugahiaruiarraltum/, da {lugal-nanna.r-'al.tnm} (MARCHESI 2004, p. 191 N. 216 e 193 IL. 226); si-li-mu-du = /silimmutû(k)/, per silim-(d)utu (STEINKELLER
1993b, p. 239 sub 25); inin-na-zu per dniri-a(yJ-zu (SLGEIST 1995, n" 178:5); ur-ri-ni-in4-na per ur-in(n)uq(MUS) (SCHEIL 1925, p. 50 n° 7:1); ni-in-nu-ù, ipocoristico di dnin-urta-sag-kal (CHAXHN 1980, p. 343); ni- in-nu-u[r-ta] per dnin-urta (GELLER 1989, p. 198 riga 6 4 ) ; :^nin/in-na-na per din'anaks/innanak,(MUS) (passim; cf. p. 215 n. 52); ecc. D'altra parte, i testi presargonici di Ebla forniscono anche esempi di forme senza assimilazione di Alef alla consonante che precede; cf. nu-gal-ì-zi per lugal-iziti (STEINKELLER 1993b, p. 239 sub 19) e ur-sa-nu-ù-du per ur-sag-utu (ibidem, p. 237 sub 1). Il segno ' segnala quindi la pre-senza originaria di /'/, /h/, /y/ o /w/. Sparita o meno che sia, ciascuna di tali consonanti gioca comunque tui ruolo nella fonologia del sumerico. Il nome Silim'utùk, ad esempio, era pronunciato /silim'utû(k)/ o /silimmutû(k)/, ma non /silimutû(k)/. Va precisato, inoltre, che le nostre letture dei logogrammi sumerici sono in parte anacronistiche. Esse derivano da sillabari, glosse di lettura e scritture sillabiche d'età paleobabilonese, se non, in qualche caso, persino del primo millennio a.C. Il sumerico del terzo millennio, specie quello del periodo protodinastico, poteva essere notevolmente diverso. Il nome scritto é-an-na-tùm e trascritto qui come E'annàbtum, ad esempio, era in realtà probabilmente pronunciato /hay'annâbtum/ o /hayyannàbtum/, da {hay-'an.'a-'a.b.i.tum}. Il valore é del segno omo-nimo rappresenta infatti una lettura tarda, esito della perdita della laringale iniziale e della successiva mutazione di /ay/ in /e/, ad un certo punto verso la fine del terzo millennio. Prestiti sumerici più antichi conservati nel semitico occidentale, come il siriaco haykal (< é-gal, "palazzo") e l'aramaico 'yk (< é-ati-na, un tipo di santuario; cf. CAVIGNEAUX 1998b), indicano che E era originariamente pronunciato /hay/ in sumerico. Analogamente, l'uso di EN come sillabogramma per /hin/, /hin/, /'in/ e /yin/ (cf. GELB 1957, p. 47 sub ,2N: en-ma, 52 sub "NN: t'n-na, 51 sub '4NB: en-bíjbu, e 191 sub N' JR: en-ar) — ma non per /en/ o /in/ — nel sillabario paleoaccadico e la forma /(u)mun/ della parola per "signore" nel dialetto letterario chiamato eme sai (cf. SCHRETIER 1990, p. 263 sub 469; e CAVIGNEAUX-AL
RAWI 1993, p. 102 righe 5 ' e 14) suggeriscono che il segno da noi traslitterato come en
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 2 0 7
(Enmetênnâk®). Dalla presente raccolta sono escluse: 1) epigrafi di statue già interpretate come regali, ma che tali in realtà 11011 sono, come ad esempio quelle attribuite a Meskigalla di Adab (Tav. LUI: 6-7)® o a Yikunsamas (¿-¿//-TJTU)® di Mari®, e comunque iscrizioni con dediche in favore del sovrano da parte di terzi; 2) casi molto dubbi, come quello di un frammento di statata da Mari in cui è conservato solo il nome del re Yíkñnsamkan ("Ikünsamagan"), col relativo ti-tolo (cf. infra, § A.1.1); 3) palesi falsi epigrafici, come quello della presunta statua di E'annâbtum ("Eannatum"; cf. p. 206 n. 1) della Collezione Menil®.
fosse in realtà letto /hen/ o, più probabilmente, /wen/. Nell'idioma locale di Lagas, poi, lo stesso era verosimilmente pronunciato /mun/ (cf. KEECHER 1 9 6 7 , pp. 8 8 - 8 9 ; BAUER 1 9 9 8 ,
pp. 435-436; e KRISPIJN 2000, pp. 154-156, e 161 "Survey" 1), cosicché il nome en-an-na(-ab)-túm lo si dovrebbe forse trascrivere Mun'annâbtum o Munnannâbtum. La trascrizione qui adottata, En'annâbtum, riflette approssimativamente la lettura del medesimo nome da parte di uno scriba paleobabilonese di Nippur. Si noti ancora, inline, che la lunghezza delle vocali non è notata nella trascrizione dei nomi propri, a meno che queste non siano vocali lunghe per contrazione. In tal caso sono trascritte con l'accento circonflesso. Quantunque la lunghezza vocalica sia fonemica in sumerico (perlomeno in paleosumerico), a causa del sistema di scrittura solo in un numero estremamente limitato di casi è possibile stabilire con certezza se una vocale sia lunga o meno.
(2) Per tale ricostruzione del nome scritto en-TE+ME-na (e sovente ancora letto o ci-tato scorrettamente come "Entemena"), cf. ALSTER 1974b; e infra, pp. 209-210 n. 23. Grafie sillabiche come a-sag4 (invece di a-sa) per asag/asa ;, ù-dug4 (invece di ú-du) per udug/udus, ges-tùg (invece di ges-tu) per gestug/gestu, ecc., così come le convenzioni scribali per E no-tazione del dativo (Gin-gir-su-ra = /ningirsùkra/ o /ningirsûr(<k)ra/ vs. Ganse = /nanser/), indicano che le consonanti in fine di paiola, compresa E /k/ del genitivo, fossero effetti-vamente pronunciate in epoca protodinastica (cf. BAUER 1989-1990, p. 77), contrariamente a quanto avviene nel sumerico d'età paleobabilonese. Queste sono pertanto notate nella trascrizione dei nomi propri (quindi Enmetênnâk, anziché Enmetênnâ; Ningirsûk, anziché Ningirsù; ecc.). Per lo stesso motivo si è preferito utilizzare qui i cosiddetti valori "lunghi" nella traslitterazione dei testi (ossia, ad esempio, barag, piuttosto che bara; gestug, piuttosto che gestu; pad, piuttosto che pà; ecc.), contrariamente alla prassi generalmente invalsa.
(3) Cf. BRÄUN HOIZINGER 1977, pp. 73-74 I M 5572; COOPER 1986, p. 17 Ad 6; e M A R -
CHESI 2004, p. 185 con n. 183. (4) Per E traslitterazione e E trascrizione dei nomi propri accadici o semitici d'età proto-
dinastica, si notino le seguenti corrispondenze convenzionali: s = /s/ = [s,s); / = /s/ = [ t ] (a Mari ed EbE = [t,d]); T = /s,s,z/ = [ts,ts,dz] (cf. HUEHNERGARD 1 9 9 7 , p. 5 8 7 ) .
( 5 ) WALKER-COLLON 1980, tav. 25: 1. Cf. BRÄUN HOLZINGER 1977, pp. 74-75 B M 90828; WALKER-COLLON 1980, p. 96 sub 1; e STEINKELLER 1984a, pp. 33-34.
(6) AAHET 1987. Perlomeno l'iscrizione - é an na túm / PA.TE.SI / lagas i(NU l rBUR) l a
** / dumu àya-kur-gal, "E'annâbtum, viceré di Lagas, figlio di Ayakurgal ("Akurgal")" — è sicuramente un falso moderno. A parte l'incongruenza cronologica tra questa e lo stile, più arcaico, delE statua, come già osservato da AMIET {loc. citi), si noti la forma a cuneo dei segni, come se fossero scritti su argilE. In altre parole, si tratta di un'imitazione di un'iscrizione su
208 APPENDICE
A. 1.1. Osservazioni preliminari
L'individuazione della persona rappresentata da una determinata statua non è sempre facile o immediatamente evidente. Nel caso suaccennato del frammento col nome di Yibünsambän, re di Mari (7-vkD -dsa-ma-Â[ari] / LUGA[L ma-n*^^, la statua di ari era parte potrebbe essere effettivamente appartenuta a tale so-vrano, ma è più probabile che si tratti ili realtà della statua di un alto funzionario o dignitario mariota, come nel caso di un'altra statua la cui iscrizione incomincia con la menzione di Yibünsambän®:
1. i-kiAsa-ma-kan Yikünsamkän' 2. LUGAL ma-ri re di Mari — 3. ABA 'I®
S. Saybum'11',
4. SAG.DLL j
il responsabile del catasto, 5. p Ù L ] - J Ù ha presentato (7) ó. [dIN] ANA X [Z] A+ZA la sua statua (5) 7. a IN ANA. ZA. ZA1'13' (6).
"sua", alla riga 5, non si riferisce al re Yibünsambän^, belisi all'autore della dedica, SaybimL15). Ciò emerge chiaramente dal confronto con un'analoga iscri-zione su un'altra statua da Mari(1<5b
mattone o su tavoletta d'argilla. I segni della scrittura monumentale impiegata nelle statue e su altri oggetti in pietra sono invece, in questo periodo, lineariformi. Il segno A, poi, è sempre costituito da due tratti orizzontali, non da tre come qui, nel nome áya(A)-kur-gal. Infine il segno LA, nella scrittura del toponimo Lagas (cf. p. 211 n. 31), è anch'esso mal riprodotto.
( 7 ) DOSSIN 1 9 6 7 , p . 3 1 0 n ° 2 ; GELB-KJENAST 1 9 9 0 , p . 11 M P 1 1 .
( 8 ) DOSSIN 1 9 6 7 , p . 3 0 9 i r 1 ; GELB-KJENAST 1 9 9 0 , p . 1 0 M P 9 .
(9) Cf. W G . LAMBERT 1986, pp. 157-158. ( 1 0 ) Per A B X Á S = A B A S , cf. GELB 1984, pp. 267 e 271-272. ( 1 1 ) Cf. FRONZAROII 1 9 9 3 , p. 1 3 7 s.r. ABXÁS. (12) SU, in D U L - L Ú , e A 4 p-KIT) sono probabilmente da interpretarsi come accado-
grammi, ossia come scritture sillabiche fossilizzate di parole accadiche, usate come logogrammi (cf. KREBERNIK 1985, pp. 53-55; Id. 1992, p. 69; e W G. LAMBERT 1989, p p 24-25). L'assenza di preposizione davanti al nome del destinatario dell'offerta nelle iscrizioni votive protodina-stiche in lingua accadica denota forse una costruzione originaria con doppio accusativo, come nell'inglese "to give someone something" (cf. CAD R, p. 146 râmu B, "to present, to grant, . . ." , analogamente costruito col doppio accusativo), il che spiegherebbe anche la differente posizione del destinatario, subito prima del verbo, rispetto a quanto avviene invece nelle iscri-zioni sumeriche, con il destinatario posto in genere all'inizio dell'iscrizione e il verbo alla fine.
(13) Cf. infra, § A.3.6. ( 1 4 ) Come ritenuto invece da DOSSIN (1967, p. 309). ( 1 5 ) C f . g i à M . LAMBERT 1 9 7 0 , p . 1 6 8 .
( 1 6 ) DOSSIN 1 9 6 7 , p . 3 2 8 i r 6 9 ; GELB-KJENAST 1 9 9 0 , p . 1 3 M P 1 4 .
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 209
1. ip-lu^-il 2. LUGAL ma-ri* 3. ur-d[N]ANSE 4. N A R M A H
5. D Ù L - J Ù 6. d r INANAX ZA+ZA1
Yipius'ii ("ibhim'T"» re di Mari — Ur-NANSE118', il sommo cantore, ha presentato (7)
7. S A J U K , la stia (di Ur-NANSE) statua (5) a INANA.ZA.ZA (6).
La statua suddetta raffigura un suonatore d'arpa119), e pertanto essa rappre-senta lo stesso personaggio che è menzionato nell'iscrizione col titolo di sommo cantore.
Varie iscrizioni su statue e oggetti votivi da Mari presargonica antepongono il nome del sovrano regnante (hi un caso unitamente a quello della regina120)) al nome del dedicante. In tali casi, non si tratta di dediche in favore del so-vrano121), quanto piuttosto di formule di datazione; nell'esempio precedente, "Yiplus'il re di Mari" significa "Yiplus'il regnante a Mari", ossia, "sotto il regno di Yiplus'il"122).
Dedicata per la vita del sovrano è invece una statua da Adab, la cui iscrizione (Tav. XLV) dice:
(17) Cf. STEINKELLER 1984c, pi 1 1 sub 9; E ID. 1993b, p. 240 sub 8. (18) Forse da leggersi /urnaziyak/ (cf. STEINKELLER 1993b, pp. 237-238 sub 6; e MAR-
CHESI in stampa, n. 86). (19) BOESE 1 9 9 6 , pp. 34-35 e 46-47 figg. 4-5. (20) Cf. MARCHESI 2004, p. 177. (21) Così SOLLBERGER-KUPPER 1 9 7 1 , pp. 8 8 - 9 0 IG4a-IG5b; e COOPER 1 9 8 6 , pp. 8 6 - 8 9
Ma 2 . 1 - 2 . 2 e Ma 5.1-5.3. ( 22 ) Cf. GRAYSON 1 9 8 7 , p. 4 6 Sargon I 2 0 0 1 : 1 - 9 : i-n[u]-m[e] / MUGAL-GIN / PA.TE.
SI a-sùr / a-na dINANA / a-su-ri-tim / NIN.A.NI / ha-ti-tum / DAM fflm'x1 / ta-ak-ru-ub, "Quando Sarrumkën ("Saigon") era viceré di Assui, Hattítum, moglie di E n n a m . d e d i c ò (questo oggetto) ad Estar di Assur, sua signora".
(23) Letto in precedenza "bàra-hé-ì-dùg" (YANG 1989, p. 12) o "bára-hé-NI/ni-du10" (STEELE 1982b, p. 188; COOPER 1986, p. 16; PETTINATO 2003, p. 220), ma tali letture non conducono a nessun significato plausibile. "Possa egli essere gradito al trono" (cf. il NP lugal-barag-ge-dùg, "Il re è gradito al trono": MARCHESI 2004, p. 190 n. 213) richiederebbe la forma verbale *ha-ba-dùg (cf. WOODS 2001, p. 539; e MARCHESI 2004, p. 190 n. 212). Più probabil-mente barag-GAN.NI-dùg va letto barag-gan-né-dùg e interpretato come variante ortografica e abbreviazione del NP (lugal*-)baiag-ga-né-dug, " (D re) è gradito al suo trono" (POVELL 1978, p. 46 n° 10 ii 7, p. 50 i r 13 ii 6; GELB et al 1991, p. 88 Appendix to nos. 22-23 x 1*; ecc.). Lo stesso nome lo si ritrova altrove ulteriormente abbreviato in barag-ga/gan-né (cf. ibidem, p. 80
1. dnin-subur 2. nam-ti 3. barag-gan-né-dùg
A Ninsuburak, per la vita di Baragannêdug ("Barahenidu")123),
210 APPENDICE
4. NÍG.PA.TE.SI viceré®* 5. uiabus(UD."NUN")k '-da di Adab25*, 6. ur-és-lílTá Ur'eslilak, 7. ab-ba ere®* anziano della città'27* 8. a mu-ru ha presentato.
La dedica "per la vita di Bar agamie dug'7 potrebbe far pensare che la statua in questione rappresenti il snddetto sovrano; tuttavia, il confronto con l'iscrizione di una statua femminile neosumerica123) suggerisce che il personaggio rappresen-tato sia, anche qui, il dedicante, ossia, Ureslilak:
ad iv 60, e p. 165). Per la trascrizione Baragannêdug (< {barag.atme.e-'i.dug}), cf. MARCHESI
2004, pp. 190-191 (si noti ancora che "suo" in sumerico è piuttosto /anne/ o /a"e/ [dialetto neosumerico di Lagas], che non /ani/; cf. KRAMER 1936, pp. 4-5; F ALKENSTEIN 1949, p. 53-54 sub e; LIMET 1968, p. 436 s.w. Inim-ma-an-ni ed Inim-ma-ati-ni-zi; ATTINGER 1993, p. 172; e KREBEKNIK 1 9 9 8 , p . 3 2 4 ) .
(24) Che NIG.PA.TE.SI sia una variante ortografica di PA.TE.SI (convenzionalmente letto énsi; ma cf. p. 223 n. 97) è ora definitivamente confermato dalla menzione del sovrano di Lagas Ayakurgal, che nelle sue iscrizioni teca il titolo PA.TE.SI lagas^fNUjj.BUR)13^ (cf. STEHLE 1982a, pp. 118-119 Akg. 1 e 7), in un documento amministrativo inedito da Adab, col suo titolo scritto, alla maniera di Adab, NÍG.PA.TE.SI lagas i(NU11 .BUR) l i * (M. E. Mi Ione, c.p.; tuia sua edizione del testo suddetto è in preparazione). Le due ortografie, PA.TE. SI e NIG.PA.TE.SI, ricorrono come varianti anche nei testi di Suruppak (cf. POMPONIO-VLSI-
CATO 1994, pp. 17-19); e su tui vaso iscritto del tempo di Meskigalla I di Adab, discusso più avanti (pp. 227-228). Il titolo (NÍG.)PA.TE.SI (accadico issi'/yakkum), generalmente tradotto "(city-)ruler' o "steward" in inglese e "Stadtfùrst" in tedesco, definisce specificamente il sovrano di una città-stato nella sua relazione col dio poliade, caratterizzando il primo come vicario del secondo; donde la traduzione "viceré", qui adottata (cf. infra, § A.1.2).
(25) Per tuia più precisa lettura /urabu/ del toponimo convenzionalmente letto /adab/, cf. YANG 1 9 8 7 ; e DE MAAIJER-JAGERSMA 1 9 9 7 - 1 9 9 8 , p. 2 8 6 s.v. a12-rà-bu (/!/ è un fonema or-tograficamente distinto da /d/ e /r/ nei testi presargonici, e sentito come /s/ dai parlanti di lingua arcadica; più tardi, a partire dal periodo neosumerico, si fonde con /d/ o con /r/, a seconda delle aree dialettali; cf. BAUER 1 9 7 5 ; e JAGERSMA 2 0 0 0 ) . Nella scrittura del toponimo nei testi presargonici da Adab, il segno NUN non è propriamente NUN, ma un segno simile che termina però a punta di freccia. Qui è traslitterato "NUN", per distinguerlo dal segno N U N propriamente detto (cf. KRECHER 1 9 9 2 , p. 2 9 8 con n. 3 8 ) .
(26) La lettura tradizionale /uru/ è puramente convenzionale e si basa su un'unica fonte lessicale molto tarda (primo millennio). Sillabari più antichi, come Proto-Ea o S1, così come l'uso del segno URU come sillabogramma col valore ré/ri nei testi del terzo millennio, indi-cano che la parola sumerica per "città" fosse piuttosto /ere/ o /iri/ (cf. EDZARD 1 9 9 1 , pp. 77-78), con E prima variante che è da preferirsi per via della forma emesal ùru (/e/ ed /i/ corrispondono rispettivamente ad /u/ ed /e/ in emesal).
(27) Su Ur'eslilak e il titolo che reca, cf. WESTENHOLZ 2004, p. 600 con n. 11. (28) STEIBLE 1991a, p. 374 N a m m a h n i 1; EDZARD 1997, pp. 198-199 E3/1.1.12.6.
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 211
I 1. dba-ú A Ba'u ("Baba")«29', La donna graziosa, la figlia di An, signora della Città Santa, sua signora, per la vita di Namhanne ("Nammahani") (30), viceré
2. amtuis sag^- ga 3. dumu an-na 4. nin ere-kug-ga 5. nin-a-[ri]é 6. nam-[t]i 7. [nam-mah-né] 8. PATE.SI
9. lagas i(TSÍUn.BUR)k "-ka-sè
10. eres-in[im]-g[i]-na
di Lagas'T',
Eres'EEmginák ("NinEEmgEia")®, la madre che lo ha generato'"'', lia presentato (questa statua) (8) dicendo (7): "Quando il genio protettore del TAR-sirsir (= Bau?))14) (2)
ii 1. ama dúd-da-né 2. d lammar TAR-sir-sir-ra 3. kisal dba-ú-ka ku -ku -da -né
4 4 4. alan-e nin-gu10 'io
( 2 9 ) C f . MARCHESI 2 0 0 2 .
(30) La pronuncia /namhanne/ del NP nam-mah-né è data dalla variante in grafia sil-labica nam-ha-né (cf. NEUMANN 1998-2001 sub 1; e supra, pp. 209-210 n. 23). Come in altre iscrizioni sue o dedicate "per la sua vita", il nome di Namhanne è stato deliberatamente can-cellato qui, nel tentativo di perpetrare una damnatio memoriae nei suoi confronti.
(31) Si noti paleosumerico /lagas/ (cf. lagas(NU)j .ELIR)k ^-sa, genitivo, EDZARD et al. 1977, p. 103) > neosumerico /lagas/ (cf. la-ga-sa, genitivo, EDZARD-FARBER 1974, p. 110). Il Ergogramma per Lagas si compone dell'ornitonimo n i immaJNl I t t. BUR) :™s™( R determina-tivo di luogo k e il complemento fonetico k . In altre parole, il toponimo Lagas è codificato a Evello di scrittura come "il luogo dell'avvoltoio", così come Nibru/Nippur è "il luogo di Ellil" (TT I .TT A o Eredug è "il luogo del Principe (= Enkìk)" (NUN^) (cf. JACOBSEN 1967, pp. 101-103; e VELDHUIS 2004, pp. 226-228 s.v. butuT™", e 276-277 s.v. nunmia(NUn .BUR/ NLIj j .BUR)™'"™). Origine e significato di tale associazione rimangono però oscuri (cf. JA-COBSEN, loc. cit., per una possibile spiegazione, peraltro alquanto speculativa).
(32) Per la lettura /eres/ del segno NIN come elemento teoforo in nomi di persona, cf. HEIMPEL 2003, p. 632; e MARCHESI 2004, pp. 188-189. Si noti inoltre la variante NLN.SÈ(= eres-sè)-an-zu del NP NIN-e-an-zu in V S 25 i r 69 iv 18 (cf. JAGERSMA 1995-1996, p. 223 ad loc.-, e MARCHESI 2004, p. 189 con mi. 200-201).
(33) In linea teorica qui si potrebbe leggere anche emedud (AMA.TU)-da-né, "sua ser-vitrice" (cf. infra, § A. 1.4 commento a Cat. 1:1). Tuttavia, l 'Eres'inimginàk della presente iscrizione è verosimilmente identica alla donna dallo stesso nome che compare Ei varie altre iscrizioni votive del tempo di Namhanne e del suo predecessore Tesgar ("LJr-GAR"). In queste essa si dice figUa di KA-kug e sposa del succitato Tesgar (cf. EDZARD 1997, p. 189 E3/1.1.9.1 e pp. 199-202 E3/1.1.12.7-10). E assai probabile, pertanto, che Eresrnimgitiâk fosse la madre di Namhanne. La traduzione "cugina" per AMAQTLJ Et questo passo, pro-posta da I. M. Diakonoff e J. Renger (cf. STEIBLE 1991a, pp. 374-375 n. 1) e adottata anche da EDZARD 1997, p. 199, non lia alcun fondamento.
(34) Cf. STEIBLE 1991a, pp. 143-144 Urbaba 5 n. 1; e Gebhard SELZ 1995, pp. 158-159 sub 4.
212 APPENDICE
5. iesgestug,°£-ga-ne-a [ha]-mu-na-ni-ru-gú
6. sískur-gu]0 hé-na-bé 7. bi-dug4!(SAG) 8. a mu-na-ru
entra nella corte (del tempio) di Ba'u (3), possa questa statua (4) portarmi all'attenzione della mia signoraQ) (4-5) e dire a lei le mie preghiere" (6).
Quest'ultima statua rappresenta ima figura femminile^: verosimilmente la dedicante, Eres'immginàk. Ne consegue, per analogia, che anche in quella pre-cedente sia più probabilmente rappresentato il dedicante (Ur'eslilak), e non il beneficiario (il sovrano Baragarmèdug).
Esistono però anche statue dedicate contemporaneamente da più persone. E questo il caso, ad esempio, di tm torso frammentario iscritto, rinvenuto ad U r u k « :
1 . dnin-subur A Ninsuburak, 2 . áya-digir-gu ]0 Ayadigirgu, 3 . ad-da padre 4 . AK sagga A tu di AK, l'anmiinistiatore template di Utu,
5 . KUM-dtir-sè™ ama e KUM-dutse, madre
6. áya-digir-gu ]0-kc4 di Ayadigirgu,
7 . ud dnin-ìmma quando Nin'immák,
8 . igù1 e-na-dé-a lo (= AK) chiamò,
9 . ni mu-ni- rguÑ facendoli sentire fieri (?)139',
1 0 . [áya]-digir-|g]u1() KUM-dtir-sè Ayadigirgii e KUM-durse
1 1 . a [mu-na-ru] le (a Ninsuburak) presentarono (questa statua)
Qui la statua è maschile, ed è ipotizzabile, quindi, che rappresenti Ayadigirgu, a dispetto della dedica congiunta da parte sua e della madre. Più problematico è invece il caso di una statua con una dedica di due persone del medesimo sesso140);
( 3 5 ) C f . WLLCKE 1 9 8 7 , p p . 9 5 - 9 6 n . 3 6 ; ID. 1 9 9 0 , p . 4 8 7 c o n n . 6 9 ; e ATTINGER 1 9 9 3 , p .
226. (36) Cf . DE SARZEC-HEUZEY 1884 -1912 , p. 347 .
(37) FALKENSTEIN 1963, pp. 2-4 E t aw . 5-6; STEIBEE 1982b, pp. 339-340 AnUruk I; BECKER 1 9 9 3 , p . 7 7 e t a w . 69 -70 : 953 .
(38) Per tale lettura, invece di "kitm-tus-se" (come proposto da STEINKELLER 1987, p. 191), cf. é KUM-dúr-ra in ITT 3 n° 5279 v. i 8.
(39) Cf. ni — gur+, "sentirsi importante/fiero" (CIVIL 1964, p. 87 ad 61). ( 4 0 ) STEIBLE 1 9 8 2 B , p p . 3 4 3 - 3 4 4 A n o n y m 6 .
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 213
1. dnin subur bàd A Ninsuburak di Bad (4 i ;/delle m u r a c i 2. en-zi se bad^ (SIPA)1431 Enzi, il pastore, 3. amar-ki-kug e Amarkikugak, 4. dumu en-zi figlio di Enzi, 5. a mu n ì hanno presentato.
Citi rappresenta quest'ultima s tatuar II padre, Enzir O il figlio, Amarkikugak? Sulla base di tali esempi si potrebbe ritenere che le statate in epoca protodina-stica fossero considerate alla stregua di qualunque altro oggetto votivo, ossia, che non fossero intese come rappresentazioni di specifici individui. In altre pa-role, esse non sarebbero state concepite come immagini o simulacri di determi-nate persone, creati allo scopo di stare perennemente in preghiera nel tempio, di fronte alla statua del dio, per conto e in sostituzione di queste^44/ ma piuttosto come espressioni di devozione e veicoli di richieste del favore divino. In tale ot-tica si noti anche il cosiddetto "Torso di Isbum/Espum", trovato a Susa, la etti iscrizione dice(45):
1. ma-an-is-tu-su Man'istusu ("Manistusu"), 2. LUGAL re 3. KISI d i K i s -4. as-bum Asbum ("Espum"), 5. IR suo servitore'44/ 6. a-na a 7. ina-ru-dt Narunde
8. A.MU.NA.RU ha presentato.
(41) Cf. il toponimo bàcE in testi tardo presargonici da Adab (BI-II 34 ii 2 e BI-II 68 i 4; F. Pomponio, c.p.). E probabile, tuttavia, che esistessero più toponimi chiamati "La fortezza" (Bad, in sumerico, o Durum, in accadico); cf. MLCHALOWSKI 1977; e STEINKELLER 1984b, pp. 83-84. Da escludersi, invece, l'interpretazione di BAD come logogramma per la città di Der (generalmente scritta B À I I A N ^ , proposta da I. Finkel apud READE 2 0 0 0 C .
(42) Cf. din'anak (MUS) da bàd-da, "Li'anak (del tempio) di fianco alle mina" ( S AT . T .A -
BERGER 1993a, p. 47 n. 199; cf. infra, p. 215 n. 52).
(43) Tale, più precisa, lettura del termine sumerico per "pastore" è implicata dalla pro-nuncia /suba(d)/ dello stesso nel dialetto emesal (cf. SCHRETIER 1990, pp. 249-250 sub 413).
( 4 4 ) C f . THUREAU DANGIN 1 9 3 4 , p . 1 3 9 ; e BRÄUN HOLZINGER 1 9 9 1 , p . 2 2 8 .
(45) GELB-KIENAST 1990, p. 80 Manistüsu B 2 ; FRAYNE 1993, pp. 81-82 E2.1.3.2001. (46) Per la formula cerimoniale che consiste nell'anteporre il nome del personaggio
più importante con cui il soggetto dell'iscrizione è in una qualche forma di relazione, cf. MARCHESI 2004, pp. 178-180. 'Album è altrimenti noto col titolo di issiyah(hi) (PA.TE.SI) elamtim (ELAMjh "viceré dell 'Elam" (GELB-KIEN'AST 1990, p. 39 S - 4 ; FRAYNE 1993, p. 304 E2.16.1.1). Probabilmente si tratta di un governatore accadico insediato a Susa dal re di Akkad Man'istüsu.
214 APPENDICE
Qui non è agevole ipotizzare che la statua rappresenti il dedicante. Stilisti-camente, infatti, questa viene ritenuta anteriore all'epoca accadica, a cui risale invece l'iscrizione di 'Asbum1'47/
Se davvero si tratta in questo caso di ima dedica secondaria'48/ come inter-pretare allora il gesto di 'As burnt Che cosa ha questi voluto fare apponendo la sua iscrizione sulla statua di un più antico notabile elamita? Usurparne l'iden-tità'4^? O piuttosto solo rendere omaggio alla dea Narundi? E allora la statua solo un medium, il veicolo di un messaggio di devozione che avrebbe potuto essere altrimenti scritto su un qualsiasi altro tipo di manufatto?
Quanto a tipologia e contenuto, le iscrizioni su statua in genere non dif-feriscono significativamente dalle epigrafi che si ritrovano su altre categorie di oggetti; cf.:
la) Cat. 2: 1. DÜNAK 2. PA.TE.SI BÁHARÉ
lb) G R É G O I R E 1 9 8 1 , tav 1 : 1 (perla): (1.) AK-'TNANA
(2.) lugal GIS.KÚSU1*
DUN A K ("Ginak"), vicer é di . . .
AK-Aster ("Aka"), re di Umma'A.
(47) Cf. STROMMENGER 1959, pp. 30-36; EAD. 1960, pp. 47-48; BRAUN HOLZINGER 1977, p. 18 con n. 105, e p. 79 Sb 82; SPYCKET 1981, pp. 73-74; e BAHRANI 1992, pp. 86-87.
(48) Per ima diversa opinione, cf. BRAUN HOLZINGER 1991, pp. 220, 257-258 (St 95) e 298, la quale spiega l'incongruenza cronologica (a suo giudizio solo apparente) tra iscrizione e stile della statua in termini di attaidamento provinciale, piuttosto che di riutilizzazione.
(49) L'unico esempio certo di usurpazione di tuia statua è rappresentato dalla statua della Collezione Liebighhaus (K HAUPTMANN 1989; BRAUN HOLZINGER 1991, p. 254 St 79), la cui autenticità è peraltro controversa (cf. MUSCARELLA 2000, p. 160 sub 8). D'altra parte, il fenomeno doveva essere piuttosto diffuso, a giudicare dalle formule di maledizione contro tale pratica apposte sulle statue a partire dal periodo sargonico (cf. POMPONIO 1990, pp. 21-22). Altri possibili casi di usurpazione di statue sono segnalati da BOESE 1996, pp. 29-33 (con argomentazioni però non del tutto convincenti).
(50) Precedentemente interpretato come 'A/Per Inan(n)a, Aka/Aga*, re di T Imma/ Gis(s)a**" (GRÉGOIRE 1981, p. 13; STEELE 1982b, p. 266 Umma: Aka 1; COOPER 1986, p. 92 Um. 2*; PETTINATO 2003, p. 125 Um. 2*; e Gebhard SELZ 2003b, p. 506**; cf. infra, § A.1.4 commento a Cat. 5:3). Tuttavia AK-dINANA è frequentemente attestato come nome di persona in epoca protodinastica (cf. BURROWS 1935, p. 31 sub 245). La variante (?) AK-as-tár nei testi di Fara (POMPONIO 1987, p. 23; si noti anche il toponimo é-AK.-as-tár in WÉSTENHOLZ 1975a, i r 24 iii 5) suggerisce che si tratti di un nome semitico; cf. il NP UR-Aas-tár (POMPONIO 1987, p. 245), da leggersi, con ogni probabilità, Kalbu'astar o Kalab'astar (cf. TONIETH 1998, pp. 93-95). Lettura e significato del segno AK nel tipo antroponimico AK-ND non sono però al momento determinabili (cf. KREBERNIK 2002, p. 12; e Gebhard SELZ 2003b, p. 509 n. 44).
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 215
2a) Cat. 3: (1.) urAammar Urlammarak, (2.) NÍG.PA.SI il viceré151/ (3.) dPA.A[N?(...)] ali dio) . . .
2b) STEIBLE 1982b, pp. 238-239 AnNip. 22 (vaso): 1. eh [in]'anak (|M|ÙS) A Ei'anak ("Inanna")®: 2. rir-Ar'anaQ Ur'in'anakak, 3. nu-bànda il soprintendente.
3a) Cat. 7: 1. é-SAR Per l'E-SAR<53>: 2. lugal-da-lu Lugaldalu, 3. lugal urabu i(UD."NUN")k ' re di Adab.
3b) STEIBLE 1982b, p. 187 Adab: Med. 1 / A (vaso; Tav X I V : 4 ) :
1. é-SAR Per l'E-SAR: 2. isib-dur-ba Isibdurbar ("Medurba")^ 3. lugal urabtglTID/'NUN") re di Adab.
4a) Cat. 5: 1. h [ara] Per Sara, 2. é-abzu E'ab zu,
( 51 ) Per ( N Ì G . ) P A . S I come variante di ( N Í G . ) P A . T E . S I , cf. HALLO 1957, pp. 3 5 - 3 8 ; e BAUER 1 9 8 7 .
(52) Il teonimo convenzionalmente letto "Lianna" è in realtà più precisamente / (n)innana(k)/, da {nin-'an.ak}, "La padrona del Gelo" (cf. p 206 n. 1). Varie scritture silla-biche attestano infatti tale lettura; cf. [m]u-gi4-ib nin-na-na-ke4 per :+nu-gig iMUS-ke t (CROS et al 1910-1914, p. 203 A O 4327 v. ii 2; cf. ZGOLL 1997); [n]in-na-na nin r A - A I - n a - rkeg per + D M Ù S nin é-an-na-ka-ke4 (CROS et al. 1910-1914, p. 203 A O 4327 v. ii 3); u r - D M Ù S = ur-ni-in- hia"1 -na (SCHEIL 1925, p. 50 n° 7:2); ÌR'-^in-na-na (ARNAUD 1994, tav. 26 n° 56 iii 9 ) ; [in-n]a-na (ARNAUD 1982, pp. 211-212 riga 25); d i " " - [ M Ù ] S (CT 25 tav. 30 K 219 v. i 14); ecc. AL contrario, nessuna grafia come i-na-an-na o simile, che documenti tuia lettura al-ternativa /manna(k)/, è invero documentata. Né esiste, con ogni probabilità, l'iscrizione di Urnammâk ("Umammu") che conterrebbe "der Schreibfehler dNatma für "Tiranna" suppor-tando così la forma "Inanna" (WLLCKE 1976-1980, p. 75 sub 2.1; cf. STEIBLE 1991b, p. 102 n. 1 adUrnammu 9; e HEIMPEL 2002, p. 157).
(53) Tempio della dea Digirmah/Ninhursagak ad Adab (cf. infra. § A.3.1). (54) Cf. Min-dur-ba ("Il signore che scioglie i lacci"?) = Iti si-gar-ke4 in An = Animi II
3 3 0 (TJTKE 1 9 9 8 , p. 1 2 7 ) . Il segno ME in ME-dur-ba dovrebbe analogamente rappresentare un titolo (quindi isib, "esorcista, purificatore"), piuttosto che la parola me, "poteri divini". L'uso di ba per /bar/, "aprire, sciogliere", è ben documentato nei testi del terzo millennio (cf . KKECHER 1 9 9 3 ) .
216 APPENDICE
3. higal GIS.KÚSU1* re di Unum, 4. mu-[g]ub'(= TUJ-iñversum) ha eretto (questa statua)255.
4b) Puisa, Archéologie, Vente du 17-18 mars 2003, Paris, rf 388 (statua di leone): 1. dsára barag-sàg-nu-di Per Sara, Baragsagnudid, 2. higal GIS.KÚSLA re di Umma, 3. mu-gub ha eretto (questa statua).
4c) STEIBLE 1982b, pp. 215-216 Kis: Mes. 1 (testa di mazza; Tav. XI: 10): (1.) ffl^SHJM Me salini ("Mesilim")'5«1, (2.) lugal kisi re di Kis, (3.) é-ra'57* l'edificatore (4.) dnin-gir-sti di Niiigirsùk'531, (5.) dnin-gir-sti per Ningirsùk, (6.) mu-gub ha eretto (questa mazza), (7.) lugal-sagj-dagal'59' (al tempo di) Lugalsagdagalak
("Lugalsa-ENGUR"), (8.) PA.TE.SI (come) viceré (9.) l agasJNUj j .BUR)^] di Lagas.
5a) Cat. lObi i i 8 - iv 1: 8. ud-ba en-mete-na-ke4 A quel tempo Enmetênnâk
9. alan-na-né diede vita (10)
(55) Il segno DU è ambiguo, potendolosi leggere sia gub ("mettere in piedi, erigere"), che ie6 (= "de6")/túm ("portare") o kur, ("portare dentro, introdurre"; cf. p. 217 n. 62). In favore della prima di tali letture, si noti: ud alan dsul-gi-e in-gub-ba-gery-àm, "come il giorno dell'erezione della statua da parte di Sulgir ("Sulgi")", in YOS 4 il" 56:20-21 (cf. HEIMPEL 1990, p. 207).
(56) Cf. GELB 1957, p. 167 sub M' s e p. 273 sub SLM; ROBERTS 1972, p. 51 s.v. Salini; e CAD M/2, p. 156 s.v. mû B (b).
(57) Cf. EDZARD 2003, p. 18. (58) Si noti che "il costruttore del tempio di Ningirsu", come traduce invece PETTINATO
2003, p. 119 (cf. anche ibidem, n. 2), corrisponde piuttosto a: lú é Gin-gir-sti rú-a, in sume-rico. Il termine é-ra (é-dù) è un nome, ossia una formazione del tipo dub-sar ("colui che scrive la tavoletta" = "scriba").
(59) Tradizionalmente letto "lugal-sà/sag4-ENGUR". L'ultimo segno, tuttavia, proba-bilmente non è ENGUR (= LAGABXAN/IDDI/HAL; cf. WIGGERMANN 1998-2001, pp. 136-137), bensi AMA nella sua forma arcaica (un rettangolo con dentro il segno AN), tale quale lo si ritrova anche nell'iscrizione di HAR.TU (Cat. 1) e nei testi arcaici di Ur (cf. BUR-ROWS 1935, tav. 26: 319). Per l'interpretazione di lugal-sag4-AMA come lugal-sag4-dagal, "Il Signore è di cuore generoso", cf. SJÖBERG 1973, p. 46 ad 16; e CHARPIN 1986, pp. 358-359 riga 39 (inno ad Asalluhi).
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 217
10. mu-dúd ad una stia statua'6^ (9),
11. en mete na deIKl le ki ág e la chiamo (12):
12. mu mu-né-se^ "Enmeténnàk è colui che Ellil ("Enlil")
a m a ' « (11);
13. dellil-la e la portò (iv 1)
14. é-a dentro il tempio,
iv 1. mu-na-ni-kuq(DU) da/per Ellifi62) (13).
5b) STEIBUE 1982a, pp. 276-277 Lug. 15 ili' (mattone): [ud-ba lugri- digir-da'6 Jl] A quel tempo Lugaldigirda ("Lugalanda")
1'. ala[n-na]-né diede vita ( 2 ) 2'. mu-dúd ad una stia statua (1 ) , 3 '. lugal-digir-da-nu-hug-gá-gír- e la chiamò (4 ) :
[nun] - sè-nu- [kds] 41 mu m[u-né-se21] "Lugaldigirdanuhugga non è mai stanco
per il Gir nun"1441 (3 ) ;
(60) Per il significato "dare vita, mettere al mondo, generare" del verbo dúd (TU) con riferimento a statue, e le relative implicazioni, cf. VÄNSTEPHOÜT 1970, pp. 13-14 con n. 30; e HOROWITZ 2003, pp. 151-152. Le statue non solo erano "messe al mondo", come se fossero esseri viventi, ma in qualche caso ricevevano anche, come questi ultimi, un loro nome pro-prio. Il significato di tali nomi apposti a statue e, più tardi, in età neosumerica, anche ad altri oggetti votivi non è stato ancora sufficientemente indagato. Per il momento, cf. GELB 1956; e G e b h a r d SELZ 1 9 9 7 , p . 1 7 6 c o n n . 1 9 8 ( a p . 1 9 9 ) .
(61) Cf. la nota precedente. La lettura convenzionale "Enlil" è basata su fonti del primo millennio, e probabilmente riflette tuia tarda paretimologia del teonimo in questione. Nel terzo millennio lo stesso era scritto dEN.É, anziché den-lrl. dEN.É è presumibilmente tui logogramma composto del tipo "diri", da leggersi /ellil/ in sumerico e / (h/y)i]lil(u)/ in ac-cadico (cf. da ultimo MARCHESI in stampa, n. 142).
(62) Per il valore /tur/ del segno DU nel significato di "entrare, introdurre", cf. KRE-CHER 1987c. Gli argomenti portati da Gebhard SELZ (1992, p. 253 sub 19) e BAUER (2004) contro questa lettura non paiono tali da invalidarla (si noti che mu-ni-túm-ma-a in En. I 9 ili 10 [STEIBLE 1982a, p. 185] non significa "als er (sie) dort hineingebracht hatte", come vuole Selz, ma piuttosto "quando / dopo che lo [= il tempio] aveva reso degno di lei [= Li'anak]"; cf. ZÓLYOMI 1999a, pp. 179-180).
(63) Letto senza eccezione "lugal-an-da", ma cf. la nota seguente. (64) Girnun, "La grande spada", è tui soprannome o epiteto del tempio di Ningirsùk
a Girsu (cf. p 264 n. 269). Un'altra statua di Lugaldigirda è chiamata, similmente, dnin-rgitr-su1 -gir-nun-sè- diu1 - [k]us, "O Ningirsùk, egli non è mai stanco per il Girntui" (DP óó vi 7; designata come alan gal lugal-digir-da, "la grande statua di Lugaldigirda", ibidem, riga 8). Tali nomi di statue sembrano fare tui giuoco di parole col nome del sovrano, Lugaldigirdanuhugga, "Il re (lugal) che non riposa quando si tratta del (di servire il) dio" (hug = nâhum). La lettura digir-da pare preferibile ad an-da, specie se si considera che il dio-cielo, An, non sembra avere avuto alcun culto a Lagas in epoca protodinastica (cf. Gebhard
218 APPENDICE
pnin-gír- su-ra] [é-a] [mu-na-ni -kui/(DU)]
e la portò dentro il tempio, da/per Ningirsûk.
D'altio canto, due statue da Man con dediche di cantori raffigurano can-tori'65/ e statue con dediche di donne in periodi più tardi sono senza eccezioni femminili'665. Inoltre varie iscrizioni su statua dicono espressamente che la statua è del dedicante; così ad esempio l'epigrafe della statua di Yindin'il ("Abihil/ Ebihil"; Tav. XVII: 2-4), da Mari, del Protodinastico Il lb iniziale'675:
Similmente, Yisklmari ("Isqlmari"), re di Mari, presentò la sua statua a 'Astar virile (?) (Cat. 13); Hin na m'il ("Eniiail"), re di Kis, fece una sua statua e la col-locò al cospetto di In'anak (Cat. 11); Enmetênnâk, viceré di Lagas, diede vita ad una sua statua e la portò nel tempio di Ellil (Cat. 10); e così via.
SELZ 1990, pp. 124 e 132; ID, 1995, p. 24 sub 6). Il termine digir denota qui il dio per eccel-lenza, ossia, a Lagas, Ningirsûk (cf. ibidem, p. 108 sub 2-3). Lugaldigkdatiuhugga è probabil-mente un nome cerimoniale derivato dal nome proprio del sovrano, analogamente ai nomi E'anak'in'anak'ibgalakakka'abtum (é-an-na-fin'anak-ib-gal-ka-ka-a-túm) e Sul'anezudigirenêk (sul-an-né-zu-digir-re-ne) di E'annâbtum e Sulgir, rispettivamente (cf. MARCHESI in stampa, n. 9). Il vero nome per esteso di Lugaldigirda era probabilmente Lugaldigirdanume'a, "H re (non regna) senza il permesso del dio" (VS 27 11° 4 iii 1). Per una diversa interpretazione del nome Lugaldigirdanuhugga, cf. BAUER 1998, pp. 475 e 515 (la quale, però, non rende conto della /a/ finale nella forma verbale /nuhugga/).
(65) Cf. BRÄUN HOLZINGER 1991, p. 220; e BOESE 1996, pp. 34-40 e 46-49. ( 6 6 ) C f . BRAUN HOLZINGER 1 9 9 1 , p . 2 1 9 .
(67) GELB-KJENAST 1990, p. 5 MP 1. Per la datazione, cf. supra, p. 14 n. 22 e p. 89. (68) Generalmente letto, in precedenza, "Abihil" o "Ebihil". Tuttavia ENTI è attestato
come nome di persona ad Ebla, dove è stato plausibilmente interpretato come forma del verbo nadànum (cf. KREBERNIK 1988, pp. 56-57 sub N-D(-N?); e PAGAN 1998, p. 145 sub ndn, e p. 307 s.v. en-tì). Siccome nel terzo millennio il dio/monte Ebih (Gebel Hamrin) non è altrimenti documentato né nel pantheon né nell'onomastica di Mari, un'interpretazione di EN.TT-/7 come en -di-il = /yindin'il/, " 'Il lia dato", pare preferibile (si noti, inoltre, che se EN.TL fosse da intendersi come Ergogramma per Ebih, ci si aspetterebbe che fosse prece-duto dal determinativo divino).
(69) Cf. infra, § A. 1.4 commento a Cat. 13:7.
1. D Ü L
2. en-dì-il 3. NU.BÀNDA 4. TNANAQNITA 5. Ad12-RJE,
di Yindin'il'68/ il soprintendente: egli la presentò (5) a Astar virile (?)169) (4).
Statua
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 219
Il teimine pei statua, sumerico alam/n, accadico saìmum (DUL), significa (e potiebbe tradursi) anche "figura, raffigurazione, immagine"'70/ E quindi pensa-bile che le statue fossero concepite come rappresentazioni dei loro dedicanti. Nel presente lavoro si suppone che le statue con iscrizioni di sovrani h rappre-sentino anche. Si noti ancora, tuttavia, il singolare caso di una statua da Mari, fine terzo / inizio secondo millennio, che reca due differenti e contrastanti iscrizioni171/ mia, in fondo alla veste, è mia dedica a nome di Puzur'estar, sovrano di Mari'72/
1. tu-ra-áda-°an Turamdagan, 2. ALIAD NI [TA]1:731 sakkatiakkum (leti, "generale") 3. mari M di Mari174' -4. PUZUR^aïiàr Puzur'estar, 5. ALDUNITA sakkatiakkum, 6. DUMU-r» suo figlio'76, 7. a-na d[EN.KI] ha presentato (11) 8. BAD-M76 ' [UNKEN] E sua statua (9) 9. UHM. [DÙL-.fe] a Heyya ("Ea")'77' (7), 10. a-\na ba-la-ti-sii\ signore dell'Assemblea (8),
11. [A. MU. RU] per la sua vita (10). 12. [sa DUB] Riguardo a colui 13. \su-a-ti\ che dovesse rimuovere (14) 14. [a-s\ a-sà- vkjC E suddetta iscrizione (12-13), 15. TNANA che 'Estar, 16. àda-tan Dagän 17. Ú dEN.KI e Heyya,
18. BAD-a/UNKEN signore dell'Assemblea, 19. SUHUS-A estirpino (20)
20. li-sû-ha le sue radici (19)
21. ú SE.NUMUN- CD e prendano (22)
22. li-il-qü-tá il suo seme (21)
23. a-dì si-tar-qí-su fino alla sua scomparsa.
( 70 ) Cf. PSD A / 3 , pp. 1 6 0 - 1 7 0 s.v. ahm; CAD S , pp. 7 8 - 8 5 s.v. salmu s.; E BRAUN HOLZ-
INGER 1991, p. 231 .
(71) NASSOUHI 1926; NAGEL 1959b; BRÄUN HOLZINGER 1991, pp. 277-278 St 168. ( 72 ) GELB-KIENAST 1 9 9 0 , p p . 3 6 3 - 3 6 4 M S 9 ; FRAYNE 1 9 9 7 , p p . 4 4 5 H 4 6 E 3 / 2 . 4 . 5 . U 1 -
21. (73) Cf. STEINKELLER 2004b, pp. 176-183.
(74) Titolo dei sovrani di Mari tra la l ine della dominazione accadica e l'avvento della dinastia amorrea (cf. DURAND 1985a, pp. 148-150; e GEIL 1992, pp. 161-162).
(75) Cf. p. 213 n. 46. (76) Cf. STEINKELLER 2004a. ( 77 ) C f . WESTENHOLZ 1 9 7 8 , p . 1 6 8 .
2 2 0 APPENDICE
L'altra, ili un cartiglio posto sotto l'avambraccio destro, è invece ruia label inscription del fratello di questi, Silla'akka'73):
1. P UZ UK-as-tár Puzur'estar, 2. ALIMENTI A sakkanakkum 3. ma-ri di Mari — 4. GVppta-kA SilE'akka, 5. NU. [BANDA] il soprintendente, 6. SE [S-su] suo fratello''9).
Sulla base di quest'ultima iscrizione si sarebbe indotti ad attribuire la statua a Silla'akka, sennonché Puzur'estar dice espressamente che la statua in questione è la sua. Non esiste tuia facile soluzione a tale problema. Non è verosimile che Puzur'estar: abbia usurpato la statua del fratello, tra l'altro senza neppure can-cellare l'iscrizione di questi. Si potrebbe speculare che si tratti di tuia statua di Puzur'estar commissionata e a Itti donata dal fratello, Silla'akka, e su cui il so-vrano di Mari Ira poi fatto incidere una sua iscrizione dedicando la statua al dio Heyya. Resta il fatto, però, che l'iscrizione di Silla'akka è del tutto analoga ad altre label inscriptions che identificano personaggi rappresentati da statue.
A.1.2. Titoli dei sovrani
Nell'ultima fase del periodo protodinastico (Hlb) la regione siró-me sopo ta-nnica appare per lo più frammentata in molteplici formazioni politiche a carat-tere sovraccittadino, usualmente chiamate città-stato (in Mesopotamia) o regni (in Skia). Ogni città-stato aveva una sua capitale, così come capoluoghi e centri minori. Il processo di formazione di tali entità politiche è in gran parte scono-sciuto, né si sa molto della loro organizzazione e delle relative strutture ammini-strative'30).
Tracce di ima precedente egemonia della città settentrionale di Kis su gran parte della Babilonia, al tempo del re di Kis Mësalini, sono ravvisabili nella do-cumentazione sia coeva, sia posteriore'31). I testi di Fara (Proto dina s ti co Illa)
( 7 8 ) GELB-KIENAST 1 9 9 0 , p. 3 6 4 M S 1 0 ; FRAYNE 1 9 9 7 , p. 4 4 6 E 3 / 2 . 4 . 5 . 1 cartouche. (79) Cf. p. 213 n. 46. (80) Cf. da ultimo WFESTENHOLZ 2002. ( 8 1 ) Cf. COOPER 1983, p. 7 con n. 5, e p. 22; ID, 2000, p. 65 con n. 8; e STEINKELLER
1993a, p. 118 con n. 22. L'impiego del titolo di "re di Kis" (lugal kisi2) nel Protodinastico B i b da parte di sovrani sumerici con aspirazioni di grandeur (i quali però verosimilmente non arrivarono mai a conquistare e governare E città di Kis) è pure probabilmente un riflesso di tale passata egemonia (cf. MAEDA 1 9 8 1 ; e STEINKELLER 1993a, p. 120).
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 221
documentano anche l'esistenza di un qualche tipo di unione tía le principali città del sud sumerico {la cosiddetta Kengir League o "Esapoli di Sumppak"), con l'ec-cezione della più meridionale Uri82-1. Non è chiaro però se tale unione rappre-senti ima qualche forma di alleanza o lega, o se rifletta invece, come pare più probabile, l'assoggettamento di queste città al dominio di Kis!a3/
L'intero paese di Sumer, ad eccezione della città-stato di Lagas/Girsu, tra-dizionalmente a sé stante, e della città santa di Nippur, feudo inalienabile del dio supremo Ellil, verrà ¿unificato alla fine del Protodinastico Illb ad opera dei re di Uruk Ensagkus'anak ("Ens a bus arma") e Lugalzagesi1®4/ prima di finire di nuovo nelle mani di un potentato del nord (Akkad).
Al vertice della città-stato c'era un gruppo di alti funzionari con vari in-carichi amministrativi o rehgiosi — tutti soggetti, comunque, all'autorità del so-vrano o principe locale. Al fianco di questi era la di lui consorte, la quale sembra godesse di pari dignità, e disponesse di beni e terreni propri, cosi come di un'or-ganizzazione amministrativa che faceva capo alla sua persona185/ L'esistenza di organi decisionali e/o consultivi collegiali, quali Assemblea Cittadina e/o Con-siglio degli Anziani, è desumibile da sporadici riferimenti nei testi186-1, ma poco o nulla si sa circa gli ambiti di competenza e il potere di tali istituzioni.
( 82 ) C f . JACOBSEN 1 9 5 7 , p p . 1 2 1 - 1 2 2 ; VLSICATO 1 9 8 9 ; STEIBLE-YILDIZ 1 9 9 3 ; e POMPONIO
VISICATO 1994, pp. 10-20.
(83) Cf. POMPONIO-VlSICATO 1994, pp. 15-17. LI tal caso, si potrebbe supporre che i testi di Fara riflettano la situazione politica del tempo di Mesalim. E piuttosto verosimile, infatti, che il regno di questi segni la fase di massima espansione verso sud di Kis, a giudicare dalle sue iscrizioni originali e dalle varie tradizioni che si sono conservate su di lui. Ad Adab, dove celebra il sacro rito del bur-gi4 (STEIBLE 1982b, p. 216 Kis: Mes. 2; Tav. XV: 2), egli è "l'amato figlio di Ninhursagak" (STEIBLE 1982h, p. 217 Kis: Mes. 3; Tav XIV: 3); è "l'edificatore di Ningirsùk" a Lagas (cf. supra, p. 216 sub 4c con n. 58); il costruttore dell'Ebabbar, il tempio del dio-sole Utu, a Larsa (ALSTER 1997, p. 218 14.16); colui che ha fissato il confine tra Lagas e Ultima sancendolo con l'erezione in loco delle sue stele, ancora visibili e giuridicamente rilevanti molto tempo dopo la sua morte (STEIBLE 1982a, p. 160 Earn 7 iv ' 5-10, pp. 230-231 Eut. 28-29 i 1-12, e pp. 234-235 Ent. 28 ii 6-8 = 29 ii 23-25). Le città-stato di Uruk (di cui faceva parte la città di Larsa nel Protodinastico III), Lagas, Umma e Adab sembra siano state quindi sotto il suo controllo ad un certo punto. E forse non è una coincidenza che proprio queste stesse città costituiscano, assieme a Nippur e Suruppak, l'unione di città nota convenzionalmente come Kenp/r League. Il ritrovamento a Girsu, sotto il livello del tempio di Ningirsùk costruito da Uman i èk ("Urnanse"), di tuta mazza votiva di Mësalim (Tav. XI: 10), associata con alcuni testi del tipo "Fara" (RTC 1-8; cf. supra, pp. 60-61 con n. 108), ben si accorda con tale ipotesi.
( 84 ) C f . MAEDA 1 9 8 1 , p p . 5 - 7 ; e POMPONIO 1 9 9 4 , p p . 1 - 5 .
(85) Cf. MAEKAWA 1973-1974; e MARCHESI 2004, p. 176 n. 140. (86) Cf. GELB 1984, p. 273; e RIDLEY 2000. Si noti anche il NP Unken'ugèdug (unken-
ùg-dùg), "L'Assemblea è gradita al popolo" (MARCHESI 2004, p. 193).
222 APPENDICE
La frammentazione geopolitica suaccennata è rispecchiata anche dalla mol-teplicità dei termini usati per designare il supremo capo politico. A seconda dei tempi, luoghi e circostanze politiche, il leader della città-stato è variamente chiamato en, lugal, "ensi(k)"'S7/ sarrum (LUGAL), rubä'um (NUN)'3^ o maìkum (EN)'895.
Il primo di questi titoli, en, solitamente tradotto come "signore" (arcadico belunPf, o "sommo sacerdote" (arcadico ënum), sembra essere stato peculiare della città di Uruk, e avere avuto, almeno in origine, forti connotazioni reli-giose'915. Altrove en è usato solo come titolo divino'925 o religioso'935, e, al plurale, come designazione collettiva per i defunti illustri'945.
lugal, tradotto hi arcadico come sarrum (paleo arcadie o sarrum), "re", significa piti precisamente "padrone", come si evince da espressioni legali come lugal asag-ga, "padrone del terreno", lugal é(-a), "padrone della casa", ecc.'955; e dal
(87) Lettura convenzionale (e prob abilmente non corretta; cf. p. 223 n. 97), qui mante-nuta solo per convenienza ai fini della discussione.
(88) Titolo del sovrano di Kis nella cosiddetta "Names and Professions List" (cf. Bo-NECHI 2001a).
(89) Quest'ultimo peculiare della regione siriana e scritto per lo più logogríf icamente mediante il segno EN o, più raramente, l 'accadogramma AÍA.-U.K (cf. ARCHI 1987b, pp. 37-38).
(90) Si noti però che tale equivalenza non è attestata prima del periodo mediobabilo-
( 91 ) C f . JACOBSEN 1 9 9 1 , p p . 1 1 6 - 1 1 8 ; HEIMPEL 1 9 9 2 , p p . 8 - 1 3 ; STEINKELLER 1 9 9 9 ; e
GOODNICK WESTENHOLZ 2 0 0 0 .
(92) Cf. ad esempio STEIBLE 1982a, pp. 219-220 Ent. 16 ii 8 - iv 3: ud-ba / irH-ra-né / du-du / sagga dnin-gír-sú-ka-ke+ / . . . / bàd kar má-addrq / gír-sú mu-fú / en-zi-sagy-gál / mu mu-na-se21, ' A quel tempo il suo servitore Dudu, l'amministratore templare di Ningirsûk, . . . costruì la fortificazione del porto per le chiatte di Girsu e per lui (= Ningirsûk) la chiamò Enzisaggal ("Il Signore è soffio vitale")". Analogamente, nei nomi propri di persona il ter-mine en (cosi come lugal) lia per referente di regola una divinità, tranne in quei casi in cui en (lugal) compare assieme ad un altro e più specifico elemento teoforo (cf. E nota seguente).
(93) Cf., a Lagas, i NNP en-Lianse-ki-ág, "L'e« è colui che Nanse ama" (STRUVE 1984, p. 59), ed en-dnanse-mu-dúd, "L'e» l 'ha generato Nanse" (DP 175 ii 3). In ambedue i casi en designa il sommo sacerdote della dea Nanse, altrimenti noto col titolo di dam Nanse, "sposo di Nanse" (cf. STEINKELLER 1999, pp. 118-120). Sporadiche attestazioni di un en e di una "casa dell'I'«" (é en-na) nei testi amministrativi presargonici di Girsu (cf. Gebhard SET .7 1995, p. 117) si riferiscono presumibilmente a tale figura. Si noti, infine, il titolo o epiteto en zag keseq(KES) deres-ura4-ke4, "l'è» che Eres'ura ("Ninurra") ha legato al (suo) fianco", portato dal re di Umma Gessagkidug (STEIBLE 1982b, p. 326 Uruk: Luzag. 2:9; per l'attribuzione di tale iscrizione, conosciuta anche come "La Frontiera di Sara", a Gessagkidug ["Gissakidu"], piuttosto che a Lugalzagesi, cf. FRAYNE in stampa: E 1.12.5.2).
( 94 ) Cf. STEINKELLER 1 9 9 9 , pp. 110-111 conn . 2 9 .
( 95 ) C f . GELB et al. 1 9 9 1 , p . 2 2 7 ; ROTH 1 9 9 5 , p . 2 8 ; e c c .
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 223
suo uso in formule reverenziali in iscrizioni votive, preghiere o lettere, per rivol-gersi a un dio, al re, o comunque a un superiore'9^.
"eiisifk)" (accadico issijakkum/issi'akkum) — variamente scritto (NIG.)PA.SI o (NIG.)PA.TE.SI, e convenzionalmente traslitterato ensik/énsi'97) (= PA.TE. SI) o ensi(k)z (= PA. SI/NÍG.PA. SI/NÍG.PA.TE.SI) - pare designasse in origine un amministratore terriero o uri funzionario incaricato di dirigere i lavori agri-coli'98! Quantunque l'etimologia del termine sia incerta199/ il Ergogramma con cui è scritto, (NIG.)PA.TE.SI, suggerisce il significato di "colui che è adatto (TE) al bastone di comando ((NÌG.)PA)"'100/ Come titolo regale "ensi(k)" sottintende la concezione che il sovrano regni per conto del dio poliade (cioè del dio prin-cipale della città-stato, capo del pantheon locale), ovvero amministri i beni e le proprietà di quest'ultimo, ritenuto in definitiva il vero padrone e sovrano del regno'101'. Pertanto "ensi(k)" è tradotto qui come "viceré".
L'ideologia che turóle il dio poliade essere il vero signore della città-stato la si ritrova, peraltro, anche laddove il sovrano porta generalmente il titolo di lugal, come ad esempio a Kis. Nella cosiddetta "Names and Professions List", una composizione lessicale protodinastica nota da Abu Salabikh ed Ebla, fi sovrano di tale città è chiamato mbà'urn (NUN), "principe", mentre fi titolo di "re di Kis" (LUGAL KISF) è attribuito al dio Zababa'102'. E a Teli Agrab, nell'iscrizione
( 96 ) C f . KRECHER 1 9 7 2 , p . 2 7 1 .
(97) La lettura /ensi(k)/ per PA.TE.SI non è affatto così ben stabilita come si potrebbe essere indotti a credere dal suo diffuso impiego. Di fatto non è attestata alcuna scrittura sillabica come en-si o simile, clie la supporti. In testi lessicali o scritti in sumerico sillabico si trovano le forme ni-in-si (FRAYNE 1997, p. 1 4 6 E 3 / 2 . 1 . 2 3 8 : 1 8 ) , im-sik (EDZARD 1974a, p. 3 2 ) e is-se (ARNAUD 1987, p. 47 riga 11), tutte riconducibili, assieme al prestito isiifyakkum in accadico, ad un etimo *ninsi'ak o, più probabilmente, Gunsi 'ak.
( 98 ) Cf. JACOBSEN 1 9 9 1 ; e SJÖBERG 1 9 9 6 , pp. 1 2 5 - 1 2 6 adii 16 . Tale accezione originaria sembra sopravvivere nel titolo PA.TE.SI-gal ("énsi-gal") ND, portato da alcuni sovrani e divinità (WLLCKE 1 9 8 5 , pp. 3 0 2 - 3 0 3 ; ID. 1 9 9 7 , p. 2 1 n. 4 5 ; JACOBSEN 1 9 9 1 , pp. 1 1 3 - 1 1 4 ; cf. anclie infra, § A . 1 . 4 commento a Cat. 1 3 : 3 - 4 ) , e nella designazione PA.TE.SI-gal ("énsi-gal") per un ufficiale di rango inferiore rispetto ail'"ensi(k)" (JACOBSEN 1 9 9 1 , p. 114 ) .
(99) Per un'interpretazione etimologica piuttosto dubbia (tra l'altro già respinta da ED-ZARD 1 9 7 4 b , p . 1 4 6 ) , c f . JACOBSEN 1 9 5 7 , p . 1 2 3 t i . 7 1 ; e ID. 1 9 9 1 , p . 1 1 5 .
(100) Cf. JACOBSEN 1991, pp. 119-120. Il segno SI è probabilmente un complemento fonetico aggiunto al logogramma propriamente detto, (NtG.)PA.TE, per indicare che questo deve essere letto /. . .s iyak/. E possibile che anche N l G in NÍG.PA.TE.SI sia da interpretarsi come tale, supponendo che /n/ muti in /g/ davanti a /s/ (cf. Gig-sig^(SAR) per ' i l ia-sigj 'SAR) in RTC 8 ii 6) e che Gurisi 'ak (cf. supra, n. 97) fosse quindi pronunciato /nigsiyak/; in tal caso avremmo una scrittura del tipo ^gestug®, ossia Giigsi 'ak (PA.TE)". Altrimenti NlG.PA si spiega come una variante ortografica di PA, il logogramma per "ba-stone di comando, scettro" (cf. infra, § A. 1.4 commento a Cat. 1:2).
(101) Cf. STEINKELLER 1993a, p. 117. ( 1 0 2 ) C f . ARCHI 1 9 8 1 ; e BONECHI 2 0 0 1 a .
224 APPENDICE
della statua Cat. 1, il Te" (lugal) si professa comunque "servitore" (subur) del dio poliade Huma'tim.
Pur avendo connotazioni diverse, i titoli "ensi(k)" e lugal paiono in ima qualche misura intercambia bili (103Z il sovrano terreno è viceré rispetto al dio, e re rispetto alla popolazione della città-sta to'104/ L'uso di un titolo piuttosto che l'altro potrebbe essere dipeso dalle tradizioni delle singole città-stato; o dalla scelta politica e ideologica di voler enfatizzare l'uno piuttosto che l'altro di questi due aspetti della regalità.
In qualche caso, però, il viceré di mia città-stato risulta essere stato sotto l'egemonia del re di un'altra città-s ta to'105/ o di un "grande re" (overlord)'la6'!. Il fatto che il termine "ensi(k)" fosse legato ili qualche modo alla nozione di governo del territorio del dio poliade su incarico di questi ha fatto sì che lugal, privo di tali associazioni, fosse preferito da quei sovrani che volevano estendere la propria autorità al di fuori dei confini della loro città-stato; e ha portato, in ultima analisi, all'emergere di tale titolo come il titolo regale per eccellenza. Contemporaneamente "ensi(k)" è venuto ad assumere, al tempo della III Dinastia di Ur, il significato di "governatore di provincia nominato dal re".
Tuttavia non c'è dubbio che a Lagas, nel Protodinastico Illb, il titolo "ensi(k)" denotasse un sovrano uidipelidente. Se cosi sia stato anche altrove e nelle altre fasi dell'età protodinastica limane controverso. Secondo Edzard, non è possibile fare mia differenza di rango tra "ensi(k)" e lugal per i tempi che pre-cedono Ere'inimgiiiàk ("Tjrukagiiia"; cf. p. 210 n. 26) e Lugalzagesf107'; mentre per Cooper, il primo termine lia piuttosto l'accezione di "governor, subordi-nate local ruler", quando è usato al di fuori di Lagas nel Protodiiiastico Illb1'108/ Qnest'tiltimo ha inoltre suggerito che l'impiego del titolo "ensi(k)" da parte dei sovrani indipendenti di Lagas sia in qualche modo un riflesso della passata ege-monia di Kis, così come l'uso di sakkanakkum o issi'/jakkum da parte dei so-vrani indipendenti di Mari, Der, Esnunak e Assur, più tardi, riflette la passata dominazione di queste città da parte dei re di Akkad o di Ur III, ossia il tempo
(103) Così è almeno a Lagas (cf. HEIMPEL 1992, pp. 6-8). ( 1 0 4 ) C f . STHTNKTTI.HR 1 9 9 9 , p . 1 1 2 c o n n . 3 3 .
(105) Cf. COOPER 1983, pp. 7, 9 n. 17; e ID. 2000, p. 65 con n. 8. (106) Cf. BIN 8 n" 26 vi 3-7: mes-ki-gal-la / PA[.TE].SI /rurabu i(UD."NUN") l9 /
lugal-zag-ge-si / lugal, "Meskigalla (I) viceré di Adab e Lugalzagesi l e (del Paese)". Si noti anche la menzione, in MVN 3 n° 105 ii 1 (sempre da Adab), di una "casa delle truppe del Paese" (é éren kalam-ma-ke^, le quali erano verosimilmente le truppe del "re del Paese" Lugalzagesi, o del suo predecessore, con tale titolo, Ensagkus'anak.
(107) EDZARD 1974b, p. 144. ( 1 0 8 ) COOPER 2 0 0 0 , p . 6 5 n . 8 .
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 2 2 5
ili cui ie suddette città erano governate da alti ufficiali al servizio del re che por-tavano per l'appunto tali titoli1109/
L'ipotesi di Cooper sembra trovare un qualche supporto nella menzione dell"'en si (k)" (PA.TE.SI) dopo il "principe" (NUN) e prima di altri alti fun-zionati quali, nell'ordine, il "contabile (del re)" (UMBISAG), il "responsabile del catasto" (SAG.DTQ, lo "scriba (del re)" (DUB.SAR), il capo dell'esercito (AEIVUNITA), il soprintendente al bestiame (?) (GUD.ÚS), "l'eminente del Paese/popolo" (URUN..KAEAM/ÙG), il "caposegretano" (GAL.SUKKAL), e cosi via, nella succitata "Names arid Professions List"1110/ E verosimile, infatti, che il suddetto elenco rifletta l'organigramma dello stato di Kis al tempo in cui fu composta tale lista1111/ e che qui "ensi(k)" denoti un ufficiale subalterno al re, ma superiore a tuffi gli altri funzionari1112/
D'altra parte, è concepibile che il rango dell'"ensi(k)" e la valenza di tale titolo varino a seconda dei luoghi e dei tempi. I sovrani di Lagas attribuivano il loro stesso titolo, "ensi(k)", ai loro omologhi di altre città-stato sumeriche1113/ ma non ai re della Babilonia settentrionale, chiamati invece invariabilmente lugal1114). In altre parole, ai loro ocelli i termini "ensi(k)" e lugal erario intercambiabili solo con riferimento a un sovrano sumerico del sud. Il che potrebbe implicare un differente significato di "ensi(k)" nel nord accadofono.
E altresì possibile che, fuori di Lagas, "ensi(k)" fosse considerato un titolo inferiore rispetto a lugal, e fosse indice di un minor grado di indipendenza o autonomia da parte di quei reggenti di città-stato che lo portavano. L'uso del titolo PA.TE.SI kisi1/ anziché lugal kisA, da parte di un règolo di Kis del Proto dinasti co Il lb (?)1115) potrebbe così riflettere una fase di decadenza della grande città della Babilonia settentrionale, ora non più egemone, ma subal-terna ad un altro centro111^. Parimenti, l'alternanza, ad Adab, dei titoli lugal
(109) Ibidem. Si noti però che Urnansék, il fondatore della cosiddetta "Prima Dinastia di Lagas", porta il titolo di lugal nelle sue iscrizioni.
( 1 1 0 ) C f . ARCHI 1 9 8 1 , p . 1 8 1 ; ID. 1 9 8 4 b , p . 1 7 1 ; e BONECHI 2 0 0 1 a .
( 1 1 1 ) C f . ARCHI 1 9 8 1 , p p . 1 7 7 - 1 8 0 .
(112) Si noti anche l'occorrenza, unica, nella medesima Usta (riga 52), di un PA.TE.SI B À N D A , "vice-'ensi(k)"' (ARCHI 1981, p. 182).
( 1 1 3 ) C f . BEHREXS-STEIBLE 1 9 8 3 , p p . 1 1 6 - 1 1 7 sub e - f .
(114) Ibidem, pp. 223-224 sub b ed e (1', 3' ed 8'). ( 1 1 5 ) C f . GELB-KIENAST 1 9 9 0 , p . 3 1 V P 1 0 .
(116) Cf. WESTENHOLZ 1999, pp. 29-30 con n. 58. La datazione di questa iscrizione al tardo Protodinastico non è però sicura: potrebbe benissimo trattarsi di un governatore in-sediato a Kis dal re di Akkad Sarrumkm ("Sargon") o da uno dei suoi due figli, Man'istüsu e Rlmus. Secondo READE (2000b), il frammento che reca l'iscrizione faceva parte di un vaso avente anche tuia seconda epigrafe: tuia dedica da parte di un tale, di cui non è conser-vato il nome, che si Regia dell'epiteto di "conquistatore di Hamazi" (ÂGA.SÊ ha-ma-gi"', cf. GELB-KIENAST 1990, p. 32 VP 11). Se le due iscrizioni sono state apposte in tempi diversi, come sostiene READE (he. cit.), è forse ipotizzabile che il vaso in questione facesse parte di
226 APPENDICE
urabu ^ e (NÍG.) PA.TE.SI uiabujA (117) potrebbe denotare alterne fasi di so-vranità e vassallaggio della suddetta città-stato; oltre al dominio di Kis nel Pro to dina s tico Illa, già ricordato (cf. p. 221 n. 83), v'è infatti qualche indizio della sottomissione di Adab prima ad Umma!118J e poi ad Uruk (cf. p. 224 n. 1 0 6 ) , nella seconda metà del Proto dina s tico IIIb (119B
un qualche bottino di guerra e che, come tale, sia stato ridedicato secondariamente dal suo
razziatore ad un proprio dio.
(117) Cf. AL MuTAWAm-MiGLUS 2002, p. 8.
(118) Se si può interpretare come tale il ritrovamento ad Adab di due esemplari del-
l'iscrizione del re di I ITTI ma Gessagkidug nota come "La Frontiera di Saia" (cf. YANG 1989,
p. 17 con ri. 31; WESTENHOLZ 1987-1990, p. 156; e supra, p. 222 n. 93). Si noti come que-
st'ultimo rechi, unico tra i sovrani protodinastici di Umilia, il titolo di PA.TE.SI kalag-ga dellil-ke4, "potente 'erisi(k)' di Ellil", che prefigura il PA.TE.SI-gal dellil portato dai "grandi
re" Lugalzagezi e Sarrumkrn (cf. infra § A.1.4 commento a Cat. 13:3-4). Le ambizioni di
egemonia e grandezza di Gessagkidug sono rese manifeste anche dai suoi epiteti nir-gál sag-
hus ki-en-gi-ke4, "il fiero principe di Sumer", e gaba-gál nu-gi4 kur-kur-ra-ke4, "l'inarrestabile
fronteggiatore di tutti i paesi stranieri".
( 1 1 9 ) La "notizia che Adab è stata presa" (NÍG.MUL urab tA S U B A R U ) in un do-
cumento amministrativo di Ebla del 22° atino di regno di Yisgaidämu (MEE 10 n" 29 v.
iii 2 6 - 2 8 ; cf. S ALLABERGER. 2 0 0 3 ) è stata interpretata da SAIIABERGER (in stampa) come un'
eco della conquista della città da parte di Lugalzagesi. Secondo Sallaberger questo evento
dovrebbe essersi verificato prima del 7° armo di regno di Lugalzagesi, dal momento che
alcuni testi da Zabala datati a tale anno registrano assegnazioni di terreni ai viceré di Adab
e Nippur, cosi come ad un alto prelato (lti-mah) di Uruk. Facendo propria l'opinione di
POWELL ( 1 9 7 8 , p. 2 7 ) , che "the right by which they hold diese allotments . . . must be via
their political relationship widi die head of die state", egli presume che i suddetti documenti
attestino la dipendenza di Adab, Nippur e Uruk da Lugalzagesi nell'anno 7 di questi (cf.
anche ARCHI-BIGA 2 0 0 3 , p 3 3 ) . Tuttavia i testi in questione ( B I N 8 i r 8 2 ; POWELL 1 9 7 8 , pp.
34-35; e M. DEJ. ELUS 1979, pp. 4 0 - 4 3 BMC 6 - 7 ) sono sì datati al 7 ° anno di Lugalzagesi,
ma non come re, quanto piuttosto come viceré di Umma (lugal-zag-ge-si PA.TE.SI 7; cf. p.
227 n. 122). Al tempo della loro redazione, Lugalzagesi era verosimilmente ancora un sem-
plice viceré, al pari dei suoi omologhi di Adab e Nippur menzionati in quei testi; e tutti e tre
erano presumibilmente sotto l 'egemonia del "grande re" Ensagkus'anak di Uruk. Infatti, una
volta salito sul trono di Uruk e divenuto "re del Paese" (lugal kalam-ma), Lugalzagesi non
solo non usa più il titolo di "ensi(k)", ma anche affida l'ufficio di viceré di Umma a Mes'e
— verosimilmente lo stesso personaggio che compare nei testi di Lugalzagesi da Zabala col
titolo di dub-sar mah, "sommo scriba" (cf. POWELL 1978, p. 1 7 ; e BALER 1998, p. 495). Per-
tanto il sincronismo Yisgardämu 2 2 = Lugalzagesi 1 ~ 7 , suggerito da SALLABERGER. {loc. citi),
non può essere accettato.
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 227
L'adozione del titolo PA.TE.SI GIS.KÚSU^120-' da parte degli ultimi reggenti di Umma, Me'anêdug1121-1, U'u ("Bubu") e Lugalzagesi1122-', in luogo di lugal GIS. KUSUM/HIXDISC123), usato dai loro predecessori1124'1, coincide significativamente con raffermarsi del re di Uruk Ensagkus'anab come "signore di Sumer" (en ki-en-gi) e "re del Paese" (lugal kalam-ma). Non è probabilmente un caso che al tempo di questi e del suo successore Lugalzagesi non sia attestato alcun reg-gente di una città-stato sumerica che porti il titolo di "re" (lugal), tranne che nel-l'indipendente Lagas, dove, paradossalmente, i sovrani erano tradizionalmente chiamati "ensi(k)". Ed è verosimilmente proprio per sottolineare il suo status di sovrano indipendente che l'ultimo principe presargonico di Lagas, Ere'inim-ginâk, cambiò il suo titolo da "ensi(k)" a lugal nel suo secondo anno di regno, ricominciando altresì a contare gli anni dal momento dell'adozione del nuovo titolo(125>.
LTn ultimo punto merita ancora di essere evidenziato. Anche quando è sog-getta all'egemonia di un re "straniero", la città-stato sumerica rimane comunque un feudo del dio poliade, e l'"ensi(k)" espressione della scelta e volontà di questi. Due iscrizioni pubblicate di recente ben dimostrano tale persistente forza del-l'ideologia della città-stato. La prima, incisa su un vaso, è ima dedica in due parti per la vita di Meskigalla E™1' di Adab:
(120) Sul problema della lettura del logogramma GIS.KUSU, cf. infra, § A. 1.4 commento a Cat. 5:3.
(121) me-an-né-dùg PA.TE.SI compare alla fine di una tavoletta inedita, simile, per forma e contenuto, ad alcuni dei cosiddetti "Testi di Lugalzagesi" da Zabala (WESTENHOIZ s.d., p. 26 ad [SC] 2824). I toponimi kar-na+ e mar-da assicurano la provenienza della sud-detta tavoletta da Umma o da Zabala (cf. POWELL 1978, pp. 14-15). Per l'interpretazione di me-an-né-dùg come Me'anèdug (< Me'ane'idug), cf. MARCHESI 2004, pp. 190-191.
(122) Cf. CDU-, P235681 i 2-7: lugal-zag-ge-si / PA.TE.SI GIS.KÚSLfi / lú-mah dniníabak (MISABA)-ke+ / dumu ú-ú / PA.TE.SI GIS.KÚSlP* / lú-mah dninrabak (NISABA)-ka-ke4, "Lugalzagesi, viceré di Umma, lumah di Ninfabak ("Nisaba"), figlio di U'u, viceré di Umma, lumah di Ninfabak" (sulla lettura del nome ú-ú, cf. MARCHESI 2002, p. 171 n. 105; per il titolo sacerdotale lú-mah dninfabaks, portato sia da Lugalzagesi che dal padre, cf. STEINKELLER 2003a).
(123) Lettura e significato del segno HIXDIS in tale titolo sono sconosciuti. Si noti che HI X DIS non è mai scritto col determinativo di luogo il che rende una sua interpretazione come toponimo (cf. W G. LAMBERT 1990a, p. 78; D. Frayne apud Gebhard SELZ 2003b, p. 507; e KREBERNIK 2003b, p. 166 n. 125) pedomeno questionabile. D'altra parte, l'interpre-tazione alternativa "re di 216.000 (uomini)", proposta da POMPONIO (1989, p. 25 n. 4), non sembra possibile (261.000 è SÁRXDIS, o più precisamente SÁRXGÉS, "3600 X 60"; i segni HI e SAR sono chiaramente distinti nelle scdttura "monumentale" protodinastica: il primo ha la forma di un rombo, il secondo quella di un cerchio).
(124) Cf. STEELE 1982b, pp. 265-269. (125) Cf. msTENHOLZ 2002, p. 29. (126) Cf . MARCHESI 2 0 0 4 , p. 1 8 3 n . 174 .
228 APPENDICE
1. dbarag-dellil-gar A Barag'ellilegarra, 2. lugal uiabugUD.1 'NUN' f re di Adab, 3. é-zi-sag4"gál EzisaggaL, 4. ugula àga-ùs-ke4 caposquadra dei soldati, 5. nam-ti per la vita ó. mes-ki-gal-la di Meskigalla, 7. PA.TE.SI viceré 8. ufabu s(UD."NUN")Nsè di Adab, 9. a mu-na-ru ha presentato (questo vaso)
B 1. 2. 3. 4.
mes-ki-gal-la NÍG.PA.TE.SI uíabu (UD-TSTUN")11
lú é diskut fú-a (lesto rotto)
MeskigaLa, viceré di Adab, il costruttore del tempio di Iskur,
(127)
Quantunque Adab sia assoggettata al te di Uiuk Lugalzagesi, al tempo di Meskigalla I (cf. p. 224 n. 106), nominalmente il sovrano della città-stato è ancora il dio poliade, ossia, nel caso specifico, Barag'eMegarra(m). Ancor più istruttiva, al riguardo, è l'iscrizione frammentaria stilla statua di un ignoto viceré di Suruppak del tempo di Rlmus1129-1:
1. [. . .(-ra)] A(l/lla dio/dea) 2. [ . . . ] NP, 3. [(NI G.) PA. TE. SI] viceré 4. isuruppagi fagak[eJ di Suruppak, 5. sag4"ge pàd-da il prescelto ó. dsùd-da-[ke4l l i0 i] di Sudi15«, 7. mu pà[d-da] il designato di
(127) Piasa, Archéologe, Vente du 17-18 mars 2003, Paris, i l" 42. (128) "Il sovrano stabilito da Ellil": probabilmente nome di una forma o ipostasi del dio
Asgi; cf. AN = Anum II 60 (LTEKE 1998, p. 73). (129) YBC 2451. L'iscrizione in questione fu identificata da citi scrive, durante una breve
visita alla Yale Babylonian Collection nella primavera del 2003. Successivamente, nell'au-tunno dello stesso anno, questa è stata di nuovo identificata da E. Frahm, il quale l 'ha poi pubblicata assieme a E. Payne (cf. FRAHM-PAYNE 2003-2004), peraltro con varie imprecisioni che giustificano la nuova edizione qui presentata.
(130) Quantunque non sia integrato da Frahm, la scrittura del suffisso ergativo alla riga 4 implica la sua presenza anche alle righe 6 e 8.
(131) La traduzione di Frahm, "chosen in the heart of the goddess Sud" (FRAHM-PAYNE 2003-2004, p. 51) è agrammaticale. L'espressione sag,-ge pàd-da dsùd-da-ke4 letteralmente significa "colui che Sud ha trovato adatto al (suo) cuore" (cf. KRECHER 1987a, p. 77) o "colui che Sud ha fatto trovare al (suo) cuore" (cf. ZÓLYOMI 1999b, pp. 243-244). Quale che
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 2 2 9
8. 9 .
10. t i . 12.
Tnn-gedruJPA)-k[a-kej Ningedrùk'13'', pei La vita del suo signore'113', Rlmus, re di Kis,
nam-ti lugal-né rí-mu-ús tiugal kisi1 -[(ka-)sè] (resto rotto)
Piti riconoscendo la sua sudditanza nei confronti del "grande re" Rlmus, P"ensi(k)" di Suruppak nondimeno sottolinea come egli sia tale non grazie a questi, ma in quanto eletto dalle divinità maggiori della sua città-sta to'134'. Che questa sia ora ridotta a provincia dell'impero accadico è solo un fatto contin-gente, tm accidente, per cosi dire, della storia. L'ordine del cosmo è stato prefis-sato dal dio supremo Ellil ima volta per tutte all'alba dei tempi. Egli ha decretato che Suruppak appartenesse alla dea Sud'1355, e tale proprietà non può essere alie-nata da nessuno, nemmeno dai potenti sovrani di Akkad, che pure conquista-rono e assoggettarono tutta la Babilonia.
A.1.3. Determinazione del corpus
Sulla scorta delle osservazioni contenute nei due paragrafi precedenti, si considera qui come regale ogni statua che presenti l'iscrizione o di un lugal/ sarrum, o di un "ensi(k)", o di un en (di Uruk), o di tm rubä'um, o di un maìkum. In realtà solo iscrizioni di sovrani o principi che recano i primi due titoli sono attestate. Inoltre, è stata inclusa nella presente raccolta anche la statua di un personaggio che non porta nessuno dei titoli suddetti. Le dimensioni eccezio-nali della statua in questione (Cat. 12a; cf. supra, pp. 135-137) e la lunga serie di
sia l'esatta lesa let telale, è chiaro che si tratta di un'espressione idiomatica per indicare l'ele-zione dell"Lensi(k)" da parte della dea Sud, o la predilezione di questa per quello.
( 1 3 2 ) Rigettata da Frahm (FRAHM-PAYNE 2 0 0 3 - 2 0 0 4 , p. 5 1 n. 18 ) , la lettura dnin-gidru, o piuttosto dnrn-gediu (in ragione della forma eme sai, citata sotto), è tuttavia probabilmente corretta qui. Esistono infatti due divinità il cui nome è scritto dNIN-PA: dNIN-had e dnin-gedrtiT-k); ma il genitivo dNIN-PA-ka-k(e4) assicura che si tratti della seconda (il genitivo di dNIN-had è dNIN-had-da; cf. MARCHESI in stampa, n. 134). Inoltre, nei testi di Suruppak il dio dNIN-PA è associato alla dea Ares-me-su-du, (cf. MARTIN et al. 2 0 0 1 , pp. 1 1 0 - 1 1 1 ) ;
queste due divinità si ritrovano associate anche in testi più tardi scritti in emesal: qui dNIN-PA compare come T Tmi in mudi irti Te (ù-mu-un-mu-duriu/umun-mu-du-ru), che è l'equivalente emesal di Ningedrûk.
( 1 3 3 ) E non "of his king" (FRAHM-PAYNE 2 0 0 3 - 2 0 0 4 , p. 5 1 ) : lugal in unione con un aggettivo possessivo non significa "re", ma piuttosto "signore, padrone" (cf. KRECHER 1972, p. 2 7 1 ) .
( 1 3 4 ) C f . FRAHM-PAYNE 2 0 0 3 - 2 0 0 4 , p p . 5 4 - 5 5 .
( 1 3 5 ) Cf. CIVIL 1 9 6 9 B , pp. 1 4 0 - 1 4 1 righe 8 8 - 9 8 ; e BIGGS 1 9 7 4 , p. 5 1 righe 1 8 0 - 1 8 1 .
230 APPENDICE
epiteti che seguono il nome del dedicante'136' inducono a ritenere che si tratti assai probabilmente di un monumento regale, nonostante l'assenza, nell'iscri-zione, di un chiaro titolo di sovrano come sarrum o maìkum. Benché rari, oggetti votivi con epigrafi di re il cui nome non sia accompagnato da alctm titolo regale sono nondimeno documentati'137'. E questo potrebbe essere il caso, anche, di una statua del Piotodinastico Illa (Tav XLIII: 5-6) che reca un'iscrizione piut-tosto singolare:
1. sùbur 2. nigir 3. Gin-é-gal 4. É(-)FÚ
Per cominciare, fi titolo nigir dnin é gal, "araldo di Niriegalak", non è al-trimenti attestato, né si sa di alctmo che sia similmente designato araldo di mia qualche divinità. E pertanto concepibile, forse, che non si tratti tanto di un nome o titolo di professione, quanto piuttosto di un epiteto. Come tale, nigir dnin-é-gal ben si adatterebbe alla figura di un sovrano. Chi potrebbe definirsi portavoce della dea Niriegalak, alias Irianak'139', se non il re medesimo?
Quanto a é(-)fú, in questo periodo lo si può interpretare sia come nome, ossia é-rú, "l'edificatore"; sia come scrittura "nucleare" per la frase é(-né) (mu-un )m, "ha costruito la sua casa"'140'. Il che anche farebbe pensare ad un sovrano o principe.
Tuttavia, l'atto di costruire per gli dei non sembra essere stato prerogativa solo del sovrano, in epoca proto dina s tica; si noti, a tal riguardo, l'iscrizione della statua di Ekui (Tav. XVI: 5-6), rinvenuta a Teli al-'Ubald'141':
(136) Le iscrizioni di altri personaggi d'aito rango (familiari e parenti del re) e di alti funzio-nari sono in genere più prosaiche e si limitano ad indicare nome, carica e relazioni parentelari. Tra i vari epiteti del dedicante di questa statua si noti soprattutto nasi' (IL) 'ili (DIGIR.DIGIR), "colui d ie sostenta gli dei", il quale richiama indubitabilmente una delle principali finizioni del sovrano: quella di provvedere alle offerte rituali per gli dei, onde assicurare il loro favore e sup-porto alla comunità umana di cui il re era il sommo rappresentante e responsabile.
(137) Cf. STEEBLE 1982b, p. 218 Kis: Enn. A l , p. 295 Uruk: Ensak. 2, e pp. 298-299 Uruk: Lukin. 1.
( 138 ) Cf. GRÉGOIRE 2 0 0 2 , p. 4 5 5 Anonyme 1 e taw. E X X X V I . X X X V I .
(139) Cf. WlLCKE 1976-1980, pp. 76-77 sub 3.1 e 3.6, e p. 79 sub 5. (140) In epoca arcaica, periodo di Fara incluso, un logogramma poteva stare per qua-
lunque forma grammaticale di un lessema, ovvero per una parola con qualunque affisso o combinazione di affissi con cui fosse combinabile, compresi i suffissi possessivi (cf JACOBSEN 1 9 8 8 , p . 1 6 2 n . 2 ; e KRECHER 1 9 9 2 , p . 2 8 9 ) .
(141) Si noti, per inciso, che non esiste un'altra statua di Ekur. L'attribuzione al medesimo personaggio di una seconda statua ritrovata a Teli al-Ubaid (Tav. XVI: 7-9; cf. C. J. Gadd in HALL-WOOIILY 1927, p. 125; e READE 2002, p. 261) è dovuta ad un errore di lettura. L'unico
Subur, l'araldo di Niriegalak,
(issi
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 231
1. é-kur Ekur, 2. ka-gum, unrig6 il soprintendente ai granai di Uruk, 3. ddam-gal-mm diede vita (4) 4. mu-dúd a una (statua di) Damgakiunak"42 ' (3) 5. réi-nfél mu-rú e costruì la sua casa.
Anche se pei casa qui si deve presumibilmente intendere non un tempio, ma piuttosto una cella o una cappella all'interno del tempio della dea Ninhursagak a Teli al-'Ubaid1'143/ nondimeno pare significativo il fatto che un semplice (?) soprintendente ai granai si vanti di aver creato un'immagine divina e di aver co-struito la dimora per questa'144/
Inolile, ritornando alla statua di Subur, é-ra potrebbe anche non avere nulla a che vedere con la costruzione di templi o edifici. Una lista di professioni dell'epoca di Fara elenca infatti é-ra (o piuttosto fú-é) tra le designazioni e/o i titoli di vari funzionari cultuali'145/
Infine, è persino possibile che l'iscrizione hi questione vada letta da sinistra a destra, piuttosto che nel modo consueto da destra a sinistra (cf. infra, § A.1.4 note a Cat. 1); hi tal caso avremmo:
1. é-rti L'edificatore 2. brin é gal di Niriegalak, 3. rugir l'araldo 4. subur- Subur"44/
segno conservato su tal'altra statua, infatti, non è E, come è stato letto da Gadd {loc. citi) e Finkel (apud READE, loc. citi), ma N I M G I R .
(142) Cf. p. 217 n. 60.
(143) Cf. STEINKELLER 1995, p. 279. (144) Cf. anche STEIBLE 1982a, pp. 219-220 Eut. 16; ed ID. 1982b, pp. 296-297 Uruk:
Ensak. 4. R potere e la ricchezza di alti funzionari e altri personaggi eminenti sono testimoniati anche dalla pregevolezza di alcuni ex-voto, come ad esempio la testa di toro in rame rinvenuta nel tempio arcaico di Ningirsùk a Girsu e conservata ora al Louvre (Tav XII: 1-3; cf supra, Tab. 5 sub n), la quale reca la dedica di un cantore di lamentazioni: lugal-si (scritto: SI.LUGAL) gala mah / unug6 / dnin-gir-sii / a imi-m, "Eugalsi, il sommo lamentatole di Uruk, ha pre-sentato a Ningirsùk". Testimonianze più dirette dei mezzi e delle possibilità economiche di taluni di questi personaggi si trovano in alcuni contratti di compravendita di terreni, come ad esempio la cosiddetta "Tavoletta di Enhegal" (GELB et al. 1991, n° 20), che registra l'acquisto di vari campi da parte del prete esorcista (isib) Lugalkigalla per una superficie complessiva di 975 ettari (cf. WLLCKE 1996, pp. 26-30).
(145) MSL 12, p. 18 ED Lu E 65; e MEE 3 n° 7 iv 2. Cf. anche MSL 12, p. 14 ED Lu C 3.
(146) Che il nome del dedicante sia preceduto dal titolo (e non viceversa) è assai inu-suale in un'iscrizione votiva; cf. tuttavia Tav. XIV: 2 (= LCCKENBUL 1930, n° 26): NIG.PA.SI lum-ma, "il viceré Lumina" (collazionato).
2 3 2 APPENDICE
Quest'ultima lettura è suggerita dal confronto con un'iscrizione molto simile di un sovrano contemporaneo di Adab (Cat. 4):
Se da un lato sembra piuttosto strano che un araldo si fregi dello stesso epiteto che è portato dal re di Adab, dall'altro sappiamo davvero troppo poco riguardo alla strutturazione politica e sociale della Babilonia proto dinastica per escludere a priori una tale possibilità. In mancanza di tilteriori e più chiari paral-leli è impossibile decidere quale delle varie interpretazioni possibili dell'iscrizione di Subur sia quella giusta, o se costui fosse o meno un re. Stante tale incertezza, si è optato di non includere la sua statua nella presente raccolta di statue regali.
A.1.4. Trascrizione, traduzione e commento delle iscrizioni su Cat. 1-13
Bib l . : LACOBSEN 1 9 4 2 , p p . 2 9 1 e 2 9 6 n ° 8 ; BKAUN HOLZINGER 1 9 7 7 , p. 6 8 O I P 6 0
Nr. 263 Ag. 35:857; STEIBLE 19S2b, p. 199 AnAgr. 1; GELB-KJENAST 1990, p . 2 8 V P 1; BRAUN HOLZINGER 1 9 9 1 , p . 2 4 2 S t 1 2 .
Parti dell'iscrizione non o scarsamente visibili in fotografia:
1. 2. 3. 4 .
e-ru ùiin-é-gal1
é-pa-è lugal urabu^ (UD. "NUN")1
L'edificatole di Nin'egalak, Epa'e, re di Adab.
Cat. 1 - HAR.TU (Tav. XXXVI: 1)!147>
(1 . ) H A R . T U
(2.) lugal P A G A R
(3.) subur DIGIR-OTÌJ- CFERAA
(4. ) ' ' A M A R N U . N A M . A M A
H A R . T U ,
re di PA.GAR, servitole di Tluma'tim, ali dio) AfiIARNU.NAM.AMA.
Fig. 1. - SUBUR (riga 3), AN (riga 4). Fig. 2. - NU, NAM, Afi íA (riga 4).
(147) L'iscrizione è stata gentilmente collazionata una prima volta da C. Woods, e poi, nell'ottobre 2003, da chi scrive. Va da sé che la responsabilità per le lettine qui proposte è solamente dell'Autore.
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 2 3 3
Non riprodotto è il segno MA, alla riga 3, comunque del tutto chiaro; cf. la copia di JACOBSEN (1942, p. 291 n° 8).
(1:) HAR.TU è ampiamente documentato come nome proprio di persona in epoca proto dina s tica; come tale lo si ritrova in un'iscrizione votiva da Esnunak (STEIBLE 1982b, pp. 202-203 AnEsn. 2:3), e in testi da Abn Salabikh (BIGGS 1974, n° 116 xiii 6), Isin ( G E L B et ai. 1991, n° 14 vii 6 e xiv 12), Lagas (DP 128 ili 7), Larsa (GRÉGOIRE 1996, tav. 1: Asltm. 1924-455 ii 2), Marad (ibidem, Aslim. 1924-462 iv 6), Nippur (WESTENHOLZ 1975b, N°
23 s 1, n° 46 i 5 e n° 52:10) e Suruppak (POMPONIO 1987, pp. 116-117). Con ogni probabilità si tratta più precisamente dell'ab-breviazione di un nome teoforo del tipo HAR.TU + ND, come ad esempio HAR.TU-dniníabak (NISABA) (BIGGS 1974, n° 34 colofone 10)," HAR.TU-dsùd (POMPONIO 1987, pp. 117-119) e HAR.TU-dasgijHIXDIS)sYd"asgiz(SIR)si4* (BI 207 v. 3 [F. Pom-poso, c.p.] ; CT 50 n° 136 v. fofecc.)'143'; cf. HAR.TU (-Vid4) (sottoposto) di munus-á-nu-kús (POMPONIO 1987, pp. 116/1 e 117/17*). Il termine HAR.TU designava tuia categoria di personale, sia maschile che femminile (Gebhard SELZ 1993, pp. 209-211; SAL-
LABERGER 1996b, p. 95). STEINKELLER (1989, p. 130 n. 389; ID.
1993a, p. 121 n. 38) e KREBERNIK (1998, p. 263 n. 267) hanno avanzato l'ipotesi che HAR.TU rappresenti un prestito dall'ac-cadico war dum, "servo, schiavo", da leggersi àr-tu (Steinkeller) o war -tu (Krebernik)'149/ Tuttavia tale interpretazione è inficiata dall'attestazione di HAR.TU come nome di persona femmi-nile'150', mentre mirdum è una parola di genere mas citile'151/ ALSTER
(1974a, p. 103) e KRECHER (1987b, pp. 16-17) hanno proposto invece che HAR.TU sia una scrittura arcaica per eme di idJ'AMA. TU/AMA.A.TU), un termine che designava un particolare tipo di servo/a o schiavo/a, detto in accadico (w)ilid/i/itti btti(m), "pro-genie dalla casa"'152/ Ciò sarebbe suggerito in primo luogo da
(148) Cf . MARCHESI 2 0 0 2 , p. 170 .
(149) Cf . a n c h e KREBERNIK 1992 , p . 118 JLIÌ H A t o .
(150) Cf. HAR/TLT ama u r H A R s a r r a k a , "HAR.TU, mache di Ur-HAR-saràk", in DP 128 iii 7-8.
(151) Oltre tutto ci si aspetterebbe **uruda come esito di un prestito dall'accadico wardum (cf. accadico wakJum > sumerico ugula).
(152) Cf. CAD I/J, pp. 71-73 s.w. ¡Mu e ¡little, e PSD A/3, pp. 206-207 s.v. ama-a-tu. Il complesso AMA(.A).TU, per cui le fonti lessicali e occasionali varianti in grafia sillabica in-dicano una lettura /emedu(d)/ (o simile), è forse da analizzarsi come ama(-a)-dúd (cf. KRE-CHER 1987b, pp. 9-12; e BORGER 1988, p. 235 s.w. emedu ed émedu). Tuttavia la tradizione
234 APPENDICE
V
un passo degli "Insegnamenti di Suruppak", in cui HAR.TU ed emedud^(AMAA.TU) compaiono come varianti: la prima in una versione protodinastica da Abu Salabikh, la seconda ili una reda-zione di epoca paleo babilonese; cf. ALSTER 1974a, pp. 12 (vi 12) e 42 (160). Inoltre emedud^ ammette im referente sia maschile che femminile (KRECHER 1987b, p. 9 il. 11), proprio come HAR.TU1; e, analogamente a questo, ricorre anche come nome proprio'1535
e come componente di nomi teofori'1545. Per di più emedud è assai raro in epoca proto dina s tica'1555, mentre HAR.TU non è pressoché più attestato dopo il periodo accadico'1565. Pertanto si potrebbe ragionevolmente supporre che questo non sia altro che una diversa e più antica scrittura per quello, da analizzarsi come emes(HAR)-dnd o emedudx(HAR)dM. L'occorrenza di AMA.TU e HAR.TU come qualificazioni o designazioni di eqiùdi in ima lista lessicale del periodo di Lara'1575 non inficia, a mio avviso, tale interpretazione. Qiù AMA.TU denota probabilmente ima femmina gravida o in grado di prolificare (KRECHER 1987b, pp. 11-12 n. 20), ed è perciò solo un omografo di emedud^(AMA. TU). Si confronti tuttavia SOLLBERGER 1966, n° 45, il quale pare contenga sia emedudjAMA.TU) che HAR.TU (righe 3-4). Del resto le varianti testuali HAR.TU ed emedud^(AMAA.TU) negli "Insegnamenti di Suruppak" potrebbero rappresentare varianti semantiche, piuttosto che ortografiche; ossia, il termine arcaico HAR.TU potrebbe essere stato sostituito, in epoca neosumerica o paleobabilonese, con un termine più moderno di significato analogo. Infine, si noti emedud^(AMA.TU)-da-né-me in Nik 19
lessicografica indigena considerava AMA(.A).TU come un composto del tipo "diri" (ovvero un logogramma composto la cui lettura non corrisponde a quella dei suoi componenti), come testimonia la sua inclusione nelle serie lessicali Proto-Diri (MSL 15, p. 30 sez. 7 righe 21-22, p. 47 righe 490-491) e Diri Ugarit (ibidem, pp. 79-80 righe 50-52). L'etimologia pro-posta da KRECHER (1987b, pp. 10-11) è parimenti poco convincente: se /emedu(d)/ signifi-casse "jedem von der Art, wie er/sie von einer Frau geboren wird", ci si aspetterebbe che fosse scritto ML7NLTS(.E).TU(.DA), invece di AMA(.A).TU.
(153) Cf. WÉSTENHOEZ 1975b ,p . 78 e ID. 1987, p. 195 s.v. Ama-tu ; LLMET 1968, p. 404 s.v.
Emedu; ecc. (154) Si noti emedud i(AMA.TU)-4nanna dumu ÌR-dnanna, in LIET 3 n° 1072:3. (155) Le sole attestazioni a me note sono: ED Lu E 175 (MSL 12, p. 19), Nik 19 iii 5
(Gebhard SELZ 1989, p. 136) e BIN 8 n° 104 ii 5. (156) Per alcune rare occorrenze di H A R T U in testi sargonici, cf. CT 50 n° 136 v. 1;
YANG 1989, p. 306 A 690+876:15; e BI 207 v. 3 (F. Pomponio, c.p.). Si aggiunga la menzione di un HAR.TU, corriere della città di Sarräkum (lú-u5 URU.SAG.RIG7t i), in un testo inedito da Umma (\XLSTENHOLZ s.d., p. 4 ad [SC] 1952/15).
(157) TE 43 xii 3 (ANSEAMA.TU) e 5 (ANSE.HAR.TU).
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 2 3 5
ili 5 (Gebhard SELZ 1989, p. 136) vs. HAR.TU-né (anziché H AR. TU-da-né) in DP 138 v 6 e 8(15Sb
(2:) PAGAR, o NIG.PA, rappresenta probabilmente il nome antico di Teli Agrab, da leggersi forse Hattam. Tale ipotesi di lettura è suggerita dall'occorrenza del toponimo ha-at-ìanP in ima lista geografica paleobabilonese da Tell Harmal (MSL 11, p. 58 riga 146), associato a centri della Babilonia settentrionale e della re-gione del Diyala. Dal momento che NIG.PA compare come logogramma per "scettro" — hattum, in accadico — nei testi del terzo millennio (cf. C I V I L 1987, p. 1 5 0 ad 41), NIG.PA = hattum potrebbe essere stato impiegato come ima sorta di scrittura-rebus per notare il nome di città Hattam, simile, se non identico in origine. Un'interpretazione alternativa di PA.GAR come scrittura silla-bica, ossia pa-gar, non è comunque esclusa; cf. i toponimi, dal suono simile, ba-ga-ratì / / bàd-gàA // bàd-ga-ra in MEE 3, p. 232 riga 66 ("Adante Geografico"), e pa-guA in UET 8 n° 14 iv' ([...] / rpA.TE.ST / akridA / ididrgna du-né a-ga-dè^ / pa-guA / X.AN.HARtì / . . . ) .
(3:) Per il complesso A N . X . M A , JACOBSEN (1942, p. 296) aveva pro-posto la lettura "dkilim(?)-ma", sulla base del raffronto con LAK-245 e LAK-246. Queste ultime due forme del segno K3LIM ri-corrono però solamente in testi più tardi, d'epoca sargonica e Ur III. Nel periodo protodinastico K3LIM è alquanto diverso (cf. KREBERNIK 1984a p. 288). Inoltre la notazione del genitivo (-ma) è del tutto inaspettata ili un'iscrizione così arcaica. In realtà, il segno interpretato da Jacobsen come KILIM è più probabilmente TUM<159>. Una divinità il cui nome è scritto AN.MA.TUM com-pare ill SF 1 vili 1 (KREBERNIK 1986, p. 175). La lettura DIGIR-ma-tum (= 'Ilimia'tim, "Dio del Paese") è suggerita dalla variante DI GIR-//A-ri in una lista di divinità contemporanea da Abu Sala-bikh (BIGGS 1974, n° 82 v i '2 ; cf. KREBERNIK 1986, p. 166). Quanto al segno precedentemente letto "SAHAR" da JACOBSEN
(1942, p. 296), questo è piuttosto da interpretarsi come una forma arcaica di SUBUR (cf. supra, p. 232 Fig. 1; e G R E E N - N I S S E N 1987, p. 290 sub 539-540). Il termine subur, "servitore", è già desueto nel Protodinastico Illa, e dopo sopravvive solo come compo-nente di nomi propri teofori (cf. STRUVE 1984, p. 173) e come ter mute letterario (cf. G E L B 1982, pp. 89-90).
(158) Cf. però KRECHER 1987b, p. 17 cou n. 43. (159) Cf. la forma del segno TUM nell'iscrizione dell'aquila leontocefala di Khafagia
(GELE etat. 1 9 9 1 , N° 9 III 8) .
2 3 6 APPENDICE
(4:) Ordine di lettura dei segui incerto. Forse si tratta della stessa divinità che compare negli "Inni zame" di Abu Salabikh come "AMAR.AMA.NA ( B I G G S 1974, p. 52 riga 211, tav 121: 267 v. ii 4, e tav 123: 268 v. ii 2), supponendo che i segni NU e NAM, in tm caso, e NA, ili quell'altro, rappresentino indicatori fone-tici. Se è giusta l'analisi del complesso dAMAR.NU.NAM.AMA come dmvnammiii(ii)am (AMAR.AMA), allora lo si può forse acco-stare anche a dNmi-um in J F 1 ix 17 (KREBERNIK 1986, p. 177). Il N D "dama:nam", citato da JACOBSEN (1942, p. 296), è invece più precisamente dama-nam-Iti, "Madre dell'abbondanza" (cf. KRE-BERNIK 1986, p. 185), e probabilmente non lia rapporto alcuno col teonimo qui discusso.
Note: L'andamento destrorso dell'iscrizione è inusuale, ma non senza paralleli; cf. Tav. L: 2, a sinistra: nr-driarise / lugal / lagasgNLQ. TURA; BUCHANAN I 9 6 0 , n° 1 3 7 : il-kuz-ru^(KU) dub-sar ¿arum; WOOLLEY 1 9 3 4 , tav 1 9 8 : 6 5 : àya-ùg-dùg lugal urim5 àya-su-sikil-an dam-né(160>; CT 3 2 tav 8 : 6 0 0 3 6 : [...]- A2 / DUMU / LUH.HA / dniii-men / JTQ-RIKg ecc. Proprio il mancato riconoscimento di tale caratteristica lia fatto si, in passato, che questo testo risul-tasse incomprensibile (cf. la bibliografia riportata suprd).
Cat. 2 - D LIN. AK (Tav. XXXVI: 3-4)
E D Ù N A K
2 . P A . T E . S I B Á H A R . É
1:
2:
(160) Cf . MARCHESI 2 0 0 4 , pp . 1 7 8 - 1 8 1 .
DÜNAK, viceré di . . . (della città del dio Nnn'iira).
B i b L : PARROT 1 9 5 2 , p . 7 4 ; ID. 1 9 5 7 , p. 2 2 5 ; BRAUN HOLZINGER 1 9 7 7 , p. 7 5 A O
20146; EDZARD et al, 1977, p. 40 s.v. E'eden; STEIBLE 1982a, p. 364 AnLag. 2; COOPER 1 9 8 6 , p p . 1 7 - 1 8 E e 1; BRAUN HOLZINGER 1 9 9 1 , p. 2 4 1 St 6 ;
FRAYNE 1 9 9 2 , p. 3 3 c o n n . 2 4 1 (a p. 119 ) ; PETTINATO 2 0 0 3 , p . 2 4 2 E ' e 1.
Letto generalmente "gin-ak", ma il primo segno è piuttosto DÙN (= KTK-786), che non GIN (= LAK-667). BAHAR.É è stato letto in precedenza "é-edhi"o "'à-diiiz(EDIN)"; tuttavia, il segno che accompagna E è chiaramente BAHAR (K4K-742), e non ED IN (K4K-747). Lo stesso toponimo è presumibilmente già attestato in ima lista geografica del periodo di Uruk; cf. ENGLUND-NBSEN 1993, p. 149 Cities 64: BAHAR. E.ZA. In una redazione più recente di questa, del periodo di
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 2 3 7
Fara, quello è scritto altrimenti BAH AR. ZA.NUN.É.TUS (SF 23 iv 9). Si noti inoltre il teonimo omografo dBAHAR.E.NUN. ZA.TUS, che compare in alcuni incantesimi neosumerici (cf. VAN D I J K - G E L L E R 2 0 0 3 , p . 5 1 n ° 1 4 : 3 ' 1 6 1 / p . 6 5 n ° 1 9 h i 8 , p . 7 5 N i
2 1 7 7 h 8 ' , e p. 7 7 VS 1 0 : 1 4 ) . Lo stesso nome divino lo si ritrova probabilmente a Lara, hi FF 1 vh 18, sotto la grafia dBAHAR. E ( K R E B E R N I K 1 9 8 6 , p. 1 7 5 ) . E probabile, allora, che BAHAR. E e varianti siano da interpretarsi come scritture del tipo ELLIL per Nibru/Nippur (la città del dio Ellil), ASAR per Ku'ara (la città del dio Asar), NANSE per Nigen (la città della dea Nanse), ecc. (cf. M A R C H E S I in stampa, n. 9 4 ) . Ossia, BAHAR.E(.NUN. ZA.TUS) è presumibilmente un logogramma per la città, sco-nosciuta, del dio dBÁHAR.É(.NUN. ZA.TUS)'162/
Cat. 3 - Urlammarak (Tav. XXXVI: 2)
(1.) nr- ìammar Urlammarak, (2.) NÍG.PA.SI il viceré, (3.) dPAA[N?(. . . ) ] per (il dio) . . .
BibI : LHNORMANT 1868; ID. 1873-1875, 11° 56; BRAÜN HOLZINGER 1977, p. 75 BM 91667; ID. 1991, p. 255 St 89.
(1:) Per l'interpretazione di ur-dlammar come grafia difettiva per /urlammara(k)/, cf. ur dlammar ra ke+, in M O L I N A 1 9 9 9 - 2 0 0 0 ,
p. 2 2 8 N ° 4 0 : 1 .
(161) Si noti che la lettura "dbáhar-un-za-ku" da parte di Getter qui è errata; sia la copia di van Dijk (VAN DIJK-GEELER 2003, tav 10), sia quella di Getter stesso (ibidem, tav. 36), sia la foto pubblicata (ibidem, tav. 45) mostrano chiaramente È.NUN in luogo di "un".
(162) Originariamente un dio artigiano, a giudicare dal logogramma con cui è scritto il suo nome (BÁHAR.É. ZA.TUS = "il vasaio che risiede nell'Eza" [cf. STEINKEILER 1989, p. 277 ad 17]; il segno NUN rappresenta verosimilmente un complemento fonetico, come si evince più sotto). Negli incantesimi neosumerici di cui sopra questi reca l'epiteto lugal nam-isib-ba-ke+) "signore dell'arte esoreistica". In incantesimi più tardi lo stesso epiteto è attribuito al dio dnun-iua4°, il quale è anche detto báhar gal an-na, "il grande vasaio del cielo / di An", e scritto mediante il logogramma dBÁHAR (cf. SALLABERGER-CIVIL 1996, pp. 5-6; CAVIGNEAÜX-KREBERNIK 1998-2001b; e W G. LAMBERT 2005). Tutto ciò suggerisce che dBÁ H AR. E.NUN. ZA .TU S non sia altro che una scrittura più arcaica per il medesimo teonimo, probabilmente da analizzarsi come d°°°nun'uras(BÁHAR.É.ZA.TUS).
2 3 8 APPENDICE
(2:) La grafia NÍG.PA.SI per "ensi(k)" (cf. supra, p. 215 n. 51 e § A.1.2) la si ritrova anche ili un'iscrizione del viceré Lumma di Adab; c£ Tav XIV: 2 (= LÜCKENBIEL 1930, n° 26): NÍG.PA.SI(163) lum ina.
(3:) Oppure solo dPA: una o più divinità dal nome cosi scritto sono attestate in epoca protodinasfica a Suruppak, Lagas (cf. Gebhard SELZ 1995, p. 271 s.v. dPA con 11. 1325) e Umma (MVN 3 n° 3 i 5: amar-dPA). Si noti moitié il nome di persona PUZU.R4-dPA in testi e iscrizioni d'epoca sargonica (STEINKELLER 1984b, pp. 83-84). Per le diverse possibilità di lettura o interpretazione del logogramma dPA, cf. KREBERNTK 2003a. L'interpretazione di dPA come scrittura per Nabu, proposta da LENORMANT (1868, pp. 234-235), da etri anche la designazione di "Statua di Nebo/Nabù" attribuita alla presente statua nella letteratura precedente, è probabilmente da rigettare come anacromstica.
Note: La tipologia dell'iscrizione (dedicante + dedicatario, nessuna for-mula di dedica) e il suo andamento "erratico" suggeriscono ima datazione al Protodinastico II. Una seconda iscrizione, apparen-temente priva di senso (GIBIL UZ KID IR), è stata aggiunta posteriormente sulla spalla destra: i segiù, irrispettosi delle giuste proporzioni(164), ricordano certe grafie arcaizzanti del primo mil-lennio (cf. PEARCE 1996, p. 473 fig. 3; W I S E M A N - B L A C K 1996, n° 229 e n° 235; e FINKEL 1997).
Cat. 4 - Epa'e di Adab (Tav. XXXVI: 5)
1. é-rú 2. dnin-é-gal!
3. é-pa-è 4. higal uiabuI(XJD."NUN")t l
BibL: AL MUTAWALLI-MIGLÜS 2002.
1-2: Cf. l'epiteto é-fù dmn-gù-su, "l'edificatore di Ningirsùk", del re di Kis Mësalim (cf. p. 216 sub Ac con 11. 58). Per la dea Nin'egalak (= In'anak?), cf. B E H R E N S - K L E I N 1998-2001.
3 : Si noti la variante é-pa-we di tale nome in WESTENHOLZ 1975a, n° 78 iii 5 e iv 1.
L'edificatole di Nin'egalak, Epa'e, re di Adab.
(163) L'integrazione "[of Adab]" da parte di COOPER (1986, p. 15) è ingiustificata; l'iscri-zione, collazionata, è infatti apparentemente completa.
(164) Si notino le forme esageratamente allungate dei segni G I B I L e UZ (soprattutto rispetto a KID).
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 2 3 9
4: Cf. p. 210 n. 25.
Cat. 5 - E'abzii di Umilia (Tav. XXIX: 1-2, 4)
1. ds[ára] Per Sara, 2. é-abzu E'ab zu, 3. lugal GIS.KÚSLY re di Emma, 4. mu[g jub (= DU-inversum) ha eretto (questa statua).
E i b l : DE SARZEC-HEUZEY 1 8 8 4 - 1 9 1 2 , p. E V I ; THUREAU DANGEM 1 9 0 7 , pp . 150 -
151 I L I ; TOSCANNE 1 9 0 8 , p p . 1 2 1 - 1 2 2 ; BRAÜN HOLZINGER 1 9 7 7 , p. 7 3 P a r i s
ohne AO Nr. (b); STEIBLE 1982b, pp. 269-270 Umma: Eab. 1; COOPER 1986 , p. 9 2 U m 3 ; BRÄUN HOLZINGER 1 9 9 1 , p. 2 5 2 S t 6 9 ; PETTINATO 2 0 0 3 ,
p. 127 Um 6.
3: Gebhard SELZ (2003b, pp. 506-508) ha proposto che il logo-gramma GIS. KU SU'3, tradizionalmente letto umma/ sia invece da analizzarsi come A gis s ig ( K U S U ) e da connettersi con l'ele-mento onomastico Gessag che compare ad esempio nel nome del sovrano ummaita ges-sagyki-dùg ("Gessag è un luogo piace-vole"). Sillabari d'epoca paleobabilonese o più tardi danno um-ma/mi/me(-en) (colonna sumerica) e ki-is/ù-saf sa (colonna ac-cadica) come letture di Gì S KUSU« < W G. LAMBERT 1990a, pp. 75-76). Kissa, o Kissa, si lascia facilmente ricondtrrie a Gessag, ed è assai probabile che quello non sia altro che tuia forma più tarda di questo, come già osservato da W G. KAMBERT (1990a, pp. 79-80) e Gebhard SELZ (2003b, pp. 507-508 con n. 38). Tut-tavia, alctme occorrenze di ges-sag4 e GIS.KUSU13 fianco a fianco nello stesso testo1165' rendono alquanto problematica l'ipotesi che GIS.KUSU« sia ima grafia logogiafica per Gessag. La grafia GIS. KÚSU^-a (anziché GlS.KUSU«-ga1166>), hi STEIBLE 1982a, p. 230 sgg Eut. 28 iii 36, iv 21 e vi 9, dimostra che a Lagas, al tempo di Enmetêrinâb, Gì S. KUSU« rappresentava Umma'1"1, e non Gessag.
4: Cf. p. 216 n. 55.
(165) Cf. CT 50 ii° 33:114-115 (ges-sag^ki-dùg / GIS.KÚSLTli-kam) e Nik 2 n° 84 v. 3 (GIS. KUSLT-ki-dùg) e 7 (ges-sag^x-zu).
(166) Per La terminazione in /g/ di Gessag, cf. il ND Ain-ges-sag^ga, "Signora/e di Gessag", in testi di Ur III da Umma (MVN 1 n° 34 v. 6 ; TCL 5 n° 6038 iv 21; ecc.).
(167) Più precisamente /ubma(/i)y/; cf. MARCHESI in stampa, n. 86.
240 APPENDICE
Note: L'iscrizione è assai probabilmente completa, come si evince dal confronto con l'iscrizione "parallela" di un altro sovrano di Umma; cf. Piasa, Archeologie, Vente du 17-18 mars 2003, Paris, n° 388: dsára barag-sàg-nu-di / lugal GIS.KUSU^ / mu-gub (statua di leone). L'altro frammento iscritto in DE SARZEC - HEUZEY 1 8 8 4 -
1912, p. LVI appartiene verosimilmente ad un'altra statua1163'1, de-dicata forse al dio Pabilsagak: [dpa]-bil^(GIS.PAP.NE)-s[ag . . . (?)] (cf. Tav XXIX: 3-4). Il tipo di dedica, ND (. . . ) mu-gub, è rilevante per l'attribuzione della statua di E'abzu al Protodinastico Illa, piuttosto che al Illb. Tale formula pare appunto peculiare di quella fase (sia la mazza di Mësalim [cf. p. 216 sub 4c] che la statua con l'iscrizione di Baragsagnudid sono certamente anteriori al Protodinastico Illb). La paleografia e la suddivisione dell'iscrizione mediante semplici linee, anziché caselle, pure supportano ima tale datazione (cf. THUREAU DANGIN 1 9 0 7 , p . 1 5 1 n . 1 ) .
Cat. 6 - Ur-AN.SI di Geskul'abâk (Tav. XXXVI: 7)
/
Kg. 3.
1. ur-AN. rSD 2. [N]ÍG.PA.TE. rSD 3. GIS. rKUlA .[UNUGlKl] 4. r . . . (?)]
U1--AN.S1, viceré di Geskul'abâk, diede vita (5) a una statua di (del dio / della dea) . . . (4) ed eresse (7) il suo podio (6).
5. [mu-dúd [?)] 6. barag-tné1
7. [mu-rú (?)]
B i b L : BRAUN HOIZINGER 1 9 9 1 , p. 2 5 5 S t 9 0 .
(168) Come suggeriscono anche le differenti proporzioni dei segni e l'assenza di linee divisorie nell'iscrizione.
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 241
1: Il NP ur-AN-SI è altrimenti attestato in B IGGS 1974, n° 42 colo-fone. Cf. anche amar-AN.SI (vai. amar-AN.LU) in "Names and Professions l i s t " 165 ( A R C H I 1981, p. 185); ed ur-AN.SI.LU in G E L B et al., n° 40 B vi 8. AN.SI compare come toponimo in E N -
GLUND-NISSEN 1993, p. 148 Cities 54. 2-3: Per NÌG.PA.TE.SI come variante di PA.TE.SI, "viceré", cf. supra,
p. 210 n. 24, e p. 223 con n. 100. Un altro viceré di tale città è attestato in BI 13 v. i 2-4: ... ur-sul / NÌG.PA.TE.SI / GIS. KUL.UNUG* (F. Pomponio, c.p). Per il toponimo GIS.KUL. UNUG/AB'U cf. EDGARD et al. 1977, pp. 96-97 s.v. Kul'aba; e STEENKEULER 1992a, p. 105. La lettura /geskul'/labak/ di GIS. KULTNUG^, probabilmente da analizzarsi come ges-Mkul'aba (UNUG)1^"169', sembra assicurata dalla grafia ges-ku-la-bàP nella versione eblaita del cosiddetto "Atlante Geografico" (MEE 3, p. 234 riga 127). Secondo FRAYNE (1992, pp. 8, 1 0 e 96), questa città sarebbe da localizzarsi sul canale Kiskattùm, a nord di Kis e vi-cino a Kudia (Tell Ibrahim).
4-7: Cf. l'iscrizione della statua di Ekur, supra, p. 231. Pei l'erezione di podi per divinità in iscrizioni votive di sovrani, cf. BEHRENS-
STEIBLE 1983, p. 39 s.v. bara 1.
Cat. 7 - Lugaldalu di Adab (Tav. XXXVI: 6)
1. é-SAR Per l'E-SAR: 2. lugal-da-lu Lugaldalu, 3. lugal u iaba (UEGNUN")* re di Adab.
ESHL: BANKS 1904-1905, p. 59; ID. 1912, pp. 196-200; THUREAÜ DANGIN 1907, pp. 1 5 2 - 1 5 3 V ; SOLLBERGER-KÜPPER 1 9 7 1 , p. 8 7 I F 3 a ; BRAÜN HOLZINGER 1 9 7 7 ,
p. 68 Istanbul IOM 3235; STEIBLE 1982b, p. 191 Adab: Lug. 1; COOPER 1 9 8 6 , p. 1 7 A d 5 ; BRAUN HOLZINGER 1 9 9 1 , p. 2 4 2 St 10 .
1: Tempio arcaico di Ninhursagak/Digirmah, forse da leggersi é-kiri6, "Casa-giardino", e comunque da non confondersi col se-miomografo tempio più tardo della dea In'anak ad Adab, chia-mato é-sar-ra [contra GEORGE 1 9 9 3 , pp. 1 4 0 - 1 4 1 sub 9 7 8 ; cf. infra, § A.3.1).
Note: La datazione di questa iscrizione è controversa. THUREAU D A N G I N
(1907, p. 153 n. 2) la reputava "wahrscheinlich älter als Ur-ninâ
(169) Cf. Proto-Dili Nippur 4:11 (MSL 15, p. 28): [KUL.UNUG.K3] = [k\u-ul-a-ber, Proto-Diri Oxford 527 (ibidem, p. 48): KULUNUG.KI = ku-ul-la-a-[ba\, e Diri IV 84 (ibidem, p. 152) : kuUa-ba = KULUNUG.KI = su.
2 4 2 APPENDICE
[= Uinansêk]". Per CURCHIN ( 1 9 7 7 , p. 9 4 ) Lugaldalu "may well fit into the period between Mesalim [= Me salini] and Eannatum [= E'annâbtum]" Secondo BRAUN HOLZINGER ( 1 9 7 7 , p. 2 8 ) , invece, "die Zeichen der Inschrift erinnern in ihrer langgezogenen, fast kalligraphisch wirkenden Form eher an sargonische Inschriften als an die des Mesilim [= Mesalim] aus Adab"; e conseguente-mente la classifica tra le iscrizioni statuarie protodinastiche piti tarde (ibidem, p. 19 con n. 109). Della stessa opinione è anche CHARVÁT ( 1 9 7 4 , p. 165), secondo cui "die script of this mo-nument is closely related to the script of die Akkad dynasty". Una datazione più alta per Lugaldalu è stata riproposta infine da Y A N G ( 1 9 8 9 , p. 9 9 ) , che pone Lugaldalu prima di Baragarmèdug, Mugesi (I) ed E'igiiùmpa'e. I seguenti punti meritano di essere richiamati qui brevemente:
1) La dedica all'è-SAR implica che Lugaldalu abbia regnato prima di E'igiiùmpa'e (cf. infra, § A.3.1), il quale è forse da datarsi non più tardi di E 'amiàbtimù1705.
2) L'iscrizione di Lugaldalu si colloca paleograficamente e ti-pologicamente nella tradizione del Protodinastico Illa. Soprat-tutto, essa è identica alle iscrizioni di Isibdurbar (Tav. XIV: 1 e 4; cf. p. 215 sub b), se si eccettua il fatto che ili quella, diversamente che ili queste, l'ordinamento dei segni è conforme all'ordine di lettura.
3) Lugaldalu porta il titolo di "re" (lugal), come i sovrani del Protodinastico Illa Isibdurbar ed Epa'e, mentre i reggenti di Adab posteriori recano senza eccezione il titolo di "viceré" (NÍG.PA.TE.SI o PA.TE.SI) (cf. p. 260 Tab. Al) . Tutto ciò, in congiunzione col fatto che lo stile della statua è ti-pico, invece, del Protodinastico Illb (cf. pp. 129-130), suggerisce che Lugaldalu abbia regnato all'inizio di quest'ultimo periodo.
(170) Così WLLCKE 1996, p. 44. Una tavoletta inedita da Adab che registra assegnazioni di schiavi a notabili locali e stranieri, tra cui anche il viceré di Lagas Ayakurgal (cf. p. 210 n. 24), potrebbe confermare tuia simile datazione. Tra gli assegnatari di schiavi figurano infatti tre persone — bü-la-la, ur-sag-kès e ú-ú-a — che si è tentati di identificare con tre personaggi importanti e imparentati tra loro, attestati in lui documento legale del tempo di E'iginimpa'e (GELB et al. 1991, Appendix to no. 32). Costoro sono l'amministratore templare di Kes bil-lalda (già morto al momento della redazione del documento), suo fratello ú-ú-a, e suo co-gnato ur-sag-kès. Se non si tratta di una mera coincidenza, avremmo qui tui'indicazione della contemporaneità di E'iginimpa'e con Ayakurgal e/o E'annâbtum (la tavoletta in questione verrà pubblicata da M. E. Milone, alla cui cortesia si devono le informazioni qui riportate).
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 243
Cai. 8 - En'amiâbtum I di Lagas (Tav. XXXII: 1)
col. i (lacuna di 4 o 5 righe) [á súm-ma] colui a cui Ellil
1'. del[lil] -ke+ ha dato il potere, 2'. sag4 pàd-da il prescelto 3'. dname-ke, di Name, 4'. kur [gii gar-gar] il soggiogatore di tutti paesi stranieri
col. ii 1. [riún-gtr-su/sú(-ka)-kej per conto di Ningirsûk,
(lacuna) . . . quando Ningirsûk . . . 1'. [k]ur-k[ur su]-né-[sé] pose (2) 2'. mu- [sè-gar-ra-a] in mano sua tutti i paesi stranieri (1 ) (lesto rotto)
EShL: V E . CRAWFORD 1977 , pp . 198 ( 4 H - T 8 ) e 218 ; STEIBLE 1982a , p. 3 6 9 A n L a g .
26.
i 2' -3': Cf. pp. 228-229 n. 131.
Note: Pei l'attribuzione di questa statua ad En'annâbtum I, cf. STEIBLE
1982a, pp. 204-207 Eli. I 33. La fiase ud ND-ke4 km-km su-né-sè m u s è g a r r a a compare anche su ima statua di Enmetêiinâk (Cat. 9 ii 9 sgg.), ma quest'ultimo non reca mai l'epiteto kur gii gar-gar dningírsu/ sú-ka nelle sue iscrizioni (cf. BEHRENS-STEIBLE
1983, p. 151 s.v. gii—gar 2).
Cat. 9 - Enmetênnâk di Lagas (Tav. XXXII: 2-3)
col. i 1. [dba-ú] Per Ba'u, 2. [muons sag9"ga] la donna graziosa, 3. [en-mete-na] Emnetêmrâk, 4. [PA.TE.Srj viceré 5. P ag a s I (NU j j .BU R)k " -ke j di Lagas, 6. [sag4 pàd-da] il prescelto 7. [riianse-kej di Name, 8. [PA.TE.SI-gal] il fattore 9. [dnin-g] Ir- [sú] -ka-ke4 di Ningirsûk, 10. [dumu] en an [nja túm figlio di En'annâbtum, 11. [PA.T]E.SI viceré 12. P aS a s I (NU j j .BU R)k f - [ k a - k e j di Lagas,
244 APPENDICE
col. il 1. [é-né] le costruì (2) 2. [mu-na-ïù] il suo tempio (1). 3. [en-mete-na] Enmeténnâk, 4. [PA.TE.SI] viceré 5. [lagaSi(NU11.BUR)ü ^ di Lagas, 6. [dumu en-an-na-túm] figlio di En'annâbtum, 7. [PA.TE.SI] viceré 8. Oagasi(NU11.BUR)1u f^-ka-ra di Lagas — 9. ud dmn-gír-sú-ke4 allorché Ningfisùk 10. mu e-né-pàd-da<-a> lo designò, 11. á e na súm ma a diede a lui il potere, 12. [kjurkur su-né-sé pose (iii 1)
col. ili 1. [mu- sè-gar-ra-a] in mano sua tutti i paesi stranieri (ii 12), 2. [ki-bala giri-ne-sè] pose (3) 3. [mu- sè-gar-ra-a] ai suoi piedi la terra ribelle (2), 4. [ud-ba en-mete-na-kej a quel tempo Enmeténnâk 5. [alati-na-né] diede vita (6) 6. [mu-dúd] a tuia sua statua (5), 7. [ . . . ] e la chiamò (8): 8. mu mu-né-se21 " . . . " (7); 9. dba-ú e la portò dentro il tempio (11), 10. murms sag^-ga da/per Ba'u (9), 11. é-a mu-na-ni-kuï (DU) la donna graziosa (10).
col. iv 1. [en-mete-na] Enmeténnâk, 2. [lú é dba-ú rú-a] l'edificatore del tempio di Ba'u — 3. [digir-ra-né] voglia il suo dio (personale), 4. [dsul-MUSxPA] Sul-MUSXPA, 5. [ud ul-la-sè] pregare (10) 6. [nam-ti] Ba'u (8), 7. [en-mete-na] -k[a- sè] la donna graziosa (9), 8. d[ba-ú] per la vita (6) 9. murms s [ag^-ga] di Enmeténnâk (7) 10. rkiti1 [su hé-na-gál] smo a giorni lontani (5).
Eibl . : SoLLBERGER. 1959 , pp. 4-6; STEffiEE 1982a , pp. 194-195 En . I 25; COOPER
1986, p. 51 La 4.11; PETTINATO 2003, p. 171 La 6.25.
I 1-7: Cf. STEIBLE 1982a, p. 272 Ent. 96. i 1: Cf. MARCTIESI 2002. i 5: Cf. p. 211 n. 31. i 8: Cf. p. 223 con il. 98.
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 2 4 5
il 12-iii 3: Cf. STEIBLE 1982a, p. 205 En. I 33 iii 5-8. iti 4 sgg.: Cf. infra, Cat. 1 0 b iv 2 sgg.; e STEIBLE 1982a, p. 255 Ent. 36 iii 1
sgg-iii 5-8: Cf. p. 217 n. 60. iii 11: Cf. ibidem n. 62.
V
iv 4: La lettura tradizionale "Sulutul" di questo teonimo è priva di qualsiasi fondamento (cf. WG. L A M B E R T 1995, pp. 135-136).
Cat. 10 - Emnetênnâk di Lagas (Tav. XXXVII: 1-4)
a) Iscrizione sulla spalla destra
col. i 1. 25.0.0 ikii en-an-na-tóm-as-né- 25 bur (di terreno del campo)
dnans e -e-ta-èd En'amràbtum'asannenanser'ebta'ed, 2. 11.0.0 iku im-zú-numun 11 bur (di terreno del campo)
Tmaihnn trainai;
3. asag ambar-nigen (NANSE)1"- nel fondo Ambarnigenak, ka
4. par (EXPAP)-kng-ge rissa adiacenti al (canale) Parkug, 5. 60.0.0 iku dellil e 60 bur (di terreno [del campo?]) di Ellil 6. asag gú-eden-na-ka nel fondo Gu'edenak
col. ii 1. en-mete-na Enmetênnâk, 2. PA.TE.SI viceré 3. lagas i(NU11BUR)b b-ke+ di Lagas, 4. dellil ha ritagliato (6) 5. é-ad-da-ka-ra per EU il (4) 6. giri e na rri delFE'adàk (5).
b) Iscrizione sulla schiena
col. i 1. [de]llil Per Ellil 2. [é-a]d- [da-k] a-ra dellE'adàk -3. en-mete-na Enmetênnâk, 4. PA.TE.SI viceré 5. lagas i(NU l1.BUR)b * di Lagas, 6. sag4 pàd-da il prescelto 7. dnanse di Nanse, 8. PA.TE.SI-gal il fattore 9. dnin-gír-sú-[k]a di Ningirsûk, 10. [dumu e]n an [ria] trim figlio di En'annábtum, 11. [PA.T]E.SI viceré 12. lagas^NUjj .BLIR)k b-ka di Lagas,
246 APPENDICE
13. d u m u k a discendente 14. ur- inanse di Urnansèk, 15. lugal re 16. lagas6-ka-ke4 di Lagas, 17. bain-gir-sù-ra costruì (19) 18. ès-dug-ru per Ningirsùk (17) 19. mu-na-iii l 'Esdugru (18); 20. a-hus per lui costruì (ii 2)
col li 1. é igi zi bar ra l'Abus (i 20), 2. mu-na-rù la casa guardata con approvazione (1); 3. bugal-ui ub^ (URU X KÁR^-ra costruì (5) 4. é-gal urub i(URUXKÁR) t '-ka-né per Lugal'uiubak (3) 5. mu-na-rù il suo palazzo di Urub (4) ; 6. baanse costruì (8) 7. é-engur-ra zú4um-ma per Natise (6) 8. mu-na-rù l'E'engurak di Zulum (7); 9. den-ki costruì (12) 10. lugal eredugt i<-ga>-ra per EnkÌk (9), 11. abzu pars(EXPAP)-sir-ra signore di Eredug (10), 12. mu-na-rù l'Abzu di Pafsir (11); 13. bain-hur- sag-ra costruì (16) 14. gi-gù-na per Ninhursagak (13) 15. tir-kug-ga il g-gitna (14) 16. mu-na-rù di Tirkug (15); 17. bain-gir-sù-ra costruì (19) 18. an-ta-sur-ra per Ningirsùk (17) 19. mu-na-rù l'Antasurra (18); 20. sag4-pàd-da costruì (21) 21. mu-rn il Sagepadda (20); 22. é dgà-tùm-dùg costruì (23) 23. mu-rn il tempio di Gatumdug (22);
col. ili 1. baanse costruì (3) 2. gi-gù-na mah-né per Nanse (1) 3. mu-na-rù il suo grandioso ^jj«»« (2) 4. é-né ki-bé mu-na-g/ e restaurò il suo tempio; 5. dellil-la costruì (7) 6. é-ad-da im-sag-gá per Ellil (5) 7. mu-na-rù l'E'adàk di Imsag (6). 8. ud-ba en-mete-na-ke. A quel tempo Enmetênnâk 9. alan-na-né diede vita (10) 10. mu-dúd ad una sua statua (9), 11. en-mete-na-dellil-le-ki-ág e la chiamò (12):
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 2 4 7
12. mu mu-né-se, j "Enmetènnâk è colui che Ellil ama' mu mu-né-se, j
( i l ) ; 13. Ami-la e la portò dentro (iv 1) 14. é-a il tempio,
col. iv 1. mu na ni kur (DU) da/pei Ellil (iii 13). 2. e n m e t e n a Enmetènnâk, 3. lú é-ad-da rú-a l'edificatore dell'E'adàk — 4. digir-ia-né voglia (10) il suo dio (personale), 5. dsul-MUSXPA Sul-MUSXPA, ó. nam-ti pregare (10) 7. en-mete-na-ka- sé Ellil (9) 8. ud ul-la-sé per la vita (6) 9. delkl-la di Enmetênnâk (7) 10. kiri su hé-na-gál sino a giorni lontani (8).
Bibl.: GADD-LEGRAIN 1928, pp. 1-2 E tav. I; SOLLBERGER 1956, p. 32 Ent. 1; SOLL-
BERGER-KUPPER 1 9 7 1 , pp . 6 6 - 6 7 I C 7 a ; STEIBLE 1 9 8 2 a , p p . 2 1 1 - 2 1 2 E n t . 1;
COOPER 1 9 8 6 , p p . 6 3 - 6 4 L a 5 . 17 ; PETTINATO 2 0 0 3 , p p . 1 7 7 - 1 7 9 L a 7 .1 .
a i l : Il segno che precede dnanse è generalmente interpretato come SUR; tuttavia esso differisce alquanto dal SUR di an ta sur ra in b ii 18. A mio avviso il passo in questione presenta piuttosto AS-tenu (cioè il segno AS obliquo), da leggersi /as/t171/ seguito dal segno NI; cf. i NNP as(AS-Ä«zi)-ne e lugal- as (AS - tenu)-né in CROS et al. 1910-1914, p. 182 AO 4348 ii 1 e 4; en-an-na-túm-as-né-dnanse-e-ta-èd è verosimilmente il nome di un campo — "En'armàbtum, solo lui è disceso fin da Nanse" (?). Il nome di En'annâbtum I, quarto sovrano della I Dinastia di Lagas, ricorre anche in altri nomi propri; cf. il NP en-an-na-tiim-sebacQSIPA)-zi, "En'armàbtum è im buon pastore" ( C R O S et al, 1910-1914, p. 52 AO 4238 v. hi 4 e 181 AO 4156 v. 1), e il nome di canale (?) eii-an-na-tiím-gen7-Ée'gestugtó£-a-ba-gá-gá, "Ciri è cosi attento come En'annâbtum?" (cf. BAUER 1972, p. 59 ad ii 2).
a i 2: Lett. "Ladro di sementi". a i 3: Per tale lettura del toponimo NANSE16, tradizionalmente letto
"nina®', cf. MARCHESI 1 9 9 9 , p. 1 1 ad Y.ii 7 con n. 3 2 .
a ii 6: Cf. bu6 giri rn-a in DP 336 ii 3 (cortesia di P. Steinkeller). b ii 15: Per il tipo di edificio sacro chiamato giguna (= tempio a ter-
razza?), cf. da ultimo WAETZOLDT 2 0 0 5 , pp. 3 2 3 - 3 2 9 .
b ili 6: Imsag, dove sorgeva l'E'adâk, era probabilmente un quartiere o im sobborgo di Nigen (cf. FALKENSTEIN 1966, pp. 7 0 - 7 1 n. 1 3 ; e Gebhard SELZ 1 9 9 5 , p. 1 2 9 ) .
( 171 ) Cf . POSTGATE 1 9 7 3 ; e MARCHESI 1 9 9 9 , p. 14 ad m 2.
2 4 8 APPENDICE
Cat. 11 - Hinnam'il di Kis (Tav. XXXII: 4-5)
col. i 1. [x+]4.0.0 IKU [x+]4 bur (di terreno): 2. e-estub i(KU6+GUD)(-rx i) (fondo) E'es tub.. . (?) 3. in ur- Gif1 '-gab in Ursagab (?); 4. 6.0.0 IKU 6 bur (di terreno): 5. su'-immuti-rxn (fondo) Summum... (?); 6. ASAG [SAjJ campi acquistati (da parte di Hinnam'il) 7. [á\s-[teJ da 8. [NP] NP. 9. 2.0.0 IKU 2 bur (di terreno): 10. ASAG SA10 campo acquistato (da parte di Hinnam'il) 11. ós te, da 12. inim-ma-né-tzi"1 Inimannezid.
col. ii 1. en-na-il Hinnam'il, 2. lugal kisi re di Kis, 3. aflati-na-né (?)] fece (4) 4. [mu-dim (?)] una sua statua (3)
. V V 5. igi in'atiak (MUS) e la eresse (6) 6. mu-gub al cospetto di Irianak (5).
Bibl.: GOETZE 1961, pp 107-108; BRAUN Hotz INGER 1977, p. 72 6N-271; GELB
etat. 1991, ri 26.
li L-Ó: Cf. FRAYNE 1 9 9 3 , p. 6 8 E 2 . 1 . 2 . 1 8 : 9 - 1 5 : ri-mu-ús / lugal / kisi / alan-m-né / an-iia-kam / i-dim / igi dellil-là-sè / ì-gub, tradotto in accadico come: ri-mu-ús / LUGAL / KISI / DUL-.ra / sa KUG. AN / ib-ni-ma / lGI- we / dELLIL / i-^a-a^ "Eimus, re di Kis, fece una stia statua di ferro (?) ed essa sta in piedi davanti ad Ellil".
ii 3: L'uso del segno ALAN invece di DUL fa pensare che questa se-conda parte dell'iscrizione (ossia, la col. ii) fosse redatta in lingua sumerica (cf. G E L B et al. 1 9 9 1 , p. 9 1 ) . Ciò si spiega forse col fatto die la statua su cui era iiidsa era stata concepita per stare nel tempio della Irianak sumerica di Nippur (dove è stata appunto rinvenuta).
Note: La prima parte di questa iscrizione (col. i) contiene la registra-zione dell'acquisto di vari appezzamenti di terreno da parte del re di Kis Hinnam'il'172! Con ogni probabilità si tratta dello
(172) Altre statue con iscrizioni di tale tipo sono: GELB et al. 1991, ri 21 e ri 25 (— Tav. V E 3 ) ; Y B C 2 2 7 9 (cf . BRÄUN HOLZINGER 1 9 9 1 , p. 2 5 5 S t 9 1 ) e W A 1 1 8 0 7 4 ( T a v X H V : 1 - 3 ;
cf. RBADE 2002, pp. 261-262 sub 2).
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 2 4 9
stesso personaggio che è menzionato col titolo di "re" (lugal) ili una copia neosumerica di un testo letterario presargonico da Nippur'"35. Dallo stesso luogo proviene anche una copia d'epoca Ur III di un'iscrizione votiva ad In'anak/'Astar, da parte di un individuo eminente con lo stesso nome: dINANA / en-na-ìl / DUMI] / áya-an-z[u]s(MI) LKVmvi itj m,Le„ j E L A M / ÀGA.SÈ / S.4y'-RIKcf "A Astar, Hinnam'il, figlio di Aya'anzud, il con-quistatore dell'Elam, ha presentato" ( G O E T Z E 1961, pp. 108-109 figg. 2b-3). L'anagrafia EDAM AGA.SE'1745 lascia intendere che l'iscrizione originale non fosse suddivisa in caselle, e che l'ordi-namento dei segni non seguisse strettamente l'ordine di lettura — caratteristiche queste che suggeriscono ima datazione anteriore al Protodinastico IIIb'1755. Generalmente si suppone che questo Hinnam'il, figlio di Aya'anzud, sia identico all'omonimo re di Kis della presente statua (cf. G O E T Z E 1961, p. 107; C O O P E R 1986, p. 21 Ki 7 11. 2; G E L B - K I E N A S T 1990, p. 3 6 W C 1 11. 2; G E L B et al. 1991, p. 92; e P O M P O N I O 1994, p. 10). L'iscrizione su questa, però, quantunque datata solitamente al Protodinastico Il la (cf. G O E T Z E 1 9 6 1 , p . 1 0 8 ; G E L B et al. 1 9 9 1 , p . 9 1 ; e P O M P O N I O 1 9 9 4 , p .
10), 11011 pare affatto così arcaica paleograficamente. Si confronti ad esempio la forma del segno LUGAL, qui, col LUGAL che compare nelle iscrizioni di sovrani di Kis del Protodinastico Illa, come Mësalim (Taw. XI: 10, XIV: 3, XV: 2), Lugalnamnirsum (Tav. XIII: 5) e LUGAL-UTU (Tav. L: 1). Supponendo che l'au-tore della dedica a In'anak/Astar e l'omonimo re di Kis che dice di aver posto la sua statua al cospetto della medesima dea siano la stessa identica persona, mia datazione di questi all'inizio del Proto dina s ti co Il lb sembra più probabile.
Cat. 12a - Sumba'll (Tav. XXXVII: 5)
col. i 1. J'»«y-BAL> 2. DAGAL DAM 3. a-GURLIS KALAG 4. me-Aa
Sumba'lï, colui che allarga/espande il dämum (?), l'uomo potente (?), colui che si cura
(173) WESTERHOLZ 1975a, n" 219 iii '2'-4': m-na-ii / lugal / Allil / - W i a / ki su silim-/ [ - ] •
( 1 7 4 ) C f . GELB-KIENAST 1 9 9 0 , p . 3 2 V P 11 .
(175) Si noti anche la scrittura inusuale di /anzu(d)/, AN.[Z]U5.M[Lj.MUSEN, che ha preciso parallelo in un testo in grafia UD.GAL.NUN da Abu Salabikh; cf. BLGGS 1974, 131 iv 51 [U]D(= AN).MI.ZU5.MUSEN.
2 5 0 APPENDICE
5. GIDIM.GIDIM degli spiriti degli antenati, 6. IL DIGIR.DIGIR colui che sostenta gli dei. 7. rwi»6-BAD Sumba'lr, 8. tf7»/16(NI) sup(KAM)-an-uh padre di Süryanwuh (?), 9. qifKXDypum Qïpum (?), 10. URU-AD 'AhlTabl (?) 11. Ù e 12. ¿i'd/y/qJ -bu-bu Girbubu (?),
col. ii 1. 'a.(NI)-»ij per i i 2. BAD-li-SU suo Signore.
B i b l . DOSSIN 1 9 6 7 , pp . 3 0 8 e 3 1 7 - 3 1 8 n ° 10 ; M . LAMBERT 1 9 7 0 , p . 1 6 9 ; BRAÜN
HOLZINGER 1977, p. 70 Miss. Mari IH Nr. 10, M 2350; KREBERNTK 1984b, p p . 1 6 6 - 1 6 7 ; EDZARD 1 9 8 5 ; GELB-KIENAST 1 9 9 0 , p p . 1 8 - 1 9 M P 2 4 ; BRAÜN
HOLZINGER 1 9 9 1 , p . 2 4 7 S t 3 6 ; KREBERNIK 1 9 9 1 , p p . 1 3 9 - 1 4 0 ; KJENAST
1 9 9 4 , p . 3 2 7 ; BOESE 1 9 9 6 , p p . 2 6 - 3 4 .
i 1: Pei l'iiitrepretazione di sum-BAD come Sumba'll, "Posterità del mio signore", cf. STEINKELLER 1993b, p. 238 sub 14 (per BAD come logogiamma per ba'lumj bëium, cf. anche ID. 2004a). Una trascrizione Sumbalim o Sumba'lum, "Posterità del Signore", è pttre possibile iti linea teorica, ma grafie esplicite come sitnr-BAD-/»w/lum o su/su^mu^ADUm/htm, che attestino l'esistenza di un simile nome, non sono documentate. Si noti però il nome amorreo Sumuba'la ( sumuba ìa ) , che appunto significa "Posterità del Signore" (cf. STRECK 2000, p. 274).
i 2-3: KREBERNIK (1991) diversamente legge e traduce: AMA DAM<. DAM?> / A GURUS.GURUS, "Mutter der Fraue<en>, Vater der Männer". Tuttavia l'epiteto di madre mal si concilia con un referente maschile, quale è fi personaggio della statua in que-stione. Inoltre fi segno A non è altrimenti documentato come lo-gogramma per "padre" in iscrizioni in lingua accadica. Pertanto si propone qtti, come alternativa, la lettiua DAGAL DAM (= murappìs däm'mi) / «-GURUS KALAG (= 'assum dannunì).
i 2: Per I74M come accadogramma per dämum, "sangue, stirpe", cf. KREBERNIK 1988, p. 80 s. v. da-mu. Il verbo rapäsum e il sostantivo dämum compaiono associati anche nei NNP ìrpis (PES)-174-AiU e rui2pù-ùs-DA-MU (ambedue nomi di re), per cui cf. B O N E C M
1997, pp. 498 e 521; ID. 2001b, pp. 141-142. Cf. inoltre CAD R, pp. 157-158 sub 3', per rapäsum in associazione con altri termini per "stirpe, progenie, famiglia".
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 2 5 1
Differenti interpretazioni di dâmum, in un senso più sociopoli-tico, sono state avanzate da B O N E C H I 1 9 9 7 , pp. 4 7 7 - 4 8 1 ; e F R O N -
ZAROII 1 9 9 8 , pp. 1 1 1 - 1 1 2 . Sulla scorta dell'ipotesi di B O N E C H I
( 1 9 9 7 , p. 4 8 0 ) , secondo cui dâmum denoterebbe una "société des alliés fondée sin le pacte de sang", si può forse tradurre murappis dämim come "colui che allarga/espande l'Alleanza" — un epiteto che potrebbe alludere ad tuia specifica alleanza, ovvero a una qualche coalizione o confederazione di cui Sumba'lì sarebbe stato il promulgatole e/o il leader. A tal riguardo, si notino anche le occorrenze di DA-Mlß^ nella lettera dei principi di Ib'äl al re di Marmwat ( F R O N Z A R O I I 2 0 0 3 , pp. 1 2 1 - 1 2 3 n° 1 1 ) , dove BA MlßA sembra designare mio specifico (?) gruppo tribale (cf. ibidem, p. 126 ad 12).
i 3 : Cf. gurus kalag(-ga*) in ETCSL 2 . 5 . 4 . 0 1 * e 2 . 4 . 5 . 1 9 (epiteto, in entrambi i casi, del re di Isin Ismedagäri). L'uso, ad Ebla, del logogramma DAM per l'equivalente femminile di GURUS ( c f . DAYTDOVIC 1 9 8 8 , p . 2 0 3 ; e SALLABERGER 2 0 0 0 , p . 1 1 7 ) s u g -
gerisce 1) che 'assatum (DAM) li non significhi "moglie", come in Mesopotamia, ma piuttosto "donna"; 2) che GURUS ili Siria sia conseguentemente da leggersi 'assum, piuttosto che hatlum¡ etlum, e da connettersi con l'arabo 'ins, "uomo" (cf. anche D A V I D O V I C 1 9 8 8 ) .
Nell'ipotesi che l'interpretazione qui proposta sia corretta, la grafia Ä - G U R U S per 'assum sarebbe analoga a ' " « - L I G U L A per (w)akìum nell'iscrizione della statua di AMAR-AN da Mari ( D O S S I N 1 9 6 7 , p . 3 1 8 n ° 1 1 ; M A R C H E S I 2 0 0 4 , p . 177)<17<5L
i 4: Per l'interpretazione di me da come mida'o meda', stato costrutto del participio di yadä'um (variante dialettale di idâm(177)), cf. A. Westenholz apud V O L K - K I E N A S T 1 9 9 5 , p. 1 6 7 ad 1 2 ' <178>. Per idâm nel senso di "preoccuparsi, aver cura", cf. (14D I/J, pp. 2 7 - 2 8 sub 2'/a'-b '.
i 5: Il termine sumerico gidim, in genere tradotto "spirito (del de-finito), spettro", è con ogni probabilità un prestito dal semi-tico *qädimum, "colui che viene prima, predecessore" (cf. arabo
(176) Ivi, ii 2, si legga appunto 'VUGULA MAH = (n)akium sayrum/sîrum (cf. UGULA MAH in GELB-KIENAST 1990, p. 29 VP 5:2), anziché LÚ a-bá-ai. "der 'Mann' des Abal (= N F ) " (GELB-KJENAST 1 9 9 0 , p . 1 2 M P 1 2 : 8 ; c f . SALLABERGER 1 9 9 8 , p . 3 5 n . 5 9 ) . L a g l o s s a a
non implica necessariamente l'aferesi della /w/ iniziale di wahlum (cf. a per /va/ nei testi di E b l a : CONTI 1 9 9 0 , p . 1 9 c o n n . 5 1 ) .
( 177) Il cui participio è invece mûdùm, da *muyda 'um. ( 178) Il NP mariota a-hu-ma-da, in un testo di Ebla, documenta anche la forma non con-
tratta may da 'um (cf. STEINKELLER 1993b, p. 241 sub 25).
252 APPENDICE
qadama, "precedere"). Si noti GIDIM — {nu-}ga-d\ì-mu-u\m ad Ebla (ARCHI 1987a, p. 97 riga 97; C I V I L 1984, p. 97), che at-testa l'esistenza di una forma sumerica più antica, *gadim (da ciù gidim, per assimilazione vocalica regressiva), più vicina al-l'etimo semitico postulato.
i 6: = nasi' 'ili (cf. K R E B E R N I K 1 9 9 1 ; CAD N/2, pp. 9 5 - 9 6 s.v. nasû Av. 2f [1 -2], e p. 113 s.v. *näsü B).
i 7: La ripetizione del nome del dedicante è assai inusuale; cf. però STEIBLE 1982b, p. 3 0 7 Uruk: Lukis. 2.
I 8-12: Per A.NI = a-buj™\ "padre" (stato costrutto), cf. KRE-BERNIK 1992, pp. 100-101 s.v. a-bù. Ciò che segue qui e alle righe successive può difficilmente interpretarsi altrimenti che come una serie di nomi di persona. Ne consegue che in questa parte dell'iscrizione siano elencati verosimilmente i figli di Sumba'lÙ130' (cf. S T E I B L E 1982b, pp. 188-189 ad 4 , per un esempio analogo). Si può presumere che la menzione dei figli avesse lo scopo di richiedere tacitamente la protezione e/o il favore divino anche per la discendenza del dedicante, così equivalendo funzionalmente alla formula nam-ti dumu-na-sè/-ne-ne-sè, "per la vita dei propri figli", che si ritrova in altre iscriziom votive.
i 8: Per il valore sup del segno KAM, cf. K R E C H E R 1983, pp. 183-184 ad ó ; K R E B E R N I K 1 9 8 8 , p . 6 3 sub S - L ; e P A G A N 1 9 9 8 , p . 9 2 sub
'sr. La lettura di KAM .AN. AH come sup-an-uh, per Süryanwuh, "Sur1181' j Il Toro (ossia il dio della tempesta Haddu/Adad) si è calmato" (cf. K R E B E R N I K 1988, p. 58 sub N-H; P A G A N 1998, p. 151 sub mvh; e S T R E C K 2000, pp. 337 e 410), è attraente, ma incerta. La polifonia dei segiù KAM (= jvVf1 a2'/ surj 183Vsup), AN (= am J an) e AH (= ah/ih/ uh) può dare adito ad altre letture'184';
(179) NI è ben attestato come sillabogramma col valore di ¿»16 sia ad Abu Salabikh (cf. KREBERNIK 1 9 9 8 , p . 2 9 4 ) c h e a d E b k (cf . ID. 1 9 8 2 , p . 1 9 8 ; CONTI 1 9 9 0 , p . 5 6 ; ARCHI et ai.
1 9 9 3 , p p . 1 9 - 2 0 ; e c c . ) .
(180) Supponendo che lo stato costrutto 'abu regga tutti i nomi che seguono (cf. VON SODEN-MAYER 1 9 9 5 , § 3 5 c ) .
(181) Cf. Au ur 'ta W G. LAMBERT 1985, p. 530 riga 27. (182) Cf. STEINKELLER 1992a, pp. 16-17. ( 183 ) Cf. FRONZARDU 2 0 0 3 , p. 2 9 6 s.u. s'ur-b'u-um; PASQUALI 2 0 0 3 ; e ID. 2 0 0 5 , pp. 8 6 - 8 7 .
(184) Si potrebbe pensare ad esempio ad un nome che finisca con 'ah, "fratello", come nei casi di a-ku-ah (CHARPIN 1987, p. 97), a-na-ah (PAGAN 1998, p. 281), ar-si-ah (ibidem, p. 288), gajqó-bajpá-ab (ibidem, p. 308), ru^f-a-ah (ibidem, p. 359), ecc.
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 2 5 3
inoltre, sebbene sia attestato^185', il predicato verbale ili seconda posizione è nondimeno piuttosto inusuale nei nomi di persona semitici d'epoca protodinastica.
i 9 : Per Qlpum ("Degno di fede") come nome di persona, cf. G E L B
1957, p. 116 sub Q"P. Si noti però che il segno KID non è al-trimenti documentato come sillabogramma in iscrizioni o testi accadici del terzo millennio. Un'altra possibilità è quella di emen-dare KID in E e leggere E-SUD, per Hay(ya)kurub, "Prega/ Benedici Hayya" (cf. TONIETTI 2003).
i 1 0 : Cf. a H a bí, "La mia città/tenda è mio padre", citato da G E L B
1957, p. 5. Per AD come logogramma per 'abum, "padre", cf. ibidem, pp. 1 0 - 1 1 sub ' B ; KREBERNIK 1 9 8 8 , p. 1 5 ; e MARCHESI
2 0 0 4 , pp. 1 9 3 - 1 9 4 . URU-AD lo si ritrova come nome di persona in BARTON 1 9 0 9 , tav 8 3 : HLb 7 3 v. 7 e sigillo 3 .
i 12: Cf. gir-bu-bu PA.TE.SI gir-kalld-ke4 in ETCSL 3.1.19:46 e 3.1.20 A 11.
Note: B O E S E (1996, pp. 26-34) lia di recente avanzato l'ipotesi che l'epigrafe di questa statua, rinvenuta nel tempio di INANA. 2A.2A ("Ninni-zaza") a Mari (cf. supra, §§ 1.1.7 e 2.1), sia un'iscrizione secondaria, da datarsi all'tiltima fase del Protodi-nastico. Che la maggior parte dei segni siano piti o meno iden-tici, quanto a forma, a quelli che si ritrovano stille altre statue e oggetti iscritti del tempio di INANA.2A.2A ( B O E S E 1996, p. 32), non corrisponde però al vero. Così come non è vero che "viele der 2eichen sind sogar schon aus eindeutig keilför-migen Elementen zusammengesetzt" (ibidem). Paleografica-mente l'iscrizione dà l'impressione di essere piuttosto arcaica, e comunque differente dalle altre epigrafi dal tempio di INANA. 2A.2A. B R A U N HOLZINGER (1977, p. 28) la data anteriormente al periodo di Fara, ossia al P rotodina s ti co II. Tuttavia le linee "curviformi" di alcmii segni, come ad esempio la "testa" del segno KA in i 9, o la parte terminale del segno AD alla riga successiva, rappresentano verosimilmente un tratto provinciale o uno stile volutamente arcaizzante (cf. infra, § A.2). Alctme caratteristiche del testo (lunghezza dell'iscrizione; suddivisione della stessa in caselle; ordine di scrittura dei segni conforme all'ordine di lettura; uso di grafie sillabiche; impiego della pre-
(185) Cf. a-ha-ar-sè (PAGAN 1998, p. 278), Uum-i-pi (WESTENHOLZ 1988, p. 114), ï-lum-is-ma (PAGAN 1998, p. 329), sar-ì-sa (ibidem, p. 362), ecc.
254 APPENDICE
posizione V-«a(1S6)) snggeiiscono infatti una datazione ben piti tarda, ossia alla fine del P rotodina s ti co Illb. L'identificazione della presumibile testa della statua, che iconograficamente si data al Proto dina s ti co Il lb finale / Protoimperiale (cf. pp. 135-1 3 6 . ) , sembra in accordo con tale datazione su base epigrafica. Le suddette peculiarità e il contenuto inusuale e senza paralleli di questa epigrafe potrebbero indicare un'origine non mariota della statua su cui è iscritta, specie se si considera che questa era dedi-cata a una divinità maschile, mentre il tempio di INANA.ZA.ZA, dove è stata ritrovata, era verosimilmente consacrato a una divi-nità femminile (cf. infra, § A.3.6). Lorse la statua in questione fu portata a Mari come bottino di guerra e dedicata secondariamente alla dea INANA.ZA.ZA (cf. BOESE 1 9 9 6 , p. 33)<137>. Il caso ben noto delle statue e dei monumenti regali mesopotamici razziati e portati a Susa dal sovrano elamita Sutruknahhunte, e da questi dedicati al dio di Susa, Insusinab, costituisce un buon parallelo (cf. H A S P E R 1 9 9 2 ) . Un'altra testimonianza, più antica, ci viene da alcune iscrizioni del re presargonico di Uruk Ensagkus'anak, il quale afferma di aver portato via le statue della città di Kis, da lui distrutta, e di averle presentate ad Ellil a Nippur (cf. STEIBLE
1982b, pp. 2 9 3 - 2 9 6 Uruk: Ensak. 1 e 3 ; COOPER 1986, p. 1 0 5 Uk 4.1)'188/
(186) La grafia 'a.-na ricorre altrimenti solamente nei testi, di Ebla, e in tina tavoletta presargonica di provenienza ignota (M. LAMBERT 1973, AO 7754 iii 7; cf. ARCHI 2002, pp. 3-4 con n. 7). Ei iscrizioni votive protodinastiche in lingua accadica da Mari, così come da altri centri mesopotamici, tale preposizione è in genere omessa (ossia, il nome della divinità a cui è dedicata l'iscrizione non è preceduto da alcuna preposizione; cf. p. 208 n. 12). Essa compare solo in un'epigrafe votiva da Sippar, d'epoca tardo protodinastica (GELB-KIENAST 1990, p. 32 VP 12:4; [x] no); e in un'iscrizione del re mariota Yiskrmari (Cat. 13), un contem-poraneo del re di Akkad Sarrumkïn (cf. p. 257 n. 197) — in quest'ultimo caso è però scritta a-na (cf. anche il NP a-na-da.-rtm, in GELB-KIENAST 1990, p. 6 MP 2:1). Nei testi amministra-tivi presargonici da Mari /'ana/ è usualmente scritto tramite il logogramma IS (cf. CHÄRPIN 1987, p. 89; e GENSHER 1997).
(187) E possibile che una seconda iscrizione, con dedica da parte di un qualche re ma-riota a INANA.ZA.ZA, fosse stata apposta nella parte posteriore del torso andato perduto.
(188) Tale costume, di razziare e portar via statue e monumenti regali dalle città vinte (cf. anche DURAND 1985a, p. 159 n. 55), potrebbe spiegare anche altri ritrovamenti di statue regali al di fuori del loro contesto originario, come ad esempio Cat. 5: appartenente a un re di Umma, ma ritrovata a Girsu (cf. supra, § 2.1), capitale del vicino, e tradizionale nemico, stato di Lagas.
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 255
Cat. 13 - Yiskimari di Mari {Tav. XXXVII: 6-7)(189)
1. ti]2(LAM) -hi¿Gif ma-ri Yiskimari, 2. LUGAL ma-ri re di Mari, 3. PA.TE.SI.GAL il fattore 4. dELLIL di ELLIL (= Dagän), 5. DÛL-3Ù lia presentato (8) 6. a-na la sua statua (5) 7. TNANA(.)NITA a (6) 8. SA12-RIK^ Astar virile (?) (7).
ESHL: THUSEAU DANGIN 1 9 3 4 , p p . 1 4 0 - 1 4 1 ; SOLLBERGER-KUPPER 1 9 7 1 , p. 8 8
I G 2a ; BRAUN HOLZINGER 1 9 7 7 , p. 6 9 M i s s . M a r i I N r . 1, M 1 7 4 ; GELB-
KIENAST 1 9 9 0 , p. 15 M P 17 ; COOPER 1 9 8 6 , p . 8 9 M a 6 ; BRAUN HOLZINGER
1991, p. 244 St 24.
(1:) Cf. PAGAN 1 9 9 8 , pp. 110-111 sub dkw. (3-4): La lettura accadica di PA.TE.SI .GAL è sconosciuta (cf. JACOBSEN
1991, p. 113 n. 2 ep. 114 n. 9). Per il titolo PA.TE.SI-gaì/PA.TE. S I . G A L N D , cf. p . 2 2 3 c o n n . 98 .
PA.TE.SI.GAL dELLIL lo si ritrova ancora in un'impronta di si-gillo dello stesso Yiskimari (Tav. EVI: 4: is^-ki^-ma-rí / LU GAL / ma-ri ! PA.TE.SI [.GAL?] / dELLIL), e nell'iscrizione della statata di Saybum, dove è riferito al re di Mari Yikfmsamas ( G E L B - K J E -
NAST 1990, p. 9 MP 8:3-4). Il suo equivalente sumerico, PA.TE.SI-gal dellil(-lá), è portato come titolo dai "grandi re" Lugalzagesi di Uruk (STEIBLE 1982b, p. 316 Urtrk: Luzag. 1:15-16) e Sarrumkìn di Akkad (FRAYNE 1993, p. 10 E2.1.1.1:10-11), oltre che dal dio Nmgirsûk/Nin'urtâk (STEINKEULER 1977, p. 51 n. 37; ID. 1989, pp. 238 e 241; JACOBSEN 1991, p. 114 n. 7). Adottando il titolo di PA.TE.SI-gal dellil nella loro titolatura regale, Lugalzagesi e Sarrumkìn verosimilmente avocavano per sé il ruolo di Nin'urtàk, e con esso l'onere/onore del mantenimento del tempio di Ellil a Nippur (cf. JACOBSEN 1991, pp. 113-114). Diverso è il caso invece dei re di Man1'190? L'uso da parte loro di PA.TE.SI.GAL dELLIL era presumibilmente dovuto all'identificazione, già nel terzo mil-lennio, del dio mesopotamico Ellil col dio siriano Dagän. In altre parole, dELLIL (= Hill ilo/Villiliy cf. p. 217 n. 61) rappresentava a
(189) Un'altra supposta statua di Yiskimari (cf. GELB-KIENAST 1990, p. 15 MP 18) reca iscritto in realtà il nome ispjfe/BAD, ossia, Yisklba'lum o Yiskïba'lï (cf. MARGUE RON 2004, p. 277 fig. 260).
(190) Si noti che nesstina iscrizione di un qualche sovrano di Mari è mai stata rinvenuta a Nippur.
256 APPENDICE
Mari un altro nome di Dagan, se 11011 addirittura un logogramma per quest'ultimo teonimo (cf. FLEMING 1994; DURAND 1995, pp. 146-152; ID. 1997, p. 278; e ARCHI 2004, pp. 322-328).
(7:) Cf. düTlJ(.)NITA in TM75.G.2593 v. iv 4-7 (Mem 1993b, pp. 470-471), usato ad Ebla per indicare il dio-sole mesopotamico, di diverso genere rispetto alla divinità solare femminile vene-rata ad Ebla e in Siria (cf. ARCHI 1993a, pp. 73-74; e POMPONIO-
XELLA 1997, pp. 341-342). Tuttavia, pare poco probabile che dINANA(.)NITA analogamente rappresenti l'oscuro e marginale dio s e mitico-occidentale 'Astar, distinto dall'omonima dea meso-potamica, come proposto ad esempio da GAWLIKOWSKA 1980 (cf. anche BORDREOL 1985; e W G . LAMBERT 1965, p. 537). Tanto piti che la controparte femminile di quello, 'Astarat, non è affatto atte-stata nelle documentazione epigrafica di Mari del terzo millennio, come invece si riteneva un tempo (cf. infra, § A.3.6)'191! dINANA(.)NITA denota presumibilmente la dea mesopotamica In'ariak/'Astar nel suo aspetto virile (cf. REINER 1995, p. 6 con n. 14; KOCH WESTENHOLZ 1995, pp. 125-126; HEIMPEL 1998-2001), ma non è chiaro se sia da leggersid'astar (ENANA) cçikrum (NITA), lett. '"Astar mascluo" (cf. THUREAU DANGIN 1934, p. 141 adi), o se sia invece da interpretarsi come un ideogramma del tipo "diri"'192) per un altro nome della dea legato appunto a questo suo aspetto'193! Cf. anche dINANA dBAD-«/ KALAM-tìm, '"Astar, il signore del Paese" (?), in ARET 5 n° 7 vi 2 (cf. KREBERNIK 1992, p. 95 LÌ. 4BE.AL(..KALAMTTM); e dINANA LUGAL, "'Estar-re" (?) in un'iscrizione votiva da Mari del tempo di Samsïhaddu ("Samsladad") (CHARPIN 1984, pp. 44-45 n° 2 riga 1 con commento ad loci).
A . 2 . CRONOLOGIA DEI SOVRANI PROTODINASHCI
La tabella che segue (p. 260) offre ima visione d'insieme dei sovrani pro-
todinastici noti, ordinati cronologicamente per città: essa scaturisce dalla corn-
ei 91 ) L'unica attestazione della dea 'Astarat (o LEstarat) nei testi di Mali risale al pe-
riodo paleobabilonese, in una lettera della principessa Gabi'atnm al re Yasma'liaddu
("Iasmahaddu"), dove tale dea è definita madre e dea del sovrano (cf. DURAND 1985b, p. 433
con n. 237). Qui essa pare piuttosto connessa col re "straniero" Yasma'haddu, ebe non con
la città di Mari.
(192) Cf . MARCHESI 2 0 0 1 , p. 3 1 6 c o n n . 36 .
(193) Presso i Sumeri ed i Semiti della Mesopotamia meridionale tale forma maschile di Irianak era chiamata Nin'usanak (scritto dnin-usans(SI/SU4)all-na; cf. HEIMPEL 1998-2001).
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 2 5 7
binazione e sintesi di informazioni testuali (parentele, genealogie, sincronismi), analisi paleografica e linguistica delle epigrafi, analisi storico-artistica dei loro supporti materiali, e dati archeologici relativi ai contesti di ritrovamento (per cui cf. sufra, §§ 1.1, 1.2 e 3.2).
E inutile sottolineare il carattere forzatamente ipotetico e provvisorio di al-ctme parti di tale quadro, specie laddove l'unico criterio utilizzabile per tuia da-tazione sia quello paleografico, come nel caso di alctmi sovrani di Adab. Infatti la paleografia delle iscrizioni su pietra è ancora scarsamente nota e studiata. L'in-dividuazione di Schriftstufen sulla base della comparazione di pochi segni tratti da un numero estremamente limitato di epigrafi provenienti, per di più, da luoghi diversi, come fa ad esempio Braun Holzlager'194/ è non solo metodologicamente scorretta e di dubbia scientificità, ma anche fuorviarne (cf. supra, § A. 1.4 note a Cat. 7 e 12).
Brggs ha dimostrato come la scrittura su argilla vari significativamente da centro a centro, in epoca proto dina s tica1195); è ragionevole supporre che lo stesso valga anche per la scrittura monumentale usata per statue e altri oggetti in pietra. Ha quindi poco senso, per esempio, confrontare un'iscrizione da Adab con una proveniente da un sito del Diyala. Quello che occorrerebbe è un numero suffi-ciente di oggetti stratificati iscritti da ogni singolo sito e l'elaborazione, a partire da questi, di tuia serie di paleografie "locali" che rendano conto dell'evoluzione della scrittura ili ogni singolo centro. Ma nulla di tutto questo è ancora stato fatto, né il materiale a disposizione è probabilmente bastevole a tale scopo.
Le epigrafi provenienti da contesti archeologici ben definiti sono poche, e in genere piuttosto brevi (cf. supra, § 1.2). Parecchi segni non presentano ap-prezzabili variazioni nel corso del tempo, e non sono quindi utilizzabili ai fini di una datazione. Ili altri casi variazioni nella forma dei segni sono più imputabili alle mani di differenti lapicidi, o ad altri fattori come dimensione e forma degli oggetti iscritti, materiali e strumenti impiegati, ecc., che non a differenze crono-logiche1196). Nel caso di iscrizioni regali, poi, si deve sempre considerare anche la possibilità dell'impiego di ima scrittura arcaizzante, che potrebbe falsare la nostra datazione delle stesse1197).
Ciò premesso, l'analisi paleografica si rivela comunque utile e/o necessaria laddove non si disponga di altro e/o di meglio. Cosi com'è utile, per l'attri-buzione di ima determinata epigrafe al Proto dina s tico Illb, piuttosto che a un
(194 ) BRAUN HOLZINGER 1 9 7 7 , p p . 2 0 - 2 8 .
(195) BIGGS 1973 .
(196) Cf . BIGGS 1973 , p. 46 .
(197) C f . a d e s e m p i o THUREAU DANGIN 1934 , p. 143 : " à e n j uge r p a r l e t y p e d ' é c r i t u r e ,
la statuette de Lamgi-Mae'ri [= Yiskrmari: Cat. 13] peut remonter à peu près au temps d'Ur-Natise [= Urnansêk]". Impronte di sigillo di Yiskïmari rinvenute di recente dimostrano in-vece che tale re era un contemporaneo del re di Akkad Sarrumkin (cf ARCHI-BIGA 2003, pp. 30-35; e supra, pp. 138-139).
258 APPENDICE
periodo anteriore, osservare se l'ordinamento dei segni corrisponda o meno al-l'ordine di lettura degli stessi. Tale criterio va però utilizzato ili modo 11011 dog-matico. A Lagas i segni venivano scritti regolarmente secondo l'ordine di lettura solo da E'annâbtum in poi. Ma non sappiamo se ciò sia l'esito di mia riforma del sistema di scrittura promossa da questo sovrano, o se si tratti invece di un'in-novazione più generalizzata della prassi scribale me sop ota mie a. L'impressione è che si tratti di una tendenza generale, ma che l'adeguamento dell'ordinamento dei segni all'ordine di lettura sia avvenuto in tempi diversi a seconda dei luoghi; di fatto, alcune epigrafi probabilmente anteriori all'epoca di E'annâbtum, come ad esempio quella della statua di E'abzu (Cat. 5), presentano già tale caratteri-stica'198).
Ovviamente più solido è il terreno 111 quei casi in cui disponiamo di infor-mazioni testuali sulla successione dei re in un determinato centro, o sui rapporti tra sovraiù di differenti città. Le sequenze dei re di Lagas, Umma, Ur, Uruk ed Ebla sono del tutto (Lagas, Umma ed Ebla) o in gran parte (Ur e Uruk) certe. Di molti sovrani di Lagas conosciamo anche la durata esatta o approssimativa dei rispettivi regni:
E'annâbtum regnò forse per ca. 30 armi'199). En'armâbtum I regnò per almeno (probabilmente non molto più di) 4 anni'2005. Enmetênnak regnò per ca. 20 o 30 armi'2015. En'annâbtum II regnò per 5 armi'2025.
(198) La maggior parte delle epigrafi dal livello VIIB del tempio di In'anak, che si data al Protodinastico Il la, sono parimenti scritte rispettando l'ordine di lettura dei segni (cf. GOETZE 1 9 7 0 - 1 9 7 1 ) .
( 199 ) Cf. CKOS et al. 1 9 1 0 - 1 9 1 4 , p. 1 8 0 b (= testo in basso), datato apparentemente al 27° anno di regno di un sovrano il citi nome non è nominato o conservato Paleografica-mente la tavoletta in questione differisce significativamente da quelle datate o databili ad Enmetênnak. Ne consegue perciò che sia da attribuirsi con ogni probabilità ad E'annâbtum, il quale, a giudicare anche dal contenuto delle sue iscrizioni, deve aver avuto un periodo di regno piuttosto lungo (cf. COOPER 1 9 8 3 , pp. 24-28; e BAUER 1 9 9 8 , pp. 4 5 6 - 4 6 6 ) .
( 200 ) Cf. BIGGS 1 9 7 6 , n° 10 , datato al 4° anno di En'annâbtum I. V. E. CRAWFORD 1 9 7 7 ,
pp. 2 1 9 - 2 2 2 4H-T38, datato al 3° anno di regno di un sovrano non specificato, è pure da attribuirsi probabilmente ad En'annâbtum I (cf. ibidem, pp. 1 9 8 - 2 0 0 ) . Essendo succeduto al fratello maggiore, E'annâbtum, che regnò per un periodo di almeno 27 anni (cf. la nota pre-cedente), è ragionevole supporre che la durata del regno di En'armâbtum I sia stata piuttosto breve. Tanto più che mori, pare, di morte violenta nel corso di un conflitto con l'eterna rivale di Lagas, Umma (cf. COOPER 1983, p. 30).
( 201 ) Cf. RTC 1 6 e CROS et al. 1 9 1 0 - 1 9 1 4 , p. 1 8 1 A O 4 1 5 6 , entrambi datati al 1 9 ° anno di Enmetênnak. Due tavolette conservate a Istanbul recano forse datazioni al 20° e 27° anno di questo stesso sovrano (MAEKAWA 1 9 7 3 - 1 9 7 4 , p. 1 3 8 , e 1 3 9 n. 8 9 ) , ma necessitano ambedue di collazione.
( 202 ) C f . BAUER 1 9 9 8 , p . 4 7 4 .
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 259
En'entarzid regnò per 5 anni e 1 mese*203). Lugaldigirda regnò per ó anni e 1 mese1204? Ere'inimginâk regnò per 11 anni1205?
Da tali dati si può inferire che il periodo compreso tra l'avvento di E'an-nàbtum e la fine del regno di Ere'inimginâk sia durato ca. 80/90 anni, e co-munque non più di un secolo. L'intera durata della dinastia fondata da Urnansêk è stimabile in ca. 110/120 anni. Aggiungendo 21/25 amù di regno di Lugalza-gesi'206/ si ottiene ima stima di ca. 131/145 anni per la durata del Protodinastico Illb. Informazioni analoghe per le fasi precedenti mancano del tutto.
(203) Ibidem. (204) Ibidem, p. 475.
(205) Ibidem, pp. 477-478. (206) I val i manoscritti della "Lista Reale S lime rica" concordano ndl 'assegnare 25 anni
di regno a Lugalzagesi come re di Uruk (JACOBSEN 1939, pp. 110-111). Dinante il 5° anno di regno di Ere'inimginâk a Lagas, re di Uruk era ancora Ensagkus'anak (cf. BAUER 1998, pp. 479-480). In Ukg. 16 (STEIBLE 1982a, p. 334 sgg) , da datarsi all'anno 8 di Ere'inimginâk (cf. BAUER 1998, pp. 477A78 e 489-493), Lugalzagesi è nominato come lú/PA.TE.SI n m m Ù Pertanto è ragionevole supporre che l'ascesa di Lugalzagesi al trono di Uruk non sia avve-nuta prima di quell'anno.
TABELLA A L . - Cronologo dei sovraniprotodìnastìà. PD LAGAÈ UMMA UR ADAB URUK KIS' MARI DIYALA ALTRI CENTRI I Pabügamea
rGfle»meá")?em
n
Pabifea? fi HAKTÜ-
n Lugalmen?'11' Ii
n DÙNAK 2 1 2 J n Isibbaragesi '1' ff
n
Urlammarak'1''
Illa
Luíiima'"1''1 lì
Illa Illa
L ug als agdag a la k 1 Ereèki salesilì LummaM'ij Mësalim Ii
Illa Baragsagpudkl Ut-AN.SI™ i'Geskul'abák) Illa
Urpabilsagakak ' Isibdurbar;ö4) UragpaW8"1 ft Lugalnamnirsum2261 Ii Abzukidug (Nippur)
Illa
E'abzu ' Mesnuneki'ag"* lì T- Í W) Epa e
LUGAL-UTU Ii Yanüpu 1' Nammah (Nippur)
Illb
EBLA Yibbi'dämu Bakaydimu
Illb
UrmnsêV™1 Pabilgagaltukuci04) Aya'ugedug'10 Lugaldalu '1 Aya'anzud?2 Hinnam'il ' Sa'ûmum
EBLA Yibbi'dämu Bakaydimu
Illb
Ayakurgal UÈ Mes'uçédug '9'1 B aragannedug1'1''' [Mes'ugédugj Istupyisar,
EBLA Yibbi'dämu Bakaydimu
Illb
E 'an nabt umD E'24 En'ikaie D Mes'anepadda c>; • ; > (243) II E ìginimpa e
Lugals ila si [E'annabtum, Mes'anepadda, Lugalsilàsi]
Yikiin'a hur>í244) 4 Yinhardämu Zuzu (Aksak)E
Illb En'annàbtum I1""1''1
Ilrlüitunäk ÌLH
. , J , ÇM) Aya anepadda
Miageá 1 S,T' 1Ì Urzag'e Ii [Urzag'e] Yikün samas lì li Yisarmalik Ursuf™ (GE&kuTabak) Illb
Erancllnrak 11'5"1
Ilrlüitunäk ÌLH Lugalki-DU.NI-
ïufod1
Lugalkis alesi
Enmc'anu' Ii
Lugalki-DU.Nl-fufud1
Lugalkis alesi
[Lugalki-DUNI-fufud1] Yikünmari lì li Kündämu Ur'cllilak (Nippur)
Illb
En'annàbtum II ôessagkidug
Lugalki-DU.NI-ïufod1
Lugalkis alesi
Enmc'anu' Ii
Lugalki-DU.Nl-fufud1
Lugalkis alesi
Yikün sa mkän " ' lì Yaddubdämu
Ur'cllilak (Nippur)
Illb
En entarzid ôessagkidug
Lugalki-DU.NI-ïufod1
Lugalkis alesi Ursagkesak,2M)
IUI
Lugalki-DU.Nl-fufud1
Lugalkis alesi Ú.HUBP U YçhrfiP* Yigrishalab 'Ilsu-ÉREN+X (Mitât)*0"
Illb
Lugaldigiida'2 1 Me'anédug2W)
U'u™ EHH HAKTU-Asgik9"1
1Ì
Lugalki-DU.Nl-fufud1
Lugalkis alesi Nl-tfJ Ihnnamdagän K YirkabdämuJKL Zia (I-]amaa)i2ö)
Proto imp.
Ere'immginâkV£fJ
Meszi Lugabagesi M
Mese Q (Ensagkus'anak) (Lugalzagesi) Lunannâk
Mmkjgallal"™' Ensagkus'anak Lugalzagesi Girimesi
'Lnbi'astar ° Urzababák? ^ Sarrumkín ("Sargon**)Q
Yikün yisar p
Tâbdâr1 YiSldmari'2 '
Yi sgardämu Sumba-r™5' (1
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 261
Simboli e convenzioni della Tab. A l :
1) NP,A NP,A = sincronismo attestato tra NP, e NP - NP,B NP, c N P , K = sin-' \ 1 1 2.' 1 1 J
cronismo attestato tra NP e NP3 e tra NP2 e NP.. 2) NP 1ì — datazione incerta, forse da innalzarsi. 3) NP W — datazione incerta, forse da abbassarsi.
(207) Tra parentesi quadre sono riportati i nomi di quei re che avocavano per sé il titolo di lugal kisi'N pur non essendo re della città di Kis. Non è chiaro se in tali casi lugal kisfo' sia da intendersi metaforicamente come "grande/potente re", riflettendo la passata potenza dei re di Kis, che un tempo estendevano la loro autorità sul sud del Paese; o se invece l'uso di tale titolo da parte di sovrani di città meridionali denotasse una loro egemonia (effettiva o solo rivendicata) sulla Babilonia settentrionale, ovvero sulla regione tradizionalmente con-trollata da Kis (cf. p. 220 m 81).
(208) Cf. MARCHESI 2004, pp. 195-197 ("On die Historicity of Gilgames").
(209) Tav LXTV: 2. Precedentemente letto "Enlilpabilgagi" (EDZARD 1959a, p. 21; STEIBLE 1 9 8 2 b , p . 2 6 5 U m m a : E n p . 1 ; PETTINATO 2 0 0 3 , p. 1 2 4 U m . 1) o P a b i l g a g i (COOPER
1986, pp. 91-91 Um 1). Tuttavia tali o analoghi nomi di persona non sono altrimenti atte-stati. Inoltre tra pa-bil-ga e il segno GI+ è interposto iellil. Meglio, forse, leggere: pa-bil-ga . . . YJlilf-la) (mu-na-an-)gi+ (cf. p. 230 n. 140), "Pabilga . . . ha restituito/risposto ad Ellil" (cf. Gebhard SELZ 2003b, p. 506 n. 31; per Pabilga come nome proprio di persona, cf. BURROWS 1935, p. 37 sub 601; POMPONIO 1987, p. 204; ecc.). Quanto al titolo di Pabilga, tradizional-mente letto "lugal SARxDIS" ed identificato col titolo lugal SAR 'DIS (più precisamente HIXDIS) portato dai re di Umma a partire da Urlummàk (cf. p. 227 n. 123), la presente iscrizione reca piuttosto HIxAS (cf. la foto pubblicata di recente in ARUZ-WALLENFELS 2003, p. 51). Non è certo, quindi, che si tratti di un re di Umma.
(210) Cat. 1. ( 211 ) Cf . BONECHI 2 0 0 1 a .
(212) Cat. 2. (213) Scritto ME-barag-si e tradizionalmente letto "Mebarasi" o "Mebaragesi". Il con-
fronto con altri nomi paralleli, come ama-barag(-ge)-si, eres-barag-ge-si, lugal-barag-ge-si, ecc., supporta una lettura del segno ME come titolo, ossia isib (cf. MlCHALOWSKI 2 0 0 3 , pp. 1 9 9 - 2 0 1 ; e supra, p. 2 1 5 n. 5 4 ) . Per una differente interpretazione, cf. KREBERNIK 2 0 0 2 , pp. 2 3 - 2 4 .
(214) Cf. p. 214 sub l b con m 50. (215) Cat. 3. (216) Tav. XIV: 2. Cf. , § A.1.4 commento a Cat. 3:2 con n. 163. (217) Tav. XI: 10. Cf. p. 216 sub 4c con m 59. (218) Tav XV: 2. Scritto NIN-KISAL-si. Per la lettura Ereskisalesi, cf. p. 211 n. 32; e
MARCHESI 2004, pp. 1 7 4 - 1 7 5 .
(219) TSS 302 colofone (v vi): gii-an-sè / [x] +20+2[(+x)] gú-sag / unug^ / lum-ma NlG.PA.TE.SI, "totale: 22+x distretti; Uruk; Lumma è il viceré". Un'edizione di questo
2 6 2 APPENDICE
importante testo che elenca i vari distretti dello città-stato di Uruk durante il periodo di Fara è in preparazione. Per una possibile datazione dei testi di Fara al periodo di Me salini, cf. p. 221 n. 83.
(220) Tav XL 10, XIV: 3, XV: 2. Cf. p. 216 sub 4c con n. 56, e pp. 220-221 con im. 81 e 83.
(221) Cf. p. 216 sub 4b, e § A.1.4 note a Cat. 5. (222) Cat. 6.
(223) Cf . MARCHESI 2 0 0 4 , pp . 1 7 2 - 1 7 3 .
(224) Tav XTV: 1 e 4. Cf. p. 218 sub 3b con n. 54.
(225) KLENGEL-KLENGEL 1 9 8 0 , p. 49 ; I2NDEMET"ER-MAR.HN 1 9 9 3 , tav. 61: 690 : u r - s a g - p a -
te1 / runug/9 [. . . ] . Per l'integrazione, nella rottura, di un titolo di sovrano (en o lugal), cf. isib-dur-ba / u r a b i y ( U D . ' M I N " ) lugal (per lugal urabu, "re di Adab") in LÜCKENBILL 1 9 3 0 , N° 8 :2-
3 (Tav XTV: 4); e [NF] /kisi [l]ugal (per lugal kisi, "re di Kis") in JACOBSEN 1942, p. 291 n. 9. (226) Tav XIII: 5-6: higal-nam-nir-súm / lugal kisi. Cf. Tab. 5 sub m e p. 201. (227) Cat. 5.
(228) Cf . MARCHESI 2 0 0 4 , p. 168 n . 9 7 .
(229) Cat. 4. (230) Tav. XIX: 4 (sigilo): LUG[AL]-UTU [LU] GAL; Tav. L: 1: LUGAL-UTU LUGAL.
Identica iscrizione anche su tuia testa di mazza proveniente da Maxi (PASROT 1956, p. 130 e tav. LTV). Il nome è forse da leggersi in accadico: Ba'lïsamsï ("Il mio signore è il mio sole"); cf. BAD-fé"UTU-n" (GELB 1952, n° 109:3'). D'altra parte, si noti lu-gal-UD in WESTENHOLZ 1975a, n° 132 i 2.
(231) Cf . FRONZARDII 2 0 0 3 , 3 9 ad 2.
(232) Cf. ARCHI 2001. Per i sincronismi tra i re di Mari e quelli di Ebla, cf. ARCHI-BIGA 2 0 0 3 .
(233) T a w XI: 5 e 7 (iscrizione inedita: [ . . . è]s gír-su mu-[fú]), XIII: 1-2 e 4, L: 2a (cf. supra, § A.1.4 note a Cat. 1) e 3-4, e LI: 1-2.
(234) Cf . MARCHESI 2 0 0 4 , p. 196 .
(235) Cf. MARCHESI 2004, pp. 178-180, 183-184 e 190-191. (236) Cat. 7. (237) Cf. § A.1.4 note a Cat. 11. (238) Cat. 11 (239) Tav XVI: 3 (sigillo): mes-ùg-dùg / lugal. Per la lettura del nome, cf. MARCHESI
2004, pp. 161-162, 183-184 e 190-191. (240) Tav XLV Cf. pp. 209-210 con n. 23 (241) Tav. LII: 1 e 3. Per la lettura del nome, cf. p. 206 n. 1. (242) Tav XVI: 4 (sigillo): mes-an-né-pàd-da / lugal kisik / dam nu-gig (cf. ZGOLL
1997).
(243) Tav. XV: 3. Cf. § A.1.4 note a Cat. 7, p. 242 m 170, e § A.3.1. (244) Tav LXEH: 1 (sigillo): NP / DAM / b 5 - k u - a - / EN ma-rik .
(245) Cat. 8 e TAV. I I : 3. Per la lettura del nome, cf. pp. 206-207 n. 1. (245) Tav XVI: 9. (247) LCCKENBILL 1930, n° 52 colofone: mug-si NÍG.PA.TE.SI ruiabuJUD.''NUN")k*i .
Un prelievo d'orzo dalla household di Mugesi per un pagamento effettuato dal viceré di Adab E'iginimpa'e (GET R et al. 1991, Appendix to no. 32) suggerisce che la suddetta household fosse
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 263
sotto il controllo eli quest'ultimo e, in ultima analisi, che Mugesi fosse a quel tempo proba-bilmente il figlio e delfino di E'iginimpa'e. Un altro viceré di Adab di nome Mugesi (mug-ge-si), che regnò presumibilmente durante il periodo accadico, è menzionato in un testo di scuola sargonico (WESTENHOLZ s.d., 26 ad [SC] 2818).
(248) Cf. § A.1.4 commento a Cat. 6:2-3.
(249) Cat. 9-10. Per la lettura del nome, cf. p. 207 n. 2. (250) Scritto sia lugal-ki-DU.NI-fu.-fu5(-d) (in iscrizioni da Nippur, Uruk e Ur), sia lugal-
ki-NI(.$É)-ru.-ru5 (in iscrizioni da Lagas). Tali varianti ortografiche sono forse da armoniz zarsi leggendo lugal-ki- ! j4sarE-fu5-ru. e higal-ki-seryNI) i ;sel-ru ;-ru_, con la seconda forma che potrebbe riflettere una differente pronuncia del nome nel dialetto locale di Lagas.
(251) Per tale lettura, piuttosto che "Lugalgiparsi", cf. MARCHESI 2004, pp. 174-175, e 190 n. 213.
(252) Scheven Collection 3792 v i 12-15: ud-ba / ENxME-nú / NÍG.PA.TE.SI / urabu (UD."NUN")ki (A. Westenholz, c.p.). La grafia ENxME-nù rappresenta verosimil-mente lo stesso nome che è scritto en-me-a-nú ("Il Signore giace tra i me [= poteri divini]") in BI 205 ii 1 (sargonico; F. Pomponio, c.p.).
(253) Cf. p. 208. (254) Citato da WESTENHOLZ s.d., p. 23 ad [ S q 2464: ur-sag-kès / NÍG.PA.TE.SI al.-til
(colofone). Per l'interpretazione del NP ur-sag-kès come sintagma genitivo (ossia, {ursag-kes.ak}, "Guerriero di Kes"), cf. ur-sag-a-ga-dè^-ka in RTC 102 ii 5.
(25 5) Cf. p. 225 con nn. 115-116. ( 2 5 6 ) Cf. p. 2 0 9 .
(257) Tav EXII: 3 (sigillo): is-má-i-lum / dumu ¿ W É R E N + X / PA.TE.SI / ma-taA-ra. Cf. STEINKELLER 1986, pp. 27-31; e GELB et al. 1 9 9 1 , p. 1 0 5 ad G 1 0 - 1 1 .
(258) Tav LXII: 1 (sigillo): lugal-digir-da-nu-hug-gá / PA.TE.SI / lagas j ;[NU11.BUR) la t ' . Per la lettura del nome, cf. pp. 217-218 n. 64.
(259) Cf. p. 227 n. 121. (260) Cf. ibidem n. 122. (261) Attestato in CUNES 02-13-021: HAR-TU-GsgL(HIxDIS)^4 / NÍG.PA.TE.SI /
i-na-lá (G. Visitato, c.p.; citazione cortesia di D. I. Owen, Conservatore delle Collezioni di Tavolette).
( 2 6 2 ) Cf. FRONZAROU 2003, pp. 30-31.
( 2 6 3 ) Cf. p. 2 2 4 n. 1 0 6 .
(264) Per i sincronismi di Eres'inimginâk con Lugalzagesi ed Ensagkus'atiak, cf. p. 259 n. 206.
( 2 6 5 ) C f . MARCHESI 2 0 0 4 , p . 1 6 7 .
(266) Generalmente letto "Hida'ar", ma molto più probabilmente da leggersi tab{DÜG)-da-ar; ossia, Tâbdâr; cf. le varianti ortografiche /AyDAPu) -da-ar e ta-da-ar del medesimo nome in ARET 1, p. 238 e ARET 3, p. 265, rispettivamente. Per l'elemento teoforo dar nell'onomastica di Ebla, cf. PAGAN 1 9 9 8 , p. 1 0 8 s.v. dwr. Si noti infine che il sigillo di questo stesso re, di cui si sono rinvenute di recente alcune impronte, recava probabilmente l'iscrizione: tabß3Ä&frda-ar / LUGAL / ma-V (cf. ARCHI-BIGA 2 0 0 3 , p. 3 0 con n. 8 4 ) .
(267) Cat. 13 e Tav. I V I : 3 (is^-ki^-ma-ri / LUGAL ma-ri) e 4 (cf. § A.1.4 commento a Cat. 13:3-4). Cf. p. 257 n. 197.
(268) Cat. 12a.
264 APPENDICE
A . 3 . N O T E SULLE DESIGNAZIONI DI ALCUNI T E M P I I PROTODINASTICI
A paite i casi, sporadici, in cui ci è stato tramandato fi nome antico del san-tuario o complesso templare (l'Emah della dea Digrumali ad Adab; il Bagara e l'Eninnu del dio Ningirsùk rispettivamente a Lagas e Gir su1269'1; ecc.), i siti cultuali protodinastici sono convenzionalmente denominati a partire dai rispettivi pro-prietari divini, o presunti tali, laddove il ritrovamento di iscrizioni di fondazione, come nel caso del tempio di Ninhursagak a Teli al-'Ubaid (antica Nutur)1-270/ o dediche di fedeli su statue o oggetti votivi ne permettano l'individuazione. Cosi si parla del "Tempio di Abu" ad Esnunak, del "Tempio di Inanna" a Nippiu", del "Tempio di Ninni-zaza" a Mari, e cosi via.
Alctme di tali denominazioni moderne, ormai codificate dall'uso, sono però inadeguate e fuorviatiti; o comunque basate su analisi errate della documenta-zione epigrafica disponibile. Qui di seguito sono trattati e discussi i nomi dei principali santuari protodinastici ili cui sono state rinvenute statue.
A.3.1. Adab
Secondo Z. Yang:
Diere were too temples in the early history of Adab, E-sar and E-mah. The archaeological evidence from Bismaya makes it sufficiently clear that E-sar was an earlier temple with a limestone foundation and that E-mah was a later temple with a foundation of plano-convex bricks, built on the top of the ruins of the E-sar. Textual evidence supports this sequence, since, of the two, E-mah was the temple mentioned in the Old Akkadian period (271).
Pili di recente A. George lia suggerito che l'è-SAR delle iscrizioni presargoni-che di Adab sia da connettersi invece con l'é-sar-ra, il tempio di In'anak ad Adab che ricorre in vari testi lessicali e letterari, a partire dal periodo paleoba-
(269) Il nome é ninrm ("Le cinquanta case") è attestato pei la prima volta con En'an-nâbtum I (cf. BEHRENS-STEIBLE 1983, p. 412). Nelle iscrizioni dei sovrani di Lagas precedenti si fa riferimento ad esso come é dnin-gír-su/sú, "tempio di Ningirsùk" (ibidem, p. 385), o ès gír-su/sù, "santuario di Girsu" (ibidem, p. 414). Un passo degli "Inni zame" da Abu Sala-bikli lascia però intendere che più anticamente tale tempio fosse chiamato é-gir-nun, "Casa-grande/nobile spada" (cf. STEIBEE 1982b, p. 17). Girnun è documentato anche successiva-mente come altro nome o epiteto del tempio di Ningirsùk (cf. BEHRENS-STEIBLE 1983, p. 414; FAEKENSTEIN 1966, p. 75 s.v. Hegirntmna, pp. 123-124 s.v. bára-gír-nun-na, e n . l a p . 124).
( 2 7 0 ) C f . STEINKEELER 1 9 9 5 .
( 2 7 1 ) YANG 1 9 8 9 , p . 9 9 .
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 265
bilonese'272/ Avremmo quindi, secondo l'interpretazione di George, due santuari distinti, l'uno (é-SAR/é-sar-ra) dedicato ad In'arrak, l'altro (é-mah) a Digit mah.
Dell'Email abbiamo un'iscrizione di fondazione di E'iginimpa'e (Tav. XV: 3), dove si dice espressamente che tale santuario era dedicato alla dea Digirmah:
1- digir-mah Pei Diga/mah, 2. é-igi-nim-pa-è E'igìnimpa'e, 3. NÌG.PA.TE.SI viceré 4. urabui(UD.ItNUrN")M di Adab, 5. é-mah mu-na-rd costruì TEmah, fi. úr-bé ki-sé e seppellì depositi di fondazione 7. temen ba-si sotto la sua base''272'.
Nella composizione letteraria nota come "Inni ai Templi", il medesimo tempio è attribuito a Ninhursagak'274/ In realtà Digirmah e Ninhursagak non sono che due diversi nomi per la stessa divinità'27^. Dalla favissa da cui provengono le iscrizioni die menzionano l'è-SAR provengono anche un frammento di vaso con dedica a Digrumali'276' e un'iscrizione del re di Kis Mësalim, dove questi reca l'epi-teto di "amato figlio di Ninhursagak"'277/ ciò suggerisce che l'é-SAR fosse, come l'Email, consacrato piuttosto al culto di Digirmah /Ninhursagak'273/
Che é-SAR fosse il nome più antico del tempio ribattezzato col nome di Email da E'igiiiimpa'e emerge chiaramente anche dal confronto dei seguenti due testi, l'imo protodinastico, l'altro sargonico:
B I N 8 7 r LUCKENBUÌ 1930 , N° 143:
1_ [x]+10 là 1 ló 1 urai(UDU)<7W)
2. é-SAR é-mah 3. 4 dasgi3(HLDIS)^ 1 é-GÁNA.SAHAR 4. 4 GÁNA.SAHAR 1 uïa 1 ura-kungal G g g p I R p 5. 2 "m'anak (MUS) 1 uia i aiskur fi. 3 den-ki 1 ud. Afiuiak^IÙS) 7. r4 é-damP 1 ura aen-ki
(272) George 1993, pp. 140-141 sub 978. (273) S TE IB UE 1982b, pp. 189-190 Adab: Eig. 1. (274) ETCSL 4.80.1:365-378. (275) Similmente a Lagas la stessa dea è nota sia col nome di Ninhursagak, sia con quello
di Eresmah (cf. Gebhard SELZ 1995, pp. 252-253 s.u. Ninhursag [2], e p. 256 s.ti Ninmah). Cf. anche An = Arnim I 1-3 (TJTKE 1998, p. 86): digir mah = àbe-kt-ì-li / deres-mah = MIN / dnin-hur-sag-gá = MIN.
(276) Steible 1982h, p. 196 AnAdab 8. (277) Cf. p. 221 n. 83. (278) Cf. già BANKS 1912, pp. 259-266. (279) Per tale lettura della parola sumerica per "montone, pecora", cf. DE M A A I J E R J A
GERSMA 1997-1998, p. 286 s.v. a]2-rà-bu.
266 APPENDICE
Il primo documento si riferisce a uomini (lù) assegnati al servizio di templi e divinità; il secondo registra tuia distribuzione di pecore (ura , ura -kruigal) e capre (ud/, sempre a templi e divinità. I due elenchi sono largamente paralleli, e é-SAR ed Emah occupano esattamente la stessa posizione nelle due sequenze. Inoltre l'é-SAR è elencato separatamente da In'anak, il che conferma che quello non era il tempio di questa.
A.3.2. Nippur
"Tempio di Inaima": identificato come tale da un'iscrizione di fondazione di Sulgiri280/ Il nome antico era é-barag-dúr-gar-ra, "Casa-podio del trono"1281/ Dai livelli protodinastici provengono numerose iscrizioni votive dedicate a Iriaiiah1232/ che confermano la continuità del culto della dea ili questo sito fin dai tempi più arcaici1233'1. Dal livello VIIB, databile al Protodinastico Illa, pro-vengono però anche due iscrizioni indirizzate alla dea Ninsig (dmii-SAR)1234/ Ciò lascia supporre che le due celle del tempio dei livelli VIII-VIIA fossero dedicate l'uria a In'anak, l'altra a Ninsig (cf. supra, §§ 1.1.2 e 1.3).
A.3.3. Tutub
"Tempio di Nintu": cosi denominato sulla base della presunta dedica alla dea "Nintu" di un bassorilievo votivo (Tav. LIA7: 1), i ciù frammenti sono stati ritrovati ili tempi diversi in differenti parti dell'area templare1285/ L'iscrizione su tale bassorilievo è stata cosi mterpretata da Jacobsen:
"To Nintu .. . , child of Dam-gal-nuna(k), has É:KÜ(?):A(?), child of Ama-abzu(k)da, presented (tins)"1236/
( 2 8 0 ) C f . ZETTLER 1 9 9 2 , p p . 16 E 2 3 9 .
( 2 8 1 ) Cf. ibidem, p. 16 con n. 3 9 ; E GEORGE 1993, pp. 71-72 sub 110. Non attestato però prima del periodo paleobabilonese.
( 2 8 2 ) Cf. GOETZE 1 9 7 0 - 1 9 7 1 ; e STEIBLE 1982b, pp. 223-224 e 233-251. (283) Le più antiche iscrizioni votive con dedica a In'anak risalgono al Protodinastico
I l la . Da mi livello inferiore del tempio di In'anak, databile al Protodinastico II, vengono tre statue iscritte (cf. supra, § 1.1.2 Tab. 3); nessuna di esse menziona però il nome della dea.
(284) Goetze 1970-1971, pp. 42-43 e 50-51 7N-122 e 7N-133 (cf. Tav LX: 6); Steible 1982b, pp. 239-240 AnNip. 24. Per Ninsig, cf. Caviglie aux-Krebeinik 1998-2001a. La grafia dnin-SAR-ga (genitivo) e le varianti "sillabiche" dnin-si e ni-in-si (ibidem, sub 1) puntano a una lettura dnin-sig i(SAR), piuttosto che dnin-nisig (così Cavigtieaux-Ktebernik loc. cit.). Per il valore /sig/ del segno SAR, cf. anche Michalowski 1993, pp. 124-125 n. 17.
( 2 8 5 ) C f . DELOUGAZ-LLOYD 1 9 4 2 , p . 8 2 .
(286) Jacobsen 1942, p. 290. Cf. anche Steible 1982b, pp. 209-210 AnHaf. 7.
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 267
Tuttavia, che mia divinità sia qualificata come "figlio/a" di un'altra divinità (per giunta del tutto secondaria come Damgalnunak) è assai inusuale in un'iscrizione votiva; più verosimilmente questa iscrizione(2S7) reca i nomi di due offerenti (presu-mibilmente i due personaggi ritratti nel bassorilievo) coi rispettivi "patronimici":
1. aNTN.TU-àga-rzii{28S) NIN.TU-agazid,?a9), 2. diurni figlio 3. adam-gal-nun di Damgalnunakfak),2ÌC/ 4. é-tus-a (ed) E tus'a, 5. diurni figlio 1. ama-ab-zu-da di Ama'abzuda, 2. a mu-ru hanno presentato (questo)
Il nome della divinità destinataria dell'offerta, non menzionato nell'iscri-zione, resta ignoto. Quale che fosse, l'attribuzione dell'area sacra in questione alla dea NIN.TU non ha alcun fondamento; di conseguenza, la designazione di "Small Shrine", più neutra e di carattere descrittivo, è preferibile a quella di "Tempio di Nintu" (cf. supra, § 1.1.1).
"Tempio di Sin": attribuito a Sin sulla base dell'iscrizione stilla statua, ivi rinvenuta, di un amministratore templare del dio Sin di Aksak, di nome Ur-KISAL1291'. Tuttavia tale iscrizione^292' non contiene una dedica a Sin, ma a un'altra divinità dal nome di problematica lettura:
1. Ur-KISAL Ur-KJSAlfi^, 2. SAGGA l'amministratore templare 3. aEN.ZU di Sin 4. aksak*1 di Aksak, 5. DUMU figlio 6. na-dì di Ñadí'294'1, 7. PARAIS il sacerdote purificatoré'295'1
8. aEN.ZU di Sin, 9. aSAG.X al dio ...
10. lia presentato.
( 2 8 7 ) JACOBSEN 1 9 4 2 , p . 2 9 1 N° 3 ; BOESE 1 9 7 1 , t a v X I I : C N 7 .
(288) Il segno ZI non compare né nella copia di Jacobsen né in quella di Boese (cf. la nota precedente), ma è parzialmente visibile nella foto pubblicata in FRANKFORT 1939a, tav. 114.
(289) "NIN.TU è la vera corona". Cf. i NNP dNIN. fTU-àga-zii, in VS 27 n° 13 vi 3, ed eres (NIN)-àga-zi, in WG. LAMBERT 1988, pp. 252 e 259 BM 86271 i 19.
(290) ddani-gal-nun è da interpretarsi qui o come nome di persona, ossia, Damgalnu-nakak, "Di / Appartenente a Damgalnunak"; o come abbreviazione di un nome di persona che cominciava con l'elemento teoforo Damgalnunak.
( 2 9 1 ) CF . DELOUGAZ-LLOYD 1 9 4 2 , p p . 6 - 8 .
( 2 9 2 ) JACOBSEN 1 9 4 2 , p . 2 9 1 n ° 4 .
( 2 9 3 ) C f . MARCHESI 2 0 0 4 , p p . 1 7 4 - 1 7 5 .
(294) Cf. G E B B 1957, p. \%sub ND'x. (295) Yztpäsisum (PA4-SIS), lett. "ungitore, addetto all'unzione", cf. ARCHI 1996.
268 APPENDICE
Il teonimo alla riga 9, ovvero il nome del dio a cui era presumibilmente con-sacrato in realtà il cosiddetto "Tempio di Sin", è stato variamente letto dKUS = Lalanf196! AN.SAG-.X1297) e dSAG.[GA], AIUSEIA « Y I segni AN e SAG (non KUS) sono assai ciliari sia nella copia di Jacobs en1299-' che in foto1300). Riguardo al terzo segno, la copia di Jacobsen è invece fuorviarne. Ili foto si vede abbastanza
V V A; V V
distintamente MUS. Il risultante teonimo S AG. MUS è probabilmente da leg-gersi isa¡2-?nM (Samus)13CI1) e da connettersi con Asa-mu-us., documentato nell'ono-mastica sargonica di Tutub1302).
A.3.4. Esnunak
"Tempio di Abu": prende nome da un'iscrizione votiva su tm recipiente di rame1303), dedicato per l'appunto al dio Ab'u1304)- Tuttavia tale recipiente non è stato rinvenuto nel tempio suddetto, ma nell'adiacente "Earlier Northern Pa-lace" (cf. pp. 25-26 n. 6). L'attribuzione al dio Ab'u di questo santuario è per-tanto tutfaltro che certa1305).
(296) JACOBSEN 1942, pp. 293-294. (297) BRÄUN IIOLZINGER 1977, p. 68; EAD. 1991, p. 243, STEIBLE 1982b, p. 211; GELB-
KIENAST 1 9 9 0 , p . 3 0 .
( 2 9 8 ) KREBERNIK 1 9 9 1 , p . 1 4 0 .
( 2 9 9 ) JACOBSEN 1 9 4 2 , p . 2 9 1 i f 4 .
( 3 0 0 ) FRANKFORT 1939a, tav 5 0 : 37E. (301) Per l'uso del segno SAG come sillabogranmia col valore di sa¡2 (= /sa/) in epoca
protodinastica, cf. FRANKFORT 1939b, tav XIV: d (ìiumsa^-if)-, e W G. LAMBERT 1989, pp. 24-25.
(302) Cf. SOMMERFELD 1999, p. 177 s.v. PÛ.SA^Sa-mu-us. GELB (1992, p. 134) interpre-tava Samus come variante di Samas, il dio-sole. Tuttavia il primo lo si ritrova solo nel nome Puzursamus, attestato tre volte, ed è sempre scritto sillabicamente (f'sa-mu-us); il dio-sole ricorre invece come elemento teoforo in diversi altri nomi di persona nei testi sargonici della regione del Diyala (non però da Tutub), ed è sempre scritto logograficamente (dUTU); cf. GELB 1 9 5 2 , p . 2 3 1 .
(303) JACOBSEN 1942, pp. 291 e 298 n° 12; STEIBLE 1982b, pp. 202-203 AnEsn. 2. (304) Per tale, più precisa lettura del NE> dab-ú (che nulla ha a che vedere con il termine
accadico abum, "padre"), cf. MARCHESI 2 0 0 2 , p. 1 6 8 . Si noti anche ur-ab-bu, in UET 3 n° 1309 sigillo 1, per uf(LÚ)-dab-ú, ibidem, tavoletta 7 (cortesia di P. Attinger), dove ab-bu rap-presenta verosimilmente una forma secondaria /abbu/ originante dalla assimilazione della laringale occlusiva /'/ di /ab'u/ alla consonante precedente (cf. pp. 2 0 6 - 2 0 7 n. 1 ) .
(305) Ab'u è una divinità piuttosto misteriosa ed elusiva. Et testi tardi (fine secondo millennio / primo millennio) è considerato lo sposo di Gula, la dea della medicina, ed è variamente identificato sia con Dumuzid, sia con Nin'urtâk (cf. TALLQVIST 1938, p. 257). Egli era figlio di Enkìk e Ninhursagak o, secondo un'altra tradizione, di Ellil e Ninhursagak (cf. ibidem-, ed ATTINGER 1984, pp. 26-31 e 45-46). Nel terzo millennio il suo culto è attestato a Ku'ara, nel sud di Sumer (cf. SALLABERGER 1993b, p. 136). L'epiteto di "signore delle piante"
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 269
A.3.5. TeliAgrab V
"Tempio di Saia": questo grande complesso templare prende nome da una presunta dedica al dio Sara su un frammento di vaso di pietra, trovato in un contesto secondario (cf. p. 35 n. 38, e p. 39 n. 49). Tuttavia l'iscrizione della statua Cat. 1 (cf. supra, § A.1.4)1306'1 suggerisce piuttosto che il tempio fosse con-sacrato a Huma'tim (presumibilmente fi dio poliade di Teli Agrab) o all'altret-tanto oscura divinità che si cela dietro la grafia dAMAR.NU.NAM.AMA (cf. § A.1.4 commento a Cat. 1:4). Inoltre, tm eventuale culto di Sara, tuia divinità lo-cale di Umma, nella semitica Teli Agrab sarebbe alquanto sorprendente. A mio avviso, dLAGA13 >IGl-gtmu nell'iscrizione sul suddetto frammento di vaso1307' non è da leggersi ''sàia, ma rappresenta invece tm logogramma per Ishara, come ad E bla1303'1 e Teli Beydar009/ Quest'ultima divinità pansemitica, attestata in Siria come fit Mesopotamia010/ potrebbe avere aiuto ima sua cappella all'interno del tempio di 'Huma'tim, di cui era forse concepita, ad Agrab, come la paredra.
A.3.6 Mari
"Tempio di Gistarat/Istarat": denominazione basata su una lettiua erronea del ND dba-sùr(KAM)-ra-afl311/ che figura in due iscrizioni votive ivi rinve-nute012/ In una di questeÍ31i), dba-sùr-ra-at è associata a did, il dio dell'ordalia fluviale, di cui era presumibilmente la paredra014/
"Tempio di Estar/Istar": più precisamente di dINANA(.)NITA, per cui cf. supra, § A.1.4 commento a Cat. 13 riga 7.
(lugal Ú), a lui attribuito nella composizione letteraria "Enki e Ninhursaga, è verosimilmente solo un gioco di parole sul suo nome (dab-ii; cf. MARCHESI 2002, p. 168), e non va quindi preso come elemento rivelatore della sua natura (contra JACOBSEN 1942, p. 298).
(306) Sul luogo di rinvenimento, cf. p. 127 con n. 2. ( 3 0 7 ) JACOBSEN 1942, pp. 291 e 297 n° 10; STEIBLE 1982b, p. 200 AnAgr. 3 ; G E L B - K J E -
NAST 1990, pp. 28-29 VP 3. Si nob che le tracce rimaste di segni alla riga 4 non supportano una restituzione della stessa come JTQQ-Riji/ (collazionato; tra l'altro in questa iscrizione ci si aspetterebbe piuttosto la formula dedicatoria sumerica, a m u ra, dato che il nome della divinità destinataria è posto all'inizio dell'iscrizione; cf. p. 208 n. 12).
(308) Cf. ad esempio ARET 2 n° 8 ii 1 (tav. XXXVII). (309) Cf . SAHABERGER 1996a , p. 52 sub 500 .
(310) Cf . ARCHI 1993a ; PRECHEL 1 9 9 6 ; e POMPONIO-XELLA 1 9 9 7 , pp . 2 0 2 - 2 1 7 .
(311) Letto "(G)is-dar-ra-at" da DOSSIN (1967, pp. 329-330), che lo interpretava come una forma arcaica di Astarte (ibidem, p. 330).
(312) Cf . KREBERNIK 1984b, p. 165.
( 3 1 3 ) DOSSIN 1 9 6 7 , p . 3 2 9 M . 2 2 4 1 ; GELB-KIENAST 1 9 9 0 , p p . 1 0 - 1 1 M P 1 0 .
(314) Cf. WG. LAMBERT 1985, pp. 535-536. dba-sur-ra-at è verosimilmente da norma-lizzarsi come Basurat, "(Buona) Annunciazione", dalla radice bsr, "annunciare (una buona notizia)" (cf. D . COHEN 1976, p. 89 AH).
270 APPENDICE
"Tempio di Ninni-zaza/INANA-ZA-ZA": da qui provengono numerose statue e oggetti votivi dedicati a iuta divinità il cui nome è scritto dINANA. ZA.ZA, dINANA X ZA+ ZA, o anche, una volta, dINANA X ZA<315). Donde il nome convenzionale Nhmi-zaza'3165 o INANA.ZA.ZA. Nello stesso luogo sono state trovate anche tre statue con dediche a dINANA(.)GIS.TIR'317), a dNIN-¿j-ra-M3185, e a tuia divinità maschile di cui non è menzionato il nome (Cat. 12a). Tra-lasciando quest'iti tima statua, portata lì da qualche altro luogo per una ragione sconosciuta (cf. supra, § A.1.4, note a Cat. 12a), è lecito supporre che dINANA. ZA.ZA, dINANA(.)GIS.TTR (= "Astar della foresta"?'3195) e dNIN-ah-ra-x ("Si-gnora di ...") rappresentino tre differenti nomi e/o forme della stessa divinità, che sarà pertanto femminile. L'accostamento con dINANA(.)GIS.TIR sugge-risce inoltre che dINANA.ZA.ZA sia una forma o ipostasi di In'anak/Astar; il che può trovare sostegno nel fatto che l'unica attestazione di dINANA.ZA.ZA al di fuori di Mari sia in un'iscrizione di Enhedu'anak'3205, la celebre poetessa e sacerdotessa, figlia del re di Akkad Sarrumkïii, che la tradizione tutoie fervente devota personale della dea In'anak/Astar'3215.
Non è chiaro però come vada interpretato e letto il logogtamma composto dINANA.ZA.ZA/dINANAXZA+ZA. W G. Lambert ha suggerito: 1) che dINANA.ZA.ZA/dINANAxZA+ZA sia una variante di dINANA.ZA; 2) che dINANA.ZA(.ZA)/dINANAXZA(+ZA) sia un logogramma per la dea Astar, cosi distinta dalla In'anak sumerica, il cui nome era scritto più semplicemente dINANA'322).
Tuttavia ambedue queste ipotesi sono facilmente confutabili. Le varianti testuali TNANAXZA+ZA e dINANAXZA citate da Lambert in due esem-plari della lista divina di Abu Salabikh non esistono; i due testi in questione presentano infatti dINANAXZÁ e dINANAXZA'323). Inoltre varianti come
(315) DOSSIN 1967, pp. 309-328. Nell'ultimo, isolato, caso (ibidem, p. 327), probabilmente da emendarsi in TN ANA X ZA<+ZA>.
(316) / ninni/ è tuia delle letture possibili del segno IN ANA/MUS (invero non ben do-cumentata; cf. GELB 1960).
(317) DOSSIN 1967, pp. 319-320 n° 12; GELB-KIENAST 1990, pp. 6-7 M P 4.
( 318 ) DOSSIN 1 9 6 7 , p . 3 2 0 i r 1 3 ; GELB-KIENAST 1 9 9 0 , p p . 2 1 - 2 2 M P 2 9 .
(319) Cf. GIS.TIR = qaßatum, "bosco, foresta" (MEE 4, p. 244 riga 400). Per una di-versa interpretazione, cf. STEINKELLER 1984a, p. 35.
(320) FRAYNE 1 9 9 3 , pp. 3 5 - 3 6 Sargon 16 .
( 321 ) C f . GOODNICK WESTENHOLZ 1 9 8 9 .
( 322 ) WG. LAMBERT 1985, p. 537; ID. 1990b. (323) BIGGS 1974, n° 82 vi 1 5 ' e n° 86 v 5 ) r ispett ivamente.
I DATI EPIGRAFICI E TESTUALI 271
d I N A N A w (ZÀR)-tó<329 / áastár sarJTÄRyba^3^/ áas-tár sa-àr-ba-afr1126' / Aas-tár sa-ar-ba-aß^ , F Ù . S A - d I N A N A / PÙ.SA-os tar (stessa persona)®®, tâ-dì{rirì)!din-AINSANA / tâ-aS/din-as-tár (stessa persona)'329/ ecc., dimostrano chia-ramente che il logogramma pei 'Astar era dINANA, e non dINANA.ZA.ZA/ dINANAXZA+ZA.
A.3./. Assur
"Tempio di Estar/Istar": così clriamato sulla base di varie iscrizioni dedicate a 'Astai/Estar, o a Estar Assurltu(m) ("Estar di Assur"), risalenti però a periodi posteriori'33"/ La più antica di queste data al periodo accadico'331/ Considerando che, di norma, il tempio di una determinata divinità era riedificato costante-mente nello stesso sito, è lecito supporre che anche il santuario piotodinastico fosse consacrato a tale dea. Tuttavia non si può escludere completamente l'ipo-tesi che Estar si sia sostituita a una divinità locale, a cui era stata assimilata'332*. Di Assur in epoca protodinastica non si sa molto, non essendo disponibile al-cuna informazione di carattere epigrafico e/o testuale'333/
( 3 2 4 ) CHARPIN 1 9 8 7 , p . 9 9 .
( 3 2 5 ) POMPONIO-XELLA 1 9 9 7 , p . 6 5 .
(326) Ibidem. ( 3 2 7 ) W G . LAMBERT 1 9 8 5 , p . 5 3 0 .
(328) HILGERT 2002, p. 59. (329) Ibidem, p. 304 con n. 60. (330) Cf. GEORGE 1993, pp. 123-124 sub 756, e p. 165 sub 1336. ( 3 3 1 ) C f . GRAYSON 1 9 8 7 , p . 7 .
( 3 3 2 ) C f . BBCKMAN 1 9 9 8 .
( 3 3 3 ) C f . GOODNICK WESTENHOLZ 2 0 0 4 , p . 11 .
ACRONIMI
A —Asiatic collection (sigla museale dell'Orientai Institute Museum, Chi-cago).
ADFU =Ausgrabungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Uruk-Warka.
ADOG =Abhandlungen der Deutschen Orient-Ge s ellschaft. AJO = Archiv für Orienforschung. AJ =Antiquaries Journal. AJA =American Journal of Archaeology. AJSL =American Journal of Semitic Languages and Literatures. AnOr =Analecta Orientalia. AO =Antìquités orientales (sigla museale del Musée du Louvre, Paris). AOAT =Alter Orient und Altes Testament. AoF =Altorientalische Forschungen. AOS = American Oriental Series.
APA =Acta Praehistorica et Archaeologica. ARES =Arcliivi reali di Ebla, studi. ARET =Archivi reali di Ebla, testi.
1: ARCHI 1984a. 2 : EDZARD 1 9 8 1 .
3 : ARCHI-BIGA 1 9 8 2 .
5 : EDZARD 1 9 8 4 .
1 1 : FRONZARDII 1 9 9 3 .
13: FRONZARDII 2003. ArOr =Archiv Orientální. AS =Assyriological Studies.
ASJ =Acta Sumerologica.
ATU = Archaische Texte aus Uruk. AuOr =Aula Orientalis. AUWE = Ausgrabungen in Uruk-Warka, Endbehchte. AVO = Altertumskunde des Vorderen Orients. BaF =Baglidader Forschungen. BAH = Bibliothèque archéologique et historique. BaAl =Baghdader Mitteilungen. BAR-S =British Archaeological Reports, international series. K4SOK =Bulletin of the American Schools of Oriental Research.
BBVO =Berliner Beiträge zum Vorderer Orient. BBVOT =Berliner Beiträge zum Vorderer Orient, Texte.
2 7 4
BI
BíMes BIN «
BiOr BJV BMO CAD
CAH tí tc
CDU
CM CMAO CNIP CRAIBL CT ( (
ft
ft
CTN CUNES
DP DV
EÇEM
ETCSL
FAOS
HANES HdO HSAO HSS HUCA LLN EVI UM ITT
74 NICOLÒ MARCHETTI
=Banca d'Italia (sigla delle tavolette cuneiformi nelle collezioni della Banca d'Italia). =Bibliotheca Mesopotamica. =Babylonian Inscriptions in the Collection of J.B. Nies. 8: HACKHAN 1 9 5 8 .
=Bibliotheca Orientalis. =Berliner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte. =Britisb Museum Quarterly. =Tbe Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chi-
=The Cambridge Ancient History. 1 / 1 : EDWARDS et al. 1 9 7 0 .
1 / 2 : EDWARDS et al. 1 9 7 1 .
=Cuneiform Digital Library Initiative, University of California at Los An-geles and Max Planck Institute for the History of Science, <http://cdli. ucla.edu/> / <http://cdh.nipiwg-beilin.mpg.de/tveb/index.htinl>. =Cuneiform Monographs. =Contributi e materiali di archeologia orientale. =Carsten Niebuhr Institute Publications. =Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, comptes rendus. =Cuneiform Texts from Babylonian Tablets in the British Museum. 2 5 : KING 1 9 0 9 .
3 2 : KING 1 9 1 2 .
5 0 : SOLLBERGER 1 9 7 2 .
=Cuneiform Texts from Nimrud.
=CorneIl University Near Eastern Studies (sigla delle tavolette cunei-formi nelle collezioni della Cornell University, Ithaca). =ÄLLCTTEE DE LA FÜYE 1908-1920. =Drevnosti Vostocnyja, Trudy Vostocnoj Komissii Enperatorskago Moskovskago Archeologiceskago Obscestva. =Eski Çark Eserleri Müzesi (sigla museale dello Eski Çark Eserleri Mtizesi, Istanbul). =Llectronic Text Corpus of Sumerian Literature, Oriental Institute, Uni-versity of Oxford, <http://www-etcsl.orient.ox.ac.uk/>. =Freibtirger altorientalisclie Studien. =Hi s tory of die Ancient Near East, Studies. =Handbuch der Orientahstik =Heidelberger Studien zum Alten Orient. =Harvard Semitic Series. =Hebreiv Union Collie Annual. =Illustrated London News.
=Iraq Museum (sigla museale dell'Iraq Museum, Baghdad). =Istanbuler Mitteilungen. =Inventaire des tablettes de Tello conservées au Musée Enpérial Ot-toman.
L A STATUARIA R E G A L E 2 7 5
I T T 3 : DE GENOLUIAC 1 9 1 2 .
JA =Journal asiatique. JAC =Journal of Ancient Civilisations. JAOS =Journal of the American Oriental Society. JCS =Journal of Cuneiform Studies. /EOT =Jaarbericht van bet Vooraifatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Eux. JNES =Journal of Near Eastern Studies. JRAS =Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. LAK =DEIMEL 1 9 2 2 .
MAD =Materials for the Assyrian Dictionary. M A M =Mission archéologique de Mari. ALARI =Mari, annales de recherches interdisciplinaires. MC =Mesopotaniian Civilizations. MDAI =Mémoires de la Délégation archéologique en Iran. Mission de Su-
siane. MDP =Mémoires de la Délégation en Perse. MEE =Materiali epigrafici di Ebla.
3 : PETTINATO 1 9 8 1 .
4 : PETTINATO 1 9 8 2 .
1 0 : MANDER 1 9 9 0 .
MHEM =Mesopotamian History and Environment, Memoirs. MMAI =Mémoires de la Mission archéologique en Lan. Mission de Susiane. MSAE =Materiali e studi archeologici di Ebla. MSL =Materialien zum sumerischen Lexikon / Materials for die Sumeri an
Lexicon. 1 1 : REINER 1 9 7 4 .
1 2 : CIVIL 1 9 6 9 .
1 5 : CIVIL 2 0 0 4 .
MSVO =Materialien zu den frühen Schriftzeugnissen des Vorderen Orients. MVAG =Mitteilungen der Vorderasiati s ch-Agyp tischen Gesellschaft. MVN =Materiali per il vocabulario neosumerico.
1 : PETTTNATO-WAETZOLDT 1 9 7 4 .
3 : OWEN 1 9 7 5 .
1 0 : GRÉGOIRE 1 9 8 1 .
MVS =Materiali per il vocabolario sumerico. NABU =Nouvelles assyriologiques brèves et utilitaires. N i k = N K D L ' S K I J 1 9 0 8 .
N i k 2 =NKDL'SKIJ 1 9 1 5 .
OA =Oriens Antiquus. OBO =Orbis Biblicus et Orientalis. OIC = Oriental Institute Communications. OIP = Oriental Institute Publications. OLA = Orientaba Lovaniensia Analecta. OLP =Orientalia Lovaniensia Periodica. OLZ =Orientalistische Literatursyitung.
276 NICOLÒ MARCHETTI
OPKF = Occasional Publications of the Samuel Noah Kramer Fund. Or =Orientalia, Nova Series. PB F =Prähi s torische Bronzetunde. PIHANS =Publications de l'Institut historique-archéologique néerlandais de
Stamboul. PSD =Tbe Sumerian Dictionary of the University Museum of the University of Penn-
sylvania. RA =Revue d'assyriologie et d'archeologie orientale. RGTC =Répertoire géographique des textes cunéiformes. RIMA =T*he Royal Inscriptions of Mesopotamia, Assyrian Periods. RIME =T*he Royal Inscriptions of Mesopotamia, Early Periods. RIA =Reallexikon der Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie. RO =Roc^nik Orientalistycryny. RAO =Rivista degli studi orientali. RT" =Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptiennes et as-
syriennes. RTC =THUREAU DANGIN 1 9 0 3 .
QDL =Quaderni del Dipartimento di Linguistica, Università degli Studi di Firenze. QuSem = Quaderni di Semitistica. SAAL =State Archives of Assyria, Literary Texts. SANE =Sources from the Ancient Near East. SAOC =Studies in Ancient Oriental Civilization. SEh =Studi eblaiti. SEL =Studi epigrafici e linguistici sul Vicino Oriente antico. L F =DEIMEL 1 9 2 3 .
StOr =Studia Orientalia. StPohl (SM) =Studia Pohl (Series Maior). StSem NS =Studi semitici, nuova serie. TAPS =Transactions of die American Pililo s ophical Society. TAVO =Tübinger Adas des Vorderen Orients. TBC =Texts from the Babylonian Collection. TCL =Musée du Louvre — Département des Antiquités Orientales: textes
cunéiformes. 5 : DE GENOUILLAC 1 9 2 2 .
TCS =Texts from Cuneiform Sources. TMH =Texte und Materialien der Frau Professor Hilprecht Collection. TSS =JESTIN 1 9 3 7 .
UAVA =Untersuchungen zur Assyriologie und Vorderasiatischen Archäo-logie.
UE =Ur Excavations. UET =Ur Excavations, Texts.
1 : GADD-LEGRAIN 1 9 2 8 .
3 : LEGRAIN 1 9 3 7 - 1 9 4 7 .
8 : SOLLBERGER 1 9 6 5 .
UMM =University Museum Monograph.
LA STATUARIA REGALE 277
VAT = Vorderasiatische Abteilung Ton tafeln (sigla museale delle tavolette cuneiformi del Vorderasiatisches Museum, Berlin).
VO = Vicino Oriente. VS = Vorderasiatische Schriftdenkmäler der Staatlichen Museen zu Berlin.
2 5 : MARZAHN 1 9 9 1 .
2 7 : MARZAHN 1 9 9 6 .
WA = We stern Asiatic Antiquities (sigla museale del British Museum, London).
WO =Die Weit des Orients. WVDOG = Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesell -
schaft. WZKM = Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. YBC =Yale Babylonian Collection. YNER =Yale Near Eastern Researches. YOS =Yale Oriental Series, Babylonian Texts.
4 : KEISER 1 9 1 9 .
Z.-4 =Zeitschrififür Assyriolqgie und verwandte Gebiete / Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie.
BIBLIOGRAFIA
A A . W 1935
A A . W 1938
A A . W ! 1964
A A . W ! 1967
A A . W ! 1973
A A . W ! 1982
A A . W ! 1983
A A . W ! 1985
A A . W ! 1987
A A . W ! 2001
A A . W ! 2003
Abu al Soof 1967
= A A . W , Miscellanea orientalia dedicata Antonio Deimel annos I5XX compienti (AnOr 12), Ponti-ficio Istituto Biblico, Roma 1935. = A A . W . , A t ó del XLK Congresso Internationale degli Orientalisti. Roma, 23-29 Settembre 1935, Ti-pografia del Senato, Roma 1938. = A A . W . , Studies Presented to A. Leo Oppen-heim, The Oriental Institute, Chicago 1964. = A A . W ! , Heidelberger Studien tum Alten Orient. Adam Falkensfein tum 17. September 1966, Har-rassowitz, Wiesbaden 1967. = A A . W , La voix de l'opposition en Mésopotamie. Colloque organisé par l'Institut des Hautes Etudes de Belgique, Institut des Hautes Études de Bel-gique, Bruxelles 1973.
= A A . W ! , Societies and Languages of the Ancient Near East. Studies in Honour of LAL Diahonoff, Aris & Phillips, Warminster 1982. = A A . W ! , The Hilly Flanks and Beyond. Essays on the Prehistory of Southwestern Asia Presented to Robert J. Braidwood, November 15, 1982 (SAOC 36), The Oriental Institute, Chicago 1983. = A A . W ! , Ea terra tra i due fiumi. Venti anni di archeologia italiana in Medio Oriente. Ea Mesopo-tamia dei tesori, Il Quadrante, Torino 1985. = A A . W ! , The Menil Collection. A Selection from the Palaeolithic to the Modern Era, Abrams, New York 1987.
= A A . W . , La Mésopotamie. Entre le Tigre et l'Euphrate (24 mars-15 juillet 2001), National Museum of History, Taipei 2001. = A A . W . , Semitic and Assyriokgical Studies Pre-sented to Polio Eron^aroli by Pupils and Colleagues, Harrassowitz, Wiesbaden 2003. = B. Abu al Soof , The Relevance of the Diyala Sequence to South Mesopotamian Sites, «Iraq» 29 (1967), pp. 133-142.
280
ABUSCH 2 0 0 2
Abusch-Be aul ie u-Hue hn e r g ar d-Machinist Steinkel 1 er 2001
Abusch-Huehnergard-Huehnergard 1990
Ada ne 1981
Alberti-Pomponio 1986
A lgaze 1983-1984
A l i o t t e de l a Fuye 1908-1920
Alst er 1974a
Al st er 1974b
Al st er 1997
Arradasi Guzzo-Liverani-Mattl i iae 2002
Airiet 1966
NICOLÒ MARCHETTI
= T. ABUSCH (ED.), Riches Hidden in Secret Places. Ancient A W Hastern Studies in Memory of Thorkild Jacobson; Eisenbrauns, Winona Lake 2002.
= T. Abiisch, P.A. Beaul ieu, J. Huehnergard , P. Machinist, P. S te inke l l e r (edd.), Historio-graphy in the Cuneiform World. Proceedings of the XLH Rencontre Assyriologique Internationale, 1, Harvard University, CDL, Bethesda 2001. = T. Abiisch, J. Huehnergard , P. Huehner-g a r d (edd.), Ungering over Words. Studies in An-cient Near Eastern Eiterature in Honor of William E Moran (HSS 37), Scholars, Atlanta 1990. = R. McC. AdairE, Heartland of Cities. Surveys of Ancient Settlement and Eand Use on the Cen-tral Floodplain of the Euphrates, University of Chicago, Chicago 1981.
= A. Alber t i , F. Poirpoiiio, Pre-Sargonic and Sargonic Texts from Ur Edited in UET 2, Supple-ment (StPohl SM 13), Biblical Institute, Rome 1986.
= G. A lgaze , Private Houses and Graves at In-gharra, a Reconsideration, «Mesopotamia» 18-19 (1983-1984), pp. 135-193. = M.F. A l i o t t e de l a Fuye, Documentsprésar-goniques, Leroux, Paris 1908-1920. = B. Als te r , The Instructions of Suruppak. A Sumerian Proverb Collection (Mesopotamia 2), Akademisk, Copenhagen 1974. = B. A l s t e r , ENJMETE.NA: His Own Lord, «JCS» 26 (1974), pp. 178-180. = B. AI st er, Proverbs of Ancient Sumer. The World's Earliest Proverb Collections, CDL, Bethesda 1997.
= M.G. Atnadasi Gtizzo, M. Liverani, P. Matt l i i ae (edd.), Da Pyrgi a Mogia. Studi sull'archeologia del Mediterraneo in memoria di Antonia Ciasca, (Vicino Oriente — Quaderno 3/1), Università di Roma «La Sapienza», Roma 2002.
= P. Anie t , Elam, Archée, Auvers-sur-Oise 1966.
LA STATUARIA REGALE 281
AMIET 1 9 6 7
Aniet 1976
Aniet 1980
Aniet 1985
Aniet 1986
Aniet 1987
Andrae 1922
Andrae 1938
Archi 1981
Archi 1984a
Archi 1984b
Archi 1987a
Archi 1987b
Archi 1988
Archi 1993a
Archi 1993b
Archi 1995
= P. AMIET, Département des antiquités orientales et section des arts musulmans, in Parr ot Adhennr (edd.), Vingt ans d'acquisitions, 1967, pp. 1-19. = P. Aniet , L'art d'Agadé au Musée du Louvre, Musées Nationaux, Paris 1976. = P. Aniet , La glyptique mésopotamienne archa-ïque, CNRS, Paris 19802.
= P Aniet , La glyptique de Mari: état de la que-stion, «MARI» 4 (1985), pp. 475-485. = P. Aniet , Le problème de l'iconographie divine en Mésopotamie dans la glyptique antérieure à l'époque d'Agadé, «CMAO» 1 (1986), pp. 1-65. = P. Aniet , A Statue of Eannatum, Prince of Lavish, in AA.W. , The Meni/ Collection, 1987, pp. 30-33.
= W Andrae, Die archaischen Ischtar-Tempel in Assur (WVDOG 39), Hinrichs, Leipzig 1922. = W Andrae, Das wiedererstandene Assur (9. Sendschrift der Deutschen Orient-Gesell-schaft), Hinrichs, Leipzig 1938. = A. Archi, Lé "LLHAH MMI EPMMSICN" EBLÍ «SEb» 4 (1981), pp. 177-204. = A. Archi, Testi amministrativi: assegnazioni di tessuti (Archivio L2769) (ARET 1), Missione Archeologica Italiana in Siria, Roma 1984. = A. Archi, The "Names and Professions List": More Fragments from Ebla, «RA» 78 (1984), pp. 171-174.
= A. Archi, The "Sign-list" from Ebla, «Eblai-tica» 1 (1987), pp. 91-113. = A. Archi, Les titres de en et lugal à Ebla et des cadeaux pour le roi de Kish, «MARI» 5 (1987), pp. 37-52.
= A. Archi (ed.), Eblaite Personal Names and Semitic Name-Giving (ARES 1), Missione Ar-cheologica Italiana in Siria, Roma 1988. = A. Ar citi, Divinités sémitiques et divinités de sub-strati le cas dlshara et distar à Ebla, «MARI» 7 (1993), pp. 71-78.
= A. Archi, Fifteen Years of Studies in Ebla: A Summary, «OL2» 88 (1993), pp. 461-471. = A. Archi, Gli Archivi Reali e l'organizppftone istituftonale e amministrativa protosiriana, in Mat-thiae et al. (eáA),Ebla, 1995, pp. 112-119.
282 NICOLÒ MARCHETTI
ARCHI 1996
Ard i i 2001
Archi 2002
Archi 2004
Archi-Biga 1982
Archi-Biga 2003
Arch iP iacent in iPonponio 1993
Arnaud 1982
Arnaud 1987
Arnaud 1994
Aruz-Wal 1 enfe l s 2003
At t inge r 1984
At t inger 1993
Bander 1995
= A. ARCHI, Eblaita: päsisu "colui che è addetto all'unzione; sacerdote purificatore; cameriere al ser-vigio di una persona", «VO» 10 (1996), pp. 37-71. = A. Archi, The King-lastsfromEbla, in Abiiscli et al. (edd.), Historiography in the Cuneiform World, 2001, pp. 1-13. = A. Archi, Prepositions at Ebla, «Eblaitica» 4 (2002), pp. 1-21. = A. Ard i i , Translation of Gods: Kumarpi, Enlil, Dagan/nisaba, Halki, «Or» 73 (2004), pp. 319-336. = A. Archi, M.G. Biga, Testi amministrativi di vario contenuto (Archivio H2769: TM.75.G.3000-4101) (ARET 3), Missione Archeologica Ita-liana in Siria, Roma 1982. = A. Archi, M.G. Biga, M Victory on Mari and the Fall of EUa, «JCS» 55 (2003), pp. 1-44. = A. Archi, P. Piacentini, F. Ponponio, I nomi di luogo dei testi di Ebla (ARET ITI ; 177-X e altri documenti editi ed inediti) (ARES 2), Missione Archeologica Italiana in Siria, Roma 1993.
= D. Arnaud, Ees textes cunéiformes suméro-acca-diens des campagnes 1979-1980 à Rur Shamra-Ou-garit, «Syria» 59 (1982), pp. 199-222. = D. Arnaud, Recherches au pays d'Astata: Emar, VI/4. Textes de la bibliothèque: transcriptions et tra-ductions, ERC, Paris 1987. = D. Arnaud, Texte aus Tarso (BBVOT 3), Reimer, Berlin 1994.
= J. Aruz, R. W a l l e n f e l s (edd.), Art of the First Cities. The Third Millennium B. C. from the Mediterranean to the Indus, The Metropolitan Museum of Art/Yale University, New York-New Haven-London 2003. = P. At t inger , Enki et (Ninhursaga, «ZA» 74 (1984), pp. 1-52. = P. At t inge r , Eléments de linguistique suméri-enne. Ta construction de du^/e/di "dire" (OBO, Sonderband), Editions Universitaires/Van-denlioeck & Ruprecht, Fribourg Suisse-Göt-tingen 1993. = D. Bander, Die Siegesstele des Xaramsin und ihre Stellung in Kunst- und Kulturgeschichte (Bei-
LA STATUARIA REGALE 283
Bär 2003
Bahr ani 1992
Banks 1903-1904
Banks 1904a
Banks 1904b
Banks 1904-1905
Banks 1905-1906a
Banks 1905-1906b
Banks 1912
Bar re l et 1974
Ba r ton 1909
B asma chi 1994
Bauer 1972
Bauer 1975
träge zur Kunstgeschichte 103), Schulz-Kirchner, Idstein 1995.
= J. Bär , Die älteren Ischtar-Tempel in Assur. Stratigraphie, Architektur und Funde eines altori-entalischen Heiligtums von der ^weiten Hälfie des 3. Jahrtausends bis p/r Mi tte des 2. Jahrtausends v.Chr. (WVDOG 105), SDV, Saarbrücken 2003. = Z. Bahr ani, Early-Third-Millennium Sculpture, in Harper et al. (EDD.), The Royal City of Susa, 1992, pp. 83-87. = E.J. Banks, Reportfrom Bismya. II, «AJSL» 20 (1903-1904), pp. 260-268 (ed. R.F. Harper). = E.J. Banks, Reports nos. 19-21, «The Biblical Wodd» 24 (1904), pp. 137-146. = E.J. Banks, The Evolution of the Babylonian Brick, «The Biblical World» 24 (1904), pp. 218-223. = E.J. Banks, The Oldest Statue in the World, «AJSL» 21 (1904-1905), pp. 57-59. = E.J. Banks, The Bismya Temple, «AJSL» 22 (1905-1906), pp. 29-34.
= E.J. Banks, Plain Stone Vases from Bismya, «AJSL» 22 (1905-1906), pp. 35-40. = E.J. Banks, Bismya, or the East City of Adab. A Story of Adventure, of Exploration, and of Excavations among the Ruins of the Oldest of the Buried Cities of Babylonia, Putnam's Sons, New York-London 1912.
= M.-T. Barrel et , Ea "figure du roi" dans l'iconographie et dans les textes depuis Ur-Nanse
jusqu'à la fin de la F" dynastie de Babylone, in Ga-r e l l i (ed.), Eepalais et la royauté, 1974, pp. 27-138. = G.A. Barton, Haverford Eibrary Collec-tion of Cuneform Tablets or Documents from the Temple Archives of Tel/oh, II, Wins ton/Headley Brodiers, Philadelphia-London 1909. = F. Basiraclii, Cylinder Seals in the Iraq Mu-seum: Uruk andJamdatMasr Periods (Edubba 3), NABU, London 1994.
= J. Bauer, Altsumerische Wirtschaftstexte aus Eagasch (StPohl 9), Biblical Institute, Rome 1972. = J Bauer, Xum ¡drI-Phonem des Sumerischen, «WG» 8 (1975), pp. 1-9.
2 8 4
BAUER 1 9 8 5
Bauer 1987
Bauer 1989-1990
Bauer 1998
Bauer 2004
Bauer-Engl und-Krebernik 1998
Beaulieu 1994
Becker 1993
Beckmm 1998
BehmBl ancke 1979
Behrens-Klein 1998-2001
Behrens-Loding-Roth 1989
Behrens-St e i t l e 1983
Beri e jung 1997
Beyer 2004
NICOLÒ MARCHETTI
= J . BAUER, Altorientalische Notizen (21-30), Höchberg [stampato in proprio] 1985. = T. Bauer, Ortsnamen in den frühen Texten aus Ur, «WO» 18 (1987), pp. 5-6. = T. Bauer, Altsumerische Wirtschaftsurkunden in Leningrad, «AfiO» 36-37 (1989-1990), pp. 76-91. = T. Bauer, Der vorsargonische Abschnitt der meso-potamischen Geschichte, in Bauer et al., «Mesopo-tamien» (1998), pp. 431-585. = J. Bauer, DU = KUFL-LF) "HNBEHNJ HABN
BREMEN?1', «ZA» 94 (2004), pp. 16-17. = J. Bauer, R.K. Englund, M. Krebernik, Mesopotamien. Späturuk-Zeit und Frühdynastische Zeit (OBO 160/1), Universitätsverlag/Van-denlioeck & Ruprecht, Freiburg Schweiz-Göt-tingen 1998.
= R-A. Beaulieu, Antiquarianism and the Con-cern for the Past in the Neo-Babylonian Period, «Bulletin of the Canadian Society for Meso-potamian Studies» 28 (1994), pp. 3732 . = A. Becker, Uruk: Kleinfunde, I. Stein (AUWE 6), von Zabern, Mainz am Rhein 1993. = G. Beckmm, In?® Œ NEBBÍ RHUGIEEBT,
«JCS» 50 (1998), pp. 1-10. = M.R. BehmBlancke , Das Tierbild in der alt-mesopotamischen Rundplastik, Eine Untersuchung •puw Stilwandel des frühsumerischen Rundbildes (BaF 1), von Zabern, Mainz am Rhein 1979. = H. Behrens, J. Klein, JAinegalla, «RIA» 9 (1998-2001), pp. 342-347. = H. Behrens, D. Loding, M.T. Roth (edd.),
DUMU-E -DUB-BA-A. STÜHE: IN HŒCR Œ 2
AKE W. Sjœmc (OPKF 11), The University Museum, Philadelphia 1989. = H. Behrens, H. St cibi e, Glossar pr den altsu-merischen Bau- und Weihinschriften (FAOS 6), Steiner, Wiesbaden 1983. = A. Beri ejung, Washing the Mouth: The Conse-cration of Divine Images in Mesopotamia, in van der T o o m (ed.), The Image and the Book, 1997, pp. 45-72. = D. Beyer, Quelques réflexions sur les contraintes spatiales et les problèmes d'échelle dans le décor des
LA STATUARIA REGALE
Biga 1992
Biga 1995
Biga 2003
Biggs 1973
Biggs 1974
Biggs 1976
Bit t el -Heinrich-Hr ouda-Nagel 1964
Boehmer 1964
Boehner 1965
Boehner 1967
Boehmer 1969
Boehmer 1980-1983
Boehmer 1987-1990
Boehmer 1990
Boehmer 1994
285
sceaux du Proche-Orient antique, «Ktèma» 29 (2004), pp. 39-49. = M.G. Biga, Les vêtements neufs de ¡Empereur, «NABU» 19 (1992). = M.G. Biga, I rapporti diplomatici nel Periodo Protosiriano, in Mat th iae et al. (edd.), Ebla, 1995, pp. 140-147. = M.G. Biga, The Reconstruction of a Relative Chronology for the Ebla Texts, «Or» 72 (2003), pp. 345-367. = R.D. Bigg s, On Regional Cuneiform Handwri-tings in Third Millennium Mesopotamia, «Ol» 42 (1973), pp. 39-46. = R.D. Biggs, Inscriptions from Tell Abri Saläblkh (OIP 99), Die Oriental Institute, Chicago-London 1974. = R.D. Biggs, Inscriptions from al-Hiba—Eagash. The First and Second Seasons (BiMes 3), Undena, Malibu 1976. = K. BnTEL, E. HEINRICH, B. HROUDA, W
NAGEL (ECO.), Vorderasiatische Archäologie. Studien und Aufsätze Anton Moortgat p/m fünf-undsechpgsten Geburtstag gewidmet von Kollegen, Freunde und Schülern, Gebr. Mann, Berlin 1964. = R.M. Boehner, Datierte Glyptik der Akkade-Zeit, in Bi t te l et al. (edd.), Vorderasiatische Ar-chäologe, 1964, pp. 42-56. = R.M. Boelimer, Die Entwicklung der Glyptik während der Akkad-Zeit (UAVA 4), de Gruyter, Berlin 1965. = R.M. Boelimer, Die Entwicklung der Hör-nerkrone von ihren Anfängen bis p/m Ende der Akkad-Zeit, «BJV» 7 (1967), pp. 273-291. = R.M. Boelimer, Zur Glyptik zwischen Mesilim-und Akkad-Zeit (Early Dynastie III), «ZA» 59 (1969), pp. 261-292. = R.M. Boelimer, Kopfbedeckung. B, «RIA» 6 (1980-1983), pp. 203-210. = R.M. Boelimer, Ei/galanda-Stufe, «RIA» 7 (1987-1990), pp. 111-114. = R.M. Bo e hirer. Zur Funktion des Steinstiß-tempels in Uruk nach Befunden der Kampagne 39, «BaM» 21 (1990), pp. 49-65. = R.M. Boelimer, Die Siegelabrollungen auf dem archaischen Tafeln der frühen Uruk-Kampagnen,
286
Bo e liner 1999
Boese 1971
Bo e se 1978
Boese 1996
Bonechi1997
Bonechi 2001a
Bonechi 2001b
Bordreui l 1985
Borger 1988
Börker Klähn 1972-1975
Börker Klähn 1979
Börker Klähn 1982a
Börker Klähn 1982b
B onnni 1988
Brann-Lycz kowska -Pojiro S te inke l l e r 1998
NICOLÒ MARCHETTI
in Engl rind, Archaic Administrative Texts from Uruk, 1994, pp. 25-28.
= R.M. Boehmer, Uruk: Früheste Siegelabrol-lungen (AUWE 24), von Zabern, Mainz am Rhein 1999. = T- Boese, Altmesopotamische Weihplatten. Eine sumerische Denkmalsgattung des 3. Jahrtausends v. Chr. (UAVA 6), de Gruyter, Berlin-New York 1971.
= J. Boese, Mesanepada und der Schatz von Mari, «ZA» 68 (1978), pp. 6-33.
= J. Boese, Zu einigen frühdynastischen Figuren aus Mari, in Magen-Rashad (edd.), Vom Halys
Zum Euphrat, 1996, pp. 25-49. = M. Bonechi, Lexique et idéologie royale à l'époque proto-syrienne, «MARI» 8 (1997), pp. 477-535.
= M. Bonechi, Notes on the Names and Profes-sions List, «NABU» 29 (2001). = M. Bonechi, On Semitic *rms, «QDL» 11 (2001), pp. 137-144.
= P. Bordreui l , Ashtart de Alari et les dieux dOugarit, «MARL) 4 (1985), pp. 545-547. = R. Borger , Assyrisch-babylonische Zeichenliste (AOAT 33/33A), Butzon & Bercker/Neukir-chener, Kevelaer-Neukirchen-Vluyn 19884. = J. Börker Kl aim, Haartrachten, «RIA» 4 (1972-1975), pp. 1-12.
= J. Börker Klähn, Die Stellung Mesilims und der mit ihm verbundene Stilbegriff, «BaM» 11 (1979), pp. 33A3. = J. Börker YA'ihn., Altvorderasiatische Bildstelen und vergleichbare Felsreliefs (BaE 4), von Zabern, Mainz am Rhein 1982.
= T- Börker Klähn , Die reichsakkadische Kunst und Ägypten, «WZKM» 74 (1982), pp. 57-94. = A. Bouniii, Découvertes archéologiques récentes en Syrie, «CRAIBL) (1988), pp. 361-378.
= J. Braun, K Lycz kowska, M. Popko, P. S te inke l l e r (edd.), Written on Clay and Stone. Ancient Near Eastern Studies Presented to Krystyna Szprzyñska on the Occasion of Her 80th Birthday, AGADE, Warsaw 1998.
L A S T A T U A R I A R E G A L E
BRAUN HOLZINGER 1 9 7 7
Braun Holz inger 1984
Bi aun Hol zing er 1991
BreniquetTCepinski 2001
Bucce l l a t i -B iggs 1969
Buchanan 1966
Buchanan 1981
BURROWS 1 9 3 5
Cagni 1984
Cagni 1987
Canby 2001
Caubet 1990
Caubet-Bernus Tay lor 1991
287
= E.A. BRAUN HOLZINGER, Frühdynastische Be-terstatuetten (ADOG 19), Gebr. Mann, Berlin 1977. = E.A. Braun Holz inger , Figürliche Bronzen aus Mesopotamien (PBF 1/4), Beck, München 1984. = E.A. Braun Holz inger , Mesopotamische Weihgaben der frühdynastischen bis altbabylonischen Z.eit (HSAO 3), Heidelberger Orientvedag, Heidelberg 1991. = C. Breniquet , C. Kepnski (edd.), Ftudes mésopotamiennes. Beam! de textes o f f e r t à Jean-Fouis Huot, ERC, Paris 2001. = G . BUCCELLATI, R . D . BIGGS, Cuneiform Texts
from Nippur: The Eighth and Ninth Seasons (AS 17), The Oriental Institute, Chicago 1969. = B. BUCHANAN, Catalogue of Ancient Near-Eastern Seals in the Ashmolean Museum, L Cylin-der Seals, Oxford University/Clarendon, Ox-ford-London 1966. = B. Buchanan, EjVSYNbckF/KISN SEIS IN TEE Ysn?. R 4RW7M -re Cmg-WTy Yale University, New Haven 1981. = E. BURROWS, Archaic Texts (UET 2), The Trustees of the Two Museums, London-Phi-ladelphia 1935. = L. Cagni (ed.), Il bilinguismo a Ebla. Atti del convino internazionale (Napoli; 19-22 aprile 1982), Istituto Universitario Onentale, Napoli 1984. = L. Cagni (ed.), EBM 1975-1985. Dmj ,f-W U nun. HMJima E fiama. Atti del convegno in-ternazionale (Napoli, 9-11 ottobre 1985), Istituto Universitario Onentale, Napoli 1987. = J.V. Can by, The 'Vr-Nammu" Stela (UMM 110), University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, Philadelphia 2001. = A. Caubet, Aux sources du monde arabe: ¡Arabie avant l'Islam. Collections du Musée du Louvre, Insdtut du Monde Arabe — RMN, Paris 1990. = A. Caubet, M. Bernus Tay lor , Le Louvre: les antiquités orientales et islamiques, Scala/RMN, Paris 1991.
288
CAVIGNEAUX 1 998A
Cavigl ie aux 1998b
Cavigneaux-Krebernik '1998-2001 a
Cav igneauxKrebe rn ik 1998-2001b
Cavigneaux-al Rawi 1993
Cha i pin 1980
Cha i pin 1984
Cha i pin 1986
Cha i pin 1987
Cha i pin 1990
Cha i pin 2005
Cha i va t 1974
Chi lde 1956
Civil 1964
Civil 1969a
Civil 1969b
Civil 1984
NICOLÒ MARCHETTI
= A. CAVIGNEAUX, Un détail de la Figure aux
Plumes, «NABU» 73 (1998).
= A. Cavigneaux, ÉANJNA ETIECTW1ZF SUMÉ KHg «NABU» 75 (1998).
= A. Cavigneaux, M. Kiebern ik , JNin-SAR,
«RIA» 9 (1998-2001), pp. 484-486.
= A. Cavigneaux, M. Kiebern ik , Nun-ura,
«RIA» 9 (1998-2001), pp. 620-621.
= A. Cavigneaux, F.N.H. a l Ravi , Gi¡games et
taureau de ciel (sul-mè-kam) (Textes de Tell Haddad
IV), «RA» 87 (1993), pp. 97-129.
= D. Charpin, AkHIB ESî1IIL-1B ET PEtPHÉE
PKTCffiHVR-BYKEIE--EnB<EE ÉHTEEH IXÏLMH-AT LE 'THLSim." (Hautes études orientales 12), Droz,
Genève 1980.
= D. Charpin, Inscriptions votives d'époque assyri-
enne, «MARI» 3 (1984), pp. 41-81.
= D. Charpin, Le clergé dVr au siècle
dHammurapi (XDC-XVUT siècles av. J.-C.)
(Hautes études orientales 22), Droz, Genève
1986.
= D. Charpin, Tablettes présargoniques de Alari,
«MARI» 5 (1987), pp. 65-127.
= D. Charpin, Nouvelles tablettes présargoniques
de Mari, «MARI» 6 (1990), pp. 245-252.
= D. Charpin, Alari et Ebla: des synchronismes
confirmés, «NABU» 1 (2005).
= P. Chat va t , P m S j s a n c M û « , «ArOr» 42
(1974), pp. 161-166.
= Y G. Chi lde , Piecing Together the Past. The In-
terpretation of Archaeological Data, Roudedge &
Kegan Paul, London 1956.
= M. Civi l , A Hymn to the Beer Goddess and a
Drinking Song, in A A . W , Studies Presented to A.
Leo Oppenheim, 1964, pp. 67-89.
= M. Civi l , The Series hi = sa and Related Texts
(MSL 12), Pontrficium Institutum Biblicum,
Roma 1969.
= M. Civi l , The Sumerian Flood Story, in WG.
Lanbe r t -M i l l a rd , Atra-hasls, 1969, pp. 138-
145, 167-172.
= M. Civi l , Bilingualism in Logographically
Written Languages: Sumerian in Ebla, in Cagni
(ed.), Il bilinguismo a Ebla, 1984, pp. 75-97.
LA STATUARIA REGALE
Civil 1987
Civil 2004
Cohen 1976
CohenSnel 1 Weisberg 1993
Col Ion 1987
C o n n a n D e schesne 1996
Cont i 1990
Cooper 1983
Cooper 1986
Cooper 1990
Cooper 1993
Cooper 1999
Cooper 2000
289
= M. Civi l , The Early History of HAR-ra: The
Ebla Unk, in Cagni (ed.), Ebla 1975-1985,
1987, pp. 131-158.
= M. Civi l , The Series DIRI = (w)atru (MSL
15), Pontificium Eistitutum Publicum, Roma
2004.
= D. Cohen, DiaiaSK-IEE I S &4ŒSE SÓHligLH
CU AUH'Mi E+J IB LINStt SBIIHgHH, fase. 2,
Mouton, Paris-La Haye 1976.
= M.E. Cohen, D.C. S n e l l , D.B. Weisberg
(edd.), The Tablet and the Scroll Near Eastern
Studies in Honor of William W. Hallo, CDL, Be-
thesda 1993.
= D. Col 1 on, First Impressions. Cylinder Seals in
the Ancient Near East, British Museum, London
1987.
= T. Comían , O. Deschesne, Ee bitume à Suse.
Collection du Musée du Eouvre, RMN/Elf Aqui-
taine Production, Paris-Pau 1996.
= G. Conti , MlSCHLStEA MLFSC-Í, 3. Il sillabario
della quarta fonte della lista lessicale bilingue eblaita
(QuSem 17), Dipartimento di l inguist ica
dell'Università di Firenze, Firenze 1990.
= J.S. Cooper, Reconstructing History from An-
cient Inscriptions: The Eagash-Umma Border Con-
flict (SANE 2/1), Undena, Malibu 1983.
= J.S. Cooper, Sumerian and Akkadian Royal
Inscriptions; I. Presargonic Inscriptions, American
Oriental Society, New Haven 1986.
= J.S. Cooper, Mesqpotamian Historical Conscious-
ness and the Production of Monumental Art in the
Third Millennium B.C., in Gunter (ed.), Investiga-
ting Artistic Environments, 1990, pp. 39-51.
= J.S. Cooper, Sacred Marriage and Popular Cult
in Early Mesopotamia, in Matsushina (ed.), Of-
ficial Cult and Popular Religion, 1993, pp. 81-96.
= J.S. Cooper, Sumer. IV. 1: Inscriptions et textes
historiques, «Supplément au Dictionnaire de la
Bible» 72 (1999), coll. 226-248.
= J.S. Cooper, Sumerian and Semitic Writing
in Most Ancient Syro-Mesopotamia, in van Ler -
berghe-Voet (edd.), Languages and Cultures in
Contact, 2000, PP. 61-77.
290 NICOLÒ MARCHETTI
CRAWFORD 1 9 5 9
Crawford 1977
Crawford 1987
Cros-Heuzey-Thureau Dangin 1910-
Cunning h i m 1997
Curchin 1977
Curt is 1993
Da rre r ow-Eng 1 und 1989
Davidovic 1988
Deinel 1922
Deinel 1923
Deinel 1924
Del aporte 1920
De lougaz 1938a
= VE. CRAWFORD, Nippur, the Holy City, «Ar-chaeology» 12 (1959), pp. 74-83. = VE. Crawford, Inscriptions from Eajpsh, Season Four, 1975-1976, «JCS» 29 (1977), pp. 189-222.
= H. Crawford, The Construction Inférieure at Tello. A Reassessment, «Iraq» 49 (1987), pp. 71-76. = G. Cros, L. Heuzey, F. Thureau Dangin, Nouvelles fouilles de Tello, Leroux, Paris DIO-DM, = G. Cunning ha ip 'Deliver me from Evil". Me-sopotamian Incantations 2500-1500 BC (StPohl SM 17), Pontifìcio Istituto Biblico, Roma 1997.
= E. Curchin, Eannatum and the Kings of Adab, «RA» 71 (1977), pp. 93-95. = J.E. Curt is (ed.), Early Mesopotamia and Iran: Contact and Conflict 3500-1600 BC. Proceedings of a Seminar in Memory of Vladimir G. Eukonin, British Museum, London 1993. = P. Damerow, R. Englund, Bemerkungen pi den vorangehenden Aufsätzen von AA. Vajman unter Berücksichtigung der 1987 erschienenen Zei-chenliste ATU 2, «BaM» 20 (1989), pp. 133-138.
= V Davidovic, Gurus in the Administrative Texts from Ebla, in H. Haupt maim-Waetzol dt (edd.), Wirtschaß und Gesellschaft von Ebla, 1988, pp. 199-204.
= A. Deimel, Die Inschriften von Fara, L Liste der archaischen Keilschriffteichen (WVDOG 40), Hinrichs, Leipzig 1922. = A. Deimel, DTEE^OWHE-:IdvFAg II. Schul-texte aus Fara (WVDOG 43), Hinrichs, Leipzig 1923. = A. Deimel, DmlMOHHHS! ICTlEíLg III. Wirt-schftstexte aus Fara (WVDOG 45), Hinrichs, Leipzig 1924.
= L. Delaporte , Musée du Louvre: catalogue des cylindres, cachets et pierres gravées de style orientale, I. Fouilles et missions, Hachette, Paris 1920. = P. Delougaz , A Short Investigation of the Temple at al-SJbaid, «Iraq» 5 (1938), pp. 1-11.
LA STATUARIA REGALE 291
DELOUGAZ 1 9 3 8 B
D e l o u g a z 1940
D e l o u g a z 1952
D e l o u g a z 1960
Del ouga z-Hil 1 -LI oyd 1967
D el o ug a z -LI oyd 1942
De Meyer 1980
Derek sen 2004
Diet r i c h L o r et z 1998
van Dijk-Gel 1 er 2003
Dit t nani i -Eder-Jacobs 2003
D o l c e 1978a
D o l c e 1978b
D o l c e 1980
= E DELOUGAZ, A Great Discovery of Sumerian
Sculptures; «LLN» 10th Dec. (n° 5199) (1938),
pp. 1091-1094.
= P. De lougaz , The Temple Oval at Khcfajah
(OIP 53), The Oriental Institute, Chicago
1940.
= P. De lougaz , Pottery from the Diyala Region
(OIP 63), The Oriental Institute, Chicago
1952.
= P. D e l o u g a z , Architectural Representations on
Steatite Vases, «Iraq» 22 (I960), pp. 90-95.
= P. De lougaz , H. H i l l , S. LI oyd. Private
Houses and Graves in the Diyala Region (OIP 88),
The Oriental Eistitute, Chicago 1967.
= P Del ougaz , S. LI oyd, Pre-Sargonld Temples
in the Diyala Region (OIP 58), D i e Oriental Ei-
stitute, Chicago 1942.
= L. De Meyer (ed.),Te// ed-Dêr, III. Sounding
at Abu Habbah (Sippar), Peeters, Leuven 1980.
= J.G. Dercksen (ed.), Assyria and Beyond. Stu-
dies Presented to Mogens Trolle Tarsen, Nededands
Instituut voor liet Nabije Oosten, Leiden
2004.
= M. Dietr ich , O. L o r e t z (edd.), dubsar anta-
men. Studien p/r Altorientalistik. Festschrift für
Willem H.Ph. Römer p/r Vollendung seines 70. Le-
benjahres mit Beiträgen von Freunden, Schülern und
Kollegen (AOAT 253), Ugarit, Münster 1998.
= J J .A. van Dijk, M.J. G e l l e r , Ur III Incan-
tations from the Frau Professor Hilprecht Collec-
tion, Jena (TMH 6), Harrassowitz, Wiesbaden
2003.
= R. Di t t i r ann , C. Eder , B. Jacobs (edd.),
Altertumswissenschaften im Dialog. Festschrift für
Wolfram Nagel p/r Vollendung seines 80. Lebens-
jahres (AOAT 306), Ugarit, Münster 2003.
= R. Do l ce , Gli intarsi mesopotamici dell'epoca
protodinastica, I (Serie archeologica 23/1), Isti-
tuto di Studi del Vicino Oriente, Roma 1978.
= R. Do l ce , Gli intarsi mesopotamici dell'epoca
protodinastica, II (Serie archeologica 23/2), Isti-
tuto di Studi del Vicino Oriente, Roma 1978.
= R. Do l ce , Gli intarsi figurativi protosiriani del
Pa/app Reale G, «SEb» 2 (1980), pp. 105-128.
292
DOLCE 1 9 8 6
Dolce 1995
Dolce 1997
Dolce 2002
Dossin 1967
Diu and 1985a
Diu and 1985b
Diu and 1987
Diu and 1995
DURAND 1 9 9 7
Eck 1996
Edwards-Gadd-Hammond 1970
Edwards-Gadd-Hammond 1971
Edzard 1959a
Edzard 1959b
NICOLÒ MARCHETTI
= R . DOLCE, Per una riconsiderazione delle opere figurative da Gebelet el-Beyda, «CMAO» 1 (1986), pp. 307-333.
= R. Dolce, La cultura artistica di Ebbiprotosi-nana, in Matth iae et al. (edd.), Ebla, 1995, pp. 126-133. = R. Dolce, Aux origines de la royauté à Lello, «Akkadica» 103 (1997), pp. 1-5. = R. Dolce, "Royal" Hairdresses and Turbans at the Court of Ebla: Two Marks of Royalty Com-pared, in Amada si Guzzo et al. (edd.), Da Pyrgi a Mofa, 2002, pp. 201-211. = G. Dossin, Les inscriptions des temples de n in n i~zp zp et de (G)iStarat, in Par ro t , Le temple dlshtarat, 1967, pp. 307-331. = J.-M. Durand, La situation historique des sakkanakku: nouvelle approche, «MARI» 4 (1985), pp. 147-172.
= T.-M. Durand, Les dames du palais de Mari à l'époque du royaume de Haute Mésopotamie, «MARI» 4 (1985), pp. 385M36. = J.-M. Durand, L'organisation de l'espace dans le palais de Alari: le témoignage des textes, in Levy (ed.), Le système palatial, 1987, pp. 39-110. = J.-M. Diu and, Lé EHKIOVEt J*m4 JHLNM EO-OMBSNXICN EE AL®, in Mander-Dur and, Mr-tologia j Religión del Oriente Antiguo, 1995, pp. 125-533.
= J . - M . DURAND, A 4 HON4H(N PJB. M CTJBÎLK,
«MARI» 8 (1997), pp. 273-282. = D.L. Eck, Darsan. Seeing the Divine Image in India, Columbia University, New York 1996'. = I.E.S. Edwards, C.J. Gadd, N.G.L. Ham moud (edd.), The Cambridge Ancient History, 1/1. Prolegomena and Prehistory, Cambridge Uni-versity, Cambridge 19707 = I.E.S. Edwards, C.J. Gadd, N.G.L. Ham mond (edd.), The Cambridge Ancient History, 1/2. Early History of the Middle East, Cam-bridge University, Cambridge 19717 = D.O. Edzard, Kënigsinschriften des Iraq Mu-seums II, «Sumer» 15 (1959), pp. 19-28. = D.O. Edzard, Enmebaragesi von Kis, «ZA» 53 (1959), pp. 9-26.
L A S T A T U A R I A R E G A L E
EDZARD 1 9 7 4 A
Edzard 1974b
Edzard 1981
Edzard 1984
Edzard 1985
Edzard 1991
Edzard 1997
Edzard 2003
Edzard-Farber 1974
Edzard-Farber-Sol lberger 1977
Ehrenberg 2002
Ehr ich 1965
Ehr ich 1992
E l l i s 1968
293
= D.O. EDZAKD, Deux lettres rojales dUr III en sumérien "syllabique " et pourvu d'une traduction accadienne, in La bat, Textes littéraires de S use, pp. 9-34. = D.O. Edzard, Problèmes de ha royauté dans la
période présargonique, in Ga re l l i (ed.), Te palais et la royauté, 1974, pp. 141-149. = D.O. Edzard, Venvaltungstexte verschiedenen Inhalts (aus dem Archiv E2769) (ARET 2), Missione Archeologica Italiana in Siria, Roma 1981. = D.O. Edzard, Hymnen, Beschwörungen und verwandtes (aus dem Archiv E2769) (ARET 5), Missione Archeologica Italiana in Siria, Roma 1984. = D.O. Edzard, L E sa-ni<Nr 'T-aP' ET GGE S B a v m & B , «MARI» 4 (1985), pp. 59-62. = D.O. Edzard, Irikagina (Urukagina), «AuOr» 9 (1991), pp. 77-79. = D.O. Edzard, Gudea and His Dynasty (RIME 3/1), University of Toronto, Toronto-Buffalo-London 1997. = D.O. Edzard, Sumerian Grammar (HdO 1/71), Brill, Leiden-Boston 2003. = D.O. Edzard, G. Färber, Die Orts- und Genässernamen der Zeit der 3. Dynastie von Ur (TAVO, Beiheft - Reihe B/7; RGTC 2), Rei-chert, Wiesbaden 1974.
= D.O. Edzard, G. Farber, E. So l lberger , Die Orts- und Gewässernamen der prcisargonischen und sargpnischen Zeit (TAVO, Beiheft — Reihe B/7; RGTC 1), Reichert, Wiesbaden 1977. = E. Ehrenberg (ed.), Eeaving No Stones Un-turned. Essays on the Ancient Near East and Egypt in Honor of Donald P. Hansen, Eisenbrauns, W'inona Lake 2002. = R.W Ehrich (ed.), Chronologies in Old World Archaeology, University of Chicago, Chicago-London 19652. = R.W Ehrich (ed.), Chronologies in Old World Archaeology, University of Chicago, Chicago-London 19924 = R.S. El l is , Foundation Deposits in Ancient Mesopotamia (YNER 2), Yale University, New Haven-London 1968.
294
E m s 1979
Eimrton 1988
Englund 1994
Englund 1995
Engl und 1996
Engl und 1998
Engl und-Nissen 1993
Erkens 2002
Fa lkenste in 1936
Fa lkenste in 1949
Fa lkenste in 1963
Fa lkenste in 1966
FLNKBEINER-DLTTMANN- HAUPTMANN 1 9 9 5
NICOLÒ MARCHETTI
= M. DE}. ELUS, Cuneiform Tablets at Bryn Mawr College, «JCS» 31 (1979), pp. 30-55. = J.A. Enei ton (ed.), Congress Volume. Jeru-salem 1986 (Vetos Testamentum, Supplement 40), Brill, Leiden 1988.
= R.K. Englund, Archaic Administrative Texts from Uruk. The Early Campaigns (ADFU 15; ATU 5), Gebr. Marni, Berlin 1994. = R.K. Englund, Late Uruk Pigs and Other Herded Animals, in Finkbeiner et al. (EDD.), Bei-träge syir Kulturgeschichte Vorderasiens, 1995, pp. 121-133.
= R.K Englund, Proto-Cuneiform Texts from Diverse Collections (MSVO 4), Gebr. Mann, Berlin 1996.
= R.K. Englund, Texts from the Late Uruk Period, in Bauer et al., Mesopotamien, 1998, pp. 15-233.
= R.K Englund, H.J. Nissen, Die lexikalischen Eisten der archaischen Texte aus Uruk (ADFU 13; ATU 3), Gebr. Marni, Berlin 1993. = F.-R. Erkens (ed.), Die Sakralität von Herr-schaß. Herrschaßslegitimierung im Wechsel der Zeiten und Räume. Fünfzehn interdisziplinäre Bei-träge zp einem weltweiten und epochenübergreifenden Phänomen, Akademie, Berlin 2002. = A. Fai kenst ein, Archaische Texte aus Uruk (ADFU 2), Deutsche Forshungsgemeinschaft, Berlin 1936.
= A. Fai kenst ein, Grammatik der Sprache Gu-deas von Lagas, I. Schrifi- und Formenlehre (AnOr 28), Pontificitini Institutum Biblicum, Roma 1949.
= A. Fai kenst ein, Zu den Inschrßfunden der Grabung in Uruk-Warka 1960-1961, «BaM» 2 (1963), pp. 1-82.
= A. Falkenste in, Die Inschrißen Gudeas von Lagos, I. Einleitung (ANOR30), PONTFICIUM IN-
sTimmi BmncuM, R O M A 1966. = U . FINKBEINER, R . DITTMANN, H . HAUPT-
MANN (EDD.), Beiträge syir Kulturgeschichte Vor-derasiens. Festschriß für Rainer Michael Boehmer, von Zabern, Mainz am Rhein 1995.
LA STATUARIA REGALE 295
FINKEEINER-RÖLUG 1 9 8 6
Finkel 1997
Finkel -Gel 1 er 1997
Fleming 1994
Forest 1996
Forest 1999
FrahmPayne 2003-2004
Frangipane 2000
Fr angipane-Haupt mum -Liver ani Mat t h i a e M e l l i nk 1993
Frankfor t 1934
FRANKFORT 1 9 3 5 A
Frankfor t 1935b
Frankfor t 1936
= U. FLNKBEINER, W ROELIG (EDD.), Gamdat Nasr. Period or Regional Style? [TAVO, Beiheft -Reilie B/62), Harrassowitz, Wiesbaden 1986. = L L Finkel , PEAŒOL Paraci PnsxBAPHir, «NABU» 1 (1997).
= I.L. Finkel , M.J. Ge l l e r (edd.), Sumerian Gods and Their Representations (CM 7), Styx, Groningen 1997. = D.E. F len ing , The Mountain ~Dagan: "'KUR and®YJJR.GAT, «NABU» 16 (1994). = J-D. Forest, Tes pseudo-temples de la Diyala, ou k contrôle de la population urbaine au Dynastique Archaïque, in Gasi;lie E h onda (edd.), Collectanea orientada, 1996, pp. 97-111. = J.-D. Forest , Tes premiers temples de Méso-
potamie (4e et 3e millénaires) (BAR-S 765), Ar-cbaeopress, Oxford 1999. = E. Fra lin; E.E. Payne, Suruppak under Rjmus: A Rediscovered Inscription, «AfiO» 50 (2003-2004), pp. 50-55.
= M. Frangipane, Origini ed evoluzione del si-stema centralizzato ad Arslantepe: dal 'tempio" al "palazzo" nel IV millennio a.C., «fsimu» 3 (2000), pp. 53-78.
= M . FRANGIPANE, H . HAUPTMANN, M . L i -
VERANI, P. MATTHIAE, M . J . MELLJNK (EDD.),
Between the Rivers and over the Mountains. Archaeo-logica anatolica et mesopotamica Alba Palmieri dedi-cata, Università di Roma «La Sapienza», Roma 1993.
= H. Frankfor t , Iraq Txcavations of the Oriental Institute, 1932/33 (OIC 17), The Oriental Institute, Chicago 1934. = H. FRANKFORT, Early Dynastic Sculptured Maceheads, in A A . W , Miscellanea Orientada, 1935, pp. 105-121.
= H. Frankfor t , Oriental Institute Discoveries in Iraq, 1933/34 (OIC 19), Die Oriental Insti-tute, Chicago 1935. = H. Frankfor t , Progress of the Work of the Oriental Institute in Iraq, 1934/35. Fifth Prelimi-nary Report of the Iraq Expedition (OIC 20), Die Oriental Institute, Chicago 1936.
296 NICOLÒ MARCHETTI
FRANKFORT 1 9 3 7 A
Frankfor t 1937b
Frankfor t 1938
Frankfor t 1939a
Frankfor t 1939b
Frankfor t 1943
Frankfor t 1948
Frankfor t 1954
Frankfor t 1955
Frankfor t 1971
Frayne 1992
Frayne 1993
Frayne 1997
Frayne in stampa
Fronzaro l i 1992
= H . FRANKFORT, Revelations of Early Mesopota-mian Culture, «ELN» ó F Nov. (ii° 5142) (1937), pp. 792-795.
= H. Frankfor t , Recensione di W o o l l e y 1934, «JRAS» (1937), pp. 330-343. = H. F rank fo r t , New Discoveries Concerning ibt Early Dynastic Period at Tell Asmar and Khafaje, in A A . W , Atti del XTK Congresso, 1938, pp. 47-50.
= H. Frankfor t , Sculpture of the Third Millen-nium B. C. from Tell Asmar and Khafdjah (OIP 44), The Oriental Institute, Chicago 1939. = H. FRANKFORT, Cylinder Seals. A Documentary Essay on the Art and Religion of the Ancient Near East, Gregg, London 1939. = H. Frankfor t , More Sculpturefrom the Diyala Region (OIP 60), The Oriental Institute, Chi-cago 1943.
= H. Frankfor t , Kingship and the Gods. A Study of Near Eastern Religion as the Integration of Sodety and Nature, University of Chicago, Chicago 1948.
= H. Frankfor t , The Art and Architecture of the Ancient Orient (The Pelican History of Art), Penguin, Harmondsworth 1954. = H. FRANKFORT, Stratified Cylinder Seals from the Diyala Region (OIP 72), The Oriental Insti-tute, Chicago 1955.
= H. Frankfor t , The Last Predynastic Period in Babylonia, «CAH» 1/2, pp. 71-92. = D.R. Frayne, The Early Dynastic List of Geo-graphical Names (AOS 74), American Oriental Society, New Haven 1992. = D.R. Frayne, Sargonic and Gutian Periods (2334-2113 BC) (RIME 2), University of To-ronto, Toronto-Buffalo-London 1993. = D.R Frayne, Us. Ill PMCD (2112-2004 BC) (RIME 3/2), University of Toronto, Toronto-Buffalo-London 1997.
= D.R. Frayne, Presargonic Period (2700-2350 BC) (RIME 1), University of Toronto, To-ronto-Buffalo-London. = P. Fronzaro l i (ed.), Eiterature and Literary Language atEbla (QuSetn 18), Dipartimento di
LA STATUARIA REGALE 297
Fi onza ro l i 1993
Fr onza ro l i 1998
Fronzaro l i 2003
Fronzarol i -Marrass in i 2005
Fur long 1987
Gadd 1934-1935
Gadd-Legra in 1928
AL GAILANI 1 9 7 2
al Gai l ani Wer r Cur t i s Mar t in McMahon-Oat e s-Re a de 2002
G a r e l l i 1974
Gai ri son-Cool Root 2001
Gasche-Hiouda 1996
l inguist ica dell'Università di Firenze, Firenze 1992.
= P. Fronzaro l i , Testi rituali della regalità (Ar-chivio E2769) (ARET 11), Missione Archeolo-gica Italiana in Siria, Roma 1993. = P. Fronzaro l i , Kam^-mu in Ebla Letters, IN LEBEAU (ED.), About Subartu, 2, 1998, pp. 103-114.
= P. Fronzaro l i , Testi di cancelleria: i rapporti con le città (Archivio L2769) (ARET 13), Missione Archeologica Italiana in Siria, Roma 2003. = P. Fronzaro l i , P. Marrass ini (edd.), Procee-dings of the 10* Meeting of Hamito-Semitic (Afro-asiatic) Linguistics (Florence, 18-20 April 2001) (QuSem 25), Dipartimento di Linguistica dell'Università di Firenze, Firenze 2005. = I. Fur long , Divine Headdresses of Mesopo-tamia in the Early Dynastic Period (BAR-S 334), Archaeopress, Oxford 1987. = C.J. Gadd, Babylonian Stone Carvings of the Early Period, «BMQ» 9 (1934-1935), pp. 42-45. = C.J. Gadd, L. Legra in , Royal Inscriptions (UET 1), The Trustees of the Two Museums, London-Philadelphia 1928. = L . AL GAILANI, Some Sumerian Statues in the Iraq Museum, «Iraq» 34 (1972), pp. 73-76.
= L. al Gai lan i W e r l , J.E. Curtis , H. Mar t in , A. McMahon, J. Oates, J. Reade (edd.), Of Pots and Plans. Papers on the Archaeology and His-tory of Mesopotamia and Syria Presented to David Oates in Honour of his 75th Birthday, NABU, London 2002.
= P. G a r e l l i (ed.), Le palais et la royauté. XLK' Rencontre Assyriologique Internationale, Geuthner, Paris 1974. = M.B. Garr ison, M. Cool Root , Seals on the Persepolis Fortification Tablets, 1. Images of Heroic Encounter (OIP 117), University of Chicago, Chicago 2001.
= H. Gasche, B. Hrouda (edd.), Collectanea orientalia. Histoire, arts de l'espace et industrie de ¡a terre. Etudes offertes en hommage à Agnès Spycket (Civilizations du Proche-Orient 1/3), Recher-ches et Publications, Neuchâtel-Paris 1996.
298
GAWÏIKDWSKA 1 9 8 0
Gelb 1952
Ge lb 1956
Ge lb 1957
Ge lb 1960
Ge lb 1982
Ge lb 1984
Ge lb 1986
Ge lb 1992
Gelb-Kienast 1990
Gel b-St e inkel 1 ei" -Whit ing 1991
G e l l e r 1989
DE GENOUILLAC 1 9 1 2
DE GENOUILLAC 1 9 2 2
de Genou i l l a c 1924
de Genou i l l a c 1925
NICOLÒ MARCHETTI
= K GAWUKOWSKA, E I R I ET JJTEL A M E I XL7
HT mmbîeee, «ROW 41/2 (1980), pp. 25-28.
= L J . G e l b, J L E S N C T a u OOI HE DIY4A R E
GTOV (MAD 1), University of Cliicago, Chicago
1952.
= LJ. Gelb, T r e N EWS Œ Ex-Vim ObjrIT in ,4t-nR-irA'lBŒŒ-îiiLI «Journal of the American
Name Society» 4 (1956), pp. 65-69.
= LJ. Gelb, Glossary of Old Akkadian (MAD
3), University of Cliicago, Chicago 1957.
= LJ. Gelb, The Name of the Goddess Innin,
«JNES» 19 (1960), pp. 72-79.
= LJ. Gelb, Terms for Slaves in Ancient Mesopo-
tamia, in A A . W . , Societies and Languages of the
Ancient Near East, 1982, pp. 81-98.
= I.J. Gelb, Sîbût kusurrä'im, "Witnesses of the
Indemnity", «JNES» 43 (1984), pp. 263-276.
= I.J. Gelb, Ebla and Eagash: Environmental
Contrast, in Weiss (ed.), The Origins of Cities,
1986, pp. 157-167.
= I J . Gelb, Ms ALD IFEKÎJH CnmzARoy, in
Young (ed.), Mari in Retrospect, 1992, pp. 121-
202.
= LJ. Gelb, B. Kienast , Die altakkadische Kö-
niginschriften des dritten Jahrtausends v.Chr. (FAOS
7), Steiner, Stuttgart 1990.
= LJ. Gelb, P. S t e i n k e l l e r , R M . Wl i i t ing ,
Earliest Land Tenure Systems in the Near East:
Ancient Kudurrus (OIP 104), The Oriental In-
stitute, Cliicago 1991.
=M.J. G e l l e r , A NW PME CF WeKHJL-H; ill
Behrens et al. (edd.), DUMU-E -DUB-BA-A,
1989, PP. 193-205.
= H. DE GENOUILLAC, Textes de l'époque dVr.
Deuxième partie (ITT 3), Leroux, Paris 1912.
= H. DE GENOUILLAC, Textes économiques
d'Oumma de l'époque d'Our (TCL 5), Geuthner,
Paris 1922.
= H. de Genou i l l ac , Premières recherches ar-
chéologiques a Kick. Mission d'Henri de Genouillac,
1911-1912,1, Champion, Paris 1924.
= H. de Genou i l l ac , Premières recherches ar-
chéologiques à Kick. Mission d'Henri de Genouillac,
1911-1912, H, Champion, Paris 1925.
LA STATUARIA REGALE
GensI er 1997
George 1993
Gibson 1972a
Gibson 1972b
Gibson 1976-1980
Gibson 1982
Gibson-Biggs 1977
Gibson-McMa hon 1997
Giul iano 2001
Gockel 1982
Goetze 1961
Goetze 1970-1971
Goodnick Westenholz 1989
GOODNICK WESTENHOLZ 2 0 0 0
299
= O.D. Gensl er, Mari Akkadian is 'Ho, for" and Preposition-Hopping in the Eight of Comparative Semitic Syntax, «OD> 66 (1997), pp. 129-156. = A.R. George, House Most High. The Temples of Ancient Mesopotamia (MC 5), Eisenbrauns, W'inona Lake 1993.
= McG. Gibson, The City and Area of Kish, Field Research Project, Miami 1972. = McG. Gibson, The Archaeological Uses of Cu-neiform Documents: Patterns of Occupation at the City of Kish, «Iraq» 34 (1972), pp. 113-123. = McG. Gibson, Kis. B. Archäologisch, «RIA» 5 (1976-1980), pp. 613-620. = McG. Gibson, A Re-evaluation of the Akkad Period in the Diyala Region on the Basis of Recent Excavations at Nippur and the Hamrin, «AJA» 86 (1982), pp. 531-538.
= McG. Gibson, R.D. Biggs (edd.), Seals and Sealing in the Ancient Near East (BiMes 6), Un-dena, Malibu 1977.
= McG. Gibson, A. McMa hoir, The Early Dj-nastic-Akkadian Transition. Part II: The Author's Response, «Iraq» 59 (1997), pp. 9-14. = A. Giuliano, Scritti minori (Xenia Antiqua, monografie 9), "L'Erma" di Bretsclmeider, Roma 2001.
= W Gockel , Die Stratigraphie und Chronologie der Ausgrabungen des Diyala-Gehietes und der Stadt Ur in der Zeit von Uruk/Eanna TV bis per Dyna-stie von Akkad, Giorgio Bretsclmeider, Roma 1982.
= A. Goetze, Early Kings of Kish, «JCS» 15 (1961), pp 105-111.
= A. Goetze, Early Dynastie Dedication Inscrip-tions from Nippur, «JCS» 23 (1970-1971), pp. 39-56.
= J. Goodnick Westenholz , Etéeduanna, En-Priestess, Hen of Nanna, Spouse of Nanna, in Behrens et al. (EDD.), DUMU-E-DUB-R4A, 1989, PP. 539-556. = J. GOODNICK WESTENHOLZ, King by Eove of Inanna — an Image of Female Empowerment^, «NINI Journal of Gender Studies in Anti-quity» 1 (2000), pp. 75-89.
300 NICOLÒ MARCHETTI
Gr ayson 1987
GREEN 1 9 7 7
Green 1982
Green-Nisseri 1987
Grégoire 1981
GRÉGOIRE 1 9 9 6
Grégoire 2002
Gunter 1990
Hackiran 1958
Haines 1956
Haines 1958
— A.K. Grayson, Assyrian Rulers of the Third and Second Millennia BC (to 1115 BC) (RIMA 1 ) , UNIVERSITY OF TORONTO, TORONTD-BUEFAID-
LONDON 1 9 8 7 .
= M.W GREEN, A Note on an Archaic Period Geographical List from Warka, «JNES» 36 (1977), pp. 293-294. = M.W Green, Miscellaneous Early Texts from Uruk, «ZA» 72 (1982), pp. 163-177. = M.W Green, H.J. Nissen, Zeichenliste der ar-chaischen Texte aus Uruk (ADFU 11; ATU 2), Gebr. Mann, Berlin 1987. = J.-R Grégoire , ÜSKHPSCW ET.'UCHL-H JOH-
MHR-nriB (l^HKFMB (MVN 10), Multigrafica, Roma 1981.
= J.-R GRÉGOIRE, Archives administratives et inscriptions cunéiformes de l'Ashmolean Museum et de la Bodleian Collection d'Oxford. Contribution à l'histoire sociale, économique, politique et culturelle du Proche-Orient Ancien, 1/1, Geuthner, Paris 1996. = J.-P. Grégoire , Archives administratives et inscriptions cunéiformes de l'Ashmolean Museum et de la Bodleian Collection d'Oxford. Contribution à l'histoire sociale, économique, politique et culturelle du Proche-Orient Ancien, 1/4, Geuthner, Paris 2002. = A.C. Gunter (ed.), Investigating Artistic Envi-ronments in the Ancient Near East, Smithsonian Institution, Washington 1990. = G.G. Hackimn, Sumerian and Akkadian Ad-ministrative Texts from Predynastic Times to the End of the Akkad Dynasty (BIN 8), Yale University, New Haven 1958.
= R.C. Haines, Where a Goddess of Eove and War Was Worshipped 4000 Years Ago: The Temple of Inanna Uncovered During Further Excavations at Nippur, the Ancient Holy City of Sumeria and Babylonia, « U N » IS 4 Aug. ( r i 6115) (1956), pp. 266-269. = R.C. Haines, Further Excavations at the Temple of Inanna — Goddess of Eove and War: Results of the Sixth Season at Nippur, Ancient Holy City of Sumeria, « E N » 6th Sept. ( r i 6222) (1958), pp. 386-389.
L A S T A T U A R I A R E G A L E
HAINES 1 9 6 1 A
Haines 1961b
Hal l 1930
H a l l - W o o l l e y 1927
H a l l o 1957
H a l l o 1988
Hansen 1963
Hansen 1965
Hansen 1971
Hansen 1975a
Hansen 1975b
Hansen 1991-1992
Hansen 1998
301
= R.C. HAINES, A Report of the Excavations at Nippur During 1960-1961, «Sumera 17 (1961), pp. 67-70. = R.C. Haines, The Temple of Inanna at Nippur, the Änderst Holy City of Sumer: Further Excava-tions at This Notahle Site, «LLN» 9th Sept. (n° 6371) (1961), pp. 408-411. = H.R. H a l l , A Season's Work at Ur, al'Ubaid, Abu Shahrain (Eridu), and Elsewhere, Being an Unofficial Account of the British Museum Ar-chaeological Mission to Babylonia, 1919, Methuen, London 1930. = H.R. H a l l , C.L. Wool l e y , Al-'Ubaid. A Report on the Work Carried Out at al-Ubaid for the British Museum in 1919 and for the Joint Ex-pedition in 1922-3 (UE 1), The Trustees of the Two Museums, London-Philadelphia 1927. = W W Hal 1 o, Early Mesopotamian Royal Titles: A Philologie and Historical Analysis (AOS 43), American Oriental Society, New Haven 1957. = W W H a l l o , Texts, Statues, and the Cult of the Divine King, in E ne r ton (ed.), Congress Volume, 1988, pp. 54-66.
= D.P. Hansen, New Votive Plaques from Nippur, «JNES» 22 (1963), pp. 145-166. = D.P. Hansen, The Relative Chronology of Me-sopotamia. Part II. The Pottery Sequence at Nippur
from the Middle Uruk to the End of the Old Baby-lonian Period (3400-1600 B.C.), in Ehr ich (ed.), Chronologies in Old World Archaeology, 1965, pp. 201-213. = D.P. Hansen, Some Early Dynastic I Sailings
from Nippur, in Mi t ten et al. (edd.), Studies Pre-sented to George AIA. Hanfmann, 1971, pp. 47-54. = D.P. Hansen, FrUhsumerische undfruhdynasti-sche Rundplastik, in Orthmann (ed.), Der Alte Orient, 1975, pp. 158-170. = D.P. Hansen, FrUhsumerische undfruhdynasti-sche Flachbildkunst, in Ort him nn (ed.), Der Alte Orient, 1975, pp. 179-193. = D.P. Hansen, al-Hiba, 1990, «AÍO» 38-39 (1991-1992), pp. 269-271. = D.P. Hansen, Art of the Royal Tombs of Ur: A Brief Interpretation, in Ze t t l e r -Horne
302 NICOLÒ MARCHETTI
Hansen 2001
Hansen 2002
Hansen-Dal es 1962
Harper 1992
HARPER-ARUZ-TALLON 1 9 9 2
Harper -Klenge l B r and t -
Ar uz-Benz el 1995
Hauptnann 1989
Haupt na nn-Pernicka 2004
Hauptnann-Wae tzo ld t 1988
Hand e i t e r -Ke rne r -Mü l l e r Neul iof 2002
(edd.), Treasures from the Royal Tombs of Ur;
1998, pp. 43-72.
= DP. Hansen, Some Notes on the Old Baby-
lonian Bagara of Ningirsu in Lagash, in Breni-
qnet -Kepinski (edd.), Etudes mésopotamiennes;
2001, pp. 215-232.
= M.H. Hansen (ed.), A Comparative Study of
Six City-State Cultures, The Rotai Danish Aca-
demy of Sciences and Letters, Copenhagen
2002. = D.P. Hansen, G.F. Dal es, The Temple of In-
anna Queen of Heaven at Nippur, «Archaeology»
15 (1962), pp. 75-84.
= P.O. HARPER, Mesopotamia» Monuments Found
at Susa, in Harper et al. (EDD.), TEE ROl'4L Qw
CF SuLi 1992, PP . 1 5 9 - 1 6 2 .
= P.O. HARPER, J . ARUZ, F. TALLÓN (EDD.), The
Royal City of Susa. Ancient Near Eastern Trea-
sures in the Eouvre, The Metropolitan Museum
of Art, New York 1992.
= P.O. Harper , E. K l e n g e l B r a n d t , J. Aruz,
K. Benzel (edd.), Discoveries atAshur on the Ti-
gris. Assyrian Antiquities in the Vorderasiatisches
Museum, Berlin, The Metropolitan Museum of
Art, New York 1995.
= R. Haupt m u m . Die sumerische Beterstatuette
(Liebieghaus Monographie 12), Stadt Frank-
furt am Main, Frankfurt am Main 1989.
= H. Hauptmann, E. Pernicka (edd.), Die
Metallindustrie Mesopotamiens von den Anfängen bis
syim 2. Jahrtausend v.Chr. (Orient-Archäologie
3), Leidorf, Rahden 2004.
= H. Hauptmann, H. W a e t z o l d t (edd.),
Wirtschaß und Gesellschaß von Ebla. Akten der
internationalen Tagung Heidelberg 4.-7. November
1986 (HSAO 2), Heidelberger Orientverlag,
Heidelberg 1988.
= A. Haus le i t e r , S. Kerne r , B. M ü l l e r
Neul iof (edd.), Material Culture and Mental
Spheres. Reception archèiologischer Denkrichtungen
in der vorderasiatischen Altertumskunde. Internatio-
nales Symposium für Hans J. Nissen, Berlin, 23. -24.
Juni 2000 (AOAT 293), Ugaiit , Münster 2002.
L A S T A T U A R I A R E G A L E
HAUSMAN 1 9 9 1
Heinpel 1990
HEIMPEL 1 9 9 2
Heinpel 1998-2001
Heinpel 2002
Heinpel 2003
He im ich 1931
Heinr ich 1936
Heinr ich 1957
Heinr ich 1982
Heuzey 1897
Heuzey 1898
Heuzey 1899
Heuzey 1902
303
= C.R. HAUSMAN, Figurative Language in Art History, in Kemi l -Gaske l l (edd.), The Lan-guage of Art Histoy, 1991. pp. 101-128. = W Heinpel , Ein zweiter Schritt cjtr Rehabi-litierung der Rolle des Tigris in Sumer, «ZA» 80 (1990), PP. 204-213.
= W HEIMPEL, Herrentum und Königtum im vor- und frühgeschichtlichen Alten Orient, «ZA» 82 (1992), pp. 4-21.
= W Heinpel , Ninsiana, «RIA» 9 (1998-2001), pp. 487-488. = W Heinpel , The Lady of Girsu, in Abusch (ed.), Riehes Hidden in Secret Places, 2002, pp. 155-160.
= W Heinpel , Letters to the King of Mari. A New Translation, with Historical Introduction, Notes, and Commentary (MC 12), Eisenbrauns, Winona Lake 2003.
= E. Heinrich, Fara. Ergebnisse der Ausgra-bungen der Deutschen Orient-Gesellschaft in Fara und Abu Hatab 1902/03 (Staatliche Museen zu Berlin, Vorderasiatische Abteilung), Staatliche Museen zu Berlin, Ber Ei 1931. = E. Heinrich, Kleinfunde aus den archaischen Tempelschichten in Uruk (ADFLI 1), Deutsche Forschungsgemeinschaft, BerEi 1936. = E. Heinr ich, Bauwerke in der altsumerischen Bildkunst (Schriften der Max Freiherr von Oppenheim Stiftung 2), Harrassowitz, Wies-baden 1957.
= E. Heinrich, Die Tempel und Heiligtümer im Alten Mesopotamien. Typologie, Morphologie und Geschichte (Denkmäler antiker Architektur 14), Deutsches Archäologisches Institut, Bedin 1982. = L. Hetizey, La construction du roi Our-Nina d'après les levés et les notes de AI. de Saipec; «RA» 4/4 (1897), pp. 87-122.
= L. Heuzey , La construction du roi Our-Nina. Notes complémentaires d'après les découvertes de M. de Saipec, «RA» 5/1 (1898), pp. 26-32. = L. Hetizey, Construction antérieure à Our-Nina, «RA» 5/2 (1899), pp. 33-56. = L. Heuzey , Musée National du Louvre, cata-logue des Antiquités Chaldéennes: sculpture et gra-vure à la pointe, Braun, Paris 1902.
304
HILGERT 2002
Hoff imnn 1964
Hole 1983
Horowitz 2003
HRDUDA 1 9 7 0
Hrouda 1971
Hrouda 1996
Huehnergard 1997
Huot 2003
Isimil -Sal i aberger-Tal on Van Lerberglie 1996
Jacobsen 1939
Jacobsen 1942
Tacobsen 1957
Jacobsen 1967
Jacobsen 1988
Jacobsen 1989
Jacobsen 1991
NICOLÒ MARCHETTI
= M. HILGERT, Akkadisch in der Ur IH-Zeit (IMGULA 5), Rhema, Münster 2002. = H. Hoff imnn (ed.), Norbert Schimmel Collec-tion, von Zaber n, Mainz 1964. = F. Hole , Symbols of Religan and Social Or-ganisation at Susa, in A A . W , The Hilly Flanks, 1983, pp. 315-333.
= VA. Horowitz, The Mesopotamia» God Image, from Womb to Tomb, «JAOS» 123 (2003), pp. 147-157. = B. HROUDA, Zur Datierung frühsumerischer Bildwerke aus Uruk-Warka, «BaM» 5 (1970), pp. 33-44. = B. Hrouda, Vorderasien, I. Mesopotamien, Ba-bylonien, Iran und Anatolien (Handbuch der Ar-chäologie), Beck, München 1971. = B. Hrouda, Einige Bemerkungen p/r Rj/ndpla-stik im Alten Orient, in Gasche-Hrouda (edd.), Collectanea orientalia, 1996, pp. 137-143. = J Huehnergard, A Grammar of Akkadian (HSS 45), Scholars, Atlanta 1997. = J.-L. Huot (ed.), Earsa. Travaux de 1987 et 1989 (BAH 165), IFAPO, Beyrouth 2003.
= F. Ismail, W Sa l l aberger , P. Ta lon , K. Van Lerberghe, Administrative Documents from Tell Beydar (Seasons 1993-1995) (Subartu 2), Brepols, Turnhout 1996.
= T. Jacobsen, The Sumerian King Eist (AS 11), The Oriental Institute, Chicago 1939. = T. Jacobsen, The Inscriptions, in Delougaz-I I oyd, Pre-Sargonid Temples, 1942, pp. 289-298.
= T. Jacobsen, Early Political Development in Mesopotamia, «ZA» 52, 1957, pp. 91-140. = T. Jacobsen, Some Sumerian City-Names, «JCS» 21 (1967), pp. 100-103. = T. Jacobsen, The Sumerian Verbal Core, «ZA» 78 (1988), pp. 161-220.
= T. Jacobsen, God or Worshipper, in Leonard-Beyer Wil l iams (edd.), Essays in Ancient Civili-sation, 1989, pp. 125-133. = T. Jacobsen, The Term Ensí, «AuOr» 9 (1991), pp. 113-121.
LA STATUARIA REGALE
JAGERSMA 1995-1996
Jagersma 2000
Jans-Br et schneidet 1998
Jean Marie 1990
Je stin 1937
johansen 1978
Katg 1984
Karg 1993-1997
Karg 1994
Keiser 1919
Ke l l y Bucce l l a t i -Mat th iae Van Loon 1986
Keiml-Gaskel l 1991
Kertzer 1988
Kessl er Sirrpson 1985
305
= B . JAGERSMA, RECENSIONE DI MARZAHN 1 9 9 1 ,
« A Ï O » 42-43 (1995-1996), pp. 222-224. = B. Jagersira, Sound Chang in Sumerian: The So-CaUed /dr/-Phoneme, « A S J » 22 (2000), pp. 81-87.
= G. Jans, J. Bret Schneider, Wagon and Chariot Representations in the Early Dynastic Glyptic. 'They Came to Tell Beydar with Wagon and Equid", in Le be an (ed ), About Subartu, 2, 1998, pp. 155-194.
= M. Jean Marie, Ees tombeaux en pierres de Mari, «MARL) 6 (1990), pp. 303-336. = R.R. Jestin, Tablettes sumériennes de Suruppak conservées au Musée de Stamboul (Mémoires de l'Institut français d'archéologie de Stamboul 3), de Boccard, Paris 1937. = F. Johansen, Statues of Gudea, Ancient and Modem (Mesopotamia 6), Akademisk, Copen-hagen 1978.
= N. Karg , Untersuchungen yi¡r älteren frühdy-nastischen Glyptik Babyloniens. Aspekte regionaler Entwicklungen in der ersten Hälfte des 3. Jahrtau-sends (BaF 8), von Zabern, Mainz am Rhein 1984.
= N. Karg , Mesilim. B. Archäologisch, «RIA» 8 (1993-1997), pp. 74-81. = N. Karg , Recensione di Mart in 1988, «ZA» 84 (1994), pp. 151-158.
= C.E. Keiser, Selected Temple Documents of the Ur Dynasty (YOS 4), Yale University, New Haven 1919.
= M. Ke l l y Bucce l l a t i , P. Matth iae , M.N. Van Loon (edd.), Insight Through Images. Studies in Honor of Edith Porada (BiMes 21), Undena, Malibu 1986.
= S. Kemal, I. Gaskell (edd.), The Language of Art History (Cambridge Studies in Philo-sophy and the Arts 1), Cambridge University, Cambridge-New York-Melbourne 1991. = D.I. Ker tzer , Ritual, Politics and Power, Yale University, New Haven-London 1988. = H.L. Kessler, M.S. Sinpson (edd.), Pictorial Narrative in Antiquity to the Middle Ages (Studies
306
Kienast 1994
Kienast-Volk 1995
King 1909
KING 1 9 1 2
KLENGEL BRANDT 1 9 9 0
Klenge l -K l enge l 1980
Kotaya shi 1984
Kotayashi 1985
Kotayashi 1989
Koch Wes tenho lz 1995
Kohlmeyer 1991
Kohl m y e r - S t r orrmeng er 1991
Kose 2000
NICOLÒ MARCHETTI
in tlie History of Art 16), National Gallery of Art, Washington 1985. = B. Kienast , Glossar pe den altakkadischen Königsinschriften (PAOS 8), Steiner, Stuttgart
1994. = B. Kienast , K. Vo lk , Die sumerischen und akkadischen Briefe (FAOS 19), Steiner, Stuttgart
1995. = L.W King, Cuneform Texts from Babylonian Tablets in the British Museum 25, THE TKL'STEE OF
THE BRITISH MUSEUM , LONDON 1 9 0 9 .
= L . W KING, Cieneiform Texts from Babylonian Tablets in the British Museum 32, THE TRUSTEE OF
THE BRITISH MUSEUM , LONDON 1 9 1 2 .
= E. KLENGEL BRANDT, Gab es ein Museum in der Hauptburg Nebukadnepirs II. in Babylon?, «Forschungen und Berichte» 28 (1990), pp. 4 1 - 3 6 .
= E. K l enge l , H. K l e n g e l , ZUM FE-B ÍM HAH1 STEETKBßH MIT HEHL INKHÜTTLE RñílIÍ KT,"
Mou®, «RO» 41 (1980), pp. 45-51. = T. Kobayashi, On the Meaning of the Offerings
for the Statue of Entemena, «Orient» 20 (1984), pp. 43-65.
= T. Kobayashi, The ki-a-nag of Enentarp', «Orient» 21 (1985), pp. 10-30. = T. Kobayashi, Was Mesandu the Personal Deity of Enentarp?, «Oriento 25 (1989), pp. 22-42. = U. Koch Westenholz , Mesopotamian As-trology, Carsten Niebuhr Institute of Near Eastern Studies, Copenhagen 1995. = K Kohlmeyer, Das '.Schloßmuseum' von Ba-bylon, hi Kohlneyer-Strommenger (edd.), Wiedererstehendes Babylon, 1991, pp. 4538 . = K Kohlmeyer, E. Stromuenger (edd.), Wiedererstehendes Babylon. Eine antike Weltstadt im Blick der Forschung, Museum fur Vor- und Frühgeschichte — Staatliche Museen Preußi-scher Kulturbesitz, Berlin 1991. = A. Kose, Das 'Palais" auf Tell M von Girsu — Wohnstätte eines hellenistisch-parthischen Samm-lers von Gudeastatuen?, «BaM» 31 (2000), pp. 377-431.
L A STATUARIA R E G A L E
KRAMER 1 9 3 6
Krasnik-Meyer 2001
Krebernik 1982
Krebernik 1984a
Krebernik 1984b
Krebernik 1985
Krebernik 1986
Krebernik 1988
Krebernik 1991
Krebernik 1992
Krebernik 1998
Krebernik 2002
Krebernik 2003a
Krebernik 2003b
307
= S . N . KRAMER, TEE SIMHLW Psßx R E M I RE
MND BI- IN THE TlAIE Œ THE E -HIER PSIMS CF Le® (AS 8), University of Chicago, Chicago 1936. = K Krasnik, J.-W Meyer, Im Tod den Göttern nahe. Eine prunkvolle Bestattung in Teil Chuera, Nordsyrien, «Antike Welt» 32/4 (2001), pp. 383-390.
= M. Krebernik, Zur Syllahar und Orthographie der lexikalischen Texte aus Ebla. Teil 1, «ZA» 72 (1982), pp. 178-236. = M. Krebernik, Die Beschwörungen aus Fara und Ebla, Olms, Hildesheim-Zuricli-New York 1984. = M. Krebernik, Zur Tesung einigerfruhdynasti-scher Inschriften aus Mari, «ZA» 74 (1984), pp. 164-167. = M. Krebernik, ZURENIWIŒIIN&E£RKHKtHHH-
IM III. J-fEPHSIND _ E H E D DER TfKTELÜT EBLA EIN VatmoizmsaEijn?KKj£isatti e D SL-msami SORmsmí , «AfO» 32 (1985), pp. 53-59. = M. Krebernik, Dm GanHHSlEt JhEg «ZA» 76 (1986), pp. 161-204. = M. Krebernik, Die Personennamen der Ebla-Texte. Eine Zwischenbilanz (BBVO 7), Reimer, Berlin 1988.
= M. Krebernik, Recensione di Gelb-Kienast 1990, «ZA» 81 (1991), pp. 133-143. = M. Krebernik, Mesopotamian Myths at Ebla, «ARET» 5, 6 and«ARET» 5, 7, in Fronzarol i (ed.), Literature and Literary Language, pp. 63-149. = M. Krebernik, Die Texte aus Fara und Tell Abu Saläblh, in Bauer et al., Mesopotamien, 1998, pp. 237-427. = M. Krebernik, Zur Struktur und Geschichte des älteren sumerischen Onomastikons, in Streck-Weninger (edd.), Altorientalische und semitische Onomastik, 2002, pp. 1-74. = M. Krebernik, dPA, ™><™'PA, «RIA» 10/1-2 (2003), p. 160. = M. Krebernik, Drachenmutter und Himmels-rebe? Zur Frühgeschichte Dumuzjs und seiner Fa-milie, in Sal laberger et al. (edd.), Literatur, Politik und Recht in Mesopotamien, 2003, pp. 151-180.
308 NICOLÒ MARCHETTI
KRECHER 1 9 6 7
KRECHER 1 9 7 2
KRECHER 1 9 8 3
Krecher 19S7a
Krecher 19S7b
Krecher 1987c
KRECHER 1 9 9 2
Krecher 1993
Krispjr i 2000
Kühne-Schneider 1988
La ta t 1974
Lanhert 1970
Lanhert 1973
LAMBERT 1 9 8 5
Lanhert 1986
Lanhert 1988
= J . KRECHER, Zum Ems. T-DITH; r l e Sumhh-
SGEX, in AA.VY, Heidelberger Studien p/m Alten Orient, 1967, PP. 87-110. = J. KRECHER, RECENSIONE DI I.J. GELB, Sargonk Texts in the Ashmolean Museum, Oxford (MAD 5), The University of Chicago, Chicago 1970, «ZA» 62 (1972), PP. 269-273. = J. KRECHER, Eine unorthographische sumerische Wortliste aus Ebla, «OA» 22 (1983), pp. 179-189.
= J. Krecher , Morphemkss Syntax in Sumerian as Seen on the Background of Word-Composition in Chukchee, «ASJ» 9 (1987), pp. 67-88. = J. Krecher , fur/ 'Mann", jeme/ "Frau" und die sumerische Herkunft des Wortes urdu( d) "Sklave", «WO» 18 (1987), pp. 7-19. = J. Krecher , DL7= KUf-È) "HNZKEEEV", "HABA1
BREMEN", «ZA» 77 (1987), PP. 7-21. = J_ KRECHER, UD.GAENUNversus "normal" Sumerian: Two Eiteratures or One?, in F ronza ro l i (ed.), Eiterature and Eiteraiy Eanguage, 1992, pp. 285-303.
= Krecher , Uber Einige 'Zusammenge-setp Verben" im Sumerischen, in Rainey (ed.), kinattütu sa därati, 1993, pp. 107-118. = TJ.H. Krispijn, The Change of Offirial Sume-rian in the City-State of Lagos, «ASJ» 22 (2000), pp. 153-175.
= H. Kühne, G. Schneider , Neue Untersu-chungen per Metallischen Ware, «Damaszener Mitteilungen» 3 (1988), pp. 83-139. = R. La ba t , Te<ih nnEL-iEES IEJ"UÏE(MDAI 57),
Geuthner, Paris 1974.
= M. Lanher t , Ees inscriptions des temples dlsh-tarat et de Ninni-p¡p¡, «RA» 64 (1970), pp. 168-171. = M. Lanher t , AO 7754, «RA» 67 (1973), P. 96. = WG. Lanher t , The Pantheon of Alari, «MARI» 4 (1985), pp. 525-539. = WG. Lanher t , The Reading of the Divine Name Sahkan, «OD. 55 (1986), pp. 152-158. = WG. Lanhert,AnQIDMÍIK.-EIA^Listcf PBÌ-SCKÍN'MB, in Le ichty et al. (edd.), M Scientific Humanist, 1988, pp. 251-260.
LA STATUARIA REGALE
LAMBERT 1 9 8 9
LAMBERT 1990A
Lambert 1990b
Lambert 1995
Lambert 2005
Lamber t -Mi l l a rd 1969
Lang don 1924
Lang don 1930
Lebeau 1985a
Le beau 1985b
Lebeau 1990
Le beau 1998
Le Bre ton 1957
Legra in 1936
309
= W G . LAMBERT, Notes on a Work of the Most
Ancient Semitic Literature, «JCS» 41 (1989), PP.
1-33.
= W G . LAMBERT, The Names of Umma, « J N E S »
49 (1990), pp. 75-80.
= WG. L a n i e r t . Addenda to W.G. Lambert,
"The Pantheon of Mari", (MARI 4 (1985) pp.
525-529) « M A M » 6 (1990), p. 644.
= WG. Lambert, Recensione di R.A. Di
Vi to , Studies in Third Millennium Sumerian and
Akkadian Personal Names. The Designation and
Conception of the Personal God (StPohl SM 16),
Pontificio Istituto Biblico, Roma 1993, «Or»
64 (1995), pp. 131-136.
= WG. Lambert, Marginalia on MSL XV,
«NABU» 29 (2005).
= WG. Lambert, A.R. M i l l a r d , Alra-hasts.
The Babylonian Story of the Flood, Clarendon,
Oxford 1969.
= S. Langdon , Excavations at Kish. The Herbert
Weld and Field Museum of Natural History Expe-
dition to Mesopotamia, I, Geuthrier, Paris 1924.
= S. Langdon, Excavations at Kish, 1928-9,
«JRAS» (1930), pp. 601-610.
= M. Lebeau, Rapport préliminaire sur la séquence
céramique du Chantier B de Mari (Ur millénaire),
«MAM» 4 (1985), pp. 93-126.
= M. Lebeau, Rapport préliminaire sur la céra-
mique du Bronze Ancien L'a découverte au 'palais
présargonique 1" de Mari, «MAM» 4 (1985), pp.
127-136.
= M. Lebeau, La céramique du tombeau 300 de
Mari (temple d'Isbtar), «MAM» 6 (1990), pp.
349-374.
= M. Lebeau, (ed.) About Subartu. Studies De-
voted to Upper Mesopotamia, 2. Culture, Society,
Image (Subartu 4/2), Brepols, Turnhout 1998.
= L. Le Bre ton , The Early Periods at Susa,
Mesopotamian Relations, «Iraq» 19 (1957), pp.
79-124.
= L. Legra in , Archaic Seal-Impressions (LIE 3),
The Trustees of die Two Museums, London
Philadelphia 1936.
310
LEGRAIN 1 9 3 7 - 1 9 4 7
Leicht y-El l is-Gerardi 1988
Lenorrrant 1868
Lenorrrant 1873-1875
Lenzen 1960
Lenzen 1961
Lenzen 1963
Leonard-Beyer Williame 1989
van Lerberghe-Voet 2000
Leslie 2002
NICOLÒ MARCHETTI
= L . LEGRAIN, Business Documents of the Third Dinasty of Ur (UET 3), The Trustees of the Two Museums, London-Philadelphia 1937-1947. = E. Leiclity, M. dej. El l is , P. Gerardi (edd.), A Scientific Humanist. Studies in Memory of Abraham Sachs (OPKF 9), University Mu-seum, Philadelphia 1988. = F. Lenorrrant , 5LB. LTE SEWEDE R-EYKT-IE-C-E DÍHRHES «Revue Archéologique» nouvelle série 18 (1868), pp. 231-236. = F. Le n or mm t , Choix de textes cunéiformes iné-dits ou incomplètement publiés jusqu'à ce jour; Mai-sonneuve, Paris 1873-1875. = H.J. Lenzen (ed.), ATT. vorläufiger Bericht über die von dem Deutschen Archäologischen Institut und der Deutschen Orient-Gesellschaft aus Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft unternommenen Ausgrabungen in Uritk-Warha, Winter 1957/58 (ADOG 5), Gebr. Mann, Berlin 1960. = H.J. Lenzen (ed.), AT77. vorläufiger Bericht über die von dem Deutschen Archäologischen Institut und der Deutschen Orient-Gesellschaft aus Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft unternommenen Ausgrabungen in Uritk-Warha, Winter 1958/59 (ADOG 6), Gebr. Mann, Berlin 1961. = H.J. Lenzen (ed.), ATA. vorläufiger Bericht über die von dem Deutschen Archäologischen Institut und der Deutschen Orient-Gesellschaft aus Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft unternommenen Ausgrabungen in Uruk-Warka, Winter 1960/61 (ADOG 8), Gebr. Mann, Berlin 1963. = A. Leonard, B. Beyer Wil l iams (edd.), Essays in Ancient Civilization Presented to Helene J. Kantor (SAOC 47), The Oriental Institute, Chicago 1989.
= K. van Lerberghe, G. Voet (edd.), L f f CEMH XFSD CUULW IN CIT-IAX AT VE CKXSKMX CF CNNIZMAZ IN TIE STXXMSŒŒNILN; REÍZLÍ.
PFCXŒZNS Œ HE 42TH RAI (OLA 96), Peeters,
Leuven 2000.
= K. Leslie, Examination and Tentative Identi-fication of Some Black Stone Objects, «ZA» 92 (2002), pp. 296-300.
LA STATUARIA REGALE 311
LÉVY 1 9 8 7
Line i 1968
Lindeitoyer-Mar t in 1993
Lit ke 1998
l i v e r ani 1988
LUTERANI 1 9 9 3
Liver ani 2002
L loyd 1969
I i o y d S a f a r 1943
van Loon 2001
Luckenhi l l 1913-1914
Luckenhi l l 1930
= E. LEYE' (ED.), Le système palatial en Orient, en Grèce et à Rome. Actes du Colloque de Strasbourg 19-22 juin 1985 (Travaux du Centre de re-cherche sur le Proche-Orient et la Grèce anti-ques 9), Brill, Leiden 1987. = H. Luret , L'anthroponymie sumerienne dans les documents de la 3' dynastie d'Ur (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Uni-versité de Liège 180), Les Belles Lettres, Paris 1968.
= E. Linderœyer, L. Mar t in , Uruk: KJein-funde, HI. Kleinfunde im Vorderasiatischen Museum •pi Berlin: Steingefäße und Asphalt, Farbresfe, Fritte, Glas, Holz, Knochen I Elfenbein, Muschel/Perl-mutt/ Schnecke (ALJWE 9), von Zabern, Mainz am Rhein 1993.
= R.L. L i t k e , M RsiwiFi.ara\ CF heAssybd-Ba BYiaU4\TGa>LSE,AN: A-nu-um and AN: Ana sä amêli (TBC 3), Yale Babylonian Collection, New Haven 1998.
= M. Liver ani, Antico Oriente. Storia, società, economia (Collezione storica), Laterza, Roma-Bari 1988.
= M. LTVERANI, (ED.) Akkad, the First World Empire. Structure, Ideology, Traditions (HANES 5), Sargon, Padova 1993. = M. Liver ani, Response to Gebhard Sely in Hausle i ter et al. (edd.), Material Culture and Mental Spheres, 2002, pp. 151-159. = S. LJoyd , Back to Ingharra, «Iraq» 31 (1969), pp. 40-48.
= S. L loyd , F. Safar , Tell Uqair. Excavations by the Iraq Government Directorate of Antiquities in 1940 and 1941, «JNES» 2 (1943), pp. 131-158. = M.N. van Loon (ed.), Selenkahiye. Final R¿'-
port on the University of Chicago and University of Amsterdam Excavations in the Tabqa Reservoir, Northern Syria, 1967-1975 (PIHANS 91), Ne-dedands Instituut voor het Nabije Oosten, Leiden 2001.
= D.D. Luckenhi l l , Two Inscriptions of Mesilim, King of Kish, «AJSD> 30 (1913-1914), pp. 219-223. = D.D. Luckenhil 1, Inscriptionsfrom Adab (OIP 14), The Oriental Institute, Chicago 1930.
312 NICOLÒ MARCHETTI
Ma ai jet-Jagersma 1997-1998
Mackay 1929
M a e d a 1 9 8 1
Maekawa 1973-1974
Magen-Rashad 1996
Mal 1 owan 1964
Ma l 1 ornan 1971
Mander 1990
Mander-Durand 1995
Marches i 1999
Marches i 2001
Marches i 2 0 0 2
MARCHESI 2 0 0 4
Marchesi in stampa
Marchetti 1995
— R. de Maa i jer , B. Jagers ira , Recensione di
PSD A/1 e A/2, «AfO» 44-45 (1997-1998),
pp. 277-288.
= E. Mackay , A Sumerian Palace and the 'A"
Cemetery at Pish, Mesopotamia, II (Field Museum
of Natural History, Anthropology Memoirs
1 /2), Field Museum of Natural History, Chi-
cago 1929.
= T. Maeda , "KeUŒ KiSH" INPKEL-EŒEICSUMEB, «Orient» 17 (1981), pp. 1-17.
= K. Maekavn, The Development of the E-MI in
Eagash during Early Dynastic HI, «Mesopotamia»
8-9 (1973-1974), pp. 77-144.
= U. Magen , M. Rashad (edd.), Vom Halys
Z¡tm Euphrat. Thomas Beran Ehren mit Bei-
trägen von Freunden und Schülern (AVO 7),
Ugarit, Münster 1996.
= M. Ma l lowan , A Cylinder Seal in the Uruk-
JamdatNasr Style, «BaM» 3 (1964), pp. 65-67.
= M. Mal 1 ovan, The Early Dynastic Period in
Mesopotamia, «CAH» 1/2, pp. 238-314.
= P. Mander , Anmwmâliœ TBŒ Œ EE AB, OEEE2769 (LIEE 10; MVS I), Università di
Roma "La Sapienza", Roma 1990.
= R Mander , J.-M. Durand, Mitología y Reli-
gion del Oriente Antiguo, II/1. Semitas Occidentales
(Ebla, Mari), AUSA, Sabadell 1995.
= G. Marchesi , Notes on Two Alleged Literary
Texts from al-Hiba/ Lagos, «SEL» 16 (1999), pp.
3-17.
= G. Marchesi , Alism SIC = HGtR¡ .TD Rh Sim M i m s , «Or» 70 (2001), pp. 313-317.
= G. Marchesi , On the Divine Name dba.ú, « O R »
71 (2002), PP. 161-172.
= G. MARCHESI, Who Was Buried in the Royal
Tombs of Uri The Epigraphic and Textual Data,
«Or» 73 (2004), pp. 153-197.
= G. Marchesi , Lumma in the Onomasticon and
Literature of Ancient Mesopotamia (HANES 10),
Sargon, Padova in stampa.
= N. Marche t t i , Die Entstehung der frühsyrischen
Stadtkultur, «Das Altertum» 41 (1995), pp. 3-
14.
L A S T A T U A R I A R E G A L E
MARCHETTI 1 9 9 6 A
Marche t t i 1996b
Marche t t i 1998
Marche t t i 2003
Marchet t i -Nigro 1995-1996
Margt ieron 1971
Margt ieron 1982a
Margt ieron 1982b
Margt ieron 1983
Margt ieron 1985
Margt ieron 1990
Margt ieron 1993
Margt ieron 1996
Margt ieron 1997
Margt ieron 2004
313
= N. MARCHETTI, The Ninevife 5 Glyptic of the Khabur Region and the Chronology of the Piedmont Style Motives, «BaM» 27 (1996), pp. 81-115. = N. Marchet t i , E'aquila Angu: nota su alcuni amuleti mesopotamici, «VO» 10 (1996), pp. 105-121. = N. Marchet t i , The Mature Early Syrian Glyptic from the Khabur Region, in Lebeati (ed.), About Subartu, 2, 1998, pp. 115-153. = N. Marchet t i , Workshops, Trading Routes and Divine Figures. On the Early Middle Brenge II SyroAnatolian Eead Figurines, «Or» 72 (2003), pp. 390-420.
= N. Marchet t i , L. Nigro, Handicraft Produc-tion, Secondary Food Transformation and Storage in the Public Building P4 in EB II A Ebla, «Berytus» 42 (1995-1996), pp. 9-36. = J.-C. Margtieron, Larsa. Rapport préliminaire sur la cinquième campagne, «Syria» 48 (1971), pp. 271-287.
= J.-C. Margt ieron, Recherches sur les palais mésopotamiens de l'Age du Brenge (BAH 107), Geuthner, Paris 1982. = J.-C. Margtieron, Alari: originalité ou dépen-dance?, «SEb» 5 (1982), pp. 121-144. = J.-C. Margtieron, Alari: rapport préliminaire surla campagne de 1980, «MARI» 2 (1983), pp. 9-35. = J.-C. Margt ieron, Quelques remarques sur les temples de Alari, «MARI» 4 (1985), pp. 487-507. = J.-C. Margt ieron, Une tombe royale sous la salle du Trône du palais des Shakkanakku, «MARI» 6 (1990), pp. 401-422. = J.-C. Margt ieron, Une couverture possible pour l'espace central de lEnceinte Sacrée, «MARI» 7 (1993), pp. 281-313. = J.-C. Margt ieron, Mari, reflet du monde syro-mésopotamien au lile millénaire, «Akkadica» 98 (1996), pp. 11-30.
= J.-C. Margueron, Autour de la tête d'une sta-tuette du temple de Ninni-gaga, «MARL) 8 (1997), pp. 725-730. = J.-C. Margueron, Mari. Métropole de l'Euphrate au III' et au début du II' millénaire av. J.-C., Picard/ERC, Paris 2004.
314
MARGUERON IN S I M PA
Marguer on-Beyer -Br eniquet -But t er 1 in-
Liégey-Mul 1er - Weygand 1997
Mart in 1988
Mar:t in-Pomponio-Visicat o-
W e s t e n h o l z 2001
Marzahn 1991
Marzahn 1996
Mat sushima 1993
Ma t thews 1989
Ma t thews 1990
Ma t thews 1991
Ma t thews 1993
Ma t thews 1997a
NICOLÒ MARCHETTI
= J.-C. MARGUERON, Mari et la chronologie: ac-
quisitions récentes et problèmes, in Ma t th i a e et al.
(edd.), From Relative Chronology to Absolute Chro-
nology, in stampa.
= J.-C. Margue ron , D. Beyer , C. Breni-
que t , P. B u t t e r l i n , A. Liégey , B. Mu l l e r , I.
Weyg and. Alari: rapport préliminaire sur les cam-
pagnes de 1990 et 1991, «MAM» 8 (1997), pp.
9-70.
= H.P. Mar t i n , Fara: A Reconstruction of the
AncientMesopotamian City of Shuruppak, Martin,
Birmingham 1988.
= HP. Mar t in , F. Pomponio, G. Vis i ra to , A.
Wes tenho lz , The Fara Tablets in the University
of Pennsylvania Museum of Archaeology and An-
thropology, CDL, Bethesda 2001.
= J. Marzahn , AmUMmSOEVHl&tlWmBCErLS
Gmsu/ID&K (VS 25), Akademie, Beilin 1991.
= J. Marzahn , AmUSimSOE VttZl-MJtUl&nE
LED HN BBH> GlESu/L^Cff (VS 27), von Za-
beln, Mainz am Miein 1996.
= E. Matsushina (ed.), Official Cult and Popular
Religion in the Ancient Near East Papers of the
First Colloquium on the Ancient Near East — The
City and Its Fife, Held at the Middle Eastern Cul-
ture Center in Japan (Mitaka, Tokyo), March 20-
22, 1992, Universitätsvedag C. Winter, Hei-
delberg 1993.
= R J . Mat thews , Excavations at Jemdet Nasr,
1988, «Iraq» 51 (1989), pp. 225-248.
= R J . Mat thews , Excavations at Jemdet Nasr,
1989, «Iraq» 52 (1990), pp. 25-39.
= R.J. Mat thews , Fragments of Officialdom from
Fara, «Iraq» 53 (1991), pp. 1-15.
= R.J. Mat t hews, Cities, Seals and Writing: Ar-
chaic Seal Impressions from Jemdet Nasr and Ur
(MSVO 2), Gebr. Maim, Berlin 1993.
= D. Mat thews , The Early Glyptic of Tell Brak.
Cylinder Seals of Third Millennium Syria (OBO,
Series Archaeologica 15), Universitätsverlag/
Vandenhoeck & Ruprecht, Freiburg Schweiz-
Göttingen 1997.
L A S T A T U A R I A R E G A L E
MATTHEWS 1 9 9 7 E
Matthews 2003
Matthews 2004
Matth iae 1974
Mat th iae 1975
Mat th i ae 1979
Mat th iae 1980a
Mat th iae 1980b
Mat th iae 1985
Mat th iae 1989a
Mat th iae 1989b
Mat th iae 1992
Mat th iae 1993
Mat th iae 1994
315
= D. MATTHEWS, The Early Dynastic-Akkadian Transition. Part I: When Did the Akkadian Period Begin?, «Iraq» 59 (1997), pp. 1-7. = R.J. Matthews (ed.), Excavations at Tell Brak, 4. Exploring an Upper Mesopotamian Regional Centre, 1994-1996 (McDonald Institute Mon-ographs), McDonald Institute for Archaeo-logical Researcli/BSAI, Cambridge-London 2003.
= R.J. Matthews, The Archaeology of Mesopo-tamia. Theories and Approaches (Approaching die Ancient World), Routledge, London-New York 2004. = P. Matth iae , A Fragment of a "Second Transi-tion Period" Statuette from Tell Mardikh, «BaM» 7 (1974), pp. 125-137. = P. Matth iae , Syrische Kunst, in Or thmum (ed.), Der Alite Orient, 1975, pp. 466-493. = P. Mat t lriae. Appunti di iconografia eblaita, I. Il turbante regale (?) eblaita di Mardikh IIB1, «SEb» 1 (1979), pp. 17-31. = P. Matth iae , Appunti di iconografia eblaita, E. La testa di Atareb, «SEb» 2, (1980), pp. 4137 . = P Mat th iae , About the Style of a Miniature Animal Sculpture from the Royal Palace G of Ebla, «SEb» 3 (1980), pp. 99-120. = P. Mat th iae , I tesori di Ebla, Laterza, Roma-Bari 19852.
= P. Matth iae , Ebla. Un impero ritrovato. Dai primi scavi alle ultime scoperte (Saggi 719), Ei-naudi, Torino 19892. = P. Matth iae , Masterpieces of Early and Old Syrian Art Discoveries of the 1988 Ebla Excava-tions in a Historical Perspective, «Proceedings of the British Academy» 75 (1989), pp. 25-56. = P. Matth iae , Figurative Themes and Literary Texts, in Fronzaro l i (ed.), Literature and Lit-erary Language at Ebla, 1992, pp. 217-241. = P. Matth iae , On this Side of the Euphrates. A Note on the Urban Origins in Inner Syria, in Fran-gipane et al. (edd.), Between the Rivers, 1993, pp. 523-530.
= P. Mat th iae , Il sovrano e l'opera. Arte e potere nella Mesopotamia antica (Grandi opere), La-terza, Roma-Bari 1994.
316 NICOLÒ MARCHETTI
MATTHIAS 1 9 9 5
Mat th i a e 1996
Ma t th i a e 1998
Mat th i ae 2000
Mat th i ae 2004
Mat th iae-Enea-Peyrone l -P innack 2000
Matth iae-van Loon-Weiss 1990
Mat th iae-Nigro-Peyrone l -Pinnock in stampa
Mat thia e -Pinnock-Scandone Mat th iae 1995
Mazzoni 1975
Mazzoni 1991
= P. MATTHIAE, Il Palalo Reale G: struttura e immagine dei centro del potere nel Periodo Protosi-riano, in Mat th i ae et al. (edd.), Ebla, 1995, pp. 104-111.
= P. Mat th i ae , L'arte degli assiri. Cultura e forma del rilievo storico (Storia e società), Laterza, Roma-Bari 1996.
= P. Mat th iae , Ees fortifications dÈbla paléo-syrienne: fouilles à Pell Mardikk (1995-1997), «CRALBL» (1998), pp. 557-588. = P. Ma t th i a e , Ea storia dell'arte dell'Oriente An-tico: gli stati territoriali 2100-1600 a.C.., Electa, Milano 2000.
= P. Mat t ine , LEPJ&SS MHEXCTITT.DTT 1A HÜB
E.4SSE DEBLA RUMOKEE+E KUUIB A THLM-FOKH (2002-2003), «CRAIBL» (2004), pp. 301-346. = P. Mat th i ae , A. Enea ,L . Peyronel , F. Pin-nock (edd.), Proceedings of the Eirst International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Rome, May 18'i-23ri 1998, Università di Roma «La Sapienza», Roma 2000. = P. Mat th i ae , M. van Loon, H. Weiss (edd.), Resurrecting the Past. A Joint Tribute to Adnan Bounni (PIHANS 67), Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, Leiden 1990.
= P. Mat th iae , L. Nigro, L. Peyrone l , F.
Pinnock (edd.), From Relative Chronology to Ab-
solute Chronology. The Second Millennium BC in
Syria-Palestine. Proceedings of the International Col-
loquium, Rome 29a November - 1" December 2001,
Accademia Nazionale dei Lincei/Università di
Roma «La Sapienza», Rome in stampa.
= P. Mat th iae , F. Pinnock, G. Standone
Mat th i ae (edd.), Ebla. Alle origini della civiltà
urbana. Trent'anni di scavi in Siria dell'Università
di Roma «La Sapienza», Electa, Milano 1995.
= S. Mazzoni, Sulle figurine eburnee del ".tesoro di
Ur" da Mari, «OA» 14 (1975), pp. 1-10.
= S. Mazzoni, Ebla e la formazione della cul-
tura urbana in Siria, «La Parola del Passato» 47
(1991), pp. 163-194.
LA STATUARIA REGALE 317
MAZZONI 1 9 9 2
Mazzoni 1995
McCown-Haines-Biggs 1978
de Mecquenem 1911 a
de Mecquenem 191 l b
de MecquenemCont enau-Pfist e i B e l a i ew 1943
Meijer 2002
Meis ter 2000
Mel l i nk -Porada -Qzgûç 1993
Meyer 1997
Meyer-Novak-Pruss 2001
Meyer-SormErfe i d in stampa
= S. MAZZONI, Le impronte su giara eblaite e si-
riane nei Bronco Antico (MSAE 1), Missione Ar-
cheologica Italiana in Siria, Roma 1992.
= S. Mazzoni , Le origini della città protosiriana,
Mat th i ae et al. (edd.), Ebla, 1995, pp. 96-103.
= D.E. McCown, E.C. Haines, R.D. Biggs,
Nippur, II. The North Temple and Sounding E.
Excavations of the Joint Expedition to Nippur of
The American Schools of Oriental Research and The
Oriental Institute of the University of Chicago (OIP
97), The Oriental Institute, Chicago 1978.
= R. de Mecquenerq Constructions e'lamites du
tell de l'Acropole de Suse, in Soutzo et al, Recher-
ches archéologiques, 1911, pp. 65-78.
= R. de Mecquenen) Vestiges de constructions
élamites, «RT» 23 (1911), pp. 38-55.
= R. de Mecquenerq G. Contenau , R.
Pf i s te r , N. Bel a iew. Mission de Susiane (MMAI
29), Presses Universitaires de France, Paris
1943.
= D.J.W Me i j e r , The Khafaje Sin Temple Se-
quence: Social Divisions at Work?, in al Gai l ani
W e r r et al. (edd.), Of Pots and Plans, 2002, pp.
218-226.
= M W Meister (ed.), Ethnography and Person-
hood. Notes from the Field, Rawat, Jaipur-New
Delhi 2000.
= M.J. Me l l i n k , E. Porada , T. Özgüc (edd.),
Aspects of Art and Iconography: Anatolia and Its
Neighbours. Studies in Honor of Nimet Ocguç,
Türk Tarili Kurumu, Ankara 1993.
= J.-W Meye r , Djebelet el-Beda: Eine Stätte der
Ahnenverehrung?, «AoF» 24 (1997), pp. 294-
309.
= J.-W Meyer , M. Novák, A. Pruss (edd.),
Beiträge cur Vorderasiatischen Archäologie Wilfried
Orthmann gewidmet; Johann W'olfgang Goethe-
Universität, Frankhirt am Main 2001.
= J.-W Meye r , W S o i m e r f e l d (edd.), 2000
v. Chr. — Politische, wirtschcftliche und gesellschaft-
liche Entwicklung im Zeichen einer Jahrtausendwende
(Colloquien der Deutschen Orient-Gesell-
schaft 3), Saarbrücken in stampa.
318
MICHALOWSKI 1 9 7 7
Micha 1 owski 1993
Micha lowski 2003
Mil one 1998
Mindl in-Gel 1 ei - Wansbrottgh 1987
Mit ten-Pedi ey-Scott 1971
Mol ina 1999-2000
Moon Ki l l i ck 1986
Moot e y 1966
Moot e y 1970
Moot e y 1977
Moot e y 1978
Moot e y 1979
Moot e y 1996
NICOLÒ MARCHETTI
= P. MiCHALOWSKI, Durum and Uruk During the Ur III Period, «Mesopotamia» 12 (1977), pp. 83-96. = P. Michalowski, On the Early Toponymy of Sumer: A Contribution to the Study of Early Meso-potamian Writing, in Rainey (ed.), kinattütu sa datati, 1993, pp. 119-135. = P. M c h a l owski, A Man Called Enmebaragesi, in Sal 1 a berget et al. (edd.), Literatur, Politik und Recht in Mesopotamien, 2003, pp. 195-208. = M.E. Mil one, Irikagina, figlio di Engisa, e'nsi di Lagos, «NABU» 106 (1998). = M. Mindl in, M.J. Ge l l e r , J .E . Wanshcough (edd.), Figurative Language in the Ancient Near East, School of Oriental and African Studies, London 1987.
= D.G. Mit ten , J.G. Pedley , J.A. Scott (edd.), Studies Presented to George MA. Hanf-mann (Fogg Art Museum, Harvard University Monographs in Art and Archaeology 2), von Zabern, Mainz am Rhein 1971. = M. Mol ina , Neo-Sumerian Letter-Orders in the British Museum. I, «AuOr» 17-18 (1999-2000), pp. 215-228.
= J. Moon Ki l l i ck , The Lower Diyala and the Hamrin Basin: Ceramic Relations during the Early Third Millennium, in Finkbeiner-Röll ig (edd.), GamdatNasr, 1986, pp. 112-119. = P.R.S. Moor ey, At Re-Consideration of the Ex-cavations on Tell Ingharra (East Kish), 1923-33, «Lraq» 28 (1966), pp. 18-51. = P.R.S. Moorey , Cemetery A at Kish: Grave Groups and Chronology, «Iraq» 32 (1970), pp. 86-128.
= P.R.S. Moorey, What Do We Know About the People Buried in the Royal Cemetery ?, «Expedi-tion» 20 (1977), pp. 24-40. = P.R.S. Moorey , Kish Excavations 1923-1933, Clarendon, Oxford 1978. = P.R.S. Moorey , Unpublished Early Dynastic Sealings from Ur in the British Museum, «Iraq» 41 (1979), pp. 105-120. = P.R.S. Moorey , A Stone Replica of an Early Dynastic III Royal Hairstyle?, in Gasche-Hrouda (edd.), Collectanea orientalia, 1996, pp. 227-238.
LA STATUARIA REGALE 319
MOOREY-GURNEY 1 9 7 8
Moor tga t 1935
Moor tga t 1940
Moor tga t 1945
Moor tga t 1949
Moor tga t 1965
Moor tga t 1967a
Moor tga t 1967b
Moor tga t 1968
Moor tga t -Moor tga t Correns 1974
Moor tga t Correns 1967
Moor tga t Correns 1972
M ü l l e r Kar pe 1993
= P.R.S. MOOREY, O . R . GURNHY, Ancient Near Eastern Seals Acquired by the Ashmolean Museum, Oxford 1963-1973, «Iraq» 40 (1978), pp. 41-60. = A. Moor t ga t , Frühe Bildkunst in Sumer (MVAG 40/3), Hinrichs, Leipzig 1935. = A. Moor t ga t , Vorderasiatische Rollsiegel. Ein Beitrag p/r Geschichte der Steinschneidekunst, Gebr. Mann, Berlin 1940.
= A. Moor tga t , Die Entstehung der sumerischen Elochkulti/r (Der Alte Orient 43), Hinrichs, Leipzig 1945.
= A. Moor t ga t , Tammup Der Unsterblich-keitsglaube in der altorientalischen Bildkunst; de Gruyter, Berlin 1949. = A. Moor tga t , Tell Chuëra in Nordost Syrien. Vorläufiger Bericht über die vierte Grabungskam-
pagne 1963 (Wissenschaftliche Abhandlungen der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 31), Westdeut-scher, Köln-Opladen 1965. = A. Moor tga t , Tell Chuëra in Nordost Syrien. Vorläufiger Bericht über die fünfte Grabungskam-
pagne 1964 (Schriften der Max Freiherr von Oppenheim-Stiftung 6), Harrassowitz, Wies-baden 1967.
= A. Moor tga t , Die Kr/nst des Alten Mesopota-mien. Die klassische Kunst Vorderasiens, DuMont Schauberg, Köln 1967. = A. Moor t ga t , Frühe kanaanäisch-sumerische Berührungen in Mari, «BaM» 4 (1968), pp. 221-231. = A. Moor t ga t , U. Moor tga t Correns, Ar-chäologische Bemerkr/ngen pt einem Schatzfund im Vorsargonischen Palast in Mari mit einer Tabelle der wichtigsten Vergleichsstucke, «Iraq» 36 (1974), pp. 155-167.
= U. Moor tga t Correns, Kleiner Männerkopf aus Eapislap/li, «ZA» 58 (1967), pp. 299-301. = U. Moor tga t Correns, Die Bildwerke von Djebelet el Beda in ihrer räumlichen und zeitlichen Umwelt, de Gruyter, Berlin-New York 1972. = M. Mü l l e r Kar pe, Metallgefäße im Iraq, L Von den Anfängen bis p/r Akkad-Zeit (PBF 11/14), Steiner, Stuttgart 1993.
320 NICOLÒ MARCHETTI
MUSCARKUA 1995
Musca re i 1 a 2000
a l Mut awnl 1 i-Migl us 2002
Nage l 1959a
Nage l 1959b
Nage l 1963
Nage l 1964
Nage l -S t romnenger 1995
Nassouhi 1926
Nel son 2000
Neumann 1998-2001
Nigro 1998
Nikol 'sk i j 1908
Nikol 'sk i j 1915
= O.W MUSCARELLA, Bapiar Archaeology, in Finkbeinet et al. (EDD.), Beiträge per Kulturge-schichte Vorderasiens, 1995, pp. 449-453. = O.W Musca r e l l a , TFELlEBBZ-MEGmin The Forgery of Ancient Near Eastern Cultures (Studies in the Art and Archaeology of Antiquity 1), Styx, Groningen 2000.
= N. al Mutawa l l i , P.A. Mig lus , Eine Statu-ette des Epa 'e, eines frühdynastischen Herrschers von Adah, «AoF» 29 (2002), pp. 3-11. = W N a g e l , Datierte Glyptik in frühdynastischer Zeit, «Or» 28 (1959), pp. 141-162. = W N a g e l , Die Statue eines neusumerischen Gottkönigs, «ZA» 53 (1959) , pp. 261-265. = W N a g e l , Datierte Glyptik aus Altvorderasien, «AfO» 20 (1963), pp. 125-140. = W Nage l , Frühdynastische Epochen in Meso-potamien, in Bit t e l et al. (edd.), Vorderasiatische Archäologe, 1964, pp. 178-215. = W N a g e l , E. S t romrenge r , Sechpig Jahre Forschung per frühdynastischen Bildkunst und ein neues Denkmal des Urdynastikums, in Finkbeiner et al. (EDD.), Beiträge per Kulturgeschichte Vordera-siens, 1995, pp. 455-468.
= E. Nassouhi, Sl-SUE d'un ELK' IE Al-M, LHff 2225 eX:J.-C., «AfO» 3 (1926), pp. 109-114. = R.S. Nel son (ed.), Visuality Before and Beyond the Renaissance, Cambridge University, Cam-bridge 2000.
= H. Neunami , Nammahani, «RIA» 9 (1998-2001), p. 135. = L. Nigro , The Two Steles of Sargon: Iconology and Visual Propaganda at the Beginning of Royal Akkadian Relief, «Iraq» 60 (1998), pp. 85-102. = M.V Nikol 'ski j , Dokumeniy chopajstvennoj oteetnosti drevnysej pochi Chaldei p sohranija N.P. Tichaceva (DV 3/2), Vostocnoj Komissii Impe-ratorskago Moskovskago Arclieologiceskago Obscestva, St. Petersburg 1908. = M.V Nikol 'ski j , Dokumeniy chopajstvennoj oteetnosti drevnysej epochi Chaldei p sohranija N.P. Tichaceva, II. Epocha dinastii Agade i ¡pocha di-nasta Ura (DV 5), Vostocnoj Komissii Impe-ratorskago Moskovskago Arclieologiceskago Obscestva, Moskva 1915.
LA STATUARIA REGALE 321
NISSEN 1 9 6 6
Nissen-Damer owUng l und 1993
Oates 1982
Oat e s- Oat e s-Mc Don a 1 d 2001
von Oppe nheim 1931
von Oppe nheim 1934
OithmLrm 1975
O i t hum m 1990
Owen 1975
Pagan 1998
Parrot 1935
Parrot 1940
Parrot 1948
Parrot 1952
= H J. NISSEN, Zur Datierung des Königsfriedhofes von Ur unter besonderer Berücksichtigung der Stra-tigraphie der Privatgräber (Beiträge zur ur- und frühgeschichtlichen Archäologie des Mittel-meer-Kulturraumes 3), Habelt, Borni 1966. = H.J. Nissen, P. Damerow, R.K. Englund, Archaic Bookkeeping. Early Writing and Techniques of Economic Administration in the Ancient Near East, University of Chicago, Chicago-London 1993.
= D. Oates, Excavations at Tell Brak, 1978-1981, «Iraq» 44 (1982), pp. 187-204. = D. Oates, J. Oates, H. McDona ld (edd.), Excavations at Tell Brak, 2. Nagar in the Third Millennium BC, McDonald Institute for Ar-chaeological Research/BSAI, Cambridge-London 2001.
= M. von Oppenlieiny Der Tell Halaf. Eine neue Kultur im ältesten Mesopotamien, Brockhaus, Leipzig 1931.
= M. von Oppenheinq Führer durch das Teil Halaf-Museum, Berlin, Franklinstr. 6, von Op-pertheim-Stiftung, Berlin 1934. = W Orthmann (ed.), Der Alte Orient (Pro-pyläen Kunstgeschichte 14), Propyläen, Berlin 1975.
= W Orthmaim, E'architecture religieuse de Teil Chuera, «Akkadica» 69 (1990), pp. 1-18. = D.I. Owen, The John Frederick Lewis Collection, I (MVN 3), Multigrafica, Roma 1975. = J.M. Pagan, A Morphological and Lexical Study of Personal Names in the Ebla Texts (ARES 3), Missione Archeologica Italiana in Siria, Roma 1998.
= A. Par ro t , Ees fouilles de Mari. Première campagne (Hiver 1933-34). Rapport préliminaire, «Syria» 16 (1935), pp. 1-28. = A. Par ro t , Ees fouilles de Mari. Sixième cam-
pagne (automne 1938), «Syria» 21 (1940), pp. 1-28.
= A. Parrot , Tello. Vingt Campagnes de fouilles (1877-1933), Albin Michel, Paris 1948. = A. Parrot , Statuaire mésopotamienne du dyna-stique archaïque, «Iraq» 14 (1952), pp. 73-75.
322
PARROT 1 9 5 3 A
Parrot 1953b
Parrot 1954
Parrot 1955a
Parrot 1955b
Parrot 1956
Parrot 1957
Parrot 1960
Parrot 1962
Parrot 1964
Parrot 1965
Parrot 1967
Parrot 1968
Parrot 1970
Parrot 1974
Parrot -Adheirar 1967
NICOLÒ MARCHETTI
= A. PARROT, Les fouilles de Mari. Huitième cam-pagne (Automne 1952), «Syria» 30 (1953), pp. 196-221. = A. Par ro t , Mari (Collection des ides pho-tographiques 7), Ides et calendes, Neûchatel-Paris 1953. = A. Parrot , Lesfouilles de Mari. Neuvième cam-pagne (Automne 1953), «Syria» 31 (1954), pp. 151-171. = A. Par ro t , Apropos de la "statue d'un homme de Mari", «Syria» 32 (1955), pp. 182-183. = A. Parrot , Les fouilles de Mari. Dixième cam-pagne (Automne 1954), «Syria» 32 (1955), pp. 185-211. = A. Par ro t , Le temple dlshtar (BAH 65; MAM 1), Geuthner, Paris 1956. = A. Par ro t , Acquisitions et inédits du musée du Louvre, «Syria» 34 (1957), pp. 223-231. = A. Parrot , Sumer (L'univers des formes), Gallimard, Paris 1960. = A. Parrot , Les fouilles de Mari. Douzième cam-pagne (Automne 1961), «Sytia» 39 (1962), pp. 151-179. = A. Parrot , Les fouilles de Mari. Treizième cam-pagne (Printemps 1963), «Syria» 41 (1964), pp. 3-20. = A. Par ro t , Les fouilles de Mari. Quinzième campagne (Printemps 1965), «Syria» 42 (1965), pp. 197-225. = A. Par ro t , Le temple dlshtarat et de Ninni-zpzp (BAH 86; M A M 3), Geuthner, Paris 1967. = A. Parrot , Le 'Trésor" dUr (BAH 87; MAM 4), Geuthner, Paris 1968. = A. Par ro t , Les fouilles de Mari. Dix-huitième campagne (automne 1969), «Syria.» 47 (1970), pp. 225-243. = A. Parrot , Mari, capitale fabuleuse (Biblio-thèque historique), Payot, Paris 1974. = A. Par ro t , H. Adhenar (edd.), Vingt ans d'acquisitions au Musée du Louvre, 1947-1967. Orangerie des Tuileries, Paris 16 décembre 1967-mars 1968, Ministère d'Etat Affaires Cultu-relles/Réunion des Musées Nationaux, Paris 1967.
LA STATUARIA REGALE
PASQUALI 2 0 0 2
Pasquali 2005
Pearce 1996
Pel t enburg 1991
Pelze l 1977
Pe t t ina to 1981
Pe t t ina to 1982
Pe t t ina to 2003
Pet t ina to-Waet zol dt 1974
Pinnock 1992
Pitt min 2001
Po l lock 1983
Po l lock 1985
Ponponio 1987
323
= J . PASQUALI, Materiati dell'artigianato eblaita. 2. sùr(HI<AT4J>ba-mim, "(argento) raffinato", «NABU» 108 (2003).
= J. Pasquali , Innovazione e continuità nel lessico dell'artigianato nella Siria del III millennio A.C., in Fronzarol i -Marrass ini (edd.), Proceedings of the 107 Meeting of Hamito-Semitic (Afroasiatic) Linguistics, 2005, pp. 267-299. = L.E. Pearce, The Number-Syllabary Texts, «JAOS» 116 (1996), pp. 453-474. = E. Pel tenburg, The Burrell Collection. Western Asiatic Antiquities, Edinburgh University, Edin-burgh 1991.
= S.M. Pel ze l , Dating the Early Dynastic Votive Plaques from Susa, «JNES» 36 (1977), pp. 1-15. = G. Pe t t ina to , Testi lessicali monolingui della biblioteca L 2769 (MEE 3), Istituto Universi-tario Orientale, Napoli 1981. = G. Pe t t ina to , Testi lessicali bilingui della biblio-teca L 2769 (MEE 4), Istituto Universitario Orientale, Napoli 1982.
= G. Pe t t ina to , I re di Sumer, I. Iscrizioni reali presargoniche della Mesopotamia (Testi del Vicino Oriente antico II/5), Paideia, Brescia 2003. = G. Pe t t ina to , H. Wae t zo ld t , 7 .ACcnmaSE SCHJIMELSL TESTI HNXOWCI TUIA m DEVML Ì n UR CH<SEESJ4II A. UTKL E HHLEIEERG (MVN 1), Multi-graiica, Roma 1974.
= F. Pinnock, Le "turban royal éblaïte", «NABU» 18 (1992).
= H. Pitt mm, Mesopotamian Intraregional Rela-tions Refected through Glyptic Evidence in the Late Chalcolithic 1-5 Periods, in Rothman (ed.), Uruk Mesopotamia and Its Neighbors, 2001, pp. 403-443. = S.M. Po l lock , The Symbolism of Prestige: An Archaeological Example from the Royal Cemetery of Ur (PhD diss., University of Michigan), UM3, Ami Arbor 1983.
= SAL Pol 1 ock, Chronology of the Royal Cemetery of Ur, «Iraq» 47 (1985), pp. 129-158. = F. Pomponio, Lé PK£CP0Œ.FA EH THE PEHLLR:
aj-ia n E-E.4 (StSem NS 3), Università «La Sa-pienza», Roma 1987.
324 NICOLÒ MARCHETTI
Pomponio 1989
POMPONIO 1 9 9 0
Pomponio 1994
POMPONIO-VISICATO 1 9 9 4
Potrponio-Xel 1 a 1997
Poi a da 1965
Poi a da 1991
Poi a da 1993
Poi a da 1995
Porada-Hansen-Dur ihamBabcock 1992
Por t e r 2002
Post ga t e 1973
Po t t i e r 1912
Po t t i e r -de Morgan-de Mecquenem 1912
= F. Pomponio, L.4 KUSE n Lasg, <(RSO» 63 (1989), PP. 25-37.
= F. POMPONIO, Fosmue h al imzia-E leía Me SŒŒS.1L4 PSEtlAISCi (Testi del Vicino Oriente antico H/1), Paideia, Brescia 1990. = F. Pomponio, RF di Uruk, "re dì Kis", <«RSO»
68 (1994), PP. 1-14.
= F. POMPONIO, G . VISICATO, Early Dynastic Administrative Tablets from Suruppak, Istituto Universitario Orientale, Napoli . = F. Ponponio, P. X e l l a , Tes dieux dEbla. Etudes analytique des divinités éblaïtes à l'époque des archives royales du lile millénaire (AOAT 245), Ugarit, Münster 1997.
= E. Por ada, The Relative Chronology of Mesopo-tamia. Part I. Seals and Trade (6000-1600 B.C.), in Ehrich (ed.), Chronologies in Old World Ar-chaeology, 1965, pp. 133-200. = E. Porada , Recensione di Mar t i n 1988 e Ka rg 1984, «AJA» 95 (1991), pp. 170-173. = E. Porada , Seals and Related Objects from Early Mesopotamia and Iran, in Curt i s (ed.), Early Mesopotamia and Iran, 1993, pp. 44-53. = E. Porada , Man and Images in the Ancient Near East (Anshen Transdisciplinary Lecture-ships in Art, Science and die Philosophy of Culture 4), Mover Bell, Wakefield-Loudon 1995.
= E. Porada , D.P. Hansen, S. Dunharq S.H. Babcock, The Chronology of Mesopotamia, ca. 7000-1600 b.c., EM EHRICH (ED.), Chronologies in Old World Archaeology, 1992, pp. 77-121. = A. P o r t e r , The Dynamics of Death: Ancestors, Pastoralism and the Origins of a Third Millennium City in Syria, «BASOR» 325 (2002), pp. 1-36. = J.N. POSTGATE, Old Sumerian GE,= as?, <AfO» 24 (1973), p. 77.
= E. Po t t i e r , Etude historique et chronologique sur les vases peints de l'Acropole de Suse, in Po t t i e r et al, Recherches archéologiques, 1912, pp. 27-103. = E. Po t t i e r , J. de Morgan , R. de Mec-quenerq Recherches archéologiques, cinquième série. Céramique peinte de Suse et petits monuments de l'époque archaïque (MDP 13), Leroux, Paris 1912.
L A S T A T U A R I A R E G A L E
POTTS-RQAF-STEIN 2 0 0 3
Powell 1978
Powel l 1996
P ie eli el 1996
Pruss 2000
Rainey 1993
Rashid 1983
Reade 2000a
Reade 2000b
Reade 2000c
Reade 2001
Reade 2002
Reichel 2003
Reiner 1974
Reiner 1995
325
= T . POTTS, M . ROAF, D . STEIN (EDD.), Cul-
ture through Objects. Ancient Near Eastern Studies in Honour of PR.J? Moorey, Griffith Institute, Oxford 2003. = M.A. Powel l , Texts from the Time of Eugal-Zpgesi: Problems and Perspectives in Their Interpreta-tion, «HUCA» 49 (1978), pp. 1-58. = M.A. Powel 1, The Sin of Eugalzpgesi, «WZKM» 86 (1996), pp. 307-314. = D. Pr echel , DmGom«Ishara. Ein Beitrag zur altorientalischen Religionsgeschichte, Ugaxit, Mün-ster 1996. = A. Pruss, Recent Excavations at Tell Chuera and the Chronology of the Site, in Mat th iae et al. (edd.), Proceedings of the First International Con-fess, 2000, pp. 1431-1446. = A.F. Rainey (ed.), kinattütu sa däräti. Ra-
phael Kutscher Memorial Volume, Institute of Archaeology of Tel Aviv University, Tel Aviv 1993.
= S.A. Rasliid, Gründungsfiguren im Iraq (PBF 1/2), Beck, München 1983. = J.E. Reade, Early Carvings from the Mocatta, Blau, and Herfeld Collections, «NABU» 71 (2000).
= J.E. Reade, The Holy Grail, «NABU» 72 (2000).
= JE. Reade, Early Dynastic Statues in the British Museum, «NABU» 73 (2000). = J.E. Reade, Assyrian King-Eists, the Royal Tombs of Ur, and Indus Origins, «JNES» 60 (2001), pp. 1-29.
= J.E. Reade, Early Monuments in Gulf Stone at the British Museum, with Observations on Some Gudea Statues and the Location of Agade, «ZA» 92 (2002), pp. 258-295. = C. Reichel , Diyala Project, in Stein (ed.), The Oriental Institute 2002-2003 Annual Report, 2003, pp. 44-50. = E. Reiner , The Senes HAR.-ra = hubullu: Tablets XX-XXTV (MSL 11), Pontificium Institution Biblioim, Roma 1974. = E. Reiner, Astral Magic in Babylonia (TAPS 85/4), American Philosophical Society, Phila-delphia 1995.
326
RIDLEY 2000
Roaf 2000
Roaf-Zgol 1 2001
Roberts 1972
Roth 1995
Rothiran 2001
Rouan l tMase t t i Rouault 1993
ROWTON 1970
R m r a i d h 2 0 0 0
Russell 1991
Safar 1971
Saggs1995
Sa l l aberger 1993a
Sa l l aberger 1993b
NICOLÒ MARCHETTI
= R.T. RIDLEY', The Saga of an Epic: Gilgamesh and the Constitution of Uruk, «Or» 69 (2000), pp. 341 -367 .
= M. Roaf, Survivals and Revivals in the Art of Ancient Mesopotamia, in Mat th iae et al. (edd.), Proceedings of the First International Congress, 2000 , pp. 1447 - 1462 .
= M. Roaf, A. Zgo l l , Assyrian Astroglyphs: Ford Aberdeen's Black Stone and the Prisms of Esarhaddon, «ZA» 91 (2001), pp. 264-295. = J.J.M. Roberts, TeeEdUSrSBHECfi-fffiEK A SlLTX'CF 3EESatlUCDHTIB AUSHJINMESCPO-T-MLA BHŒE UR III, Jolins Hopkins University, Baltimore-London 1972. = M.T. Roth, EAF Camniaz BCM MHŒŒ-R1L4 L B ASA MIRer (Writings from the Ancient World 6), Scholars, Atlanta 1995. = M.S. Rothmui (ed.), Uruk Mesopotamia and Its Neighbors. Cross-Cultural Interactions in the Era of State Formation, School of American Re-search /Currey, Santa Fe-Oxford 2001. = O. Rouault , M.G. Maset t i Rouault (edd.), E Eufrate e il tempo. Ee civiltà del Medio Eufrate e della Gerirà siriana, Electa, Milano 1993. = M.B. ROWTON, Chronology II. Ancient Western Asia, «CAH» 1/1, pp. 193-239. = S.S. Ruimidh, Excavations in Chokha, an Early Dynastic Settlement (Edubba 8), NABU, London 2000.
= J.M. Russel l , Sennacherib's Palace without Rival at Nineveh, University of Chicago, Chicago 1991.
= F. Safar , A Stela from Badre, «Sumer» 27 (1971), pp. 15*-24* (in arabo). = H.WF. Saggs, Babylonians (Peoples of die Past), Die Trustees of the British Museum, London 1995.
= W Sa l l aberger , Die kultische Kalender der Ur M Zeit, 1 (UAVA 7/1), de Gruyter, Berlin 1993.
= W Sa l l aberger , Die kultische Kalender der Ur Iii-Zeit, 2 (UAVA 7/2), de Gruyter, Berlin 1993.
L A S T A T U A R I A R E G A L E
SALLABERGER I 9 9 6 A
Sa l l aberger 1996b
Sa l l aberger 1998
Sa l l aberger 1999
Sa l l aberger 2002
Sa l l aberger 2003
Sa l l aberger 2004
Sa l l aberger in stampa
Sa l l aberger -C iv i l 1996
Sa l l aberger - Vo ik -Zgo l l 2003
Sa l l aberger - Westenholz 1999
de Sarzec-Heuzey 1884-1912
Sativage 1998
327
= W SALLABERGER, Sign List: Paleography and Syllabary, in Isrrail et al., Administrative Docu-ments, 1996, pp. 33-67. = W Sa l l aberger , Grain Accounts: Personnel Lists and Expenditure Documents, in Ismail et al., Administrative Documents, 1996 pp. 89-106. = W Sa l laberger , Ein Synchronismus der Urkunden von Tell Beydar mit Mari und Ebla?, in Lebeau (ed.), About Subartu, 2, 1998, pp. 23-39. = W Sa l l aberger , Recensione di Sonne r i e l d 1999, «BiOr» 57 (1999), coll. 112-118. = W Sa l l aberger , Den Gottern nähe — undfern den Menschen? Formen der Sakralität des altmesopo-tamischen Herrschers, in Erkens (ed.), Die Sakra-lität von Herrschaß, 2002, pp. 85-98. = W Sa l l aberger , Nachrichten an den Palast von Ebla. Eine Deutung von ntgmul-(an), in AA.VV, Semitic and Assyriological Studies Presented to Polio Franganoli, 2003, pp. 600-625. = W Sa l l aberger , Palast. A. I. Mesopotamien im HL Jahrtausend, «RIA» 10/3-4 (2004), pp. 200-204.
= W Sa l laberger , Relative Chronologie von der späten frühdynastischen bis gur altbabylonischen Zeit, in Meyer-Sonnerfe ld (edd), 2000 t: Chr., in stampa. = W Sa l l abe rge r , M. Civil, Der babylonische Töpfer und seine Gefäße nach Urkunden altsume-rischer bis altbabylonischer Zeit sowie lexikalischen und literarischen Zeugnissen / HAR-ra = hubullu: Tablet X dug = karpatu (MHEM 3), University of Ghent, Ghent 1996. = W Sa l l aberger , K. Volk , A. Zgo l l (edd.), Eiteratur, Politik und Recht in Mesopotamien. Fest-schrift fur Claus Wilcke, Harrassowitz, Wies-baden 2003. = W Sa l l aberger , A. Westenholz , Meso-
potamien. Akkade-Zeit und Ur-III-Zeit (OBO 160/3), Universitätsvedag / Vandenlioeck St: Ruprecht, Freiburg Schweiz-Göttingen 1999. = E. de Sarzec, L. Heuzey, Découvertes en Chaldée, Leroux, Paris 1884-1912. = M. Sauvage, Ea brique et sa mise en œuvre en Mésopotamie des origines à l'époque achéménide, ERC, Paris 1998.
328 NICOLÒ MARCHETTI
SCANDONE MATTHIAE 1979
Scandone Ma t th i a e 1995
Schaudig 2003
Sclieil 1925
SCHMANDT BESSERAT 1 9 9 3
Sd i r et t er 1990
Schtiol 2000
Schwa r t z-Curve r s-Dunha mSt ira11 2003
Se fa t i-Art zi-Cohen-Eie hi er-
Horowitz 2005
Se lz 1983
SEIZ 1989
Se l z 1990
= G . SCANDONE MATTHIAE, Vasi iscritti di Chefren e Pepi I nei Palalo Reale G di Ebla, « S E B »
1 (1979), pp. 33-43.
= G. Scandone Mat th i ae , Ebla, la Siria e l'Egitto nel Bronco Antico e Medio, in Ma t th i a e et al. (edd.), Ebla, 1995, pp. 234-241. = H. Schaudig, Nabonid, der 'Archäologe auf dem Königsthron ". Rum Gesichtsbild des ausgehenden neu-babylonischen Reiches, in Gebhard Sel z (ed.), R¡t-schrift für Burkhart Kienast, 2003, pp. 447M97. = V Schei l , Quelques particularités du sumérien en Elam, «RA» 22 (1925), PP. 45-53. = D . SCHMANDT BESSERAT, Images of Enship, in Frangipane et al. (edd.), Betneen the Rivers, 1993, pp. 201-219.
= M.K. Schre t t e r , BliHUdTLOEi SPBAH ¡TD ErmELWSCHOmtm Ucl!öSlZHEtE\ZLESXEv'tE3E\ FRÎN-EPR-CEECE SutitmSŒE^ Institut für Spracli-wissenschaft der Universität Innsbruck, Inns-bruck 1990.
= M. Scl iuol , Die Charakene: Ein mesqpotamisches Königeich in helknistisch-parthischer Zeit (Oriens et Occidens 1), Steiner, Stuttgart 2000. = G. Schwartz, H.H. Curvers, S. Dunham, B. S tuar t , A Third-Millennium B.C. Elite Tomb and Other New Evidence from Tell Umm el-Marra, Syria, «AJA» 107 (2003), pp. 325-361.
= Y Sefat i , P. Art zi, C. Cohen, B.L. Eich ler , V A . Horowitz (edd.), ÍÍÍZM Expmsm) S<BEE WHD NESSES NŒHN3'. ANJEIT NEU EIWHSN Slum IN Herat œ J-tm Km:-; CDL, Bethesda 2005. = Gudrun Selz , Die Bankettszene. Entwicklung eines "überzeitliches" Bildmotifs in Mesopotamien von der frühdynastischen bis zurAkkad~zeit (FAOS 11), Steiner, Wiesbaden 1983.
= GEBHARD J. SELZ,Altsumerische Verwaltungtexte aus Lagos, 1. Die altsumerischen Wirtschaßsurkunden derEremitage zp Leningrad (FAOS 15/1), Steiner, Stuttgart 1989. = Gebhard J. Sei z, Studies in Early Synchretism: The Development of the Pantheon in Lagos. Ex-amples for Inner-Sumerian Synchretism, «ASJ» 12 (1990), pp. 111-142.
LA STATUARIA REGALE
SELZ 1992
Se lz 1993
Se lz 1995
Se lz 1997
Se lz 1998
Se lz 2003a
Se lz 2003b
Sieve r t sen 1992
S ig i ist 1995
S jöbe rg 1973
SJÖBERG 1996
von Soden-Mayer 1995
329
= GEBHARD J. SELZ, Eine Kultstatue der Herr-sehergemahlin Sosa: Ein Beitrag giim Problem der Vergöttlichung «ASJ» 14 (1992), pp. 245-268. = Gebhard J. Se lz , Altsumerische Verwaltungs-texte aus Eagas, 2. Altsumerische Wirtschaftsur-hunden aus amerikanischen Sammlungen (FAOS 15/2), Steiner, Stuttgart 1993. = Gebhard J. Se lz , Untersuchungen gur Göt-terwelt des altsumerischen Stadtstaates von Eagas (OPKF 13), The Samuel Noah Kramer Fund, Philadelphia 1995.
= Gebhard J. Se lz , "The Holy Drum, the Spear, and the Harp". Towards an Understanding of the Problems of Deification in Third Millennium Me-sopotamia; in Finkel -Gel 1 ei (edd.), Sumerian Gods, 1997, pp. 167-213.
= Gebhard J. Se lz , Uber mesopotamische Herr-schiftskonyetde. Zu den Ursprüngen mesopotamischer Herrscherideologie im 3. Jahrtausend, in Dietr ich-L o r e t z (edd.), dubsar anta-men, 1998, pp. 281 344.
= Gebhard J. Se l z (eAl), Festschrift für Burkhart Kienast <yu seinem 70. Geburtstage dargebracht von Freunden, Schülern und Kollegen (AOAT 274), Ugarit, Münster 2003.
= Gebhard J. Se lz , Who is Who? Aka, König von (fiis(s)a: zur Historizität eines Königs und seiner möglichen Identität mit Aka, König von Kis(i), in Gebhard Se l z (ed.), Festschrift für Burkhart Kienast, 2003, pp. 499-518. = U. Sievertsen, Das Messer vom Gehel al-Arak, «BaM» 23 (1992), pp. 1-75. = M. Sigr ist , Neo-Sumerian Texts from the Royal Ontario Museum, 1. The Administration at Drehern, CDL, Bethesda 1995.
= Á.W Sjöberg, Miscellaneous Sumerian Hymns, «ZA» 63 (1973), PP. 1-55. = Ä . W SJÖBERG, U E T VII , 73: AN Exhuse T-BIETENUMm-mtC Pucmsiass, ill Tuuca-Dehe-se l l e (edd.), Tablettes et images aux pays de Sumer et dAkkad, 1996, pp. 117-137. = W von Soden, W.R. Mayer , Grundriss der akkadischen Grammatik (AnOr 33), Pontificio Istituto Biblico, Roma 1995/
330 NICOLÒ MARCHETTI
VAN SOLDT 2001
Sol l berger 1956
Sol l berger 1959
Sol l berger 1965
Sol l berger 1966
Sol l berger 1972
So l l berger-Kupper 1971
Sommerfeld 1999
Soutzo-Pézard-Bondoux-de Mecquenem Pézard-Gautier-To scanne 1911
Spycket 1981
Spycket 1992
Steible 1982a
Steible 1982b
Ste iUe 1991a
Ste iUe 1991b
= W VAN SOLDT, Stone Objects, in van Loon (ed.), Selenhahiye, 2001, pp. 447-477. = E. So l lberger , Corpus des inscriptions ''royales" présargoniques de Tapas, Droz, Genève 1956. = E. So l lberger , Sumerica, «ZA» 53 (1959), pp. 1-8. = E. So l lberger , Royal Inscriptions, II (UET 8), Hie Trustees of the British Museum and of die University Museum of die University7
of Pennsylvania, London-Philadelphia 1965. = E. So l lberger , Business and Administrative Correspondence under the Kings of Ur (TCS 1), Augustin, Locust Valley 1966. = E. So l lberger , Pre-Sargonic and Sargonic Economic Texts (CT 50), The Trustees of die British Museum, London 1972. = E. So l lberger , J.-R. Küpper, Inscriptions royales sumériennes et akkadiennes, Cerf, Pads 1971.
= W Sommerfeld, Die Texte der Akkade-Zeit, 1. Das Dijala-Gebiet Tutub (IMGULA 3/1), Rhema, Münster 1999.
= M.C. Soutzo, G. Pézard, G. Bondoux, R. de Mecqueneiq M. Pézard, J.-E. Gautier , P. Toscanne, Recherches archéologiques, quatrième série (MDP 12), Leroux, Pads 1911. = A. Spycket, Ta statuaire du Proche-Orient an-rien (HdO 7/1/2/B/2), Brill, Leiden-Köln 1981. = A. Spycket, Tes figurines de Suse, L Tes figu-rines humaines IV-IT millénaires av. J. -C. (MDAI 52), Gab aida, Pads 1992. = H. Steible, Die altsumerischen Bau- und Wei-hinschriften, L Inschriften aus "Tagas" (FAOS 5/1), Steiner, Wiesbaden 1982. = H. Steible, Die altsumerischen Bau- und Wei-hinschriften, II. Kommentar pi den Inschriften aus "Tagas", Inschriften ausserhalb von "Tagas" (FAOS 5/2), Steiner, Wiesbaden 1982. = H. SteiUe, Die neusumerischen Bau- und Wei-hinschrften, 1. Inschrften der IL Dynastie von Tagas (FAOS 9/1), Steiner, Stuttgart 1991. = H. SteiUe, Die neusumerischen Bau- und Wei-hinschrifien, 2. Kommentar pt den Gudea-Statuen, In-
LA STATUARIA REGALE
Steit l e-Yildiz 1993
Stein 2003
Ste inke l ler 1977
Ste inke l ler 1984a
Ste inke l ler 1984b
Ste inke l ler 1984c
Ste inke l ler 1986
Ste inke l ler 1987
STEINKELLER 1 9 8 9
Ste inke l ler 1992a
Ste inke l ler 1992b
Ste inke l ler 1993a
Ste inke l ler 1993b
S te inke l l e r 1995
S te inke l l e r 1998
331
Schriften der IH. Dynastie von Ur, Inschriften der IV. und 'V." Dynastie von Uruk, Varia (FAOS 9/2), Steiner, Stuttgart 1991. = H. Steihle, E Yildtz, Ki'engi aus der Sicht von Suruppak: Eine frühdinastische Regio nach Fam-neii-lichen Urkunden, «LstM» 43 (1993), pp. 17-26. = G.J. Stein (ed.), The Orientai Institute 2002-2003 Annual Report, The Oriental Institute, Chicago 2003. = P. S te inke l le r , Seal Practice in the Ur III Pe-riod, in Gibson-Biggs (edd.), Seals and Sealing 1977, pp. 41-53. = P. S te inke l le r , TheEhhitePreposition qidimay "Before", «QA» 23 (1984), pp. 33-37. = P. St einkel 1 er, Old Akkadian Miscellanea, «RA» 78 (1984), pp. 83-88. = P. Ste inkel ler , The Sumerian Verb lug (LUE), «SEL» 1 (1984), pp. 1-17.
= P. Ste inkel ler , Seal of Isma-ilum, Son of the Governor of Matar, «VQ» 6 (1986), pp. 27-40. = P. S te inke l le r , Recensione di B.R. Foster, Umma in the Sargonk Period, Arclion, Hamden 1982, «WZKM» 77 (1987), PP. 182-195. = P. STEINKELLER, Sale Documents of the U r f f i -Period (FAOS 17), Steiner, Stuttgart 1989. = P. St einkel 1 er, Third-Millennium Eegal and Administrative Texts in the Iraq Museum, Baghdad, Eisenbrauns, Winona Lake 1992. = P. S te inke l le r , Mesopotamia in the Third Mill-ennium B.C., in D.N. Freedrran et al. (edd.), The Anchor Bible Dictionary, 4, Doubleday, New York-London-Toronto-Sydney-Auckland 1992, pp. 724-732.
= P. S te inke l le r , Early Political Development in Mesopotamia and the Origin of the Sargonk Empire, in Liverani ( e d f t A h k a d , 1993, pp. 107-129. = P. S te inke l le r , Observations on the Sumerian Personal Names in Ebla Sources and on the Onomas-ticon of Mari and Kish, in Cohen et al. (EDD.), The Tablet and the Scroll, 1993, pp. 236-245. = P. S te inke l l e r , A RMSAXHE) AKKPELW Cm?, «ASJ» 17 (1995), pp. 275-281. = P. S t e inke l l e r , Inanna's Archaic Symbol, IN BRAUN et al. (edd.), Written on Clay and Stone, 1998, pp. 87-100.
332
STEINKELLER 1999
St ei i ikel l er 2002a
S te inke l l e r 2002b
S te inke l l e r 2003a
S te inke l l e r 2003b
S te inke l l e r 2004a
S te inke l l e r 2004b
Stephens 1937
St reck 2000
Streck-Weninger 2002
Stromrenger 1959
Stromrenger I960
Stromrenger 1971
S t romrenger -Himer 1962
NICOLÒ MARCHETTI
= P. STEINKELLER, O» Rulen, Priests and Sacred Marriage: Tracing the Evolution of Early Sumerian Kingship, in Wat ana be (ed.), Priests and Officials, 1999, pp. 103-137. = P. S te inke l l e r , Archaic City Seals and the Question of Early Babylonian Unity, in Abnsch (ed.), Riches Hidden in Secret Places, 2002, pp. 249-257. = P. S te inke l l e r , More on the Archaic City Seals, «NABU» 30 (2002). = P. S te inke l l e r , The Question of Eugalzpgesi's Origins, in Gebhard Se lz (ed.), Festschrift für Burkhart Kienast, 2003, pp. 621-637. = P. S t e inke l l e r , An Ur III Manuscript of the Sumerian KingTist, in Sa l l aberger et al. (edd.), Literatur, Politik und Recht in Mesopotamien, 2003, pp. 267-292. = P. S t e inke l l e r , On the Writing of behim in Sargonic and Earlier Sources, «NABU» 17 (2004). = P. S te inke l l e r , Studies in Third Millennium Paleography, 4: Sign Us, «ZA» 94 (2004), pp. 175-185. = F.J. St ephens, Votive and Historical Texts from Babylonia and Assyria (YOS 9), Yale Univer-sity/ Oxford University; New Haven-Oxford 1937. = AI.P. St reck , Dos amurritische Onomastihon der altbabylonischen Zeit, 1. Die Amurriter, die ono-mastische Forschung, Orthographie und Phonologie, Nominalmorphologe (AOAT 271/1), Ugaht, Münster 2000. = M P Streck , S. Weninger (edd.). Altorien-talische und semitische Onomastik (AOAT 296), Ugarit, Aliinster 2002. = E. S t romrenger , Statueninschriften und ihr Datierungswert, «ZA» 53 (1959), pp. 27-50. = E. S t romrenger , Das Menschenbild in der alt-mesopotamischen Rundplastik von Mesilim Ins Harn-murapi, «BaM» 1 (1960), pp. 1-103. = E. Stromrenger , Mesopotamische Gewand-typen von der Fruhsumerischen bis yiir Larsa-Zeit, «APA» 2 (1971), pp. 37-55. = E. S t ronnenger , M. Hirner , Fünf Jahrtau-sende Mesopotamien. Die Kamst von den Anfängen
LA STATUARIA REGALE
Struve 1984
Sturenhagen 1999
Sturenhagen 2002
Szarzyáska 1997
Taha 1970
Tal lqv is t 1938
Teissier 1993
Thal im nn 2003
Thureau Dangin 1903
Thureau Dangin 1907
Thureau Dangin 1934
Toniet t i 1998
333
um 5000 v.Chr. his gu Alexander dem Großen, Hirmer, München 1962.
= V.V Struve, Onomastika rannedinasticeskogo Lagosa, Nauka, Moskva 1984. = D. Sturenhagen, Untersuchungen gur relativen Chronologie Babyloniens und angrengender Gebiete von der ausgehenden ' Ubaidgeit bis gum Beginn der
frühdynastisch Ii-Zeit 1. Studien gur Chronostrati-graphie des südbabylonischen Stadtruinen von Uruk und Ur (HSAO 8), Heidelberger Orientvedag, Heidelberg 1999.
= D. Sturenhagen, Death in Mesopotamia: The Royal Tombs' of Ur Revisited, in al Gai lan i Werr et al. (EDD.), Of Pots and Plans, 2002, pp. 324-338.
= K. Szarzyiiska, Sumerico. Prace sumerognawcge (Philologia Orientali s 3), Dialog, Wars z ava 1997. = M.Y Taha, Sumerian Statues from Tell Ma'tuq, «Sumei» 26 (1970), pp. 101+108+ (in arabo). = K.L. Tal 1 qvist, Akkaehscbe Götterepitheta, mit einem Göttervergeichnis und einer Uste der Prädika-tiven Elemente der sumerischen Götternamen (StOr 7), Societas Odentalis Fennica, Helsingforsiae 1938.
= B. Teissier, ÜERläER.WTMTEEPBIHD Of> j W OWB. IdEECMfi'CNGlWHCmtM KÜJB'EIN 1HE KFD - SBH'-U Mnmmxi B.C., in Mei l i nk et al. (edd.), Aspects of Art and Iconography, 1993, pp. 6 0 1 - 6 1 2 .
= J.-R Thal nana , Earsa 1987¡ 1989: le bâtiment B 33, in Huot (ed.), Earsa, 2003, pp. 35-139. = F. Thür earn Dangin, Recueil de tablettes chaldéennes, Leroux, Paris 1903. = F. Thureau Dangin, Die sumerischen undak-kadischen Königsinschriften (Vorderasiatische Bi-bliothek I/l ) , Hinrichs, Leipzig 1907. = F. Thureau Dangin, Inscriptions votives sur da statuettes de Ma'eri, «RA» 31 (1934), pp. 137-144.
= M.V Toniet t i , The Mobility of the NAR and the Sumerian Personal Names in Pre-Sargonic Mari Onomasticon, in Lebeau (ed.), About Suhartu, 2,
1998 , pp. 8 3 - 1 0 1 .
334 NICOLÒ MARCHETTI
TONTETTE 2003
van de i T o o i n 1997
To scanne 1908
Tunca 1984
Tunca 2004
Tunca-Dehese l l e 1996
Unger 1926
V a l i et 2001
VANSTIPHOUT 1 9 7 0
Veldhuis 2004
Vis icato 1989
Vis icato 2000
W a e t z o l d t 2005
W a l k e r - C o l l o n 1980
= M.V ToNIETn, É = bltum or = 'a? About
Eu in Early Dynastic Sources, in AA.VY, Semitic
and Assyriologcal Studies Presented to Pelio Fro/ipá-
roli, 2003, pp. 666-679.
= K. van der Toorn (ed.), The Image and the
Book, Iconic Cults, Aniconism, and the Rise of
Book Religion in Israel and the Ancient Near East
(Biblical Exegesis & Theology 21), Peeters,
Leuven 1997.
= O. Toscanne, Textes divers babyloniens, «RT»
30 (1908), pp. 121-136.
= O. Tunca, E'architecture religieuse protodyna-
stique en Mesopotamie (Akkadica Supplementum
II), Peeters, Leuven 1984.
= O. Tunca, A propos d'une figure de la plaque
perforée dVr-Nanse (Urn. 20): fille (femme, fils ou
devin?, «NABU» 22 (2004).
= O. Tunca, D. Dehese l l e (edd.), Tablettes et
images aux pays de Sumer et d'Akkad. Mélanges of-
ferts à Monsieur H. Timet, Université de Liège,
Liège 1996.
= E. Unge r , Sumerische und akkadische Kunst
(Jedermanns Bücherei), Hirt, Breslau 1926.
= R. V a l i e t , Khafadjé ou les métamorphoses d'un
quartier urbain au IIP millénaire, in Bren iquet -
Kepinski (edd.), Etudes mésopotamiennes, 2001,
pp. 449-461.
= H.L J. VANSTIPHOUT, Political Ideology in Early
Sumer, «OLP» 2, (1970), pp. 7-38.
= N. Veldhuis , Religion, Eiterature, and Scholar-
ship. The Sumerian Composition "Nana and the
Birds" (CM 22), Brill/Styx, Leiden 2004.
= G. Vis icato , Fara ed Ebla. Nuove prospettive
storico-politiche nel periodo protodinastico, «QA» 28
(1989), pp. 169-176.
= G. Vis icato, The Power and the Writing. The
Early Scribes of Mesopotamia, CDL, Bethesda
2000.
= H. W a e t z o l d t , Tempelterrassen und Ziqqur-
rate nach der Sumerischen Überlieferung, in Sefa t i
et al. (edd.), Î U E x i m t Œ ) SŒEE WH) Neglects
Nothing", 2005, pp. 322-342.
= C.B.F. W a l k e r , D. C o l l o n , HormuZd Ras-
sam's Excavations for the British Museum at Sippar
LA STATUARIA REGALE 335
Wal ker Dick 2001
Wataoabe 1999
Wat eliti 1929
Wat el iii-La tig don 1934
Weiss 1986
Weiss 1990
Westenholz 1975a
Westenholz 1975b
Westenholz 1978
Westenholz 1987
in 1881-1882, in De Meyer (ed.), Tell ed-Dër IH, 1980, pp. 93-114.
= C.B.F. Walker , M. Dick, The Induction of the Cult Image in Ancient Mesopotamia. The Mesopo-tamian Mis PÎ Ritual. Transliteration, Translation and Commentary (SAAL 1), The Neo-Assyriati Text Corpus Project, Helsinki 2001. = K. Watanabe (ed.), Priests and Officials in the Ancient Near East. Papers of the Second Col-loquium on the Ancient Near East — The City and Its Ufe, Held at the Middle Eastern Culture Center in Japan (Mitaka, Tokyo), March 22-24, 1996, Winter, Heidelberg 1999. = L.C. Wate l in , Rapport sur les fouilles de Kish, «JA> 215 (1929), pp. 103-116. = DC. Wate l in , S. Langdon, Excavations at Kish. The Herbert Weld and Field Museum of Natural History Expedition to Mesopotamia, IV, Geuthner, Paris 1934.
= H. Weiss (ed.), The Origins of Cities in Dry-farming Syria and Mesopotamia in the Third Millen-nium B.C., Four Quarters, Guilford 1986. = H. Weiss, "Civi l izing" the Khabur Plains: Mid-Third Millennium State Formation at Tell Eeilan, in Matth iae et al. (edd.), Resurrecting the Past, 1990, pp. 387H07.
= A. Westenholz, Early Cuneiform Texts in Jena. Pre-Sargonic and Sargonic Documents from Nippur and Fara in the Hilprecht-Sammlung vorderasiatischer Altertümer Institut für Alter-tumswissenschaften der Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Munksgaard, Kobenliavn 1975. = A. Westenholz, OlDSUMm,EUEDOlDAKlLA iMsr TBŒ INPHLEHPHU (HFFIRACM NIPPUR, 1. Uterary and Uxical Texts and the Earliest Admin-istrative Documents from Nippur (BiMes 1), Un-dena, Malibu 1975.
= A. Westenholz, Some Notes on the Ortho-graphy and Grammar of the Recently Published Texts from Mari, «BiOr» 35 (1978), pp. 160-169. = A. Westenholz, OLD SUMBLET .ED OLD AKKSŒT TBVTT IN PHLEEPH.Ì 2. The 'Akka-dian " Texts, the Enlilemaba Texts, and the Onion
336
Westenho lz 1987-1990
Westenholz 1988
Westenholz 1999
Westenholz 2002
Westenholz 2004
Westenholz s.d.
W igge rnami 1981-1982
WIGGERMANN 1998-2001
Wi lcke 1973
Wi lcke 1976-1980
Wi lcke 1985
Wi lcke 1987
Wi lcke 1990
NICOLÒ MARCHETTI
Archive (CNIP 3), Museum Tusculatium, Co-penhagen 1987.
= A. Westenholz , Lugilpigesi, «RIA» 7 (1987-1990), pp. 155-157. = A. Westenholz , Personal Names in Ebla and in Pre-Sargonic Babylonia, in Archi (ed.), Eblaite Personal Names and Semitic Name-Giving, 1988, pp. 99-117.
= A. Westenholz , The Old Akkadian Period: History and Culture, in Sa l l aberge r -Wes ten-l io lz , Mesopotamien, 1999, pp. 17-117. = A. Westenholz , The Sumerian City State, in M.H. Hansen (ed.), A Comparative Study, 2002, pp. 23-42.
= A. Westenholz , "HSE ICD Bmç AB« PBŒ HEW IDO JO JG?'* iti Dercksen (ed.), .Assyria and Beyond, 2004, pp. 599-606. = A. Westenholz , Early Dynastic and Sargonic Tablets and Inscriptions in the Schoyen Collection, Nasjonalbiblioteket, Oslo (manoscritto in-edito) .
= FA.M. Wigge rnann , Exit talim! Studies in Babylonian Demonology, I, «JEOL» 27 (1981 1982), pp. 90-105.
= F.A.M. WIGGERMANN, Nammu, «RIA» 9 (1998-2001), pp. 135-140. = C. Wi lcke , Politische Opposition nach sumeri-schen Quellen: der Konflikt pvishen Königtum und Ratversammlung. Eiteraturwerhe als politische Ten-denpchriften, in A A . W , La voix de l'oppostion en Mésopotamie, 1973, pp. 37-65. = C. Wi lcke , I \ « T A Í V ( M m P Œ M m d ) . A. Pmaoasai «RIA» 5 (1976-1980), pp. 74-87. = C. Wil cke, Neue Quellen ansian p<r Geschichte der Ur-III-Zeit und der I. Dynastie von Isin, «Or» 54 (1985), pp. 299-318.
= C. Wi lcke , A Riding Tooth: Metaphor, Met-onymy and Synecdoche, Quick and Frozen in Eve-ryday Eanguage, in Mindl in et al. (EDD.), Figura-tive Language, 1987, pp. 77-102. = C. Wi lcke , Orthographie, Grammatik und lite-rarische Form. Beobachtungen pt der Vaseninschrift Lugalpiggsis (SAKI 152-156), in Abuscli et al. (edd.), Ungering over Words, 1990, pp. 455-504.
LA STATUARIA REGALE 337
WILCKE 1 9 9 5
Wilcke 1996
Wilcke 1997
Wi lhe lm 2001
Wilkinson 1999
Wilson 1986
Wilson 2002
Winkel mum 2003
Winter 1984
WINTER 1 9 8 5
Winter 1986a
Winter 1986b
Winter 1992
= C. WlLCKE, Die Inschrift der "Figure aux plumes " — ein frühes Werk, sumerischer Dichtkunst, in Finkbeiner et al. (edd.), Beiträge zur Kulturge-schichte Vorderasiens, 1995, pp. 669-674. = C. Wil cke, Neue Rechtsurkunden der altsumeri-schen Zeit, «ZA» 86 (1996), pp. 1-67. = C. Wilcke, Amar-girids Revolte gegen Naräm-Su'en, «ZA» 87 (1997), pp. 11-32. = G. Wi lhe ln ; Der "Mann in Netzpoch" und kultische Nacktheit, in Meyer et al. (edd.), Be-iträge zur Vorderasiatischen Archciologe, 2001, pp. 478^183.
= T.A.H. Wilkinson, Early Dynastie Egypt, Roudedge, London-New York 1999. = KL . Wil son, Nippur: The Definition of a Mesopotamian Gamdat Nasr Assemblage, in Fink-beiner-Röll ig (edd.), Gamdat Nasr, 1986, pp. 57-89.
= K.L. Wil son, The Temple Mound at Bismaya, in Ehrenberg (ed.), Tearing No Stones Un-turned, 2002, pp. 279-299. = S. Winkel imnn, Berliner Schlangenhecken, Trichterbecher und Cincinnati-Mann: verkannte Schlüsselobjekte der altorientalischen Archäologie?, in Ditt i la mi et al. (edd.), Altertumswissenschaften im Dialog, 2003, pp. 567-678. = LJ. Winter , Recensione di Spy cke t 1981, «JOS» 36 (1984), pp. 102-114. = LJ. WINTER, After the Barile is Over. The Stele of the Vultures and the Beginning of Historical Narrative in the Art of the Ancient Near East, in Kessler-Sinp6on (edd.), Pictorial Narrative, 1985, pp. 11-32.
= I.J. Wint er, Eannatum and the "King of Kis"?: Another Look at the Stele of the Vultures and "Cartouches" in Early Sumerian Art, «ZA» 76 (1986), pp. 205-212. = I.J. Winter , The King and the Cup: Iconography of the Royal Presentation Scene on Ur III Seals, in Ke l l y Buccel la t i et al. (edd.), Insight Through Images, 1986, pp. 253-268. = I.J. Wint er, "Idols of the Kings": Royal Images as Recipients of Ritual Action in Ancient Mesopo-tamia, «Journal of Ritual Studies» 6 (1992), pp. 13-42.
338 NICOLÒ MARCHETTI
WINTER 2 0 0 0 A
Winter 2000b
Winter 2000c
Winter 2003
Wiserran-Bl ack 1996
Woods 2001
Woo l l e y 1923
Wool 1 ey 1934
Wool 1 ey 1936
Wool 1 ey 1956
Wool 1 ey 1962
W o o t t o n 1965
W r e d e 1995
Yang 1987
= I.J. WINTER, The Eyes Have I f : Votive Statuary, Gilgamesh ï Axe, and Cathected Viewing in the An-cient Near East, in Ne lson (ed.), Visuality Before and Beyond the Renaissance, 2000, pp. 22 A4. = LJ. Win te r , Babylonian Archaeologists of the(ir) Mesopotamia Past, in Ma t th i a e et al. (edd.), Pro-ceedings of the First International Congress, 2000, pp. 1785-1800.
= I.J. Win te r , Opening the Eyes and Opening the Mouth: The Utility of Comparing Images in Worship in India and the Andent Near East, in Meist er (ed.), Ethnography and Personhood, 2000, pp. 129-162.
= LJ. Win te r , "Surpassing Work": Mastery of Materials and the Value of Skilled Production in Ancient Sumer, in Po t t s et al. (edd.), Culture through Objects, 2003, pp. 403-421. = D.J. Wiseman, J A . B1 ack, Literary Texts from the Temple of Nabu ( C I N 4), British School of Archaeology in Iraq, London 1996. = C.E.Woods, The Deictic Foundations of Sume-rian Language (PhD diss., Harvard University), U M , Ann Arbor 2001.
= C.L. Wool l e y , Excavations at Urof the Chal-dees, «AJ» 3 (1923), pp. 311-333. = C.L. Wool l e y , The Royal Cemetery. A Report on the Predynastic and Sargonid Graves Excavated between 1926 and 1934 (UE 2), Tlie Trustees of die Two Museums, London-Philadelphia 1934.
= C.L. Wool l e y , Introductory Note, in Le g ra in , Archaic Seal-Impressions, 1936, pp. vii-viii. = C.L, Wool 1 ey, The Early Periods (UE 4), The Trustees of the Two Museums, London-Philadelphia 1956.
= C.L. W o o l l e y , The Neo-Babyhnian and Per-sian Periods (LIE 9), H i e Trustees of the Two Museums, London-Philadelphia 1962. = J.E. W o o t t o n , A Sumerian Statue from Tell Asmad, «Sumer» 21 (1965), pp. 113-118. = N. Wrede , Relief einer Göttin oder Herrscher-statue?, in Finkbeiner et al. (EDD.), Beiträge sgir Kulturgeschichte Vorderasiens, 1995, pp. 677-689. = Z. Yang, The Name of the City Adab, «JAC» 2 (1987), 121-125.
LA STATUARIA REGALE
Yang 1988
Yang 1989
Young 1992
Zervos-Coppol a 1935
Ze t t l e r 1978
Ze t t l e r 1989
Ze t t l e r 1992
Zet t l e r -Home 1998
Zgo l l 1997
Z i in i rumn 1998
Z ó l y o n i 1 9 9 9 a
ZÓLYOMI 1999B
339
= Z. Yang, The Excavation of Adah, «JAC» 3 (1988), 1-21. = Z. Yang, Sargonic Inscriptions from Adab (Pe-riodic Publications on Ancient Civilizations 1), The Institute for the History of Ancient Civilizations, Changchun 1989. = G.D. Young (ed.), Mari in Retrosped. F i f t y Years of Mari and Mari Studies, Eisenbrauns, Winona Lake 1992. = C. Zervos, H. Coppola, L'art de la Mésopo-tamie de la fin du quatrième millénaire au XV siècle avant notre ère. Elam, Sumer; Akkad, Cahiers d'art, Paris 1935. = R.L. Ze t t l e r , Recensione di H. Kühne, Die Keramik von Fell Chuera und ihre Beziehungen ZU Funden aus Syrien-Palästina, der Türkei und dem Iraq, Gebr. Mann, Berlin 1976, «JNES» 37 (1978), pp. 245-350. = R.L. Z e t t l e r , Pottery Profiles Reconstructed
from Jar S eatings in the Lower Seal Impression Strata (SIS SP) at Ur: New Evidence for Dating, in Leonard-Beyer Wil l iams (edd.), Essays in Ancient Civilization, 1989, pp. 369-393. = R.L. Zet t l er , The Urlìi Temple of Inanna at Nippur. The Operation and Organization of Urban Religious Institutions in Mesopotamia in the Late Third Millennium B.C. (BBVO 11), Reimer, Berlin 1992. = R.L. Z e t t l e r , L. Hörne (edd.), Treasures
from the Royal Tombs of Ur, University of Penn-sylvania Museum of Archaeology and An-thropology, Philadelphia 1998. = A. Z g o l l , Inarm als nugig, «ZA» 87 (1997), pp. 181-195. = PC. Zimmerman, A Critical Reexamination of the Early Dynastic 'Royal Tomb" Architecturefrom Ur, MA diss., University of Pennsylvania. = G. Zólyoni , Recensione di Edzard 1997, «OLZ» 94 (1999), con. 178-189. = G. ZÓLYOMI, Directive Infix and Oblique Object in Sumerian: An Account of the History of Their Relationship, «Or» 68 (1999), pp. 215-253.
INDICE
INTRODUZIONE P a g .
1. CONTESTI ARCHEOLOGICI E CRONOLOGIA DELLA STATUARIA PROTODINASTICA
1.1. I principali contesti di ritrovamento della statuaria e di altri materiali visuali stratificati del Protodinastico » 19
1.1.1. Teli Asmar (Esnunab), Kliafagia (Tutub) e Teli Agrab (PA.GAR) » 19
1.1.2. Nuffar (Nippur) » 49 1.1.3. Tello (Grisù) » 53 1.1.4. Bismava (Adab) » 64 1.1.5. Teli al-Muqayyar (Ur) » 71 1.1.6. Teli al-'Ubaid (Nutur) » 84 1.1.7. Tell Hariri (Mari) » 85 1.1.8. Qal'at Shergat (Assur) » 95 1.1.9. Teli Ingharra (Kis) » 96 1.1.10. Shush (Susa) » 105 1.1.11. Alcuni gruppi di oggetti scolpiti da altri siti mesopotamici » 107
1.2. La cronologia del Protodinastico e lo sviluppo dei documenti visuali ed epigrafici » 112
1.3. Alcune osservazioni sui templi protodinastici » 121
2. LA STATUARIA REGALE DEL PROTODINASTICO
2.1. La statuaria regale identificata epigraficamente » 127 2.2. La statuaria di prestrmibile committenza regale » 141 2.3. Lo sviluppo della statuaria regale: contesto storico e significato » 148
414 NICOLÒ MARCHETTI
2.4. Catalogo della statuaria legale Pag. 154 2.4.1. Statuaria regale .pio to dina s tica identificata .epigraficamente » 155 2.4.2. Statuaria pioto dinas tica. di. presumibile, committenza regale » 158
3 . R E G A L I T À E C O M U N I C A Z I O N E V I S U A L E
N E L P R O T O D I N A S T T C O
3.1. L'epoca protostorica e il problema dell'identificazione del "re-sacerdote" » 161
3.2. Iconografie e temi dell'arte protodinastica » 174 3.3. Ebla e la cultura protosiriana » 190
4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
4.1. Dettagli antiquari e significato visuale: il sovrano e l'ammini-strazione statale arcaica » 195
4.2. Dalla coralità all'unicità: lo sviluppo della propaganda visuale del sovrano nel Protodinastico IIIa-b » 198
A P P E N D I C E
S T A T U E R E G A L I , S O V R A N I E T E M P L I D E L P R O T O D I N A S T I C O .
I D A T I E P I G R A F I C I E T E S T U A L I
d i GIANNI MARCHESI
A.1. Le iscrizioni della statuaria regale » 205 A. 1.1. Osservazioni preliminari » 208 A. 1.2. Titoli dei sovrani » 220 A. 1.3. Determinazione del corpus » 229 A.1.4. Trascrizione, traduzione e commento delle iscrizioni
su Cat. 1-13 » 232 A.2. Cronologia dei sovrani protodinastici » 256 A.3. Note stille designazioni di alctmi templi protodinastici » 264
A.3.1. Adab » 264 A.3.2. Nippur » 266 A.3.3. Tutub » 266