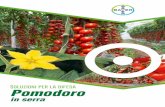"Sopra le sciocchezze del Kirchero stampate in Italia"
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of "Sopra le sciocchezze del Kirchero stampate in Italia"
Claudio Annibaldi
«Sopra le sciocchezze del Kirchero stampate in Italia»:
risvolti e strascichi polemici della Musurgia universalis
sullo sfondo del Seicento musicale romano
Claudio Annibaldi
60
I La prima parte del titolo del presente contributo corrisponde a una frase che si legge nell’Historia musica di Giovanni Andrea Angelini Bontempi (1626–1705) al termine della celebre pagina autobiografica che rievoca il tirocinio a cui le «scole di Roma» sottoponevano i giovani avviati a una carriera musicale.1 Considerando quanto spesso questa pagina sia stata sintetizzata, parafrasata o trascritta da studiosi del Seicento musicale,2 non è il caso che mi dilunghi sui dettagli spesso pittoreschi di un appren-dimento largamente basato sulla trasmissione orale, in cui le quotidiane lezioni teori-co-pratiche di un maestro di provata esperienza erano integrate quanto più spesso possibile dall’ascolto di rinomati virtuosi. Non sarà inutile, invece, insistere sull’idea sfocata che si ha solitamente di questa eccezionale testimonianza una volta che tutte le sintesi, le parafrasi o le trascrizioni che ne sono state proposte finora non vanno oltre l’inizio della frase in cui Bontempi rende omaggio al suo insegnante, Virgilio Mazzoc-chi. Così facendo, infatti, non soltanto si è ignorato il riferimento alle «sciocchezze del Kirchero» che segue tale elogio, ma si è anche perso di vista lo scopo per cui Bontempi ha ritenuto di far spazio ai propri ricordi giovanili in una sezione del suo trattato con-cernente la pratica musicale nell’antichità.
Il punto è che, nonostante le apparenze, egli non intendeva polemizzare con Athanasius Kircher – morto ormai da quindici anni – ma con il filologo Marcus Meibom, che più di quattro decenni prima aveva criticato i capitoli della Musurgia universalis dedicati alla teoria musicale degli antichi Greci, dichiarandosi sorpreso che Roma, culla d’una civiltà millenaria, avesse potuto ispirare a Kircher tanti errori.3 Per Bontempi, pertanto, liquidare la «dottrina […] dimostrata nella sua Musurgia» come una dottrina che nessun musicista romano avrebbe potuto prendere «né meno per ombra, non che per corpo reale, in considerazione» aveva un solo scopo: concludere che Roma era stata soltanto la città dove le «sciocchezze del Kirchero» erano state date alle stampe.
Ai tempi d’oro della Kircher-Renaissance avviata quarant’anni fa, quando si dava per scontata l’irresistibile fortuna della Musurgia presso i contemporanei, era fatale che un giudizio così inappellabile fosse liquidato in tutta fretta.4 Ma oggi, grazie 1 Angelini Bontempi 1695, 169s. Della carriera musicale di Bontempi qui basterà ricordare che cantò a Venezia sotto la direzione di Claudio Monteverdi e Francesco Cavalli, e che servì la corte elettorale di Dresda come Kapellmeister insieme a Heinrich Schütz. 2 Si veda, fra gli esempi più recenti, Bianconi 1991, 68. 3 Sulle critiche che Meibom mosse a Kircher nella prefazione di Antiquae musicae auctores septem, graece et latine (Amsterdam 1652) cfr. Annibaldi/Cinque 2007, 48s., nota 27. 4 All’epoca il passo dell’Historia musica che qui interessa fu ridotto a una sorta di ottusa rivendicazione nazionalistica: evitare che i musicisti italiani venissero considerati responsabili degli errori imputati da Meibom a un
Risvolti e strascichi polemici della Musurgia universalis
61 a una migliore conoscenza del mondo musicale evocato da Bontempi, quei tempi sono cambiati. E non pochi sono i dubbi suscitati su quella fortuna dalla scarsissima presen-za di musicisti di professione nelle lettere concernenti la genesi e la recezione della Musurgia fra il 1645 e il 1677, che ho illustrato insieme alla dottoressa Maria Teresa Cinque durante il convegno kircheriano svoltosi nel 2002 al Deutsches Historisches Institut di Roma.5
Ovviamente non si tratta di tutte le lettere che Kircher spedì o ricevette in quei trent’anni relativamente a problemi teorico-musicali trattati nella Musurgia, ma solo di quelle conservate a Roma, nell’archivio della Pontificia Università Gregoriana. Nondimeno la circostanza che solo tre lettere su centotrentatré risultino essergli state indirizzate da musicisti di professione – due di Johann Jakob Froberger e una di Ga-leazzo Sabatini6 – è un buon motivo per riconsiderare il giudizio sulle «sciocchezze del Kirchero» espresso da un cantante e compositore dalla brillante carriera internazionale come Bontempi. E per chiedersi, tanto per cominciare, se non lo si debba considerare un’eco, lontana ma fedele, delle prime reazioni dell’ambiente musicale romano alla pubblicazione della Musurgia, quali troviamo descritte in una lettera del 17 giugno 1650 a firma di Johannes Schega, un padre gesuita che all’epoca serviva come segreta-rio il nobile dedicatario dell’opera, l’arciduca Leopold Wilhelm d’Absburgo.7
Rispondendo a una lettera di Kircher apparentemente perduta ma di cui non è difficile immaginare il contenuto, Schega accenna alla pubblicazione della Musurgia come a un evento accolto dai musicisti romani con sdegno e disgusto, ed esorta il confratello a non curarsene, essendo di gran lunga superiore ai suoi oppositori.8 Si tratta di un incoraggiamento che richiama alla mente, per contrasto, il tono ottimisti-co con cui Kircher aveva minimizzato eventuali attacchi alla Musurgia nelle due prefa-zioni del primo tomo: lì dichiarandosene anticipatamente risarcito dal favore di emi-
musicografo tedesco (Scharlau 1969b, 360s.). Circa la tesi dell’immediata popolarità della Musurgia, cfr. Fletcher 1982, 76, e Chierotti 1994, 384. L’inattendibilità di codeste posizioni – fra l’altro dimentiche che la Musurgia universalis non ebbe ristampe, diversamente da altre opere teoriche di Kircher – è sottolineata in Annibaldi/Cinque 2007, 43s. (l’indicazione «Appendice, 129» di p. 44 è errata, e va corretta in «Appendice, 128»). 5 Un regesto delle lettere in questione è allegato a Annibaldi/Cinque 2007, 69–77. Nelle pagine seguenti esso verrà citato con la sigla REGESTO seguita dal numero d’ordine delle lettere via via interessate. 6 Sul contenuto di queste lettere (REGESTO nn. 30, 112 e 116) cfr. Annibaldi/Cinque 2007, 48s. Le ipotesi avanzate da alcuni studiosi a giustificazione della presenza minima di musicisti di professione fra i corrispondenti di Kircher sono discusse ibid., 51s. 7 REGESTO n. 49. 8 Schega scrive testualmente: «Quod attinet ad romanos musicos, quibus indignationem et stomachum movere videtur opus musurgicum in lucem datum, non debet eos Reverentia Vestra curare, cum nimis emineat eorum comparatione sitque extra invidiam omnium». I moderni apologeti della Musurgia universalis hanno minimizzato questa testimonianza come già quella di Bontempi. Così in Scharlau 1969b, 353, le reazioni negative dei musicisti romani sono riferite ai procedimenti di composizione automatica esposti nell’Ottavo libro, mentre in Fletcher 1982, 81, il contenuto della lettera di Schega è ridotto a una frase insignificante: «[Schega] has received the Musurgia and finds it ‹beyond all criticism›».
Claudio Annibaldi
62 nenti personaggi come l’arciduca sopra menzionato e l’imperatore Ferdinando III suo fratello, qui attribuendo quegli attacchi ai settori più retrivi del mondo musicale del tempo e dicendosi sicuro dell’appoggio della sua parte migliore.9 Il fatto che Schega lo incoraggiasse a ignorare avversari indegni di lui mostra forse che quest’appoggio venne a mancargli?
Diciamo intanto che non è difficile identificare coloro che Kircher poteva ri-tenere pronti a prendere le sue difese. In vari luoghi del testo, ma segnatamente nella seconda prefazione e nel Settimo libro, si trovano citati circa una ventina di musicisti attivi a Roma a metà Seicento: alcuni di essi figurano fra gli autori dei brani musicali inseriti nel volume a mo’ di esempi (così Giacomo Carissimi e Domenico Mazzocchi), altri fra i maestri di cappella e i cantori al centro della scena musicale romana (tali i maestri basilicali Orazio Benevoli e Francesco Foggia o i cantori pontifici Loreto Vit-tori e Marc’Antonio Pasqualini), altri ancora fra i consulenti dell’autore su problemi specifici (in primis Antonio Maria Abbatini, che, oltre ad affiancarlo come consulente per lo stylus ecclesiasticus, aveva anche redatto la lusinghiera relazione peritale che si legge all’inizio del primo tomo). La domanda precedente può dunque essere riformu-lata come segue: l’esortazione di Schega a non curarsi del modo in cui la Roma musi-cale aveva accolto la Musurgia mostra che a Kircher mancò anche la solidarietà dei musicisti che riteneva schierati dalla sua parte?
Per tentare di rispondere occorre risalire alla causa prima delle reazioni in questione, che già al convegno kircheriano del 2002 ho proposto di individuare nelle dure critiche che Kircher rivolge ai musicisti romani nei capitoli della Pars II del Set-timo libro intitolati «De musicae harmonicae sive figuratae abusibus & defectibus musicorumque sive phonascorum ingenio», e «De defectibus & abusibus modernorum melothetarum, sive quos componistas vulgo vocant».10 A orientarmi in tal senso erano state, oltre al tono provocatorio di quelle critiche, la tipologia e la tempestività della risposta dei musicisti romani. È evidente che reazioni improntate a sdegno e disgusto, come quelle evocata da Schega il 17 giugno 1650, non potevano conseguire a una lettura ponderata dell’opera. E non solo perché quest’operazione era fuori della portata di gran parte dei musicisti del tempo11 ma anche perché Kircher non avrebbe potuto 9 Mi riferisco rispettivamente all’ultimo capoverso della Praefatio I. Ad lectorem e al terzo capoverso della Praefatio II. Ad eruditos musicarum rerum professores. 10 In conseguenza dei ripensamenti a cui accenneremo più oltre, il Settimo libro presenta incongruenze di varia natura. Per ora mi limito a segnalare l’indicazione Pars II, che s’incontra dopo il secondo dei capitoli in questione (Kircher 1650, I, 564) ma anche una decina di pagine prima (p. 555). Si tratta di una duplicazione a cui Kircher sembra essere stato costretto dalla necessità di segnalare una nuova partizione del libro (quella relativa all’esposizione della teoria degli affetti) senza dover modificare la suddivisione in due parti del libro stesso. D’ora innanzi citerò queste due indicazioni rispettivamente come Pars II (a) e Pars II (b). 11 A rendere ardua tale impresa erano non solo la monumentalità dell’opera e la scarsa dimestichezza dei musicisti dell’epoca con la lingua latina – carenza espressamente lamentata in Kircher 1650, I, 563 – ma anche lo stile pletorico e neologico caratteristico degli scritti teorici di lui.
Risvolti e strascichi polemici della Musurgia universalis
63 tirare un bilancio di tali reazioni a soli due mesi dalla pubblicazione del volume (una copia della Musurgia risulta ricevuta alla corte di Vienna entro la fine del precedente mese di aprile).12
Un interessante supporto a questi indizi viene da un’altra lettera di Schega a Kircher, che orienta sui canali attraverso cui il contenuto dei capitoli polemici del Settimo libro potè diffondersi così rapidamente nell’ambiente musicale romano. Si tratta della lettera del 27 novembre 1649 con cui Kircher fu informato del desiderio dell’arciduca Leopold Wilhem che, a pubblicazione avvenuta, la Musurgia fosse spedi-ta al papa Innocenzo X e ai cardinali legati alla casa imperiale d’Austria.13 Se le copie destinate a costoro furono, com’è verosimile, tra le primissime che circolarono a Ro-ma, il volume ebbe fra i suoi primi lettori in questa città i segretari incaricati da quei personaggi di ringraziare l’arciduca per l’omaggio ricevuto. Ai quali segretari bastò, per risalire rapidamente ai capitoli polemici in questione, scorrere l’Index rerum notabi-lium e l’Index capitum che chiudono, rispettivamente, il primo e il secondo tomo della Musurgia: un’operazione ch’essi compirono allo scopo di formulare un ringra-ziamento adeguato al dono e al donatore, ma che li portò ad imbattersi in locuzioni e titoli capaci di sollecitare la curiosità anche dei meno interessati a questioni musicali come «Musici moderni defectus» o, rispettivamente, «De defectibus, qui in modernis compositionibus committi solent». Dopodiché, auspice la vocazione per il pettegolezzo caratterizzante ogni ambiente cortigiano, non dovette passare molto tempo da quando codesti lettori per dovere d’ufficio buttarono l’occhio sui capitoli suddetti al momento in cui – a partire dai cantori al servizio del papa e dei cardinali legati agli Absburgo – i musicisti romani vennero a sapere che nel monumentale trattato di teoria musicale testé pubblicato da un celebre professore del Collegio Romano (Kircher vi insegnava, com’è noto, lingue orientali, fisica e matematica) si leggeva che in tutta Roma non c’era un cantore capace di intonare correttamente composizioni stilisticamente incon-suete, che i maestri di cappella vi promuovevano esclusivamente la loro musica e che anche nelle sedi più prestigiose si ascoltavano musiche mediocri marcate dal più arro-gante disinteresse dei loro autori per la produzione compositiva di altri paesi.14
Ce n’era abbastanza non solo per inimicare all’autore della Musurgia i musici-sti romani più retrivi ma anche per mettere in imbarazzo quelli che Kircher escludeva automaticamente dalle proprie critiche in quanto «periti & iudicio pollentes».15 Come stupirsi se, a fronte delle reazioni negative a cui accenna la lettera di Schega del giugno 1650, egli non sentì levarsi alcuna voce in sua difesa?
12 REGESTO n. 42. 13 REGESTO n. 35. 14 Kircher 1650, I, 561–563. 15 Ibid., 563.
Claudio Annibaldi
64 II Nella relazione per il convegno kircheriano del 2002 ho prospettato i capitoli polemici della Musurgia universalis come la pars destruens di un ambizioso progetto di rinno-vamento della ‹musica moderna› delineato da Kircher nei libri quinto e settimo del primo tomo, indicando la più massiccia prova e silentio del fallimento di quel progetto nella presenza irrisoria di musicisti di mestiere nell’epistolario kircheriano della Ponti-ficia Università Gregoriana.16 Quanto alle cause ultime di un tale risultato ho proposto di cercarle nell’ambiguità dell’ideologia della scienza coltivata negli ambienti gesuitici del tempo: oscillante fra moderno sperimentalismo e naturalismo magico e quindi portata ad affermare l’utilità della ricerca scientifica nel momento stesso di assumere a proprio oggetto il meraviglioso.17 Donde la contraddittorietà di fondo dei due tomi della Musurgia: il primo dei quali si propone di rifondare – «nova, vera, certa et de-monstrativa ratione» – la tecnica compositiva, mentre l’altro squaderna «curiosas mate-rias» di vario interesse, tra cui noti dispositivi meccanici atti a trasformare chiunque, «etiam quantumvis musicae imperitus», in un compositore provetto.18
In questa sede vorrei tornare sulle pagine polemiche della Musurgia universa-lis con un duplice scopo: chiarire i termini delle reazioni negative dei musicisti romani al di là di quanto suggerito dalle testimonianze convergenti di Schega e Bontempi (e dunque mostrando come anche certi elogi di Kircher a quei musicisti potessero tra-sformarsi in casus belli ) e dar conto dei legami della Musurgia con Roma al di là di quanto sostenuto polemicamente da Bontempi, in modo da comprendere come non solo la concezione generale ma anche l’organizzazione interna dell’opera siano state condizionate dalla residenza del suo autore nella città in cui avevano sede i pontefici romani, agivano cappelle musicali rinomate in tutto il mondo cattolico e fermentava una vita culturale cosmopolita, foraggiata dalle élites ecclesiastiche e laiche ruotanti intorno alla corte papale.
Cominciamo da due esperienze personali di Kircher legate entrambe al suo trasferimento a Roma nel novembre 1633 ed entrambe decisive per la maturazione del progetto di rinnovamento della ‹musica moderna› di cui si diceva: da un lato, i «curiosi ragionamenti» intercorsi per alcuni anni fra lui e il musicografo fiorentino Giovan Battista Doni (1594–1647), che fino al 1640 occupò un posto di rilievo nella corte del papa Urbano VIII; dall’altro lato, la cognizione diretta del decadimento dei servizi musicali nelle chiese di Roma, che sin dai tardi anni Trenta furono oggetto di appositi
16 Sulla progressiva rimozione delle ambizioni pedagogiche della Musurgia da parte di Ulf Scharlau, pioniere della Kircher-Renaissance tuttora in atto, cfr. Annibaldi/Cinque 2007, 49–50 nota 29. 17 Rossi 1998, 325s. 18 Le espressioni latine di questo capoverso ricorrono, rispettivamente, in Kircher 1650, I, 211 e 690, e in Kircher 1650, II, 1.
Risvolti e strascichi polemici della Musurgia universalis
65 provvedimenti delle congregazioni pontificie preposte al controllo della vita religiosa della città.19
Nell’ottobre 1647 Doni, che era da tempo rientrato a Firenze e vi sarebbe morto di lì a poco, riceveva una lettera di Kircher che gli annunciava il completamento della Musurgia universalis, precisando di non aver avuto altro scopo che mostrare i difetti della musica moderna e il modo di ridurla a perfezione.20 La frase usata a tal proposito da Kircher («hoc unicum agens ut modernae musicae imperfectionem ostendam, modum quo perfici possit doceam») è solitamente riferita alla Musurgia nel suo complesso.21 Si tratta però di un’interpretazione che non tiene conto della subor-dinazione sintattica di tale affermazione a quella precedente, nella quale Kircher preci-sa che il suo nuovo lavoro si occupa, sì, del rapporto fra la musica antica e quella mo-derna ma lo fa in chiave più filosofica e matematica che filologica. Ove se ne ripristini la connessione, queste due proposizioni si prospettano dunque come un’excusatio non petita circoscritta alle parti della Musurgia – la pars prima e la pars II (a) del Settimo libro – che riprendono gli stessi temi trattati da Doni in De praestantia musicae vete-ris, un dialogo latino ancora fresco di stampa ma già disponibile a Roma nell’estate 1647.22
In effetti l’approccio dei due studiosi al rapporto fra la musica antica e quella moderna presenta analogie molteplici, dal lessico adottato all’articolazione espositiva. Anche Doni, ad esempio, intende musurgia come pratica e non come azione musicale (secondo l’accezione che Meibom avrebbe poi rinfacciato a Kircher), e anch’egli aspira a restituire alla ‹musica moderna› la capacità di sollecitazione emotiva di quella antica, scagliandosi con sarcasmo contro l’insipienza dei musici pratici.23 Tuttavia si tratta di analogie che insistono su due progetti d’intervento sulla musica del proprio tempo 19 Le sue conversazioni con Kircher sono rievocate da Doni all’inizio del primo dei suoi tre discorsi Del sintono di Didimo, e di Tolomeo (Doni 1763, vol. 1, 349): uno scritto che egli dedicò allo stesso Kircher dopo essere definitivamente tornato a Firenze. 20 La lettera di cui si parla fu data alle stampe già nel XVIII secolo. Il passaggio qui citato è trascritto integralmente in Annibaldi/Cinque 2007, 50, nota 30. Che Kircher abbia conosciuto Doni poco dopo il suo trasferimento a Roma è attestato dalle lettere di Doni a Mersenne citate ibid., 53, nota 33. 21 Così, ad esempio, in Scharlau 1969b, 46 e 375. Anche il modo in cui questa frase è commentata in Annibaldi/Cinque 2007, 49s., è stato condizionato da questo fraintendimento. 22 Come attesta una lettera pubblicata in Solerti 1905, 303–307, il 4 luglio 1647 una copia di De praestantia musicae veteris fu ricevuta a Roma da Pietro della Valle, un eclettico musicofilo menzionato in Kircher 1650, I, 675, in quanto inventore di strumenti adatti all’esecuzione di musiche ispirate alle teorie di Doni. 23 Sull’accezione del termine musurgia da parte di Doni si veda la «Synopsis musicarum, Graecarum, atq. obscuriorum vocum: cum earum Interpretatione; & indice Rerum notabilium» (Doni 1647, 246). Quanto alle critiche di lui verso i musicisti dell’epoca è sintomatico che, diversamente da Kircher, egli ne abbia in serbo anche per un Palestrina o un Frescobaldi, in quanto esponenti di una musica irreparabilmente inferiore all’antica. Così, uno degli interlocutori immaginari di De praestantia musicae veteris sbeffeggia Frescobaldi in quanto fautore di un tipo di accordatura organistica orientata verso il temperamento equabile, e definisce ironicamente il Palestrina come il musicista che aveva defraudato il papa Marcello II del merito di aver bandito la polifonia dalle chiese (ibid., 30, 41 e 49).
Claudio Annibaldi
66 fondamentalmente diversi. Giacchè per Doni la ‹musica moderna› era geneticamente inferiore a quella antica e non c’era altra soluzione che sbarazzarsene a vantaggio di tecniche compositive ed esecutive ispirate alla musica greca,24 mentre per Kircher essa prevaleva indiscutibilmente sull’altra e la via per ridurla a perfezione passava per la riqualificazione professionale dei musicisti di mestiere, unici responsabili della sue carenze attuali.25
Ciò che verosimilmente portò Kircher a conferire a quest’idea i tratti di un progetto pedagogico rivolto in primis ai musicisti di chiesa, e segnatamente a quelli che agivano a Roma, fu lo scadimento qualitativo dei servizi musicali nelle chiese romane da cui, in quanto sacerdote, egli doveva essere particolarmente colpito.26 Non a caso i capitoli polemici della Musurgia, le cui critiche alle imperfezioni della ‹musica moderna› spesso coincidono perfettamente con quelle di Doni, alludono alla musica sacra anche quando affrontano argomenti generici.27 Così Kircher depreca l’inettitudine dei compositori moderni ad esprimere il contenuto affettivo dei testi da loro intonati, spiegando questa carenza con l’ignoranza del latino, lingua della liturgia cattolica. E ironizza sulla gesticolazione grottesca di certi cantanti in quanto motivo di distrazione per gli uditori, facendo emergere, dietro argomentazioni apparentemente scontate contro i malvezzi dei virtuosi del tempo, un’esigenza che di lì a qualche anno avrebbe portato alla recinzione delle cantorie delle chiese di Roma con apposite gelo-sie.28
In tal modo Kircher contrappose agli orizzonti utopici di Doni un program-ma operativo perfettamente in linea con le iniziative prese da almeno dieci anni a quella parte dalle autorità ecclesiastiche a tutela del decoro dei servizi musicali delle chiese di Roma. Si pensi ai decreti emanati nell’ottobre 1639 dalla congregazione della Sacra Visita Apostolica e nel febbraio 1643 dalla congregazione dei Sacri Riti allo scopo, nel primo caso, di vietare la composizione di musiche sacre su «altre parole che dell’Officio corrente o della Sacra Scrittura» e, nel secondo, di ribadire quanto stabilito a suo tempo dal concilio tridentino contro l’inserimento di musiche profaneggianti nei
24 Ecco come egli si esprime al riguardo, celandosi al solito dietro gli interlocutori del suo dialogo (Doni 1647, 32): «Nam si Donium nostrum audimus, tota haec modulandi ratio, quam symphoniasticam ipse vocat, quae palilogijs ac polylogijs passim exuberat, barbara prorsus, planeque incondita censenda est; quaeque nullo modo repurgari possit, nisi ad vivum resecetur» (secondo la spiegazione che egli stesso ne dà ibid., 273ss, i termini palilogia e polylogia valgono per Doni ripetizione di una stessa parola e, rispettivamente, sovrapposizione di parole diverse). 25 Si confronti la citazione riportata nella nota precedente con la perentoria affermazione di Kircher «sane veterum Graecorum musicam multo nostra inferiorem existimo» (Kircher 1650, I, 547). 26 Sulla centralità dell’esperienza della musica sacra nel pensiero teorico di Kircher cfr. Beck 2007. 27 Per i due passaggi citati qui appresso cfr. Kircher 1650, I, 563s. e 561s. 28 Su questo provvedimento torneremo nelle pagine successive.
Risvolti e strascichi polemici della Musurgia universalis
67 servizi liturgici.29 Né va dimenticata l’iniziativa presa, poco prima della pubblicazione del trattato di Kircher, dai cantori della Cappella pontificia, che fra il 1648 e il 1649 sollecitarono con appositi memoriali Innocenzo X a intervenire «per la riforma delli abusi di cantilene poco decenti nella chiesa di Dio», candidandosi a interlocutori privi-legiati di questo papa per un’azione ufficiale in tal senso.30
Considereremo più oltre la possibilità che le proposte teorico-musicali di Kir-cher abbiano contribuito a provvedimenti e iniziative consimili, specialmente durante il pontificato di Alessandro VII, che in minoribus era stato tra i suoi estimatori più convinti.31 Prima dobbiamo considerare il meno appariscente dei legami della Musur-gia universalis con la Roma seicentesca: quello fra la sua organizzazione interna e una città che, in quanto sede del papato, fu spesso teatro di eventi decisivi nella storia del cattolicesimo.
III Nel quarto capitolo della Pars II (b) del Settimo libro – prima di addentrarsi nella trattazione degli stili e degli affetti musicali – Kircher avverte il lettore che questi ulti-mi saranno esemplificati con brani d’autore diversi da quelli a cui aveva pensato in un primo tempo.32 Egli giustifica questo suo ripensamento con l’esigenza di procedere senza indugi alla pubblicazione della Musurgia – un’esigenza a cui potrebbe collegarsi anche la stampa simultanea dei due tomi presso diverse tipografie33 – ma non specifica il motivo di tanta sollecitudine. Tuttavia lo si può desumere osservando gli imprima-tur in calce alla pagina immediatamente precedente il Primo libro, che non sono datati ma che per certo furono rilasciati successivamente alle autorizzazioni e alle perizie riportate nella medesima pagina, la più recente delle quali (la summenzionata perizia di Abbatini) reca la data del 21 dicembre 1649. Pertanto, una volta stabilito che la stampa dell’opera fu avviata fra la fine del 1649 e l’inizio del 1650,34 la sollecitudine con cui vi si pose mano può essere collegata a un’occasione imperdibile per la diffusio-ne del volume: la congregazione generale che la Compagnia di Gesù tenne a Roma fra il 13 dicembre 1649 e il 20 febbraio 1650. Infatti, se i padri gesuiti giunti da ogni
29 Per il decreto della Congregazione della Sacra Visita Apostolica, si veda I-Rasv, Miscellanea, Armadio VII, vol. 39, cc. 62r–v; per quello della Congregazione dei Sacri Riti, Romita 1936, 77. 30 I due memoriali sono citati in I-Rvat, Diari sistini, n. 68, c. 6r, 20 gennaio 1649. Peraltro non risulta che Innocenzo X ne abbia tenuto conto. 31 Al riguardo cfr. Annibaldi/ Cinque 2007, 45 e 62, e REGESTO nn. 77, 78, 80. 32 Kircher 1650, I, 580s. 33 Come si ricorderà, il primo tomo fu stampato presso gli eredi di Francesco Corbelletti, mentre il secondo lo fu presso Ludovico Grignani. 34 Peraltro molte questioni tecniche – come quelle relative alle tavole illustrative dei due tomi – erano state affrontate assai per tempo (REGESTO nn. 16, 25, 28, 31).
Claudio Annibaldi
68 parte del mondo per prendervi parte fossero rientrati nelle rispettive sedi portando con sé una copia della Musurgia, non soltanto si sarebbe garantita una distribuzione dell’opera a livello planetario, ma si sarebbe anche fatta giungere nelle più lontane terre di missione la notizia di quelle tecniche di composizione automatica che Kircher era stato spesso sollecitato a divulgare ad uso dei confratelli operanti colà, onde agevo-larli nella confezione di canti adatti alle comunità da loro evangelizzate.35
La Musurgia riuscì effettivamente ad essere stampata, come abbiamo visto, entro i primi mesi del 1650 e, tramite i gesuiti convenuti a Roma per le loro assise, ne furono diffuse trecento copie «non in Europam tantum, sed et in Asiam, Africam, et Americam».36 Ma tanta efficienza ebbe un prezzo e – come appunto suggeriscono le modifiche apportate alle esemplificazioni musicali della teoria degli affetti – questo fu pagato soprattutto dal Settimo libro:37 il più ricco della Musurgia quanto a brani fir-mati da compositori nati, formatisi o stabilitisi a Roma in qualche periodo della loro carriera (su un totale di sedici compositori, undici sono romani nel senso ora detto).38
Ciò è particolarmente interessante perché la vecchia tesi secondo cui la Roma musicale di metà Seicento aderì compatta alla realizzazione del capolavoro musicogra-fico di Kircher ha il suo punto di forza proprio in tale dato statistico, sicché, ove que-
35 Si tratta delle prime tre parti dell’Ottavo libro, l’ultima delle quali contiene esempi musicali dedicati, via via, «Ad sacrae linguae Societ[atis] Iesu Professores», «Ad Societatis Iesu in Syria Patres, & praesertim Maronitas montis Libani incolas», «Ad Societ[atis] Iesu Patres in Aegipto, Syria & tota Asia commorantes», «Ad Societ[atis] Iesu Patres in Aethiopia», «Ad Soc[ietatis] Iesu, aliarumque Religionum Patres Armenos» (Kircher 1650, II, 126–136). Alle pressioni ricevute perché divulgasse i procedimenti compositivi in questione, Kircher accenna ibid., 2s. Non è da escludersi che, senza di esse, anche l’ultima e più celebre parte dell’Ottavo libro, quella relativa a due dispositivi per la composizione automatica denominati arca musarithmica e arca musurgica, non sarebbe mai stata resa di pubblico dominio. Infatti essa presuppone le tre parti precedenti, anche se poi le sviluppa in direzione di pratiche compositive assai sofisticate, alcune delle quali Kircher si riserva di illustrare verbalmente «solis Principibus & benemeritis amicis» (ibid., 184). 36 Il numero delle copie diffuse dai padri gesuiti convenuti a Roma per la loro congregazione generale è specificato in una lettera di Kircher databile fra il 1650 e il 1651 (REGESTO n.71). 37 La ristrettezza dei tempi di stampa della Musurgia ha avuto sul Settimo libro conseguenze che, per quanto mi consta, sono sempre passate inosservate. A quanto già notato nella precedente nota 10 e alle vistose incongruenze di cui ci occuperemo fra breve va aggiunto che in Kircher 1650, I, 606 e 613, ci si imbatte in un frammento di Christe eleyson a sei voci avulso dal contesto e nel preannuncio di un madrigale di Carlo Gesualdo di cui poi non c’è traccia. Né va dimenticata la nota elencazione degli stili musicali expressi (ibid., 581–597), perché Kircher enumera otto stili ma poi ne descrive nove, con il risultato di fuorviare anche gli studiosi più attenti. Così in Bianconi 1991, 56s., quei nove stili vengono riportati ad otto a scapito dello stile motecticus. 38 Si tratta, per l’esattezza, di Antonio Maria Abbatini (602s. e 610–613), Gino Angelo Capponi (611s.), Giacomo Carissimi (604s. e 673.), Johann Hieronymus Kapsberger (586–597 e 621–623), Domenico Mazzocchi (660–663 e 674s.), Romano Micheli (p. 584), Cristóbal Morales (p. 624), Giovanni Pierluigi da Palestrina (582s. e 599), Giuseppe Tricarico (p. 607), Giovanni Troiani (601 e 613), Pierfrancesco Valentini (p. 585). I cinque autori restanti sono Antoine du Cousu (627–634), Carlo Gesualdo (599 e 602), Ferdinando III d’Absburgo (685–689), Luigi XIII di Borbone (p. 690) e Galeazzo Sabbatini (664–672). Tutte le indicazioni di pagina di questa nota si riferiscono ovviamente al primo tomo della Musurgia.
Risvolti e strascichi polemici della Musurgia universalis
69 sto risultasse prodotto da circostanze esterne, ne uscirebbe ridimensionata essa stessa.39 Ma c’è di più. Dal passo in cui Kircher spiega di aver dovuto impostare ex novo i suddetti esempi musicali risulta che egli non era affatto partito dall’idea di servirsi di brani di compositori romani. Al contrario: la sua intenzione sarebbe stata quella di mostrare come l’espressione musicale degli affetti fosse intesa da autori di diversi paesi, tant’è vero che si era già accordato con un gruppo di compositori «ex diversis nationi-bus, Italia, Germania, Anglia, Gallia praecipui», perché ciascuno di loro componesse una serie di brani su testi biblici dal differente contenuto affettivo.40 Purtroppo la scarsa puntualità di costoro nel fargli avere i materiali richiesti si era scontrata con la necessità di stampare la Musurgia in tempi rapidi costringendolo a ripiegare sui tredici esempi che attualmente corredano il capitolo sulla teoria degli affetti: quattro dei quali sono ripresi da volumi a stampa del Palestrina e di Carlo Gesualdo da Venosa, due da uno stesso mottetto di Giovanni Troiani e sette dalle opere manoscritte e a stampa di un gruppo di musicisti con cui Kircher era in rapporti personali: Abbatini (che gli fornì da solo quattro esempi), Carissimi, Gino Angelo Capponi e Giuseppe Tricari-co.41
Certo, far dipendere queste scelte dalla facilità con cui Kircher poté procurarsi le musiche in questione non significa ancora negare che i compositori a cui si rivolse fossero i migliori presenti a Roma a metà Seicento, né escludere che la collaborazione da essi prestatagli implicasse un’adesione entusiastica alle sue proposte teorico-musicali. Per compiere questo passo ulteriore dobbiamo spostare la nostra attenzione
39 La tesi di cui si parla ha cominciato ad affermarsi un secolo dopo la morte di Kircher grazie a Esteban de Arteaga, un musicografo spagnolo che in gioventù aveva fatto parte anch’egli della Compagnia di Gesù. In un passo di una sua celebre storia dell’opera italiana costui contesta come segue quanto affermato nell’Historia musica di Bontempi circa l’inesistenza di qualsiasi rapporto fra il mondo musicale romano e la realizzazione della Musurgia universalis: «scorrer soltanto di volo le due prefazioni poste dal Kirchero avanti alla Musurgia [equivale a] veder ivi espressi i nomi di quelli stessi compositori romani citati da Buontempi [sic] con più altri assai de’ più famosi, i quali o consultati, o pregati, o con musica, o con trattato, o in altra maniera concorsero al compimento di quell’opera» (Arteaga 1785, vol. 1, 349). Si tratta di argomentazioni che, come mostra il contributo di Klaus Pietschmann al presente volume, sono ancor oggi alla base di varie ipotesi sull’incidenza positiva della Musurgia universalis nelle vicende musicali del secondo Seicento romano. In tal modo, però, gli studiosi continuano sostanzialmente a parafrasare quanto Kircher già affermava nella seconda prefazione della Musurgia, dichiarando di averla fatta esaminare e approvare pubblicamente dai massimi musicisti viventi («a praestantissimis huius temporis symphoniarchis, & in hoc Romano Urbis & Orbis theatro»). 40 Kircher 1650, I, 581. 41 Di Abbatini e Carissimi come consulenti e autori della Musurgia abbiamo già detto. Circa i suoi rapporti personali con Capponi, Kircher ne accenna nel secondo tomo, lì dove presenta una cantata composta con tecnica automatica da un prelato della curia romana, Bernardino Rocci, privo di particolari cognizioni musicali (Kircher 1650, II, 166). Capponi è qui citato come il musicista incaricato da Kircher di controllare la realizzazione della cantata onde evitare che «quispiam ex malevolis» insinuasse che non era opera di Rocci. Quanto a Giuseppe Tricarico – la cui posizione marginale negli ambienti musicali romani risulta dalla generica qualificazione professionale («in accademiis experto») attribuitagli in un volume a stampa del 1649 (RISM A/I: T 1214) – la conoscenza diretta che ne ebbe Kircher si desume dalla circostanza che questi lo cita come «omnibus Naturae donis instructus» (Kircher 1650, I, 607), elogiandolo non soltanto come musicista.
Claudio Annibaldi
70 sul rapporto fra il rilievo dato da Kircher agli autori contemporanei citati a vario titolo nella Musurgia e il ruolo da essi effettivamente svolto sulla scena musicale romana. Infatti non è certamente cosa di poco conto che Troiani, Tricarico e Capponi – vale a dire: un maestro di cappella che quella scena musicale non calcava più da un pezzo,42 un musicista che vi si era affacciato da poco, e un musicofilo altolocato che operava per definizione ai margini di essa – siano presenti nel Settimo libro con uno o più brani polifonici di loro composizione, mentre di molti grossi calibri della musica ro-mana di allora – dai cantori pontifici ai maestri di cappella delle maggiori basiliche della città – Kircher si limita a fare i nomi sia pure associandoli a epiteti ed elogi alti-sonanti. Se poi osserviamo come tali cerimoniosità verbali siano talora abbinate a osservazioni piuttosto atte a ferire la suscettibilità che a blandire la vanità dei musicisti interessati, annoverare quei grossi calibri fra i sostenitori della Musurgia si prospetta come un’operazione quanto meno incauta. Si pensi, per citare subito un caso sintoma-tico, ai cinque cantori pontifici che Kircher nomina nel passo del Settimo libro con-trassegnato a margine con la locuzione «Romanorum Musicorum sive Phonascorum Laus», magnificandone, sì, i talenti ma osservando nel contempo che solo con la guida di un maestro di cappella competente e il supporto di un repertorio appropriato avrebbero potuto esplicarli appieno.43
In altri termini, per interpretare come indice del livello di adesione dei musi-cisti romani alle proposte teorico-musicali di Kircher il numero di quelli da lui citati nella Musurgia, non basta valutare, in base ai dati biografici attualmente disponibili, la rappresentatività di costoro rispetto all’ambiente professionale d’appartenenza. Occor-re valutare il rilievo che Kircher conferisce a ciascuno di loro in rapporto a quello che conferisce agli altri, perché ogni sua possibilità di assicurarsi la solidarietà dei musicisti via via chiamati in causa dipendeva da quanto ognuno di loro giudicasse equilibrato quel rapporto. In ciò, certo, contavano eventuali rivalità professionali, ma contava molto di più una peculiarità delle relazioni interpersonali nella società circostante che stiamo per considerare più da vicino: l’acuto senso dell’onore che portava ogni indivi-duo a valutare i comportamenti altrui nei suoi confronti badando soprattutto a che risultassero rispettosi della propria immagine sociale.
42 Dopo il periodo in cui resse la cappella musicale della basilica di Santa Maria Maggiore (1596–1601), a cui fa riferimento Kircher, della carriera di Giovanni Troiani non risulta altro che l’inclusione di un sua composizione per due cori in un volume antologico uscito vent’anni dopo (RISM B/I: 16221). 43 «His igitur aut similibus egregijs musicis instructus industrius quispiam choragus, accedente praesertim elega(n)ti, ac ingeniosa compositione, posset […] uti mihi certo persuadeo, eos ipsos admirandos effectus, affectusque in auditorium animis excitare, quos tantopere depraedicant, ac posteritati commendarunt veterum olim historiarum scriptores» (Kircher 1650, I, 598). I cantori pontifici menzionati da Kircher in questo passo sono il soprano Domenico Palombi, il contralto Mario Savioni, i tenori Francesco Bianchi e Giovanni Marciano, e il basso Bartolomeo Nicolini.
Risvolti e strascichi polemici della Musurgia universalis
71 IV La rinuncia a utilizzare come esempi musiche di autori di varia nazionalità non fu l’unica che la necessità di stampare rapidamente la Musurgia impose ai capitoli con-cernenti la teoria degli affetti. Una rinuncia ancora più vistosa è documentata dal breve paragrafo in cui Kircher menziona Orazio Benevoli, Carlo Cecchelli, Francesco Foggia, Stefano Fabri e Bonifacio Graziani – maestri di cappella presso cinque fra le più importanti basiliche e chiese di Roma44 – invitando i lettori a cercare nelle compo-sizioni di costoro gli esempi necessari a completare la panoramica degli otto affetti-base avviata nelle pagine precedenti ma interrotta dopo l’ampia trattazione dei primi tre (amore, dolore, gioia) e di una sottospecie del secondo (l’affectus plangentium). Si tratta di un’interruzione tanto brusca da non lasciar dubbi, a mio avviso, che Kircher abbia finito per riconoscere come, pur valendosi esclusivamente di musiche di autori romani, non sarebbe mai riuscito a completare i capitoli corrispondenti ai cinque affetti residui (ira, stupore, superbia, disperazione, arroganza) senza rallentare il proces-so di stampa della sua opera.45 Stavolta però la soluzione di ripiego adottata – l’invito al lettore a proseguire per proprio conto, munendolo di sommarie indicazioni sulle musiche da consultare – era tanto astratta e impraticabile che Kircher non esitò a tornare sui propri passi per segnalare, quanto meno, un brano musicale associato speci-ficamente all’affetto d’ira. Così, messo da parte ogni riferimento alle opere dei cinque maestri testé citati, egli si concentra su un Beatus vir di Gino Angelo Capponi (già autore di uno dei tre esempi musicali dell’affetto di gioia) magnificandone l’articolazione ritmica degli ultimi versetti in quanto atta a esprimere, oltre all’affetto suggerito dal testo salmodico, altri affetti consimili.46
E’ questo un esempio illuminante su come i passi della Musurgia nei quali importanti musicisti romani sono oggetto di elogi pronti a trasformarsi in casus belli siano ispirati unicamente dalla coerenza di Kircher con i propri convincimenti. Dal suo punto di vista, infatti, anteporre Capponi ai più quotati maestri di cappella di Roma era del tutto consequenziale, visto che finanche il proprio progetto di riqualifi-cazione della ‹musica moderna› postulava che i professionisti della musica accettassero di farsi ammaestrare da un non-professionista come lui.47 E’ vero che ciò poteva non risultare altrettanto consequenziale agli occhi di cinque musicisti di professione, prima
44 Kircher 1650, I, 614. Il paragrafo in questione – il sesto del capitolo VI della Pars II (b) – fu evidentemente steso prima del 1 settembre 1649, giorno in cui Carlo Cecchelli – non Domenico, come scrive erroneamente Kircher – lasciò la direzione della cappella della basilica liberiana ad Abbatini. Una considerazione simmetrica vale per la seconda prefazione della Musurgia che, in quanto cita Abbatini come maestro di cappella della medesima basilica, fu evidentemente dettata dopo il passaggio di consegne fra i due musicisti (28 ottobre 1649). 45 Per una diversa ipotesi, secondo cui Kircher avrebbe interrotto la trattazione degli affetti rendendosi conto dell’inadeguatezza della classificazione adottata, cfr. Schaal-Gotthardt 2007, 150s. 46 Kircher 1650, I, 614. 47 Su questo tema centrale del pensiero teorico-musicale di Kircher cfr. Annibaldi/Cinque 2007, 63s.
Claudio Annibaldi
72 elogiati come «symphoniarchi praestantissimi» e poi scalzati da un compositore dilet-tante, ma era un rischio comportato dall’elevatezza del progetto medesimo, che non tutti potevano apprezzare come meritava.
Un esempio più complesso della coerenza intellettuale di Kircher è rappresen-tato dalle citazioni che egli riserva nel Sesto e nel Settimo libro a Gregorio Allegri – il più illustre dei cantori pontifici allora al servizio di Innocenzo X48 – in quanto inevita-bilmente destinate ad attirare l’attenzione del Collegio dei cantori pontifici di cui Allegri faceva parte di diritto: un’istituzione composta, all’epoca, da una trentina di musicisti che la pretesa di essere i migliori del mondo portava puntualmente a insorge-re come un sol uomo a ogni offesa, vera o presunta che fosse, arrecata alla reputazione dei suoi membri.49 Ora, se consideriamo che Allegri è citato nel Settimo libro come erede dei maestri storici dello stylus ecclesiasticus ed è presentato nel Sesto come auto-re di una sinfonia per viole (ovviamente elogiata da Kircher come perfetto esempio di musica per ensemble di strumenti ad arco),50 dobbiamo ammettere che esistevano due buoni motivi perché il Collegio dei cantori pontifici si adontasse per come il suo espo-nente più illustre veniva trattato nella Musurgia. Uno era il pregiudizio corrente verso la musica strumentale, tuttora considerata inferiore a quella vocale (un pregiudizio a cui ne era spesso associato un altro, che dava per scontata l’inettitudine degli autori di musiche per strumenti a comporre per le voci umane);51 l’altro era costituito dai ricor-renti attriti fra il Collegio e tre musicisti che invece la Musurgia trattava con tutti gli onori: Abbatini, Romano Micheli e Pier Francesco Valentini.52
48 Basterà ricordare al riguardo i segni di apprezzamento rivolti ad Allegri da Innocenzo X, che nell’ottobre 1649 gradì assai l’esecuzione di sua messa e nel gennaio successivo mostrò «segni di gusto non ordinario» per la sua elezione a maestro della Cappella pontificia per l’anno santo in corso (I-Rvat, Diari sistini, n. 68, cc. 39r e 66r, 4 ottobre 1649 e 1 gennaio 1650). 49 Per un esempio delle misure punitive adottate dal Collegio contro i suoi denigratori si veda la seguente nota 52. 50 La symphonia pro chelybus di Allegri, l’unica composizione strumentale che gli è tuttora attribuita, si trova in Kircher 1650, I, 487–494. Mette conto ricordare che gli altri esempi d’autore utilizzati da Kircher nello stesso capitolo del Sesto libro (466–475 e 480ss.) sono appropriatamente firmati da ‹suonatori› come Johann Jakob Froberger, all’epoca organista alla corte imperiale di Germania, e il tiorbista romano Lelio Colista. 51 Che i cantori pontifici condividessero tali pregiudizi è dimostrato dal testo di Antimo Liberati che consideremo nell’ultima sezione del presente contributo (Liberati 1685, 36 e 55s.). Ma non vanno in altra direzione i cenni della Musurgia ad alcuni generi di musica per strumenti da tasto come semplici introduzioni a performances vocali (Kircher 1650, I, 465). 52 Fra il 1644 e il 1645, ad esempio, Micheli e Valentini ebbero a criticare aspramente il canone composto da Allegri per l’epitaffio del sepolcro collettivo dei cantori pontifici in Santa Maria alla Vallicella (Gerbino 1995, 90ss.). Quanto ad Abbatini, va ricordato che nel 1649 costoro decisero di punirne le ricorrenti scorrettezze nei propri confronti vietando a tutti i componenti del loro Collegio di collaborare occasionalmente con lui (I-Rvat, Diari sistini, n. 68, cc. 51r–53v, 30 novembre 1649). Il provvedimento fu disposto mentre Abbatini stava redigendo la relazione sulla Musurgia più volte citata, sicché Kircher ne fu certamente a conoscenza. Non è dunque è da escludersi che si sia adoperato per ottenerne la revoca, visto che a convincere in tal senso il Collegio dei cantori pontifici fu Pompeo Colonna (I-Rvat, Diari sistini, n.69, c. 23v, 14 aprile 1650): il principe romano i cui interessi
Risvolti e strascichi polemici della Musurgia universalis
73 Stavolta è impensabile che Kircher non si rendesse conto che una presenta-zione ambigua della figura di compositore di Allegri era esposta al rischio di essere interpretata come una conferma delle riserve espresse sulla statura compositiva di costui da Abbatini, Micheli e Valentini. Tuttavia è pur sempre la sua straordinaria coerenza con i propri convincimenti a offrire la spiegazione più verosimile del perché egli non abbia fatto nulla per evitare tale rischio. Infatti, se l’ambizione di coinvolgere tutta la Roma musicale nelle sue proposte di rinnovamento della ‹musica moderna› gli imponeva di tener conto anche della Cappella pontificia, ciò non poteva fargli dimen-ticare la valutazione dell’attività musicale di Allegri e dei suoi colleghi espressa nel passo del Settimo libro ricordato più sopra per le critiche rivolte alla colpevole autore-ferenzialità dei maestri di cappella romani e alla conseguente mediocrità della musica eseguita ‹anche nelle sedi più prestigiose›. È questa una locuzione già sufficiente a farci includere, fra i destinatari di tali critiche, i cantori addetti alla persona del papa re-gnante. E in ogni caso essa è seguita poco dopo da una domanda retorica – «Quis Orlandi, Moralis, Praenestini [ingenium et dexteritatem] eorum(que) ingeniosum in harmonis [sic] contextu(m) ex modernis assequitur?»53 – che non lascia dubbi su come, secondo Kircher, la gloriosa tradizione polifonica di cui quei cantori si vantavano di essere i depositari fosse ancora in attesa di un compositore in grado di riprenderne degnamente la lezione.
Possiamo finalmente procedere alla verifica rinviata dianzi circa la possibilità che il suo progetto di riqualificazione della ‹musica moderna›, e specialmente di quella sacra, abbia guadagnato a Kircher l’approvazione delle autorità ecclesiastiche che negli ultimi anni si erano ripetutamente adoperate per arginare il decadimento dei servizi musicali nelle chiese di Roma. Non c’è dubbio, infatti, che una tale approvazione avrebbe reso meno risentite le reazioni con cui il mondo musicale romano rispose alle molteplici provocazioni rivoltegli dalla Musurgia universalis.
In effetti, segnali in tal senso sembrerebbero provenire addirittura dal vertice della corte papale. Si pensi all’ordine che Innocenzo X impartì nel Natale 1652 ai suoi cantori perché nelle messe papali si astenessero dal praticare il cosiddetto contrappunto alla mente, un’antica tecnica d’improvvisazione vocale a più voci criticata da Kircher nel Quinto libro della Musurgia.54 Oppure si pensi alla chiusura mediante apposite gelosie delle cantorie dove operavano quotidianamente i cantori papali, che fu realizza-ta all’inizio del pontificato di Alessandro VII attuando di fatto una misura caldeggiata scientifici e letterari sono elogiati nella prima prefazione della Musurgia e una cui canzone Al Serenissimo Leopoldo Arciduca d’Austria è pubblicata subito dopo la lettera dedicatoria dell’opera. 53 Kircher 1650, I, 563. I compositori citati insieme a Giovanni Pierluigi da Palestrina sono, ovviamente, Orlando di Lasso e Cristóbal Morales. Essendo sottintese dalla costruzione grammaticale della frase, nella prima parentesi quadra si riportano due parole che fanno parte della frase immediatamente precedente. 54 Ibid., 242. Per le disposizioni di Innocenzo X sulla tecnica improvvisativa in questione e le reazioni dei cantori pontifici cfr. I-Rvat, Diari sistini, n. 70. cc. 49v–52v, 25 dicembre 1652.
Claudio Annibaldi
74 da Kircher nel deplorare, come abbiamo visto, la mimica indecorosa di molti cantori.55 Né va dimenticata, su un piano più generale, la cristallizzazione dei repertori della Cappella pontificia nel secondo Seicento che finì per fare di questa istituzione plurise-colare una sorta di sacrario della polifonia vocale ‹a cappella›. È questo un esito che, quando non è apertamente biasimato, viene letto dagli studiosi moderni in chiave di una sorta di ‹divisione del lavoro› fra le cappelle romane, quasi che quella pontificia fosse esclusa dalla «coltivazione di forme più moderne e più monumentali di polifonia sacra».56 Nondimeno esso collima troppo perfettamente con quella visione conservatri-ce della composizione polifonica, che portava Kircher a ignorare tutta la vasta area della prassi musicale coeva non riconducibile alla sfera del contrappunto cinquecente-sco,57 per non chiedersi se, oltre a ispirare due pontefici, la Musurgia abbia fatto brec-cia anche nelle scelte di repertorio della cappella musicale addetta alla loro persona.
Purtroppo tutti i segnali di cui si parla perdono consistenza appena si proceda a contestualizzarli. Appurare che, di fronte alle vivaci proteste dei suoi cantori, Inno-cenzo X revocò l’ordine di abolire il contrappunto alla mente dalle messe papali accon-tentandosi di una riduzione del numero dei canti della messa eseguiti secondo quella tecnica improvvisativa, è tutt’uno che accorgersi come questo papa, ormai quasi ottan-tenne, non intendesse affatto riformare le tradizioni esecutive della sua cappella ma solo abbreviare la durata delle funzioni solenni che prevedevano la sua presenza.58 Analogamente, quando ci si rende conto che passarono nove anni prima che la recin-zione delle cantorie dei palazzi apostolici del Vaticano e del Quirinale fosse estesa alle chiese di Roma e che nel 1665 ciò avvenne per decreto della Congregazione della Sacra Visita Apostolica, diventa assai difficile attribuire ad Alessandro VII uno speciale interesse per tale provvedimento (non a caso non ve n’è traccia nel breve del 1657 con cui egli intervenne personalmente sulla regolamentazione dei servizi musicali nelle chiese cittadine).59 Quanto poi al passatismo delle scelte di repertorio della Cappella pontificia seicentesca sarebbe più plausibile vedervi il modello dell’ideale di polifonia sacra vagheggiato da Kircher che non azzardare l’ipotesi contraria, giacché si tratta di un fenomeno prodotto da fattori storici e culturali con cui le idee di lui non ebbero nulla a che fare. Si consideri, per convincersene, che il fattore più importante in tal
55 I-Rvat, Diari sistini, n. 74, cc. 10v e 13r, 13 aprile e 24 maggio 1656. 56 Bianconi 1991, 117. 57 È noto come la sola menzione della Musurgia alla tecnica del basso continuo – che pure è utilizzata in non pochi brani d’autore scelti da Kircher come esempi musicali – consista in un fuggevole cenno alla sua invenzione da parte di Ludovico Grossi da Viadana (Kircher 1650, I, 544). 58 Non sarà inutile aggiungere che il compromesso raggiunto con i suoi cantori resse finché Innocenzo X restò in vita: appena i riti funebri per la sua morte si furono conclusi, quelli tornarono a praticare il contrappunto alla mente come avevano sempre fatto (I-Rvat, Diari sistini, n. 73, cc. 8v–9r, 18 gennaio 1655). 59 Per maggiori ragguagli sui documenti qui citati cfr. Romita 1936, 77ss. (per il breve papale del 1657), e Bianconi 1991, 117ss. (per l’editto del 1665).
Risvolti e strascichi polemici della Musurgia universalis
75 senso fu la gestione clientelare dei meccanismi di reclutamento dei cantori praticata sistematicamente dai papi succedutisi nell’arco del Seicento, con conseguente svili-mento dei concorsi a cui era tradizionalmente affidata la selezione dei componenti della Cappella papale e progressiva scomparsa di cantori-compositori in grado di rin-novarne i repertori.60
A questo punto si sarebbe tentati di concludere che Roma contribuì in ma-niera decisiva a fare della Musurgia universalis l’opera che conosciamo ma fu anche la città in cui la sua diffusione rimase circoscritta più che altrove alla cerchia dei musico-fili altolocati e dei musicisti ‹speculativi› con cui Kircher era entrato in contatto sin dai suoi primi anni romani. Tuttavia non è ancora il momento di tirare le somme del percorso compiuto sin qui, restando da considerare una testimonianza d’epoca che, se nella sostanza non modifica la conclusione abbozzata or ora, l’arricchisce di un impor-tante dettaglio, in quanto suggerisce come la provocatorietà di cui la Musurgia potè caricarsi agli occhi dei musicisti romani non fu l’unico motivo per cui essi non riten-nero di prenderla «né meno per ombra, non che per corpo reale, in considerazione».
V Nel 1684 il contralto pontificio Antimo Liberati (1617–1692) fu invitato a pronun-ciarsi sulle prove compositive di cinque concorrenti al posto di maestro di cappella del duomo di Milano. Era una richiesta che rientrava nell’usanza di ricorrere al Collegio dei cantori pontifici per consulenze o arbitrati concernenti questioni tecnico-musicali, ed egli la soddisfece nella maniera più consona alla fama dell’istituzione di cui faceva parte, stendendo un rapporto denso di riferimenti eruditi e di puntuali rinvii ai precet-ti della «nostra scola» (come Liberati definisce tout court la tradizione compositiva risalente al Palestrina) che fu stampato l’anno dopo con il titolo di Lettera scritta dal sig. Antimo Liberati in risposta ad una del sig. Ovidio Persapegi.61
Ad attirare l’attenzione sulla citazione della Musurgia universalis che ricorre in tale contesto sono vari elementi. Da un lato c’è la concidenza della carriera di Libe-rati nella Cappella papale con gli ultimi due decenni della vita di Kircher e l’importanza generalmente riconosciuta a questa Lettera come «il primo manifesto ideologico attraverso cui fu costruita l’identità di una scuola musicale romana»:62 per
60 Su questo tema cfr. Annibaldi 2011. 61 Sul destinatario della Lettera sappiamo solo quanto si evince dal prosieguo del titolo della versione a stampa, e cioè che fu la persona che scrisse a Liberati chiedendogli di indicare la migliore prova compositiva fra le cinque sottoposte al suo giudizio. Il fatto che nel corso della Lettera Liberati apostrofi Persapegi come ‹signore› senza l’aggiunta di attributi onorifici (illustre, illustrissimo eccetera) suggerisce di identificare costui con un incaricato della commissione giudicatrice del concorso in questione. 62 Morelli 2008, 129. Quanto alla carriera di Liberati all’interno della Cappella pontificia, egli vi fu ammesso nel 1661 ma aveva tentato di entrarvi già quindici anni prima.
Claudio Annibaldi
76 cui si sarebbe portati a leggere la citazione in parola come chiave del ruolo effettiva-mente svolto dai cantori pontifici nella recezione della Musurgia. Dall’altro lato c’è la circostanza che Liberati è il solo cantore pontificio del Seicento a cui sia attribuibile una conoscenza diretta di quest’opera,63 e che oggetto di questa sua Lettera sono que-stioni di teoria e tecnica della composizione: il che porterebbe a cercare in detta cita-zione qualche indizio sull’influsso esercitato dalla teoria kircheriana del comporre sulla prassi dei musicisti romani di fine secolo.
In realtà neppure una di tutte queste aspettative trova un riscontro nella Let-tera di Liberati. Questi, infatti, si limita a menzionare la Musurgia nel corso di un dotto excursus sulle controversie teoriche susseguitesi nella storia della musica, che gli offre il destro di ricordare le critiche che «ultimamente fece il Mehibomio [sic], per altro valorosissimo commentatore, ed interprete di molti autori greci, in una sua argu-tissima apologia contro il Kircherio nella sua Musurgia, il medemo ancora vivente passandosela sub silentio senza alcuna risposta».64 Più che compiere un ultimo passo avanti, quindi, sembrerebbe d’essere tornati al punto di partenza: a valutare, cioè, il ricordo che un musicista formatosi, proprio come Bontempi, nelle «scole di Roma» poteva serbare delle polemiche che la pubblicazione della Musurgia vi aveva innescato a metà Seicento. D’altronde come interpretare l’accento posto da Liberati sulla manca-ta replica di lui alle critiche di Meibom se non come allusione maliziosa alla vulnerabi-lità di Kircher anche in discipline che rientravano nelle sue competenze scientifiche, e quindi come motivo ulteriore per diffidare dei suoi sconfinamenti en amateur nel campo della teoria musicale?
C’è però un dato che differenzia la Lettera in questione dalle pagine autobio-grafiche dell’Historia musica di Bontempi: l’assenza di una valutazione esplicita della Musurgia. Che è un’assenza marginale, se ci si limita a collegarla all’intenzione di Liberati di evitare divagazioni teoriche per concentrarsi sulle musiche sottoposte al suo giudizio,65 ma che diventa fondamentale se la si considera alla luce di un concetto ripetuto da Liberati fino alla noia: «la musica è una mera opinione […] di cui non si può dar certezza veruna».66 A ben vedere, infatti, codesta sua insistenza rinvia a una visione della scienza musicale in cui la classica bipartizione in ‹musica teorica› e ‹musi-ca pratica› sembra aver ceduto il passo a una compartimentazione in settori disciplinari
63 Liberati cita i capitoli del Settimo libro relativi alla musica antica nella sua Epitome della musica: un volumetto manoscritto «concernente il principio della musica, et in che modo fosse rimessa in piedi molte volte», da lui steso nel 1665 per uso personale di Alessandro VII (I-Rvat, Diari sistini, n.83, c.10r, 1 gennaio 1666). Dal punto di vista culturale, peraltro, Liberati rappresentava un’eccezione rispetto ai suoi colleghi della Cappella pontificia, dato che in gioventù si era dedicato a studi letterari e giuridici, e aveva anche esercitato per qualche tempo la professione di notaio. 64 Liberati 1685, 15. 65 Ibid., 14. 66 Ibid., 12. Varianti di questa sua asserzione ricorrono a 15s., 16, 22, 31, 37, 39, 48–50.
Risvolti e strascichi polemici della Musurgia universalis
77 incomunicanti, in conseguenza della quale Liberati può apprezzare, non diversamente da come avrebbe potuto fare Kircher, i meriti di un ‹musico speculativo› come Pier Francesco Valentini e allo stesso tempo riferirsi alla propria attività di musico pratico con affermazioni come «quella musica è stimata bona e perfetta che deletta [sic] più all’orecchio» oppure «servire, ed essercitarsi [sic] nelle cappelle per prezzo […] è il vero stimolo d’approfittarsi in questa virtù»,67 che sono agli antipodi dei moniti lanciati da Kircher ai musicisti che componevano a orecchio o scrivevano musica per danaro anziché per farsi onore.68
Che una tale divaricazione fra teoria e prassi sia da riferirsi alla dinamica della musica d’arte del XVII secolo è difficile negare. È ben noto, ad esempio,69 che «dentro la cornice teorica e pratica dell’arte contrappuntistica tramandata dal secolo preceden-te» quella dinamica introdusse «maniere compositive diverse», a fronte delle quali «gli strumenti compositivi necessari e sufficienti per comporre un mottetto, un madrigale [erano] necessari ma insufficienti a comporre una cantata, una toccata, una ciaccona, un’aria, un oratorio». Ed è altrettanto noto che codesti vuoti teorici furono colmati, «intieramente, dalla prassi quotidiana dell’imitazione diretta» con conseguente avvento di due fenomeni epocali: «in termini istituzionali, un potenziamento del concetto di scuola, per via del maggior ruolo diretto del maestro in mancanza di un canone teorico ampio ed esauriente; in termini di poetica, un adeguamento mimetico alla moda, al ‹gusto› musicale del momento».
Se ciò è corretto, la Lettera di Liberati si prospetta come un pendant delle pa-gine autobiografiche di Bontempi non già per echeggiare a suo modo le polemiche che accompagnarono la pubblicazione della Musurgia, ma per integrare così perfettamente il loro valore documentario da dar conto della loro stessa drasticità nei confronti delle «sciocchezze del Kirchero». Infatti, laddove Liberati testimonia della situazione dei professionisti della musica del secondo Seicento, costretti a navigare nel mare infido delle mode senza altra bussola che i precetti della scuola d’appartenenza, Bontempi testimonia della situazione dei giovani che venivano contemporaneamente avviati a una professione musicale tramite un tirocinio basato su una «mistura di apprendimen-to formalizzato e canonico e di apprendimento mimetico»70 al cui confronto le astra-zioni dei teorici finivano davvero per risultare elucubrazioni prive di senso.
Le mie considerazioni sui risvolti e gli strascichi polemici della Musurgia uni-versalis sullo sfondo della Roma musicale del secondo Seicento terminano qui. Ma prima di congedarmi dal lettore vorrei soffermarmi brevemente sull’interrogativo
67 Ibid., 15s. e 26. Il secondo passo è contestuale all’apprezzamento di Valentini come «peritissimo teorico, e specolativo [sic] musico». 68 Kircher 1650, I, 562s. 69 Tutte le citazioni di questo capoverso sono tratte da Bianconi 1991, 51 e 67. 70 Ibid., 68.
Claudio Annibaldi
78 «Steinbruch oder Wissengebäude?», scelto come sottotitolo del convegno di cui il presente volume raccoglie gli atti. Benché concepito come invito a una valutazione complessiva delle proposte teorico-musicali di Kircher, esso si presta benissimo a veri-ficare la pertinenza del percorso qui compiuto e della sua complementarità rispetto al percorso retrostante la relazione che ho presentato con Maria Teresa Cinque al conve-gno kircheriano del 2002.
ll punto è che, pur riprendendo la stessa tematica (le critiche di Kircher ai musicisti romani come pars destruens del suo progetto di rinnovamento della ‹musica moderna›; le reazioni negative di coloro come prova del fallimento del progetto stesso), i due percorsi mi hanno indotto a collegare tale insuccesso, nel primo caso, all’ambiguità genetica della ‹scienza gesuitica› del XVII secolo, e nell’altro, al pragmati-smo del coevo professionismo musicale. Ora, tali chiavi di lettura collimano alla perfe-zione con le opzioni suggerite dalla domanda «Steinbruch oder Wissengebäude?». Infatti, ove si consideri la coerenza ideologica della Musurgia con la nozione di scienza coltivata negli ambienti in cui operò professionalmente Kircher, non si può non defi-nirla una costruzione scientifica e porla, come tale, fra i maggiori esiti della musicogra-fia seicentesca, mentre, ove si considerì l’utilità che poteva trarne il nuovo professioni-smo musicale del tempo, non si può che considerarla una ‹cava di materiali› a cui attingere secondo le proprie esigenze personali. Né ciò si deve soltanto alla contradit-torietà fra i due tomi, a cui ho accennato nella sezione iniziale del presente contributo, perché vi contribuisce anche la diversissima capacità d’attrazione che i libri di ciascun tomo, i rispettivi capitoli e persino i singoli paragrafi potevano esercitare sui musici pratici del secondo Seicento. Valga per tutti l’esempio della lettera da Vienna del 18 settembre 1649, con cui Johann Jakob Froberger riferisce a Kircher di aver consegnato all’imperatore Ferdinando III la macchina compositiva che aveva prelevato mesi addie-tro a Roma, dopo essersene impratichito sotto la guida personale del suo inventore. Si trattava di una macchina davvero mirabolante, con cui sarebbe stato possibile realizza-re musiche in cinque stili diversi, ma non è ad essa che il musicista si mostra interessa-to bensì a un metodo per la costruzione di canoni «per via della mathematica» rivela-togli in gran segreto da Kircher nel loro ultimo incontro romano.71 Ne consegue che, se avesse avuto a disposizione l’Ottavo libro della Musurgia dove le ‹materie curiose› della costruzione matematica di canoni musicali e della composizione automatica in più stili sono trattate consecutivamente, il Kammerorganist di Ferdinando III si sareb-
71 REGESTO n. 30. Su questo episodio della biografia di Froberger e il testo della lettera qui citata cfr. Annibaldi 1998: un articolo che smentisce l’ipotesi formulata in Scharlau 1969b, 39 e 350s., secondo cui il musicista sarebbe tornato a Roma, dove aveva già studiato con Frescobaldi, per completare la sua formazione con Giacomo Carissimi. Colgo l’occasione per rettificare quanto si afferma su tale episodio in una relazione del convegno kircheriano del 2002 (Klotz 2007, 27s.), attribuendo erroneamente la ricostruzione sull’apprendistato di Froberger con Kircher «agli studi di Carlo Maria Chierotti» anziché ai miei.
Risvolti e strascichi polemici della Musurgia universalis
79 be concentrato sul paradoxum I, che apre il capitolo IX della Pars IV, e avrebbe saltato a pie’ pari il paradoxum II che lo segue a distanza di neppure mezza pagina.72
A questo punto mi si potrebbe obiettare che il quesito «Steinbruch oder Wis-sengebäude?» sottintende un aut aut mentre io l’ho sostituito con un et et. La mia risposta coincide con l’osservazione con cui chiusi la relazione per il convegno del 2002: la prospettiva di un’opera labirintica come la Musurgia dipende essenzialmente dal varco attraverso cui penetriamo al suo interno. Pertanto quella che ho tracciato di essa, prima nella relazione suddetta e ora nel presente contributo, è unicamente la prospettiva di chi si è addentrato nei suoi meandri attraverso lo spiraglio delle polemi-che che ne accompagnarono la pubblicazione nella Roma di metà Seicento. Il che naturalmente non toglie che io ritenga degno di nota aver tentato l’impresa due volte, aver seguito ogni volta un percorso diverso e aver ottenuto risultati che si rafforzano a vicenda, essendo in entrambi i casi approdati a un punto di vista della Musurgia uni-versalis che non ha più bisogno di riferirsi a polemiche di sorta per spiegare come mai essa sia stata molto meno universale di quanto Kircher avrebbe voluto.
72 Per i due paradoxa in questione cfr. Kircher 1650, II, 165–184. Il secondo è praticamente costituito dalla cantata di Rocci menzionata nella precedente nota 41, giacchè Kircher ritiene opportuno non fornire informazioni sulla tecnica usata nella composizione (su motivi di questa sua reticenza si veda la precedente nota 35). Su come Rocci si sia servito, con ogni evidenza, di un’arca musurgica simile a quella consegnata da Froberger a Ferdinando III cfr. Annibaldi 1998, 52s.