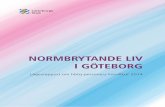Da Ariosto al "Ballo delle Ingrate". Un itinerario di affluenze
Shakespeare, Ariosto e Pasqualigo: due congetture per le fonti di \"Cymbeline\", in...
Transcript of Shakespeare, Ariosto e Pasqualigo: due congetture per le fonti di \"Cymbeline\", in...
IDA CAMPEGGIANI
SHAKESPEARE, ARIOSTO E PASQUALIGO: DUECONGETTURE PER LE FONTI DI CYMBELINE
ESTRATTOda
RINASCIMENTO2014 ~ a. 54
ISSN 0080-3073
VOLUMELIV
Rin
asci
men
to
Olschki
2014
Rinascimentodirettore
Michele Ciliberto
ISTITUTO NAZIONALE
DI STUDI SUL
RINASCIMENTO
Seconda SerieVOLUME LIV
Leo S. Olschki Editore
2014
ISTITUTO NAZIONALE
DI STUDI SUL
RINASCIMENTO
Rinascimentodirettore
Michele Ciliberto
Seconda SerieVOLUME LIV
Leo S. Olschki Editore
2014
DirettoreMICHELE CILIBERTO
Comitato scientifico
MICHAEL J. B. ALLEN - SIMONETTA BASSI - ANDREA BATTISTINI - FRANCESCOBAUSI - GIUSEPPE CAMBIANO - MICHELE CILIBERTO - CLAUDIO CIOCIOLA - BRIANP. COPENHAVER - MARIAROSA CORTESI - GERMANA ERNST - MASSIMO FERRETTIMASSIMO FIRPO - GIAN CARLO GARFAGNINI - SEBASTIANO GENTILE - MARIANOGIAQUINTA - TULLIO GREGORY - JAMES HANKINS - FABRIZIO MEROI - FILIPPOMIGNINI - VITTORIA PERRONE COMPAGNI - LINO PERTILE - ADRIANO PROSPERIFRANCISCO RICO - ELISABETTA SCAPPARONE - LORIS STURLESE - JOHN TEDESCHI
Segretario di redazioneFABRIZIO MEROI
RedazioneSALVATORE CARANNANTE - LAURA CAROTTI - FRANCESCA DELL’OMODARME
ELISA FANTECHI - LAURA FEDI - ILENIA RUSSO
Per contatti e invii: [email protected] scritti proposti per la pubblicazione sono sottoposti a double blind peer review.
Direzione - RedazioneIstituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Palazzo Strozzi, 50123 Firenze
Tel. 055.28.77.28 • Fax 055.28.05.63 • E-mail: [email protected] • http://www.insr.it
AmministrazioneCasa Editrice Leo S. Olschki • Casella postale 66, 50123 Firenze
Viuzzo del Pozzetto 8, 50126 FirenzeTel. 055.6530684 • Fax 055.6530214 • e-mail: [email protected]
Conto corrente postale 12707501
Abbonamento annuo 2014ISTITUZIONI - INSTITUTIONS
La quota per le istituzioni è comprensiva dell’accesso on-line alla rivista.Indirizzo IP e richieste di informazioni sulla procedura di attivazione
dovranno essere inoltrati a [email protected] rates for institutions include on-line access to the journal.
The IP address and requests for information on the activation procedureshould be sent to [email protected] € 115,00 • Foreign € 134,00
(solo on-line - on-line only € 103,00)
PRIVATI - INDIVIDUALS
(solo cartaceo - print version only)Italia: € 104,00 • Foreign € 110,00
Direttore responsabile: MICHELE CILIBERTO
Registrazione del Tribunale di Firenze n. 1381 del 2 luglio 1960
~ V ~
SOMMARIO
Saggi e testimonianze
IÑIGO RUIZ ARZALLUZ, Su un’ipotetica Prefazione C al De viris illus- tribus di Petrarca . . . . . . . . . . . . . . p. 3
MICHAEL J. B. ALLEN, Marsilio Ficino’s Last Great Achievement: his Commentaries on the Mystical Theology and the Divine Names of Dionysius the Areopagite . . . . . . . . . . . » 51
SEBASTIANO GENTILE, Vasoli, Ficino e il mito dei ‘prisci theologi’ . » 69MASSIMO FIRPO, Baccio Bandinelli e il coro di Santa Maria del Fiore » 85SARA OLIVIA MIGLIETTI, Al di là dell’‘auteur d’un seul livre’: Cesa-
re Vasoli lettore di Jean Bodin . . . . . . . . . . » 133IDA CAMPEGGIANI, Shakespeare, Ariosto e Pasqualigo: due congettu-
re per le fonti di Cymbeline . . . . . . . . . . . » 147
Testi e commenti
GIOVANNI LICATA, An Unpublished Letter of Elijah del Medigo to Giovanni Pico della Mirandola: de nervis et sensu tactus . . » 175
Note e varietà
GUILLAUME ALONGE, Dalla carità all’eresia. Il Divino Amore e il dis-senso religioso nell’Italia del primo Cinquecento . . . . . » 187
LAURA CAROTTI, Due note su Giordano Bruno . . . . . . . » 211
Rassegne
ANDREA SUGGI, Jean Bodin filosofo del Rinascimento. Rassegna de-gli studi 1996-2014 . . . . . . . . . . . . . . » 237
Sommario
~ VI ~
Indice dei manoscritti . . . . . . . . . . . . . p. 273
Indice dei nomi . . . . . . . . . . . . . . . » 275
~ 147 ~
IDA CAMPEGGIANI
SHAKESPEARE, ARIOSTO E PASQUALIGO: DUE CONGETTURE PER LE FONTI DI CYMBELINE *
ABSTRACT. – This essay aims to demonstrate the influence that two Italian au-thors, Ludovico Ariosto and Alvise Pasqualigo, may have had on Shakespeare’s Cymbeline. Ariosto’s play Il Negromante is proposed as a possible source, par-ticularly for dramaturgical choices and for the character of Iachimo, whose mod-el may have been Ariosto’s Iachelino. Some precise references to the Orlando fu-rioso are then highlighted. Finally, convergences with Pasqualigo’s tragicommedia Il Fedele are illustrated. Each proposal is supported by a close reading of the text.
«Io non difendo Cymbeline. È in massima parte ciarpame teatrale di infimo ordine melodrammatico»: con questo giudizio George Bernard Shaw cominciava la sua recensione allo spettacolo del Cymbeline mes-so in scena nel 1896 da Henry Irving.1 Effettivamente il dramma shake-speariano non ha goduto di grande fortuna critica, e il punto di vista di Shaw incontra quello di tutti coloro che ne hanno sottolineato il caratte-re molteplice e disomogeneo. Le incongruenze sono numerose, anomale anche per Shakespeare, che notoriamente si concedeva frequenti licenze fantastiche: riguardano la rappresentazione storica, perché nell’epoca del-la guerra condotta dai Romani in una Britannia eroica e primigenia, cioè il I secolo a.C., sembra aprirsi uno squarcio sulla Roma rinascimentale; e coinvolgono i generi, in quanto il dramma storico sfuma nell’idillio pasto-
[email protected]* Desidero ringraziare Lina Bolzoni, Alberto Casadei e Nadia Fusini per l’attenta lettu-
ra di questo saggio.1 La recensione, intitolata Blaming the Bard, apparve nel 1896 sul «Saturday Review»: cfr.
G. B. SHAW, Dramatic Opinions and Essays with an Apology, ed. by J. HUNEKER, 2 voll., New York 1922 [1906], II, pp. 51-59: 51: «I do not defend Cymbeline. It is for the most part stagey trash of the lowest melodramatic order [...]». Shaw scrisse anche un’originale versione del quin-to atto di Cymbeline, che trovava insoddisfacente soprattutto per le agnizioni che vi si susseguo-no a un ritmo intollerabile per il lettore moderno: cfr. ID., Cymbeline Refinished, & Good King Charles, London 1946, pp. 131-150.
Ida Campeggiani
~ 148 ~
rale. In più la pluralità dei personaggi, dei frangenti narrativi e dei sen-timenti messi in scena quasi confonde; Shaw, da uomo di teatro, doveva riferirsi soprattutto a questi ultimi aspetti, che potremmo definire dram-maturgici poiché legati alla struttura del testo, anzitutto alle sue compli-cazioni a livello di trama.
Ma sarebbe opportuno pretendere di trovare nel Cymbeline i confini rassicuranti di una trama principale? 2 Gli editori e i commentatori recen-ti, da Nosworthy a Melchiori e Boitani,3 sembrano caldeggiare una lettura il più possibile aperta e problematica, che rispetti l’essenza di questo testo: quella di una mistura di storie ciascuna delle quali derivante da una fonte diversa. Certo era consuetudine per Shakespeare prendere la sua materia da ogni dove, assimilare e fondere spunti disparati; ma nel Cymbeline la pluralità delle fonti sembra davvero all’origine del suo carattere composi-to e in definitiva sperimentale. Una chiave di lettura valida per questo te-sto potrebbe essere quella ormai consolidata per l’intera produzione tar-da di Shakespeare, e cioè la chiave del romance, o dramma romanzesco. Si tratta di una definizione equivalente all’espressione «tragicommedia»,4 la quale designa le commedie gravi che fiorirono in Italia nel secondo Cin-quecento. E in effetti somiglianze sul piano strutturale con le tragicom-medie italiane sono state riscontrate in varî drammi (ricordiamo almeno due casi diversamente esemplari, quelli di Midsummer Night’s Dream e di The Twelfth Night: il primo ha stimolato la fondamentale riflessione teo-rica di Louise George Clubb sulla trasmissione in Inghilterra dei caratteri della commedia grave; il secondo è oggetto di un saggio di Hilary Gatti, che riprende le congetture di Frances Yates e Gilberto Sacerdoti intor-no alle fonti bruniane di Love’s Labour’s Lost sviluppandole da un punto di vista squisitamente drammaturgico); 5 e quando si parla di influssi sul-
2 Punto di vista sotteso al giudizio insoddisfatto di Frank Raymond Leavis, per il quale il dramma non rappresenta un organismo completo, non essendo improntato in tutte le sue parti a una emozione ideale. Cfr. F. R. LEAVIS, A Criticism of Shakespeare’s Late Plays, «Scrutiny», X, 1942, pp. 339-345; poi in ID., The Common Pursuit, London 1952, pp. 173-181.
3 W. SHAKESPEARE, Cimbelino, a cura di P. BOITANI, Milano 2014 (testo originale a fronte); forniremo gli estremi bibliografici delle altre edizioni in corrispondenza dei passi citati.
4 Cfr. G. MELCHIORI, Introduzione a W. SHAKESPEARE, I drammi romanzeschi, a cura di G. MELCHIORI, Milano 1981, p. XXXVIII. Cfr. la voce di N. FUSINI, Tragicommedia, in Letteratu-ra europea, diretta da P. BOITANI e M. FUSILLO, II, Generi letterari, Torino 2014, pp. 243-256.
5 L. G. CLUBB, La commedia grave del XVI secolo all’estero: influenze e strutture italiane nelle opere di Shakespeare, in Interrogativi dell’Umanesimo, I, Essenza, persistenza, sviluppi, Atti del IX Convegno internazionale del Centro di studi umanistici (Montepulciano, Palazzo Tarugi, 1972), a cura di G. TARUGI, Firenze 1976, pp. 146-161: 159; H. GATTI, Giordano Bruno’s Cande-
Shakespeare, Ariosto e Pasqualigo: due congetture per le fonti di Cymbeline
~ 149 ~
la drammaturgia ciò che conta è proprio un debito sensibile nella trama e nella tonalità dell’opera, un debito talvolta difficile da circoscrivere ma importante proprio per questa sua ineffabile ispirazione globale. A un pri-mo sguardo, anche il Cymbeline sembra del tutto assimilabile a una com-media grave così come siamo abituati a qualificarla: romantica, incline al simbolismo, ai toni tragici, ai discorsi morali e astratti, tortuosa nella tra-ma e infine sciolta da un provvidenziale deus ex machina; anche il modu-lo del dramma pastorale, che occupa una parte cospicua nel testo shake-speariano, è un frutto di questa contaminatio di ingredienti che va sotto il nome di tragicommedia.
La trama si compone, come si è detto, di più storie, che per comodi-tà possiamo ricordare distinguendole per argomento, malgrado siano tra loro perfettamente intrecciate. Lo stesso criterio distintivo fu per altro se-guito dall’astrologo Simon Forman quando nel suo diario annotò una spe-cie di riassunto dello spettacolo (visto a teatro poco tempo prima di mo-rire annegato nel Tamigi, nel settembre del 1611: data che per gli studiosi rappresenta un prezioso termine ante quem per la cronologia della com-posizione del testo). Possiamo dunque contare molteplici vicende: la guer-ra tra Roma e la Britannia ribelle all’Impero; la storia dei due figli di re Cymbeline rapiti da bambini, allevati tra le montagne e divenuti guerrieri (il cui valore si rivelerà decisivo nella battaglia contro i Romani); la storia di Imogen, anch’essa figlia del re, sposata con Posthumus, orfano cresciu-to a corte e bandito subito dopo il matrimonio poiché Imogen era stata promessa al brutale Cloten, figlio della regina sposata da Cymbeline in se-conde nozze; infine la scommessa tra Posthumus e Iachimo sulla fedeltà di Imogen, stipulata durante l’esilio a Roma, presso la casa di Philarius.
Proprio la scommessa è parsa a molti interpreti lo schema narrativo fon-damentale del dramma, e perciò, nell’ottica della ricerca delle fonti, è sta-to studiato attentamente il retroterra di wager plots che Shakespeare pote-va conoscere. In particolare, tra le varianti esistenti all’interno del cycle de la gageure, individuate da Gaston Paris e discusse più recentemente da Guido
laio and Possible Echoes in Shakespeare and Ben Jonson, «Viator», XLIII, 2012, 2, pp. 357-376. Quanto ai fondamentali lavori di Yates e Sacerdoti, andrà specificato che se la Yates scorge echi bruniani nell’opera di Shakespeare (F. A. YATES, A Study of Love’s Labour’s Lost, Cambridge 1936), Sacerdoti procede anche al contrario, come dichiara egli stesso: «in questo libro non ci si riferisce tanto a certe questioni filosofiche, teologiche e politiche allo scopo di capir meglio Shakespeare, quanto piuttosto il contrario», usando il dramma come uno specchio singolarmen-te illuminante per comprendere quei problemi (G. SACERDOTI, Sacrificio e sovranità. Teologia e politica nell’Europa di Shakespeare e Bruno, Torino 2002, pp. 24-25).
Ida Campeggiani
~ 150 ~
Almansi, la scommessa del Cymbeline mostra grande affinità con la novella IX della seconda giornata del Decameron.6 Naturalmente si continua a di-battere sulla conoscenza della lingua italiana da parte di Shakespeare, e mol-ti studiosi – tra i quali, da ultimo, Alessandro Serpieri – hanno ricordato che il testo boccacciano sarebbe stato tradotto in inglese solo dopo la sua mor-te, non prima del 1620: parrebbe quindi opportuno dedurre che Shakespe-are lo leggesse nell’originale italiano (o semmai in una traduzione francese, ad esempio quella di Antoine le Maçon).7 Qualunque sarà la conclusione di questo dibattito – e fermo restando che, considerando anche solo le voci di Croce e Praz, ci sembra plausibile supporre che Shakespeare comprendes-se almeno superficialmente la lingua italiana 8 – va detto che esiste una tra-duzione inglese di una sorta di versione tedesca della novella di Barnabò,
6 G. PARIS, Le cycle de la ‘Gageure’, «Romania», XXXII, 1903, pp. 481-551; ID., Le conte de la ‘Gageure’ dans Boccace (Décamér. II, 9), in Miscellanea di studi critici edita in onore di Ar-turo Graf, Bergamo 1903, pp. 107-116; G. ALMANSI, Il Decameron, Cymbeline e il ‘Cycle de la gageure’, in Il Boccaccio nella cultura inglese e anglo-americana, a cura di G. GALIGANI, Firenze 1970, pp. 193-202, poi in ID., Il ciclo della scommessa. Dal Decameron al Cymbeline di Shake-speare, Roma 1976, pp. 7-25 (in questo stesso volume Almansi si sofferma sul problema attri-buzionistico che ha interessato il dramma, specie la parte del quinto atto contenente la visione di Posthumus, che per alcuni critici è talmente fiacca da non poter essere frutto della mano di Shakespeare: cfr. Il problema di Cymbeline, ivi, pp. 53-79).
7 A. SERPIERI, Cimbelino, in W. SHAKESPEARE, Drammi romanzeschi, Venezia 2001, p. 157. Sulle traduzioni inglesi del Decameron, cfr. gli studî di Herbert Wright, come H. G. WRIGHT, The First English Translation of the Decameron, «Modern Language Review», XXXI, October 1936, pp. 500-512, poi ID., The First English Translation of the Decameron (1620), in Essays and Studies in English Language and Literature, Upsala 1953; e il più recente G. GALIGANI, Il Boccac-cio nel Cinquecento inglese, in Il Boccaccio nella cultura inglese e anglo-americana, cit., pp. 27-57; nel 1566 era uscito il Palace of Pleasure di Painter, contenente sedici novelle tratte dal Decame-ron; e negli anni Settanta e Ottanta seguirono altre pubblicazioni di raccolte, che però attinge-vano al Boccaccio in misura minore (cfr. ivi, p. 31). Per una ricostruzione della ricezione ingle-se di Boccaccio dal Trecento al Cinquecento cfr. A. PETRINA, Boccaccio oltremanica. Il primo ap-prodo del Decameron nelle isole britanniche, in Premio ‘Città di Monselice’ per la traduzione let-teraria e scientifica, a cura di G. PERON [Fortuna e traduzioni del Decameron in Europa, Atti del XXXV Convegno sui problemi della traduzione letteraria e scientifica, Monselice 2007], Pado-va 2008, pp. 249-270. Alle traduzioni francesi del Decameron, specie come tramite per l’elabo-razione delle traduzioni in inglese, accenna T. PISANTI, Boccaccio in Inghilterra tra Medioevo e Ri-nascimento, in Boccaccio in Europe, ed. by G. TOURNOY, Leuven 1977, pp. 197-208.
8 B. CROCE, Shakespeare, Napoli, e la Commedia napoletana dell’arte, in ID., Nuovi saggi sul-la letteratura italiana del Seicento, Bari 1931, pp. 269-283; M. PRAZ, L’Italia di Shakespeare, in ID., Machiavelli in Inghilterra ed altri saggi sui rapporti letterari anglo-italiani, Firenze 1962, pp. 173-194: 192: «Siccome i libri italiani eran molto letti nella società in cui si muoveva lo Shake-speare, non è affatto straordinario che egli conoscesse la nostra letteratura; anzi, sorprendereb-be il contrario. Che questa conoscenza dovesse essere poco più che superficiale, par dimostrato dal fatto che lo Shakespeare di solito ricorreva a traduzioni e imitazioni inglesi delle opere ita-liane; questo è specialmente il caso dei sonetti, i cui passi convenzionali richiamano fonti ingle-si anziché italiane o francesi».
Shakespeare, Ariosto e Pasqualigo: due congetture per le fonti di Cymbeline
~ 151 ~
Zinevra e Ambrogiuolo. Si intitola Frederyke of Jennen e secondo Noswor-thy va considerata come una fonte ancora più immediata rispetto alla no-vella boccacciana, la quale comunque resta fondamentale per alcuni ele-menti che Shakespeare può avere tratto solo da quella, non essendo filtrati altrove. In altre parole, sembra necessario presupporre la conoscenza di en-trambi i testi da parte di Shakespeare, perché solo così si può giustificare la presenza di dettagli prelevati indipendentemente dall’uno e dall’altro. Non entriamo nel merito della discussione di questi dettagli, e piuttosto ricordia-mo che, nelle linee generali, Frederyke of Jennen è aderente alla novella di Boccaccio per quanto concerne la trama, che converrà ripercorrere in bre-ve: due mercanti, Barnabò da Genova e Ambrogiuolo da Piacenza, fanno una scommessa sulla fedeltà della moglie del primo, Zinevra; Ambrogiuo-lo riesce a introdursi nella camera da letto di questa nascosto in un baule e successivamente riferisce a Barnabò una subdola descrizione di tutto ciò che ha spiato, facendogli credere che la moglie gli sia stata infedele; da qui l’intreccio prosegue verso il riscatto della figura femminile, la quale sfugge alla vendetta di Barnabò riuscendo a impietosire il sicario inviato a uccider-la; infine, travestita da uomo ed entrata al servizio del sultano, incontra il perfido Ambrogiuolo e in qualche modo lo costringe a confessare la verità al cospetto di Barnabò; ciò le permette di riassumere l’identità femminile e di dimostrare la propria innocenza.
Se ora guardassimo oltre le fonti indicate dalla critica per il plot del-la scommessa, se cioè cominciassimo a osservare la struttura portante di Cymbeline dall’alto, potremmo scorgere aspetti complessivi che non sono riconducibili né alla novella di Boccaccio né alla sua rielaborazione te-desca. In quest’ottica più generale, punti di contatto con il dramma sha-kespeariano sono offerti dalle opere di due autori italiani: l’Ariosto del Negromante e dello stesso Furioso da un lato; il Pasqualigo della tragicom-media intitolata Il Fedele dall’altro.
Consideriamo per primo il Negromante, e in particolare la seconda re-dazione della commedia, stampata per la prima volta da Giolito nel 1551 (a cura di Lodovico Dolce, che ne ebbe il testo da Virginio Ariosto). La scelta della seconda redazione è motivata dal fatto che essa sola contiene alcuni elementi potenzialmente importanti per Shakespeare, e non la pri-ma, che pure ha goduto di una fortuna internazionale dopo la traduzione francese di Jean de La Taille.9
9 J. DE LA TAILLE, Le Négromant, Texte édité et présenté par Fr. RIGOLOT, in Théâtre fran-