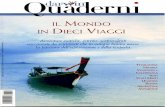Servio e la metempsicosi
Transcript of Servio e la metempsicosi
Testi e studi di cultura classica
Collana fondata daGiorgio Brugnoli e Guido Paduano
Diretta daGuido Paduano, †Alessandro Perutelli, Fabio Stok
60
000_pag.edit._000_pag.edit. 14/11/13 15.22 Pagina 3
Totus scientia plenus.Percorsi dell’esegesi virgiliana antica
a cura diFabio Stok
Edizioni ETS
000_pag.edit._000_pag.edit. 14/11/13 15.22 Pagina 5
www.edizioniets.com
© Copyright 2013EDIZIONI ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 [email protected]
DistribuzionePDE, Via Tevere 54, I-50019 Sesto Fiorentino [Firenze]
ISBN: 978-884673782-3
Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Roma «Tor Vergata»
(fondo PRIN 2009)
000_pag.edit._000_pag.edit. 14/11/13 15.22 Pagina 6
Servio e la metempsicosi
di Fabio Stok
1. Enea e la Sibilla, giunti nell’Elisio, vedono Anchise intento ad osser-vare la schiera dei propri discendenti: inclusas animas superumque ad lumen ituras / lustrabat (vv. 680-681). Anime in procinto di tornare alla luce: è il primo riferimento alla metempsicosi che troviamo nel poema ed insieme l’annuncio della successiva Heldenschau. Una coincidenza che evidenzia il ruolo della metempsicosi quale elemento di saldatura fra la tradizionale Nekya omerica ed il carattere «protrettico»1 del viaggio ultraterreno di Enea, finalizzato appunto alla Heldenschau. Una connes-sione di cui Servio è ben consapevole, come vedremo oltre.
Dopo l’incontro con il padre, e il canonico abbraccio mancato (vv. 700-702), Enea nota l’affollarsi delle anime sulle sponde di un fiume e chiede lumi in merito ad Anchise (vv. 703-712). Quest’ultimo risponde che le anime destinate alla reincarnazione bevono l’acqua del fiume Lete per perdere la memoria: animae, quibus altera fato / corpora debentur, Lethaei ad fluminis undam / securos latices et longa oblivia potant (vv. 713-715). Enea appare incredulo della possibilità che le anime, dopo es-sersi liberate del corpo, possano voler reincarnarsi, vv. 719-721:
O pater, anne aliquas ad caelum hinc ire putandumst sublimis animas iterumque ad tarda reverti corpora? Quae lucis miseris tam dira cupido?
Anchise spiega, dopo un excursus cosmologico (vv. 724-734), che le anime devono scontare la pena per i delitti commessi e purificarsi (vv. 735-742). Di seguito continua in questi termini, vv. 743-751:
Quisque suos patimur manis. Exinde per amplum
1 SETAIOLI 1985, 956.
Fabio Stok
166
mittimur Elysium, et pauci laeta arva tenemus, donec longa dies, perfecto temporis orbe, concretam exemit labem purumque relinquit aetherium sensum atque aurai simplicis ignem. Has omnis, ubi mille rotam volvere per annos, Lethaeum ad fluvium deus evocat agmine magno, scilicet immemores supera ut convexa revisant, rursus et incipiant in corpora velle reverti.
Quello che ci interessa è il rapporto fra i pauci (v. 744) e gli omnis (v. 748). L’interpretazione prevalente2 è che solo poche anime completino la purificazione nell’Elisio, riprendendo così la loro originaria consisten-za ignea ed eterea; tutte le altre anime, trascorsi mille anni, si reincarna-no in un altro corpo dopo che il Lete ha cancellato in esse il ricordo della vita precedente3. Nel contesto narrativo has omnis si riferirebbe quindi alle anime che Enea ha visto ammassate sulla sponda del fiume, non a tutte le anime.
Una diversa interpretazione del passo è attestata da Agostino, che la critica e la definisce platonica: quod Platonice videtur dixisse Vergilius, in campos Elysios purgatas animas missas […] ad fluvium Letheum evo-cari, hoc est ad oblivionem praeteritorum (civ. 10, 30, 1). Anche le ani-me già purificate (purgatae), secondo questa interpretazione, sarebbero destinate alla reincarnazione: has omnis è evidentemente riferito, in que-sta versione, a tutte le anime, comprese quelle dei pauci che godono del-l’Elisio. Agostino fa riferimento ad un teoria platonica, per la quale ut mortuos ex vivis, ita vivos ex mortuis semper fieri, che è evidentemente quella del Fedone, dove Socrate descrive un passaggio incessante delle anime dai morti ai vivi (70c; 72a).
Lo stesso Agostino precisa che una diversa posizione in merito alla metempsicosi era stata sostenuta da Porfirio4, per il quale le anime puri-
2 Cfr. NORDEN 1957, 19-20; AUSTIN 1977, 230-3. Non sono però mancate proposte di emen-
dazione, espunzione e trasposizione di versi: ancora GEYMONAT 1973 (20082) colloca i vv. 743-744 fra parentesi, con la conseguenza che la purificazione descritta ai vv. 745-747 è riferita alle anime purificande dei vv. 739-742. Il testo qui riprodotto è quello di CONTE 2009.
3 STETTNER 1934, 54 attribuisce l’ambiguità del passaggio virgiliano alla diversità delle fonti utilizzate: stoica ai vv. 745-747, platonica ai vv. 748-750. Una fonte neo-Academica è ipotizzata da BOYANCÉ 1960.
4 Sui problemi posti dall’uso di Porfirio da parte di Agostino cfr. GOULET 2012 (anche per la bibliografia precedente). Di seguito segnalo le numerazioni dei frammenti del De regressu animae
Servio e la metempsicosi
167
ficate possono liberarsi definitivamente del corpo: merito displicuit hoc Porphyrio, quoniam re vera credere stultum est ex illa vita quae beatis-sima esse non poterit nisi de sua fuerit aeternitate certissima, desiderare animas corruptibilium corporum labem et inde ad ista remeare, tam-quam hoc agat summa purgatio, ut inquinatio requiratur (civ. 10, 30 = Porph. de regressu animae frg. 11, 1 Bidez = 13C Madec - Goulet)5. È da notare che l’adozione della posizione di Porfirio, da parte di Agosti-no, non comporta una diversa interpretazione del brano virgiliano, che anche in altri passi del De civitate dei è criticato in quanto “platonico” (cfr. 13, 19: quod Vergilius ex Platonico dogmate dixisse laudatur; 22, 26: posuit ex Platone Vergilius). Anche Porfirio, così sembra suggerire Agostino6, avrebbe adottato l’episodio virgiliano come esemplificazione poetica della tesi per cui le anime si reincarnerebbero in perpetuo, senza postularne una diversa interpretazione.
Definisco per comodità come “ortodossa”7 la posizione combattuta da Agostino (anche se in Platone, in realtà, è rilevabile qualche oscilla-zione: in Tim. 42b e Phaedr. 248e-249b è ammesso il ritorno dell’anima dei saggi all’astro di origine8), e come “porfiriana” la revisione che Ago-stino attribuisce a Porfirio (prescindendo dai problemi posti dalla ricostruzione del De regressu animae9). La posizione “ortodossa” era stata certamente ripresa, nell’ambito dal Neoplatonismo, da Sallustio (il filosofo identificabile con l’omonimo amico dell’imperatore Giuliano)10 e da Proclo11; probabilmente anche da Plotino12 (meno chiara la posizio-ne di Giamblico13). Il ritorno delle anime migliori al cielo è ovviamente ammesso da Macrobio, che per questo aspetto è aderente al Somnium Scipionis, ma una sua presa di posizione a somn. 2, 7, 14 ha fatto pensa-
delle edizioni BIDEZ 1913 e MADEC - GOULET 2012.
5 Su questa posizione di Porfirio cfr. STETTNER 1934, 74-75; DEUSE 1983, 159-61. 6 Ma è scettico, su questa possibilità, MADEC - GOULET 2012, 155n. 7 PELLIZZARI 2003, 166 la ritiene «interpretazione più tradizionalista e letteraria», mentre l’al-
tra (quella porfiriana) sarebbe «più filosofica». 8 Cfr. STETTNER 1934, 31-41; SETAIOLI 1995, 130. 9 Sui quali cfr. GOULET 2012. 10 Nel De deis et mundo 20. Cfr. STETTNER 1934, 78-79. 11 Cfr. in remp. II 177, 29-179, 3; elem. theol. 206 (SETAIOLI 1995, 134-35). 12 STETTNER 1934, 71 segnala Enn. 4, 3, 24, dove Plotino ammette la possibilità di un ritorno
delle anime alla sede celeste, ma SMITH 1974, 33-34 ritiene che anche per Plotino la liberazione perpetua dalla reincarnazione fosse impossibile.
13 Cfr. STETTNER 1934, 76; CUMONT 1949, 372-77.
Fabio Stok
168
re a Flamant che egli non volesse prendere una posizione chiara sulla di-sputa fra il platonismo “ortodosso” e Porfirio (o forse ricalcare troppo apertamente la valutazione di Agostino)14.
In ambito cristiano la teoria della metempsicosi era stata criticata, pri-ma di Agostino, da Tertulliano de an. 30-31 e da Lattanzio inst. 7, 22-23. È di notevole interesse il fatto che anche Lattanzio, come Agostino, attribuisca a Virgilio la posizione “ortodossa”, e tenda anzi a presentare quest’ultima come superstizione poetica, alla quale anche il saggio Pla-tone avrebbe creduto (unde etiam Plato de animam disserens … poetis ineptissime creditit):
poetae vero cum scirent hoc saeculum malis omnibus redundare, oblivionis amnem induxerunt ne malorum ac laborum memores animae reverti ad superos recusarent. Unde Vergilius “o pater …. cupido?” [Aen. 6.719-721]. Ignorabant enim quomodo aut quando id fieri oporteret, itaque renasci eas putaverunt et denuo ad uterum revolvi et ad infantiam regredi (inst. 7, 22, 16-19)15.
L’interpretazione “platonica” dell’episodio virgiliano testimoniata da Lattanzio e da Agostino fa pensare che a partire dal sec. III circolasse un’esegesi neoplatonica del poema virgiliano, identificabile forse nell’o-pera (o nelle opere) a cui fa riferimento Servio nel proemio al libro VI del suo commento: multa per altam scientiam philosophorum, theologo-rum, Aegyptiorum, adeo ut plerique de his singulis huius libri integras scripserint pragmatias.
Più che ad uno specifico commento dell’opera virgiliana Setaioli pen-sa ad «un corpus esegetico di carattere platonizzante relativo special-mente alla vicenda dell’anima, alla divinità ed ai problemi connessi»16, e scarta comunque l’ipotesi che questo commento fosse stato allestito da Mario Vittorino17, in considerazione del fatto che l’esegesi neoplatonica
14 FLAMANT 1977, 627. Al De regressu animae di Porfirio Macrobio sembra fare riferimento
a somn. 1, 13, 16 (in arcanis de animae reditu disputationibus): cfr. COURCELLE 1948, 27n; RE-GALI 1983, 338.
15 Alla metempsicosi virgiliano-platonica Lattanzio oppone la cristiana resurrezione dei corpi: non igitur renascentur, quod fieri non potest, sed resurgent et a Deo corporibus induentur… (7, 23, 1). Cfr. COURCELLE 2001, 374.
16 SETAIOLI 1995, 240. 17 Tesi avanzata da BITSCH 1911 e rilanciata da COURCELLE 1955, 66-69; ripresa poi da HA-
DOT 1971, 215-31; FLAMANT 1977, 625; ARMISEN-MARCHETTI 2003, LXI; JEUNET-MANCY
Servio e la metempsicosi
169
dell’episodio virgiliano era nota già a Lattanzio18 (e forse anche a Porfi-rio), quindi in epoca precedente a Mario Vittorino.
L’esegesi neoplatonica citata da Agostino è nota, come vedremo fra poco, anche a Servio. Lo stesso Servio, però, in più scoli espone anche l’altra teoria della metempsicosi, quella sostenuta da Porfirio19, per la quale la maggior parte delle anime si reincarna, ma alcune ascendono al-la sede eterea. La presenza in Servio di ambedue le interpretazioni, se-gnalata in precedenza solo incidentalmente20, è stata attribuita da Gersh all’incertezza suscitata nel commentatore dalla conoscenza delle diffe-renti posizioni di Plotino e di Porfirio21. Setaioli, diversamente, ritiene che l’incongruenza sia conseguente all’uso di fonti esegetiche diverse da parte di Servio: un’esegesi più antica, di impianto rigorosamente neopla-tonico, ed una più recente, aderente alla posizione di Porfirio22. La circo-stanza non è ritenuta da Setaioli sorprendente: «il carattere di compila-zione del commento serviano basta ampiamente a spiegare la contempo-ranea presenza delle due opposte posizioni»23 (una spiegazione ripresa, in seguito, anche da Pellizzari24 e da Jeunet-Mancy25).
Che da Servio non ci si possa aspettare troppa coerenza dottrinale, su tematiche di controversia filosofica, appare ovviamente condivisibile, ma è difficile pensare che sfuggisse al commentatore il rilievo della que-stione, evidenziato dalla polemica contro la metempsicosi sviluppata da-gli autori cristiani a partire già da Tertulliano. L’ipotesi che Servio non fosse consapevole dei termini di questo problema, obbligherebbe a con-siderare il suo commento un meccanico e casuale aggregato di materiali esegetici preesistenti26.
Una soluzione è forse individuabile verificando la funzione esegetica 2012, CXXVII.
18 SETAIOLI 1995, 240-41. 19 Come notò COURCELLE 1948, 26. 20 GEORGII 1891, 297 e 305-06; FLAMANT 1977, 625-26; CLARK 1979, 179n. 21 GERSH 1986, 754-55. 22 SETAIOLI 1995, 55. 23 SETAIOLI 1995, 143. 24 PELLIZZARI 2003, 171: Servio, «grammatico e non filosofo di professione», riprendendo
«dalle sue fonti interpretazioni filosofiche anche complesse dei poemi virgiliani, non si curò di ar-monizzarle in un insieme coerente».
25 JEUNET-MANCY 2012, CXXVI: «Servius n’est pas un philosophe […] on ne trouve donc pas dans son commentaire un système cohérent et dogmatique».
26 È la conclusione a cui arrivava GEORGII 1891, 306, confermata nella sostanza da SETAIOLI 1995, 125: «carattere di congerie, spesso caotica del commento serviano».
Fabio Stok
170
delle prese di posizione di Servio (che sono distribuite, va ricordato, in scoli diversi, ciascuno dei quali ha specifiche finalità esplicative). L’ana-lisi che propongo privilegia questo approccio27 e tenta quindi di verifica-re se le posizioni serviane sulla metempsicosi abbiano una loro logica, attinente all’interpretazione dell’opera virgiliana.
2. La tesi per cui il comportamento retto garantisce all’anima il ritorno nella sede celeste è ben esplicitata da Servio nello scolio ad Aen. 6, 136, a proposito delle istruzioni che la Sibilla dà ad Enea per poter iniziare il suo viaggio ultraterreno: sub imagine fabularum docet rectissimam vi-tam per quam animabus ad superos datur regressus28. La nota prelude alla successiva interpretazione del ramo d’oro come simbolo della Y pitagorica29, che Servio presenta come pertinente alla questione de reditu animae30: novimus Pythagoram Samium vitam humanam divisisse in mo-dum Y litterae. La simbologia evidenzia la scelta dell’uomo fra i vizi e la virtù: bivium autem Y litterae a iuventute incipere, quo tempore homines aut vitia, id est partem sinistram, aut virtutes, id est dexteram partem se-quuntur.
Il motivo della Y pitagorica è ripreso da Servio anche per alcune tap-pe dell’itinerario percorso da Enea nell’Oltretomba: nello scolio ad Aen. 6, 295, per la via che conduce al Tartaro, quae vel ad vitia vel ad ducit, e in quello ad Aen. 6, 477, per gli arva abitati dai guerrieri morti in batta-glia. In quest’ultimo scolio Servio precisa che il motivo presuppone l’in-terpretazione dell’Oltretomba come allegoria della vita umana: nam infe-ri humanam continent vitam (è la teoria che Macrobio espone a somn. 1, 10, 9 sgg., presentandola come la più antica delle teorie sulla discesa dell’anima31). A questa allegoria è evidentemente correlata la proiezione del motivo della Y nella topografia dell’Oltretomba, simboleggiando la Y la scelta morale dell’individuo in vita, non certo post mortem.
La correlazione fra il motivo della Y pitagorica e l’Oltretomba virgi-
27 Programmaticamente non considerato da Setaioli: cfr. SETAIOLI 1995, VI. 28 Dove non indicato specificamente il testo di Servio per il libro VI è quello di JEUNET-
MANCY 2012; per gli altri libri utilizzo le edizioni Harvardiana (libri I-V), di Ramires (libri VII e IX) e di Thilo (libri VIII e X-XII).
29 Su questo motivo pitagorico cfr. JOOST-GAUGIER 2006, 215-20. 30 REGALI 1985, 338 ipotizza che qui Servio riecheggi qui il titolo porfiriano De regressu ani-
mae (peraltro dibattuto: cfr. GOULET 2012, 68-69) 31 Sulle possibili fonti di Macrobio cfr. REGALI 1983, 307-08.
Servio e la metempsicosi
171
liano era presente già nell’esegesi preserviana. Ne abbiamo testimonian-za anche in questo caso da Lattanzio32, che a inst. 6, 3, 6 propone una ri-lettura del motivo pitagorico in chiave cristiana rinviando al viaggio di Enea nell’Oltretomba33: dicunt enim humanae vitae cursum Y litterae si-milem, quod unus quisque hominum cum primae adulescentiae limen adtigerit et in eum locum venerit, “partis ubi se via scindit in ambas” [Aen. 6, 540], haeret nutabundus ac nesciat in quam se partem potius in-clinet34.
Sia nella prospettiva serviana che in quella cristiana di Lattanzio l’al-ternativa morale simboleggiata dalla Y comporta, a seconda della scelta effettuata, la salvezza dell’anima oppure la sua dannazione. La metem-psicosi non è direttamente evocata negli scoli citati, ma la ripresa del motivo pitagorica è evidentemente compatibile con la posizione “porfi-riana”, non con quella “ortodossa”.
Questa considerazione trova conferma negli scoli in cui Servio adotta in tutta evidenza la versione “porfiriana” della metempsicosi. In ad Aen. 6, 127, a proposito della porta dell’Ade descritta dalla Sibilla ad Enea (vv. 126-129: facilis descensus Averno, / noctes atque dies patet atri ia-nua Ditis; / sed revocare gradum superasque evadere ad auras / hoc opus, hic labor est), Servio segnala il carattere poetico della collocazio-ne sotterranea dell’Oltretomba, quale si legge in Virgilio, e passa poi ad illustrare il significato filosofico del passo:
secundum philosophorum altam scientiam, qui deprehenderunt bene viventium animas ad superiores circulos id est ad originem suam redire: quod dat Lucanus Pompeio ut vidit quanta sub nocte
32 Cfr. COURCELLE 2001, 367-68. 33 Un’analoga ripresa del motivo pitagorico in chiave cristiana è rilevabile in Zeno di Verona,
che a tract. 1, 2, 4 (pp. 15-16 Loefstedt) mette in opposizione le opinioni dei filosofi pagani con la visione dei poeti, cioè di Virgilio: Poetae autem melius, qui duplicem viam apud inferos ponunt: impiorum unam, quae ducit in Tartarum; piorum aliam, quae ducit ad Elysium; eo fortius adden-tes, quod defunctorum ibidem non tam formae, quam facta noscantur, ac necessario recipiant, se-cundum quod mundanae administrationis suis in actibus portant, recte dicentes: Quisque suos pa-timur manes [Aen. 6, 743] (cfr. DOIGNON 1981, 110-12; COURCELLE 1984, 484-85).
34 Poco oltre (6, 4, 1-2) Lattanzio prende le distanze dalla credenza pagana nell’Elisio ricor-rendo ancora alla topografia ultraterrena virgiliana: una est itaque virtutis ac bonorum via, quae fert non in Elysios campos, ut poetae loquuntur, sed ad ipsam mundi arcem, “at laeva malorum / exercet poenas et ad impia Tartara mittit” [Aen. 6, 542-543]. Est enim criminatoris illius, qui pra-vis religionibus institutis avertit homines ab itinere caelesti et in viam perditionis inducit.
Fabio Stok
172
iaceret nostra dies (9, 13)35. Male viventium vero diutius in his permorari corporibus permutatione diversa et esse apud inferos semper.
La distinzione fra le anime dei male viventes che si reincarnano e quelle dei bene viventes, che ritornano in cielo36, riecheggia il bivio simboleg-giato dalla Y pitagorica che abbiamo trovato negli scoli citati sopra. L’e-spressione in superiores circulos va correlata alla parte precedente dello scolio stesso, in cui Servio descrive un sistema di nove cerchi che cir-condano la terra, sette dei quali sono identificati nei pianeti (Saturno, Giove, Marte, Sole, Venere, Mercurio e Luna), mentre gli ultimi due so-no definiti magni. Uno dei due è da identificarsi nel cielo delle stelle fis-se; l’altro, secondo Setaioli37, è il Cristallino o Primo Mobile, la cui in-troduzione nel sistema astronomico è testimoniata a partire da Tolo-meo38.
Va comunque osservato che le nove sfere di cui parla Servio sono correlate all’interpretazione allegorica che egli dà dei nove giri che Vir-gilio fa fare allo Stige, noviens Styx interfusa (6, 439), cfr. lo scolio rela-tivo: qui altius de mundi ratione quaesiverunt, dicunt intra noven hos mundi circulos inclusas esse virtutes, in quibus et iracundiae sunt et cu-piditates, de quibus tristitia nascitur, id est Styx. La correlazione fra pia-neti e peccati è ripresa negli scoli ad Aen. 6, 451; 6, 466 e 6, 673 a pro-posito dei dannati del Tartaro di cui Enea ha notizia dalla Sibilla, ma in un altro scolio, ad Aen. 426, Servio correla le nove sfere senz’altro alla topografia dell’Oltretomba virgiliano (ho indicato fra parentesi i riferi-menti specifici):
CONTINVO AVDITAE VOCES novem circulis inferi cincti esse
35 L’esegesi virgiliana si intereseca per questo aspetto con quella lucanea, in quanto il Com-
mentum Bernese rinvia a sua volta ad Aen. 6, 736-740 (e a georg. 4, 225-227): cfr. ESPOSITO 2004, 34-35. Un altro caso di convergenza fra l’esegesi dei due autori è rilevabile fra Serv. ad Aen. 6, 532 e Comm. Bern. 1, 455 (cfr. PELLIZZARI 2003, 167). Sul rapporto fra esegesi virgiliana ed esegesi lucanea cfr. anche BARBARA 2011.
36 La stessa opposizione è in ad Aen. 6, 743: post mortem aut adserimur in meliorem vitam, aut condemnarum in deteriorem: per quos aut vacationem meremur, aut reditum in corpora.
37 SETAIOLI 1995, 74-75. 38 Più prudente nell’identificazione è JEUNET-MANCY 2012, XCV-XCIX. SETAIOLI 1995, 72-
74 segnala la presenza della stessa esegesi di Aen. 6, 749 nel commento di Favonio Eulogio al Somnium Scipionis 19, 4-7, ma dubbi sulla sua analisi sono stati formulati recentemente da MAR-CELLINO 2012, 127 (che rinvia in proposito a TOMMASI MORESCHINI i.c.s).
Servio e la metempsicosi
173
dicuntur, quos nunc exequitur. Nam primum dicit animas infan-tium tenere [vv. 427-429], secundum eorum qui sibi per simplici-tatem adesse nequiverunt [v. 430], tertium eorum qui evitantes ae-rumnas se necarunt [vv. 434-437], quartum eorum qui amarunt [vv. 441-444], quintum virorum fortium esse dicit [vv. 477-478], sextum nocentes tenent qui puniuntur a iudicibus [vv.566-569], in septimo animae purgantur [vv. 739-743], in octavo sunt animae ita purgatae ut redeant (in corpora add. SD) [vv. 706-709], in no-no, ut iam non redeant, scilicet campus Elysius [vv. 637-665].
La sistemazione è chiaramente correlata alla tesi “porfiriana”: al nono cerchio, identificato tout court nell’Elisio, arrivano solo le anime che evitano la reincarnazione39.
Un altro scolio in cui Servio riprende in modo anche più esplicito la posizione “porfiriana” è ad Aen. 6, 404, per la motivazione che la Sibilla dà a Caronte della presenza di Enea: ad genitorem imas Erebi descendit ad umbras. Nello scolio Servio illustra che cos’è l’Erebus:
Erebus proprie est pars inferorum in qua hi qui bene vixerunt mo-rantur. Nam ad Elysium non nisi purgati perveniunt, unde est et pauci laeta arva tenemus [v. 744]. Hinc fit ut quaeratur an animae de Elysio in corpora possint redire. Et deprehensum est non redi-re, quia per purgationem carent cupiditate.
39 Tracce di un’esegesi diversa sono rilevabili in alcuni scoli in cui dove Servio colloca L’Eli-
sio nel cerchio lunare (cfr. JEUNET-MANCY 2012, XCII-XCIII), localizzazione suggerita da un pa-io di notazioni virgiliane relative all’Elisio, largior hic aether (v. 640) e aeris in campis (v. 887), che paiono effettivamente alludere alla Luna (cfr. NORDEN 1957, 23-26, ma per HORSFALL 1991, 98-99 la descrizione virgiliana dell’Elisio è senz’altro aporetica). Così intende Macr. somn. 1, 11, 6-7, aetheriam terram physici vocaverunt, che segnala anche la collocazione nel cerchio lunare delle anime dei defunti: inter lunam terrasque locum mortis et inferorum vocari, tesi medioplato-nica da cui si sarebbe distaccato Porfirio nel proporre quella che Macrobio presenta come la terza delle teorie sulla collocazione degli Inferi (REGALI 1983, 314 condivide l’ipotesi di MRAS 1933, 254 per cui Macrobio si sarebbe avvalso della parte dossografica di un’opera dello stesso Porfi-rio). La collocazione lunare è registrata da Servio nello scolio ad Aen. 6, 640, re vera largior, si lunarem intelligis circulum, con rinvio al precedente ad Aen. 5, 735, dove era proposta una triplice possibile collocazione dell’Elisio: Elysium est ubi piorum animae abitant post corporis animaeque discretionem, … quod secundum poetas in medio inferorum…, secundum philosophos elysium est insulae fortunatae, … secundum theologos circa lunarem circulum, ubi iam aer purior est. Nello scolio a 6, 887 si nota una certa prudenza sulla collocazione lunare, che è attribuita a Virgilio, ma che Servio sembra riconoscere come divergente dalla sistemazione proposta negli scoli citati so-pra: locutum autem est secundum eos qui putant Elysium lunarem esse circulum (a proposito del-l’espressione aeris in campis).
Fabio Stok
174
Servio ricalca qui l’interrogativo che Enea rivolge al padre dopo aver vi-sto le anime ammassarsi sulla sponda del Lete: anne aliquas ad caelum hinc ire putandum est / sublimis animas iterumque ad tarda reverti / corpora? Quae lucis miseris tam dira cupido? (vv. 719-721). La rispo-sta di Servio è molto netta: le anime arrivate nell’Elisio non si reincarna-no in quanto si sono purificate, e quindi sono esenti da passioni. La mo-tivazione riecheggia la citata obiezione di Agostino a civ. 10, 30, per cui il desiderio delle anime di tornare nei corpi è tamquam hoc agat summa purgatio, ut inquinatio requiratur.
Nel complesso degli scoli finora esaminati40 Servio non sembra aver dubbi nell’adottare la versione “porfiriana” della metempsicosi, che ap-pare connessa sia alla concezione del destino delle anime evidenziata dalle riprese del motivo della Y pitagorica, sia all’interpretazione del-l’Oltretomba virgiliano e della sua configurazione.
3. Alla teoria platonica della metempsicosi Servio fa riferimento, prima del libro VI, già nello scolio ad Aen. 3, 68 (a proposito delle onoranze funebri prestate a Palinuro): Plato perpetuam dicit animam et ad diversa corpora transitum facere statim pro meritis vitae prioris41 (presuppone Tim. 42c, dove Platone afferma che il comportamento tenuto in una vita determina il tipo di corpo in cui l’anima successivamente trasmigra; cfr. anche Phaedr. 248e). La teoria platonica è citata negli stessi termini nel successivo scolio ad Aen. 3, 140, secundum eos scilicet qui dicunt ani-
40 Non ho discusso lo scolio ad Aen. 6, 545, dove Servio riferisce le interpretazioni che erano
state date delle parole di Deifobo, explebo numerum reddarque tenebris: per una di esse Deifobo annuncerebbe la reincarnazione dell’anima in un nuovo corpo (finiam tempus statuum purgationi et in corpus recurram etc.); una seconda interpretazione, che Servio scarta, è quella per cui Deifo-bo alluderebbe alla durata della vita interrotta dalla morte violenta (in locis his sum quamdiu vitae per vim ereptae expleam tempus): riecheggia l’interpretazione del passo che leggiamo in Macro-bio somn. 1, 13, 12 (cfr. SETAIOLI 1995, 210-11). La spiegazione che Servio avvalora è quella per cui Deifobo abbandonerebbe i visitatori per ritornare nell’ombra: in considerazione del fatto che circa Aenean et Sibyllam aliquid lucis fuisse intelligimus (spiegazione di «buon senso terra terra», come nota SETAIOLI 1995, 210). JEUNET-MANCY 2012, 241 ritiene che Servio si dimostri così «très pragmatique, au détriment, comme c’est assez souvent le cas, de la cohérence de son com-mentaire», ma mi pare che la posizione sia adottata proprio per non interferire con la ricostruzione complessiva che si legge nel commento.
41 Di seguito Servio differenzia la posizione di Platone da quella di Pitagora, che non metem-yuvcosin, sed paliggenesivan esse dicit, hoc est redire, sed post tempus. Nello scolio ad Aen. 6, 603, diversamente, i due termini sono presentati come sinonimi (cfr. STETTNER 1934, 3-4; SETA-IOLI 1995, 92 e 133).
Servio e la metempsicosi
175
mam esse perpetuam et ad diversa corpora transitum facere. Non è esplicitato, in questo scolio, se la reincarnazione interessi tutte le anime, ma è probabile che Servio si riferisca qui alla versione “ortodossa”, che comunque è dichiaratamente attribuita a Platone (nel secondo scolio il secundum eos conferma che il commentatore presenta una tesi non ne-cessariamente condivisa).
Nel contesto relativo a Palinuro troviamo un ulteriore riferimento alla metempsicosi, nello scolio ad Aen. 3, 63 relativo ai manes, per i quali Servio propone diverse identificazioni, una delle quali recita: animae illo tempore quo de aliis recedentes corporibus necdum in alia transierunt. Egli appare peraltro interessato soprattutto all’etimologia del nome, che fa derivare dall’agg. manus: sunt autem noxiae et dicuntur kata; ajntiv-frasin, nam ‘manum’ ‘bonum’ est42. L’identificazione citata non colli-ma con quella che troviamo nello scolio ad Aen. 6, 743 (quisque suos patimur manes), dove i manes citati da Anchise sono identificati nei due démoni, l’uno buono e l’altro cattivo, che accompagnerebbero la vita dell’uomo: cum nascimur, duos genios sortimur, unus est qui hortatur ad bona, alter qui depravat ad mala. Quibus adsistentibus post mortem aut adserimur in meliorem vitam, aut condemnamur in deteriorem, per quos aut vacationem meremur, aut reditum in corpora43. In questo sco-lio, come si vede, non solo è chiaramente evocata la versione “porfiria-na” della metempsicosi, ma essa è anche messa in connessione con la metafora del bivio che abbiamo già trovato nelle riprese serviane del motivo della Y pitagorica.
È probabile che l’esegesi derivi dalla stessa fonte utilizzata da Servio negli scoli in cui riprende quest’ultimo motivo: lo fa pensare il fatto che Lattanzio, nel passo citato delle Divinae institutiones in cui tratta del te-ma della Y pitagorica, riprenda anche la teoria dei due démoni, in termi-ni molto vicini a quelli dello scolio serviano: utriquae [scil. viae] prae-positum esse dicimus ducem utrumque immortalem, sed alterum honora-
42 Un’altra etimologia esposta da Servio fa riferimento alla collocazione delle anime nel cielo
lunare, alii manes a manando dictos intelligunt: nam animabus plena sunt loca inter lunarem et terrarum circulum, unde et defluunt, con notevole corrispondenza in Macr. somn. 1, 11, 6: et ani-mae inde in terram fluentes mori, inde ad supera meantes in vitam reverti nec immerito aestima-tum est.
43 BOYANCÉ 1935 riteneva la teoria senz’altro pitagorica, ma SETAIOLI 1995, 167 ha segnalato che la dottrina dei due démoni personali era nota anche a Porfirio, che ne tratta nel De regressu animae (Aug. civ. 10, 21 = frg. 5 Bidez, 4 Madec - Goulet; cfr. anche GOULET 2012, 107-08).
Fabio Stok
176
tum, qui virtutibus ac bonis praesit, alterum damnatum, qui vitiis ac ma-lis (6, 3, 14).
Potremmo ipotizzare che nel commento al libro III Servio abbia ri-preso una fonte che forniva informazioni aderenti alla posizione platoni-ca “ortodossa”. È possibile che si trattasse della fonte utilizzata anche dal Servio Danielino (forse il commento donatiano), in quanto nello scolio ad Aen. 3, 63 il Danielino propone ulteriori etimologie / identifi-cazioni dei Manes, che Servio sembrerebbe aver omesso. Negli scoli che ci interessano del libro VI, diversamente, Servio sembra aver utilizzato, per la tematica che ci interessa e più in generale per le questioni di carat-tere filosofico, fonti specifiche, probabilmente quelle a cui fa riferimento nel proemio del libro. Non è forse casuale il fatto che non ci siano ag-giunte pertinenti del Danielino negli scoli che abbiamo esaminato, e più in generale appare significativo che il commento al libro VI sia quello in cui l’entità delle aggiunte Danieline è proporzionalmente minore.
La versione “porfiriana” è ripresa, come abbiamo visto, negli scoli relativi alla configurazione dell’Oltretomba virgiliano. Gli scoli in cui Servio espone la versione “ortodossa” della metempsicosi sono invece concentrati nella sezione relativa all’intervento con cui Anchise illustra ad Enea il destino delle anime.
A 6, 703, dopo il canonico mancato abbraccio con il padre, Enea vol-ge lo sguardo al fiume Lete: interea videt Aeneas in valle reducta ecc. Servio prende lo spunto da questo verso per introdurre l’intero episodio e precisa che la materia trattata è platonica: tractat de Platonis dogmate, quod in Phaedone positum est peri; yuch`~44. Il tractat de Platonis dog-mate è assai vicino all’affermazione di Agostino civ. 13, 19 per cui Vir-gilio avrebbe trattato la questione ex Platonico dogmate: questa e le altre convergenze segnalate fanno pensare ad una fonte comune, in considera-zione del fatto che Agostino non sembra conoscere il commento servia-no45.
Il rinvio alla dottrina platonica è proposto da Servio, va osservato, in riferimento al discorso pronunciato successivamente da Anchise, che il commentatore introduce in questo scolio. Per il discorso stesso Servio ri-corre alla figura retorica dell’hirmos: hirmos est hoc loco, id est unus
44 Ed anche varroniana: de qua re Varro in primo Divinarum plenissime tractavit, cfr. CAR-DAUNS 1976, 28 (frg. 29) e 158 (anche STETTNER 1934, 48-49).
45 Il De civitate dei fu composto fra il 413 e il 426; il commento serviano probabilmente nel primo decennio del secolo (cfr. MURGIA 2003).
Servio e la metempsicosi
177
sensus protensus per multos versus46. Nell’Ars maior Donato definisce l’hirmos quale series orationis tenorem suum usque ad ultimum servans (398, 30-31 K.), e che esemplifica proprio con Aen. 6, 724-726 (la coin-cidenza fa pensare che almeno per questo particolare lo scolio serviano dipenda dal commento donatiano). Quello di Anchise, quindi, per Servio è una sorta di discorso “a tesi”, precisamente rapportato, nei termini in cui è esposto nello scolio, all’interrogativo posto da Enea sul destino delle anime:
Aeneas dum per inferos pergeret, respexit fluvium quendam loci remotioris, ad quem innumera multitudo tendebat animarum. In-terrogavit patrem qui esset fluvius vel qua ratione ad eum perge-rent animae. Pater ait: Lethaeus est; pergunt autem ut potent et oblivionem patiantur, ut incipiant in corpora velle remeare. Stupe-factus Aeneas interrogat: dic, pater, et animae quae propter prae-teritam vitam tot supplicia pertulerunt possunt habere votum re-vertendi in corpora? Non est verisimile liberatas de corporis car-cere ad eius nexum reverti. Suscepta narratione haec Anchises ex-sequitur: primo debere fieri ut redeant, deinde posse, deinde velle. Quae quoniam obscura sunt, aliis subdivisionibus innotescunt. Quid est debere? Cuncta animalia a deo originem ducunt. Quae nasci cernimus, revertuntur sine dubio: nam unde cuncta procre-antur? Deinde posse sic probat: quia immortales sunt animae, et sunt quae possunt reverti. Tertium est utrum velint: quod dici fieri per Lethaeum fluvium. Et hoc est quod dicturus est, sed inciden-tes quaestiones faciunt obscuritatem.
Come Agostino, anche Servio enfatizza il dialogo fra Enea e il padre, polarizzando sui due personaggi le diverse posizioni del dibattito sulla metempsicosi: Enea è detto stupefactus per le parole del padre. Oltre che nel passo citato del De civitate dei, Agostino valorizza il dialogo virgi-liano anche in serm. 241, 5, 5 [PL 38, 1135-36], dove afferma che me-lius filius intelligebat quam pater exponebat, in quanto Enea reprehendit cupiditatem animarum rursus in corpora redire volentium. Analoga l’obiezione che Servio fa formulare ad Enea, per cui non est verisimile liberatas de corporis carcere ad eius nexum reverti, che trova riscontro anche nella citata argomentazione che Agostino attribuisce a Porfirio,
46 È l’unica occorrenza del termine segnalata nell’Index di Mountford - Schultz.
Fabio Stok
178
per la quale stultum est credere che l’anima purificata possa desiderare le impurità del corpo e ad ista remeare.
Che Servio tenda ad attribuire all’intervento di Enea le obiezioni di Porfirio alla metempsicosi “ortodossa” lo possiamo verificare anche nel-lo scolio ad Aen. 6, 720: SVBLIMES ANIMAS non omnes, sed sublimes. Enea è sorpreso per il fatto che le anime ritornino a vivere nel mondo so-vrastante; Servio, forzando il valore di sublimis, assegna al termine un significato morale ed intende l’interrogativo in riferimento alle anime purgate, in aderenza alla posizione porfiriana.
Nello scolio a 6, 703 Anchise replica ad Enea con argomentazioni pa-lesemente platoniche: quae nasci cernimus, reventuntur sine dubio rie-cheggia la citata teoria di Phaedr. 70c-f per la quale le anime sono in nu-mero limitato e devono reincarnarsi regolarmente per garantire la conti-nuità della vita47. Se il debere è spiegato alla luce di questa teoria, e il posse a partire dalla tesi platonica dell’immortalità dell’anima, il passag-gio su cui Servio mostra la propria perplessità è quello che riguarda il velle, per il quale egli trova poco convincente l’argomento per cui sareb-be l’acqua del Lete a garantire che le anime incipiant in corpora velle remeare (cfr. il v. 751: rursus et incipiant in corpora velle reverti). È la stessa obiezione che Agostino muove alla teoria platonica, trovando in-concepibile che le anime facta penitus oblivione veterum miseriarum, in-cipiunt velle reverti in corpora (serm. 241, 4, 4 [PL 38, 1135])48.
L’interpretazione del discorso di Anchise è ripresa nello scolio ad Aen. 6, 724 (il più lungo dell’intero commento). Non sfugge a Servio il carattere digressivo della descrizione stoicheggiante dell’universo che Anchise propone ai vv. 724-738: interrogatus Anchises, quare animae velint reverti ad corpora, quasi aliud dicit. Dopo aver proposto svariati
47 Un argomentazione ripresa nel passo citato (n. 10) del filosofo Sallustio: cfr. SETAIOLI
1995, 132. 48 Un’esegesi che presenta notevoli convergenze con quella serviana, ma senza le riserve di
Servio sul velle, si legge in Beda De mundi coelesti terrestrique constitutione (PL 90 899B): phi-losophorum sententia est, quod animae solutae a corpore velint, debent et possint reicorporari. Velint, quia, potato Lethaeo, oblitae sunt praeteritorum videntesque praemium sibi propositum, si bene meruerint in corpore, desiderant incorporari. Possunt quia sunt immortales. Debent per ne-cessitatem, quia cum quotidie creentur corpora, animae vero semel iam ab origine omnes creatae sunt. Come ha osservato COURCELLE 2001, 376 Beda (o l’autore di questa operetta: l’attribuzione non è accolta unanimemente) appare qui «impregnato del pensiero macrobiano», accettando senza riserve quella metempsicosi che è regolarmente criticata nelle fonti cristiane (cfr. anche COUR-CELLE 1984, 493).
Servio e la metempsicosi
179
interrogativi sull’anima e sulla purgazione a cui essa è sottoposta dopo la morte del corpo, Servio torna, nella parte finale dello scolio, all’inter-rogativo posto da Enea:
Si ergo purgantur et recipiunt naturam suam, cur volunt reverti? Quia potant, inquit, oblivia. Etiam est illud ambiguum: aut ut praeteritarum obliviscantur poenarum, aut certe ut ignarae futuri habeant desiderium redeundi in corpora. Quod sine passione non fit: nam animus in quo est passio, meretur reverti.
La purgatio a cui l’interrogativa fa riferimento è quella descritta ai vv. 740-740, che nello stesso intervento di Anchise prelude all’arrivo nell’E-lisio: exinde per amplium / mittimur Elysium (vv. 743-744). Nella topo-grafia dello scolio a 6, 426, si ricordi, la purgatio corrisponde all’ottavo cerchio, l’Elisio al nono. Come nello scolio ad Aen. 6, 703, Servio mani-festa la propria perplessità sull’argomentazione addotta da Anchise per spiegare la volontà delle anime, cioè il fatto di bere l’acqua del Lete. L’obiezione è evidenziata nella parte finale: la reincarnazione non può avvenire sine passione. Essa riecheggia lo scolio a 6, 404, dove la rein-carnazione era detta impossibile in assenza di cupiditas. L’obiezione de-linea una sorta di aporia della posizione “ortodossa”: la reincarnazione presuppone una passio, ma quest’ultima dovrebbe esser stata eliminata in seguito alla purgatio.
Nello scolio Servio segnala anche l’ambiguità dell’espressione obli-via utilizzata da Anchise, che può essere riferita al passato, ut praterita-rum obliviscantur poenarum (riecheggia l’argomentazione di Enea nello scolio a 6, 703: animae quae propter praeteritam vitam tot supplicia pertulerunt), oppure al futuro, la cui conoscenza sarebbe un fattore che annullerebbe la volontà dei reincarnazione. La questione dell’oblio del futuro è trattata anche nello scolio a 6, 714, dove Servio giustifica il termine virgiliano oblivia proprio perché compatibile con ambedue le possibilità, che egli attribuisce rispettivamente ai poeti e ai filosofi: se-cundum poetas praeteritorum, secundum philosophos futuri (la duplice direzione temporale della perdita di memoria è segnalata anche per l’im-memores di 6, 750: vel praeteritorum vel futurorum). Non è chiaro chi siano i filosofi a cui Servio si riferisce49, in quanto nella tradizione plato-
49 SETAIOLI 1995, 60 rinvia ad Agostino serm. 241, 5, 5, che attribuisce la perdita di memoria alle miseriae della vita passata, ma che solo prospetticamente accenna a quelle della vita futura.
Fabio Stok
180
nica la perdita di memoria riguarda la natura divina dell’anima, che essa dimentica nel momento in cui si incarna: concetto peraltro evocato da Servio nella prima parte dello scolio ad Aen. 6, 714, cum coeperit in cor-pus descendere, potat stultitiam et oblivionem, unde non potest implere vim numinis sui post naturae suae oblivionem.
L’intera argomentazione sviluppata nello scolio a 6, 724 è attribuita ad Anchise: quia potant, inquit, oblivia. Anche in questo importante sco-lio, direi, Servio attribuisce la tesi “ortodossa” della metempsicosi ad Anchise, ed anche in questo caso non sembra ritenere la tesi stessa con-vincente.
Servio non ha dubbi, comunque, sul fatto che questa sia la posizione adottata da Anchise. Lo conferma il fatto che egli spiega sulla base di questa teoria alcuni passaggi specifici dell’intervento di Anchise. Così nello scolio a 6, 744, PAVCI LAETA ARVA TENEMVS non omnes, qui enim minus purgantur statim redeunt ad corpora, dove è esplicitata la posizione di Anchise sul rapporto pauci / multi: il privilegio dei primi non riguarda una diversa destinazione, che per tutte le anime resta la reincarnazione, ma solo la durata della permanenza nell’Elisio. Nella stessa direzione va lo scolio a 6, 748, dove Servio nota che al v. 713 Anchise non aveva specificato che tutte le anime si reincarnano: HAS OMNES ac si diceret: etiam has omnes. Nam supra non omnes dixit, sed animae quibus altera fato corpora debentur.
Anche nel successivo scolio a 6, 745 Servio espone la tesi “ortodos-sa” sostenuta da Anchise:
DONEC LONGA DIES PERFECTO TEMPORIS ORBE quia e-tiam post purgationem opus est tempore, ut perseveret in purga-tione et sic redeat. Et queritur utrum animae per apotheosin, de quibus ait pauci laeta arva tenemus (744) possint merere perpe-tuam vacationem. Quod non potest fieri: merentur enim temporis multi, non perpetuitatis, et quae male vixerunt statim redeunt, quae melius tardius, quae optime diutissimo tempore sunt cum numinibus. Paucae tamen sunt quae et ipse exigente ratione, licet tarde, coguntur reverti.
Il comportamento tenuto non influisce sulla destinazione dell’anima, ma
Un’influenza orfica, nel riferimento della perdita di memoria alle vite passate, è suggerita da MARCELLI 1998, 116
Servio e la metempsicosi
181
solo sulla durata della permanenza nell’Elisio. Negli scoli a 6, 127 e 6, 713 Servio aveva proposto, nell’argomentare la tesi opposta, una biparti-zione fra bene e male viventes; in questo caso propone una gradazione fra le anime quae male / melius / optime vixerunt per negare la possibili-tà di sfuggire alla metempsicosi. Il capovolgimento è netto, ma esso è spiegabile con il fatto che in questo caso Servio illustra la posizione di Anchise, diversa dalla propria.
Troviamo un’analoga distinzione, propter vitae merita / propter mala vitam, nello scolio ad Aen. 6, 713, dove Servio propone invece quella che è invece la propria convinzione, come segnala il sciendum:
ANIMAE QVIBVS ALTERA FATO CORPORA DEBENTUR sciendum non omnes animas ad corpora reverti: aliquae enim propter vitae merita non redeunt; aliquae redeunt propter malam vitam, aliquae propter fati necessitatem.
Anche questo scolio, un’obiezione / precisazione all’affermazione di Anchise, presenta una notevole analogia con le obiezioni mosse a Virgi-lio da Porfirio / Agostino. Rispetto alla posizione formulata in scoli pre-cedenti Servio introduce qui, accanto alla mala vita che condanna le ani-me alla reincarnazione, anche una seconda variabile, la fati necessitas. Setaioli50 ritiene che sia ripresa qui la tesi platonica di Tim. 42b-d67 sul-la prima incarnazione delle anime, ma Servio si riferisce inequivocabil-mente alla reincarnazione. Su una possibile diversa spiegazione di que-sta fati necessitas tornerò fra poco51.
50 SETAIOLI 1995, 66-67. 51 Fra gli scoli che presuppongono la versione “ortodossa” SETAIOLI 1995, 123 include ad
Aen. 6, 719, dove è distinto un significato “poetico” (Enea chiede se le anime risalgano in terra per reincarnarsi: nam secundum poetas hoc dicit: credendum est animas ab inferis reverti posse ad corpora? – ut caelum superos intelligamus, id est nostram vitam) ed uno “filosofico”, secundum philosophos vero hoc dicit: credendum est animas corporis contagione pollutas ad caelum rever-ti? Ma mi pare che anche nella versione “filosofica” l’interrogativa confermi la posizione “porfi-riana” di Enea, essendo ovviamente impossibile per le anime corporis contagione pollutae il ritor-no alla sede astrale (lo stesso SETAIOLI 1995, 212 interpreta questa parte dello scolio come «verità filosofica di un ricongiungimento dell’anima alla sua patria celeste»). È notevole, peraltro, la con-sonanza fra l’espressione virgiliana e l’opinione che Agostino attribuisce a Porfirio a civ. 10, 30 (frg. 11, 1 Bidez = 13 Madec - Goulet): vidit hoc Porphyrius purgatamque animam ob hoc reverti dixit ad Patrem, ne aliquando iam malorum polluta contagione teneatur. Cfr. anche lo stesso Agostino poco prima: dicit etiam ad hoc Deum animam mundo dedisse, ut materiae cognoscens mala ad Patrem recurreret nec aliquando iam talium polluta contagione teneretur.
Fabio Stok
182
4. Il comportamento di Servio, sulla base dell’analisi proposta, risulta meno contraddittorio di quanto non appaia a prima vista. Nel complesso del commento egli espone a più riprese la concezione “porfiriana” della metempsicosi, per la quale le anime dei peccatori si reincarnano, mentre quelle di coloro che hanno completato la purgazione raggiungono la se-de celeste. Nel connettere questa concezione all’architettura che egli in-dividua nell’Oltretomba virgiliano, Servio attribuisce evidentemente questa concezione a Virgilio. Lo stesso Servio, però, ritiene che Anchise esponga ad Enea la tesi platonica “ortodossa”, per cui tutte le anime si reincarnano; fa quindi riferimento a questa tesi nell’esegesi del discorso di Anchise, anche se non manca di far trasparire i propri dubbi in propo-sito.
Se si accetta questa ricostruzione, che restituisce una certa coerenza all’esegesi di Servio, si pone il problema delle ragioni che potrebbero aver indotto il commentatore a questa strategia. Una risposta a questo in-terrogativo è suggerita dallo scolio ad Aen. 6, 752, dove Anchise termina il suo discorso ed annuncia la Heldenschau: DIXERAT ANCHISES ante dicta de reversione animarum probatio huc tetendit, ut celebret Roma-nos et praecipue Augustum. Sihler, in un pregevole contributo pubblica-to oltre un secolo fa, deduceva da questo passo che, secondo Servio, Vir-gilio «merely resorted to metempsychosis as a device which would enable him to introduce a prospective survey of Roman greatness and grandess»52. Possiamo precisare meglio questo giudizio se identifichia-mo la probatio de reversione animarum nella teoria “ortodossa” sulla metempsicosi che Anchise ha appena esposto. Questa teoria, afferma Servio, è funzionale alla celebrazione di Roma e di Augusto sottesa alla Heldenschau.
In che senso la metempsicosi “ortodossa” può essere più funzionale di quella “porfiriana” alla celebrazione di Roma? Possiamo rispondere a questo interrogativo prendendo in considerazione la percezione corrente della metempsicosi nella Tarda Antichità, per la quale possiamo ricorre-re ancora ad una testimonianza agostiniana di Porfirio: si reincarnano, afferma Porfirio, le anime di coloro che immoderate atque inhoneste vi-xerint (civ. 12, 27 = De regressu animae frg. 11, 2 Bidez = 18 Madec - Goulet). Questa immagine “negativa” delle anime condannate alla rein-carnazione è corrente: Sinesio paragona l’anima reincarnata ad un lavo-
52 SIHLER 1920, 10.
Servio e la metempsicosi
183
ratore salariato che rimane in perpetua schiavitù per amore di una ser-va53. Nella versione di Servio, aderente a quella di Porfirio, le anime dei bene viventes raggiungano l’Elisio, mentre quelle dei male viventes sono costrette a reincarnarsi. Questo implica che le anime destinate a reincar-narsi negli eroi romani sono anime in precedenza male viventes. Se si ammette che questo fosse un problema effettivo per il lettore antico del-l’Eneide54, non c’è dubbio che l’interpretazione “ortodossa” risolveva la difficoltà: se tutte le anime si reincarnano, si può immaginare che quelle che diventeranno eroi romani ed augustei siano le migliori, e lo facciano dopo aver goduto a lungo dell’Elisio. È probabile che Servio, con la sua osservazione sulla probatio di Anchise finalizzata alla celebrazione dei Romani e di Augusto, pensasse a questa maggiore coerenza garantita al-la costruzione virgiliana dalla teoria “ortodossa”.
Il problema a cui la soluzione adottata da Servio cerca di rispondere è conseguente ad una giustapposizione fra metempsicosi ed Heldenschau che è stata spesso segnalata dalla critica moderna: Norden, prendendo a prestito una notazione di Probo55, parlò di ajpivqanon plavsma (“goffa in-venzione”)56, Setaioli di «antinomia difficilmente componibile»57. Nella prospettiva di Servio la soluzione adottata da una parte consentiva di e-ludere la citata difficoltà posta dalla reincarnazione degli eroi romani, dall’altra consentiva al commentatore di non attribuire a Virgilio una posizione platonica “ortodossa” che egli non condivideva (e che gli autori cristiani rimproveravano al poeta58). Appare costante, infatti, la tendenza di Servio a mettere in relazione il destino ultraterreno delle a-nime con il comportamento tenuto in vita, quindi con il fattore morale
53 Cit. in SETAIOLI 1995, 66. 54 Una traccia di questa sensibilità è rilevabile forse in una nota di Tiberio Donato, che prende
in considerazione un’improbabile interpretazione dell’espressione inclusas di v. 680, per la quale le anime dei futuri Romani sarebbero “prigioniere” in quanto colpevoli di qualche reato: non ad iniuriam dixit “inclusas” sed ad meliorem spem separatas a ceteris et penitus viridi in valle di-scretas. Hoc ipsum potest apparere, quando adiectum est “superumque ad lumen ituras”; non enim dimitterentur ad vitam, si ob reatum aliquem tenerentur inclusae (p. 596, 10-14 G.).
55 Testimoniata dal Servio Danielino ad Aen. 11, 554. 56 NORDEN 1984, 46. 57 SETAIOLI 1985, 957. 58 COURCELLE 2001, 305 vede in civ. 14, 5, dove Agostino commenta con espressioni tratte da
Virgilio l’interrogativo “porfiriano” che Enea rivolge ad Anchise, un tentativo del filosofo cristia-no di indicare «che lo stesso Virgilio non era pienamente convinto di questa dottrina». Ma Agosti-no, come abbiamo visto, è piuttosto netto nel rimproverare a Virgilio, a più riprese, la posizione platonica “ortodossa”.
Fabio Stok
184
(proprio questo fattore, del resto, è quello che maggiormente differenzia, già a partire dall’età ellenistica, le diverse concezioni della metempsico-si59). Per questo aspetto Servio non poteva condividere la metempsicosi “ortodossa”. Egli la conserva, però, limitatamente all’interpretazione del discorso di Anchise: anche in presenza, si direbbe, di un’esegesi neo-platonica dell’episodio virgiliano che doveva essere piuttosto influente e radicata, non essendo messa in discussione, come abbiamo visto, neppu-re dagli autori cristiani.
In riferimento alla concezione “porfiriana” (ma anche a quella “orto-dossa”) appare poco congruente il riferimento al fato che abbiamo trova-to nello scolio ad Aen. 6, 713, dove sono indicate due diverse cause della reincarnazione, il comportamento tenuto (propter malam vitam) e la ne-cessità del fato (propter fati necessitatem)60. Al di là della possibilità che Servio recepisse qualche fonte filosofica non identificabile61, resta il so-spetto che egli abbia qui evocato il destino per garantire in qualche mo-do agli eroi romani una provenienza meno sospetta di quella implicata dalla posizione “porfiriana”, senza dover aderire all’insostenibile posi-zione “ortodossa”62. Sarebbe stato infatti un provvidenziale destino, se si accetta questa interpretazione, e non il cattivo comportamento, a deter-minare la reincarnazione delle anime degli eroi della storia romana.
5. L’adozione della posizione “porfiriana” in tema di metempsicosi col-loca Servio in un’area di relativa convergenza con la posizione che ab-
59 Cfr. SETTNER 1934, 26. 60 Di necessitas parla anche uno scolio successivo, a proposito delle anime che vanno verso il
Lete, chiamate da un dio agmine magno (v. 749). Servio rileva la metafora militare ed osserva: et dictum est imperative, ajpeilhtikw`~: non enim blanditiis inductae redeunt, sed necessitate qua-dam coguntur ut potantes velint reverti. Ma la necessitas, in questo caso, sembra piuttosto quella postulata da Anchise per spiegare il fatto che le anime si rechino a bere l’acqua del Lete.
61 Una spiegazione di questo tipo, come abbiamo visto, è tentata da SETAIOLI 1995, 66-67. 62 Servio sembra introdurre criteri non morali nel determinare il destino delle anime anche nel-
lo scolio ad Aen. 6, 129, dove sarebbero distinte, secondo Setaioli 1995, 124, «tre categorie di uo-mini la cui anima torna all’origine celeste»: tria genera hominum dicit ad superos posse remeare: quos diligit Iuppiter, hoc est quos in ortu benignus siderum aspectus inradiat … quos prudentia sublevat … item religiosos quos a diis genitos dicit (il passo virgiliano è citato in relazione al de-stino delle anime e in senso cristiano da Giovanni di Salisbury in Policr. 5, 4 547: cfr. COURCEL-LE 2001, 367). Ma mi sembra che Servio qui resti aderente al contesto virgiliano, che riguarda (nelle parole della Sibilla) coloro a cui è stato consentito visitare l’Oltretomba e risalire sulla terra (v. 128: revocare gradum superasque evadere ad auras), e che lo scolio non interessi quindi il problema in esame.
Servio e la metempsicosi
185
biamo trovato sostenuta da Lattanzio e da Agostino. Ambedue questi au-tori, come abbiamo visto, contestano la posizione “platonica” di Virgi-lio63, ed Agostino guarda con evidente simpatia alla revisione della teo-ria platonica operata da Porfirio.
La posizione di Servio, nei termini in cui l’abbiamo ricostruita, da una parte fa propri i rilievi posti dai due autori cristiani, ed adotta sen-z’altro la posizione di Porfirio, dall’altra salva la posizione di Virgilio, mettendolo al riparo dalle critiche che gli erano state rivolte: la posizio-ne platonica, infatti, è attribuita ad Anchise, mentre l’impianto virgiliano dell’Oltretomba, nei termini in cui Servio interpreta la finzione poetica, appare del tutto funzionale alla posizione porfiriana.
Queste conclusioni possono contribuire alla ridefinizione della tradi-zionale collocazione di Servio nell’ambito del neoplatonismo pagano, quale è stata a lungo suggerita dalla presenza di Servio nei Saturnalia di Macrobio64. Ma già diversi anni fa Kaster ha segnalato la distanza del Servio-personaggio di Macrobio dal Servio che conosciamo grazie al commento virgiliano65. Anche un altro argomento addotto tradizional-mente a sostegno della posizione anticristiana di Servio, il suo impegno nella conservazione degli antichi riti pagani66, è stato fortemente ridi-mensionato qualche anno fa da Murgia, che ha segnalato uno scarto si-gnificativo fra l’esegesi serviana e quella del Servio Danielino, risalente probabilmente a Donato: mentre nelle note del Danielino i riferimenti ai rituali pagani sono formulate al presente, nella versione serviana il pre-sente è volto in un tempo passato67. Una modifica, questa di Servio, che riflette un dato fattuale, l’abolizione dei sacrifici pagani decretata da Teodosio nel 391, ma che appare anche sintomatica di un approccio di Servio nei confronti del rapporto paganesimo / Cristianesimo meno netto di quanto non si pensasse in passato.
La Jeunet-Mancy, nel rilevare alcune convergenze fra le posizioni di Servio e quelle cristiane, ritiene che esse siano interpretabili «comme
63 Non mi pare quindi che Lattanzio, come afferma KAUFMANN 2010, 158, per questo aspetto consideri Virgilio «a proto-Christian».
64 Cfr. per es. JONES 1986, 113: «Neoplatonic doctrine was employed by pagan writers as a countervail to Christianity, and Servius clarly belongs in this company as his presence as an interlocutor in the Saturnalia of the Neoplatonist Macrobius shows».
65 KASTER 1980 (anche KASTER 1988, 60-62). La figurazione macrobiana di Servio è stata analizzata più recentemente da GOLDLUST 2011, che ha individuato in essa tratti caricaturali.
66 Cfr. JONES 1986, 117. 67 MURGIA 1988, 486n; MURGIA 2004, 190-91; CAMERON 2011, 575-80.
Fabio Stok
186
una réponse aux promesses de salut faites par le chrétiens»68, ma il giu-dizio risente evidentemente della tradizionale collocazione di Servio nei circoli dell’aristocrazia pagana mitizzata da Macrobio69. Potremmo facil-mente interpretare le citate convergenze in senso non conflittuale: Ca-meron, nel suo volume sui Last Pagans of Rome, colloca Servio fra i «center-pagans», con una definizione mutuata dalla moderna terminolo-gia delle collocazioni politiche70. L’opera di Servio, del resto, era indi-rizzata ad un pubblico in larga parte cristianizzato, e di questa realtà egli non poteva certo non tener conto.
L’operazione che abbiamo ricostruito in merito alla metempsicosi avvalora questa ridefinizione della collocazione culturale di Servio. Egli recupera in parte, come abbiamo visto, la tradizionale esegesi neoplato-nica, ma la circoscrive all’intervento di Anchise, attribuendo a Virgilio una posizione “porfiriana” che era vista come maggiore simpatia negli ambienti cristiani, come evidenzia Agostino. L’interpretazione neoplato-nica, va peraltro osservato, doveva essere piuttosto consolidata, in quan-to essa è nota ancora a Fulgenzio, che cita Aen. 6, 720, sublimes animas iterumque ad tarda reverti corpora, come tesi tipicamente platonica (è da notare che Fulgenzio, con ogni probabilità, interpreta sublimes nel senso che abbiamo trovato esplicitato da Servio). Nel dialogo dell’Expo-sitio Virgilianae continentiae Virgilio spiega l’affermazione come inser-zione epicurea volta a rimarcare il proprio paganesimo: si inter tantas Stoicas veritates aliquid etiam Epicureum non desipissem, paganus non essem (dove “epicureo” è sinonimo di “pagano”, senza alcun riscontro nella filosofia epicurea71).
Che Servio adottasse una posizione di mediazione fra la tradizione pagana e la sensibilità cristiana lo evidenziano anche gli scoli in cui toc-ca aspetti specifici, connessi alla metempsicosi, che erano oggetto di dis-senso fra pagani e cristiani. Nello scolio ad Aen. 6, 532 Servio, prenden-do lo spunto da un verso di Tiberiano, cita la tesi per cui la reincarnazio-ne avverrebbe agli antipodi: prudentiores atiam animas per metempsico-sin dicunt ad alterius climatis corpora transire, nec in eo orbe versari in quo prius fuerunt. Lo scolio ad georg. 1, 243 mette in relazione questa
68 JEUNET-MANCY 2012, CXII-CXIII. 69 Cfr. JEUNET-MANCY 2012, XVI-XIX. 70 CAMERON 2011, 176. 71 L’affermazione, come ha osservato SETAIOLI 2004, 341, risente della conoscenza ormai ste-
reotipata dell’Epicuresimo che prevale nell’età di Fulgenzio.
Servio e la metempsicosi
187
tesi con la purificazione che si verificherebbe con il passaggio dell’ani-ma attraverso la zona torrida: tesi che Servio trova verosimile in consi-derazione del fatto che le anime aut igni aut vento aut aqua purgari (si riferisce ovviamente a Aen. 6, 740-742)72. L’esistenza degli antipodi era negata dai cristiani (cfr. Lact. inst. 3, 24; Aug. civ. 16, 9)73, ma era un dato anche ben consolidato nella tradizione filosofica e scientifica, e non sorprende quindi che Servio lo riprenda nei luoghi citati. Proprio alla questione degli antipodi si riferisce probabilmente la nota conclusiva dello scolio ad georg. 1, 243, dove Servio rivela le difficoltà poste dalla questione, ma conferma la sua verità filosofica: licet alii hoc a Vergilio dictum per poeticam licentiam velint, tamen sciendum est eum poeticae licentiae inseruisse philosophiam.
Setaioli segnala, fra i punti di divergenza fra Servio e gli autori cri-stiani, anche la possibilità di trasmigrazione delle anime in corpi di ani-mali74. Si tratta di un postulato platonico che il neoplatonismo tardo ten-de ad abbandonare, ed anche per questo aspetto Agostino civ. 10, 30 (frg. 11, 1 Bidez = 13A Madec - Goulet) esalta il ruolo innovatore avuto da Porfirio, che avrebbe negato questo dogma platonico conservato an-cora da Plotino. Non è in realtà del tutto chiara la portata della svolta o-perata da Porfirio, connessa a difficoltà dottrinali che si erano poste da tempo nella tradizione platonica75. Se nel De regressu animae Porfirio sostenne la posizione attribuitagli da Agostino, in sede di esegesi ome-rica egli sembra aver avvalorato un’interpretazione allegorica dell’episo-dio odissiaco di Circe (ap. Stob. I 445, 15-448, 3)76.
L’unico scolio in cui Servio fa riferimento esplicito alla reincarnazio-ne in animali è ad Aen. 6, 741, a proposito delle tre forme di purgazione
72 In ambedue gli scoli la tesi della metempsicosi agli antipodi è suffragata dalla citazione di
Lucano 1, 456-457, regit idem spiritus artus / orbe alio. Corrispondenze sono rilevabili nell’ese-gesi lucanea (cfr. anche nota 35): i Commenta Bernensia ad l. rinviano alla teoria della metempsi-cosi e citano Aen. 6, 532.
73 Cfr. SETAIOLI 1995, 184; JEUNET-MANCY 2012, LXXXVII. 74 SETAIOLI 1995, 14-15 e 217-18. 75 Per la ricostruzione dell’intero dibattito resta fondamentale il contributo di DÖRRIE 1957. 76 Cfr. BUFFIÈRE 1956, 507-17. DÖRRIE 1957, 425 ritiene questa allegoresi del mito non con-
traddittoria rispetto alla posizione attribuita a Porfirio da Agostino. Più prudente SMITH 1984, per il quale la posizione di Porfirio (e di Giamblico) resta incerta. MRAS 1933, 253 aveva ipotizzato un’evoluzione del pensiero di Porfirio, dal platonismo ortodosso alla revisione testimoniata da Agostino (possibilità presa in considerazione anche da DEUSE 1983, 138-48, che però non esclude che la testimonianza di Stobeo sia spuria).
Fabio Stok
188
delle anime descritte da Anchise ai vv. 740-742: triplex est omnis purgatio: aut enim in terra purgantur quae nimis oppressae sordibus fuerint, deditae scilicet corporalibus blandi-mentis, id est transeunt in corpora terrena: et hae igni dicuntur purgari, ignis enim ex terra est quo exuruntur omnia, nam caele-stis nihil periit; aut in aqua, id est transeunt in corpora marina, si paulo melius vixerint; aut certe in aere, transeundo scilicet in aeria corpora, si satis bene vixerint. Quod in Statio legimus, ubi de au-guriis tractat.
La teoria che Servio riecheggia è quella che si legge in Plato Tim. 91d-92c, dove la reincarnazione in animali aerei, terrestri e acquatici è corre-lata con la maggiore o minore contaminazione dell’anima nella vita pre-cedente77. Ma nell’adattare Platone al passo virgiliano l’esegesi ripresa da Servio ha dovuto operare una forzatura, identificando il fuoco con l’elemento terra, per giustificare così la reincarnazione in animali terre-stri. Il passo di Stazio, non identificato da Thilo, è probabilmente Theb. 3, 485-48678, dove Anfiarao accenna alla reincarnazione delle anime ne-gli uccelli79. L’esegesi potrebbe derivare dalla già più volte menzionata esegesi neoplatonica dell’opera virgiliana, anche se l’interpretazione non è citata da Agostino a civ. 21, 13, dove il passo virgiliano è citato come “platonico”, e contestato in quanto prevede la purificazione anziché la punizione dei peccati:
qui hoc opinantur nullas poenas nisi purgatorias volunt esse post mortem, ut, quoniam terris superiora sunt elementa aqua aer ignis, ex aliquo istorum mundetur per expiatorias poenas quod terrena contagione contractum est, aer quippe accipitur in eo quod ait su-spensae ad ventos, aqua in eo quod ait sub gurgite vasto, ignis au-tem suo nomine expressus est cum dixit aut exuritur igni.
In luogo dell’interpretazione serviana citata, Agostino sembra presup-porne una vicina a quella che si legge nel seguito dello scolio serviano: tres sunt istae purgationes: nam aut taeda purgant ex sulphure, aut
77 Cfr. SETAIOLI 1995, 212-18. 78 Cfr. SETAIOLI 1995, 213; JEUNET-MANCY 2012, 170; MONNO 2013, 137-38. 79 Alla teoria della metempsicosi fa riferimento anche Lattanzio Placido nello scolio ad l.: hoc
philosophice. Aiunt enim metemyuvvcwsin fieri animarum in corpora.
Servio e la metempsicosi
189
aqua abluunt, aut aere ventilant (lo stesso Servio, come abbiamo visto, accoglie un’interpretazione più letterale del passo virgiliano anche nello scolio ad georg. 1, 24380).
Un accenno indiretto alla reincarnazione in corpi animali è rilevabile forse nella parafrasi dell’intervento di Anchise, nel citato passaggio in cui Servio espone la motivazione del debere: cuncta animalia a deo ori-ginem ducere. Quae nasci cernimus, revertuntur sine dubio: nam unde cuncta procreamur? (ad Aen. 6, 703), dove cuncta animalia riecheggia la dottrina platonica.
Meno sicuri mi sembrano altri riferimenti alla reincarnazione in ani-mali segnalati da Setaioli. Generico è il permutatione diversa nello sco-lio citato ad Aen. 6, 127. Di maggiore rilievo sono i riferimenti al mito di Circe, in quanto il tema era stato trattato, come abbiamo visto, da Por-firio. Ma negli scoli ad Aen. 3, 386 e 7, 10 Servio si limita a segnalare l’etimologia di Aeaea (l’isola di Circe) ab horrore transeuntium, quod homines mutabantur in feras (così a 7, 10), senza riferimenti espliciti al-la teoria platonica. È forse significativo, inoltre, che Servio non com-menti l’esplicito riferimento di ecl. 8, 70 alle metamorfosi operate da Circe, socios mutavit Ulixi.
Il silenzio di Servio appare anche più significativo se si considera che la vicenda di Circe era probabilmente trattata, in riferimento alla metem-psicosi, dall’esegesi neoplatonica di Virgilio: Ambrogio De excessu fra-tris 2, 128, nel contestare la metempsicosi in animali, riecheggia Aen. 7, 15 e altri passi virgiliani81. Nella reticenza che mostra sulla vicenda di Circe, Servio tenne certamente conto della radicata ostilità della cultura cristiana nei confronti di questo tipo di metempsicosi (diversamente da Macrobio, che a somn. 1, 9, 5 ammette senz’altro la reincarnazione in animali82).
Sulla metempsicosi in animali, in definitiva, Servio mantiene un at-teggiamento piuttosto prudente, pur senza abbandonare esplicitamente la tradizione platonica. È probabile che anche per questo aspetto egli rical-casse la posizione di Porfirio. È vero che quest’ultima, come abbiamo visto, non è del tutto chiara, ma comunque resta del tutto verosimile che
80 Per SETAIOLI 1995, 221-22 si tratta di «un adattamento non meglio riuscito di quello di ad Aen. 6, 741».
81 Cfr. COURCELLE 1884, 485-86; COURCELLE 2001, 374. Più prudente, su questa possibilità, è SETAIOLI 1995, 217.
82 In dipendenza probabilmente da Plotino: cfr. FLAMANT 1977, 620-22.
Fabio Stok
190
il filosofo avesse sottoposto a revisione anche questo postulato della tra-dizione platonica. Qualche motivo deve pure averlo avuto, Agostino, nel definire Porfirio un platonico che in melius a Platone dissentit (civ. 10, 30).
Bibliografia
ARMISEN-MARCHETTI M. 2003: (éd.) Macrobe, Commentaire au Songe de
Scipion I, Paris. AUSTIN R. G. (1977): (ed.) P. Vergili Maronis Aeneidos liber sextus, Oxford. BARBARA S. 2011: “Le Commentaire à l’Énéide de Servius et les Adnotatio-
nes super Lucanum: regards croisés”, in Servius et sa réception de l’Anti-quité à la Renaissance, éd. M. Bouquet et B. Méniel, Rennes, 277-308.
BIDEZ J. 1913: Vie de Porphyre: le philosophe néo-platonicien, Gand-Leipzig. BITSCH F. 1911: De Platonicorum quaestionibus quibusdam Vergilianis, diss.
Berlin. BOYANCÉ P. 1935: “Le deux démons personnels dans l’antiquité grecque et
latine”, RPh 61, 189-202. BOYANCÉ P. 1960: “Sur le discours d'Anchise (Énéide VI 724-751), in
AA.VV. Hommage à G. Dumezil, Bruxelles 1960, pp. 60-76. BUFFIÈRE F. 1956: Les mythes d’Homère et la pensée grecque, Paris. CAMERON A. 2011: The Last Pagans of Rome, Oxford. CARDAUNS B. 1976: (ed.) M. Terentius Varro, Antiquitates Rerum Divina-
rum, 2 voll., Wiesbaden. CLARK R. 1979: Catabasis: Vergil and the Wisdom Tradition, Amsterdam. CONTE G. B. 2009: (ed.) P. Vergilius Maro, Aeneis, Berlin-New York. COURCELLE P. 1948: Les lettres grecques en Occident de Macrobe à Cassio-
dore, Paris (19431). COURCELLE P. 1955: “Les Pères de l’Église devant les enfers virgiliens”,
AHMA 30. 5-74. COURCELLE P. 1984: Lecteurs païens et lecteurs chrétiens de l’Énéide I, Pa-
ris. COURCELLE P. 2001: Conosci te stesso. Da Socrate a San Bernardo, trad. it.
Milano (ed. orig. 1974-1975). CUMONT F. 1949: Lux perpetua, Paris. DEUSE W. 1983: Untersuchungen zur mittelplatonischen und neeplatonischen
Seelenlehre, Wiesbaden. DOIGNON J. 1981: “«Quisque suos patimur manes» (Virgile, «Énéide», VI,
743) dans le christianisme latin à la fin du IVe siècle (Zénon de Vérone, Au-sone, Ambroise)”, in L'épopée gréco-latine et ses prolongements indo-euro-péens, éd. R. Chevallier, Paris, 107-116.
Servio e la metempsicosi
191
DÖRRIE H. 1957: “Kontroversen um die Seelenwanderung im kaiserzeitlichen Platonismus”, Hermes 85, 414-35 (rist. in Id., Platonica Minora, München 1976, 420-40).
ESPOSITO P. 2004: “Virgilio e Servio nella scoliastica lucanea: tra Adnotatio-nes super Lucanum e Commenta Bernensia”, in Gli scolii a Lucano ed altra scoliastica latina, a c. di P. Esposito, Pisa, 25-107.
FLAMANT J. 1977: Macrobe et le néo-platonisme latin à la fin du IVe siècle, Leiden.
GEORGII G. 1891: Die antike Aeneiskritik aus den Scholien und anderen Quel-len, Stuttgart.
GERSH S. 1986: Middle Platonism and Neoplatonism. The Latin tradition, No-tre Dame, Ind.
GEYMONAT M. 1973: (ed.) P. Vergilius Maro, Opera, Torino (Roma 20082). GOLDLUST B. 2011: “Macrobe «Serviomastix» ? L’image paradoxale de Ser-
vius dans le livre II des Saturales”, in Servius et sa réception de l’Antiquité à la Renaissance, edd. M. Bouquet - B. Méniel, Rennes, 27-38.
GOULET R. 2012: “Augustin et le De regressu animae de Porphyre”, in Augu-stin philosophie et prédication. Hommage à Goulven Madec. Actes du col-loque international organisé à Paris les 8 et 9 septembre 2011, Paris, 67-110.
HADOT P. 1971: Marius Victorinus. Recherches sur sa vie et ses oeuvres, Pa-ris.
HORSFALL N. 1991: Virgilio: l’epopea in alambicco, Napoli. JEUNET-MANCY E. 2012: (ed.) Servius, Commentaire sur l’Énéide de Virgi-
le. Livre VI, Paris. JONES J. W., Jr. 1986: “The Allegorical Traditions of the Aeneid”, in Vergil at
2000 Commemorative Essays on the. Poet and his Influence, ed. J. D. Ber-nard, New York, 107-32.
JOOST-GAUGUER C. L. 2006: Measuring Heaven. Pythagoras and His In-fluence in Thought and Art in Antiquity and the Middle Ages, Ithaca, NY.
KASTER R. A. 1980: “Macrobius and Servius: Verecundia and the Gramma-rian’s Function”, HSCPh 84, 219-62.
KASTER R. A. 1988: Guardians of Language. The Grammarian and Society in Late Antiquity, Berkeley-Los Angeles-London.
KAUFMANN H. 2010: “Virgil’s Underworld in the Mind of Roman Late Anti-quity”, Latomus 69, 151-60.
MADEC G - GOULET R. 2012: “Porphyre de Tyr: Sur le retour de l’âme. Un recueil provisoire des témoignages et des fragments avec une traduction française et des notes”, in Augustin philosophie et prédication. Hommage à Goulven Madec. Actes du colloque international organisé à Paris les 8 et 9 septembre 2011, Paris, 111-84.
Fabio Stok
192
MARCELLI E. 1998; “Servio platonizzante”, GIF 50, 113-22. MARCELLINO G. 2012: (ed.) Favonii Eulogii, Disputatio de Somnio Scipionis,
Napoli. MONNO O. 2013: La Tebaide nella bibliotheca di un grammatico. Citazioni di
Stazio nel commento di Servio a Virgilio, Bari. MRAS K. 1933: “Macrobius’ Kommentar zu Ciceros Somnium. Ein Bietrag zur
Geistesgeschichte des 5. Jahrhunderts n. Chr.”, SPAW, 232-86. MURGIA Ch. 1988: “Aen. 9.236 – An Unrecognized Virgilian Variation”,
Hermes 116, 493-99. MURGIA Ch. 2003: “Tha Dating of Servius Revisited”, CPh 98, 49-59. MURGIA Ch. 2004: “The Truth about Vergil’s Commentators”, in Romane me-
mento. Vergil in the Fourth Century, ed. R. Rees, London, 189-200. NORDEN E. 1957: (ed.) Publius Vergilius Maro, Aeneis Buch VI, Stuttart4. PELLIZZARI A. 2003: Servio. Storia, cultura e istituzioni nell’opera di un
grammatico tardoantico, Firenze. REGALI M. 1983: (ed.) Macrobio, Commento al Somnium Scipionis libro I, Pi-
sa. SETAIOLI A. 1985: s.v. “inferi, loci”, Enciclopedia Virgiliana II, Roma, 953-
63. SETAIOLI A. 1995: La vicenda dell’anima nel commento di Servio a Virgilio,
Frankfurt a. M. SETAIOLI A. 2004: “Interpretazioni stoiche ed epicuree in Servio e la tradizio-
ne dell’esegesi filosofica del mito e dei poeti a Roma (Cornuto, Seneca, Fi-lodemo) I, IJCT 10, 335-76.
SIHLER E. G. 1910: “Serviana”, AJPh 31, 1-24. SMITH A. 1974: Porphyry’s Place in the Neoplatonic Tradition. A Study in
Post-Plotinian Neoplatonism, The Hague. SMITH A. 1984: “Did Porphyry reject the Transmigration of Souls into Ani-
mals?”, RhM 127, 276-84 (rist. in Id., Plotinus, Porphyry and Iamblichus: Philosophy and Religion in Neoplatonism, Farnham 2011, n. XVII).
STETTNER W. 1934: Die Seelenwanderung bei Griechen und Römern, Stutt-gart-Berlin.
TOMMASI MORESCHINI C. O. i.c.s.: “Un testimone poco noto della fortuna degli Oracoli Caldaici in latino: Favonio Eulogio”, in Actes de la Duexième journée d’études sur les Oracles chaldaïques, éd. A. Lecerf et L. Saudelli, in corso di stampa.
Indice
Fabio Stok Introduzione
7
Giancarlo Abbamonte Tra filologia e poetica: riflessi del commento virgiliano di Anneo Cornuto nell’esegesi posteriore e nei poeti del I sec. d.C.
15 Daniel Vallat Per transitum tangit: allusions, sens cachés et réception de Virgile dans le commentaire de Servius
51 Maria Luisa Delvigo Servio e i veteres
83
Caterina Lazzarini Servio: lezioni di stile. Citazioni di poeti fra esegesi e formazione
101 Olga Monno Saggio di scavo nella bibliotheca di un grammatico: Servio, Virgi-lio e Stazio
125
Giampiero Scafoglio Servio e i poeti romani arcaici
145
Fabio Stok Servio e la metempsicosi
165
Jean-Yves Guillaumin Nursia e i Gracchi (Servio ad Aen. 7, 715)
193
Liliana Pégolo La exégesis serviana acerca del carácter non enarrabile del escudo de Eneas
205
452
Carlo Santini Tracce serviane negli scolii alla Tebaide di Lattanzio Placido Giuseppe Ramires
219
Il valore delle aggiunte dei mss. a nella costituzione del testo dei Commentarii virgiliani di Servio
231
Stefano Poletti La tradizione delle interpolazioni a Servio tipiche del Reg. lat. 1495
257 Monique Bouquet Le Servius de Cristoforo Landino, d’après le commentaire aux Bu-coliques de Virgile
293
Carlo M. Lucarini Per la storia delle Interpretationes Vergilianae di Tiberio Claudio Donato: dagli esemplari tardo antichi alla fase insulare e carolin-gia a Luxeuil
315
Luigi Pirovano Note filologiche al ‘nuovo’ Tiberio Claudio Donato
341
Massimo Gioseffi Interpretatio e paraphrasis da Seneca a Tiberio Claudio Donato
361 Marisa Squillante Talem monstrare Aenean debuit, ut dignus Caesari parens praebere-tur: Augusto in Tiberio Claudio Donato
391
Alice Daghini La brevitas nelle Interpretationes Vergilianae di Tiberio Claudio Donato
401 APPENDICE: Il carteggio su Servio di Timpanaro – Ramires
429
Raffaella Tabacco Timpanaro, il latino tardo e gli strumenti elettronici
431
Paolo Esposito Servio, Timpanaro, Ramires e il metodo della filologia per litteras
443
Indice 451
Edizioni ETSPiazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
[email protected] - www.edizioniets.comFinito di stampare nel mese di novembre 2013
FINITO_000_pag.edit. 14/11/13 15.26 Pagina 1
Testi e studi di cultura classica
Collana fondata daGiorgio Brugnoli e Guido Paduano
Diretta daGuido Paduano, †Alessandro Perutelli, Fabio Stok
1. Giorgio Brugnoli, Foca: vita di Virgilio. Introduzione, testo, traduzione ecommento, 1983, 19952, pp. XX-58 [con due tavole fuori testo].
2. Fabio Stok, Percorsi dell’esegesi virgiliana. Due ricerche sull’Eneide,1988, pp. 200.
3. Giorgio Brugnoli, Identikit di Lattanzio Placido. Studi sulla scoliasticastaziana, 1988, pp. 82.
4. Elena Rossi, Una metafora presa alla lettera: le membra lacerate dellafamiglia. «Tieste» di Seneca e i rifacimenti moderni, 1989, pp. 154.
5. Domenico De Venuto, Il Bucolicum Carmen di F. Petrarca. Edizionediplomatica dell’autografo Vat. Lat. 3358, 1990, pp. XLVI-182.
6. Rosa Maria Lucifora, L’ablativo assoluto nella Pharsalia. Riflessioni sultesto e sullo stile di Lucano, 1991, pp. 172.
7. Nicoletta Palmieri, L’antica versione latina del «De Sectis» di Galeno(Pal. lat. 1090), 1992, pp. 236.
8. Alessandro Grilli, Inganni d’autore. Due studi sulle funzioni del prota-gonista nel teatro di Aristofane, 1992, pp. 232.
9. [Aristotele], De spiritu, a cura di Amneris Roselli, 1992, pp. 160.
10. Giorgio Brugnoli, Fabio Stok, Ovidius parw/dhvsa", 1992, pp. 218.
11. Preveggenze umanistiche di Petrarca. Atti delle giornate petrarchesche diTor Vergata (Roma-Cortona 1/2 giugno 1992), 1994, pp. 320.
12. Giorgio Brugnoli, Curiosissimus Excerptor. Gli «Additamenta» di Giro-lamo ai «Chronica» di Eusebio, 1995, pp. LX-248.
13. Carlo Santini, I frammenti di L. Cassio Emina. Introduzione, testo, tra-duzione e commento, 1995, pp. 228.
14. Tiziana Privitera, Didone mascherata: per il codice genetico di EmmaBovary, 1996, pp. 84.
TESTI E STUD.CULT.CLAS. _000_pag.edit. 06/11/13 09.50 Pagina 1
15. Pompei exitus. Variazioni sul tema dall’Antichità alla Controriforma, acura di Giorgio Brugnoli e Fabio Stok, 1996, pp. 260.
16. Patrizio Domenicucci, Astra Caesarum. Astronomia, astrologia e cata-sterismo da Cesare a Domiziano, 1996, pp. 194.
17. L. Iuni Moderati Columellae, Rei rusticae liber decimus (carmen de cul-tu hortorum), a cura di Francesca Boldrer, 1996, pp. 404.
18. Rosa Maria Lucifora, Prolegomeni all’elegia d’amore, 1996, pp. 192.
19. Marco Fucecchi, La teicoskopiva e l’innamoramento di Medea. Saggiodi commento a Valerio Flacco «Argonautiche» 6,427-760, 1997, pp. 300.
20. Giorgio Brugnoli, Studi Danteschi. I Per suo richiamo, 1998, pp. 218.
21. Giorgio Brugnoli, Studi Danteschi. II I tempi cristiani di Dante, 1998,pp. 212.
22. Giorgio Brugnoli, Studi Danteschi. III Dante Filologo: l’esempio diUlisse, 1998, pp. 134.
23. Nicoletta Palmieri, L’eroe al bivio: modelli di “mors uoluntaria” in Sene-ca tragico, 1998, pp. 204.
24. Giorgio Brugnoli, Roberto Rea, Studi leopardiani, 2001, pp. 126.
25. Fabio Stok, Studi sul Cornu Copiae di Niccolò Perotti, 2002, pp. 240.
26. Lucio Anneo Seneca, Medea, introduzione, traduzione e commento diAnnalisa Németi, con un saggio di Guido Paduano, 2003, pp. 306.
27. Alessandro Perutelli, Prolegomeni a Sisenna, 2004, pp. 144.
28. Silvia Paponi, Per una nuova edizione di Nevio comico, 2005, pp. 172.
29. Emanuele Narducci, Cicerone e i suoi interpreti. Studi sull’opera e lafortuna, 2004, pp. 444.
30. Giorgio Brugnoli, Studi di filologia e letteratura latina, a cura di SilviaConte e Fabio Stok, 2004, pp. 252.
31. Hinc Italae gentes. Geopolitica ed etnografia italica nel Commento diServio all’Eneide, a cura di Fabio Stok e Carlo Santini, 2004, pp. 314.
32. Gli scolii a Lucano ed altra scoliastica latina, a cura di Paolo Esposito,2004, pp. 204.
33. Aspetti della Fortuna dell’Antico nella Cultura Europea, I, a cura diEmanuele Narducci, Sergio Audano, Luca Fezzi, 2005, pp. 210.
34. Giorgio Brugnoli, Fabio Stok, Studi sulle Vitae Vergilianae, 2006,pp. 160.
TESTI E STUD.CULT.CLAS. _000_pag.edit. 06/11/13 09.50 Pagina 2
35. Aspetti della Fortuna dell’Antico nella Cultura Europea, II, a cura diEmanuele Narducci, Sergio Audano, Luca Fezzi, 2005, pp. 110.
36. Tiziana Privitera, Terei puellae: metamorfosi latine, 2007, pp. 104.
37. «Vediamo se sei filologo….». Studi, interessi e curiosità di Giorgio Bru-gnoli, a cura di Riccardo Scarcia e Fabio Stok, 2007, pp. 158.
38. Una guerra in Colchide. Valerio Flacco, Argonautiche 6,1-426, introdu-zione, traduzione e commento a cura di Marco Fucecchi, 2006,pp. 392.
39. Aspetti della Fortuna dell’Antico nella Cultura Europea, III, a cura diEmanuele Narducci, Sergio Audano, Luca Fezzi, 2007, pp. 172.
40. Quinto Ennio, Le opere minori. Introduzione, edizione critica deiframmenti e commento a cura di Alessandro Russo, 2007, pp. 300.
41. Aspetti della Fortuna dell’Antico nella Cultura Europea, IV, a cura diEmanuele Narducci, Sergio Audano, Luca Fezzi, 2008, pp. 192.
42. Esegesi dimenticate di autori classici, a cura di Carlo Santini, FabioStok, 2008, pp. 404.
43. Agostino a scuola: letteratura e didattica, a cura di Fabio Gasti e Mari-no Neri, 2009, pp. 194.
44. Alessio Umbrico, Terenzio e i suoi nobiles. Invenzione e realtà di uncontroverso legame, 2010, pp. 136.
45. Aspetti della Fortuna dell’Antico nella Cultura Europea, V, a cura diSergio Audano, 2010, pp. 168.
46. Sub Imagine Somni: Nighttime Phenomena in Greco-Roman Culture,edited by Emma Scioli and Christine Walde, 2010, pp. 340.
47. Devotionis munus. La cultura e l’opera di Adamo di Brema, a cura diRiccardo Scarcia e Fabio Stok, 2010, pp. 208.
48. Vates Operose Dierum. Studi sui Fasti di Ovidio, a cura di Giuseppe LaBua, 2010, pp. 272.
49. Sedula Cura Docendi Studi sull’Anthologia Latina per / con RiccardoScarcia, a cura di Tiziana Privitera e Fabio Stok, 2011, pp. 128.
50. Lorenzo Miletti, L’arte dell’autoelogio. Studio sull’orazione 28 K di ElioAristide, con testo, traduzione e commento, 2011, pp. 230.
51. Alessandro Perutelli, Studi sul teatro latino, a cura di Guido Paduano eAlessandro Russo, 2013, pp. 190.
TESTI E STUD.CULT.CLAS. _000_pag.edit. 06/11/13 09.50 Pagina 3
52. Tatiana Korneeva, Alter et ipse: identità e duplicità nel sistema dei per-sonaggi della Tebaide di Stazio, 2011, pp. 250.
53. Letteratura e Civitas. Transizioni dalla Repubblica all’Impero. In ricordodi Emanuele Narducci, a cura di Mario Citroni, 2012, pp. 456.
54. Claudio Buongiovanni, Gli epigrammata longa del decimo libro di Mar-ziale, introduzione, testo, traduzione e commento, 2012, pp. 480.
55. L’addio di Medea. Valerio Flacco, Argonautiche 8,1-287, introduzione ecommento a cura di Caterina Lazzarini, 2012, pp. 282.
56. Giancarlo Abbamonte, Diligentissimi uocabulorum perscrutatores.Lessicografia ed esegesi dei testi classici nell’Umanesimo romano di XVsecolo, 2012, pp. 250.
57. Edipo. Margini, confini, periferie, a cura di Patrizia Pinotti, MassimoStella, 2013, pp. 442.
58. Sebastiano Timpanaro, Giuseppe Ramires, Carteggio su Servio 1993-2000, a cura di Giuseppe Ramires, prefazione di Fabio Stok, 2013,pp. 286.
59. Patrizio Domenicucci, Il cielo di Lucano, 2013, pp. 110.
60. Totus scientia plenus. Percorsi dell’esegesi virgiliana antica, a cura diFabio Stok, 2013, pp. 454.
TESTI E STUD.CULT.CLAS. _000_pag.edit. 06/11/13 09.50 Pagina 4