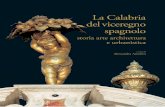Segni di famiglie spagnole in Calabria
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Segni di famiglie spagnole in Calabria
19,00
a cura di Donatella Gagliardi
Rubbettino
La cu
ltur
a ispanic
a nella C
alabria
del C
inq
ue-Seic
ento
Rubbettino
Si raccolgono in questa miscellanea i contributi che sedici specialisti di vari settori scientifico-disciplinari (storico, filologico-letterario, storico-artistico e architettonico) hanno presentato al convegno internazionale svoltosi presso l’Università della Calabria nella primavera del 2012, nell’ambito di un più ampio progetto di ricerca. Le strategie di gestione del potere (sia secolare che religioso) attuate dalla corte di Madrid nei territori calabresi; il rapporto controverso che nobiltà, funzionari, intellettuali e clero locali stabilirono sul piano politico e culturale con il governo centrale; l’influenza ispanica nella produzione filosofica, letteraria e artistica della Calabria cinque-seicentesca sono alcuni dei temi trattati in queste pagine, che ci restituiscono un’immagine della periferia calabrese dell’impero spagnolo ricca di nuove sfumature e di suggestioni finora inesplorate.
Donatella GaGliarDi insegna letteratura spagnola presso l’Università della Calabria. Tra le sue principali linee di ricerca si annoverano la trattatistica rinascimentale sull’educazione femminile, i romanzi cavallereschi, e la censura letteraria nel Siglo de Oro. Oltre a vari articoli e capitoli di libri, ha pubblicato una monografia su Beatriz Bernal, autrice del Cristalián de España (Zaragoza, 2010), e l’edizione bilingue della terza giornata del Ragionamento di Aretino (Roma, 2011). Sta ultimando l’edizione di una versione castigliana della Pietra del paragone politico, opera postuma di Traiano Boccalini.
In copertina: Palazzo Arnone (Cosenza), stemmi della volta dell’androne
La CuLtura iSpaniCa neLLa CaLabria DeL Cinque-SeiCento
Letteratura, Storia, arte
Do
natella G
agliar
di (a cura di)
Rubbettino
La cultura ispanicanella Calabria
del Cinque-SeicentoLetteratura, Storia, Arte
Rubbettino
a cura di
Donatella Gagliardi
Rubbettino
Marilisa Morrone NaymoDeputazione di Storia Patria per la Calabria
Segni di famiglie spagnole in Calabria
Premessa
Tra le testimonianze più significative e durature della cultura ispanicain Calabria, senza dubbio si possono annoverare quelle araldiche, segno di-retto della presenza e dell’attività nel territorio di un personaggio o di unafamiglia. Lo stemma, infatti, secondo le definizioni dei teorici della discipli-na araldica, è l’estensione grafica del nome, il «codice fiscale a colori» delsuo titolare, in ogni caso è un forte e preciso segno identificativo che, gra-zie al linguaggio grafico, riesce a fornire corrette informazioni cronologichee prosopografiche simili a quelle ricavabili da un’iscrizione. L’Araldica è unadisciplina che ha molte affinità con la Storia dell’Arte: entrambe si fondanosull’analisi formale dei manufatti e sui significati simbolici delle figure checontengono. Rileva a questo proposito il Savorelli:
situata al crocicchio tra semiotica, storia, storia dell’arte, filologia, linguistica,sociologia, essa si occupa oggi di psicologia storica, di mitologia, di evoluzione delgusto, e sfiora, nell’ambito iconologico, il campo della «metaforologia politica», lostudio cioè dei rapporti tra immagini simboliche e potere. Dalla filologia e dall’ar-cheologia, insomma, ad un approccio più latamente antropologico, connesso ad unventaglio esteso di scienze umane. Da questo mutamento ha tratto vantaggio lostesso ruolo, non più esclusivo, dell’araldica come «scienza ausiliaria» della storia,che oggi si esercita, con un respiro più ampio, attraverso l’utilizzazione di una me-todologia ispirata a presupposti comparativi: lo studioso dei simboli offre materia-
1 SAVORELLI, 1999, p. 9.2 Per l’utilizzo dell’araldica in archeologia e storia dell’arte si veda MORRONE, 2012, pp.
21-22.3 PASTOREAU, 1993, p. 247; SAVORELLI, 1999, p. 21.4 Se ne presentano qui alcuni fra gli esemplari più significativi.
Rubbettino
li (e contemporaneamente ne riceve) alla storia dell’arte e della letteratura, alla sto-ria sociale, del costume e del mito1.
Uno stemma è una fonte diretta e parlante, e molto spesso datante, per-ciò prenderlo in considerazione risulta una necessità nell’analisi di un ma-nufatto artistico o architettonico, in taluni casi l’unica possibilità di giunge-re ad una conclusione certa. È anche un’opera d’arte carica di informazionisimboliche e non, come tutti i manufatti. Per questo motivo studiare unostemma, oltre che a valutarne l’aspetto e il significato, «serve» anche allescienze storiche per così dire «maggiori» in quanto consente di arrivare aconclusioni e chiarimenti su: la famiglia o il personaggio che lo fece realiz-zare, l’epoca in cui fu realizzato, l’area di realizzazione, le circostanze per cuivenne realizzato, il rapporto con il monumento che lo ospita.
Lo stemma, dunque, è un importante elemento di datazione e di defini-zione delle questioni connesse ad un qualsiasi manufatto artistico, architet-tonico o documentale su cui esso è presente2. Secondo una definizione or-mai invalsa in ambito scientifico, a partire dal Pastoreau, e ripresa da Savo-relli «gli stemmi costituiscono una specie di “stato civile” di un’opera d’arte:offrono infatti preziose informazioni sia sulla cronologia dell’esecuzione,sia sull’identità, le intenzioni e l’ideologia della committenza»3.
* * *La presenza di personaggi e famiglie spagnole in Calabria tra ’500 e ’600,
dunque, è ampia e documentata anche da manufatti araldici4, retaggio so-prattutto delle numerose intestazioni feudali di cui furono destinatarie illu-stri dinastie provenienti dal mondo iberico5. Già in età aragonese, un’ampiaschiera di personaggi ispanici approdò in Calabria per ricoprire cariche pre-stigiose: oltre ai feudatari, castellani, capitani a guerra, vicari regi, condot-tieri, vescovi, mercanti, provenienti dalla penisola iberica, si insediano unpo’ ovunque nella regione, dando vita a rami ormai italiani dei loro casati6.
Del XV secolo rimangono alcuni stemmi su sculture o architetture re-lativi ai regnanti, ad esempio sui castelli di Castrovillari o Belvedere Marit-timo, e a personaggi legati alla corte aragonese, come i de Ayerbe d’Arago-na, o i Siscar, venuti con Francesco, nato a Valenza nel 1400 morto ad Aiel-lo nel 1480 e ivi sepolto7. Castellano di Cosenza dal 1461 si distinse per va-
5 Basta scorrere le successioni feudali per rendersene conto: si veda sull’argomento PEL-LICANO CASTAGNA, 1984-2002.
6 È molto vasta la bibliografia sull’argomento, si rimanda per un inquadramento gene-rale del fenomeno a GALASSO 1992, in particolare pp. 764 e 832; inoltre le opere di materianobiliare DI CROLLALANZA,1981; MAZZELLA, 1601, PALAZZOLO DRAGO, 1927; LOBSTEIN, 1973-1977; ID., 2007.
7 PELLICANO CASTAGNA, 1984-2002, vol. I, pp. 23-24.
272 Marilisa Morrone Naymo
Rubbettino
ri eventi bellici e per la fedeltà alla Corona, tanto da avere come riconosci-mento la contea di Aiello nel 14638. Il suo successore Paolo fu anche Capi-tano Generale e Vicario delle Calabrie dal 1480 e oppose una strenua dife-sa durante l’occupazione francese del Regno9. Ad Aiello, capoluogo dellostato feudale dei Siscar, nell’architrave litico del portale di S. Maria Maggio-re si conserva ancora lo stemma a testa di cavallo con l’inquartato Siscar/Ventimiglia (la moglie di Francesco, madre di Paolo, fu Emilia Ventimi-glia)10.
Il capostipite dei segni ispanici in Calabria tra ’500 e ’600 può conside-rarsi il pregevole stemma regio erratico conservato a Seminara11 (fig. 47),databile con precisione dai quarti di cui è composto. Si tratta di un manu-fatto realizzato con apprezzabile perizia della tecnica araldica, in cui il com-plesso inquartato viene reso con qualche difficoltà nel rispetto delle propor-zioni, ma con particolare calligrafia. Lo stemma presenta nel 1° e nel 4° con-troinquartato in a) e d) di Castiglia; in b) e c) di León; nel 2° e 3° partito d’A-ragona-Sicilia; di Angiò-Napoli, di Gerusalemme; II) d’Angiò; in c) d’Un-gheria antica; innestato in punta fra il 3° e il 4° granquarto di Granada12 el2° e 3° il partito è asimmetrico, con la partizione Aragona-Sicilia più eviden-te: sembra quasi un Aragona-Sicilia sinistrato Angiò-Napoli. Tale particola-re è una conferma della complessità realizzativa di questi stemmi, e dellaconseguente facilità di incorrere in errori (anche involontari) di interpreta-zione o di esecuzione. Negli angoli della lastra in cui è scolpito lo stemma abassorilievo, si collocano le due imprese dei Re cattolici: il fascio di frecce,impresa di Isabella, «las flechas o saetas son también las palabras divinas conlas que herir a los malvados»13, perciò alludente alla vittoria sui Mori, e il gio-go, impresa di Ferdinando «representación del poder de mando y coerción»14,adottata durante la guerra di successione contro la principessa Juana. La
273Segni di famiglie spagnole in Calabria
8 Ibidem.9 Ibidem; PONTIERI (a cura di), 1961, p. XI.10 CAGLIOTI-HYERACE, 2009, p. 363.11 DE MARCO, 2010, p. 28, fig. 4.12 Il blasone completo è il seguente: inquartato: nel 1º e 4º contrinquartato: in a) e d) di
rosso, al castello d’oro, aperto e finestrato d’azzurro (Castiglia); in b) e c) d’argento, al leone diporpora (León); nel 2° e 3° partito: in I) decussato d’oro a 4 pali di rosso Aragona); in II, di [ar-gento] (Aragona); all’aquila al volo abbassato di [nero], sormontata da una corona [dello stes-so], la destra rivolta (Svevia) (il tutto Aragona-Sicilia); in II) interzato in palo in A) nel I d’ar-gento, alla croce potenziata accantonata da quattro crocette, il tutto d’oro (Gerusalemme,); II)in B) d’azzurro, seminato di gigli d’oro, al lambello di rosso (d’Angiò) (il tutto Angiò-Napoli);inC) fasciato di otto pezzi di rosso e d’argento (Ungheria antica). innestato in punta fra il 3° e il4° d’argento, alla mela granata aperta, ramifera e fogliata al naturale (granquarto di Grana-da). Ringrazio M.C.A. Gorra per i preziosi suggerimenti nella formulazione di questo com-plesso blasone.
13 Sulle imprese di Isabella di Castiglia si veda ORTEGA LAMADRID, 1951.14 Ibidem.
Rubbettino
presenza del quarto di Napoli e Sicilia e l’assenza dell’arma di Navarra, po-ne esattamente lo stemma a cavallo tra il 1504, anno dell’incoronazione co-me Ferdinando III di Napoli e II di Sicilia, e la conquista della Navarra, av-venuta tra il 1513 e il 151515.
La presenza a Seminara dello stemma reale dei sovrani cattolici è damettere in relazione agli eventi bellici che si svolsero sotto le sue mura nel1503, con la ricacciata dei Francesi ad opera del Gran Capitano GonzaloFernández de Córdoba (la cosiddetta seconda battaglia di Seminara, la pri-ma fu nel 1496)16: è probabile che il Re abbia voluto ricordare con un mo-numento o un’iscrizione (oggi perduti) quell’episodio che conservò alla Co-rona d’Aragona i territori italiani.
Lo stemma reale dei Cattolici si pone come un classico stemma ibericoinquartato; i quarti sono rappresentati dalle armi dei vari regni accorpatidall’unione matrimoniale di Isabella di Castiglia e León e di Ferdinandod’Aragona, e di quelli conquistati o ereditati dopo l’unione tra i due sovra-ni. L’uso di inquartare gli stemmi risale proprio alle Spagne e rimase comesegno caratteristico dell’araldica ispanica17 passato poi agli altri paesi euro-pei, soprattutto all’Italia che ne recepì la cultura araldica in maniera parti-colarmente accentuata.
Il primo inquartato usato sistematicamente in araldica fu infatti quellotra le armi di Castiglia e quelle di León, già in uso agli albori del XIII sec. Isovrani di questi due regni già in età prearaldica (l’araldica intesa come ere-ditarietà dello stemma identificativo nasce nel XII secolo) usavano come si-gilli le armi parlanti del castello e del leone. Fu Ferdinando III sovrano deidue regni dal 1217 al 1230, che riunì le due armi in una18. In un disegno delcronista e miniatore inglese Matteo di Parigi (fig. 48), tratto dall’operaChronica maiora, realizzata dal frate-cronista nell’abbazia di Saint Albansdal 1235 al 125919, ci è stato tramandato questo primo inquartato, ancorasemplice, ma significativo. È la prima testimonianza di questa particolareforma di araldica che divenne frequente non solo tra i sovrani20: con questoespediente si rendevano immediatamente leggibili i possessi della coronaattraverso il loro stemma. L’uso di inquartare le armi, come già accennato,fu frequentissimo in Spagna, anche per il tradizionale uso ispanico di per-petuare l’agnizione femminile nel cognome.
15 BELENGUER, 2001, p. 364.16 Ivi, p. 261.17 Sull’argomento si vedano: SALAZAR, 1642; AGUSTÍN, 1734.18 NEUBECKER, 1980, p. 55.19 Il disegno è riprodotto ibidem.20 L’uso si diffuse anche tra le famiglie nobili che indicavano così le ascendenze genea-
logiche femminili.
274 Marilisa Morrone Naymo
Rubbettino
Inquartare le armi non è la sola caratteristica dell’araldica ispanica; al-tro segno distintivo di essa, in particolare di quella castigliana, è l’uso fre-quente della bordura21, ovvero una sorta di cornice che corre lungo i bor-di dello scudo e ne occupa circa un terzo della superficie (fig. 49); può es-sere semplice oppure caricata di figure allusive a fatti notevoli della Recon-quista, divenute tipiche dell’araldica ispanica e usate anche come figureprincipali. In Spagna acquista tale significato, ma è anche legata a specialiconcessioni reali, i cui simboli trovano posto nella bordura unitamente al-le armi principali; o a matrimonio, per cui le armi della sposa vanno a ca-ricare le bordure e lo stemma dello sposo occupa il campo principale22. Inaltri paesi europei, come l’Inghilterra e la Francia, essa invece acquista ca-rattere di brisura (ossia segno distintivo) di rami cadetti o addirittura ba-stardi della famiglia23. Nel Regno napolitano la bordura compare in rari ca-si già nel corso del XIV secolo24, ma diventò usuale dal periodo aragonesein poi, nelle armi delle famiglie di origine ispanica; dall’analisi dei manu-fatti si può concludere che l’uso della bordura continua ad avere lo stessosignificato della madrepatria. Ne vedremo alcuni esempi anche negli stem-mi ispano-calabresi.
La bordura più classica spagnola è la cosiddetta bordura aspada españo-la, caricata da croci di Sant’Andrea; l’uso di questa bordura secondo la leg-genda risale alla battaglia di Baeza contro i Saraceni, svoltasi nel giorno disant’Andrea del 1227; i guerrieri partecipanti alla battaglia, in ricordo dellavittoria, secondo la tradizione, ornarono i bordi dei loro scudi con le crocidel santo25. Le famiglie dei discendenti di quei cavalieri perpetuarono l’usodi questa figura: uno studio statistico sulle bordure spagnole ha, ovviamen-te, dimostrato che l’uso della bordura aspada trascende di gran lunga le li-nee genealogiche di quei cavalieri di Baeza, estendendosi a circa un terzodegli stemmi spagnoli con bordura26.
Altri tipi di bordura sono: la bordura caricata da scudetti, che riprodu-ce nello scudetto stesso lo stemma di una baronia o altro ramo della fami-glia o stemma femminile, insomma funge da brisura. La bordura flordelisa-da, ovvero quella caricata da gigli. La bordura calderona, che è quella cari-cata da calderas o paioli: l’uso di essa deriva da una concessione dei re di Ca-
275Segni di famiglie spagnole in Calabria
21 Per un compendio sull’uso della bordura nell’araldica spagnola si veda la completatrattazione, con studi statistici sulla sua diffusione, in VALERO DE BERNABÉ, 2007, pp. 28-49.
22 Si veda al proposito SALAZAR, 1642.23 FOX DAVIES, 1996, p. 138; NEUBECKER, 1980, pp. 98-101.24 Si vedano gli splendidi esempi degli stemmi dei Sanseverino di Mileto sui sarcofagi
provenienti dalla distrutta cattedrale normanna, oggi nel Museo Nazionale di Mileto; cfr.GORRA, 2010, p. 10.
25 VIGNOLO, 1899, p. 187; SCORDO, 1991-1992, p. 48.26 VALERO DE BERNABÉ, 2007, p. 32.
Rubbettino
stiglia ai ricos hombres27 che radunavano e mantenevano armati in serviziodella corona. Le calderas simboleggiavano l’uso antico di conservare le mo-nete nelle pentole che il signore usava per mantenere gli armati senza gra-vare sui sudditi del feudo. Oltre alle calderas era invalso l’uso del pendón opennone, una sorta di vessillo che il signore spiegava in guerra per segnala-re il privilegio di portare armati. Le famiglie della più alta nobiltà castiglia-na, ossia los ricos hombres, furono appellati con l’ambito riconoscimento dinobili di pendón y caldera28.
Altre bordure sono la bordura jacobea, caricata da conchiglie di S. Gia-como, la bordura castillada, caricata da castelli, la bordura escacada, com-posta da scacchi; la bordura caricata da cruz floreada, ovvero da croci si-mili a quelle dell’Ordine di Calatrava ma di smalti diversi, legata al ricor-do della battaglia di Úbeda combattuta dal re di Navarra contro i Mori nel121229. La cruz floreada30 viene usata come figura principale dello stemma,per concessione regia a molti discendenti dei cavalieri partecipanti a quel-la battaglia. Altra figura tipica dell’araldica ispanica, che ritroviamo inmolti esempi calabresi, sono las panelas cioè foglie cuoriformi disposte acinque o a quindici31, e los roeles, dischi simili a monete, che secondo la tra-dizione deriverebbero da biscotti, los chochos, distribuiti da un re ai solda-ti per simboleggiare la strage di Mori; tali figure in Italiano sono dette bi-santi o torte32. Ultima figura tipica dell’araldica ispanica, attestata anche inCalabria nell’arma della famiglia Moxica o Mojica di Pizzo33, è la banda dedragantes ossia una banda che parte dalle fauci spalancate di due teste feri-ne situate agli angoli dello scudo, detta anche banda engollada. Anche que-sta figura si lega alla leggenda di una battaglia contro i Mori combattuta daCastigliani e Portoghesi a Salado nel 1340, benché risulti già usata daAlfonso XI nel 133234. Tra i cavalieri ricordati in questa battaglia si anno-vera anche un Moijca. Tale figura fu usata come impresa dai reali di Casti-glia e poi da Ferdinando il Cattolico e da Carlo V, aggiunta alle personali(fig. 50).
L’araldica ispanica tende (già con Carlo V, ma in specie dal XVII-XVIII)a comporre stemmi con figure naturalistiche e complesse, quasi «quadretti
27 Per ricos hombres si intendevano gli appartenenti alla più alta nobiltà di sangue e pos-sedimenti: cfr. VIGNOLO, 1899, p. 187.
28 Ibidem.29 Ibidem.30 È la figura che campeggia nello stemma di una nota famiglia ispano-calabrese, cioè
gli Alarcón.31 O’KELLY DE GALWAY, 1901, p. 373; PASTOREAU, 1996, p. 159.32 VIGNOLO, 1899, p. 188. VALERO DE BERNABÉ, 2007, pp. 112-114.33 LOBSTEIN, 2007, pp. 40-41.34 VIGNOLO, 1899, p. 187.
276 Marilisa Morrone Naymo
Rubbettino
pittorici», come vedremo anche in uno stemma di Squillace con un quartoAlcántara. L’uso degli stemmi figurativi è prerogativa soprattutto dell’aral-dica dei conquistadores: gli stemmi concessi da Carlo V nel nuovo mondodiventano incredibili quadretti di fantasia35.
Tornando alla Calabria e ai suoi stemmi ispanici, uno dei più antichi delsecolo XVI è senz’altro quello scoperto sul bastione a mandorla del Castel-lo di Palizzi, che ha permesso a Francesca Martorano di datare con preci-sione la realizzazione di questo particolare tipo di fortificazione ascenden-te a Francesco di Giorgio Martini36. Lo stemma (fig. 51) è un inquartato, nel1° e nel 4° dei Ruffo (troncato cuneato d’argento e di nero) nel 2° e nel 3° de-gli Aragona e degli Ayerbe (d’oro a 4 pali di rosso e croce caricata da 5 scu-detti d’argento alla fascia d’azzurro). Lo stemma è ascrivibile alla coppia Gi-rolama Ruffo, diventata baronessa di Palizzi nel 1516 alla morte del padre,e Alfonso de Ayerbe d’Aragona, conte di Simeri, che già nel 1504 aveva avu-to assegnata dal re la baronia di Palizzi per la ribellione del suocero Anto-nello Ruffo, poi restituita e riavuta come dote della moglie37. L’arma dei deAyerbe d’Aragona in questa forma con la croce caricata degli scudetti, si ri-trova riprodotta in un disegno di un armoriale spagnolo38 (fig. 52), ma neitesti iberici viene riferita soltanto al ramo dei Videura d’Ayerbe. In Calabria,altri esemplari, sempre del ramo dei conti di Simeri, presentano la variantesostanziale della bordura caricata da scudetti, mentre sparisce la croce e re-stano solo i pali aragonesi.
Altri stemmi regi sono presenti in Calabria: sempre a Seminara trovia-mo un bell’esemplare dipinto su una fontana e ritrovato di recente dopoun’operazione di diserbo. Anche se lacunoso, è facile scorgervi i quarti ag-giunti allo stemma dei re Cattolici dal nipote Carlo V, ad esempio lo scudet-to in cuore, partito di Tirolo e Fiandra. La presenza di Carlo V a Seminaraè testimoniata dal noto episodio del 1535 quando l’imperatore sbarcò in Ca-labria dopo l’impresa di Tunisi39.
Un altro notevole esemplare di stemma imperiale si conserva a Croto-ne sul bastione Toledo (fig. 53). Lo stemma fu posto a ricordo della costru-zione della fortezza e della ristrutturazione del castello, voluta dall’impera-tore ed eseguita a partire dal 1541 da don Pedro de Toledo vicerè di Napoli
277Segni di famiglie spagnole in Calabria
35 Una splendida miniatura riassume la mirabolante araldica della nobiltà ispanica delnuovo continente: cfr. Las águilas heráldicas del Códice Techialoyan García Granados. Sul-l’argomento: Aa.Vv., 1892; USECHE, 2012.
36 MARTORANO, 2002, p. 375, n. 97.37 Per le vicende della successione Ruffo - de Ayerbe d’Aragona a Palizzi si veda PELLI-
CANO CASTAGNA, 1984-2002, vol. IV, pp. 6-7.38 PIFERRER, 1855, vol. I, tav. 14.39 L’episodio è rappresentato anche sulla base del monumento a Carlo Spinelli conte di
Seminara; cfr. DE MARCO 2010, pp. 274-277, figg. 274-277.
Rubbettino
dal 1532 al 155340. Il bassorilievo è datato al 1546 per la scoperta dell’atto diappalto agli scalpellini Bartolomeo Della Scala (chiamato fiorentino nell’at-to)41 e Carlo Mannarino di Catanzaro, stipulato nell’aprile del suddetto1546, in cui si dichiara anche che a novembre dello stesso anno la sculturaera stata realizzata ma non fu subito messa in opera a causa delle cattive con-dizioni del baluardo42. Il costo del lavoro dei due scalpellini viene stabilitoin ducati 75 da pagarsi in tre rate uguali: ducati 25 anticipati alla stipula delcontratto, altri ducati 25 ad opera finita ed i rimanenti alla sistemazione de-finitiva della scultura nel baluardo don Pedro. L’atto risulta molto interes-sante per capire l’iter della committenza di uno stemma agli esecutori; ilcommittente in questo caso è il commissario generale della Regia Fabrica diCrotone, il capitano Gaspar de Mardones, che affida il lavoro ai suddettiscalpellini. Si specifica che gli stemmi di Sua Maestà e di sua Exelentia deb-bano essere di tali dimensioni: «li arme de sua Maesta de essere hoc modolo scuto de mezo alto pl. [palmi] 8, largo pl. 6/ lo scuto de sua Ex.tia alto pl.6 largo pl. 4 per quatro/ lo pittafio longo pl. 14 largo pl. 4, lo adornamentode intorno le arme pl. 2 incirca largo/ longo pl. 10½».
Si stabilisce con esattezza la pietra di cui dovranno essere realizzati, cioèla pietra delle cave di Mesoraca, per la quale viene anche fatto un accordocon i mastri Joseph Molinaro e Paolo Molinaro di Mesoraca ed il perratoreAntonio Grastello; questi cominciano a cavare e preparare la pietra per lascultura ed ai primi di luglio le prime 25 canne di materiale per «le arme deSua Maestà et de sua Ex.tia» sono trasportate con i carri trascinati dai buoida Mesoraca a Crotone. Dopo questo primo invio, verso la fine di luglio Ja-copo de Amato, capomastro della regia fabrica, che dirige i lavori di fortifi-cazione di Crotone come sostituto del barone dell’Acaya, affitta una muladal crotonese Marco Malerba e va ad ispezionare la pietra ed i cantoni chesi stanno tagliando a Mesoraca. Da quanto affermato nell’atto, il progettodella scultura era dunque degli stessi architetti della fortezza, che dovevanoinserire il complesso bassorilievo nella mole del baluardo scegliendo anchei materiali che si adattassero al contesto. Non ci sono tuttavia nell’atto indi-cazioni circa il contenuto degli scudi che, verosimilmente, era descritto inun preciso blasone fornito agli scalpellini; non abbiamo testimonianze cir-ca l’utilizzo, per questa o altre opere araldiche, di cartoni o disegni, perciòè sempre più probabile pensare ad una certa libertà compositiva degli arte-
40 MUSSARI, 2002, pp. 422-423.41 ASN, Dipendenze della Sommaria, Fasc. 197, Libro L, f. 114; Il Della Scala fu autore in
quegli stessi anni degli stemmi dell’imperatore e di don Pedro de Toledo sul Palazzo Regio diCosenza, noto come Palazzo Arnone, perciò è stato possibile identificarlo con il Bartolomeo fio-rentino dell’atto di Crotone: sull’argomento si veda MUSSARI, 2002, p. 452, n. 193, fig. 63.
42 Si veda PESAVENTO, 1997, p. 10. ASN, Dipendenze della Sommaria, Fasc. 197, Cedo-le di pagamento 248, 255, 259, 261, 264, 271, 277.
278 Marilisa Morrone Naymo
Rubbettino
fici che, pur nel rispetto delle figure contenute nello stemma del commit-tente, potevano anche incorrere, come spesso si può constatare, in sviste ofraintendimenti. Ciò, ovviamente, era più raro in una committenza comequesta, che riguardava le insegne regali, ma non è del tutto infrequentequando si tratta di stemmi familiari, in particolare realizzati lontano dallezone di residenza della stessa famiglia.
Un’altra considerazione da fare è la specializzazione raggiunta ormaidagli scalpellini locali, qui in collaborazione con un mastro toscano, anchein queste opere complesse che comunque richiedevano buone conoscenzedi tecnica araldica nel rispetto delle proporzioni delle figure e anche deicomplicati quarti di cui era composto lo stemma reale. Il bassorilievo pre-senta in una pregevole composizione lo stemma imperiale sovrapposto aquello del viceré43, con ornamenti accessori (l’adornamento intorno). Lo sta-to di conservazione della scultura è precario, tuttavia lo stemma imperialesembra essere affiancato dall’impresa delle colonne d’Ercole.
Ancora sul bastione di un castello, quello di Gerace, si trova un altrostemma (fig. 54), prezioso ai fini della datazione della struttura. È situa-to precisamente sul Bastione Sud, che fiancheggia l’ingresso alla fortezzaed è facilmente visibile dal Baglio. È inserito entro un vano rettangolarein pietra lavica, incorniciato da conci calcarei. Lo scudo è appuntato, colcapo fiorito, modellato in marmo bianco a bassorilievo44. L’insieme è par-zialmente rovinato, soprattutto nel timbro, ma ancora ben godibile nel-l’accuratezza della manifattura. Lo stemma, in base ai quarti femminili, èattribuito a Gonzalo Fernández de Córdoba il giovane, nato nel 1520, 3°duca di Terranova e di Sessa, signore di Gerace e governatore dello Statodi Milano, morto a Madrid nel 1578. Erede della madre Elvira de Córdo-
279Segni di famiglie spagnole in Calabria
43 L’arma di Pedro de Toledo innalza uno scaccato partito di due e spaccato di quattro li-nee a sette scacchi d’argento e otto d’azzurro.
44 Blasone: inquartato: nel 1° di [rosso], a due caldaie sovrapposte di [oro], (ognuna colmanico formato da due serpi affrontate di [verde]?), alla bordura di [rosso], caricata da diecicaldaie simili (Herrera); addestrato di [oro], a tre fasce di [rosso] (Cordova); nel 2° di [rosso],a due caldaie sovrapposte [scaccate d’oro e di nero], (ognuna con due gruppi di tre serpi di [ver-de] uscenti a ventaglio dai manici?); alla bordura composta di quattordici pezzi di León e diCastiglia (Manrique de Lara); nel 3° di León, cappato abbassato ricurvo di Castiglia (Henrí-quez); addestrato di […], alla bordura caricata da dodici bisanti di […] (Sarmiento?); nel 4°partito: in a) decussato: in I) di [verde], alla banda di [rosso], bordata di [oro]; in II) di [argen-to], alla legenda AVE MARIA di [nero], scritta in palo lungo il fianco dello scudo; in III) di [ar-gento], alla legenda GRATIA PLENA di [nero], scritta similmente; in IV) di[verde], alla sbar-ra di [rosso], bordata di [oro] (Mendoza); in b) di [oro], a cinque foglie di fico di [verde], postein decusse (Figueroa). Timbro: una corona gemmata, forse originariamente a cinque fioroni.Per questo stemma si vedano MARTORANO, 2002, p. 370, n. 89, in cui Roberto Fuda per la pri-ma volta redige un blasone completo con identificazione dei quarti di questo complessostemma; OLIVA 2005, p. 42, n. 57 e GORRA-MORRONE 2008, pp. 38-39.
Rubbettino
ba (figlia del Gran Capitano investito di Gerace nel 1502, morto nel 1515)e figlio di Luis de Córdoba conte di Cabra, lontano parente che soprav-visse alla moglie (morta nel 1524) governando in nome del figlio mino-renne45.
Lo stemma del duca di Sessa è un concentrato di araldica ispanica co-me delineata nel corso di questo lavoro: oltre alla complessità dell’inquar-tato, che è già da sé un segno distintivo ispanico, si ritrovano distribuite neiquarti relativi ad alcune tra le famiglie della più alta aristocrazia iberica lefigure e gli usi araldici caratteristici di quel paese: calderas, roeles, castello,bordure caricate.
Un ulteriore stemma de Ayerbe d’Aragona si ritrova nella collezione LupisCrisafi a Grotteria, centro detenuto dai conti di Simeri dal 1576 al 163246. Sitratta di un tipico scudo (fig. 55) databile al terzo quarto del XVI secolo47 e pro-veniente forse dalla Cappella di S. Maria di Loreto nella chiesa dei Domenica-ni di Grotteria, fondata dal conte di Simeri come cappella funeraria, subito do-po il suo insediamento nel centro48. È anche questo uno stemma complesso eparticolare: nella partizione principale lo scudo inquarta le armi dei de Ayer-be d’Aragona con quelle dei de Guevara semplificato, perciò è attribuibile adAlfonso de Ayerbe d’Aragona 3° conte di Simeri, e alla moglie Diana de Gue-vara, primi feudatari di questa famiglia, ad insediarsi nella contea di Grotteria.Nel quarto inferiore presenta lo stemma semplificato dei Domenicani, costi-tuendo un’anomalia araldica: è molto raro uno stemma partito d’alleanza ma-trimoniale inquartato con lo stemma di un ordine religioso.
L’arma de Ayerbe d’Aragona qui proposta offre spunti di riflessione circale varianti araldiche: il personaggio titolare dello stemma è nipote ex filio delconte di Simeri titolare dell’inquartato nel castello di Palizzi, trattato in pre-cedenza. È sparita la pezza della croce caricata da scudetti, mentre comparela bordura caricata da scudetti, che poi diventerà la variante ufficiale dellostemma de Ayerbe d’Aragona calabrese. Tale caso sicuramente è l’attestazio-ne di come la bordura non sempre rappresenti bastardia o brisura, bensì pos-sa anche affermarsi con l’uso consolidato nel tempo, per scelta del titolare.
45 PELLICANO CASTAGNA, 1984-2002, vol. II, pp. 306-307.46 Ivi, pp. 335-337.47 Scudo ovale in cartiglio con evidenti arricciature. Dietro lo scudo due guiggie raccol-
te in alto ad occhiello e dalle estremità a nastro svolazzanti. Blasone. Troncato: nel 1°, parti-to: in a) d’(oro) a tre pali di (rosso); alla bordura d’(azzurro) caricata da nove scudettid’(argento), alla fascia d’(azzurro) (de Ayerbe d’Aragona). In b), d’(oro), alla banda d’(argento),caricata di tre moscature d’armellino di nero (de Guevara); nel 2°, d’argento, al cane pezzato,coricato, bailonato d’una fiaccola accesa, il tutto al naturale, sormontato da un ramo di palmae da un giglio di giardino dello stesso, decussati e inframmezzati in capo da una stella di sei rag-gi d’oro (ordine dei Predicatori [Domenicani]).
48 Per questo stemma si veda la scheda n° 1 in MORRONE-PAPASIDERO, 2012, p. 513, do-ve si attribuisce lo stemma al monumento del 1579 nella Cappella di Loreto.
280 Marilisa Morrone Naymo
Rubbettino
Non è propriamente una famiglia spagnola la titolare del celebre stem-ma situato sul castello di Vibo Valentia49, ma è evidente l’intenzione delcommittente di attenersi all’uso ispanico dell’inquartato ormai consolida-tosi pure in Calabria; in esso compare anche l’arma di una celebre famigliaispanica trapiantata nel Regno, i Mendoza. Lo stemma è assegnabile a Etto-re III Pignatelli, 1574/1622, figlio di Girolama Colonna di Paliano e sposodi Caterina Caracciolo, a sua volta figlia di Carlo e di Anna Mendoza di Val-le Siciliana50. In base a ciò, si può riassumere il blasone come un inquartatoPignatelli, Caracciolo Pisquizi, Colonna e Mendoza, e aggiungere che lostemma risale a non oltre la scomparsa di Ettore III.
Tra le famiglie feudali calabresi sicuramente più prestigiose si annove-rano i Borgia, discendenti dal figlio di papa Alessandro VI, Goffredo, cheebbe il feudo di Squillace come dote dalla moglie Sancia d’Aragona diSquillace nel 149451. Nel principato di Squillace si ritrovano due pregevoliesemplari araldici dei Borgia: uno è sul portale del castello di Squillace (fig.56), l’altro sul portale del palazzo (oggi Marincola) situato sul promonto-rio di Stalettì-Copanello (fig. 57)52. Ambedue le sculture sono di ottima fat-tura e rappresentano il classico stemma partito Borgia-Oms53; in entram-be, nel quarto Borgia non è rappresentata la bordura54. I due stemmi, da-tabili agli inizi del XVII sec., sono attribuiti a scultori forestieri operanti inCalabria in quegli anni e non a scalpellini locali. La scomparsa della bor-dura forse è da riportare ad una scelta dell’artista, ma è probabile che la fa-miglia avesse la volontà di italianizzare l’arma ad un secolo dal suo insedia-mento nel feudo.
A Squillace si conserva anche un bell’esemplare di stemma tutto spa-gnolo, databile al XVII secolo55. Si tratta di uno scudo inquartato (fig. 58),con uno scudetto sul tutto attribuibile ai Figueroa; gli altri quarti possono
281Segni di famiglie spagnole in Calabria
49 Blasone: inquartato: nel 1° di (oro), a tre pignatte di (nero), le superiori affrontate; nel 2° di(oro), al leone di (azzurro); nel 3° di (rosso), alla colonna di (argento), coronata di (oro); nel 4° de-cussato: in a) di (verde), al palo di (rosso), bordato di (oro); in b) di (oro), alla legenda AVE GRA-TIA di (nero) scritta lungo il bordo dello scudo; in c) di (oro), alla legenda PLENA di (nero) scrittalungo il bordo dello scudo; in d) di (verde), alla banda di (rosso), bordata di (oro); scudo ovale incartiglio, convesso, posta sul portale d’ingresso al castello; il cartiglio reca alla sommità una con-chiglia, ed alla base un ceffo di leone alato. Timbro: una corona non più identificabile, ridotta auna porzione del cerchio gemmato. Blasone tratto da GORRA, 2010, p. 73.
50 PELLICANO CASTAGNA, 1984-2002, vol. III, pp. 238-240.51 VALENTE, 1980, vol. I, pp. 12-14.52 Lo stemma è attribuito ad un artista napoletano da PANARELLO, 2010, p. 194, fig. 17.53 Blasone: (d’oro), al bove (di rosso) che si pasce di un covone (di verde) (Borgia)/ fascia-
to (d’oro e di nero) (Oms). Una trattazione completa delle varianti dell’arma Borgia è in BOR-GIA, 1990a.
54 Lo stemma completo dei Borgia ha la bordura caricata da covoni o ciuffi erbosi.55 Per questo stemma e l’esemplare del castello, ringrazio la cortesia di Gerardo Scalzo
di Squillace che me ne ha fornito anche le fotografie.
Rubbettino
attribuirsi agli Alcántara, ai Ramón, forse ai Borgia e ai Córdoba. Questostemma testimonia come ancora nel pieno del XVII secolo le famiglie spa-gnole fossero per così dire endogamiche, nonostante ormai trapiantate inCalabria e aggregate ai seggi locali. Alcune delle famiglie rappresentate inquesto stemma, si ritrovano, infatti, nel seggio di Catanzaro56.
Un frammento di stemma da Reggio, ancora in corso di identificazio-ne, si conserva tra i materiali dell’ex Museo Civico. Si tratta di un frammen-to di uno scudo sagomato in cartiglio, in marmo bianco, databile fra XVI eXVII secolo; l’ottima resa artistica e il corretto rispetto delle regole araldi-che, fa attribuire il pezzo ad un artista di rango. Le componenti ancora visi-bili dell’arma57 suggeriscono che la famiglia titolare sia di agnazione ispani-ca, come appare dimostrato dalla bordura caricata da crocette in decusse,che è tipica, come abbiamo visto, del sistema araldico di quella nazione.
Nella navata sinistra della chiesa Matrice della Cattolica di Castelvetere(oggi Caulonia), nella cappella di Sant’Ignazio, alla base della lunetta, sonocollocati tre scudi ovali in cartiglio (fig. 59), bombati, modellati in stucco atre dimensioni58. Il destro è attribuibile ai Tagliavia d’Aragona-Ventimi-glia59. L’insieme palesa inesattezze nella resa delle figure dell’arma Arago-na-Sicilia, in cui compare un numero inferiore di pali rispetto al canonicostemma aragonese: le aquile sono scomparse e se ne intravedono solo le im-pronte. Gli stemmi sono pertinenti a Giulia Tagliavia d’Aragona, moglie diFabrizio Carafa principe di Roccella e marchese di Castelvetere. Si confer-ma in questo stemma l’uso araldico della famiglia siciliana di eliminare lacomponente dei Tagliavia per conservare solo quella, più prestigiosa, degliAragona-Sicilia.
Sempre a Castelvetere-Caulonia si ritrovano stemmi della principessaGiulia Tagliavia d’Aragona nella lapide, oggi fuori contesto, che doveva co-prire le spoglie mortali del principe Fabrizio e forse anche della moglie (fig.60)60. All’angolo superiore sinistro della cornice della lapide, ed in quello in-
56 D’AMATO, 1670, pp. 263-269.57 Blasone: (inquartato): nel 1° contrinquartato da un filetto in croce: in a) e d) un giglio;
in b) una stella di otto raggi; in c) (?), alla bordura attraversante caricata da (otto) crocette indecusse; nel 2° (cinque) fasce ondate; (nel 3° [?]; nel 4°[?]).
58 Su questi stemmi di recente si è soffermato PANARELLO, 2012, pp. 481-482, fig. 6, cheli attribuisce ad artista di formazione romana attivo in Campania.
59 Blasone: partito da un palo diminuito di […]: nel 1° decussato da un filetto in croce diSant’Andrea di […]: in a) e d) di […], al palo di […]; in b) e c) di […] pieno (Aragona-Sicilia);nel 2° di [azzurro], alla banda scaccata di due file di [argento] e di [rosso] (Altavilla). Timbro:una corona (gemmata a tre fioroni, alternati a due coppie di perle su punte?). Scudo accol-lato ad un nastro svolazzante. La corona è perduta, ne rimane solo l’impronta. Cfr. GORRA-MORRONE 2008, pp. 54-55.
60 L’identificazione con Fabrizio Carafa è dettata dalla presenza della Collana del Tosond’Oro.
282 Marilisa Morrone Naymo
Rubbettino
feriore destro, si trovano due scudetti con stemma Aragona-Sicilia61, che sialternano ad altrettanti scudetti con l’arma Carafa. La cornice inquadra unosplendido esemplare di stemma partito Carafa/Aragona- Sicilia accollato alcollare del Toson d’Oro62.
Un altro esempio di stemma ispanico mantenutosi nelle sue forme ori-ginarie è quello dei Ramírez, famiglia nobile castigliana trapiantata a Gera-ce e Reggio. A Gerace si conservano stemmi di alleanza dei Ramírez, ambe-due ascrivibili al XVII secolo. Il primo si trova all’interno della cripta dellacattedrale, sul pianerottolo della scala che sale alla chiesa. Su una lapide inmarmo rosso (forse a suo tempo con iscrizione) è modellato uno scudo ova-le in cartiglio, bombato (fig. 61), la cui partizione principale, ovvero quartomaschile, è attribuibile ai Deodino63, mentre la partizione femminile reca lanota arma dei Ramírez64. Si tratta di uno stemma con figure tipiche dell’a-raldica ispanica: due calderas e la bordura aspada española, cioè la borduracaricata da decusse o croci di Sant’Andrea, che viene sempre conservata ne-gli esemplari noti dello stemma di questa famiglia. L’arma dei Ramírez aGerace si ritrova, sempre nella partizione femminile, in uno stemma parti-to situato su Casa Lacopo (già Bennati), nel quale sono rispettati sia le figu-re che la bordura65. Non è stato ancora possibile attribuire la titolarità delquarto maschile del bassorilievo.
Nell’ambito degli stemmi feudali si segnalano a Pizzo due importantiesemplari del XVII secolo, uno sul portale del castello, l’altro su uno deiplinti del portale della chiesa di S. Giorgio66. Si tratta delle armi dei princi-
283Segni di famiglie spagnole in Calabria
61 Blasone: decussato: nel 1° e 4° di [oro], a tre pali di [rosso]; nel 2° e 3° di [argento], al-l’aquila al volo abbassato di [nero], sormontata da una corona [dello stesso], la destra rivolta.Timbro: una corona gemmata a cinque fioroni, alternati a quattro perle su punte. Scudo ac-collato da un nastro svolazzante.
62 La lapide è stata pubblicata per la prima volta in GORRA-MORRONE, 2008. pp. 58-59,dove si formula l’identificazione degli stemmi e dei personaggi titolari degli stessi.
63 La famiglia Deodino o Teotino, originaria del Salento, venne in Calabria nel XV sec.e si stabilì a Motta Gioiosa, poi si diramò a Roccella e soprattutto a Gerace; cfr. NAYMO, 2004,pp. XXIX-XXXI.
64 Blasone: partito: nel 1° di [azzurro], alla banda (scorciata, dentata inferiormente),[trinciata di rosso e d’argento, caricata da una rosa dello stesso, stelata e fogliata di verde], ac-costata da due (foglie di quercia?), ed accompagnata in capo da un rastrello di [rosso] (Teoti-no); nel 2° di [argento], a due caldaie sovrapposte [al naturale], (ognuna con un serpe uscenteda ambo le basi dei manici), alla bordura di [rosso], caricata da nove decusse di [oro] (Ramí-rez). Cfr. GORRA-MORRONE 2008, p. 15.
65 Blasone: partito: nel 1° una torre ritorricellata, aperta, finestrata di due pezzi, e fonda-ta su di una zolla (?); nel 2° due caldaie sovrapposte, alla bordura caricata da nove crocette.Timbro: un elmo chiuso, posto di profilo. Insieme di rozza fattura, specialmente nella formadell’elmo. GORRA-MORRONE, 2008, p. 42.
66 Questo stemma, parte integrante del portale, è stato di recente attribuito a CosimoFanzago: PANARELLO, 2012, p. 335, fig. 3.
Rubbettino
pi di Mileto Gómez de Sylva67. L’esemplare del castello (fig. 62) è un inquar-tato Gómez de Sandoval - de Sylva - Mendoza - de La Cerda. Il personag-gio titolare dello stemma è identificabile dai quarti che lo compongono, giàconsolidati nella genealogia con Ruy Gómez de Sylva, 3° principe di Mileto(1593). Il complesso intreccio dinastico dei principi di Mileto, dimostra an-cora una volta l’endogamicità delle famiglie della più alta aristocrazia ispa-nica. Diego Hurtado de Mendoza 1° principe di Mileto, lascia erede nel 1579la figlia Anna de Mendoza 2ª principessa di Mileto (amante del segretariodel re Filippo II Antonio Pérez), che sposa nel 1553 Ruy Gómez de Sylva,principe di Eboli e duca di Pastrana, favorito del re di Spagna Filippo II68. Ilfiglio di questa coppia è Ruy Gómez de Sylva y Mendoza, 3° principe di Mi-leto dal 1593 erede di sua madre, morta nel 1592: da questo momento iquarti dello stemma sono già formati. A lui succede Rodrigo II Gómez deMendoza 4° principe di Mileto, erede del padre morto nel 1596. Morì nel1625 molto indebitato. Rodrigo III 5° principe di Mileto dal 1628, morì nel1693. Ritengo che lo stemma si possa attribuire a quest’ultimo. L’esemplaredi S. Giorgio è invece un semplice partito de Sylva/Mendoza sempre attri-buibile a Rodrigo III.
Il quarto Mendoza si riscontra in molti degli stemmi superstiti in Cala-bria, come nel già citato stemma Pignatelli del castello di Vibo Valentia. Lafamiglia, oriunda della Castiglia, discendente dagli antichi signori di Llodio,discendeva a sua volta dai sovrani di Vizcaya [Biscaglia], la terra Basca69. IMendoza, è stato notato, durante il primo cinquantennio della presenzaspagnola a Napoli, su indicazione della Corona stessa, attuarono un proces-so di naturalizzazione napolitana. Oltre ai feudi ricevuti dal sovrano, la fa-miglia era stata aggregata al più importante seggio nobile della capitale, cioèquello di Capuana70. Questo dato concorda con quanto emerge dall’eviden-za araldica della Calabria, dove, come detto, il quarto Mendoza è presentesu molte armi d’alleanza matrimoniale non solo con casate ispaniche ma an-che con casate italiane, confermando la politica di naturalizzazione napoli-tana della famiglia riscontrata in altri ambiti. Le armi originarie di questafamiglia sono: di verde alla banda di rosso filettata d’oro più tardi portaronol’inquartato, nel 1° e nel 4°, di rosso alla banda di verde; nel 2° e nel 3°, d’o-ro al saluto evangelico Ave Maria gratia plena in lettere d’azzurro, che ritro-viamo in tanti stemmi calabresi.
67 La dinastia dei principi di Mileto vede succedersi una serie di famiglie spagnole estin-tesi l’una nell’altra: Mendoza, de Sylva, Gómez de Sandoval: cfr. PELLICANO CASTAGNA, 1984-2002, vol. III, pp. 177-180.
68 Ibidem.69 TARANTINO, 2005.70 NOVI CHAVARRIA, 2009.
284 Marilisa Morrone Naymo
Rubbettino
Per tornare all’araldica regia, a Cosenza, nell’androne di Palazzo Arno-ne, sulla volta si ritrovano splendidi esemplari di stemmi affrescati. Come ènoto, il palazzo, iniziato da Bartolo Arnone agli inizi del XVI secolo, fu poivenduto ancora in fase di costruzione allo Stato e adibito a sede di Tribuna-le e Regia Udienza. In seguito fu abitazione dei Presidi di Calabria Citerio-re e poi Grande Archivio Generale di Giustizia71. A quest’ultimo periodo ri-salgono gli stemmi dell’androne qui rappresentati in armonica composizio-ne (fig. 63)72. Essi sono pertinenti alle tre cariche statali del momento: il Re,il Viceré, il Preside di Calabria Citeriore.
Il primo stemma è di re Filippo IV; è uno scudo semirotondo, con scu-detti semirotondi e coronati d’oro al suo interno73. È un complesso inquarta-to Castiglia-León / Aragona / Aragona Sicilia / Gerusalemme / Austria / Bor-gogna antica / Borgogna moderna / Brabante / Granada / Portogallo / Tiro-lo / Fiandra. Lo stemma potrebbe essere stato ritoccato con qualche confu-sione degli smalti originari; inoltre esso presenta numerose «licenze d’arti-sta», come spesso accade: il castello di Castiglia qui è d’argento, aperto e fine-strato di nero, ma normalmente è d’oro, aperto e finestrato d’azzurro; il leonedi León qui è di rosso, ma normalmente è di porpora; Aragona qui è palato didieci pezzi d’oro e di rosso, ma normalmente è d’oro, a quattro pali di rosso;Borgogna antica qui è delineato con scarsa precisione e sembra un bandatod’azzurro e d’oro, ma normalmente è bandato d’oro e d’azzurro; Granada quiè con il campo d’oro, che normalmente è d’argento; le figure in bordura di Por-togallo qui sono sette torri d’argento, ma normalmente sono otto castelli d’o-ro, aperti e finestrati d’azzurro; i quinas (scudetti) di Portogallo qui sono ca-ricati da quattro bisanti in croce, ma normalmente sono cinque in decusse; loscudetto in cuore qui è posto al di sotto del punto d’incrocio dell’inquartato,ma normalmente è sull’incrocio medesimo; lo scudetto in cuore qui è più pic-
285Segni di famiglie spagnole in Calabria
71 Sul Palazzo Regio di Cosenza, già Palazzo Arnone, si veda MUSSARI, 1995.72 Questi stemmi sono stati oggetto di brevi schede in occasione del restauro: cfr. CIPOL-
LA, 2007 in cui però ci sono fraintendimenti di alcuni quarti dello stemma reale (ad esempionon è identificato il quarto di Svevia; si confonde Tirolo con Anversa) e in quello di Gueva-ra y Taxis (le panelas vengono blasonate come cuori, il tasso dello scudetto Taxis viene iden-tificato come mastino).
73 Blasone: Inquartato: nel 1° contrinquartato di Castiglia e di León; nel 2° partito semi-troncato d’Aragona, d’Aragona-Sicilia e di Gerusalemme; nel 3° troncato d’Austria e di Borgo-gna antica; nel 4° troncato di Borgogna moderna e di Brabante. Innestato in punta fra il 3° e il4° granquarto, di Granata. Sul tutto nel punto d’onore, di Portogallo. Sul tutto in cuore, parti-to di Tirolo e di Fiandra. Scudo accollato dalla collana dell’Ordine del Toson d’oro. Timbro:tre elmi d’acciaio, chiusi, i laterali affrontati, il centrale in maestà e coronato d’oro, foderatidi rosso, tutti con svolazzi d’argento foderati d’oro. Cimieri: al centro, un castello d’argento,aperto e finestrato di nero, cimato da un leone nascente e coronato d’oro, tenente nella bran-ca anteriore destra una spada d’argento alta in sbarra; a destra, un drago nascente d’oro, ri-volto; a sinistra, un drago nascente d’oro.
Rubbettino
colo di quello nel punto d’onore, ma normalmente è il contrario, oppure le di-mensioni coincidono; l’aquila del Tirolo qui è rivolta, di nero e in campo d’o-ro, ma normalmente è di rosso, legata d’oro sulle ali, e in campo d’argento; illeone di Brabante qui è di rosso, ma normalmente è di nero.
Il secondo stemma è attribuibile ad un grande personaggio del Seicen-to spagnolo: don Íñigo Vélez de Guevara y Tassis, viceré di Napoli dal 1648al 1653. È uno scudo semirotondo, con corona gemmata d’oro a cinque fio-roni, alternati a quattro gigli74. Si possono fare le seguenti osservazioni: lecode d’armellino qui sono tendenzialmente puntiformi; ma normalmentesono meglio caratterizzate secondo lo schematismo di tale figura araldica, epiù facilmente riconoscibili; il tasso dei Taxis ha un aspetto slanciato, pocoadatto alla reale forma dell’animale75.
Il titolare di questo stemma è un noto personaggio dell’aristocrazia spa-gnola (m. 1658), conte di Oñate. Arrivato a Napoli nel 1648, si trovò a fron-teggiare con successo la rivolta del duca di Guisa. Contro la sua energica re-staurazione fu ordita la congiura di Andrea d’Ávalos principe di Montesar-chio. Insieme a don Giovanni d’Austria avviò una repressione non eccessivae mirata solo ai responsabili della congiura. Il viceregno del conte Oñate si di-stinse per una ripresa della vita culturale della capitale in collaborazione coni Gesuiti e con il cardinale Ascanio Filomarino: fu avviata una politica di or-todossia cattolica e fedeltà alla monarchia spagnola. Al suo ritorno in Spagnafu nominato consigliere di stato e insignito del titolo di marchese de Gueva-ra. Nel 1658 fu nominato governatore di Milano, ma nello stesso anno morì76.
Il terzo stemma è con sicurezza attribuibile a Francesco Capecelatro77,Preside di Calabria Citeriore dalla fine del 1648: è uno scudo semirotondo,con corona gemmata d’oro a cinque fioroni, alternati a quattro gigli78. Fran-
74 Blasone: Inquartato, nel 1° e 4° d’oro, a tre bande d’armellino (Guevara); nel 2° e 3° dirosso, a cinque panelas d’argento, poste in decusse (Vélez). Sul tutto, uno scudetto semirotondo,coronato d’oro, troncato: nel 1° d’oro, all’aquila bicipite di nero (coronata del campo su ambole teste?); nel 2° d’azzurro, al tasso stante d’argento (Taxis). Scudo accollato dalla croce del-l’Ordine di Calatrava.
75 La figura è stata identificata con un mastino nello studio di CIPOLLA, 2007, p. 26, manon sussistono dubbi circa l’identificazione con il tasso dei Taxis della antica famiglia austria-ca di origine bergamasca, di cui il de Guevara portava anche il cognome (la nonna paterna eraMarianna dei conti Taxis) e la cui arma coincide precisamente col quarto dello scudetto sultutto di questo stemma. L’arma del viceré è nota da altri esemplari in tutto il Regno, in parti-colare da quello sulla fontana della Selleria a Napoli, dove la figura del tasso è ben evidente.
76 SALVÁ, 1853, pp. 526-527; ÁLVAREZ BAENA, 1790, pp. 405-407.77 L’attribuzione, per quanto non documentata, di questo terzo stemma a Francesco Ca-
pecelatro è proposta da CIPOLLA, 2007, p. 25.78 Blasone: Inquartato, nel 1° e 4° losangato in banda d’argento e di rosso, al rastrello con-
finante d’azzurro; nel 2° e 3° di nero, al leone d’oro. Scudo accollato dalla croce dell’Ordine diSantiago. La presenza del lambello, segno di brisura, lo discosta dallo stemma della lineaprincipale della casata.
286 Marilisa Morrone Naymo
Rubbettino
cesco Capecelatro nacque nel 1597 da Alfonso signore di Nevano e da Lu-crezia Pignone dei marchesi di Oriolo. Rimasto orfano da bambino, lo zioOrazio, suo tutore, vendette il feudo di Neviano per far fronte ai debiti pa-terni79, perciò Francesco da signore feudale divenne parte integrante del ce-to nobile cittadino e presto ne abbracciò le tendenze politiche antiassoluti-stiche80. Ad una prima parte della sua vita trascorsa a rappresentare il cetoaristocratico contrapposto alla politica reale, culminata con la condanna al-l’esilio81 e al carcere durante il viceregno di Monterrey e continuata sottoMedina Torres, seguì, sotto questo stesso viceré, una nuova fase di riavvici-namento alla corona che gli costò, però, anche accuse di trasformismo e op-portunismo82. Fu allora che il Capecelatro iniziò una scalata a cariche edonori, attraverso una fedeltà alla corona esplicata soprattutto durante i mo-ti del 1647, che culminarono con la nomina a Preside di Calabria Citeriorenel 1648 da parte di Vélez de Guevara. In Calabria83, che da più parti si eraribellata, al pari della capitale e di altre zone del Regno, alla politica fiscaledi Filippo IV, l’azione del governatore fu energica e quanto mai decisa: nelsuo diario egli stesso ci dà contezza delle azioni intraprese per sedare le ri-volte scoppiate nel capoluogo e in tutta la provincia: a Rossano, Cassano, S.Donato, Lungro, dove impiccagioni e carcerazioni si susseguirono senza so-sta con l’appoggio di due compagnie spagnole di armati84. Alla fine delleoperazioni, avendo sedato le rivolte, soprattutto avendo vinto la riottositàdella nobiltà cittadina, il Capecelatro volle celebrare l’evento con un’operache rimanesse imperitura nella memoria di tutti, come da lui stesso ricor-dato nel Diario: «e volendo che di ciò che io fedelmente in servigio del Reoperato aveva, rimanesse memoria, fatto rinnovare ed abbellire il sottoporti-co del palagio del Viceré, ch’è assai magnificamente edificato in detta città,con dipingervi le armi del Re, del Conte di Ognatte, e le mie, vi feci porre inmarmo la seguente scrittura…»85.
287Segni di famiglie spagnole in Calabria
79 VOLPICELLA, 1854, p. 5. Rientrò nei ranghi feudali nel 1661, quando comprò il feudodi Lucito ottenendovi il titolo marchionale. Ringrazio Davide Shamà per la precisazione dialcune notizie biografiche.
80 RUSSO 1975.81 VOLPICELLA, 1854, p.15.82 ID., 1854, p. 52; RUSSO, 1975.83 Il Capecelatro, come racconta egli stesso nel Diario, salpò per la Calabria il 26 dicem-
bre 1648 per giungere a Cosenza il 2 gennaio dell’anno successivo: CAPECELATRO 1854, vol.III, p. 513. Vi rimase per tre anni e tre mesi: ID., p. 527.
84 Per la capillare descrizione delle operazioni si veda ivi, pp. 514-525.85 Ivi, p. 525. Il testo dell’iscrizione, oggi perduta, era il seguente: D.O.M. INDICO
VELEZ DE GUEVARA ET TASSIS, COMITE DE OGNATTE ET VILLAEMEDIANAE,PROREGE VIGILANTISSIMO, /d. FRANCISCUS CAPICIUS LATRO ORDINIS SANC-TI JACOBI DE SPATA, TRIBUNUM MILITUM, ARMORUMQUE PRAEFECTUS, CON-CREDITAM PROVINCIAM, BONIS OMNIBUS ACCLAMANTIBUS, PRUDENTIA ED
Rubbettino
L’insieme araldico di Cosenza è dunque databile con certezza al 1649, esi lega ad un preciso momento celebrativo in cui gli stemmi assumonoquanto mai il compito di eternare il nome di coloro che avevano compiutola non facile impresa di domare la ribelle provincia di Calabria Citra. Il Dia-rio di Capecelatro ci offre anche un concreto elemento di datazione e com-mittenza del rifacimento dell’androne di Palazzo Arnone.
La presenza di famiglie spagnole in Calabria è massiccia anche tra i ve-scovi delle diocesi della regione. Uno stemma vescovile del XVII secolomolto significativo è quello di Juan Lozano, vescovo di Tropea dal 1646 al1656 (fig. 64). Il presule, appartenente all’Ordine degli Eremitani di sant’A-gostino, fa uso di uno stemma alquanto enfatico, tipico dello Spirito dellaControriforma86. L’ispanicità del titolare traspare dall’insieme che risentedel clima mistico e magniloquente della cattolicità spagnola del XVII seco-lo. Molti stemmi iberici di questo periodo sono caratterizzati dagli stessi ac-centi.
A Gerace si conservano molti esemplari dello stemma di un altro vesco-vo di origine ispanica, cioè Domenico Diez de Aux (1689-1729)87. Si trattadi un’arma che ancora conserva la bordura aspada española88 (fig. 65).
Fra le maggiori famiglie del Regno, si distingue quella dei d’Ávalos cheinnalzano un’arma rimasta immutata nei secoli, dalla Spagna all’Italia. InCalabria, ma anche in Sicilia, è molto diffuso un celebre stemma di alleanzamatrimoniale con il quarto femminile d’Ávalos: quello di Carlo Maria Cara-fa principe di Roccella e di Butera, dal 1671 divenuto marito di Isabella d’Á-valos di Vasto89. Lo stemma è presente in diversi esemplari nel principato diRoccella, su manufatti argentei e litici, oltre che su stampe. Un esemplare daGrotteria, originariamente collocato sul seggio cittadino, oggi nella collezio-
JUSTITIA AD TOTAM SECURITATIS TRANQUILLITATEM CONFIRMAVIT; OPPI-DORUM ALIQUOT ORTA SEDITIONE REPRESSA, MOTISQUE SEDATIS, AUCTORI-BUS CAESIS, PROFLIGATIS EZTORIBUS, CAETERISQUE AD DEDITIONEM DE-DUCTIS, NOVITER MOLIENTIBUS SOLERTER DETECTIS, ET IN EOS SEVERE VIN-DICATUM, DEMUM REGIO MILITARI AERARIO RESTAURATO, OMNIA PACISPRAESIDIO MUNITA COMITER CUNCTANDO RESTITUIT; D. ANTONIO URSINODE SILVA, D. MICHAEL DE PAZE, ET IGNATIO DE AMICO, REGIIS CONSILIARIS ETAUDITORIBUS, ET JOANNE MARIA CALÁ REGII FISCI PATRONO ASSISTENTI-BUS. A.D. MDCXLIX.
86 Blasone: Un cuore, trafitto da due frecce cadenti e decussate; scudo sagomato in carti-glio, in marmo chiaro con iscrizione alla base datata 1650. Timbro: cappello prelatizio a seinappe per lato. Cfr. GORRA, 2010, p. 53.
87 Per questo vescovo si veda D’AGOSTINO 1984, pp. 141-145.88 Blasone: di [argento], alla cometa di otto raggi di [rosso], ondeggiante in palo; alla bor-
dura [del primo], caricata da dieci crocette in decusse [del secondo]. Timbro: un cappello pre-latizio a sei nappe per lato. Cfr. GORRA-MORRONE 2008, p. 36.
89 RACCO, 2010, p. 14.
288 Marilisa Morrone Naymo
Rubbettino
ne Lupis Crisafi90, presenta un bassorilievo in marmo con scudo ovale in car-tiglio, timbrato da una corona principesca a fioroni di tre punte91.
L’esemplare è datato 1674, come riportato nell’iscrizione che l’accompa-gnava. È un manufatto curato e corretto nella tecnica araldica e ben esegui-to anche dal punto di vista artistico (fig. 66). Sempre alla coppia Carafa-d’Á-valos sono pertinenti due scudi ovali in cartiglio, bombati, modellati a bas-sorilievo, e con tratteggio parziale ed errato92, su un reliquiario in argento,con teca di cristallo in cima ad un fusto su base ottagonale, conservato nel-la chiesa Matrice di Castelvetere-Caulonia. Fu proprio Carlo Maria Carafaa recepire la lezione araldica degli Spagnoli, componendo quello straordi-nario albero genealogico figurato, che è il complesso inquartato del suostemma93, riportato nelle sue opere a stampa e soprattutto sul suo monu-mento funerario a Mazzarino94: in un piccolo spazio trovano posto due se-coli di storia familiare, in cui si intrecciano più volte famiglie spagnole co-me gli Aragona-Sicilia, i Siscar, i d’Ávalos (fig. 67).
Nella Regia città di Stilo si ritrova un altro stemma con la partizionefemminile di famiglia ispanica. Nel seggio di nobiltà cittadino, erano iscrit-te molte famiglie di origine iberica: Escobar, Ponce de León, e Villaroel o Vi-gliarolo95, che compare in questo manufatto. Lo stemma presenta un’altradelle figure araldiche tipicamente ispaniche, los roeles, ovvero i bisanti, innumero di 13: si tratta di un evidente stemma parlante, richiamante il no-me della famiglia Vignarolo (Villaroel) nella forma spagnola.
La piccola rassegna di stemmi calabresi di famiglie di origine ispanica traXVI e XVII secolo, presentata in queste pagine, offre la possibilità di fare al-cune considerazioni e di ordine araldico e di ordine storico. Emerge dall’ana-lisi dei manufatti che in genere le famiglie feudatarie tendevano a stringere al-leanze matrimoniali con famiglie di pari grado ed etnia, e ciò si evince daicomplessi inquartati tutti spagnoli, come quelli dei principi di Mileto. Tutta-via ci furono famiglie che al contrario scelsero una politica di integrazione conl’elemento locale e si trasformarono di fatto in famiglie totalmente napolita-ne. Si può affermare che il retaggio dell’antica patria verrà mantenuto alme-no nella tradizione araldica, che ancora nel pieno del XVII secolo (e per alcu-ne famiglie tuttora fiorenti, ancora oltre) si conservava per la maggior parte
289Segni di famiglie spagnole in Calabria
90 Per questo pezzo cfr. MORRONE-PAPASIDERO, 2012, pp. 515-516, fig. 30. Un esemplareanalogo si conserva a Siderno.
91 Blasone: partito, nel 1° di (rosso), a tre fasce di (argento), attraversate in banda da un ra-mo di spino di (verde) [Carafa]; nel 2° di (azzurro), alla torre d’oro, merlata di sei pezzi, aperta efinestrata di (nero), alla bordura diminuita composta di (argento) e di (rosso) [d’Ávalos].
92 GORRA-MORRONE, 2008, p. 56.93 BORGIA, 1990b, pp. 603-609.94 RACCO, 2010, pp. 166 e 171.95 Sulle famiglie nobili di Stilo si veda LOBSTEIN, 2009.
Rubbettino
dei casi. Gli elementi della tradizione araldica spagnola vivono e si integranocon quella locale, talvolta trasformandosi, come nel caso degli stemmi deAyerbe d’Aragona o dei Borgia, ma comunque mantenendo sempre quel ca-rattere del tutto peculiare delle figure e delle composizioni ispaniche.
L’araldica, dunque, offre allo studioso sicuramente alcuni tra i segni piùevidenti e duraturi della presenza spagnola in Calabria.
Bibliografia
Aa.Vv., 1892, Nobiliario de conquistadores de Indias, M. Tello, Madrid.AGUSTÍN, A., 1734, Diálogos de las armas, i linages de la nobleza de España, Juan de
Zuñiga, Madrid.ÁLVAREZ BAENA, J.A., 1790, Hijos de Madrid ilustres en santidad dignidades, armas,
ciencias y artes, Oficina de D.B. Cano, Madrid, vol. II.BELENGUER, E., 2001, Ferdinando e Isabella. I Re Cattolici, traduzione di D. Gagliar-
di e F. Canale Cama, Salerno, Roma.BORGIA, L., 1990a, Ricerche e documenti su alcune famiglie Borgia italiane, G. Pagni-
ni, Firenze.ID., 1990b, Sull’arma della casa Carafa, in «Archivio Storico Italiano», CXLVIII,
545, pp. 581-611.CAGLIOTI, F., HYERACE, L., 2009, Antonello Gagini e le tombe Carafa di Castelvetere,
in A. ANSELMI (a cura di), La Calabria del viceregno spagnolo. Storia, arte, ar-chitettura e urbanistica, Gangemi, Roma, pp. 337-382.
CAPECELATRO, F., 1854, Diario di Francesco Capecelatro, contenente la storia delle co-se avvenute nel Reame di Napoli negli anni 1647-1650, Stabilimento tipograficodi G. Nobile, Napoli, 3 voll.
CIPOLLA, S., 2007, Descrizione araldica degli stemmi della volta dell’androne di Pa-lazzo Arnone, in «Bollettino della Galleria Nazionale di Cosenza», 2007, vol.zero, pp. 25-27.
D’AGOSTINO, E., 1984, I vescovi di Gerace-Locri, Frama Sud, Chiaravalle Centrale.D’AMATO, V., 1670, Memorie historiche dell’illustrissima, famosissima e fedelissima
città di Catanzaro, Gianfrancesco Paci, Napoli.DE MARCO, M., 2010, Dal primo Rinascimento all’ultima maniera. Marmi del Cin-
quecento nella provincia di Reggio Calabria, Esperide, Pizzo.DI CROLLALANZA, G.B., 1981, Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e no-
tabili italiane, estinte e fiorenti, Forni, Bologna, 3 voll. (riproduzione facsimiledell’edizione originale stampata presso la direzione del Giornale araldico, Pisa,1886-1890).
FOX-DAVIES, A. C., 1996, Complete Guide to Heraldry, Thomas Nelson and Sons,Lid. Wordsworth, London.
GALASSO, G., 1992, Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese, in Sto-ria d’Italia, UTET, Torino, vol. XV, tomo I.
290 Marilisa Morrone Naymo
Rubbettino
GORRA, M.C.A. 2010, Per un blasonario del vibonese, Corab, Gioiosa Jonica.GORRA, M.C.A., MORRONE M., 2008, Pan perì symbolon. Araldica religiosa e laica
nell’antica diocesi di Gerace, Corab, Gioiosa Jonica.LOBSTEIN, F. von, 1973-1977, Settecento Calabrese e altri scritti, Fausto Fiorentino,
Napoli, voll. I-II.ID., 2007, Settecento Calabrese, Piria, Perugia, vol. V.ID., 2009, La città di Stilo e le sue nobili famiglie, Franco Pancallo, Locri.MARTORANO, F., 2002, L’architettura militare fra Quattrocento e Cinquecento, in S.
VALTIERI (a cura di), Storia della Calabria nel Rinascimento, Gangemi, Roma,pp. 353-408.
MAZZELLA, S., 1601, Descrittione del Regno di Napoli e sulle famiglie nobili, G.B. Cap-pello, Napoli.
MORRONE, M., 2012, A cosa serve l’araldica?, in L. LOPRIORE (a cura di), Guida ra-gionata, Edizioni del Rosone «Franco Marasca», Foggia.
MORRONE, M., PAPASIDERO P., 2012, Collezionisti e collezioni archeologiche e numisma-tiche nella Locride: dalla riscoperta archeologica della Calabria alla nascita dellatutela, in A. ANSELMI (a cura di) Collezionismo e politica culturale nella Calabriavicereale borbonica post-unitaria e contemporanea, Gangemi, Roma, pp. 490-527.
MUSSARI, B., 1995, Il Regio Palazzo di Cosenza, in «Quaderni del DipartimentoP.A.U.», V, 10, pp. 101-114.
ID., 2002, La fortificazione della città. Un esempio: Crotone, in S. VALTIERI (a cura di),Storia della Calabria nel Rinascimento, Gangemi, Roma, pp. 409-456.
NAYMO, V., 2004, Uno Stato feudale nella Calabria del Cinquecento. La platea di Gio-vambattista Carafa, marchese di Castelvetere e conte di Grotteria, Corab, Gioio-sa Jonica.
NEUBECKER, O., 1980, Araldica. Origini, simboli, significato, Longanesi, Milano.NOVI CHAVARRIA, E., 2009, Anna Mendoza, in Dizionario Biografico degli Italiani,
Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, vol. 73, pp. 448-449.O’KELLY DE GALWAY, A., 1901, Dictionnaire Archéologique et Esplicatif de la Science
du Blason, Bégerac, Paris.ORTEGA LAMADRID, P., 1951, El emblema heráldico de las flechas de la Reina Isabel la
Católica comentado por un humanista italiano, in «Publicaciones de la Institu-ción Tello Téllez de Meneses», n. 6, p. 111-116.
PALAZZOLO DRAGO, F., 1927, Famiglie nobili siciliane, Reber, Palermo.PANARELLO, M., 2012, Fanzago e fanzaghiani in Calabria. Il circuito artistico fra Ro-
ma, Napoli e la Sicilia, Rubbettino, Soveria Mannelli.PASTOUREAU, M., 1993, Traité d’heraldique, Picard, Paris.PELLICANO CASTAGNA, M., 1984-2002, Storia dei Feudi e dei titoli nobiliari della Ca-
labria, CBC, Catanzaro, 4 voll.PESAVENTO, A., 1997, Una scultura del Cinquecento: le armi di Carlo V e di Don Pe-
dro de Toledo, in «La Provincia KR», n. 35, p. 10.PIFERRER F., 1855-1860, Nobiliario de los reinos y señoríos de España, M. Minuesa,
Madrid, 6 voll.
291Segni di famiglie spagnole in Calabria
Rubbettino
PONTIERI, E. (a cura di), 1961, Fonti aragonesi. I registri della Cancelleria vicereale diCalabria (1422-1453), Accademia Pontaniana, Napoli.
RACCO, F., 2010, Una codificazione feudale del Seicento calabrese. Gli ordini, pandet-te ed istituzioni del Principe Carlo Maria Carafa e il buongoverno nello Stato del-la Roccella, Corab, Gioiosa Jonica.
RUSSO, C., 1975, Francesco Capecelatro, in Dizionario Biografico degli Italiani, Isti-tuto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, vol. 18, pp. 442-445.
SALAZAR, A. de, 1642, Libro de armas de los mayores señores de la España, Parigi.SALVÁ, M., 1853, Colección de documentos inéditos para la historia de España, Imp.
de la Viuda de Calero, Madrid, vol. 23.SAVORELLI, A., 1999, Piero della Francesca e l’ultima crociata. Araldica, storia ed ar-
te tra Gotico e Rinascimento, Le Lettere, Firenze.SCORDO, A., 1991-1992, Della “bordura” nelle armi gentilizie d’Italia, in «Atti della
Società Italiana di Studi Araldici», 8°-9° convivio, p. 48.TARANTINO, F. P., 2005, Araldica degli Alarcon-Mendoza, testo della conferenza te-
nuta a Tossicia (TE) il 18 ottobre 2003, edizione internet 2005, in http://www.findthatfile.com/search-52624853-hPDF/download-documents-araldica.pdf.htm.
USECHE, O. I., 2012, Hacia una representación simbólica de la aristocracia en la Amé-rica colonial: escudos de armas, memoria e identidad, https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:6zki8jpK3BMJ:www.columbia.edu/~oiu1/LatinAmerica/Heraldica.doc+O.+I.+Useche,+Hacia+una+representacion+simbol
VALENTE, G., 1980, Storia della Calabria nell’età moderna, Frama Sud, ChiaravalleCentrale, 2 voll.
VALERO DE BERNABÉ, L., 2007, Análisis de las características generales de la Heráldi-ca gentilicia Española y de las singularidades heráldicas existentes entre los diver-sos territorios históricos hispanos, Memoria para optar al grado de doctor, Uni-versidad Complutense de Madrid, Facultad de Historia, Madrid.
VIGNOLO, A. 1899, Su alcuni mobili del blasone spagnolo, in «Calendario d’oro», pp.186-188.
VOLPICELLA, S., 1854, Della vita e delle opere di Francesco Capecelatro: discorso,Stampa di Giorgio Franz, Monaco.
292 Marilisa Morrone Naymo
Rubbettino