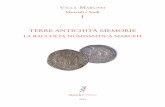Segesta. I villaggi di età imperiale
Transcript of Segesta. I villaggi di età imperiale
lizzazione incompiuta della Sicilia con tre aspettiproblematici: basso numero di senatori, di cavalieri edi militari, debole evergetismo imperiale, scarsa pre-senza nell’isola di senatori romani. Questa latitanzaappare agli storici tanto più stridente, proprio pensan-do alla rilevante quantità di proprietà senatorie pre-senti in Sicilia. L’assenteismo dei senatori e la sepa-ratezza fra le proprietà di questi e le società localisono fenomeni reali. Gli edifici architettonicamenteevoluti, già pochissimi nelle campagne siciliane fra latarda repubblica e il primo impero, al contrario diquanto accadeva altrove, appaiono circoscritti allafase tardoantica 6. In Sicilia si andava raramente,anche quando si possedevano veri e propri praetoria
o palatia nelle campagne, come Piazza Armerina, edenormi estensioni di terreno, per di più caratterizzatida grandi potenzialità agronomiche. L’urbanizzazio-ne di epoca imperiale appare stagnante o addirittura
623
sta. Al progetto collaborano: Sandra Bernardini (età arcaica,classica ed ellenistica), Ilaria Neri (età tardo repubblicana eimperiale), Maria Aprosio (Tarda Antichità, età bizantina),Alessandra Molinari (Medioevo; cfr. anche Molinari 1997).
2 Aprosio, Cambi, Molinari 1997; Bernardini et alii 2000;Cambi 2003.
3 Wilson 1990; Pinzone 1999a e 2000; Facella 2003.4 Pace 1958.5 Vera 1996, 31-57.6 A R. Wilson e a O. Belvedere si devono importanti ricer-
che condotte nell’agrigentino e nell’imerese: Alliata et alii1988; Belvedere et alii 2002; Wilson 1990a; Id. 2000, 337-370.
Premessa e antefatto
In questo contributo tenterò di delineare unaprima definizione delle tipologie insediative tardoan-tiche nel comprensorio di Segesta, basandomi essen-zialmente sui dati raccolti in occasione delle campa-gne di ricognizione degli anni 1995-1999 1, alcuniresoconti delle quali sono state pubblicate in variecircostanze 2.
La provincia di Sicilia aveva cessato, con gli annidel passaggio al Principato, di essere uno dei luoghicentrali della storia romana, venendo così emarginatarispetto alle fonti storiografiche 3. Oggi molte cosesono cambiate rispetto a quando Biagio Pace scrive-va che la storia della Sicilia imperiale era «una pagi-na bianca» 4, e una messe di studi recenti permette unmaggiore ottimismo. D. Vera 5 spiegava la municipa-
Segesta.I villaggi di età imperiale
di Franco Cambi *
Segesta. The Imperial Age villages
In Late Antiquity and in Early Middle Ages the history of Segesta territory, as well as the one of other areas in Sicily, is nolonger a history about a town, but it becomes a history about villages and rural life. The villages in the Sicilian territoryseem to be one of its constant features, as the excavations and their relative surveys have proved so far. After the slavewars at the end of the 2nd century B.C. and the turmoil of civilian wars, towns and small rural settlements undergo acommon crisis. During the Early Empire literary and epigraphic sources are both silent. The population now settles in thevillages which are more and more numerous in the Sicilian valleys. From the 1st to the 3rd century A.D. villages aresubstantially self-sufficient as regards the food supplying and starting from the 4th century they are archaeologicallydocumented. The growing of these settlements is probably connected to the consolidation of Sicily as a granary provinceof Rome, after the grain from Egypt has been allotted to Constantinople. Villages mark the life of Western Sicily all throughLate Antiquity up to the Early Middle Ages. Some of them will later be occupied and inhabited again in the Islamic period.
Keywords: Segesta, antique landscapes, rural settlements, roman period.
* Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti, Univer-sità di Siena; [email protected].
1 Il progetto di studio del territorio di Segesta-Calatafimi,effettuato dall’Università degli Studi di Siena, era nato da unaidea di Alessandra Molinari e finanziato a suo tempo dallaSoprintendenza BB. CC. e AA. di Trapani (1997) e dal Comu-ne di Calatafimi-Segesta, in due riprese (1995-1996 e 1999).Le campagne di ricognizione sul terreno si sono svolte neglianni 1995, 1996 e 1997, lo studio dei reperti negli anni 1996-1999. Complessivamente sono stati individuati più di 500nuovi siti archeologici. Alcune elaborazioni di carattere espo-sitivo hanno avuto luogo nel 2000-2001, sfociando in unaserie di pannelli segnalatori ora esposti a Calatafimi e a Sege-
declinante in Sicilia, rispetto alle altre province 7
cosicché la vita cittadina nell’isola, relativamentevivace nei vecchi centri sicelioti, langue negli abitatiristrutturati dai romani, anche per l’intento sostan-zialmente predatorio che era stato alla base dellaristrutturazione augustea dell’isola 8.
In età ellenistica o forse, più probabilmente, anco-ra nella tarda età classica (dalla metà del IV secoloa.C.), si era osservata in molte parti della Sicilia latumultuosa esplosione dell’insediamento sparso. Nelcomprensorio Segestano case (o epàuleis, per dirlacon Diodoro Siculo) 9 di diverse dimensioni e condiverse caratteristiche si distribuiscono lungo i corsid’acqua, lungo le strade, nei fondovalle, sopra le altu-re e intorno alla città. I villaggi sembrano invece col-locarsi, per lo più, nei pendii ad O, affacciati sullavalle di monte Domingo. Il luogo privilegiato dall’in-sediamento per villaggi è certamente la valle delfiume Freddo, dove pure non è del tutto assente l’in-sediamento sparso. Questo è il paesaggio che fa dascenario alla crescita di Segesta tardo-classica edellenistica.
In precedenti occasioni 10 avevo avuto modo dirilevare come, nel periodo compreso fra la fine del-l’orizzonte dell’èpaulis 11 (II secolo a.C.) e la mediaetà imperiale non si formasse in Sicilia la facies dellavilla, malgrado la presenza di proprietà senatorie emalgrado la precedente esperienza delle epàuleis,documento archeologico importante, ancorché sotto-valutato, per lo studio della genesi della villa romana.Questa inizia a formarsi con la conquista romana del-l’Italia meridionale, circostanza nella quale l’archi-tettura e l’agronomia romane ampliano i propri oriz-zonti in maniera esponenziale e svolgono una liberaelaborazione ispirandosi a precisi modelli italici emediterranei. Il primo modello è senz’altro quellodell’anàctoron-regia 12, radicato nel mondo etrusco e
romano dall’età orientalizzante, e con sviluppi inepoca alto-repubblicana, benché sfuggano gli aspettiriguardanti le tipologie di conduzione agraria 13. Unostraordinario know-how agronomico, fra IV e IIIsecolo, derivò inoltre dalla scoperta delle costemagno-greche, con particolare riferimento alla Cam-pania e alle due sponde della Lucania. Il terzo model-lo, di carattere decisamente architettonico, si innestasull’esperienza dei palatia dell’area macedone, tessa-la ed epirota 14. Il quarto modello va legato alla cono-scenza dei contesti cartaginesi metropolitani, per iquali sono noti i presupposti agronomici (trattato diMagone 15), meno quelli strutturali e coloniali. Il con-tatto, avvenuto durante la prima guerra punica,dovette rappresentare uno straordinario momento disintesi di esperienze diverse 16.
Gli effetti del consolidamento dell’eparchia puni-ca sulla riorganizzazione delle campagne nel IVsecolo sono visibili, oltre che in Sicilia, nell’isola diPantelleria, dove la tipologia insediativa della ‘fatto-ria tardo-punica’ (la ‘casa 1 e 2’ della tipologia da noicostruita a Segesta) concorre a definire un modellointerpretativo 17 complesso e dotato di cisterne ditipologia punica, segno di un approccio progettualesofisticato alle strutturali difficoltà di approvvigiona-mento idrico dell’isola 18. Le anfore greco-italichepresenti nella quasi totalità delle case rurali segesta-ne, pantesche e di altri comprensori 19 appartengonoin buona misura alle varianti più antiche (IV-III seco-lo a.C.) e a produzioni quasi certamente siceliote 20. Ildato è indice di una diffusa prosperità del paesaggioche emerge con forza particolare fra le età di Timo-
Franco Cambi
624
7 Fonti per la storia della città: Camerata Scovazzo 1996;De Vido 2000, 389-435; Cicerone come fonte per la storiasegestana: Michelini 2000, 777-808; Paoletti 2003, 999-1027;Lazzeretti 2000 e 2002.
8 Vera 1996; Wilson 2000a, 134-160.9 Cfr. Cambi 2003.10 Cambi in Bernardini et alii 2000; Cambi 2003 e Id. c.s.11 Sull’argomento ho cercato di fare il punto nel contributo
del 2003.12 Si vedano le osservazioni di Cifani 1998, 53-57; Id.,
2002, 247-260.
13 Questa tipologia comincia a delinearsi in modo abbastan-za preciso: Carandini et alii 1997, 117-148.
14 Lauter 1987, 345 ss.15 L’incertezza sull’opera (probabilmente una vera e pro-
pria summa del pensiero agronomico punico) si estende anchealla personalità dell’autore e persino all’epoca in cui visse,forse la seconda metà del IV secolo. Il credito di cui godettepresso gli scrittori latini è chiaro segno che la sua opera dovet-te rappresentare il punto di arrivo dell’agronomia cartaginese(Marcone 1997, 19).
16 Carandini 1989.17 Monti 2002, 935-942.18 Massa 2004.19 Baldassari, Fontana 2002, 953-990, in part. 971 ss.20 Baldassari, Fontana 2002, 957, fig. 1; Vandermersch
1994; Campagna 2000, 443-478, con bibliografia precedente.
leonte e di Agatocle anche se vanta origini in qualchecaso risalenti almeno alla fine del V. L’esportazionedi vino siceliota in Africa, peraltro, attestato da anfo-re greco-italiche di tipologia antica, è riferita da Dio-doro Siculo ad episodi già della fine del V secolo a.C.(XII, 81, 4-5) 21. Conclusioni analoghe possono esseretratte per i vicini territori di Erice e di Trapani, dovela crescita dell’orizzonte delle case di campagna delIV secolo a.C. procede di pari passo con la crescitadelle attestazioni di anfore vinarie di produzionelocale o regionale 22.
Dalla tarda età repubblicana alla prima età impe-
riale
Nelle campagne l’orizzonte dell’èpaulis, dopoavere attraversato in maniera relativamente indoloreil volgere degli anni della prima guerra punica e deidecenni successivi 23 sembra subire la prima svolta,profonda anche se non decisiva nell’immediato, conl’intervento di Valerio Levino 24 nel 210, artefice dellatrasformazione della Sicilia da giardino-piantagionea provincia granaria. Il cambiamento non dovetteessere breve, almeno stando ai dati provenienti dalterritorio, relativamente stabili almeno fino alla metàdel II secolo a.C. 25 e all’esempio, databile attorno al150 a.C., della èpaulis di tipologia avanzata come lacasa di Contrada Mirabile 26. La tradizionale ricchez-za agraria della Sicilia dovette consentire per piùtempo la convivenza di forme di gestione anche assaidiverse: cerealicoltura, allevamento, vitivinicoltura.Un dato certo è però rappresentato dalla bassissimaincidenza delle anfore vinarie greco-italiche di tipo-logia più recente rispetto a quelle di fine IV-III. Siespandevano, evidentemente, le conduzioni agricoleche richiedevano un basso livello di tecnologia e digestione coordinata 27. Con i decenni centrali della
seconda metà del II secolo le campagne segestaneappaiono caratterizzate da una serie di fattori incon-trovertibili: abbandono progressivo dei siti più picco-li, embrionale tendenza alla polarizzazione degli abi-tati, probabile crescita delle dimensioni delle pro-prietà e delle torme di schiavi che operavano nellecampagne 28. Il quadro emergente dalle fonti archeo-logiche per la Sicilia occidentale appare fortementecontrastato in questa fase. Mentre la vita urbana tornaad essere brillante e in ripresa (Segesta 29), oppuredecisamente visibile (Lilibeo 30), quella rurale apparepesantemente condizionata e segnata in profonditàdagli eventi delle turbolenze dovute alle rivolte servi-li che, significativamente, le nostre fonti chiamanobella. Poiché la seconda di queste prese avvio daidintorni di Halyciae-Salemi, si dovrà pensare che leconseguenze nelle campagne circostanti siano statemolto gravi. Ancor prima che l’orizzonte dell’èpaulis
avesse cominciato ad evolvere verso il paesaggiodella villa romana, alla metà del II secolo, il processoveniva interrotto e ciò malgrado che fossero presenti,in Sicilia, quegli elementi di imprenditorialità chealtrove avevano portato alle diverse forme di ricchez-za senatoria ed equestre, di origine tanto urbanaquanto italica 31. La consolidata tradizione dell’oikos-
ktèsis-proedium rappresentato dall’èpaulis, innervatadai più avanzati criteri agronomici, costituiva un ter-reno particolarmente fertile. Invece la tipologia della
Segesta. I villaggi di età imperiale
625
21 Denaro 1995, 183-208; per gli scavi di Entella: Corretti,Capelli 2003, 287-351.
22 Filippi 2003, 497-506. 23 Bernardini et alii 2000 103-105; Cambi 2003, 148-153.24 Pinzone 1999a, 27; 45.25 Bernardini et alii 2000, 103-105; Cambi 2003, 148-153;
Filippi 2003, 497-506.26 Fentress, Kennet, Valenti 1986, 75-96. 27 Per l’anno 169 si ha notizia di un forte prelievo di grano
siciliano operato dai Rodii dietro autorizzazione del Senato(Polibio 28, 2; Pinzone 1999a, 46-47).
28 Occorre precisare che questa tendenza, marcata nel com-prensorio in esame anche per la straordinaria abbondanzadella documentazione, non può, almeno al momento, esseregeneralizzata ad altri contesti. È peraltro da precisare che ifossili guida presenti nel territorio, mentre consentono didistinguere abbastanza agevolmente i siti del IV-III da quellidi epoca successiva, non sempre permettono di identificarefacilmente le linee di demarcazione fra la prima e la secondametà del II e fra la fine di questo e gli inizi del successivo.
29 Contributi di C. Ampolo e M.C. Parra, in Ampolo c.s.30 Giglio 2001.31 Pinzone 1999b, 381-402. A Segesta l’architetto pubblico
al quale viene commissionato il progetto del nuovo bouleute-rion tardo-repubblicano è di origini italiche (Ampolo c.s.). Unaltro riflesso delle attività di soggetti di origine italica è costi-tuito dalle numerose attestazioni di anfore rodie (Denaro1995), a partire soprattutto dalla fine del III secolo a.C. LaSicilia era evidentemente ben inserita nei circuiti mercantiliche facevano capo all’Egeo e che erano, almeno per il II seco-lo a.C., diretti da Italici. Sulla figura emblematica dell’Octa-vius di Siracusa, cfr. considerazioni in Cambi c.s.
villa romana non prese piede in Sicilia né nella formaestensiva ben documentata in Apulia 32 né in quellararefatta vista nella Calabria salentina 33 né, tantome-no, in quella intensiva centro-italica 34, che pure l’è-
paulis siciliana aveva contribuito a formare. Comin-ciarono, al contrario, a manifestarsi i prodromi delpaesaggio latifondistico tipico della Sicilia imperiale.
In città, invece, si hanno segni sicuri che la roma-nizzazione, leggibile negli edifici pubblici della se-conda metà del II a.C., ebbe un riflesso forte anchenella vita privata. Mentre la domus cittadina presepiede in Sicilia, come dimostrano esempi illuminantida alcuni degli antichi abitati dell’isola, non ultima lastessa Segesta 35, è altresì imbarazzante la scarsitàdella documentazione archeologica relativa alle cam-pagne, con l’eccezione dei pochi insediamenti e deifundi come quello di Nympho, di Centurie o quello diQ. Lollius ad Aetna 36. Anche a Segesta gli abbandonidegli insediamenti sparsi fra la fine del II e la primametà del I secolo a.C. rappresentano la regola, cosic-ché il quadro, già fortemente contrastato, si fa a tintesempre più scure. La Sicilia appare sempre più sepa-rata in aree con vocazioni, sia sociali sia economiche,molto sofisticate e spiccate (Siracusa e la costa io-nica 37) ed aree che cominciano a ripiegarsi su sé stessee ad assumere forme di paesaggio più estensive. Lepagine di Diodoro relative ai bella servilia lascianointravedere, soprattutto per le zone interne ed occi-dentali, un mondo completamente diverso rispetto alpassato 38. Creata la provincia, venne creato, grazie so-prattutto a Levino, anche un assetto plausibile per l’e-conomia isolana, destinata ad un futuro nel quale i ce-reali avevano sempre più spazio 39 anche se non un
predominio assoluto 40. In virtù di un controllo del Se-nato sempre più forte, soprattutto rispetto al III secoloa.C., l’isola continuò ad essere coltivata ma divennepiù deserta. Le epàuleis dismisero l’immagine di pic-cole città trapiantate nelle campagne, accreditata daDiodoro Siculo e ritrovata nelle ricognizioni e negliscavi, assomigliando sempre più a casolari e sempremeno a ordinate piantagioni. La stessa èpaulis di Con-trada Mirabile, evolvendo verso il tipo della grandecasa con ergastulum a corte centrale, sembra alluderead una realtà nella quale le masse servili hanno uncerto rilievo quantitativo. Diodoro, che aveva cono-sciuto l’Italia centrale del suo tempo, sapeva coglierele differenze fra una campagna ordinatamente e disci-plinatamente coltivata dalle turmae dei servi compe-
diti e dai salta semideserti. Le bande di schiavi, primacircoscritte e irreggimentate nelle piantagioni delleepàuleis, erano ora sempre più numerose e sparsenelle pianure e nelle valli, e in masse tali da fare spa-vento se i numeri citati da Diodoro rispondono a ve-rità 41. In ogni caso, la reiterazione del bellum nel 104-101 a.C. indica comunque un degrado progressivodell’ordine pubblico. Nelle campagne segestane, apartire dalla seconda metà del II secolo a.C., apparenetta la flessione dell’insediamento sparso (fig. 1),non particolarmente apprezzabile nei dintorni di Se-gesta (forse la vicinanza della città era una garanzia disicurezza) ma assai visibile nella valle del fiumeFreddo e altrove. In una fase di rilevante monumenta-lizzazione dell’acropoli di Segesta 42, come di altrerealtà urbane della Sicilia, le campagne sembranosempre più marginali. Diodoro identifica il teatrodella seconda guerra servile proprio nella Sicilia occi-dentale, nei territori di Halyciae-Salemi, di Lilibeo, diSegesta 43, zona nella quale si ha una forte e concomi-
Franco Cambi
626
32 Volpe 1990.33 Cambi 2001, 363-390; Aprosio c.s. e Ead. in questo
volume.34 Carandini 1989, 101-200. 35 Cambi 2003, 155, con bibliografia precedente.36 Wilson 2000a, 157.37 Gaggiotti 2002.38 Diod. 34, 27, 29.39 Strabone VI, 2, 7. Secondo Wilson le città ancora occu-
pate nel periodo di Verre formano un quadro variopinto e sipuò ancora parlare di una Sicilia fiorente e bourgeoning, gra-zie anche allo sviluppo della cerealicoltura. Meno convincenteappare la possibilità che gli agricoltori siciliani abbiano accre-sciuto i loro profitti grazie all’aumento della produttività, asua volta indotta dalla accresciuta tassazione (Wilson 2000a,149).
40 L’allevamento doveva rappresentare un’attività impor-tante, visto che, durante la guerra sociale, la Sicilia riforniscedi pelli e tuniche tutti gli eserciti romani (Cic. Verr. II, 2, 5;Gebbia 2003, 38). Si tratta però di attività che, come lo zaffe-rano, il miele, ed ugualmente le pelli, il bestiame e la lana,ricordati da Strabone (infra), non lasciano tracce archeologi-che.
41 La prima rivolta (135-132 a.C.), dice Diodoro (XXXIV-XXXV, 2) vide impegnati addirittura 200.000 schiavi.
42 Camerata Scovazzo 1996; D’Andria 1997.43 Diod. 36, 3. Il testo riporta comunemente una chora
Alykyàion, emendato da un Ankylion in maniera non del tuttocerta.
tante rarefazione dell’insediamento sparso, con parti-colare riferimento al settore della valle del fiumeFreddo compreso fra monte Baronia e Contrada Rosi-
gnolo e affacciatoverso Gibellina e Sa-lemi (è una dellezone dell’eremìa diStrabone?) 44.
Tra la fine del-l’età repubblicana el’inizio dell’etàimperiale la rarefa-zione degli insedia-menti interessa anchel’area circostanteSegesta (fig. 2). Lecentinaia di dimoreunifamiliari chedovevano scorgersidall’acropoli dellacittà vennero pro-g r e s s i v a m e n t eabbandonate e analo-ga sorte toccò all’in-sediamento sparsonella fertile valle diContrada Sasi e nel-l’entroterra meridio-nale compreso tra ilfiume Freddo e ladorsale montuosa diMontagna Grande.Sull’assetto socioeconomico dellaSicilia dovette avereripercussioni signifi-cative l’eclissi, a untempo, della centra-lità strategica dellaSicilia, conseguentealla pax augustea, e
della sua importanza economica, conseguente all’as-segnazione dei rifornimenti annonari dell’Italia all’Egitto 45.
Segesta. I villaggi di età imperiale
627
44 Strabone VI, 2, 6. Molte delle città indigene risulterebbe-ro disabitate e tale era lo stato di abbandono (eremìa) chemontagne e pianure vennero lasciate all’allevamento deicavalli, dei buoi e dei montoni. Strabone imputa ai pastori, chedi queste forme di allevamento erano evidentemente i soggettiattivi, il peggioramento della situazione generale. I pastori sidedicavano dapprima sporadicamente alle rapine, più tardi siunirono fra loro in massa e devastarono le città. Ancora all’e-
poca di Strabone (anno 35 a.C.) un certo Seleuro avrebbelungo tempo devastato la regione etnea. La sorte del personag-gio straboniano riecheggia quella, altrettanto sfortunata evalorosa, dello schiavo Satiro di Diodoro (36.10) che, cattura-to alla fine della seconda guerra servile e condannato al com-battimento con le belve nel circo, preferì darsi la morte insie-me con i suoi compagni.
45 Cracco Ruggini 1980; Vera 1996 e 1997-1998.
1. - Le campagne segestane nella tarda età repubblicana (metà II-I secolo a.C.).
Dal punto di vista dell’assetto dei paesaggi, ildato significativo emergente è rappresentato dallatendenza sempre più forte alla polarizzazione degliabitati. Nell’area Segestana i poli principali sono: idintorni del monte Pispisa; Ponte Bagni-aquae Sege-
stanae; Punta Fegotto; Contrada Arcauso; il settoreinterno della valle del fiume Freddo.
Non sembra potersi riscontrare nell’area segesta-na la condizione di assoluta decadenza, testimoniataper i territori di altre città. Vale la pena di riprendere
il testo di Strabone.Pochi passi dopo ilriferimento all’e-
remìa, il geografotorna sul topos dellafertilità della chora
siceliota per affer-mare che l’isola ècelebre per il grano,il miele e lo zaffera-no, prodotti per iquali vanta addirittu-ra il primato, e sog-giunge: «e la chia-mano, appunto, gra-naio (tameion) diRoma; infatti porta aRoma tutto ciò cheproduce – ad ecce-zione del poconecessario per ilconsumo locale –cioè non solo i suoiraccolti ma anche ilbestiame, le pelli, lalana ed altri prodottisimili» 46. Dalla com-parazione dei duepassi strabonianisembra emergerel’immagine di unaSicilia bifronte: perquanto, nei luoghipiù marginali, lostato di eremìa fini-sca per favorire con-duzioni del suolosempre meno orga-
nizzate come l’allevamento brado e un degrado che,in vista dell’età augustea, non sembra essersi ancoraarrestato, la Sicilia è ancora in grado di esportare,non solo grano, ma anche merci più preziose. Chepoi, dal punto di vista archeologico, le merci in que-stione (miele, zafferano, bestiame, pelli, lana) sianopraticamente intangibili (a differenza delle anfore
Franco Cambi
628
46 Strabone VI, 2, 7 (traduzione di A.M. Biraschi).
2. - Le campagne segestane nella prima età imperiale (I-II secolo d.C.).
vinarie classiche ed ellenistiche), questo è un altrodiscorso.
Pare di potere riscontrare, in ogni caso, un signifi-cativo processo di trasformazione in atto, dai contor-ni ancora sfumati, che ha al suo centro l’abbandonodel popolamento sparso in favore di nuove forme diinsediamento.
Fonti epigrafiche e fonti scritte 47 sono la dimo-strazione che Segesta, malconcia, esisteva ancoranella prima età imperiale, quando i Segestani restau-rarono il teatro 48 e si rivolsero poi a Tiberio 49 e aClaudio 50 per ottenere altri lavori per il tempio diVenere ad Erice, vetustate conlapsum. Indaginirecenti 51 sull’acropoli della città contribuiscono aspostare la data di morte di Segesta più avanti neltempo: sono noti interventi in età flavia e l’abbando-no del sito può essere archeologicamente datato allafine del II-inizi del III secolo d.C. La notizia relativaalla assegnazione di terre ai veterani nell’agro Sege-stano da parte di Vespasiano 52, pur consentendo dicongetturare una qualche forma di continuità dellapiccola proprietà in alcuni settori del territorio, non èal momento suffragata dalla ricerca archeologica.Sarebbe interessare verificare la possibilità di unnesso fra questa notizia e il dato archeologico dellaristrutturazione flavia dell’agorà, quale sembraemergere dai recenti scavi.
Segesta appare sempre più come abitato margina-le, dal punto di vista demografico se non da quellodel ruolo amministrativo 53. Nelle campagne si conso-lida l’orizzonte dei villaggi 54 che, con poche eccezio-ni, dominerà l’intera età imperiale, trasformando inun lontano ricordo il paesaggio delle case sparse, oepàuleis, che aveva fatto da scenario alla Segestaellenistica. Solo pochi insediamenti sparsi sembranonascere nel I d.C. È del tutto ipotetica la possibilitàche in essi vada ravvisata la misteriosa deduzione dietà flavia ricordata dal Liber Coloniarum (I, Gromat.
Vet., 11).Il fenomeno della polarizzazione degli abitati si
accentua senza sosta nei secoli successivi al I d.C.
Fra l’altro, occorre sottolineare il fatto che alla pro-gressiva e ulteriore riduzione dei siti sparsi si accom-pagna la crescita contestuale degli insediamentiagglomerati, con il dato particolare, a mio avvisoimportante, della nascita di tre nuovi villaggi accantoa quelli già esistenti, nel corso del II secolo d.C. Inuna carta di sintesi relativa alla prima età imperiale laprevalenza dei villaggi sull’insediamento sparso èormai evidente.
La media età imperiale
Appare abbastanza chiara la tendenza alla pro-gressiva nucleazione (come la definirebbero gliarcheologi inglesi ed anche i medievisti italiani) degliabitati, insediamenti accentrati, spesso dotati diimpianti produttivi, nei quali alloggiavano piccolecomunità che coltivavano le campagne circostanti. Sitratta prevalentemente di antichi insediamenti, talvol-ta di lungo corso, fondati in età classica e caratteriz-zati da una evidente floridezza in età ellenistica, dasempre presenti nel panorama dei paesaggi sicelioti,e localizzati in posizioni geograficamente favorevolibenché eccentriche rispetto alla città. I villaggi, perlungo tempo costretti in un ruolo marginale, ancheper effetto della duplice, travolgente centralità assun-ta tanto dalla forma urbana, soprattutto a partire dal Vsecolo a.C., quanto dall’insediamento sparso, rappre-sentano la chiave per l’interpretazione dei paesaggisegestani della media e della tarda imperiale.
Secondo la appropriata definizione di G. Volpe ilvillaggio è «un’entità insediativa sparsa in un’areapiù o meno ampia, con spazi edificati e zone libere,un agglomerato di case ed altri edifici verosimilmen-te disseminati nella campagna intorno ad un nucleocentrale» 55. Altre caratteristiche possono essere, sem-pre secondo Volpe:
– il gravitare intorno alle strutture di una villa che hamodificato le proprie funzioni;
– il gravitare intorno ad una stazione viaria;
Segesta. I villaggi di età imperiale
629
47 De Vido 1991; Nenci 1991. 48 De Vido 1991.49 Tac. Ann. IV, 43, 4.50 Suet. Claud. XXV.51 C. Ampolo e M.C. Parra, in Ampolo c.s. 52 Liber Coloniarum, I, Gromat. Vet., 11.
53 Pinzone 1999a e 2000.54 Dal punto di vista storico-giuridico, si veda il tradiziona-
le contributo di R. Martini (1973) e i recentissimi saggi diL. Capogrossi Colognesi (2002a e 2002b). Il versante archeo-logico della questione appare invece ancora molto nebuloso.
55 Volpe 1996, 156.
– la disponibilità di depositi per l’immagazzinamen-to di derrate;
– la gamma delle attività produttive;– lo svolgimento di attività commerciali;– la disponibilità di acqua.
Queste condizioni sono comuni a molti villaggi dimolte regioni dell’Italia tardoantica, fra le quali, cer-tamente, l’Etruria 56 e la Apulia et Calabria 57. Conl’esclusione della prima delle condizioni elencate(sviluppo nel sito di una precedente villa), si puòaffermare che le restanti cinque caratterizzino lamaggior parte dei siti siciliani tardoantichi interpreta-bili come villaggi.
La progressiva eclissi del centro principale, l’ab-bandono dell’insediamento sparso in favore dinuove forme di insediamento causano, per contra-sto, l’emersione di abitati locali, fra i quali apparecentrale la stazione di posta di aquae Segestanae inlocalità Ponte Bagni. Molti dei villaggi esistenticontinuano a vivere ed altri nuovi si aggiungono, so -prattutto a partire dal III ma con una accentuazionenel IV e nel V.
La trasformazione può dirsi compiuta nella mediaetà imperiale, consolidandosi principalmente lungo levalli del fiume Gaggera e del fiume Freddo, caratte-rizzate da fondovalle ricchi d’acqua e ben collegatialla viabilità minore. Due sono le tipologie insediati-ve: fattorie mono o plurifamiliari (casa 1 e casa 2nella nostra classificazione convenzionale) e soprat-
tutto villaggi (fig. 3). Benché questi siti abbiano vis-suto momenti di difficoltà in età augustea, nonmostrano cesure nella documentazione archeologicae all’inizio del II secolo recuperano un’intensa vita-lità, espressa archeologicamente da manufatti diimportazione di costo contenuto.
In altre circostanze 58 si era potuto osservare,anche da un semplice conteggio numerico dei mate-riali, la vivacità di questi centri e dei loro contatti conle rotte commerciali del tempo. La massiccia quantitàdi vasellame da mensa (Terra Sigillata Africana A,particolarmente attestato nelle forme Hayes 3 A e B,Hayes 8 A e B, Hayes 9 A e B) e di vasi da cucina diprovenienza nordafricana testimonia infatti comel’attività di importazione di prodotti di uso quotidia-no e di costo contenuto fosse estremamente vitale. Alcontrario, la presenza irrilevante di anfore da derratealimentari di provenienza africana, spagnola e orien-tale indica che non vi era necessità di far giungeredall’estero vino, olio, grano, conserva di pesce o difrutta. A partire dal IV secolo la dipendenza dall’A-frica Proconsolare coinvolgerà anche le merci ali-mentari, come dimostra il crescente numero di conte-nitori cilindrici di medie dimensioni (Keay XXV), dispatheia (Keay XXVI e XXVII) e di altre anforenord-africane (Keay XXXV, XXXVI, LXII). Se sideve dare credito a questo tipo di informazione, lecampagne segestane erano in grado di produrre alme-no per il pieno soddisfacimento del fabbisogno inter-no, se non per la commercializzazione, come inveceera avvenuto nelle epoche precedenti. La scelta inse-diativa orientata sempre più verso siti di medie egrandi dimensioni pare da un lato indicare il definiti-vo abbandono del sistema della piccola proprietà infavore del latifondo, dall’altro forme di gestione assai
630
56 Cambi 1993 e Id. 2004; Cambi et alii 1994.57 Volpe 1996; sul territorio di Brindisi: Aprosio c.s. e Ead.
in questo volume.58 Bernardini et alii 2000, 111-112.
TIPO DIMENSIONI MATERIALI DA
COSTRUZIONE
ELEMENTI CARATTERIZZANTI CRONOLOGIA ATTIVITÀ RANGO LOCALIZZAZIONE
Frequentazione Noncalcolabili
Nessuno Pochi-pochissimi frammentifittili
Sempre Attività umane svolte Ovunqueal di fuoridell’abitato(concimazioni)
CASA 1 Da 10x10 a20x20
Laterizi, spezzonicalcarei, pietre,ciottoli di fiume.
Rari manufatti dilusso/importati; anfore greco-italiche e puniche (rare conorlo ad echino); vernice neralocale o siceliota; ceramicacomune (bacini con orlopendulo)
IV-I secoloa.C.
Numerosi pesi datelaio: grandediffusione dellapastorizia, consumodi carni, produzionedi lana.
Famiglia contadina Dintorni di Segesta
CASA 2 Da 20x20 a40x40
Frr. intonaco,elementiarchitettonici, opussigninum
Ceramiche importate, vasi damensa, anfore.
IV a.C.- Id.C.
Agricolturaspecializzata (vino,olio).
Epaulis. Mediaproprietà.
Terme Segestane e PoggioFegotto; corso del fiumeFreddo
VILLAGGIO Da 50 x 100a 200 x 200m
Laterizi, spezzonicalcarei, pietre,ciottoli di fiume.
Povertà dei manufatti,generalmente disposti achiazze sul terreno.
VI secoloa.C.-VIId.C.
Cerealicoltura,allevamento ovino
Pagus/Vicus/Statio/Mansio
Lontani da Segesta: PoggioFegotto, Margana, Pispisa,Pergole. Più diffusi nella partesettentrionale del territorio(Ponte Bagni, Angimbè, Costadi Ballo) e, a sud, in ContradaArcauso
CASA/TOMBA Laterizi (talvolta) Ceramica (pochissima) Sempre OvunqueTOMBA Da 5x5 a
10x10Frr. di lastre dicopertura
Ossa umane, lucerne,unguentari
Sempre Vario Ovunque
NECROPOLI 100x100 Spargimentocontinuo di tegole eceramica,caratterizzato damacchie di terra dicolore scuro
Ceramica bruciata, frr. di ossaumane, cenere
Sempre Vario Ovunque
3. - Territorio di Segesta. I criteri per la interpretazione delle principali categorie insediative.
complesse, fra le quali la cerealicoltura deve essereconsiderata assolutamente prevalente ma non ancoraesclusiva. Almeno per la media età imperiale, forse,non si può ancora parlare di identità fra latifondo emonocoltura cerealicola. La situazione del III secolod.C., stando alle parole di D. Vera, riflette una fram-mentazione che solo nel secolo successivo saràricomposta nel quadro del latifondo tardoantico 59.
Stando ai dati in nostro possesso 60, può forseessere smussata la visione decisamente pessimisticaformulata dalla storiografia degli anni Ottanta 61. Ilquadro relativo ad una stagnazione produttiva ed aduna emarginazione culturale che avrebbe caratteriz-zato la Sicilia nella prima e nella media età imperiale,conseguenza della marginalità politica nella quale l’i-sola effettivamente si trovava, può, in qualche misu-ra, essere temperato. La rinascita delle campagnesegestane in età tardoantica può quindi essere vistaalla luce di una ulteriore accelerazione di un processogià in atto da lungo tempo (almeno dal II secolo d.C.)e nel quale la consistenza demografica dei villaggigioca un ruolo fondamentale (fig. 4).
La Tarda Antichità
L’esistenza dei villaggi segestani, lungi dal potereessere considerata come pura sommatoria di soggettipuntiformi, va letta in un contesto differente, a un tem-
po più complesso e strategicamente concepito. Osser-vando la distribuzione dei siti nella valle del fiumeFreddo, si noterà come ai due estremi opposti si trovi-no due grossi centri rurali, tali da modificare radical-mente l’equilibrio dell’intero territorio. Si tratta del si-to di Contrada Rosignolo 62, a S, e di Ponte Bagni 63
(figg. 5 e 6), a N. La floridezza della maggior parte diquesti abitati non si esaurisce nella media età imperia-le ma prosegue nei secoli successivi (u ni ca eccezioneSG 177-178, Baglio Gallitello): Baglio Pietrarenosa(SG 198-199), Baglio Cardella ( SG 373), Stazione diAlcamo (SG 316), e nell’entroterra l’importante sitodi Contrada Arcauso, sorto in età classica e sempreabitato fino almeno al VI secolo, per poi essere dinuovo rioccupato alla metà del X.
La località at tuale di Ponte Ba gni è stata identifi-cata con la stazione di posta di Aquae Segestanae,citata dall’Itinerarium Antonini tra Par thenicum eDrepanum sulla via Valeria 64. L’area, sede in etàellenistica di un culto delle acque calde che ivi tutto-ra sgorgano e che alimentano un moderno istitutotermale, appare caratterizzata da uno sviluppo pro-gressivo a partire dalla prima età imperiale. Il sito èoggetto di una crescita sorprendente e improvvisaalla metà del IV secolo, momento al quale può esse-
631
59 D. Vera, in questo volume.60 Molinari, Neri 2004.61 Gabba 1982-83 e 1986; Clemente 1980-81; Coarelli
1980; Cracco Ruggini 1980 e 1982-83; Mazza 1980-81 e 1986,Carandini, Ricci, De Vos 1982.
62 I. Neri, in Bernardini et alii 2000, 116.63 Strabone (VI, 2, 9) ricorda le sorgenti di acqua calda,
«quelle di Egesta», che sarebbero state, fra l’altro, potabili.Plinio (n.h. 31, 61) ricorda semplicemente «le acque di Sege-sta». Fonti in Bernardini et alii 2000, 116-118.
64 I. Neri, in Bernardini et alii 2000, 117-121.
Località UT Dimensioni 500 400 300 200 100 0 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 950-1250Calemici 079 50x50
080 18x6081 12x8082 10x10083 15x10
Vallone Fusa 108 95x35C.da Scorciagatto 112 150x150Margana Soprana 158-160 100x100Baglio Gallitello 176-177-178 150x150Pietrarenosa 198-199 200x200
207 200x200AquaeSegestanae
209-219
AquaeSegestanae
220-229
ContradaAngimbè
247,248,249,254140x200
Costa di Ballo 270 250x200Calathamet 284 100x50Fagotto 303 35x30Contrada Pergole 308 250x50ContradaGiancaldara
31280x80
Stazione Alcamo 316Stazione Alcamo 317
373 80x40Canichiddeusi 410 62x50Costa di Pampina 427 100x60C.da Eredità 435-436ContradaRosignolo
439-455110x70
C.da Favarottella 464 32x50ContradaArcauso
64034x125
641 85x118643645UT 500 400 300 200 100 0 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 950-1250
4. - I villaggi del territorio segestano e le loro fasi cronologiche. In grigio chiaro sono indicate le fasi precedenti l’età impe-riale e le eventuali rioccupazioni.
re riferita la costruzione di numerosi edifici situati aidue lati della strada, tra i quali sicuramente unimpianto termale. L’insediamento cresce in manierasostanziale ma la situazione, con particolare riferi-mento al quadro generale, appare molto diversarispetto al secolo precedente: la dipendenza dallemerci alimentari esterne a partire dal IV secolo si fa
sempre più forte(fig. 7) 65. La pre-senza cospicua dianfore africane daderrate alimentari aRosignolo come adaquae Segestanae
indica che il tipo dicoltura praticatanelle campagneche facevano rife-rimento ai due vil-
laggi è cambiato: l’olio è ora importato in mas-sicce quantità dall’Africa settentrionale e non piùprodotto localmente.
Il borgo di Rosignolo, analogo ad Aquae Sege-
stanae se si pensa alle dimensioni dell’area dispargimento dei reperti archeologici e alla tipolo-gia dei materiali rinvenuti, ha come principale ca-ratteristica la nascita, dal nulla, al principio del IVsecolo (fig. 8). Sebbene non vi siano sorgenti diacqua calda, la cospicua presenza di tubuli fittiliper condutture idriche parrebbe indicare la pre-senza di un edificio termale. La possibilità che an-che in questo caso si tratti di una mansio non è poicosì remota in considerazione del fatto che non èmai stato localizzato con certezza il sito di ad Oli-
vam, l’ultima sosta citata dall’Itinerarium Anto-
nini lungo la strada da Agrigentum a Lilybaeum,generalmente posta nei pressi dell’attuale Sa-lemi 66. Le caratteristiche tipologiche del sito cor-risponderebbero a quel le di una stazione di posta,per confronto con aquae Segestanae e con l’unicoesempio fino ad ora scavato in Sicilia, cioè ilborgo di Sophiana 67. Nel caso di Rosignolo, tutta-via, occorre segnalare che l’eventuale identifica-zione con ad Olivam non è confortata dal com-puto delle miglia trasmesso dall’Itinerarium.
La necessità, cui sopra si è accennato, diimportare olio, potrebbe costituire un indizio ulte-
riore del passaggio definitivo ad un sistema latifondi-stico stavolta basato sulla monocoltura cerealicola,
632
65 Devo queste informazioni a Ilaria Neri, che ha studiato leceramiche di età imperiale raccolte nelle ricognizioni.
66 Molinari, Neri 2004.67 Bernardini et alii 2000, 118.
5. - Il sito delle aquae Segestanae (planimetria).
6. - Il sito delle aquae Segestanae (le anomalie riscontrate nellalet tura di una foto aerea).
logica conseguenza delle mutate condizioni politicheed economiche della Sicilia in seguito al passaggiodelle forniture granarie dell’Egitto da Roma aCostantinopoli nel 332 68. L’annessione all’Italiasuburbicaria aveva posto fine alla marginalità politicanella quale l’isola si era trovata per quattro secoli,rendendo il suo governatorato di nuovo attraente per
l’aristocrazia senato-ria, che ricominciò adinvestirvi capita li 69.Ciò che ad alcuni puòapparire come il segnodi un ritrovato interes-se da parte del poterecentrale per la piùantica provincia del-l’impero, è invece daconsiderare come ilforzato ricorso, comeun tempo, alle risorsegranarie dell’isola.
Il numero dellecase minori (tipo 1 e2) permane pressochéinvariato nella primametà del V secolo(fig. 9). Alcuni sitivennero ab ban donatimentre alcune caserioccuparono siti elle-nistici nell’area tra ilfiume Caldo e il fiumeFreddo (SG 287, 288,267, 243), in tor no alMonte Calemici (SG86), nella vallata ad Odel monte Pispisa (SG140), nel pianoro sottoCalathamet (SG 284)e in Contrada Cani-chiddeusi.
Questo apparenteritorno all’insedia-mento sparso ebbecomunque breve dura-ta, perché alla metàdel V secolo tutti que-sti piccoli insediamen-
ti vennero definitivamente e simultaneamente abban-donati. Una relazione con l’invasione di Gensericodel 440 pare poco probabile, sebbene il famoso passo
Segesta. I villaggi di età imperiale
633
68 Considerazioni di I. Neri, in Molinari, Neri, 2004.69 Vera 1996 e 1997-1998; Cracco Ruggini 1980.
11
8
9
2
3
1
3 3
6
2
0
2
4
6
8
10
12
Keay XXV Keay XXVI Keay XXXV Keay LIII Keay LVII Keay LXI Keay LXII Africana II Late Roman1
Late Roman2
7. - Aquae Segestanae: le relazioni mercantili viste attraverso le anfore (IV-VII secolo d.C.).
12
4
12
1 1 1
10
1
21
13
1
Keay XXV Keay XXVI Keay XXXV Keay XXXVI Keay LVII Keay LXI Keay LXII Keay LXXII Africana II Late Roman1
Late Roman2
Late Roman3
8. - Contrada Rosignolo. Le importazioni (inizi IV-fine VII secolo d.C.).
del Codex Theodosianus (VII, 13, 20) parli esplicita-mente di gravi devastazioni causate alle campagnesiciliane dalle scorrerie vandaliche, tali da indurreValentiniano III a esentare parzialmente dai tributi iproprietari terrieri che avevano subito i danni piùingenti 70. Gli insediamenti più importanti, fra i qualiAquae Segestanae e Rosignolo, non sembrano subirealcuna flessione in questo periodo, anzi la forza cen-tripeta da essi esercitata e il conseguente loro accre-scimento potrebbero giustificare l’abbandono deipiccoli siti periferici (fig. 10).
Aquae Segestanae, abitato del quale molto ci sa-rebbe da dire, anche considerando il suo ruolo nel de-finitivo abbandono della città di Segesta, il suggesti-vo toponimo, il rapporto con la via Valeria, rimasefiorente per tutto il VI secolo e cominciò a ridursi, al-meno nelle dimensioni dello spargimento di superfi-
cie, solo alla metà delVII secolo, come di-mostra la scarsitàdelle forme più tardedella Terra SigillataAfricana della pro-duzione D, larga-mente attestate inve-ce a Rosignolo. Lapresenza di alcuneceramiche altome-dievali sembrerebbeindicare la continuitàdell’insediamento –o almeno una sua fre-quentazione – anchenei secoli VIII-X, fi-no alla definitiva cri-si e all’abbandonoverificatosi presumi-bilmente agli inizidell’XI secolo, quan-do gli abitanti del-l’indifeso villaggiodi Aquae Segestanae
preferirono trasferir-si sulla vicina alturadi Calathamet 71.
L’abbandono di Rosignolo, alla fine del VII seco-lo, fu improvviso come la sua nascita, quasi 400 anniprima. I fossili guida offrono un orizzonte cronologi-co molto netto e preciso, essendo la quasi totalità deireperti datanti di provenienza africana: Terra SigillataAfricana D, anfore da derrate alimentari (olio o con-serva di pesce), ceramica comune (giare, bacini, mor-tai) con puntuali confronti in coevi contesti cartagi-nesi. La ceramica da fuoco e da cucina veniva inveceimportata da Pantelleria. Una produzione vinaria,magari destinata all’autoconsumo, doveva esistere,considerato il numero limitato di anfore orientali davino rinvenute sia ad Aquae Segestanae che a Rosi-gnolo. Sono stati rinvenuti tantissimi coppi ‘striati’,tipici della Sicilia tra V e VII secolo, attestati in molti
634
70 Vera 1996 e 1997-1998.
71 Lo studio del periodo altomedievale e medievale è curatoda Alessandra Molinari, che ringrazio per le sue delucidazioni(Molinari, in Molinari, Neri 2004).
9. - Il territorio di Segesta nella Tarda Antichità (IV-VI secolo d.C.).
altri siti nel nostro territorio (ma non ad aquae Sege-
stanae, per motivi che, al momento, sfuggono). La funzionalità di Rosignolo e di aquae Segesta-
nae come poli di riferimento per i centri minori è evi-dente: si trattava certamente dei grossi centri a cuifacevano capo le unità cellulari minori affidate aicoloni, nell’ambito del modello organizzativo dellatifondo di grande estensione, anche se queste sonocertamente di più difficile identificazione e localizza-zione, almeno nell’ambito di una normale ricognizio-ne 72. I villaggi e le stazioni di posta fungevano daluogo di smistamento dei prodotti del latifondo,erano sede di mercato e di scambio dove si acquista-vano attrezzi, sementi e prodotti di importazione. Ilsorgere dell’orizzonte dei villaggi indica che le cittàerano ormai da tempo tramontate insieme con ilmodello di insediamento e di vita da esse rappresen-tato.
Nell’ambito geografico siciliano, come in moltialtri, la guerra gotica sembra rappresentare uno spar-tiacque decisivo, vero momento di svolta fra la TardaAntichità e l’Altomedioevo. Dopo la metà del VIsecolo, con l’eccezione di aquae Segestanae, che sispegne progressivamente nel corso del VII secolo, edi Rosignolo, che conclude bruscamente alla fine
dello stesso secolo la suaesistenza, la vita nellecampagne segestane sem-bra languire e neanche ivillaggi sono più in gradodi conservare il loro ruolodi punto di riferimento.
Conclusioni
Una ricerca condottada A. Filippi nelle aree diAlcamo e poi di Erice e diTrapani 73 sembra portare aconclusioni simili. Comein tutta la Sicilia occiden-tale, anche nei comprenso-ri contermini a quello
segestano, gli esiti dell’affermazione dell’abitatosparso non si concretizzano prima della metà del IVsecolo a.C. Persistenze diacroniche degne di notasono da registrarsi, per gli insediamenti medio-gran-di, fino alla Tarda Antichità e talvolta oltre, fino al -l’età arabo-normanna. Anche ad Alcamo e ad Erice-Trapani, nella pri ma età imperiale, si assiste ad unaprima crescita degli abitati rurali, talvolta fino ai 4ettari di superficie, reiterata da una ulteriore espan-sione nella piena età tardoantica. Dalla valutazionedei primi risultati, largamente preliminari, di un’altraricerca in corso nel territorio confinante di Salemi,condotta dalla Soprintendenza di Trapani e dalla Uni-versità dell’Illinois 74, emergono dati, a mio avviso,molto attraenti, che ritengo utile riassumere nellatabella di seguito riprodotta (fig. 11).
Gli autori, adottando un atteggiamento molto pru-dente nei confronti delle loro scoperte, le classificanoseguendo parametri molto generali e utilizzandocategorie interpretative altrettanto generiche (villa,sito isolato, grande fattoria, casa rurale ecc.). I diciot-to siti di Salemi possono essere suddivisi, sulla basedelle aree, in quattro gruppi ascendenti, da ‘A’ a ‘D’.Comparando i parametri di questi dati con quellidella tabella dei siti della ricognizione segestana, si
Segesta. I villaggi di età imperiale
635
72 Neri, in Bernardini et alii 2000; Neri, in Molinari, Neri2004.
73 Filippi 2003.74 Kolb, Vecchio 2003.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
I sec. d.C. II sec. III sec. IV sec. V sec. VI sec. VII sec.
Casa 1 Casa 2 Villaggio
10. - Istogramma riassuntivo. Le tendenze insediative nel tempo.
ottiene una possibile griglia interpretativa. I nove sitidella classe ‘A’ possono essere riferiti a case rurali dicospicue dimensioni, con l’eccezione di una necropo-li. Nella categoria ‘B’ vi sono quattro siti interpreta-bili come villaggio di circoscritte dimensioni e unocome necropoli. Al di sopra dei due ettari si trovanotre siti di grandi dimensioni, interpretabili come vil-laggi del tipo più grande (villaggio 2).
Molti dei diciotto siti databili alla Tarda Antichitàrivestono inconfondibilmente l’aspetto del villaggio.Si tratta di insediamenti estesi per più di due ettari,talvolta anche quattro o sei. In molti casi sono statiregistrati materiali costruttivi di rango anche moltoelevato, che qualificano, dunque, abitati certamenterurali, non necessariamente rustici 75.
Per l’abitato localizzato in Contrada Conceria, trechilometri a SE di Salemi, esteso per più di trediciettari, la definizione di villaggio è, a mio avviso,troppo stretta. Nel caso in cui, per questo sito, fosseroconfermate tanto la frequentazione di lungo periodo(a partire dalle età arcaica o classica) quanto lastraordinaria estensione, si potrebbe anche comincia-re a pensare, in via del tutto congetturale, si intende,
se non dovesse esserelocalizzata qui la Haly-
ciae delle fonti, piuttostoche nel sito di San Mice-li a Salemi, seguendo latradizione 76.
L’entroterra imerese,altro ambito significati-vo, recentemente pubbli-cato da Oscar Belvede-
re 77, si presenta in un assetto piuttosto variegato. Intaluni scorci del territorio imerese si assiste in età tar-doantica ad una ripresa dell’insediamento sparso 78
che sembra sottintendere la scelta di un uso intensivodel suolo, da collegare a produzioni agricole specia-lizzate e a produzioni anforarie di una certa impor-tanza, come quelle di Termini Imerese 79. In altri, conparticolare riferimento alle aree interne e alle alturefra i fiumi Imera e Torto, si assiste invece ad una uni-voca concentrazione della popolazione in pochissimisiti, segno, questo, della formazione di un vastolatifondo incentrato sulla villa di Buonfornello 80.Evidentemente, all’interno dello stesso territorio edello stesso comprensorio potevano convivere realtàanche molto diverse e contrastanti: le colture specia-lizzate e l’organizzazione sparsa della massa fundo-
rum e il latifondo impostato sul saltus, che prevedeuna maggiore concentrazione della forza lavoro equindi il ricorso alla scelta preferenziale del villaggiocome luogo eletto della concentrazione.
Sul profilo del villaggio siciliano tardoantico con-tinua a pesare la scarsità della documentazionearcheologica, intesa come scavi in estensione condot-
636
75 Isidoro (Origines, 15, 2, 11), nell’intento di precisare iconcetti di vici et castella et pagi, vorrà specificare hi sunt quinulla dignitate civitatis ornantur, sed vulgari hominum con-ventu incoluntur et propter parvitatem sui maioribus civitati-bus adtribuuntur. Evidentemente la realtà è assai complessa.Un villaggio non è paragonabile alla città (gli difetta la digni-tas) ed è abitato da persone di rango inferiore e proprio per lasua piccolezza (e pochezza morale?) deve dipendere da cittàpiù grandi. Il vicus, in Isidoro (15, 2, 12), è un luogo abitatoformato solo da case, ovvero ha soltanto vie senza mura. Sitratta, infatti, di un agglomerato di case, sebbene siano dettivici anche gli edifici di una città. Poco dopo (15, 2, 14) siaggiunge: pagi sunt apta aedificiis loca inter agros habitanti-bus. Il pagus è dunque anche il luogo adatto alla costruzionedi case per chi abita in campagna. In questo caso l’allusione aluoghi classificabili come non-città, o addirittura liminari,appare quasi scontato. Purtuttavia, anche in assenza di una
dignitas civitatis, si tratta comunque di abitati caratterizzati dauna certa solidità (riferimento agli aedificia), certo non dipoche capanne sparse nei campi.
76 La localizzazione di Halyciae a Salemi, tradizionalmenteaccettata, si fonda su dati archeologici forti anche se non pro-banti. R. Wilson (1990, 145) non concorda sulla tradizionaleidentificazione dell’abitato antico con Salemi, ripreso da S.Storti (1997). Maurici (2003, 900-902) si limita a sintetizzarele diverse posizioni sul tema. I dati di cui disponiamo sono,per lo più, riferibili alla Tarda Antichità e all’Altomedioevo.La ricerca è in ogni caso da approfondire, tanto nell’area urba-na di Salemi quanto in Contrada Conceria.
77 Belvedere et alii 2002.78 Ivi, 393-394.79 Ivi, 395, n. 126.80 Alliata et alii 1988, 216.
Sito Superficie(in ha)
Località Interpretazione/funzioniindicati dagli autori
Categoria InterpretazioneProposta
S-147 0,2 Abbeveratoio 2 Sito isolato A Casa 2S-171 0,2 Contrada Le Rocche Casa rurale A Casa 2S-121 0,3 Vaniddotti 1 Necropoli A NecropoliS-123 0,6 Baglio Capo Feto Necropoli A NecropoliS-162 0,7 Contrada Mokarta 1 Parte di Villaggio A Casa 2S-164 0,7 Contrada Mokarta 3 Parte di villaggio A Casa 2S-165 0,7 Contrada Mueli 1 Sito isolato A Casa 2S-166 0,7 Al Corvo 2 Grande fattoria A Casa 2S-163 0,8 Contrada Mokarta 2 Parte di villaggio A Casa 2S-146 0,9 Abbeveratoio 1 Sito isolato A Villaggio 1S-167 1,2 Al Corvo Grande fattoria B Villaggio 1S-132 1,3 Ardigna Necropoli B NecropoliS-159 1,4 Casa Lambiasi Sito pluristratificato B Villaggio 1S-152 1,5 Casa Zizzo Sito di controllo B Villaggio 1S-135 2,2 Timpone di Grasti Sito isolato C Villaggio 2S-113 5.2 Giardino Grande Non specificato C Villaggio 2S-122 6,0 Vaniddotti 2 Grande villa C Villaggio 2S-112 13,5 Conceria Villa D Città
(Halyciae?)
11. - Gli insediamenti dell’area di Salemi (da Kolb, Vecchio 2003).
ti in siti ben conservati. Al momento il miglior esem-pio di villaggio noto archeologicamente della Siciliaimperiale resta quello di Contrada Sofiana 81. Altrocaso interessante di villaggio è il grande abitato sca-vato da Wilson in Contrada Campanaio (Agrigento),recentemente pubblicato 82. Il villaggio inizia la suavita attorno al 200 a.C. e conosce una serie di com-plesse ristrutturazioni. Fino al I secolo a.C. si trattaforse più di una grande casa rurale che di un villaggiovero e proprio ed è questo un tipo di evoluzione che,forse, è presente anche in ambito segestano. La vitadell’abitato attraversa il I, il II e il III secolo d.C. Conla fine del IV, si assiste ad un generalizzato incremen-to delle attività, alla costruzione di nuovi edifici eall’esordio di nuove attività manifatturiere (produzio-ni di olio, calce, ferro, tegole, mortai, anfore). Lafine, collocata attorno al 460, fu violenta (attaccovandalo?). Vi erano però, nella Sicilia tardoantica, leenergie per ricostruire e rivitalizzare un villaggiocosicché l’abitato riprese alla fine del V ed ebbe vitafino alla prima età bizantina. Il peso dell’impattodelle invasioni vandale sulle campagne siciliane èancora oggi da considerare controverso. Al momentova, in ogni caso, registrata la scomparsa simultaneadi tutti gli insediamenti più piccoli 83, un fatto, questo,che non toglie nulla al primato demografico dei vil-laggi ma che pare degno di attenzione. La sensibileflessione nella circolazione delle merci, in Siciliacome altrove, successivamente alla metà del V seco-lo, è ugualmente un dato significativo.
L’archeologia siciliana di età imperiale, malgradole prime, e superficiali, impressioni, non è poi cosìstridente nei confronti delle fonti. Il silenzio dellefonti scritte ha un rapporto di conseguenza moltostretto con l’assenza di due elementi chiave dellaromanizzazione: le reciproche diffusioni del modellourbano e del modello della villa. Il primo, comeabbiamo detto all’inizio anche sulla scorta delleosservazioni degli storici, dopo avere conosciutoun’intensa ripresa in epoca tardorepubblicana, appare
già con la primissima età imperiale addirittura in riti-rata. Il secondo, invece, all’indomani del complessoprocesso genetico collegato con la diffusione dell’è-
paulis, produce, di fatto, molto poco, dopo il II seco-lo a.C. L’assenza di senatori, di cavalieri e di tutto ilmondo che attorno a loro ruotava, comporta necessa-riamente che si debba fare a meno degli scritti cheessi, in altri ambiti geografici, come l’Italia centraletirrenica, hanno lasciato. Sarebbe tuttavia errato cre-dere che all’assenza di ville-senatori-fonti debbameccanicamente corrispondere una sorta di vuotototale. Anzitutto si conoscono casi fortunati di villag-gi citati dalle fonti anche se, spesso, poche indicazio-ni di carattere antiquario possono essere desunte sulfunzionamento dei villaggi, trattandosi di sintetichefonti geografiche o di fonti giuridiche 84. Inoltre il vil-laggio, pur essendo una categoria insediativa per suanatura caratterizzata da un livello basso di alfabetiz-zazione, è comunque presente dal punto di vista epi-grafico 85.
Le fonti attraverso le quali il villaggio trova unaforte espressione sono quelle archeologiche, non dirado scaturite dalla cristianizzazione. Si è accennatoal caso del sito di San Miceli a Salemi 86, con le suefasi monumentali che scandiscono il periodo compre-so fra la metà del IV e il VII. Altrove la cristianizza-zione appare più sfumata e difficile da inquadrareanche se non mancano segni, al momento poco piùche indizi, di una precoce diffusione del culto anchein ambito rurale. Non pochi sono, tuttavia, i problemi,anche di carattere epigrafico, connessi con la questio-ne 87. Il problema è che devono essere attivate nuovefonti e, soprattutto, nuovi sistemi di fonti e questo nonpuò prescindere dall’iniziativa di indagini stratigrafi-che ad ampio raggio nei villaggi tardoantichi.
Al momento ci limitiamo a suggerire un abbozzodel paesaggio così come può essere inquadrato attra-verso i villaggi. Se riprendiamo le glosse di Festo 88 edi Servio 89, ci pare di poter desumere che un ruoloimportante nei pagi (e nei vici?) fosse giocato dal-
Segesta. I villaggi di età imperiale
637
81 Bibliografia in Wilson 1990.82 Wilson 2000b.83 Neri, in Molinari, Neri 2004.84 Rinvio agli scritti di L. Capogrossi Colognesi 2002a e
2000b. 85 Calbi, Donati, Poma 1993.86 Cfr. da ultimo Maurici 2003, 900-902.
87 Secondo Manganaro (1993) la maggiore resistenza delgreco e la contemporanea estraneità del cristianesimo nei pagiva di pari passo con il predominante uso del latino e la precocecristianizzazione delle città.
88 ThLL X, 1, ad vocem. Secondo Festo (Paul. Fest. Lind-say 247, 221): pagi dicti a fontibus, quod eadem aqua uteren-tur; aquae enim lingua Dorica paga… appellantur.
89 Secondo Servio (Georg. 2, 382): pagi apÕ twn p“gwn
l’acqua e che un’importanza ancora maggiore l’aves-se il problema dell’approvvigionamento idrico. Inalcuni villaggi tardoantichi scavati altrove (Etruria,Apulia et Calabria), sorgevano cisterne talvoltaanche imponenti, che finivano per diventare il vero eproprio centro del villaggio 90. Quale significato sideve attribuire alla espressione pagi dicti a fontibus,
quod eadem aqua uterentur? Nel merito, dovrebbeessere aperta una discussione sul termine fons, chenon indica semplicemente la fonte. Il fons ha unavalenza molto ampia, spaziando da aspetti semplice-mente infrastrutturali per arrivare ad aspetti collegaticon la vita religiosa delle campagne (molti sono ifontes dedicati a questa o quella divinità in Italia, conparticolare frequenza alle Ninfe e ad Hercules) e saràinteressante indagare questo aspetto 91. Il tema delpagus e del fons potrebbe tuttavia non essere circo-scritto e spiegato semplicemente con la presenza diuna sorgente intesa come episodio topograficamentelocalizzato ma esteso ad un comprensorio geograficodi varia estensione. Se questa congettura avesse un
qualche fondamento, allora la eadem aqua cui si rife-riscono i commentatori tardoantichi potrebbe assu-mere una valenza molteplice. Da un lato aqua vaintesa nel senso di sorgente-fonte-fontana che soddi-sfa il fabbisogno idrico del villaggio e della comu-nità. Dall’altro, aqua potrebbe assumere un significa-to più estensivamente geografico e riferirsi al bacinoidrografico nel quale il villaggio si trova. Il pagus
finirebbe allora, per quanto riguarda l’ambito specifi-camente segestano, per connotare le diverse piccolevalli tributarie del fiume Freddo.
I due secoli successivi all’invasione vandalavanno inquadrati come una fase a sé stante, per moltiversi interlocutoria e da approfondire. Se, da un lato,si intravede il tramonto del paesaggio del latifondomaturo, realizzatosi fra i primi anni del IV e perdura-to fino alla metà del V, dall’altro molto è ancora dachiarire riguardo alla lunga continuità di vita di inse-diamenti come aquae Segestanae, Rosignolo, Stazio-ne di Alcamo e altri, che hanno, evidentemente, unafase a sé stante compresa fra la seconda metà del V etutto il VII secolo. In questo lungo arco cronologico,secondo tempi e modalità tutti ancora da definire, ilvillaggio siciliano o, forse, più modestamente, il vil-laggio segestano, è ancora il protagonista assoluto delpaesaggio circostante.
Franco Cambi
638
appellantur, id est a fontibus, circa quos villae consueveratcondi; unde et pagani dicti sunt, quasi ex uno fonte potantes.
90 Volpe 1994 e 1996, 156-160.91 Arnaldi 2000.
Alliata V., Belvedere O., Cantoni A., Cusimano G.,Marescalchi P., Vassallo S. 1988, Himera III.1. Pro-spezione archeologica nel territorio, Roma.
Ampolo C. (ed.) c.s., Ritorno a Segesta, Atti del Conve-gno, Pisa 2003, ANSNS.
Aprosio M. c.s., I paesaggi romani e medievali di Brin-disi.
Aprosio M., Cambi F., Molinari A. 1997, Segesta eCalatafimi tra la tarda antichità e i secoli centralidel medioevo, in Atti del Congresso della Societàdegli Archeologi Medievisti Italiani (Pisa, 29-31maggio), Pisa, 187-193.
Arnaldi A. 2000, La valenza salutare del culto di Fonsnella documentazione epigrafica dell’Italia romana,in Epigraphai. Miscellanea epigrafica in onore diLidio Gasperini, Ichnia, 5, Tivoli, 47-61.
Baldassari R., Fontana S. 2002, Anfore a Pantelleria:appunti per una storia economica dell’isola nell’an-tichità, in L’Africa romana, Atti del XIV Convegno
di Studio (Sassari, 7-10 dicembre 2000), vol. II,953-990.
Belvedere O. et alii (eds.) 2002, Himera III, 2. Prospe-zione archeologica nel territorio, Roma.
Bernabò Brea L., Cavalier M. (eds.) 2000, MeligunìsLipara X. Scoperte e scavi archeologici nell’areaurbana e suburbana di Lipari, Roma.
Bernardini S., Cambi F., Molinari A., Neri I. 2000, Ilterritorio di Segesta fra l’età arcaica e il Medioevo,in Nenci 2000 (vedi), 91-133.
Calbi A., Donati A., Poma G. (eds.) 1993, L’Epigrafiadel villaggio, Atti del Colloquio Borghesi (Forlì1990), Faenza.
Cambi F. 1993 Paesaggi d’Etruria e di Puglia, inCarandini A., Cracco Ruggini L., Giardina A. (eds.),Storia di Roma, 3.2. L’età tardoantica. I luoghi e leculture, Torino, 229-254.
Cambi F. 2001, Calabria romana. Paesaggi tardore-pubblicani nel territorio Brindisino, in Lo Cascio,Storchi Marino 2001 (vedi), 363-390.
Bibliografia
Segesta. I villaggi di età imperiale
639
Cambi F. 2003, Insediamenti ellenistici nella Siciliaoccidentale. Il caso segestano, in Quarte GiornateInternazionali di Studi sull’Area Elima (Erice,dicembre 2000), Pisa, 135-169.
Cambi F. 2004, Le campagne di Falerii e di Capenadopo la romanizzazione, in Patterson H. (ed.), Brid-ging the Tiber, Atti del Colloquio (Roma 1997), 75-101.
Cambi F. c.s., Segesta. I paesaggi della tarda età repub-blicana, in Ampolo c.s. (vedi).
Cambi F., Citter C., Guideri S., Valenti M. 1994, Etru-ria, Tuscia, Toscana. La formazione dei paesaggialtomedievali, in Francovich R., Noyé Gh. (eds.), Lastoria dell’altomedioevo italiano alla luce dell’ar-cheologia, Atti del Colloquio (Siena 1992), Firenze,183-215.
Camerata Scovazzo R. (ed.) 1996, Segesta I. La CartaArcheologica, Palermo.
Campagna L. 2000, Le anfore della necropoli in contra-da Portinenti (Proprietà Leone), in Bernabò Brea,Cavalier 2000 (vedi), 443-478.
Capogrossi Colognesi L. 2002a, Pagi, vici e fundi nel-l’Italia romana, Athenaeum, XC, 1, 5-48.
Capogrossi Colognesi L. 2002b, Persistenza e innova-zione nelle strutture territoriali dell’Italia romana,Napoli.
Carandini A. 1989, La villa romana e la piantagioneschiavistica, in Gabba E., Schiavone A. (eds.), Sto-ria di Roma, 4. Caratteri e morfologie, Torino, 101-200.
Carandini A. et alii 1997, La villa dell’Auditorium,Römischen Mitteilungen, 104, 117-148.
Carandini A., Ricci A., De Vos M. 1982, Filosofiana.La villa di Piazza Armerina, Palermo.
Cifani G. 1998, Caratteri degli insediamenti rurali nel-l’ager Romanus tra VI e III secolo a.C., BAR Int.Series, 718, II, Oxford, 53-57.
Cifani G. 2002, Notes on the rural landscape of centralThyrrenian Italy in the 6th-5th c. B.C. and its socialsignificance, JRA, 15, 247-260.
Clemente G. 1980-81, Considerazioni sulla Sicilia nel-l’Impero romano (III sec. a.C.), Kokalos, 26-27,192-219.
Coarelli F. 1980, Sicilia. Guida Archeologica, Roma-Bari.
Coarelli F., Torelli M. 1992(3), Sicilia. Guida archeolo-gica, Roma-Bari.
Corretti A., Capelli C. 2003, Entella. Il granaio elleni-stico (SAS 3). Le anfore, in Quarte Giornate Interna-zionali di Studi sull’Area Elima (Erice, dicembre2000), Pisa, 287-351.
Cracco Ruggini L. 1980, La Sicilia tra Roma e Bisan-zio, in Storia della Sicilia, 3, Napoli, 3-96.
Cracco Ruggini L. 1982-83, Sicilia, III/IV secolo: ilvolto della non città, Kokalos, 28-29, 477-515.
Crawford M.H. (ed.) 1986, L’impero romano e le strut-
ture economiche e sociali delle province, Bibliotecadi Athenaeum, 4, Como.
D’Andria F. 1997, Ricerche archeologiche sul teatro diSegesta, in Nenci 1997 (vedi), 429-450.
De Vido S. 1991, Appendice: fonti letterarie, epigrafi-che, numismatiche, in AA.VV., Segesta. Storia dellaricerca, parco e museo archeologico. Ricognizionitopografiche (1987-1988) e relazione preliminaredella campagna di scavo 1989, ASNP, S. III, XXI,929-994.
De Vido S. 2000, Città elime nelle Verrine di Cicerone,in Nenci 2000 (vedi), 389-435.
Denaro M. 1995, La distribuzione delle anfore ellenisti-co-romane in Sicilia (III sec. a.C.- III sec. d.C.),Kokalos, XLI, 183-208.
Di Stefano G. 2000, I recenti scavi di Camarina, in Unponte fra l’Italia e la Grecia, Atti del Simposio inonore di A. Di Vita, Padova, 194-212.
Facella A. 2003, Note di toponomastica latina nellaSicilia occidentale, Quarte Giornate Internazionalidi Studi sull’Area Elima (Erice, dicembre 2000),Pisa, 437-457.
Fentress E., Kennet D., Valenti I. 1986, A Sicilian Villaand its Landscape (Contrada Mirabile, Mazara delVallo), Opus, V, 75-96.
Filippi A. 2003, Indagini topografiche nel territorio diErice e Trapani, Quarte Giornate Internazionali diStudi sull’Area Elima (Erice, dicembre 2000), Pisa,497-506.
Gabba E. 1982-83, La Sicilia nel III-IV sec. d.C., Koka-los, 28-29, 71-85.
Gabba E. 1986, La Sicilia romana, in Crawford 1986(vedi), 1-85.
Gaggiotti M. 2002, Nuova luce sull’economia dellaSicilia romana, in L’Africa romana, Atti del XIVConvegno di Studio, (Sassari 2000), Roma.
Gebbia C. 2003, Cicerone e la utilitas Provinciae Sici-liae, Kokalos, XLV, 27-40.
Giglio R. (ed.) 2001, Mozia-Lilibeo. Un itinerarioarcheologico, Trapani.
Kolb M.J., Vecchio P. 2003, Siti dell’agro Salemitanotra tardoantico ed età bizantina, in Quarte GiornateInternazionali di Studi sull’area Elima, (Erice,dicembre 2000), Pisa, 839-846.
Lauter H. 1987, Les éléments de la “regia” hellénisti-que, in Levy 1987 (vedi), 345-358.
Lazzeretti A. 2000, Furti d’arte ai danni di privati nelleVerrine di Cicerone: le città, i derubati, le opered’arte, Kokalos, XLVI, c.s.
Lazzeretti A. 2002, Cic., In Verrem, actio secunda, IV(De Signis): Commento storico e archeologico, Tesidi Dottorato di Ricerca in Storia Antica (Storia poli-tica e culturale dell’Antichità classica), Universitàdegli Studi di Firenze, XIV ciclo.
Lévy E. (ed.) 1987, Le système palatial en Orient, enGrèce et à Rome, Strasbourg.
Liber Coloniarum, I, Gromat. Vet., 11.
Franco Cambi
640
Lo Cascio E., Storchi Marino A. (eds.) 2001, Modalitàinsediative e strutture agrarie nell’Italia meridiona-le in età romana, Atti del Convegno (Napoli, giugno1998), 363-390.
Manganaro G. 1993, Greco nei pagi e latino nelle cittàdella Sicilia “romana” tra I e VI secolo d.C., inCalbi, Donati, Poma 1993 (vedi), 343-594.
Marcone A. 1997, Storia dell’agricoltura romana,Roma.
Martini R. 1973, Il pagus romano nella testimonianza diSiculo Flacco, Istituto Lombardo di Scienze e Lette-re.
Massa S. 2004, Da Kossyra a Pantelleria. Archeologiadel paesaggio dalla conquista romana alla conqui-sta araba, Tesi di Dottorato di Ricerca, UniversitàCattolica del Sacro Cuore, Milano, inedita.
Maurici F. 2003, Sicilia bizantina: il territorio dellaprovincia di Trapani dal VI al IX secolo, in QuarteGiornate Internazionali di Studi sull’Area Elima(Erice, dicembre 2000), Pisa, 885-931.
Mazza M. 1980-81, Economia e società nella Siciliaromana, Kokalos, 26-27, 292-358.
Mazza M. 1986, La fatica dell’uomo. Schiavi e liberinel mondo romano, Catania.
Michelini C. 2000, Il patrimonio artistico siciliano dialcune poleis siceliote nel De Signis ciceroniano, inNenci 2000 (vedi), 777-808.
Molinari A. 1997, Segesta 2. Il castello la moschea,Palermo.
Molinari A., Neri I. 2004, Dall’età tardo-imperiale alXII secolo, in Molinari A. (ed.), La Sicilia islamica,Atti del Convegno (Roma 2001), MEFRM, 116, 1,109-127.
Monti A. 2002, Ricognizioni e GIS a Pantelleria. Inse-diamento e strutture del territorio in età tardopuni-ca: un primo modello interpretativo, in L’Africaromana, Atti del XIV Convegno di Studio, (Sassari2000), Roma-Bari, vol. II, 935-942.
Nenci G. 1991, Florilegio epigrafico segestano, inAA.VV., Segesta. Storia della ricerca, parco emuseo archeologico. Ricognizioni topografiche(1987-1988) e relazione preliminare della campa-gna di scavo 1989, AnnPisa, S. III, XXI, 920-929.
Nenci G. (ed.) 1997, Seconde Giornate Internazionalidi Studi sull’area Elima, Atti del Convegno (Gibel-lina 1994), Pisa-Gibellina.
Nenci G. (ed.) 2000, Terze Giornate Internazionalidi Studi sull’area Elima, Atti del Convegno (Ghi-
bellina-Erice-Contessa Entellina 1997), Pisa-Gibellina.
Pace B. 1958, Arte e civiltà della Sicilia antica, I,Roma-Napoli.
Paoletti M. 2003, Verre, gli argenti e la cupiditas delcollezionista, in Quarte Giornate Internazionali diStudi sull’Area Elima (Erice, dicembre 2000), 999-1027.
Pesando F. 1989, La casa dei Greci, Milano. Pinzone A. 1999a, Provincia Sicilia. Ricerche di storia
della Sicilia romana da Gaio Flaminio a GregorioMagno, Catania.
Pinzone A. 1999b, L’immigrazione e i suoi riflessi nellastoria economica e sociale della Sicilia del II sec.a.C., in Origine e incontri di culture nell’antichità,Atti del Convegno, (Messina 1996), Pelorias, 4,Messina, 381-402.
Pinzone A. 2000, La romanizzazione della Sicilia occi-dentale in età repubblicana, in Nenci 2000 (vedi),849-878.
Smith S., Serrati J. (eds.) 2000, Sicily from Aeneas toAugustus, Edinburgh.
Storti S. 1997, Il problema di Alicie, in Nenci 1997(vedi), 1287-1296.
Vandermersch C. 1994, Vins et amphores de GrandeGrèce et de Sicilie, IV-III s. av. J.C., Naples.
Vera D. 1996, Augusto, Plinio il Vecchio e la Sicilia inetà imperiale, in “Da Akragas ad Agrigento”, Attidel Colloquio (Palermo, 28 ottobre 1996), Kokalos,42, 31-57.
Vera D. 1997-1998, Fra Egitto e Africa, fra Roma e Co-stantinopoli, fra annona e commercio: la Sicilia nelMediterraneo tardoantico, Kokalos, 43-44, 33-73.
Volpe G. 1990, La Daunia nell’età della romanizzazio-ne, Bari.
Volpe G. 1994, Per pagos et vias. Un sito di età tar-doantica lungo l’Appia nell’ager Brundisinus, inMarangio C., Nitti A. (eds.), Scritti di antichità inonore di Benita Sciarra Bardaro, Fasano, 69-80.
Volpe G. 1996, Contadini, pastori e mercanti nell’Apu-lia tardoantica, Bari.
Wilson R.J.A. 1990, Sicily under the Roman Empire,Warminster.
Wilson R.J.A. 2000a, Ciceronian Sicily: an archaeologicalperspective, in Smith, Serrati 2000 (vedi), 134-160.
Wilson R.J.A. 2000b, Rural Settlement in Hellenisticand Roman Sicily: excavation at Campanaio (AG),1994-98, BSR, 68, 337-370.