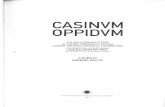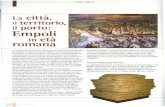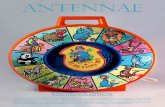L'adolescenza e la perdita di un genitore in età evolutiva
-
Upload
uninettuno -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of L'adolescenza e la perdita di un genitore in età evolutiva
86 Psichiatria dell ’infanzia e dell ’adolescenza (2013), vol. 80: 86-104
L’adolescenza e la perdita di un genitorein età evolutiva. Uno studio longitudinalein un campione di ragazzi dagli 11 ai 16 anni
Early Parental Loss and psychological functioning.A longitudinal study in a sample of subjects from11 to 16 years of age
Gianluigi Monniello*, Silvia Cimino**, Luca Cerniglia***,Giulia Ballarotto****, Laura Polito*****
Summary Th e present longitudinal study, about the loss of a parent during childhood as a
traumatic experience, is the continuation of a previous research (Cimino, Monniello, Sinesi,
2012) and has the purpose of evaluating the possible change in the overall psychological func-
tioning from pre-adolescence period to adolescence in a non referred sample, investigating the
impact of the loss of a signifi cant caregiver (mother or father) occurred in childhood on the cur-
rent psychological profi le. Th ree specifi c samples are assessed in this study: 1) subjects who had
lost a signifi cant caregiver during the fi rst three years of life; 2) subjects who had the same loss
experience when they were between three and ten years old; 3) a control sample composed of
subjects who didn’t experience any kind of parental loss. We have administered three self-report
questionnaires: 1) SCL-90-R (Derogatis et al., 19739; 2) EAT-40 (Garner, Garfi nkel,1979);
3) A-DES (Armstrong et al., 1990. Moreover, as regards to the fi rst two groups the surviving
parent was also given the SCL-90-R. Th e results show that there is a signifi cant decrease in
the scores reported by children in the transition from pre-adolescence to the mid-late adolescence.
Children who have suff ered the loss of a caregiver within the fi rst 3 years of life, however, con-
tinue to report higher scores than the other two groups. In addition, research has shown that
parental psychopathology signifi cantly predicts SCL-90-R scores of sons.
Key words Bereavement during childhood – Adolescence – Eating disorders – Dissociative
experiences – Psychological functioning.
* Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile, Sapienza Università di Roma.** Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Sapienza Università di Roma.*** Dottore di Ricerca in Psicologia Dinamica, Clinica e dello Sviluppo, Università Telematica
Internazionale Uninettuno, Roma.**** Dottore in Psicologia, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Sapienza Università
di Roma.***** Medico Chirurgo, Frequentatore scientifi co, Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria
Infantile, Sapienza Università di Roma.
L’ADOLESCENZA E LA PERDITA DI UN GENITORE IN ETÀ EVOLUTIVA 87
Numerosi studi suggeriscono che, per i soggetti in età evolutiva, la perdita di un genitore provochi un impatto rilevante su numerosi aspetti del loro funzionamen-to aff ettivo1, cognitivo e comportamentale (Akerman, Statham, 2011). Molti studi hanno dimostrato che i soggetti in età evolutiva che hanno perso un genitore nella loro infanzia presentano un maggior numero di diffi coltà di adattamento e proble-mi psicopatologici rispetto ai coetanei che non hanno subìto questa esperienza. Tali soggetti mostrano un aumento di stati emotivi come paura, aggressività, depressione, somatizzazione, sintomi ossessivo-compulsivi e problemi scolari (Cerel et al., 2006; Melhem et al., 2008), così come una diminuita autoeffi cacia (Balk, Corr, 2001) e sintomi traumatici (Nader, 1997). In un recente studio Rolls e Payne (2007) hanno valutato bambini e adolescenti che avevano perso un genitore, riscontrando comples-se diffi coltà emotive e sociali, tra cui la diffi coltà a gestire i propri sentimenti, senso di isolamento, problemi scolastici ed emozioni di timore verso il genitore superstite. La sintomatologia dei soggetti in età evolutiva è però diff erente in base alla fase di sviluppo in cui si trovano: alcune ricerche mostrano infatti che depressione e senso di colpa sono presenti maggiormente nell’adolescenza rispetto all’età infantile (Weller et al., 1991; Cheifetz, Stavrakakis, Lester, 1989). Inoltre alcuni Autori hanno asso-ciato quest’esperienza vissuta nell’infanzia con la comparsa della depressione in età adulta (Kendler et al., 2002). Altri studi non hanno però trovato queste diff erenze di adattamento psicologico fra bambini e adolescenti che hanno aff rontato il lutto dei genitori ed un campione di controllo (Siegel, Karus, Raveis, 1996). Tutto ciò suggerisce che non tutti i soggetti in età evolutiva che hanno subìto quest’esperienza riportano delle problematiche: sicuramente una varietà di fattori, come la struttura della famiglia, il funzionamento psicologico del genitore rimasto e la natura della morte del genitore, possono infl uire sulla regolazione emotiva di un bambino o di un adolescente che ha subìto un lutto, negli anni successivi alla perdita.
Per quanto riguarda il soggetto in età evolutiva, bisogna considerare che la perdita di un genitore ha un impatto diff erente in relazione all’età e alla fase di sviluppo in cui avviene quest’esperienza e vi sono varie risposte che egli può manifestare di fronte a tale perdita (Abdelnoor, Hollins, 2004; Ratnarajah, Schofi eld, 2007). Le capacità di far fronte a tale evento si presentano tanto più adeguate quanto maggiore è l’età in cui avviene la perdita e l’attivazione di strategie resilienti e adattive si collega alla presenza di ulteriori fi gure di accudimento con cui il minore aveva stabilito forti ed intensi legami precedenti la perdita (Haine et al., 2008).
Numerosi studi retrospettivi su soggetti psichiatrici adulti, comunque, riportano eventi di perdita di un genitore avvenuti durante l’infanzia (Zanarini et al., 1989).
La letteratura scientifi ca che ha approfondito gli esiti sullo sviluppo della perdita di un genitore in età infantile non ha però distinto in dettaglio le fasi specifi che in cui
1 Il termine affetto è qui inteso nell’accezione psicodinamica che descrive l’espressione quali-tativa della quantità di energia pulsionale. In questa ottica metapsicologica esso è sempre legato a una rappresentazione psichica. Distinguiamo questo concetto da quello di emozione, utilizzato nel più vasto ambito psicologico, che può essere descritta come una reazione da uno stimolo ambi-entale che provoca una modificazione a livello somatico, vegetativo e psichico ( J. Laplanche e J.B. Pontalis, Enciclopedia della psicoanalisi, vol. 1, Bari, Laterza, 2005).
88 G. MONNIELLO - S. CIMINO - L. CERNIGLIA ET AL.
è avvenuta tale esperienza di lutto (ad esempio la prima o la seconda infanzia) e si è concentrata poco sui possibili esiti di questo evento durante l’adolescenza, fase evolu-tiva in cui il ragazzo deve far fronte a numerosi compiti e deve allontanarsi dalle fi gure di attaccamento, al fi ne di sviluppare una propria identità autonoma. Luecken et al. (2009) sottolineano come quest’esperienza potenzialmente traumatica vissuta nell’in-fanzia abbia notevole infl uenza sul distress individuale percepito durante l’adolescenza.
Blos (1989) inoltre sottolinea come l’entrata nell’adolescenza porti in primo piano la rielaborazione e la gestione dei traumi infantili, cioè di esperienze che sono state vissute dal soggetto come soverchianti e che devono essere integrate nell’Io. In questo senso sembra che una perdita molto precoce, in una fase della vita in cui il bambino ha rilevanti diffi coltà di elaborare un evento di lutto, abbia un’infl uenza molto più negativa sul funzionamento psicologico rispetto allo sperimentare una perdita nella seconda infanzia in cui il minore ha a sua disposizione una gamma molto più diver-sifi cata di strumenti cognitivi ed aff ettivi.
Alcuni studi hanno evidenziato, nei ragazzi che hanno perso la madre nell’infan-zia, comportamenti aggressivi, delinquenziali, problemi scolastici, rabbia, ipocondria, identifi cazione con la persona deceduta (Dowdney et al., 1999; Dowdney, 2000; Dra-per, Hancock, 2011). Tali comportamenti possono interferire con l’adempimento dei compiti di sviluppo tipici di questa fase evolutiva.
Per quanto riguarda le variabili della rete sociale del bambino dobbiamo consi-derare che questo evento infl uenza ogni membro della famiglia e la famiglia nel suo complesso. Le modalità con cui il genitore superstite aff ronta la perdita del proprio partner infl uenza le modalità di elaborazione del lutto utilizzate dai propri fi gli (Kir-win, Hamrin, 2005) ed il loro adattamento alla vita (Saldinger, Porterfi eld, Cain, 2004). Il genitore in lutto può avere diffi coltà a gestire i propri sentimenti di perdita e il dolore, compromettendo il suo ruolo genitoriale; si può sentire soverchiato dalle responsabilità che si trova a sostenere, così da non riuscire a sostenere le aumentate necessità del bambino (Auman, 2007) e spesso amici e familiari sono concentrati a confortare il coniuge rimasto, lasciando che siano i bambini a superare questa fase da soli. Madigan e collaboratori (2006) hanno inoltre sottolineato che il genitore superstite può non essere in grado di elaborare nel tempo il lutto subìto sperimen-tando diffi coltà emotive che possono infl uenzare negativamente gli scambi aff ettivi e relazionali con i propri fi gli anche molti anni dopo la perdita del partner. Molti autori hanno parlato a questo proposito di scarsa capacità materna di monitorare l’esperien-za emotiva del fi glio a causa di pensieri ed emozioni legati alle esperienze non risolte che limitano l’interazione attuale con il proprio fi glio (Out, Bakermans-Kranenburg, Van IJzendoorn, 2009). Inoltre Weller et al. (1991) hanno riscontrato che soggetti in età evolutiva che hanno perso la fi gura paterna riportavano un maggior numero di sintomi depressivi rispetto ai soggetti della stessa età che avevano perso la fi gura ma-terna. La letteratura scientifi ca riporta però dati contrastanti al riguardo: due recenti studi (Kalter, 2002; Raveis, Siegel, Karus, 1999), infatti, hanno valutato i sintomi depressivi in bambini che avevano perso un genitore, non riscontrando diff erenze signifi cative nella sintomatologia tra bambini che avevano perso il padre e bambini che avevano perso la madre.
L’ADOLESCENZA E LA PERDITA DI UN GENITORE IN ETÀ EVOLUTIVA 89
Dowdney (2000) rileva che, quando sono presenti adeguati fattori di protezione, solo un soggetto su cinque che ha sperimentato la perdita di un genitore nell’infanzia mantiene nel tempo una sintomatologia tale da giustifi care un invio ai servizi specia-listici. Considerando quindi la letteratura scientifi ca in questo campo e la diffi coltà di ottenere dati chiari sull’impatto della perdita precoce di un genitore nel corso dell’età evolutiva, abbiamo condotto uno studio longitudinale, che si basa su una precedente ricerca (Cimino, Monniello, Sinesi, 2012), al fi ne di valutare il passaggio dalla fase pre-adolescenziale a quella adolescenziale in ragazzi che hanno avuto esperienze di perdita nell’infanzia, approfondendo i cambiamenti nel tempo delle caratteristiche del profi lo emotivo e adattivo dei ragazzi e il profi lo psicologico del genitore rimasto.
È utile ricordare che il periodo della pre-adolescenza costituisce una fase di svi-luppo particolarmente complessa in cui il funzionamento psicologico del ragazzo è instabile e mutevole, tanto che eventuali indici di funzionamento disadattivo devono essere interpretati clinicamente con cautela poiché potrebbero essere temporanei e non caratteristici del soggetto in fasi di sviluppo successive (Steele, Malchiodi, Ku-ban, 2008; Cimino, Monniello, Sinesi, 2012).
Nella precedente ricerca (Cimino, Monniello, Sinesi, 2012) era stato valutato il funzionamento psicologico globale in un campione di pre-adolescenti non referred, studiando l’impatto della perdita di un caregiver signifi cativo (la madre o il padre) av-venuta nell’infanzia sul profi lo psicologico attuale. Il campione esaminato dagli Au-tori era stato suddiviso in tre sottocampioni: 1) soggetti che hanno vissuto la perdita di un genitore nei primi tre anni di vita; 2) soggetti che hanno vissuto la perdita fra i tre ed i dieci anni; 3) soggetti che non hanno sperimentato alcuna perdita genitoriale. I risultati di questo studio suggeriscono che i ragazzi che hanno sperimentato il lutto di un genitore nei primi tre anni di vita presentano un funzionamento psicopatologi-co in diverse aree, tra cui in particolare i comportamenti alimentari disfunzionali e la sperimentazione di vissuti dissociativi. Questo gruppo di pre-adolescenti ha eviden-ziato un rischio molto signifi cativo di stabilizzarsi all’interno di un funzionamento psicologico disadattivo.
Obiettivo del lavoro
Il presente contributo di ricerca si è posto l’obiettivo di mettere in luce le diff eren-ze signifi cative che si riscontrano nel passaggio dalla fase pre-adolescenziale a quella adolescenziale in soggetti che hanno perso un genitore nella prima infanzia. La va-lutazione del funzionamento emotivo-adattivo dei ragazzi ha preso in esame, speci-fi catamente, le esperienze dissociative, i comportamenti alimentari inappropriati e l’eventuale presenza di un profi lo psicopatologico. Inoltre è stato studiato il profi lo psicologico del genitore rimasto in vita.
In particolare, questo studio si è proposto di:1. valutare se i punteggi dei ragazzi agli strumenti di valutazione empirica variano
al variare dell’età, tenendo in considerazione le variabili genere, perdita del padre o della madre e perdita avvenuta nella prima o nella seconda infanzia;
90 G. MONNIELLO - S. CIMINO - L. CERNIGLIA ET AL.
2. valutare se il profi lo emotivo-adattivo dei ragazzi varia in funzione dell’SCL-90-R dei genitori.
Soggetti e Metodi
Gli stessi soggetti dello studio di Cimino, Monniello e Sinesi (2012), sono stati contattati ed è stata proposta loro la prosecuzione della ricerca, nella quale ci siamo prefi ssi l’obiettivo di valutare i cambiamenti del funzionamento emotivo-adattivo dei ragazzi nel passaggio dalla fase evolutiva pre-adolescenziale a quella adolescenzia-le. Inoltre, per quanto riguarda i primi due sotto-campioni, è stato somministrato l’SCL-90-R anche al genitore rimasto in vita, al fi ne di valutare se i punteggi degli adolescenti fossero predetti da quelli del caregiver.
Nella Tabella 1 sono descritti sia i soggetti appartenenti al primo studio (Cimino, Monniello, Sinesi, 2012) sia quelli appartenenti allo studio attuale, reperiti grazie alla collaborazione di Istituti scolastici pubblici e privati del territorio laziale. Il campio-ne del presente studio risulta numericamente inferiore a quello del primo lavoro, in quanto alcuni soggetti hanno scelto di non partecipare.
Tutte le famiglie dei ragazzi che hanno partecipato allo studio appartengono ad uno status socio-economico medio (Hollingshead, 1975). Inoltre, tutti i ragazzi che hanno partecipato alla ricerca hanno compilato i questionari in forma anonima pre-vio consenso informato da parte delle famiglie.
Tabella 1. Soggetti dello studio longitudinale [che include lo studio Cimino, Monniello e Sinesi,
(2012) e il presente studio] suddivisi in tre gruppi di studio: soggetti che hanno subìto una perdita
genitoriale nei primi 3 anni di vita; soggetti che hanno subìto una perdita genitoriale fra i 3 ed i
10 anni di vita; soggetti che non hanno vissuto alcuna perdita genitoriale.
Gruppo di studio
Campione tempo 1 (pre-adolescenza) Campione tempo 2 (adolescenza)
numerosità età in anni genere numerosità età in anni genere
esperienza di perdita nei primi 3 anni di vita
N=38media= 12,47
ds=1,08
17 maschi 21 femmine
N=33media=16,33
ds=0,7416 maschi
17 femmine
esperienza di perdita tra i 3 ed i 10 anni di
vita
N=39media=12,41
ds=1,1118 maschi
21 femmineN=31
media=16,19 ds=0,75
15 maschi 16 femmine
nessuna esperienza di perdita
N=40media=12,37
ds=1,0720 maschi
20 femmineN=32
media=16,22 ds=0,71
16 maschi 16 femmine
L’ADOLESCENZA E LA PERDITA DI UN GENITORE IN ETÀ EVOLUTIVA 91
Gli strumenti utilizzati sono i seguenti:a) La Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R) (Derogatis, Lipman, Covi, 1973) è un
questionario self-report che è stato somministrato nel presente studio ai soggetti in età evolutiva e al genitore superstite e che fornisce una misura standardizzata dello sta-tus psicologico e/o psicopatologico attuale di un individuo, applicabile a popolazioni normali o psichiatriche di adulti e adolescenti. La SCL-90-R permette di ottenere un ampio spettro di informazioni sull’esperienza soggettiva attuale di benessere e/o di disagio psicologico, consentendo di eff ettuare screening sia in ambito clinico che di ricerca. I punteggi ottenuti sono interpretati sulla base di 9 dimensioni primarie: 1) Somatizzazione, 2) Ossessione compulsione, 3) Sensibilità interpersonale, 4) Depressione, 5) Ansia, 6) Ostilità, 7) Ansia fobica, 8) Ideazione paranoide, 9) Psicoticismo. Inoltre, sulla base di tre Indici Globali (Global Severity Index, Positive Symptom Distress Index, Positive Symptom Total), la SCL-90-R fornisce il livello di gravità e l’ampiezza del di-stress psicologico individuale relativo alle nove dimensioni primarie misurate. Questo strumento può anche evidenziare cluster di sintomi associati a specifi che condizioni psicopatologiche (ad es., disturbi aff ettivi e di personalità). La coerenza interna della versione italiana, testata su un campione di adolescenti e di adulti, è soddisfacente (coeffi ciente alpha compreso tra 0.70 e 0.96) e il cut-off clinico è risultato pari ad 1 (Prunas, 2012).
b) L’Eating Attitude Test (EAT-40) è un questionario di autovalutazione costruito da Garner e Garfi nkel (1979; 1982) che nel presente studio è stato somministrato ai ragazzi. È un test utile per la valutazione clinica di comportamenti alimentari abnormi e, in particolare, dell’anoressia mentale (Cuzzolaro, Petrilli, 1988). In ripe-tute ricerche ha sempre dimostrato la sua attendibilità e validità, sia nella versione integrale che in quella ridotta, l’EAT-26. La versione integrale è composta da 40 item con una scelta fra sei risposte per ogni item; fornisce un punteggio totale e tre punteggi parziali suddivisi in tre sottoscale: Digiuno (D), Bulimia e preoccupazione per il cibo (B), Controllo orale (CO). Un punteggio totale elevato indica insoddisfazione per la propria immagine corporea, desiderio di magrezza, preoccupazione per l’eff etto negativo dei comportamenti alimentari sul peso e rigido auto-controllo sull’alimen-tazione. Lo strumento presenta una soddisfacente attendibilità (coeffi ciente alpha da 0.79 a 0.94), è stato validato su un campione di pazienti adulti con diagnosi di ano-ressia nervosa, ed è spesso utilizzato per rilevare la presenza di disturbi alimentari in popolazioni non-cliniche. Da studi di validazione, il cut-off clinico è risultato pari a 30 (Garner, Garfi nkel, 1980). Punteggi superiori al cut-off indicano la presenza molto probabile di sintomi del Disturbo del Comportamento Alimentare (DCA) ma non implicano, necessariamente, una diagnosi di anoressia nervosa o di bulimia nervosa. Infatti l’EAT-40 non ha capacità diagnostiche, ma è prezioso come strumento di screening in ricerche epidemiologiche ed è utile come strumento clinico di valutazio-ne della gravità dei sintomi e del loro andamento nel tempo.
c) L’Adolescent Dissociative Experiences Scale (A-DES) (Armstrong et al., 1997) è un questionario self-report composto da 30 item su scala Likert a 11 punti, sommi-nistrato a soggetti tra gli 11 e i 18 anni; nel presente studio è stato somministrato ai soggetti in età evolutiva. Lo strumento indaga quattro aree specifi che: a) Amnesia
92 G. MONNIELLO - S. CIMINO - L. CERNIGLIA ET AL.
dissociativa; b) Coinvolgimento immaginativo e assorbimento; c) Infl uenza passiva; d) Depersonalizzazione e derealizzazione. Punteggi elevati indicano un livello patologico di dissociazione e giustifi cano un’ulteriore indagine. Vediamo quindi come anche questo strumento non venga utilizzato per scopi diagnostici, ma di screening. La A-DES presenta una buona coerenza interna (coeffi ciente alpha=0.93) e una buona stabilità al test-retest (r = 0,91) (Zoroglu et al., 2002). La A-DES è stata validata su un campione di adolescenti con sviluppo tipico tra i 12 e i 17 anni e il cut-off clinico è risultato pari a 4 (Smith, Carlson, 1996).
Risultati
Utilizzando l’ANOVA a misure ripetute, abbiamo valutato l’andamento dei pun-teggi agli strumenti di valutazione empirica considerando come fattore entro i sog-getti (within) il tempo trascorso fra le due somministrazioni e come fattori tra i sog-getti (between) l’appartenenza ai diversi sotto-campioni, la perdita del padre o della madre ed il genere dei soggetti.
Valutazione del cambiamento dello status psicologico e/o psicopatologico dei soggetti dal-la preadolescenza all ’adolescenza.
Per quanto riguarda i punteggi al test SCL-90-R, sono state evidenziate diff eren-ze signifi cative per quanto riguarda il GSI, Global Severity Index (eff etto del fattore tempo: F=14,040 gdl=1; p<0,001; eff etto del fattore tempo per sotto-campione di appartenenza: F=4,31; gdl=1; p<0,05), il Positive Symptom Total (eff etto del fattore tempo: F=17,502; gdl=1; p<0,001) e il Positive Symptom Distress Index (eff etto del fattore tempo: F=7,39; gdl=1; p<0,01; eff etto del fattore tempo per sotto-campione di appartenenza: F=11,469; gdl=1; p<0,01).
Nel particolare, le diff erenze signifi cative riguardano le medie nei punteggi alle sottoscale Ossessione compulsione (eff etto del fattore tempo: F=5,697; gdl=1; p<0,05), Depressione (eff etto del fattore tempo: F=15,14; gdl=1; p<0,001; eff etto del fattore tempo per sotto-campione di appartenenza: F=11,236; gdl=1; p<0,01), Ansia (ef-fetto del fattore tempo: F=5,099; gdl=1; p<0,05), Ostilità (eff etto del fattore tempo: F=5,885; gdl=1; p<0,05), Ansia fobica (eff etto del fattore tempo: F=14,943; gdl=1; p<0,001; eff etto del fattore tempo per sotto-campione di appartenenza per tipo di perdita per genere: F=5,222; gdl=1; p<0,05), Ideazione paranoide (eff etto del fattore tempo: F=7,051; gdl=1; p<0,01; eff etto del fattore tempo per sotto-campione di ap-partenenza: F=8,059; gdl=1; p<0,01), Psicoticismo (eff etto del fattore tempo: F=7,420; gdl=1; p<0,01) e Sensibilità interpersonale (eff etto del fattore tempo per campione: F=20,14; gdl=1; p<0,001).
È interessante sottolineare che i soggetti che superano il cut-off del GSI sono così distribuiti:
1) nel primo sotto-campione tutti i 38 soggetti esaminati nella prima sommini-strazione e tutti i 33 soggetti esaminati nella seconda;
L’ADOLESCENZA E LA PERDITA DI UN GENITORE IN ETÀ EVOLUTIVA 93
2) nel secondo sotto-campione 6 soggetti dei 39 valutati nella prima sommini-strazione e 3 soggetti dei 31 esaminati nella seconda;
3) nel terzo sotto-campione 22 soggetti dei 40 esaminati nella prima sommini-strazione e 17 soggetti dei 32 valutati nella seconda.
Nella Figura 1 possiamo vedere le diff erenze fra le medie dei tre indici principali per quanto riguarda l’SCL-90-R.
Figura 1. Diff erenze fra le medie dei tre indici principali dell ’SCL-90-R
nelle due somministrazioni (pre-adolescenza e adolescenza).
Valutazione della variazione dei comportamenti alimentari disadattivi dalla pre-ado-lescenza all ’adolescenza.
Per quanto riguarda i comportamenti alimentari disadattivi invece, sono state evi-denziate diff erenze fra le medie dei punteggi totali al test (eff etto del fattore tempo: F=8,957; gdl=1; p<0,01; eff etto del fattore tempo per sotto-campione di appartenen-za: F=9,274; gdl=1; p<0,01). In particolare, le diff erenze signifi cative riguardano le medie dei punteggi nelle sottoscale D (eff etto del fattore tempo: F=10,536; gdl=1; p<0,01; eff etto del fattore tempo per sotto-campione di appartenenza: F=10,684; gdl=1; p<0,01) e B (eff etto del fattore tempo per genere: F=5,635; gdl=1; p<0,05; eff etto del fattore tempo per sotto-campione di appartenenza per genere: F=8,034;
94 G. MONNIELLO - S. CIMINO - L. CERNIGLIA ET AL.
gdl=1; p<0,01; eff etto del fattore tempo per genere per tipo di perdita: F=6,302; gdl=1; p<0,05; eff etto del fattore tempo per sotto-campione di appartenenza per genere per tipo di perdita: F=5,364; gdl=1; p<0,05).
Inoltre, abbiamo rilevato che 33 soggetti del primo sotto-campione superano il cut-off dell’EAT-40 nella prima somministrazione (N=38), mentre nella seconda questo avviene solo per 15 soggetti dei 33 esaminati. Nel secondo sotto-campione, invece, nessun soggetto oltrepassa il cut-off del test sia alla prima che alla seconda somministrazione. Nel campione di controllo, infi ne, 2 soggetti superano il punteg-gio soglia nella prima somministrazione, mentre 1 nella seconda.
Anche in questo caso riportiamo le diff erenze fra le medie dei punteggi ai test nella Figura 2.
Figura 2
Valutazione del cambiamento delle esperienze dissociative esperite dal soggetto nel pas-saggio dalla fase pre-adolescenziale a quella adolescenziale.
Infi ne, esaminando le variazioni dei vissuti dissociativi, abbiamo riscontrato diff erenze signifi cative fra le medie dei punteggi, sia nel punteggio totale (eff etto del fattore tempo: F=25,676; gdl=1; p<0,001; eff etto del fattore tempo per sotto-campione di appartenenza: F=6,33; gdl=1; p<0,05), che nelle sottoscale Amnesia dissociativa (eff etto del fattore tempo: F=24,734; gdl=1; p<0,001; eff etto del fatto-re tempo per sotto-campione di appartenenza: F=13,647; gdl=1; p<0,001; eff etto
L’ADOLESCENZA E LA PERDITA DI UN GENITORE IN ETÀ EVOLUTIVA 95
del fattore tempo per sotto-campione di appartenenza per tipo di perdita per ge-nere: F=4,547; gdl=1; p<0,05), Assorbimento immaginativo (eff etto del fattore tem-po: F=30,636; gdl=1; p<0,001; eff etto del fattore tempo per sotto-campione di ap-partenenza: F=5,333; gdl=1; p<0,05), Infl uenza passiva (eff etto del fattore tempo: F=24,778; gdl=1; p<0,001) e Depersonalizzazione-derealizzazione (eff etto del fattore tempo: F=37,16; gdl=1; p<0,001; eff etto del fattore tempo per sotto-campione di ap-partenenza: F=10,321; gdl=1; p<0,01; eff etto del fattore tempo per sotto-campione di appartenenza per tipo di perdita: F=4,444; gdl=1; p<0,05).
I dati riguardanti le esperienze dissociative sono molto interessanti, infatti:1) tutti i soggetti del primo sotto-campione superano il cut-off dell’A-DES nella
prima somministrazione, mentre solo 16 dei 33 soggetti esaminati nella seconda.2) nel secondo sotto-campione le esperienze dissociative risultavano eccessive per
2 soggetti nella fase pre-adolescenziale, mentre durante l’adolescenza nessun sogget-to supera il cut-off .
3) infi ne, nessun soggetto supera il cut-off dell’A-DES, sia nella prima che nella seconda somministrazione.
Come possiamo vedere nella Figura 3, i punteggi riguardanti le esperienze disso-ciative sono signifi cativamente inferiori nella seconda somministrazione.
Figura 3. Diff erenze fra le medie del punteggio globale dell ’A-DES e delle sue sottoscale, nelle due
somministrazioni (pre-adolescenza e adolescenza).
96 G. MONNIELLO - S. CIMINO - L. CERNIGLIA ET AL.
Valutazione dell ’infl uenza dello status psicologico e/o psicopatologico del genitore su quello del fi glio.
Per valutare se i punteggi al test SCL-90-R del genitore potessero predire i pun-teggi al test dei ragazzi, abbiamo utilizzato la regressione lineare. Ne è emerso che sia il Global Severity Index (β=0,966; t=29,295; p<0,001), il Positive Symptom Total (β=0,970; t=31,686; p<0,001) e il Positive Symptom Distress Index (β=0,853; t=12,893; p<0,001) che tutte le sottoscale dell’SCL-90-R del genitore sembrerebbero predire i punteggi dei ragazzi al test (Somatizzazione: β=0,978; t=37,011; p<0,001; Ossessione compulsione: β=0,979; t=37,366; p<0,001; Sensibilità interpersonale: β0,964; t=28,507; p<0,001; Depressione: β=0,941; t=21,945; p<0,001; Ansia: β=0,889; t=15,304; p<0,001; Ostilità: β=0,853; t=12,871; p<0,001; Ansia fobica: β=0,965; t=29,132; p<0,001; Idea-zione paranoide: β=0,828; t=11,643; p<0,001; Psicoticismo: β=0,413; t=3,572; p<0,01)2.
Infi ne è stato rilevato che 19 genitori dei soggetti appartenenti al primo sotto-campione (N=33) superano il cut-off dell’SCL-90-R per quanto riguarda il GSI, mentre solo 3 genitori dei soggetti appartenenti al secondo sotto-campione (N=31). È interessante anche notare che tutti questi genitori hanno fi gli che superano il cut-off .
Discussione dei dati e conclusioni
I dati emersi dalla nostra ricerca possono essere inseriti all’interno di un ampio fi -lone di studi empirici. L’adolescenza fa il suo esordio con la pubertà. In questo perio-do si verifi cano due cambiamenti fondamentali per lo sviluppo psicofi sico dell’indi-viduo: lo sviluppo puberale e il consolidarsi del pensiero logico-formale che permette di organizzare i contenuti dell’esperienza. I ragazzi vanno incontro ad una rapida e spesso inattesa maturazione corporea, con la conseguente modifi ca del rapporto con se stessi che viene spesso percepita come fuori dal proprio controllo (Carbone Tirelli, 2006). Inoltre, secondo Piaget (1976) nel periodo puberale il ragazzo inizia ad acqui-sire il pensiero ipotetico deduttivo o formale, acquisizione che terminerà verso i 15 anni, in piena adolescenza. Bisogna anche considerare lo sviluppo cerebrale che av-viene in questa fase. Jay Giedd et al. (1999) hanno condotto alcuni studi al National Institute of Mental Health di Betesda. Gli Autori, attraverso studi su 1800 bambini e adolescenti, hanno riscontrato che appena prima della pubertà la corteccia prefron-
2 Dalle analisi statistiche effettuate sui profili emotivo-adattivi dei ragazzi (SCL-90-R; EAT-40; A-DES) dei tre gruppi esaminati (adolescenti con perdita nella prima infanzia, adolescenti con perdita nella seconda infanzia e adolescenti senza esperienza di perdita di un genitore nell‘infanzia) il fattore perdita della madre o perdita del padre non ha prodotto differenze significative in alcuna area di funzionamento (p>0.5). Inoltre, rispetto al fattore genere dei ragazzi, non sono emerse differenze significative fra maschi e femmine in tutti i gruppi. È stata rilevata una differenza sta-tisticamente significativa (p>0.01) solo nella sottoscala Bulimia e preoccupazione per il cibo dello strumento EAT-40 per la quale le femmine mostrano punteggi più elevati rispetto ai maschi in tutti i gruppi e in entrambi i tempi di somministrazione (Tempo 1: F=8,235 gdl=1 p<0,01; Tempo 2: F=4,864, gdl=1 e p<0,05).
L’ADOLESCENZA E LA PERDITA DI UN GENITORE IN ETÀ EVOLUTIVA 97
tale si trova in fervente attività di crescita. In particolare quest’ultima, defi nita “area di ripensamento assennato”, controlla l’ippocampo, responsabile dei bisogni primari. Si è quindi osservato un aumento repentino della crescita neuronale tra gli 11 e i 12 anni, che fa sì che gli adolescenti abbiano meno risorse disponibili per l’apprendi-mento e il rispetto delle regole sociali. La corteccia frontale e prefrontale (Th om-pson et al., 2000) sono infatti deputate al controllo degli impulsi, alla regolazione delle emozioni e alla consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni. Queste funzioni raggiungeranno il loro sviluppo solo all’inizio dell’età adulta (Monniello, Quadrana, 2010).
Attraverso la somministrazione dell’SCL-90-R abbiamo riscontrato, infatti, una sensibile diminuzione dei punteggi dalla fase pre-adolescenziale alla media-tarda adolescenza. Questo probabilmente conferma il fatto che le modifi cazioni puber-tarie comportino un periodo di “smarrimento”, nel quale il ragazzo deve aff rontare numerosi processi di perdita (Birraux, 1994) al fi ne di compiere ciò che Blos (1967) defi nisce un secondo processo di individuazione. È però interessante notare anche come variano i punteggi nei diversi sotto-campioni. Infatti, come possiamo vedere dai risultati, i soggetti che hanno subìto la perdita di un genitore entro i tre anni superano il cut-off dell’SCL-90-R sia alla prima che alla seconda somministrazione. Soggetti che invece hanno subìto la perdita del genitore fra i 3 e i 10 anni superano il cut-off in un numero molto inferiore rispetto al gruppo di controllo. Quest’ultimo dato potrebbe dipendere dallo status psicopatologico dei caregiver ma, non avendo somministrato l’SCL-90-R ai genitori del gruppo di controllo, non è possibile veri-fi care questo dato.
Per quanto riguarda i punteggi dell’EAT-40, anche qui si evidenzia una diminu-zione dei punteggi riportati al test dai ragazzi fra la prima e la seconda somministra-zione. Come riporta Corcos (2006), l’età media di comparsa dei disturbi precoci del comportamento alimentare è di circa 11 anni e la sintomatologia è nel complesso identica a quella che si osserva nella forma tipica dell’adolescenza. Durante la puber-tà è il corpo che dall’essere indiff erenziato da quello della madre subisce passivamente i cambiamenti dello sviluppo puberale che riattivano i processi di diff erenziazione e individuazione (Blos, 1967). In questa fase il corpo, “garante della continuità” (Carau, Fusacchia, 2006), si pone come punto di intersezione fra continuità e discontinuità: Ladame (1998) ha sottolineato la centralità del corpo per l’adolescente come mezzo di riconoscimento e sperimentazione della realtà3. Se durante le fasi precoci della vita del bambino, questi non ha però avuto la possibilità di costruire la propria identità at-traverso lo sguardo della madre, in questo periodo il ragazzo aff ronterà diffi cilmente questa nuova fase di separazione dai genitori. Dai nostri risultati emerge infatti che i ragazzi che hanno vissuto una perdita genitoriale nei primi tre anni di vita riportano alla prima somministrazione (durante la pubertà) alti punteggi per quanto riguar-da i comportamenti alimentari disadattivi. Questo trova spiegazione nel fatto che il
3 De Mijolla-Mellor, riprendendo i concetti espressi da Ladame, ha parlato della “relazione Io-corpo” che “viene a sostituirsi al rapporto Io-l’altro” nei pazienti psicotici (in Pensare la psicosi. Una lettura dell ’opera di Piera Aulagnier, Roma, Borla, 2001).
98 G. MONNIELLO - S. CIMINO - L. CERNIGLIA ET AL.
ragazzo può aver perso la fi gura materna o che quest’ultima poteva essere immersa nelle dinamiche del lutto coniugale; infatti, come riporta Corcos (2006), in momenti di smarrimento, di impotenza, di impedimento, o di lutto profondo, la madre può essere incapace di sintonizzarsi con i bisogni emotivi del bambino. Ciò che quest’ul-timo vede, e di cui in parte si nutre attraverso lo sguardo della madre, dipende da ciò che essa riesce a trasmettere e da ciò che il bambino riesce a percepire e a rappresen-tarsi. Storicamente è stato messo in luce che durante la pubertà i ragazzi aff rontano i cambiamenti corporei e si rivolgono verso se stessi, mentre durante la media e tarda adolescenza si separano dalle fi gure genitoriali e costruiscono una propria identità. Dai nostri risultati si può vedere infatti come i comportamenti alimentari disadattivi decrescano nell’intero campione nel passaggio dalla pubertà alla media-tarda adole-scenza.
Anche per quanto riguarda le esperienze dissociative riportate dai ragazzi no-tiamo una signifi cativa diminuzione fra la pubertà e l’adolescenza. Numerosi studi riportano infatti che i soggetti in età evolutiva esibiscono un range di comportamenti dissociativi4 che decrescono con l’età; la tendenza a dissociare raggiunge un picco verso i 9-10 anni e declina nell’adolescenza fi no a dei livelli bassi e stabili nella prima età adulta (Putnam, 1993; Sanders, Braun, Kluft, 1989). Coerentemente con questi dati, gli adolescenti esaminati riportano minori esperienze dissociative rispetto alla prima somministrazione. L’andamento dei comportamenti dissociativi decresce in tutti i gruppi, anche se possiamo notare come gli adolescenti che hanno subìto la perdita del genitore nei primi tre anni di vita riportano punteggi superiori rispetto agli altri due gruppi.
Abbiamo inoltre notato che, come sottolinea la letteratura scientifi ca più recente (Kalter, 2002; Raveis, Siegel, Karus, 1999) non ci sono diff erenze signifi cative fra la perdita del padre e quella della madre nello sviluppo emotivo-adattivo dei ragazzi, tranne che per l’ansia fobica: i soggetti in età evolutiva che hanno perso la fi gura paterna sembrano riportare, infatti punteggi maggiori in questa sottoscala dell’SCL-90-R.
Il dato più interessante del nostro studio si riferisce al rapporto fra la psicopa-tologia dei genitori e disturbi nei fi gli. Ravi et al. (2009) riportano infatti che sia le madri che i padri di adolescenti con anoressia nervosa riportano punteggi elevati di sintomi ossessivi-compulsivi, ostilità, depressione ed ansia, mentre Clark et al. (2004) riportano che la psicopatologia, sia materna che paterna, può essere associata ad un possibile rischio per lo sviluppo di problemi internalizzanti ed esternalizzanti nei fi gli adolescenti. Inoltre, i risultati dello studio di Liakopoulou et al. (2010) mostrano che genitori di bambini con disturbi ossessivo-compulsivi riportano punteggi elevati in ossessioni, compulsioni, ansia, depressione e sensibilità interpersonale.
Coerentemente con questi studi, i nostri risultati mostrano che la psicopatologia genitoriale predice signifi cativamente i punteggi dell’SCL-90-R dei fi gli adolescenti
4 È opportuno ricordare che i comportamenti dissociativi qui discussi si differenziano dalla dissociazione psicopatologica per come ad esempio la definisce Bromberg (in Standing in the Spa-ces: Essays on Clinical Process, Trauma, and Dissociation, Hillsdale, NJ, The Analytic Press, 1998).
L’ADOLESCENZA E LA PERDITA DI UN GENITORE IN ETÀ EVOLUTIVA 99
e che tutti i fi gli di genitori che riportano punteggi globali all’SCL-90-R superano anch’essi il cut-off . Il presente studio, inserito in un fi lone di ricerca più ampio e an-cora da approfondire, indica l’utilità clinica di indagare la psicopatologia del genitore rimasto in vita a seguito di un lutto poiché le conseguenze di questo sembrano com-promettere lo sviluppo del bambino che ha perso l’altra fi gura genitoriale. Th ompson et al. (1991) riportano che soggetti che hanno perso il coniuge continuano a mostrare alti livelli psicopatologici anche dopo 30 mesi dal lutto e, come sottolineano Kirwin e coll. (2005), la perdita di un genitore in età evolutiva, se non supportata nelle fasi precoci dello sviluppo possono sviluppare seri disturbi emozionali e comportamen-tali che possono comportare alcuni disturbi psichiatrici maggiori. Questi dati sono importanti al fi ne di prevenire lo sviluppo di una psicopatologia nei fi gli. Una geni-torialità positiva può avere un impatto particolarmente forte per bambini che hanno vissuto la perdita di un genitore o un divorzio (Tein, 2007), perché contrasta il senso di insicurezza e di abbandono, collegati con i problemi di salute mentale che posso-no insorgere nei soggetti in età evolutiva che hanno sperimentato queste esperienze (Wolchik et al., 2002; Wolchik et al., 2008). Vediamo quindi quanto possa essere importante il sostegno alla relazione fra i bambini ed ai genitori colpiti dal lutto del coniuge. Un intervento mirato a sostenere la relazione fra pre-adolescenti e genitore potrebbe diminuire il rischio di un peggioramento delle diffi coltà psicologiche in adolescenza e rinforzare le risorse già presenti nel ragazzo e nel genitore come fattori di protezione verso l’insorgenza di una psicopatologia.
La nostra ricerca possiede però dei limiti. Innanzi tutto non sono state indagate alcune variabili come la modalità con cui è avvenuta la morte del genitore. Come sottolinea Dowdney (2000) è importante andare ad indagare anche come è avvenuta la morte del genitore, se vi è stato un omicidio, un suicidio o se la morte è avvenuta dopo una lunga malattia. Inoltre, la nostra ricerca non ha tenuto in considerazione la rete sociale che può essere stata di supporto al pre-adolescente durante il suo svilup-po: un buon rapporto sia con la rete della famiglia allargata che con i pari, rapporto fondamentale in questo periodo evolutivo, possono essere importanti fattori di pro-tezione che vanno indagati maggiormente.
Un altro limite riguarda l’utilizzo di strumenti self-report. Infatti una valutazione tramite questa tipologia di strumenti può non sempre essere una strategia di valuta-zione adeguata, soprattutto in caso di adolescenti o adulti con disturbi di personalità, a causa di una possibile diffi coltà di porsi in una dimensione prospettica e a causa delle distorsioni prodotte dai meccanismi difensivi, che si rifl ettono sui resoconti self-report (Westen, Shedler, 1999).
Riassunto Il presente studio, sulla perdita di un genitore nell’infanzia quale evento al-tamente traumatico, è la continuazione di una ricerca precedente (Cimino, Monniello, Sinesi, 2012) ed ha lo scopo di valutare il cambiamento del funzionamento psicologico globale dal periodo preadolescenziale a quello adolescenziale in un campione non refer-
red, indagando l’impatto della perdita di un caregiver signifi cativo (la madre o il padre) avvenuta nell’infanzia sul profi lo psicologico attuale. Abbiamo analizzato tre gruppi spe-
100 G. MONNIELLO - S. CIMINO - L. CERNIGLIA ET AL.
cifi ci: 1) ragazzi che hanno vissuto un’esperienza di perdita di un caregiver signifi cativo nei primi tre anni di vita; 2) ragazzi che hanno esperito tale evento dai tre ai dieci anni; 3) un campione di controllo in cui non si sono verifi cati eventi di perdita di fi gure si-gnifi cative nell’infanzia. Abbiamo somministrato agli adolescenti gli stessi questiona-ri self-report, somministrati precedentemente dagli Autori (Cimino, Monniello, Sinesi, 2012): 1) l’SCL-90-R (Derogatis et al., 1973), 2) l’EAT-40 (Garner e Garfi nkel, 1979), 3) l’A-DES (Armstrong, Putnam, Carlson, 1990). Inoltre, per quanto riguarda i primi due gruppi, è stato somministrato anche l’SCL-90-R al genitore rimasto in vita. I risul-tati mostrano che vi è una sensibile diminuzione dei punteggi ai test riportati dai ragazzi nel passaggio dalla pre-adolescenza alla medio-tarda adolescenza. I ragazzi che hanno subìto la perdita di un caregiver entro i primi 3 anni di vita continuano però a riportare punteggi più elevati rispetto agli altri 2 gruppi. Inoltre la ricerca ha mostrato che la psi-copatologia genitoriale potrebbe essere signifi cativamente associata a specifi ci punteggi dell’SCL-90-R dei fi gli adolescenti.Parole chiave Lutto durante l’infanzia, Adolescenza, Disturbi alimentari, Esperienze dissociative, Funzionamento psicologico.
Bibliografi a
Abdelnoor A., Hollins S. (2004), How Childern cope at school after family be-reavement, Educational and Child Psychology, 21, 3: 85-94.
Akerman R., Statham J. (September, 2011), Childhood Bereavement: a rapid lit-erature review, Childhood wellbeing research centre, 1-19.
Armstrong J.G., Putnam F.W., Carlson E.B. (1997), Development and valida-tion of a measure of adolescent dissociation: the Adolescent Dissociative Experi-ences Scale, Th e Journal of Nervous and Mental Disease, 185: 491-497.
Auman M.J. (2007), Bereavement support for children, Th e Journal of School Nursing, 23, 1: 34- 39.
Balk D.E., Corr C.A. (2001), Bereavement during Adolescence: A review of DeNigris: Trauma in youth research, in M.S. Stroebe, R.O. Hansson, W. Stroebe, H. Schut (Eds), Handbook of bereavement research: Consequences, coping, and care, Washington, American Psychological Association.
Birraux A. (1994), L’adolescent face à son corps, Bayard Editions.Blos P. (1967), Th e second individuation process of adolescence, Th e Psychoanalitic
Study of the Child, 22: 162-186.Blos P. (1989), L’adolescenza. Un’interpretazione psicoanalitica, Milano, Franco An-
geli.Carau B., Fusacchia M.G. (2006), Metapsicologia del corpo in adolescenza, in L.
Carbone Tirelli (Ed.), Pubertà ed adolescenza. Il tempo della trasformazione: segnali di disagio tra gli 11 e 14 anni, Milano, Franco Angeli.
Carbone Tirelli L. (2006) (Ed.), Pubertà e adolescenza. Il tempo della trasformazione: segnali di disagio tra gli 11 e 14 anni, Milano, Franco Angeli.
L’ADOLESCENZA E LA PERDITA DI UN GENITORE IN ETÀ EVOLUTIVA 101
Cerel J., Fristad M.A., Verducci J., Weller R.A., Weller E.B. (2006), Child-hood bereavement: Psychopathology in the two years post-parental death, Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiarty, 45, 6: 681-690.
Cheifetz P.N., Stavrakakis G., Lester E.P. (1989), Studies of the aff ective state in bereaved children, Canadian Journal of Psychiatry, 34: 688-692.
Cimino S., Monniello G., Sinesi S. (2012), La perdita di un genitore nell’infanzia: uno studio empirico su un campione di pre-adolescenti, Psichiatria dell ’Infanzia e dell ’Adolescenza, 2, 79: 398-410.
Clark D.B., Cornelius J., Wood D.S., Vanyukov M. (2004), Psychopathology risk transmission in children of parents with substance use disorders, Th e Ameri-can Journal of Psychiatry, 161, 4: 685–691.
Corcos M. (2006), I disturbi del comportamento alimentare ad esordio precoce, in L. Carbone Tirelli (Ed.), Pubertà ed adolescenza. Il tempo della trasformazione: segnali di disagio tra gli 11 e 14 anni, Milano, Franco Angeli.
Cuzzolaro M., Petrilli A. (1988), Validazione della versione italiana dell’E-AT-40, Psichiatria dell ’Infanzia e dell ’Adolescenza, 55: 209-217.
Derogatis L.R., Lipman R.S., Covi L. (1973), Th e SCL-90: An outpatient psy-chiatric rating scale- Preliminary report, Psychopharmacologic Bulletin, 9: 13-28.
Dowdney L., Wilson R., Maughan B. Allerton M., Schofield P., Skuse D. (1999), Bereaved children: Psychological disturbance and service provision, Brit-ish Medical Journal, 319: 354-357.
Dowdney L. (2000), Annotation: Childhood Bereavement Following Parental Death, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, 7: 819-830.
Draper A, Hancock M. (2011), Childhood parental bereavement: the risk of vul-nerability to delinquency and factors that compromise resilience, Mortality, 16, 4: 285-306.
Garner D.M., Garfinkel P.E. (1979), Th e eating attitudes test: An index of the symptoms of anorexia nervosa, Psychological Medicine, 9: 273-279.
Garner D.M., Garfinkel P.E. (1980), Socio-cultural factors in the development of anorexia nervosa, Psychological Medicine, 10: 647-657.
Garner D.M., Garfinkel P.E. (1982), Body image in anorexia nervosa: Measure-ment theory and clinical implications, Th e International Journal of Psychiatry in Medicine, 11: 263-284.
Giedd J.N., Blumenthal J., Jeffries N.O., Castellanos F.X., Liu H., Zijden-bos A., Et Al. (1999), Brain development during childhood and adolescence: a longitudinal MRI study, Nature Neuroscience, 2, 10: 861–863.
Haine R.A., Ayers T.S., Sandler I.N., Wolchik S.A. (2008), Evidence-based practices for parentally bereaved children and their families, Professional Psychol-ogy: Research and Practice, 39, 2: 113-121.
Hollingshead A.B. (1975), Four Factor Index of Social Status, Unpublished manu-script, New Haven, Yale University.
Kalter N,. Lohnes K.L., Chasin J., Cain A.C., Dunning S., Rowan J. (2002), Th e adjustment of parentally bereaved children: I. Factors associated with short-term adjustment, Omega (Westport), 46, 1: 15-34.
102 G. MONNIELLO - S. CIMINO - L. CERNIGLIA ET AL.
Kendler K.S., Sheth K., Gardner C.O., Prescott C.A. (2002), Childhood pa-rental loss and risk for fi rst-onset of major depression and alcohol dependence: Th e time-decay of risk and sex diff erences, Psychological Medicine, 32, 7: 1187-1194.
Kirwin K.M., Hamrin V. (2005), Decreasing the risk of complicated bereavement and future psychiatric disorders in children, Journal of Child and Adolescent Psychi-atric Nursing, 18, 1: 62-78.
Ladame F. (1998), Adolescence and Psychoanaliys: the story and the history, London, Karnac Books.
Liakopoulou M., Korlou S., Sakellariou K., Kondyli V., Kapsimali E., Sara-fidou J., Et Al. (2010), Th e Psychopathology of Parents of Children and Ado-lescents with Ossessive-Compulsive Disorder, Psychopathology, 43, 4: 209-215.
Luecken L.J., Kraft A., Appelhans B.M., Enders C. (2009), Emotional and car-diovascular sensitization to daily stress following childhood parental loss, Devel-opmental Psychology, 45, 1: 296-302.
Madigan S., Bakermans-Kranenburg M.J., Van IJzendoorn M.H., Moran G., Pederson D.R., Benoit D. (2006), Unresolved states of mind, anomalous pa-rental behavior and disorganized attachment: A review and meta-analysis of a transmission gap, Attachment & Human Development, 8: 89-111.
Melhem N.M., Walker M., Moritz G., Brent D.A. (2008), Antecedents and Sequelae of Sudden Parental Death in Off spring and Surviving Caregivers, Ar-chives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 162, 5: 403-410.
Monniello G., Quadrana L. (2010), Neuroscienze e mente adolescente, Roma, Edi-zioni Magi.
Nader K.O. (1997), Childhooid traumatic loss: Th e interaction of trauma and grief, in C.R. Figley, B.E. Bride, N. Mazza (Eds), Death and trauma: the traumatology of grieving, Washington, Taylor & Francis.
Offer D., Boxer A. (1991), Normal adolescent development: Empirical research fi ndings, in M. Lewis (Ed.), Child and adolescent psychiatry: A comprehensive text-book, Baltimore, MD.
Out D., Bakermans-Kranenburg M.J., Van IJzendoorn M.H. (2009), Th e role of disconnected and extremely insensitive parenting in the development of disor-ganized attachment: validation of a new measure, Attachment & Human Develop-ment, 11: 5, 419-443
Piaget J. (1976), Le possible, l’impossible et le nécessaire: les recherches en cours ou projetées au Centre international d’épistémologie génétique, Archives de Psycholo-gie, Genève, 44, 172: 2281-299.
Prunas A., Sarno I., Preti E., Madeddu F., Perugini M. (2012), Psychometric properties of the Italian version of the SCL-90-R: A study on a large community sample, European Psychiatry, 27, 8: 591-597.
Putnam F.W. (1993), Dissociative disorders in children: behavioural profi le and problems, Child Abuse and Neglect, 17: 39-44.
Ratnarajah D., Schofield M.J. (2007), Parental suicide and its aftermath: a re-view, Journal of Family Studies, 13, 1: 78-93.
L’ADOLESCENZA E LA PERDITA DI UN GENITORE IN ETÀ EVOLUTIVA 103
Raveis V.H., Siegel K., Karus D. (1999), Children’s psychological distress follow-ing the death of a parent, Journal of Youth and Adolescence, 28,2: 165-180.
Ravi S., Forsberg S., Fitzpatrick K., Lock J. (2009), Is Th ere a Relationship Be-tween Parental Self-Reported Psychopathology and Symptom Severity in Ado-lescents with Anorexia Nervosa?, Eating Disorder, 17: 63-71.
Rolls L., Payne S. (2007), Children and young people’s experiences of UK bereave-ment services, Mortality, 12, 3: 281-303.
Saldinger A., Porterfield K., Cain A.C. (2004), Meeting the needs of parentally bereaved children: A framework for child-centered parenting, Psychiatry, 67, 4: 331-352.
Sanders B., Braun B.G., Kluft R.P. (1989), Childhood stress and dissociation in a college population, Dissociation, 2: 17-23.
Siegel K., Karus D., Raveis V.H. (1996), Adjustment of children facing the death of a parent due to cancer, Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 35: 442-450.
Smith S.R., Carlson E.B. (1996), Th e reliability and validity of the Adolescent Dissociative Experiences Scale, Dissociation, 9: 123-127.
Steele W., Malchiodi C., Kuban C. (2008), Resilience and posttraumatic growth in traumatized children, in C. Malchiodi (Ed.), Creative Interventions with Trau-matized Children, New York, Guilford Press.
Tein J.Y., Sandler I.N., Ayers T.S., Wolchik S.A. (2006), Mediation of the Ef-fects of the Family Bereavement Program on Mental Health Problems of Be-reaved Children and Adolescents, Prevention Science, 7, 2: 179-195.
Thompson L.W., Gallagher-Thompson D., Futterman A., Gilewski M.J., Peterson J. (1991), Th e eff ects of late-life spousal bereavement over a 30-month interval, Psychology and Aging, 6, 3: 434-441.
Thompson P., Giedd J., Woods R., MacDonald D., Evans A., Toga A. (2000), Growth patterns in the developing brain detected by using continuum-mechani-cal tensor maps, Nature, 404: 190-193.
Weller R.A., Weller E.B., Fristad M.A., Bowes J.M. (1991), Depression in recently bereaved prepubertal children, Th e American Journal of Psychiatry, 148: 1536-1540.
Westen D., Shedler J. (1999), Revising and assessing Axis II, Part 1: Developing a clinically and empirically valid assessment method, Th e American Journal of Psy-chiatry, 156: 273-285.
Wolchik S.A., Tein J.Y., Sandler I.N., Doyle K.W. (2002), Fear of abandon-ment as a mediator of the relations between divorce stressors and mother-child relationship quality and children’s adjustment problems, Journal of Abnormal Child Psychology, 30, 4: 401-418.
Wolchik S.A., Tein J.Y., Sandler I.N., Ayers T.S. (2008), Parentally bereaved children’s grief: self-system beliefs as mediators of the relations between grief and stressors and caregiver–child relationship quality, Death Studies, 32, 7: 597-620.
Zanarini M.C., Gunderson J.G., Marino M.F., Schwartz E.O., Frankenburg
104 G. MONNIELLO - S. CIMINO - L. CERNIGLIA ET AL.
F.R. (1989), Childhood experiences of borderline patients, Comprehensive Psy-chiatry, 30, 1: 18-25.
Zoroglu S.S., Sar V., Tuzun U., Tutkun H., Savas H.A. (2002), Reliability and validity of the Turkish version of the adolescent dissociative experiences scale, Psychiatry and Clinical Neurosciences, 56: 551–556.