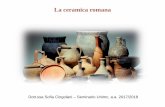Ceramica della media e avanzata età del Ferro
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Ceramica della media e avanzata età del Ferro
Serena Solano
Ceramica della media e avanzata età del Ferro
61
Introduzione
Lo scavo del santuario protostorico di Breno haportato al recupero di una quantità conside-revole di ceramica, con questo offrendo la pos-sibilità di ampliare il quadro di conoscenzasulla cultura materiale della media e avanzata etàdel Ferro della Valcamonica, aggiungendo nuovidati a quanto già delineato grazie soprattuttoagli studi di R.C. De Marinis sui siti di Breno-Val Morina, Borno-Val Camera, Capo di Ponte-Dos dell’Arca e Darfo-Luine1 e di R. PoggianiKeller relativamente a Temù-località Desert2.Nel presente contributo vengono illustrati irisultati dell’analisi del complesso ceramico per-tinente all’utilizzo del santuario all’aperto tipoBrandopferplatz dalla fase di VI-V secolo a.C.fino alla prima monumentalizzazione dell’areain età augustea. Dai livelli esaminati provengonocirca 60 chilogrammi di ceramica, caratterizzatada un elevato livello di frammentazione, confratture fresche e nette nella maggior parte deicasi e dimensioni che sovente non superano i2 centimetri. Tale precario stato di conserva-zione, se da un lato è imputabile alle condi-zioni di seppellimento e alla movimentata storia
Sono molto grata a Filli Rossi per avermi affidato questostudio e a Franco Marzatico per la costante disponibilità eper le preziose indicazioni bibliografiche e interpretative.
(1) DE MARINIS 1982a, DE MARINIS 1988, DEMARINIS 1989, DE MARINIS 1992 e DE MARINIS1999.(2) POGGIANI KELLER 2001; POGGIANI KELLER,DE VANNA 1999-2000; POGGIANI KELLER 2009.Negli ultimi anni ulteriori informazioni sono state offertedall’analisi di contesti insediativi di lunga durata fra pro-tostoria ed età romana (quali Berzo Demo, Darfo BoarioTerme, Cemmo: SOLANO 2006-2007 e SOLANO2008), dai materiali ceramici dai livelli di frequenta-zione dell’età del Ferro dei centri cerimoniali di Cemmo-Pian delle Greppe e Ossimo-Pat (POGGIANI KELLER1999-2000, pp. 237-238 e POGGIANI KELLER 2002,fig. 7, p. 386) e dal ritrovamento di un villaggio mine-rario di VI-V secolo a.C. in alta quota a Cevo-Dos delCurù (POGGIANI KELLER 2006a) e di un abitatopluristratificato a Malegno-via Cavour (POGGIANIKELLER 2006b; i materiali ceramici sono inediti). Perla tarda età del Ferro rimangono di fondamentale impor-tanza i dati restituiti dall’abitazione scavata a Pescarzo di
(7) PERONI 1996, p. 20.(8) Nel caso di Spinera significativa appare la presenzadi attacchi o di frammenti riferibili a un medesimo reci-piente in strati diversi, non sempre in diretta relazionestratigrafica.(9) TOMEDI, HYE, LACHBERGER, NICOLUSSICASTELLAN 2006, p. 119.(10) HÖCK, ZANIER 2002, p. 38.(11) Così per le US 1185, 1181 e 1177.(12) US 1173=1174 distinta dalla soprastante US 1129.(13) Dall’alto verso il basso: US 1129, US 1173=1174,US 1177, US 1181 e US 1185.
Capo di Ponte (ROSSI et alii 1999).(3) Così ad esempio ai Campi Neri di Cles (CIUR-LETTI, DEGASPERI, ENDRIZZI 2004, p. 454), aStenico (MARZATICO 2002, p. 716), al Noafer Bühl(MAHLKNECHT 2002, pp. 126-127), al Rungger Egg(GLEIRSCHER, NOTHDURFTER, SCHUBERT2002, p. 30 e p. 125), alla Groa di Sopramonte (PERINI1979, p. 61) e anche in area golasecchiana a Pombia(GAMBARI 2001, p. 96). Al Monte Covolo, la pre-senza di numerosi ciottoli fluviali con segni di percussioneè stata collegata al rito della frantumazione degli oggettiprima della deposizione (BARFIELD, BUTEUX,BOCCHIO 1995, p. 19). La frantumazione rituale dellaceramica quale elemento distintivo degli Alpine Brandop-ferplätze è stata recentemente messa in discussione daSteiner (STEINER 2007).(4) Ad esempio a Este nel santuario orientale a Meg-giaro (GREGNANIN 2002, p. 164).(5) Tale pratica è evidente ad esempio in area retica aiCampi Neri di Cles (CIURLETTI, DEGASPERI,ENDRIZZI 2004, p. 456) e a Mechel (MARZATICO1992a, p. 232 e nota 114), dove numerosi reperti sonorisultati spezzati o ritorti.(6) Così per esempio situle miniaturistiche e fibule in fet-tuccia, non utilizzabili, si ritrovano fra le offerte del san-tuario di Mechel in Val di Non (MARZATICO 1992a,p. 232). Sulla miniaturizzazione e sul significato votivodella ceramica nei santuari si veda MOREL 1992, pp.226-229.
del sito, interessato da periodiche interferenzedel fiume, dall’altro lascia spazio a suggestionicirca la possibilità di una frantumazione edispersione rituale del vasellame, in relazione apratiche cerimoniali, così come ipotizzatoaltrove in numerosi contesti cultuali. La fram-mentazione della ceramica si registra infatti inmaniera abbastanza costante tanto nei luoghi diculto alpini contraddistinti da aree per offertecombuste (Alpine Brandopferplätze)3 quantonei santuari paleoveneti4, dove il vasellameappare non di rado rotto e sparpagliato, alpunto che si ipotizza un’intenzionalità di defun-zionalizzazione sottesa ai gesti dello spezzare edello spargere le offerte, operando una “distru-zione volontaria” dell’oggetto, finalizzata a ren-derlo inservibile sottolineandone il valore d’usosimbolico, secondo una prassi riservata anchead altre tipologie di manufatti, quali ad esempioi metalli5. La stessa logica sembra giustificare peraltro la donazione di esemplari miniaturistici oche solo nella forma imitano oggetti reali6,
riflettendo, secondo R. Peroni, una nuova con-cezione dell’offerta votiva che si esprime in un“rovesciamento del dono in sacrificio - cioènella distruzione, cruenta o comunque vio-lenta, dell’offerta - e nella dedizione”7.Se dunque gesti intenzionali e connessi al ritualedell’offerta e della libagione possono avere deter-minato rotture, spargimenti e spostamenti delmateriale, d’altra parte non vanno trascurateanche attività di manutenzione, pulizia e ripri-stino dell’area e delle strutture sacre chedovevano accompagnare e seguire la deposi-zione dei manufatti, contribuendo così alla lorodistruzione e dispersione8.Per quel che riguarda le aree per offerte com-buste, considerazioni utili per ricostruire ledinamiche di seppellimento dei materiali pro-vengono dalle osservazioni registrate per alcuniluoghi di culto (ad esempio Ampass 9 eWilten10) dove la ceramica è apparsa distri-buita “a pacchetti” (Scherbenpakete) separati dastrati di pietrisco, quasi a scandire momentidistinti di una medesima gestualità. Nel caso diSpinera, i diversi orizzonti carboniosi legati allestrutture d’altare sono risultati in sede di scavoseparati tra loro da successivi “piani di cottura”11
e, in almeno una circostanza12, da una sistema-zione a sfaldature calcaree. La maggior partedella ceramica esaminata (circa 45 chilogrammisui 60 chilogrammi totali) proviene da questilivelli13 tumuliformi, che si rivelano come esitodi deposizioni e accumuli successivi di ossicombusti frantumati e materiale votivo e rituale,non sempre cronologicamente coerente, inquanto evidenti rimescolamenti in antico nehanno alterato la sequenza con alcuni sposta-menti in senso verticale, ma che tuttavia, in
62
considerazione delle “divisioni” antiche rico-nosciute in sede di scavo fra un deposito el’altro, possono essere considerati come con-testi “chiusi”. Pur riconoscendo dei limitioggettivi nell’attendibilità delle associazioni edelle attribuzioni cronologiche dei dati, facendoun computo del numero di esemplari ricono-scibili14 e procedendo per considerazioni sta-tistiche sulla presenza/assenza di determinateforme, è possibile riconoscere, partendo daglistrati più recenti, materiali compresi principal-mente fra III e fine del I secolo a.C. nell’US1129 (con sporadiche intrusioni residuali di Ve IV secolo a.C.), ceramica per lo più di V-IIIsecolo a.C. nell’US 1173=1174 e nell’US 1177,ceramica databile fra VI e IV secolo a.C. nell’US1181 e materiale compreso tra VI e V secoloa.C. nell’US 1185. Dai livelli in relazione conil recinto cerimoniale ellittico innalzato a norddell’altare (US 1182) e dal piano d’uso internoal recinto stesso (US 1150) provengono circa 2,3chilogrammi di cocci, databili fra V-IV e Isecolo a.C.Nello studio e nell’esposizione dei dati, purprocedendo secondo un criterio crono-tipo-logico dei materiali, si è cercato di superareuna mera catalogazione e presentazione tipo-logica dei reperti, cercando di riscoprire piut-tosto attraverso di essi anche gli aspetti delrituale che li vedeva protagonisti e le eventualimodifiche nel tempo.
Metodologia di analisi
La maggior parte della ceramica analizzata èdel tipo grezzo, definizione15 con cui sonoindicati in questa sede recipienti dal corpoceramico grossolano, ricco di inclusi di granu-lometria e frequenza variabile, visibili a livellomacroscopico, a volte affioranti in superficie,altre dissolti in cottura o durante il seppelli-mento, ma comunque testimoniati dall’abbon-danza di vacuoli e dalla porosità dei frammenti.La lavorazione, al tornio lento o manuale,prevede non di rado rifiniture a stecca, a pettineo scopettato. La colorazione presenta tonalità
(14) La quantificazione è stata effettuata, dopo avereverificato eventuali pertinenze e attacchi, contando gliorli, le anse e i fondi e i frammenti di parete significativiper corpo ceramico, colore, decorazione o rifinitura.(15) Per le problematiche connesse alla definizione diceramica grezza, non univocamente accettata e utilizzata,si rimanda a SANTORO BIANCHI 1993 con riferi-menti bibliografici alla nota 2 e a FAILLA, GUER-MANDI, SANTORO BIANCHI 1994, p. 183.
(19) Secondo quanto già osservato per la Valcamonica(POGGIANI KELLER 2002, p. 387) e attestato anchein contesti protostorici valtellinesi (POGGIANI KELLER1995) e trentini (MARZATICO 2007).
(16) PEACOCK 1982.(17) MOREL 1992.(18) L’espressione “corpo ceramico” è preferita a quelladi “impasto” in quanto quest’ultimo sta a connotarepiuttosto la materia argillosa cruda, mentre il primo siriferisce al prodotto cotto e finito e quindi a ciò cheeffettivamente è oggetto di analisi archeologica(CUOMO di CAPRIO 1985).
diverse anche in uno stesso recipiente, evidenzaben riscontrabile nelle fratture che spesso hannouna cromia molto differente dalla superficieesterna, a indizio di un difficile e poco attentocontrollo della temperatura di cottura, avvenutain strutture tecnologicamente rudimentali. Laproduzione rimanda a un ambito domestico elocale, rientrando nei primi due livelli delmodello proposto da Peacock (household pro-duction e household industry)16. Si tratta di pro-dotti di artigianato che seguono schemi con-divisi, ma che non sono mai tra loro uguali,mostrando anzi una notevole varietà nei dettagli,nelle dimensioni e nelle rifiniture. Alcuni par-ticolari nel trattamento delle superfici e nelleaggiunte decorative suggeriscono per alcuniesemplari la volontà di ottenere vasellame spe-cificatamente “da offerta”17.Tutti i frammenti sono stati distinti a secondadel corpo ceramico18 individuabile a un’in-dagine preliminare meramente macroscopica,valutando colore della superficie e caratteri-stiche mineralogiche e petrografiche (argille,inclusi e degrassanti). Nella prima fase di lavorosono stati così definiti i seguenti gruppi, veri-ficati poi a livello archeometrico (secondo lecorrispondenze indicate tra parentesi):- gruppo 1 (1F): corpo ceramico grigio-rosato
o grigio-marrone con inclusi micacei grigilucenti puntiformi o a scaglie con granulo-metria da fine a medio-grossa (fino a 4 mil-limetri). Le superfici possono essere lisciate erifinite a stecca, a pettine o scopettato. Appar-tengono al gruppo boccali, ollette, coppette,bacili;
- gruppo 2 (distinto a seguito delle analisiarcheometriche in 2F e 3F): corpo ceramicoarancio-marrone o arancio-rosato con inclusibianchi calcitici a granulometria da fine amedia a grossa. Le superfici talvolta sonolisciate a stecca. Il gruppo si riferisce per lo piùa olle e teglie;
- gruppo 3 (8F): corpo ceramico marrone-rosatocon inclusi lucenti grigi e bianchi opachi a gra-nulometria medio-fine. Le superfici sonolevigate e lucidate a stecca e conferiscono airecipienti un aspetto estremamente compatto
e “metallico”. Appartengono al gruppo alcuniboccali;
- gruppo 4 (4F): corpo ceramico arancio-marrone con inclusi marroni lucenti, grigiopachi, neri e bianchi a granulometria da finea grossa. Le superfici sono spesso rifinite apettine o scopettato. Il gruppo, compren-dente olle, teglie e boccali, caratterizza prin-cipalmente materiali di II-I secolo a.C.;
- gruppo 5 (5F): corpo ceramico rosato coninclusi affioranti grigi e bianchi opachi a gra-nulometria da fine a grossa. Si riferiscono aquesto gruppo alcuni boccali e coppette;
- gruppo 6 (6F): corpo ceramico depurato osemidepurato, arancio-rosato, sovente conun’anima più scura con rari inclusi arancio-marroni a granulometria medio-fine. Appar-tengono a questo gruppo esclusivamentecoppe di tradizione tardoceltica;
- gruppo 7 (7F): corpo ceramico marrone oarancio-beige estremamente poroso, dal-l’aspetto spugnoso, dovuto al dissolvimentoin cottura di inclusi (calcite?). Appartengonoal gruppo pressoché esclusivamente alcuneolle.
L’insieme di ogni gruppo è stato quindi pesato,ai fini di valutare l’indice di presenza dei singolicorpi ceramici e quindi di ottenere utili indi-cazioni in merito a possibili relazioni qualicorpo ceramico/forma, corpo ceramico/fun-zione e corpo ceramico/datazione (Grafico 1).Il gruppo più rappresentativo, che interessa il60% del totale, è quello a corpo micaceo(gruppo 1=1F), che le analisi archeometrichehanno indicato provenire da suoli di altera-zione su rocce scistose, che si conferma comeil più diffuso e tipico della ceramica proto-storica centroalpina19. È probabile che alla basedella scelta dell’impasto, impiegato per rea-
Grafico 1. Sono indicate le presenze percentualidei singoli gruppi di corpo ceramico.
63
lizzare le forme vascolari più caratteristichedella facies culturale camuna della seconda etàdel Ferro (dai boccali tipo Breno e Dos del-l’Arca, ai bacili tipo Temù), stesse la volontàdi ottenere un risultato gradevole e pregiato:l’abbondanza di miche bianche dall’aspettoargentato conferiva infatti al prodotto finitoun particolare effetto luminescente che potevasenz’altro soddisfare il desiderio di imitare piùpreziose forme in lamina metallica20. I reci-pienti pertinenti a tale gruppo non dovevanoessere destinati alla cottura, bensì alle libagioni,alla mensa e all’offerta. Il corpo ceramicomicaceo appare esclusivo della protostoria etende a scomparire sul finire del I secolo a.C.,con la romanizzazione, quando diventa predo-minante il gruppo 4 (4F=1R). Degli altri gruppiil 3 (8F) e il 5 (5F) si riferiscono soprattutto aboccali, nei casi riconoscibili ascrivibili fra V eIII secolo a.C., mentre il 6 (6F) appare carat-teristico di ceramiche inquadrabili nella tradi-zione tardoceltica, per le quali non è impro-babile pensare a fenomeni di importazione.Meno caratterizzanti sono il gruppo con calcite(2=2F e 3F) e quello dall’aspetto poroso (7=7F):il primo di lunga durata, il secondo del tuttoprivo di informazioni, data l’assenza di inclusisignificativi.Tali osservazioni, suffragate dalle analisi archeo-metriche condotte in laboratorio21, possonoportare utili implicazioni in merito alla possi-bilità di riconoscere nelle caratteristiche delcorpo ceramico una discriminante cronologicache unitamente alle varianti morfologiche possaaiutare nella definizione della scansione crono-tipologica di alcune forme di lunga durata(Henkeldellenbecher e Lappenbecken).Una volta suddivise in macro raggruppamenti,le ceramiche sono state classificate attraverso iframmenti significativi (orli, fondi, anse, paretidecorate e/o recanti sovradipinture o iscrizioni)a seconda della forma (aperta o chiusa) e quindidistinte in tipi e varianti sulla base delle carat-teristiche metriche e morfologiche del vaso, alfine di ricercare confronti utili per l’attribu-zione cronologica, nonché per avanzare pro-poste in merito alla funzione rituale delvasellame.
(20) Lo stesso è ipotizzato per i bacili tipo Temù (POG-GIANI KELLER 2001, p. 13).(21) Per maggiori dettagli e considerazioni si rimanda aRiccardi, Basso, Solano, Ronchi in questo volume.
Breno e con il medesimo trattamento della superficiesono ad esempio da Pozzuolo del Friuli (VITRI, LEO-NARDI, CORAZZA, BALISTA, MIZZAN 1992, pp.29-32, fig. 30, 7-8).(27) CONRADIN 1978, Abb. 11, 12, 17, 32, 61, 62,64, 65, 70 e pp. 117-130.(28) CONRADIN 1978, p. 82, Abb. 17, n. 22 (inornato)e in particolare n. 23, con il medesimo trattamento dellasuperficie; RAGETH 1992, fig. 3, 8; RAGETH 1999,fig. 4, 8, p. 441.(29) In Valtellina, a Teglio e Valdisotto (POGGIANIKELLER 1995, fig. 84, p. 99, nn. 3, 16, 26) e a Grosio(POGGIANI KELLER 1995, fig. 21, 20, p. 34 e fig. 77,7, p. 85, fig. 79, 4-8); nella Bergamasca a Castione dellaPresolana (POGGIANI KELLER 1989b, fig. 93, p. 86).In Valcamonica esempi sono da Luine di Darfo BoarioTerme (DE MARINIS 1989, fig. 119, 9, p. 110) e daBienno-Campolungo (TIZZONI CUCINI, FER-RARIO, MORIN, IXER, RUFFA, TIZZONI,ZAHOVA 2001, fig. 4, 4, p. 117).(30) Esempi da San Giovanni Massimeno in Val Rendena(MARZATICO 1995a, fig. 8, 11 e 18, p. 521; fig. 9, 19,29-31, p. 522; MARZATICO 1999a, fig. 2, 11, 18 e fig.3, 19, 29-31, pp. 469-471).
(22) Olle: Tav. I, 1-16 (St. 160548, US 1198; St. 160313,US 1198; St. 160217, US 1185; St. 160219, US 1185;St. 160244, US 1181; St. 160245, US 1181; St. 160246,US 1181; St. 160248, US 1181; St. 160249, US 1181;St. 160250, US 1181; St. 160251, US 1181; St. 160328,US 1172; St. 160543, US 1181; St. 160544, US 1220;St. 160257, US 1124; St. 160581, US 1177). Boccali:Tav. II, 1-5 (St. 160275, US 1129; St 160555, US 1129;St. 160547, US 1182; St. 160585, US 1126; St. 160215,US 1185). Teglie: Tav. II, 6 (St. 160218, US 1185 e US1181).(23) US 1198.(24) Oggetti deposti integri in piccole buche sono statitrovati anche a Pombia, accanto a materiale frantumatoe accumulato nell’area del Brandopferplatz, per cui si èipotizzato che la frantumazione rituale fosse connessa ariti di banchetto e che le offerte sepolte integre costi-tuissero veri e propri doni (GAMBARI 2001, p. 96).(25) RITTATORE VONWILLER 1966, tavv. XXXII-XXXV e XXXVIII; DE MARINIS 1982b, fig. 122, p.92. Del tutto diversa è la sintassi decorativa che caratte-rizza le urnette della Ca’ Morta, sovente a cerchielli e aschematici motivi impressi e accompagnata da uningobbio marrone sulla superficie.(26) Due ollette morfologicamente affini a quella di
Materiali di VI-V secolo a.C.22
Olle (Tav. I, 1-16)
Nel complesso esaminato i materiali più antichisi datano al VI-V secolo a.C. e sono rappre-sentati prevalentemente da olle. Fra i repertiche si collocano in questa fase si distingue l’ol-letta a corpo ovoide, con corpo ceramicomarrone-rosato, con inclusi calcitici, quarzosie scuri affioranti di piccole dimensioni, conorlo estroflesso lievemente assottigliato su bassagola arrotondata e spalla sfuggente, rifinitura astriature verticali rese a pettine sul corpo, fondopiano con leggera concavità al centro, prove-niente dal riempimento di una delle fosse indi-viduate nel settore sud, lato est, nei pressi imme-diati della rupe rocciosa, verso la grotta prin-cipale23 (Tav. I, 1 e Fig. 1). In questo caso nonè improbabile che l’oggetto, che presenta leggeretracce di combustione sia internamente cheesternamente, sia stato deposto integro, forsecon un contenuto24. I confronti morfologici edecorativi rimandano a un periodo compresofra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C.:l’esemplare di Breno è assimilabile infatti performa e dimensioni tanto alle urnette situli-formi della necropoli golasecchiana della Ca’Morta datate fra fine VI e V secolo a.C.25,quanto a certe ollette rinvenute in contesti coevidi ambito paleoveneto, dove si ritrova per altroanche la medesima rifinitura a striature ver-ticali dalla spalla al fondo26. Tale decorazione,
resa a pettine o a scopettato, caratterizza altresìla cosiddetta Besenstrichkeramik tardohallstat-tiana dei Grigioni27, che offre un confrontoutile al caso di Breno dalla necropoli diTamins28. Recipienti ceramici decorati a pettinee scopettato ricorrono con una certa frequenzanelle vallate della Lombardia orientale29 e siritrovano anche nelle Giudicarie trentine30. Almedesimo gusto decorativo è associabile il fram-mento di orlo estroflesso appiattito superior-mente di olletta a impasto micaceo, rifinitocon striature verticali a pettine provenientedalla stessa fossetta (Tav. I, 2).Sono inquadrabili nello stesso orizzonte cro-nologico un frammento di olla, caratterizzata dacorpo ceramico calcitico, con orlo estroflesso,
Fig. 1. Olletta a corpo ovoide.
64
leggermente ingrossato e margine arrotondato31
(Tav. I, 3), e alcune olle e ollette a corpoceramico micaceo a granulometria fine, dal-l’alto orlo distinto, ad andamento estroflesso,più o meno svasato, appiattito superiormentee variamente ingrossato e sagomato32 (Tav. I,4-14), che trovano corrispondenze morfolo-giche in Valcamonica a Bienno-Campolungo eDarfo-Luine33, in Valtellina a Grosio-Dossodei Castelli34 e nella valle dell’Inn a Birgitz-Hohe Birga35. In particolare, l’olla con orloestroflesso con bordo ingrossato e appiattitosu alta gola (Tav. I, 4) trova affinità anche conalcune forme della Schnellerkeramik affermatasinella Valle del Reno intorno al V secolo a.C.36.L’impasto micaceo (1F) che contraddistinguequeste olle è da questa fase in avanti elementocaratterizzante a livello macroscopico la mag-gioranza del vasellame. Fra VI e V secolo a.C.può collocarsi anche il frammento di orlo estro-flesso a sezione trapezoidale superiormentepiatto (Tav. I, 15), presente come elementoresiduale in uno degli strati legati agli inter-venti postaugustei di sistemazione dell’area37:a corpo micaceo fine con tracce di sovradi-pintura rossa esterna, esso è accostabile, anchese in maniera non puntuale, a un orlo di olladatata intorno al V secolo a.C. dal sito diPezzaze-Roccolo della Croce in Valtrompia38,e a un analogo orlo da Himmelreich-Kuppe
(31) L’olla proviene dall’US 1185 che rappresenta illivello più antico dei depositi carboniosi addossatiall’altare protostorico posto a sud del recinto cerimo-niale. Un confronto abbastanza stringente è con un’ollada Grosio-Dosso dei Castelli dalla fase 6 dello scavo,datata fra la fine del VI e la prima metà del V secolo a.C.(POGGIANI KELLER 1995, fig. 79, 1, p. 88).(32) I frammenti provengono dai livelli tumuliformi US1185 e US 1181 addossati all’altare nell’area sud, dalnucleo (US 1172) dello stesso altare e dal piano d’uso US1220 in relazione al secondo altare individuato a norddel recinto cerimoniale.(33) Per Bienno-Campolungo si veda TIZZONICUCINI, FERRARIO, MORIN, IXER, RUFFA,TIZZONI, ZAHOVA 2001, fig. 4, 4, p. 117; per Darfo-Luine si rimanda a DE MARINIS 1989, fig. 119, 9, p.110.(34) POGGIANI KELLER 1995, fig. 77, 6-10, p. 85.In particolare il n. 8 offre un confronto stringente per gliorli leggermente ripiegati internamente dei frammenti diTav. I, 6, 8 e 11.(35) GLEIRSCHER 1987, Abb. 64, 16, p. 348, confron-tabile in particolare con gli orli di Tav. I, 6, 8 e 11.(36) Il frammento viene dall’US 1185. I confronti sonocon CONRADIN 1978, Abb. 76, 9-10, p. 137.(37) US 1124.(38) DE MARINIS 1989, fig. 115, 2, p. 107.
(45) I frammenti provengono dal deposito più recenteaddossato all’altare (US 1129), dall’US 1182 (in relazioneal recinto cerimoniale) e dall’US 1126 (livello di riportodi età giulio-claudia).(46) POGGIANI KELLER 2001, pp. 9-12, fig. 14, fig.19, 3 e fig. 21, 1-4; POGGIANI KELLER 2009, tavv.VIII-XI, pp. 63-64.(47) I reperti vengono dal piano di calpestio del vano 277datato tra fine del VI e inizio del V secolo a.C. (POG-GIANI KELLER 1992, fig. 5, 7 e 10, p. 315).(48) PERINI 1970, fig. 8, 4, 7, 14, p. 162.(49) MARZATICO 1995a, fig. 8, 2, p. 521; MAR-ZATICO 1999a, fig. 2, 2, p. 469.(50) Per Temù POGGIANI KELLER 2001, fig. 21, 1-2, p. 12; POGGIANI KELLER, DE VANNA 1999-2000, fig. 42, p. 48; POGGIANI KELLER 2009, fig. 20,p. 35; tavv. VIII-XI, pp. 63-64; per il Monte OzolPERINI 1970, fig. 8, 14, p. 162.
(39) APPLER, ALTENBURGER, ZEISLER 1997, Taf.8, 4, p. 21.(40) DE MARINIS 1989, fig. 118, 9, p. 109.(41) PERINI 1969b, fig. 14, d, p. 206.(42) L’olla proviene dall’US 1177 che rappresenta unodei livelli del tumulo carbonioso intorno all’altare sud.(43) Nel caso di Grosio si tratta di un’olletta dall’US148, assimilata, per il tipo di decorazione, a forme tran-salpine (POGGIANI KELLER 1995, fig. 38, 11, pp.49-51). Lo schema decorativo caratterizza sempre aGrosio-Dosso dei Castelli piccoli vasi dal profilo sinuosoin ceramica fine, morfologicamente confrontati conurnette della necropoli tardohallstattiana di Tamins neiGrigioni (POGGIANI KELLER 1995, fig. 78, 1 e 14-16, p. 87), ed è presente nei Grigioni su alcune olle dellaSchnellerkeramik (CONRADIN 1978, Abb. 17, 25, p.82, Abb. 26, p. 92, Abb. 61, 10-11, p. 121, Abb. 79, 3,p. 139).(44) Lo strato rappresenta, come già ricordato, il secondolivello cronologicamente più antico nell’insieme deilivelli tumuliformi addossati alla struttura d’altare.
nella valle dell’Inn39. L’appiattimento supe-riore caratterizza anche un frammento dai livellidi fine VI secolo a.C. da Luine di Darfo BoarioTerme in Valcamonica40. Infine, un’affinitàpuò essere proposta anche con un recipientedai Montisei di Serso (Trento), contraddistintodal medesimo trattamento della superficie consovradipintura rossa41.Può essere attribuita a questa fase anche l’ollettaparzialmente ricostruita da vari frammenti42
(Tav. I, 16), a corpo ceramico micaceo fine dicolore bruno, con orlo estroflesso, leggermenteassottigliato e spalla ornata da una fila oriz-zontale di piccole tacche impresse “a chicchidi riso”, che trova una stretta somiglianza aGrosio-Dosso dei Castelli con un piccolo vasofra i materiali in situ di uno strato datato fra VIe V secolo a.C. e che, per il tipo di decora-zione, trova corrispondenze nei Grigioni43.
Boccali (Tav. II, 1-5)
Difficile è discernere con certezza frammentiriconducibili a boccali della fase più antica dalmomento che frammenti micacei di fondopiano, di orlo estroflesso e di anse variamentefoggiate pertinenti a boccali monoansati di tra-dizione alpina sono presenti con sempre mag-giore incidenza nei depositi tumuliformiaddossati all’altare posto a sud del recinto ceri-moniale a partire dall’US 118144, e quindidopo il V secolo a.C., mentre scarseggiano nellivello stratigraficamente precedente (US 1185)e sono del tutto assenti tra i materiali dalle fos-sette della prima fase di frequentazione del-l’area. Sono forse pertinenti a forme di VI-V
secolo a.C. resti di boccali monoansati a corpomicaceo, dalla forma globosa, con breve orloestroflesso e ripiegato in corrispondenza del-l’attacco dell’ansa sviluppata in lunghezza, fondopiano e appiattimento della parete in corri-spondenza dell’ansa45 (Tav. II, 1-4 e Fig. 2),accostabili a frammenti ascrivibili fra VI e Vsecolo a.C. da Temù in alta Valcamonica46, daParre nella Bergamasca47, dal Ciaslir del MonteOzol in Val di Non48, da San Giovanni Mas-simeno in Val Rendena49. Il contesto di rinve-nimento, confronti con boccali con larghe ansea nastro da Temù e dal Monte Ozol50 e osser-vazioni archeometriche suggeriscono una data-zione al medesimo periodo anche per il fram-mento di larga ansa liscia con corpo ceramicogrigio compatto e levigato a stecca (gruppo3=8F) dall’US 1185 (Tav. II, 5). L’attribuzionecronologica dei boccali sulla base della differentetipologia dell’ansa non è tuttavia univoca equindi deve essere proposta con una certa pru-denza, dal momento che una medesima
Fig. 2. Boccale monoansato.
65
Tav. I. Olle e ollette di VI-V secolo a.C. (scala 1:3) (dis. A. Massari).
1
2
3
4
5 6
78 9
10 1112
13
14
1516
66
variante, come nel caso specifico quella a nastroliscia, può essere di lunga durata e caratterizzareesemplari tipologicamente e cronologicamentelontani.
Teglie (Tav. II, 6)
Dall’US 1185 e dall’US 1181 provengonoalcuni frammenti marroni micacei, a granulo-metria fine, pertinenti a un recipiente di grandidimensioni (il diametro all’orlo raggiunge i40,4 centimetri), identificabile come una sortadi teglia, dall’orlo ingrossato internamente,appiattito superiormente e con profilo squa-drato, con superficie esterna rifinita a scopettato(Tav. II, 6), che trova un confronto puntuale aGrosio-Dosso dei Castelli51, in contesti di VI-V secolo a.C., e affinità con teglie dotate diprese a linguetta o anse verticali e orli ingrossatiinternamente da Himmelreich-Kuppe nellavalle dell’Inn52.
Materiali di V-III secolo a.C.53
Si datano a questa fase recipienti provenienti dailivelli tumuliformi addossati all’altare inpietra54, dagli strati in relazione con il recinto
(51) Materiale dal Dosso dei Castelli: POGGIANIKELLER 1995, fig. 77, 1, p. 85.(52) APPLER, ALTENBURGER, ZEISLER 1997, Taf.8, 13, 21, Taf. 12, 20, 21, 25, p. 25, Taf. 21, 13 e 15, p.34.(53) Olle: Tav. II, 7-12 (St. 160376, US 1174; St.160293, St. 160283, US 1129; St. 160229, US 1171; St.160207, US 1122; St. 160165, US 1182). Boccali: Tav.III, 1-15 (St. 160237, St. 160238, St. 160240, US 1177;St. 160367, St. 160368, St. 160369, St. 160571, St.160573, US 1173; St. 160380, US 1174=1173; St.160273, US 1129; St. 160323, US 1150; St. 160160, US1182; St. 160557, US 1169; St. 160319, US 1148; St.160208, US 1122); Tav. IV, 1-13 (St. 160377, US 1174;St. 160309, St. 160299, US 1129; St. 160262, US 1204;St. 160365, US 1173; US 1181; St. 160285, US 1129;St. 160202, US 1126; St. 160383, US 1174; St. 160364,US 1173; St. 160289, US 1129; St. 160241, US 1177;St. 160254, US 1181). Bacili: Tav. V, 1-18 (St. 160197,US 1149; St. 160199, US 1126; St. 160234, US 1145;St. 160239, US 1177; St. 160260, US 1124; St. 160278,St. 160279, St. 160291, St. 160304, St. 160546, US1129; St. 160314, US 1125; St. 160316, US 1148; St.160327, US 1172; St. 160334, US 1147; St. 160378, St.160545, US 1174; St. 160388, US 1151; St. 160228, US1171 e US 1177). Teglie: Tav. VI, 1-6 (St. 160373, US1173; St. 160539, US 1129; St. 160387, US 1151; St.160216, US 1185; St. 160270, US 1129; St. 160370, US1173). Tazze: Tav. VI, 7-11 (US 1173; St. 160296, St.160297, US 1129; St. 160372, US 1173; St. 160227, US1171).(54) US 1181, US 1177, US 1173=1174 e US 1129.
(62) POGGIANI KELLER 1995, fig. 20, 15, p. 32; fig.21, 10, p. 34; fig. 78, 2-5, 7, 11, p. 87; fig. 80, 10, p.90.(63) GLEIRSCHER 1987, Abb. 63, 9 e in particolare10, p. 347.(64) Si veda in particolare per il frammento di olletta conorlo estroflesso a breve tesa obliqua sfuggente verso l’in-terno di Tav. II, 8 CONRADIN 1978, Abb. 76, 10, p.137.(65) Frammenti con scanalature orizzontali da Borno-Val-camera sono pertinenti a boccali tipo Dos dell’Arca (DEMARINIS 1989, fig. 124, p. 115). La medesima deco-razione è presente su un frammento di parete con attaccodella gola decorata da fitte solcature orizzontali a Grosio-Dosso dei Castelli, in associazione a frammenti di boccaletipo Dos dell’Arca (POGGIANI KELLER 1995, fig.21, 10, p. 32).(66) L’olla proviene dall’US 1182 che è uno dei livelli inrelazione al recinto ellittico posto fra i due altari.(67) Per Birgitz-Hohe Birga si rimanda a GLEIRSCHER1987, Abb. 38, 3, p. 322; per Himmelreich-Kuppe si vedaAPPLER, ALTENBURGER, ZEISLER 1997, in parti-colare Taf. 6, 2 e 20, p. 19.(68) PERINI 1969a, pp. 180-183.(69) DE MARINIS 1982a, pp. 90-91; DE MARINIS1989, pp. 109-111, con carta di diffusione in fig. 125,p. 116; DE MARINIS 1992, pp. 155-158 e carta di
(55) US 1182.(56) US 1150.(57) US 1171, US 1124, US 1148=1151 e US 1122.(58) US 1177 e US 1174=1173.(59) Osservazioni sulle modifiche nelle presenze e nel-l’articolazione morfologica della ceramica sono anchein ambito paleoveneto a Este, nei santuari di Meggiaroe ad Altino, dove la ceramica più antica è rappresentatada olle, mentre nelle fasi più recenti è più numeroso ilvasellame da libagione (GREGNANIN 2002, pp. 164-165; TIRELLI 2002, p. 315).(60) Da US 1122 (strato legato alla sistemazione flaviadell’area) e US 1171 (livello di età augustea), da US1129 e da US 1174 (livelli dei depositi tumuliformiaddossati all’altare).(61) Ollette con orlo e decorazione analoga sono adesempio da Montorio Veronese (BIONDANI,CORRENT, SALZANI 2000, p. 62 e p. 64, fig. 3, 7-8)in contesti datati al V secolo a.C. e da San Giorgio di Val-policella (SALZANI 1992, pp. 46, 55-57, 61, 65 e tav.III, 2, 4 e 6; tav. IV, 7-11, 13-16; tav. V, 13, 15, 17; tav.IX, 4-7; tav. XIII, 11) in contesti datati fra V e inizio delIII secolo a.C.
cerimoniale ellittico innalzato a nord dell’altarestesso55 e dal piano di calpestio in terra battutainterno al recinto56. Frammenti pertinenti avasellame di V e IV secolo a.C. si trovano, comeapporti residuali, anche negli strati di età giulio-claudia e in quelli relativi al livellamento eall’obliterazione delle strutture protostorichein età flavia57.Gli orizzonti di V-IV secolo a.C. denotano uncambiamento nella ceramica funzionale al cultoe un’evoluzione del rituale verso pratiche prin-cipalmente libatorie, con una netta predomi-nanza di boccali e vasellame potorio di dimen-sioni medio-piccole che negli strati “centrali”58
dei depositi carboniosi addossati all’altare rap-presentano oltre l’80% della ceramica59. Unconfronto sui dati ponderali dei frammenti daquesti depositi mostra inoltre come rispetto ailivelli di VI-V secolo a.C. il quantitativo diceramica deposta sia più che raddoppiato, conquesto testimoniando una frequentazione piùintensiva del santuario.
Olle (Tav. II, 7-12)
Fra i materiali inquadrabili fra V e IV secoloa.C. vi sono alcuni frammenti di ollette concorpo ceramico scuro, micaceo a granulometriafine, con orlo estroflesso e spalla decorata dafasci di solcature orizzontali60 (Tav. II, 7-11):l’andamento dell’orlo rispetto alla spalla e lasintassi decorativa trovano corrispondenze inambito paleoveneto con ollette diffuse fra V efine del IV secolo a.C.61. La decorazione con
motivi a sottili solcature orizzontali caratte-rizza anche recipienti di tradizione centroalpina,come mostrano ad esempio vasi da Grosio-Dosso dei Castelli62 e da Birgitz-Hohe Birga63,e nei Grigioni alcune olle del gruppo Schneller64.Lo stesso motivo ornamentale si ritrova anchesu alcuni boccali, soprattutto nella versioneDos dell’Arca, diffusa a partire dal III secoloa.C.65, tuttavia distinta dai frammenti in esameda un orlo maggiormente estroflesso e dallagola nettamente separata dall’alta spalla arro-tondata.Possiamo ascrivere fra V e IV secolo a.C. anchel’olla con orlo estroflesso su breve gola a col-letto66 (Tav. II, 12) sulla base di confronti nellavalle dell’Inn da Birgitz-Hohe Birga e da Him-melreich-Kuppe67. Difficilmente determinabilia livello crono-culturale, morfologico e tipo-logico sono infine numerosi orli micacei, varia-mente estroflessi, che potrebbero essere attribuititanto a ollette, quanto a boccali.
Boccali (Tav. III, 1-15; Tav. IV, 1-13)
In questa fase il tipo caratterizzante ha cometratti distintivi il fondo appena svasato, il corpoa profilo leggermente concavo, lievemente rien-trante in corrispondenza dell’ansa, spalla brevee arrotondata e orlo estroflesso. Sono ricondu-cibili a tale tipo, definito Stenico A68 oppureBreno-Muota da Clüs69, numerosi frammenti
67
Tav. II. 1-5. Boccaletti globosi; 6. Bacile; 7-12. Ollette (scala 1:3) (dis. A. Massari).
2
3
45
6
7 8 9
1011
12
1
68
di fondo appena svasato dagli strati tumuli-formi addossati all’altare70, dai livelli in rela-zione con il recinto71 e, come apporti residuali,dai livelli legati alla fase giulio-claudia e agliinterventi di età flavia72 (Tav. III, 1-15). Ilcorpo ceramico che caratterizza questi boccaliè grigio micaceo (1F), oppure grigio-rosato,compatto e lucidato a stecca (gruppo 3=8F), oancora rosato, con inclusi opachi affioranti insuperficie (gruppo 5=5F). L’evidente variabilitànel grado di accentuazione della svasatura fra unesemplare e l’altro rivela l’esistenza di variantiper così dire “intermedie” e anticipatrici delsuccessivo tipo Dos dell’Arca, distinto per ilcaratteristico piede “a trombetta”, fortementesvasato, e la parete dalla concavità pronun-ciata73. I frammenti di Tav. III, 4 e 8 rappre-sentano una sorta di variante più schiacciata,confrontabile con un boccale da Mesocco-Coopin Val Mesolcina74. Fra gli esemplari presentia Breno-Spinera si differenziano per la presenzadi elementi decorativi il frammento micaceo
distribuzione in fig. 7, p. 160; DE MARINIS 1999, pp.119-120, con carta di diffusione in fig. 1, p. 121. Boccalio bicchieri monoansati con corpo più o meno sinuosoe parete inflessa in corrispondenza dell’ansa (Henkeldel-lenbecher) sono diffusi, con numerose varianti, nell’arcoalpino centro-orientale per tutta l’età del Ferro (DEMARINIS 1982a, DE MARINIS 1989, DE MARINIS1992 e DE MARINIS 1999; MARZATICO 2001, p.511, con carta di distribuzione in fig. 40, p. 525; GLEIR-SCHER, NOTHDURFTER, SCHUBERT 2002, p.116 e tav. 146 con carta di distribuzione) e perduranofino alla tarda età romana. L’areale di massima diffu-sione dei boccali tipo Breno e dei successivi tipo Dos del-l’Arca e tipo Lovere corrisponde alla Valcamonica, allaValtrompia, alla Valtellina e alle Giudicarie e coincide conle attestazioni di iscrizioni preromane in alfabeto diSondrio o camuno. Sulla base di queste osservazioni, levalli alpine della Lombardia orientale risultano caratte-rizzate secondo De Marinis da una specifica facies cul-turale, distinta da, ma in stretta relazione con, quella diFritzens-Sanzeno. Recenti osservazioni sulla scansionecrono-tipologica dei boccali tipo Henkeldellenbecher sonoin LEITNER 2004-2005.(70) US 1177, US 1173, US 1174 (=US 1173) e US1129.(71) US 1150 (piano d’uso) e US 1182.(72) US 1169, US 1148 e US 1122.(73) Sul tipo Dos dell’Arca si veda DE MARINIS 1989,pp. 111-117 e figg. 120 e 123; DE MARINIS 1992,pp. 156-158. L’esistenza di forme intermedie tra il tipoBreno e quello Dos dell’Arca è già stata prospettata daMarzatico a proposito dei materiali dal sito di Monte SanMartino di Riva del Garda (MARZATICO 2007, p.174).(74) CONRADIN 1978, Abb. 66, p. 126. Il boccale èassociato a quattro fibule a drago ascrivibili al GolaseccaIIIA1.
piglia con un disegno a raggiera (esempi sono a MonteSan Martino del Garda: MARZATICO 2007, tav. 3, 1-2, p. 185 e a Vigo Lomaso, nelle Giudicarie: PERINI1978, fig. 11, 1, p. 366).(77) POGGIANI KELLER 1995, pp. 31-32, fig. 20,13.(78) POGGIANI KELLER 1989a, fig. 72, 9, p. 67.(79) RAGETH 1989, p. 171 e RAGETH 1999.(80) Esempio al Monte Ozol e a Vadena (MARZATICO1992a, p. 215 e nota 18).(81) I frammenti provengono dai livelli carboniosi US1174 e US 1129.(82) I frammenti provengono dall’US 1129 e dall’US1204 (piano d’uso tra l’altare nord e il recinto ellittico).La medesima decorazione sull’attacco dell’ansa si ritrovaad esempio a Stenico (PERINI 1969a, fig. 3, in parti-colare nn. 2, 3, e 9, p. 182).
(75) La decorazione a occhi di dado caratterizza ancheun frammento di fondo concavo di boccale tipo Brenoproveniente dal sito di Temù, che ha anche cordonaturenel punto di massimo restringimento, secondo un motivosolitamente più frequente nel tipo Dos dell’Arca (POG-GIANI KELLER 2001, fig. 19, 4, p. 11; POGGIANIKELLER 2009, tav. XV, 1, p. 65).(76) L’ipotesi, prospettata da De Marinis (DE MARINIS1989, p. 110), non è applicabile a Spinera dove la deco-razione più ricorrente è quella a cerchielli impressi, pre-senti tanto sul tipo Breno, quanto sul tipo Dos dell’Arca.Fra i motivi che altrove caratterizzano il repertorio deco-rativo dei boccali tipo Breno vi è quello che prevede unaserie di piccoli triangoli convergenti impressi a stam-
(Tav. III, 8 e Fig. 3) con cerchielli a occhi didado impressi a stampiglia accompagnati dasemplici motivi resi a rotella75 e due esemplari,con corpo ceramico rosato del gruppo 3=8F(Tav. III, 6-7), decorati l’uno da un motivo afiore a quattro petali impressi a stampiglia inprossimità del fondo e l’altro da cerchielli aocchi di dado sul corpo. A eccezione del motivoa quattro petali, che rappresenta un unicumnel complesso di Breno-Spinera e per il qualenon sono stati trovati confronti puntuali daaltri siti, il repertorio decorativo che caratte-rizza i boccali tipo Breno non sembra differen-ziarsi in maniera esclusiva da quello delle solu-zioni più recenti76. Il boccale dal fondo leg-
germente concavo (Tav. III, 13 e Fig. 4) hacorpo ceramico micaceo, superficie lucidata astecca e sovradipintura rossa, con un tratta-mento della superficie che contraddistingueràanche i boccali tipo Dos dell’Arca. Frammentidi boccali tipo Breno con sovradipintura rossasono noti altrove in Valtellina, da Grosio-Dossodei Castelli77 e da Tresivio-località Castello-Calvario78.La tradizione di dipingere alcune zone dei vasicon tinte rosse, a volte associate a decorazioninere a grafite, è ampiamente attestata nellanecropoli di Tamins, così come in altri siti deiGrigioni (ad esempio a Felsberg e a Chur),allacciandosi a espressioni vascolari della culturadi Hallstatt C2/D1 dell’area Svizzera e dellaGermania meridionale79. Esemplari ceramicidipinti in rosso sono annoverati anche nel-l’areale meridionale del gruppo Fritzens-Sanzeno, quando, a partire dal VI secolo a.C.,si diffonde anche l’abitudine di decorare i reci-pienti con motivi a stampiglia a occhi di dado,a punti, a linee verticali, a triangoli conver-genti ecc.80. Rientrano in questo gusto deco-rativo diversi frammenti a corpo ceramicomicaceo, con sovradipintura rossa e/o decora-zione a occhi di dado81 (Tav. IV, 1-2), e alcuniframmenti a impasto granuloso grigio-rosato(gruppo 3=8F)82 (Tav. IV, 3-4). Appare interes-sante osservare come la sovradipintura rossacontraddistingua esclusivamente vasellame acorpo ceramico micaceo (1=1F).Nel santuario di Spinera, la frequente associa-zione di boccali tipo Breno e boccali tipo Dosdell’Arca lascia ipotizzare il coesistere delle duevarianti tipologiche per un certo periodo equindi la possibilità di estendere almeno finoagli inizi del III secolo a.C. la cronologia delprimo boccale, tradizionalmente ascritto,
Fig. 3. Frammento di boccale con decorazione acerchielli impressi.
Fig. 4. Frammento di boccale a fondo concavo.
71
seguendo De Marinis, fra V e IV secolo a.C.83.Seguendo la classificazione del medesimoautore84 potrebbero appartenere al tipo Brenoanche alcune anse micacee a sezione ellitticalievemente carenate85 (Tav. IV, 5-6), a sezionebiconvessa con larga scanalatura centrale86 (Tav.IV, 7-9) e a sezione semicircolare con due sca-nalature longitudinali parallele87 (Tav. IV, 10).In realtà, come già osservato, in assenza di altrielementi discriminanti è bene mantenere delleriserve nelle attribuzioni cronologiche e tipolo-giche delle anse, che a Breno sono rappresentateda un’ampia variabilità di fogge che rimandanoa numerosi boccali e bicchieri monoansati, mache la genericità o la frammentarietà impediscedi classificare in modo preciso e univoco.I frammenti di boccali tipo Breno (Tav. III, 7e 9) che conservano l’attacco dell’ansa indicanocome questa fosse piuttosto spessa, a sezioneellittica e apparentemente liscia. L’evidenza percui i gruppi di impasto 3=8F e 5=5F non sem-brano caratterizzare mai il più recente boccaletipo Dos dell’Arca può essere indicatore perriferire al tipo Breno il frammento di orlo estro-flesso su alta spalla arrotondata, con ansa asezione ellittica liscia e frammento di paretecon motivo inciso a impasto rosato (5=5F)88
(Tav. IV, 11), e per datare entro lo stesso oriz-zonte cronologico le anse a nastro, lisce a sezionepiana a impasto 3=8F89 (Tav. IV, 12) e 5=5F90
(Tav. IV, 13).
Bacili (Tav. V, 1-18)
Assenti nei livelli più antichi91, ma presenti innumero considerevole92 nei depositi tumuli-formi addossati all’altare in associazione a mate-riale databile dal V secolo a.C., sono frammentiriferibili a bacili dal corpo ceramico micaceo,con inclusi affioranti, orlo ingrossato, spesso
(83) DE MARINIS 1989, p. 111 e DE MARINIS 1992,p. 156.(84) DE MARINIS 1989, pp. 110-111 e fig. 120 per unrepertorio esemplificativo di anse attribuite al tipo Brenodal sito di Dos dell’Arca.(85) Le anse vengono dall’US 1173 e dall’US 1181.(86) I frammenti provengono dai depositi legati all’altarenell’area sud (US 1129 e US 1173) e dall’US 1126(livello di riporto di età giulio-claudia).(87) Dall’US 1173.(88) I frammenti vengono dall’US 1129.(89) Dall’US 1177.(90) Dall’US 1181.(91) Assenti nelle fossette della prima fase e nell’US1185.(92) Almeno sette bacili sono da US 1177; nove da US1174; almeno trenta diversi da US 1129.
(100) Frammenti di teglie sono da US 1173 e US 1129(depositi in relazione all’altare a sud) e da US 1151(livello relativo al santuario romano di età giulio-claudia).(101) Una trentina di campioni di teglie da contestiprotostorici trentini sono stati analizzati da chi scrivenel 2007 su gentile concessione della Soprintendenzaper i Beni Archeologici della Provincia Autonoma diTrento, per cortesia del dottor G. Ciurletti e della dot-toressa L. Endrizzi (SOLANO 2006-2007). La maggiorparte degli esemplari esaminati (le analisi, condotte nellaboratorio di Scienze della Terra dell’Università di Pavia,sono state seguite dalla dottoressa E. Basso e dalla pro-fessoressa M.P. Riccardi) proviene da contesti databilitra V e IV secolo a.C. (Fai della Paganella-Dos Castel;Mazzin-Dos dei Pigui; Tesero-Sottopedonda; Sanzeno-fondo Paternoster; Castel Tesino-Dosso Sant’Ippolito).(102) I primi esemplari sicuri di teglie con prese a lin-guetta sono dalla necropoli di Vadena e si datano all’VIIIsecolo a.C. (DAL RI 1992, fig. 8, 4). Nel corso del VI
(93) POGGIANI KELLER 2001, fig. 19, 5, p. 11 e p.13; POGGIANI KELLER, DE VANNA 1999-2000,pp. 49-50 e fig. 43; POGGIANI KELLER 2009, pp.43-46 e tavv. I-VI, pp. 61-62 e tavv. XIX-XXIX, pp. 66-68.(94) Da Teglio-Dos de la Forca e Panaggia e da Valdisotto-San Martino di Serravalle (POGGIANI KELLER 1995,fig. 84, 3, 5, 6, 9, 10, 26 e 27, p. 99); da Grosio-Dossodei Castelli (POGGIANI KELLER 1995, fig. 21, 20, p.34).(95) A Surcasti-Kirchenügel (CONRADIN 1978, Abb.61, 3, p. 121), a Sagogn-Schiedberg (CONRADIN1978, Abb. 65, 1, p. 125) e Chur-Markthallenplatz(CONRADIN 1978, Abb. 70, p. 130).(96) POGGIANI KELLER 2001, p. 13; POGGIANIKELLER 2009, p. 44.(97) POGGIANI KELLER 2001, p. 13; POGGIANIKELLER, DE VANNA 1999-2000, p. 50; ARDOVINO2009, p. 92.(98) Tre diversi bacili sono da US 1126, tre da US 1149;un frammento da US 1147; sei da US 1151; un fram-mento da US 1171; uno da US 1148.(99) Da US 1171 e da US 1177.
ripiegato, ribattuto esternamente e più o menoondulato, corpo sovente decorato da striaturea pettine o scopettato, vasca concava e fondodistinto da un leggero gradino, rispondenti allatipologia ben riconosciuta in alta Valcamonicaa Temù in contesti di VI e V secolo a.C.93, pre-sente in ambito centroalpino in Valtellina inassociazione a materiali databili fra fine VI e IIIsecolo a.C.94 e nei Grigioni95 in contesti del-l’Hallstatt C/D, per cui si è ipotizzata una spe-cifica produzione localizzata intorno alle Alpiretiche96. La particolarità del fondo, lo spessoresottile delle pareti e l’attenzione nella rifinituradell’orlo e della superficie lasciano ipotizzareche questi recipienti volessero imitare vasi inlamina metallica, proponendosi quindi comeprodotti di un certo pregio97.A Spinera di Breno frammenti diffusi di talirecipienti, adatti alla mensa e all’offerta (disemi? granaglie?) e che verosimilmente pren-devano parte anche a cerimonie libatorie con-nesse a bagni e abluzioni rituali, anche nei livellidella tarda età del Ferro e della prima etàromana, in associazione a materiali di III-Isecolo a.C. quali boccali tipo Dos dell’Arca eolle situliformi tipo Wattens98, denotano lafortuna della forma, perdurante probabilmentealmeno fino agli inizi del III secolo a.C.Alcuni esemplari, come ad esempio quello diTav. V, 1899, hanno orlo ripiegato sia esterna-mente che internamente, superficie esterna piùscabra e interna più liscia, rifinita da sottilistriature a scopettato. L’evoluzione dell’orlo,da ondulato a semplicemente ingrossato e
appiattito, non rappresenta a Spinera un indi-catore utile a differenti determinazioni crono-logiche, dal momento che nel medesimo stratosi trovano insieme frammenti con orli molto ete-rogenei (Tav. V, 1-17).
Teglie (Tav. VI, 1-6)
Sono databili allo stesso periodo alcune teglie100
(Tav. VI, 1-3 e Fig. 5) dal corpo ceramico cal-citico, con pareti spesse, dal profilo tronco-conico e con larghe prese a linguetta sul fondo(Lappenbecken) che, rispetto ai bacili tipo Temù,mostrano minore accuratezza nella realizza-zione e nell’impasto, lasciando intuire una desti-nazione meno ricercata e piuttosto mirata allapreparazione, cottura e offerta di cibo (pani,focacce?). Osservazioni condotte su alcuni esem-plari dal Trentino101 hanno permesso di rico-struire l’evoluzione tecnologica e morfologicadi tale recipiente, che, presente in area retica findall’VIII secolo a.C., si diffonderà in manieramassiccia in Valcamonica e nel Bresciano conla romanizzazione, perdurando fino alla tardaetà romana102.
Fig. 5. Frammento di teglia con presa a linguetta.
72
Tav. V. Bacili tipo Temù (scala 1:3) (dis. A. Massari).
1 23
4
5
6
7 8 9
10
11 12 13
14 15
16
17 18
73
La forma, a profilo troncoconico e fondo pianosu cui si impostano quattro prese a linguetta, haorlo estroflesso, indistinto o lievementeingrossato, tagliato e appiattito superiormente;le pareti, piuttosto spesse, sono sovente lisciatea stecca e in alcuni casi rifinite con leggerestriature rese a scopettato. Il corpo ceramico, dicolorazione marrone-rossastro o grigio-marrone,è ricco di inclusi calcitici, a granulometriamedio-grossa, ed è frequentemente alterato dalfuoco. Sulla base dei confronti con gli esemplaritrentini103 e veneti104, dei contesti di rinveni-mento e delle associazioni (boccali tipo Brenoe Dos dell’Arca, bacili tipo Temù), i frammentida Breno possono essere datati fra V e III secoloa.C.Avvicinabili per il corpo ceramico ricco diinclusi calcitici alle teglie con presa a linguetta,ma morfologicamente affini ai bacili tipo Temùper l’andamento concavo della vasca, per lospessore più fine delle pareti e per l’orlo, sonoalcuni frammenti con orlo ingrossato, appiattitosuperiormente, ripiegato e ribattuto esterna-mente105 (Tav. VI, 4-5), e un frammento di
secolo a.C. nella valle dell’Inn si sviluppa una formasimile, ma con anse verticali coassiali, in alcuni casi conorlo schiacciato e ondulato affine al tipo Temù (CON-RADIN 1978, Abb. 32 e Abb. 64, pp. 99 e 125), atte-stato ad esempio nel vicentino a Rotzo (LEONARDI,RUTA SERAFINI 1981, fig. 35, p. 38) accanto a formecon prese a linguetta. Nel corso del V e IV secolo a.C.la diffusione delle Lappenbecken nell’arco alpino centro-orientale investe tutto l’areale della cultura Fritzens-Sanzeno, compreso il territorio delle Prealpi venete:MARZATICO 1992a, pp. 219-220, fig. 3, 4; GLEIR-SCHER, NOTHDURFTER, SCHUBERT 2002, concarta di diffusione (tav. 145 e lista 58). Per osservazionisulle caratteristiche morfologiche e sul ciclo di produzionedi tali teglie si veda SOLANO 2006-2007 e SOLANO,BASSO, RICCARDI c.s.(103) Quasi tutte le teglie trentine si datano fra V e IVsecolo a.C.: per Tesero si rimanda a MARZATICO 1991,tav. II, 9 e 13, p. 388, tav. V, 3, p. 395, tav. VII, 4, p. 400,tav. IX, 13, p. 405; per Castel Tesino si veda BRU-SCHETTI 1999, fig. 7, 3 e fig. 11, pp. 47 e 53; per Faidella Paganella MARZATICO 1999b, p. 154 e fig. 7, 7,p. 156. In quest’ultimo caso, il ritrovamento di frammentidi teglie nei pressi del focolare e accanto a uno spiedosembra sottolineare la valenza “da fuoco” di tale reci-piente.(104) Da Montorio Veronese un frammento di tegliacon larghe prese alla base è fra il materiale di IV-IIIsecolo a.C. (BIONDANI, CORRENT, SALZANI 2000,fig. 3, 6, p. 64); da San Giorgio di Valpolicella due esem-plari sono datati fra V e IV secolo a.C. (SALZANI 1992,p. 46 e tav. III, 11, p. 55, tav. XIV, 16, p. 66).(105) Dal livello più antico dei depositi carboniosi in rela-zione all’altare a sud (US 1185) e dal livello più recente(US 1129).
(111) Per Monte San Martino: MARZATICO 2007,tav. 1, 1-2, p. 183; per il Rungger Egg: GLEIRSCHER,NOTHDURFTER, SCHUBERT 2002, tav. 56, 7-8.(112) Per Sanzeno si rimanda a MARZATICO 1993, p.46 e fig. 39, 5, p. 42, p. 50 e fig. 41, 13, p. 44; perPonte San Marco si veda Ponte S. Marco 1994, fig. 61,2, 3, 5, 6, p. 85.(113) Olle: Tav. VII, 1-5 (St. 160308, US 1129; St.160194, US 1149; St. 160264, St. 160331, US 1131; St.160305, US 1129). Boccali: Tav. VII, 6-17 (St. 160204,US 1126; St. 160226, US 1171; St. 160272, US 1169;St. 160274, US 1129; St. 160163, US 1182; St.160164,US 1129; St. 160574, US 1174 e US 1151; St. 160311,US 1129; St. 160243, US 1181; St. 160366, US 1173;St. 160379, US 1174; St. 160300, US 1129); Tav. VIII,1-17 (St. 160162, St. 160166, US 1182; St. 160201, US1126; St. 160230, US 1171; St. 160242, US 1177; St.160256, US 1181; St. 160284, St. 160294, US 1129; St.160236, US 1177; St. 160362, US 1173; St. 160167, US1182; St. 160200, US 1126; St. 160214, US 1169; St.160554, US 1174; pulizia; St. 160281, US 1129; St.160386, US 1151). Teglie: Tav. IX, 1-4 (US 1129; St.160540, US 1151 e US 1129; St. 160205, US 1126; St.160385, US 1151). Tazze e coppe: Tav. IX, 5-14 (St.160280, US 1129; US 1173; St. 160374, US 1174; St.160198, US 1149; St. 160322, US 1150; St. 160528, US963; St. 160326, US 1140; St. 160069, US 1129; St.160161, US 1182; St. 160263, US 1120).(114) US 1129.(115) Frammenti di tali olle sono dall’US 1149 (fase di
(106) Il frammento viene dall’US 1173, quindi da unodei livelli dei depositi carboniosi in relazione all’altare asud.(107) Il frammento viene dall’US 1173.(108) MARZATICO 1992a, pp. 214, 215; MAR-ZATICO 2001, pp. 510-511 e fig. 1, p. 481, con cartadi distribuzione; GLEIRSCHER, NOTHDURFTER,SCHUBERT 2002, pp. 96-100, tavv. 61-75 e tavv. 139,A, 140, B, 141, A, 142 e 143 con carte di distribuzione;MARZATICO 2007, pp. 169-170 e tav. I, 1-3, p. 183.(109) Per Sanzeno si veda MARZATICO 1993, p. 37 efig. 38, 3, p. 41, fig. 42, 6, p. 45; per Tesero MAR-ZATICO 1991, tav. IV, 6, p. 393 (decorata con sol-cature e in associazione a materiale di V-IV secolo a.C.),tav. IX, 2 (ornata con solcature) e 11 (inornata), p. 405(datate al V-IV secolo a.C.); per i reperti di La Groa diSopramonte si veda PERINI 1979, pp. 59-60, in parti-colare i nn. 18-19.(110) I frammenti vengono dai diversi livelli dei depositicarboniosi legati all’uso dell’altare a sud del recinto ceri-moniale (US 1129 e US 1173) e dall’US 1171, riferibilealla fase giulio-claudia.
parete svasata a impasto calcitico con orloingrossato, ripiegato esternamente e ondulato106
(Tav. VI, 6).
Tazze (Tav. VI, 7-11)
È inseribile nel repertorio delle tazze con profiloa S schiacciato rappresentative della cultura diFritzens-Sanzeno o retica dal VI al III secoloa.C. il frammento di orlo estroflesso a tesaobliqua su parete convessa107 (Tav. VI, 7), concorpo ceramico grigio scuro, micaceo con super-ficie lucidata a stecca. Tazze con profilo a S,con orlo più o meno sviluppato, contraddi-stinte da un rilievo interno sul fondo (omphalos),inornate o più spesso caratterizzate da un ampiorepertorio decorativo a stampiglia o a lineeimpresse, sono fra i principali “fossili guida”delle botteghe ceramiche della cultura diFritzens-Sanzeno o retica dal VI al I secoloa.C.108. L’esemplare di Breno trova confronticon tazze ampiamente diffuse fra fine del VI eIV secolo a.C., come testimoniano ad esempiocasi da Sanzeno, Tesero e la Groa di Sopra-monte109.Possono essere riferiti tanto a tazze globose conprofilo a S quanto a ollette frammenti con breviorli estroflessi ingrossati e arrotondati, su ampiaspalla tondeggiante inornata110 (Tav. VI, 8-11). Il profilo li avvicina a tipi di tazze a Sschiacciato diffusi principalmente fra fine delVI e IV-III secolo a.C., ma la frammentarietàdei pezzi impone prudenza, in quanto ilmedesimo orlo estroflesso con labbro ingrossatoe arrotondato può caratterizzare anche ollette
globose, distinte dalle tazze unicamente perl’andamento rettilineo della parete sottostantela spalla. Esemplari di tazze simili ai frammentidi Breno, egualmente inornati, e rientranti nellavariante Fritzens sono infatti ad esempio daMonte San Martino (Trento) e dal sito delRungger Egg (Bolzano)111, mentre olletteovoidi, morfologicamente affini, sono presentia Sanzeno (Trento) e a Ponte San Marco(Brescia) in orizzonti di VI-V secolo a.C.112. Icontesti di rinvenimento collocano i frammentidi Spinera fra V e III secolo a.C.
Materiali di III-I secolo a.C.113
Olle (Tav. VII, 1-5)
Caratteristiche degli orizzonti della tarda etàdel Ferro e della romanizzazione (II-I secoloa.C.) e verosimilmente perduranti almeno finoalla metà del I secolo d.C. sono alcune olle,caratterizzate da una doppia presa sormontanteforata, funzionale all’inserimento di un’ansa inmetallo atta alla sospensione del recipiente sulfocolare. Il tipo, attestato nei livelli superiori deidepositi addossati all’altare114 (Tav. VII, 1) e neilivelli della romanizzazione antecedenti lacostruzione del santuario di età flavia115 (Tav.
74
Tav. VI. 1-3. Lappenbecken; 4-6. Bacili a impasto calcitico; 7. Tazza tipo Fritzens-Sanzeno; 8-11. Tazze/ollette globose (scala 1:3) (dis. A. Massari).
1
2
3
4 5 6
7 8
9 10 11
75
VII, 2-4), è ben esemplificato in Valcamonicadal recipiente integro con ansa in ferro rin-venuto nella casa di Pescarzo di Capo di Ponte,in associazione a materiali datati fra II e I secoloa.C.116.Tali olle rispondono al tipo Wattens di vasisituliformi di tradizione centroalpina che, nellevarianti Wattens, Fritzens e Appiano, caratte-rizzano la cultura Fritzens-Sanzeno117. Olletipo Wattens sono tradizionalmente datate sullabase di contesti tirolesi al medio La Tène (II-Isecolo a.C.)118: diffuse nella valle dell’Inn, inAlto Adige e in Trentino119, nelle Alpi lom-barde esse sono attestate in area valtellinese aGrosio-Dosso dei Castelli120 e in Valcamonica,oltre che a Pescarzo, a Berzo Demo121, aCemmo-Pian delle Greppe122, a Capo di Ponte-Le Sante123 e a Capo di Ponte-Dos dell’Arca124,sempre in associazione a boccali tipo Dos del-l’Arca e/o a teglie con prese a linguetta del tipo“della romanizzazione”. Per quel che riguardagli esemplari di Breno-Spinera i materiali e icontesti di rinvenimento lasciano ipotizzareuna datazione compresa tra gli inizi del I secoloa.C. e la metà del I secolo d.C., confermandoper altro quanto già osservato nell’insediamentodi Berzo Demo, dove tali olle sono in associa-zione a materiali della tarda età del Ferro e dellaprima età imperiale125. Indicazioni più precisea livello cronologico potrebbero probabilmentederivare da analisi archeometriche sul corpoceramico, dal momento che alcuni frammentidella Valcamonica, tra cui un caso da Breno-Spinera126, verosimilmente più antichi, hannoimpasto micaceo, mentre la maggior parte ha
frequentazione giulio-claudia) e dall’US 1131 (piano dicantiere per la realizzazione del santuario di età flavia).(116) ROSSI et alii 1999, tav. I, 4, p. 145.(117) GLEIRSCHER 1987, Abb. 40, 13, p. 324; MAR-ZATICO 1992a, p. 218, fig. 4, 1-2, p. 219.(118) GLEIRSCHER 1987, pp. 228-233.(119) Una carta di distribuzione è in GLEIRSCHER1987, Abb. 12, p. 230.(120) POGGIANI KELLER 1995, fig. 20, 14, p. 32.(121) SOLANO 2006-2007; SOLANO 2008, tav. II, 6,p. 62, tav. III, 2, p. 63, tav. VI, 4, p. 66, tav. XVI, 1, p.76, tav. XVII, 1, p. 77.(122) POGGIANI KELLER 1999-2000, fig. 5, 1, p.238.(123) SOLANO 2006-2007.(124) ANATI 1968, fig. 29, p. 34; DE MARINIS 1989,fig. 123, 1, pp. 114-115.(125) SOLANO 2008, tavv. II, III e XVI, pp. 62-63 e76.(126) Sono micacee una presa sormontante forata daBreno-Spinera US 1129 e una da Berzo Demo(SOLANO 2008, tav. VI, 4, p. 66 e fig. 21 al centro).
1992, fig. 4, p. 156).(132) Così ad esempio a Borno-Val Camera (DEMARINIS 1989, fig. 124, p. 115; DE MARINIS 1992,fig. 5, 1 e 6, p. 157) e a Stenico (PERINI 1969a, fig. 1,7, p. 180).(133) Il boccale viene dall’US 1129. Attribuzioni alboccale tipo Dos dell’Arca sono state proposte per fram-menti analoghi, con orlo estroflesso e alta spalla decoratada solcature orizzontali, da Monte San Martino (MAR-ZATICO 2007, p. 172, tav. 2, 13-15, p. 184).(134) Da US 1181, US 1173 e US 1174 (depositi in rela-zione all’altare a sud del recinto).(135) Da US 1129 (livello più recente dei depositiaddossati all’altare sud).(136) Per la decorazione a stampiglia si vedano POG-GIANI KELLER 1989b, p. 86 e POGGIANI KELLER1995, p. 88; MARZATICO 1992a, pp. 215-216;RAGETH 1999.(137) Si veda Morandi in questo volume.(138) Frammenti ceramici iscritti in caratteri preromaniin Valcamonica sono da Capo di Ponte-Dos dell’Arca(ANATI 1968, fig. 33, p. 38; PROSDOCIMI 1971), daBorno-Val Camera (DE MARINIS 1992, fig. 5, 8 e 11,p. 157), da Pescarzo di Capo di Ponte (ROSSI et alii1999, tav. I, 2, p. 145).(139) Ceramiche con sigle alfabetiche sono piuttostofrequenti in contesti di culto: così ad esempio a Stenico(PERINI 1983, p. 44, fig. 17) e a Monte San Martino(MARZATICO 2007, tav. 1, 14-15, 17, tav. 2, 6-9, 18,tav. 3, 17-19, tav. 4, 5-6, 17, 22-23, pp. 183-186).Numerosissimi frammenti ceramici iscritti sono dalRungger Egg (GLEIRSCHER, NOTHDURFTER,SCHUBERT 2002, tav. 60, 16; tav. 61, 11-15; tav. 62,
(127) L’olletta viene dall’US 1129.(128) ANATI 1968, fig. 29, p. 34.(129) Circa settecentosessanta frammenti di boccali tipoDos dell’Arca, in alcuni casi segnati da grafemi in caratteripreromani, provengono dal sito eponimo di Capo diPonte. La definizione, l’evoluzione rispetto alla precedentevariante Breno e la scansione cronologica del tipo sonostate proposte da R.C. De Marinis (DE MARINIS1982a, pp. 91-92; DE MARINIS 1989, pp. 111-117,figg. 120 e 123 e fig. 125, p. 116 con carta di diffu-sione; DE MARINIS 1992, pp. 156-158 e carta di distri-buzione in fig. 7, p. 160; DE MARINIS 1999, pp. 120-121 e carta di diffusione in fig. 1). Su tale boccale sivedano anche MARZATICO 2001, p. 511 e fig. 40, p.525 (con carta di distribuzione); GLEIRSCHER,NOTHDURFTER, SCHUBERT 2002, p. 116, tav.146, B (con carta di distribuzione) e lista 54, C, p. 146;MARZATICO 2007, pp. 172-173.(130) Dall’US 1182 (strato in relazione al recinto ceri-moniale), dall’US 1129 e dall’US 1174 (depositi carbo-niosi in relazione all’altare a sud del recinto). Appar-tiene al boccale di Tav. VII, 12 da US 1174 anche unframmento da US 1151.(131) DE MARINIS 1989, fig. 124, p. 115; DEMARINIS 1992, fig. 5, p. 157. Analoga decorazionecaratterizza un esemplare di provenienza ignota con-servato al Museo Archeologico di Como (DE MARINIS
corpo ceramico arancio-marrone con inclusimicacei marroni lucenti e tonalite macinata(gruppo 4F=1R), secondo una “ricetta” cheappare tipica dei recipienti della romanizza-zione.È databile a questa fase infine, sulla base del con-testo di rinvenimento127 e di confronti da Capodi Ponte-Dos dell’Arca in associazione a mate-riali di II-I secolo a.C.128, anche un’ollettaglobosa a impasto micaceo fine, con orlo intro-flesso, ingrossato, con profilo a mandorla (Tav.VII, 5).
Boccali (Tav. VII, 6-17; Tav. VIII, 1-17)
I boccali continuano a rappresentare fino al Isecolo a.C. la forma ceramica maggiormenteattestata. Il boccale “fossile guida” in questafase è il tipo definito Dos dell’Arca129, ascrittoal III-I secolo a.C., contraddistinto da un corpoceramico micaceo (1F) e morfologicamente dabase fortemente svasata con piede “a trom-betta”, corpo dal profilo concavo, alta spallaconvessa, orlo estroflesso e parete inflessa peragevolare la presa dell’ansa (Tav. VII, 6-9).Alcuni frammenti di piede130 (Tav. VII, 10-12) sono contrassegnati da costolature paralleleorizzontali nel punto di massimo restringi-mento del fondo, secondo un espediente deco-rativo attestato ad esempio in Valcamonicaanche a Borno-Val Camera131. Il frammento di
Tav. VII, 12 conserva inoltre una sorta di ingob-biatura marrone sulla superficie esterna e traccedi combustione internamente. Motivi a sottilisolcature orizzontali possono decorare la spalladi alcuni esemplari132, elemento che potrebbeattribuire al tipo Dos dell’Arca anche un fram-mento di orlo estroflesso e spalla convessa consolcature133 (Tav. VII, 13).Un discreto quantitativo di frammenti134 (tracui quelli in Tav. VII, 14-16) ha tracce di unasovradipintura rossa, mentre uno135 (Tav. VII,17) conserva una decorazione a stampiglia conmotivo a occhi di dado136. Il frammento inTav. VII, 14 ha ansa a nastro liscia con forocircolare passante realizzato a crudo in pros-simità dell’attacco al fondo.Appartengono a boccali di questo tipo anchealcuni frammenti iscritti con grafemi in caratteripreromani137. La ricorrente presenza di segnie lettere alfabetiche o pseudoalfabetiche suboccali tipo Dos dell’Arca, oltre che (più rara-mente) tipo Breno e su coppe138, contribuiscea connotare tali recipienti di una particolarevalenza magico-religiosa, caratterizzandoli comedoni di prestigio139.
76
Tav. VII. 1-4. Olle situliformi tipo Wattens; 5. Olletta; 6-17. Boccali tipo Dos dell’Arca (scala 1:3) (dis. A. Massari).
1 2 34
5
6 7 8
9 10 11
12 13 14
15 16 17
77
Secondo la classificazione di De Marinis140
possono essere attribuite al tipo Dos dell’Arcaanche numerose anse micacee a sezione ton-deggiante o piano convessa con stretta e pro-fonda scanalatura centrale141 (Tav. VIII, 1-8).Tuttavia, alcuni boccali micacei a fondo pianoe parete inflessa in corrispondenza dell’ansa142
(Tav. VIII, 9-10) mostrano come tale ansa nonsia esclusiva del tipo Dos dell’Arca, che peraltro, come ben evidenziato da due esemplarida Pescarzo di Capo di Ponte, può avere ancheansa con doppia scanalatura143, simile ai fram-menti in Tav. VIII, 11-13144. Sempre a Pescarzodi Capo di Ponte è evidente come questaseconda soluzione di ansa possa caratterizzareanche il boccale tipo Lovere, che rappresenta unulteriore stadio evolutivo dei boccali con pareteinflessa che, con esiti e soluzioni diverse, pro-seguiranno fino alla tarda età romana.Il tipo Lovere, definito anche Stenico B eascritto fra I secolo a.C. e metà del II secolod.C.145, si distingue dalle soluzioni più anticheper il corpo ceramico marrone-arancio coninclusi micacei, bianchi, neri e grigi opachi(simile a quello 4F=1R) e per la forma, a paretitroncoconiche, con fondo piano, spalla ampiae arrotondata e orlo estroflesso, su cui si innestal’ansa che arriva fino alla parte inferiore delcorpo. La parete del corpo in corrispondenzadell’ansa non è più semplicemente appiattitacome nei boccali più antichi, ma è fortementerientrante verso l’interno del vaso. La super-
12 e 14; tav. 63, 7 e 21; tav. 64, 16; tav. 65, 5-6, 17; tav.66, 6 e 13; tav. 67, 3, 6, 9, 15; tav. 68, 1, 6, 17; tav. 69,4-5, 10-13, 18; tav. 70, 3; tav. 71, 1-16; tav. 73, 1-2, 8,20; tav. 75, 23; tav. 77, 1-6, 8, 20; tav. 78, 10, 12, 16-18; tav. 79, 9-10, 16-17; tav. 80, 7-22; tav. 81, 1-24; tav.82, 1-24; tav. 83, 1-20; tav. 93, 3, 25-28; tav. 99, 18; tav.108, 9-39; tav. 109, 1-19; tav. 110, 44-49; tav. 111, 1-35; tav. 112, 18-33; tav. 114, 15-17; tav. 115, 1-3; tav.118, 8; tav. 121, 1; tav. 122, 7).(140) DE MARINIS 1989, pp. 110-111.(141) Dai livelli in relazione al recinto cerimoniale (US1182) e all’altare a sud del recinto (depositi US 1181, US1177, US 1129) e dai livelli della romanizzazione (US1126 e US 1171).(142) Da US 1177 e US 1173.(143) ROSSI et alii 1999, tav. I, 1-2, p. 145.(144) Dall’US 1182 e dai livelli di età giulio-claudia US1126 e US 1169.(145) Per la definizione del tipo si vedano PERINI1969a, p. 181; DE MARINIS 1982a, p. 92 e fig. 17, 2-3, p. 89; DE MARINIS 1989, pp. 111 e 117; DEMARINIS 1992, p. 158. Carte di diffusione sono inGLEIRSCHER, NOTHDURFTER, SCHUBERT2002, lista 56, p. 147 e tav. 146, B e in MARZATICO2001, fig. 40, p. 525.
(151) CONRADIN 1978, Abb. 26, p. 92.(152) POGGIANI KELLER 1995, fig. 20, 15-16, p.32.(153) POGGIANI KELLER 1999, fig. 15, p. 182.(154) GLEIRSCHER, NOTHDURFTER, SCHUBERT2002, tav. 58, 2, 4, 6, 9, 11, tav. 88, 19, tav. 90, 9.(155) US 1129 (livello più recente fra i depositi cor-relati all’uso dell’altare a sud del recinto) e US 1151(riporto di età giulio-claudia).
(146) Per i boccali da Lovere si vedano DE MARINIS1982a, fig. 17, 2-3, p. 89 e TIZZONI 1984, p. 109 e tav.CXI, a-b; per Capo di Ponte-Dos dell’Arca ANATI 1968,fig. 28, p. 33; per Pescarzo ROSSI et alii 1999, tav. 1, 1-2, p. 145; per Borno JORIO 1999, pp. 243-244, figg.10-11; per Parre POGGIANI KELLER 1989b, fig. 102,4, p. 92; per Stenico PERINI 1969a, fig. 2, 3-4, p. 181.(147) Per Stenico si veda PERINI 1969a, fig. 2, 1-2, p.181; per Vigo Lomaso PERINI 1978, fig. 13, 4, p. 365.(148) Da US 1174.(149) Così ad esempio a Pescarzo (ROSSI et alii 1999,tav. 1, 1-2, p. 145), a Capo di Ponte-Dos dell’Arca(ANATI 1968, fig. 32, p. 37; DE MARINIS 1989, fig.123, 8, 15-16), a Borno-Val Camera (DE MARINIS1989, fig. 124). Dal Dos dell’Arca proviene un ampiorepertorio di fondi con ruote raggiate, con soluzioni dif-ferenti: il frammento 2672SE in ANATI 1968, fig. 32ha una ruota con otto raggi, simile al caso di Breno. Perulteriori riscontri del motivo della ruota raggiata sivedano a titolo esemplificativo i casi di Monte SanMartino (MARZATICO 2007, p. 172, fig. 4 e tav. 3, 4-6, p. 185 e ulteriori riferimenti in nota 25) e Stenico(PERINI 1969a, p. 185).(150) Per Pescarzo si rimanda a ROSSI et alii 1999, tav.1, 3, p. 145; per il Dos dell’Arca si veda in DE MARINIS1989, fig. 123, il frammento n. 14 con fondo piano.
ficie del corpo, a eccezione della parte inflessa,è spesso caratterizzata, come nei casi di Lovere,Capo di Ponte-Dos dell’Arca, Pescarzo, Borno,Parre e Stenico, da una decorazione a motivi atacche lineari e rosette rese a stampiglia146,mentre è priva di decorazione in alcuni esempitrentini da Stenico e Vigo Lomaso147. L’ansa,a sezione piano convessa o ellittica, può avereprofonda scanalatura centrale (come in un esem-plare da Lovere), larga scanalatura centrale(come a Borno), oppure essere a nastro liscia(come a Parre), o ancora solcata da due sottiliscanalature longitudinali (come in un caso aLovere), o ancora avere una doppia scanalatura(come già osservato per Pescarzo).Possiamo riferire a un boccale tipo Lovere ilfondo piano con resti di parete inflessa in cor-rispondenza dell’ansa e ruota raggiata impressaa rilievo sulla superficie esterna148 (Tav. VIII,14 e Fig. 6a-b) secondo un motivo che, più omeno schematico, caratterizza tanto boccalitipo Dos dell’Arca149 quanto tipo Lovere, comeesemplificato a Pescarzo di Capo di Ponte e alDos dell’Arca150. Nel caso di Breno la morfo-logia del fondo esclude con certezza la perti-nenza al tipo Dos dell’Arca. Sempre a unboccale tipo Lovere si può attribuire un piccoloframmento di parete con corpo ceramicoarancio-marrone (gruppo ceramico 4=4F),decorata da un motivo stampigliato a fileparallele di piccole tacche, recuperato tra i mate-
riali di pulizia della zona sud dell’area durantelo scavo del 2003 (Tav. VIII, 15).Di incerta attribuzione sono infine un fram-mento di orlo esoverso su alto collo distintocon spalla decorata a tacche oblique “a goccia”e solcatura sottostante (Tav. VIII, 16) e unframmento di parete con analoga decorazione(Tav. VIII, 17). Il motivo ornamentale “a goccia”trova confronti, se pure non puntuali, nei Gri-gioni nella ceramica di Tamins151, a Grosio-Dosso dei Castelli, in due frammenti avvicinatial gruppo di tazze tipo Sanzeno152, a Parre nellaBergamasca in un contesto di II-I secolo a.C.153,al Rungger Egg (Bolzano) su alcune tazze ditipo Fritzens e su alcuni frammenti di olle154.Per i frammenti di Breno il profilo e la sol-catura orizzontale che marca la spalla possonolasciare ipotizzare l’attribuzione a boccali che,sulla base dei contesti di rinvenimento155, pos-siamo ritenere dell’orizzonte di III-I secolo a.C.(Fig. 7).
Teglie e bacili (Tav. IX, 1-4)
Fra i materiali dal livello più recente dei depositicarboniosi legati alla struttura d’altare a suddel recinto cerimoniale (US 1129) figurano
Fig. 6a-b. Fondo di boccale con ruota raggiataimpressa.
78
Tav. VIII. Boccali (III-I secolo a.C.) (scala 1:3) (dis. A. Massari).
1
2
3
4
5 6
7 8
9 10
11 12 13
14
15
16
17
79
diverse teglie con corpo ceramico arancio-marrone, con inclusi a granulometria medio-fine (gruppo 4F=1R con tonalite macinata),profilo troncoconico e prese a linguetta sulfondo. Tali teglie, che sono un’evidente evolu-zione delle Lappenbecken di tradizione alpinadella media età del Ferro, diventeranno unadelle forme prevalenti nei livelli della romaniz-zazione e proseguiranno, con diverse soluzioni,fino alla tarda età romana. Teglie dell’orizzontedi II-I secolo a.C., attestate in Valcamonica aCapo di Ponte-Pescarzo e Dos dell’Arca156, sidistinguono dagli esemplari più recenti sullabase del corpo ceramico, di colorazione marronescuro, e dell’orlo, indistinto o appena ingrossato,mentre si rivelano del tutto simili per quel cheriguarda il raffinato ed elaborato trattamentodella superficie a fitte striature a scopettato.Per quel che riguarda Breno-Spinera, mentre sipreferisce rimandare al contributo sulla ceramicadel santuario giulio-claudio157 per una tratta-zione più dettagliata di tali recipienti nel periododella romanizzazione, in questa sede si pre-sentano alcuni esemplari che si possono consi-derare esemplificativi della fase di transizione daiprototipi protostorici alle forme romane. Fraquesti si inserisce la teglia dal corpo ceramicomarrone (4F), lavorato grossolanamente, conorlo indistinto e assottigliato dall’US 1129158
(156) Per Pescarzo si veda ROSSI et alii 1999, tav. I, 5,p. 145; per il Dos dell’Arca si veda ANATI 1968, figg.29-30, pp. 34-35.(157) Si veda Guglielmetti, Solano in questo volume.(158) Confrontabile per la semplicità dell’orlo e la
(162) MARZATICO 1992a, p. 215 e p. 217, fig. 2, 6;MARZATICO 2007, pp. 170-172, tav. I, 4-18 e tav.II, 1-12.(163) Dai depositi US 1129 e US 1173.(164) Dall’intero complesso ceramico provengono unadozzina di frammenti di orli e fondi appiedati, alcuni deiquali probabilmente pertinenti al medesimo recipiente(l’alta frammentazione impedisce di associare i fram-menti in maniera sicura).(165) Il colore dal giallo-rossastro al nocciola-rosato dellasuperficie e l’anima scura (marrone o grigia) evidente infrattura appaiono una costante di questa produzione,come osservato anche in contesti di pianura (GUGLIEL-METTI, LECCA BISHOP, RAGAZZI 1991, pp. 138-142; CORTESE 2003, p. 69). Su tali coppe si vedanoinoltre STÖCKLY 1975; DE MARINIS 1989, p. 108 efig. 116; ARSLAN, MORANDINI, RAGAZZI, ROSSI2008, pp. 254-258, con ampia bibliografia di confronto.
linearità delle pareti con teglie da Monte San Martino(MARZATICO 2007, tav. 5, 17, p. 187) e da BerzoDemo (SOLANO 2008, tav. I, 11, p. 61).(159) Dall’US 1151.(160) Frammenti da US 1129 e da US 1151.(161) US 1126 e US 1151.
(Tav. IX, 1), che rispetto alle teglie della mediaetà del Ferro si distingue per le caratteristichedel corpo ceramico e per il profilo più retti-lineo della vasca, che anticipa quello dei reci-pienti della romanizzazione, ma che tuttaviada questi ultimi si distacca per l’assenza di rifi-nitura sul corpo e per la semplicità dell’orlo.Altri frammenti rimandano invece ai bacili acorpo ceramico micaceo, rivelando una sottileparentela fra questi, le teglie fini della romaniz-zazione e le Lappenbecken protostoriche: fra glielementi indicativi di questo percorso evolutivovi sono una parete micacea con resti di presa alinguetta159, un frammento micaceo di teglia(Tav. IX, 2) a profilo troncoconico con orloingrossato, dal profilo a mandorla, su pareterifinita finemente a pettine160 e due piccoleteglie con corpo ceramico 4F=1R dai livelli dietà giulio-claudia161, con orlo ingrossato,ribattuto esternamente e ondulato e pareterifinita a fitte striature a pettine, del tutto similimorfologicamente ai bacili tipo Temù, ma affinialle teglie della romanizzazione per via del corpoceramico (Tav. IX, 3-4).
Tazze e coppe (Tav. IX, 5-14)
Nei livelli più recenti dei depositi tumuliformiaddossati all’altare protostorico e negli stratidella romanizzazione si rinvengono alcuni fram-menti micacei riconducibili a tazze sinuose,avvicinabili a forme diffuse fra la metà del IIIe gli inizi del I secolo a.C.162 in area retica,quale derivazione terminale delle tazze conprofilo a S presenti dal VI secolo a.C. in tuttol’areale del gruppo Fritzens-Sanzeno. In parti-colare possono rientrare in questo gruppo ditazze, note come tipo Sanzeno e caratterizzateda collo imbutiforme distinto e corpo ombe-licato schiacciato, alcuni frammenti di parete acorpo micaceo fine, con superficie lucidata astecca e tracce di ingobbio scuro, dal profilofortemente convesso163 (Tav. IX, 5-6).A partire dai livelli di III secolo a.C. e con mag-giore incidenza in associazione a materiali di II-I secolo a.C. compaiono, se pure mai in manieraconsiderevole 164, frammenti in ceramicaarancio-rosata, dal corpo ceramico abbastanzadepurato (gruppo 6F), sovente caratterizzatoda un’anima interna più scura, indice di unacottura in atmosfera ossidante ma di qualitàimperfetta, pertinenti a coppe carenate di tra-dizione tardoceltica, diffuse fra V e I secoloa.C. a imitazione di vasellame pregiato a vernicenera165.Tali coppe sono assenti completamente neglistrati più antichi dei depositi tumuliformiaddossati all’altare (US 1185 e US 1181),mentre scarsi frammenti (24 grammi in totale:due frammenti di parete e un frammento diorlo) provengono dall’US 1177, per i quali nonè esclusa un’intrusione dai livelli soprastanti.Le coppe da Breno-Spinera, conservate in con-dizioni di estrema frammentazione, mostrano
Fig. 7. Carta di distribuzione dei boccali tipo Breno, Dos dell’Arca e Lovere.
80
in alcuni casi la superficie lisciata, ma non con-servano tracce evidenti di ingobbio rossastro omarrone come attestato altrove166. Nell’insiemedei frammenti morfologicamente significativisi riconoscono due tipologie principali: unaprima variante ha orlo con profilo a mandorla,dal bordo ispessito e lievemente inflesso, aformare un breve incavo internamente, altacarenatura e andamento sinuoso della parete,vasca profonda e piede ad anello ad andamentoleggermente concavo. Tale tipo, rappresentatodai frammenti di Tav. IX, 7-10167, ha un’ampiadistribuzione geografica e una diffusione cro-nologica di lunga durata, a partire dal V secoloa.C. fino al I secolo a.C. Diffuso nel V secoloa.C. nel periodo Golasecca IIIA, diventacomune nel La Tène B nelle necropoliticinesi168. Nel Bresciano coppe simili sono adesempio dalla città, dal complesso di SantaGiulia169, datate fra II e I secolo a.C., daPezzaze, Valtrompia, datate fra V e III secoloa.C.170, da Flero171, in un corredo funerariodatato fra IV e III secolo a.C.172, a Peschiera delGarda, in associazione a materiali datati fra IIIe II secolo a.C.173. Nel Veronese, figurano frai materiali dei livelli pretemplari del Capitoliumdella città174 e sono presenti a Montorio inassociazione a materiali fra IV e III secoloa.C.175; a Milano si rinvengono in depositi difine del II-inizio del I secolo a.C.176. Per lecoppe da Breno è plausibile una datazione fraII e I secolo a.C.
(166) Così ad esempio a Brescia, Santa Giulia(ONGARO 1999, p. 44) e a Flero (ARSLAN,MORANDINI, RAGAZZI, ROSSI 2008, p. 255).(167) Tali coppe provengono dai livelli US 1173 (depositicorrelati all’altare a sud), da US 1149 (riporti di etàgiulio-claudia), da US 1150 (piano d’uso interno alrecinto cerimoniale) e come elemento residuale da US963 (livello relativo al santuario di età flavia).(168) STÖCKLY 1975, p. 22 e fig. 18.(169) ONGARO 1999, pp. 44-45 e tav. XI, 5-6, tav. XII,1, 3, 5, 7, pp. 527-528.(170) DE MARINIS 1989, fig. 116, p. 108.(171) ARSLAN, MORANDINI, RAGAZZI, ROSSI2008, p. 255, fig. 4, 3-4 e p. 256, fig. 5, 1-2.(172) ARSLAN, MORANDINI, RAGAZZI, ROSSI2008, pp. 254-257 (tipo 2, fig. 4, 3-4, p. 255 e fig. 5,1-2, p. 256).(173) BRUNO, CAVALIERI MANASSE 2000, p. 81,fig. 5, 1.(174) MORANDINI 2008, p. 434, tav. LXIV, 1-2.(175) BIONDANI, CORRENT, SALZANI 2000, p.62 e p. 64, fig. 3, 1, 2, 4, 5.(176) GUGLIELMETTI, LECCA BISHOP, RAGAZZI1991, tav. LV, 3-4 e p. 141. Non è escluso che i fram-menti siano residui più antichi.
(186) Olle e boccali: Tav. X, 1-18 (St. 160252, US 1181;St. 160375, US 1174; St. 160235, US 1177; St. 160258,US 1124; St. 160223, US 1168; St. 160222, US 1168;St. 160231, US 1171; St. 160286, St. 160287, US 1129;St. 160363, US 1173; St. 160382, US 1174; St. 160361,US 1173; St. 160307, St. 160306, US 1129; St. 160318,US 1148; US 1173; St. 160233, US 1145; St. 160277,US 1129). Colini: Tav. XI, 1-3 (St. 160301, St. 160302,St. 160303, US 1129). Coppe: Tav. XI, 4-6 (St. 160584,US 1214; St. 160203, US 1126; St. 160580, US 1129).(187) Dall’US 1181.(188) Per Tesero si veda MARZATICO 1991, tav. II, 19e p. 390 con confronti alla nota 39; per Sanzeno MAR-ZATICO 1993, fig. 38, 32 e 35, p. 41; per Birgitz-HoheBirga GLEIRSCHER 1987, Abb. 27, 19 e 22, p. 311.(189) SOLANO 2006-2007, tav. XXXVII, 10.(190) Dai depositi in relazione all’altare a sud del recinto(US 1174 e US 1177) e dai livelli di età giulio-claudia(US 1124 e US 1168).(191) Per Sanzeno MARZATICO 1993, fig. 36, 15, p.39; per San Giovanni Massimeno MARZATICO 1999a,fig. 3, 39-40, p. 471.(192) Dai livelli di età giulio-claudia (US 1168, US1171) e dai depositi carboniosi in relazione all’altare a suddel recinto cerimoniale (US 1129, US 1173, US 1174).(193) Dall’US 1173.
(177) ONGARO 1999, p. 45 e tav. XII, 4, 6, 8-15, p.528.(178) ARSLAN, MORANDINI, RAGAZZI, ROSSI2008, fig. 4, 1-2, p. 255.(179) DE MARINIS 1997, pp. 137-138.(180) GUGLIELMETTI, LECCA BISHOP, RAGAZZI1991, pp. 141-142, tav. LV, 10 e tav. LVI, 1-11;CORTESE 2003, fig. 3, 2, p. 77.(181) US 1140.(182) US 1129.(183) Tale piede è presente anche su altri recipienti,come vasi a trottola del periodo tardo La Tène. Un ten-tativo di classificazione tipologica e cronologica dei fondidi coppe rinvenute in contesti ticinesi del La Tène C eD è stato effettuato da STÖCKLY 1975, pp. 56-58.(184) Proviene dall’US 1182 (strato in relazione al recintocerimoniale).(185) Dall’US 1120; altri tre frammenti sono anche daUS 1148, da US 1130 e da US 1131.
Una seconda variante, caratterizzata dall’orloinflesso e dalla vasca troncoconica dal profilocurvilineo, è testimoniata da un frammento diorlo e da frammenti di orlo e di piede ad anellocon grafemi preromani (Tav. IX, 11-12). Perquel che riguarda questa coppa, esempi daBrescia, Santa Giulia, sono datati fra II e Isecolo a.C.177. A Flero una coppa simile, macon orlo che prima di inflettersi si alza interrom-pendo la curvatura delle pareti, è in un contestodi IV-III secolo a.C.178. L’andamento a lineacontinua dell’orlo è invece in un esemplare daCastiglione delle Stiviere datato al pieno IIIsecolo a.C.179. Coppe rientranti in questavariante sono a Milano in contesti di fine delII-I secolo a.C.180. Nel caso di Breno, il primoesemplare proviene da uno strato riferibile allivellamento dell’area funzionale all’impianto delsantuario augusteo181 e si data quindi intornoalla fine del I secolo a.C.; la seconda coppa,particolarmente importante data anche la pre-senza di lettere in caratteri preromani, è invecedal livello più recente dei depositi carboniosilegati all’altare protostorico182, in associazionea materiale compreso fra III e I secolo a.C.Appartengono alla medesima tipologia di reci-pienti anche alcuni frammenti di fondo conpiede ad anello, a profilo esternamentesagomato e talvolta leggermente rialzato, nondiscriminanti ai fini di una classificazione pun-tuale183: un frammento di fondo con piede adanello184 (Tav. IX, 13) è in associazione aboccali tipo Breno e tipo Dos dell’Arca, altriframmenti vengono dai livelli più recenti, inassociazione a materiale della romanizzazione185
(Tav. IX, 14).
Materiali di incerta attribuzione cronologica/morfologica186
Olle e boccali (Tav. X, 1-18)
Non si prestano a una precisa determinazionecronologica né a una definizione morfologicaunivoca numerosi orli estroflessi e fondi pianidal corpo ceramico micaceo riferibili tanto aollette quanto, più probabilmente, per il tipodi trattamento e per l’abbondanza di ansetrovate in associazione, a boccali monoansati,genericamente inquadrabili nella seconda età delFerro. Fra i frammenti di fondo si distinguonoil frammento con piccolo piede a sottileanello187 (Tav. X, 1), che trova confronti incontesti protostorici in area retica a Tesero-località Sottopedonda, a Sanzeno e nella valledell’Inn a Birgitz-Hohe Birga188 e in Valca-monica a Berzo Demo189, e alcuni esemplaricaratterizzati da un andamento particolarmenteestroflesso e svasato delle pareti190 (Tav. X, 2-5), assimilabili a frammenti rinvenuti a Sanzenoin Val di Non e a San Giovanni Massimeno inVal Rendena191.Non risultano precisamente inquadrabili perla lunga persistenza della foggia numerose ansea nastro piane o lievemente insellate, tutte aimpasto micaceo192 (Tav. X, 6-11), così comeil frammento di boccale a fondo piano e ansaa nastro liscia193 (Tav. X, 12), la piccola ansa a
81
Tav. IX. 1-4. Teglie; 5-6. Tazze tipo Sanzeno; 7-14. Coppe tardoceltiche (scala 1:3) (dis. A. Massari).
1
2
3 4 5 6
7 8 9
10
11
12
13 14
82
Tav. X. Materiali di incerta attribuzione cronologica: olle e boccali (scala 1:3) (dis. A. Massari).
1 2 3
4
5
6 7
89
1011
12
13
1415
1617
18
83
bastoncello con solcatura mediana194 (Tav. X,13), le anse a sezione piano-convessa con duescanalature longitudinali195 (Tav. X, 14-15) edue frammenti di anse a sezione ellittica concoppella impressa in prossimità dell’attacco allaspalla (Tav. X, 16)196. Possono essere attribuitigenericamente alla seconda età del Ferro alcuniframmenti di ol le con orlo introflesso,ingrossato, a profilo squadrato e rifinitura ascopettato sulla spalla197 (Tav. X, 17-18) chetrovano confronti con un vasetto globoso daCavalese (Trento), Monte Rocca, in associa-zione a materiali datati tra fine della prima etàdel Ferro e inizio della seconda198, in Valca-monica a Berzo Demo, in associazione a mate-riali della seconda età del Ferro199, a Parre, incontesti di VI-V secolo a.C.200. Le caratteri-stiche dell’impasto (corpo ceramico arancio-marrone con inclusi a granulometria medio-fine, assimilabile al tipo 4F=1R) e i contesti dirinvenimento fanno propendere per una data-zione compresa fra III e I secolo a.C.
Colini (Tav. XI, 1-3)
Dai depositi correlati all’altare a sud del recintoellittico201 provengono alcuni frammenti diparete e un fondo a impasto micaceo caratte-rizzati dalla presenza di piccoli fori passantiottenuti a crudo (Tav. XI, 1-3). Benché l’estremaframmentarietà dei pezzi impedisca di risalireall’originaria forma di pertinenza, è ragionevoleriferirli a recipienti a carattere funzionale,impiegati per cuocere a vapore, scolare ortaggio formaggi e/o filtrare liquidi. L’uso di conte-nitori filtro è prassi attestata in antico fin dallapreistoria202 e testimoniata in numerosi contestiprotostorici, romani e altomedievali. Oltre allaceramica potevano svolgere tale funzione ancheoggetti in metallo, come ben testimonianoesemplari in bronzo da Nomi-Bersaglio in
(194) Dall’US 1129.(195) Dall’US 1129 e dall’US 1148 (livello riferibileagli interventi di età giulio-claudia).(196) Dall’US 1177 e dall’US 1173. Confronti da Stenico(PERINI 1969a, fig. 3, 8, p. 182).(197) Dall’US 1145 e dall’US 1129. Un frammento diorlo e uno di fondo sono anche dall’US 1177 e dall’US1173.(198) LEONARDI 1991, fig. 140, 2, p. 120.(199) SOLANO 2006-2007, tav. XL, 3.(200) POGGIANI KELLER 1992, fig. 7, 14, p. 319.(201) Da US 1177, US 1173=1174 e US 1129.(202) Come testimonia ad esempio un frammento datatoal Bronzo Recente da San Martino di Lupari(BIANCHIN CITTON 1989, fig. 20, 2, p. 235).
(213) DE MARINIS 1989, fig. 119, 1, p. 110.(214) Esempi sono da Montisei di Serso in associazionea materiale di V-II secolo a.C. (si veda ad esempioPERINI 1969b, fig. 11, 3, p. 204; il frammento ha unasovradipintura rossa ed è associato a tazze con profilo aS. Altri esemplari, datati al Retico C, sono in PERINI1973, fig. 4, 5-6), da Vigo Lomaso (Lomaso 4°, suc-cessivo al III secolo a.C.: PERINI 1978, fig. 13, 1, p.365), da Monte San Martino (MARZATICO 2007, tav.5, 5-6, p. 187). Coppe a orlo introflesso, dal profilovariamente modellato, sono dal sito del Rungger Egg(GLEIRSCHER, NOTHDURFTER, SCHUBERT2002, pp. 119-120, p. 148, lista 57, tavv. 119 e 120 e121, 10; in particolare i nn. 18 e 20 di tav. 120 offronoun confronto per il frammento di Breno-Spinera Tav. XI,6).
(203) MARZATICO 1995b, fig. 13, 1, p. 527; MAR-ZATICO 2001, p. 513, fig. 16, 13.(204) CROCE DA VILLA 1996, fig. 6, 9, p. 91.(205) Alcune osservazioni sugli elementi che comple-tavano il servizio simposiaco sono in DE MARINIS1997, pp. 164-167.(206) Si tratta di un frammento di parete con numerosipiccoli fori (ONGARO 1999, p. 33 e nota 52, tav. VIII,2, p. 34).(207) Si tratta di una ciotola carenata con fondo forato(POGGIANI KELLER 1989b, fig. 104, 5, p. 95).(208) DE MARINIS 1989, fig. 124, p. 115; DEMARINIS 1992, fig. 6, 6, p. 159.(209) Per Brescia si veda BONINI, FELICE, GUGLIEL-METTI 2002, tav. V, 5, p. 242 (tegame forato), tav. VI,8, p. 243; per Verona si rimanda a MORANDINI 2008,p. 438, tav. LXVI, 17.(210) GUGLIELMETTI, LECCA BISHOP, RAGAZZI1991, tav. CIX, 9-10 e p. 236.(211) CROCE DA VILLA 1996, pp. 84-85.(212) I frammenti provengono da US 1214 (piano d’usoin relazione all’altare a nord del recinto cerimoniale),US 1129 (deposito in relazione all’altare sud) e US 1126(livello di riporto di età giulio-claudia).
Trentino203 e da Musile di Piave in area paleo-veneta204, rinvenuti in associazione a materialidi IV secolo a.C. Colatoi metallici costituivanoanche parte del servizio simposiaco per ilconsumo del vino205. Esempi di colini inceramica in contesti protostorici sono dal mate-riale preromano di Santa Giulia di Brescia206 eda Bergamo-convento di San Francesco, daicontesti protourbani di VI-V secolo a.C.207.In Valcamonica, un boccale con parete inflessasotto l’ansa e fondo forato adattato a colino èda Borno-Val Camera208, in associazione aboccali tipo Breno e tipo Dos dell’Arca. In etàromana sono diffusi ampiamente contenitorifiltro, cosiddetti vasi pertugiati, presenti anchea Brescia e a Verona fra i materiali dei Capi-tolia209 e a Milano, in contesti di IV e V secolod.C.210.Nel caso di Spinera, data l’assenza di tracce dicombustione diretta, i colini erano probabil-mente impiegati nel rituale libatorio, confer-mando una prassi testimoniata nei santuaripaleoveneti dal ritrovamento non infrequentedi colatoi bronzei211.
Coppe (Tav. XI, 4-6)
Alcuni frammenti di orlo a impasto grigio-rosato micaceo, a granulometria fine212 (Tav.XI, 4-6) sono riferibili a coppe a orlo intro-flesso, pareti ad andamento più o meno linearerispetto all’orlo e vasca a calotta, che dovevaterminare in un fondo su piede ad anello varia-mente concavo a seconda degli sviluppi cro-
nologici. Coppe simili sono attestate in Valca-monica da Borno-Val Camera, in associazionea numerosi boccali tipo Dos dell’Arca213, esono diffuse nell’ambito culturale Friztens-Sanzeno per tutta la seconda età del Ferro214.Mentre gli esemplari più antichi hanno unimpasto più grossolano, quelli più recenti hannocorpo ceramico micaceo a granulometria piùfine. In assenza di elementi caratterizzanti, qualesoprattutto il fondo, è difficile trovare appiglimorfologici utili per avanzare proposte di deter-minazione cronologica precise per i frammentidi Breno, per i quali tuttavia si ipotizza, sullabase dei contesti di rinvenimento e dell’im-pasto particolarmente fine, una datazione com-presa fra III e I secolo a.C. La forma dell’orlo,molto simile a quello della variante a orlo intro-flesso delle coppe semidepurate di tradizione tar-doceltica, potrebbe far pensare a imitazionilocali di recipienti in ceramica fine (Grafico2).
Conclusioni
Nel tentativo di trarre dal materiale la mag-giore quantità di informazioni e ai fini di nonfalsare considerazioni statistico-quantitative, siè analizzato inizialmente il totale dei fram-menti, cercando di determinare sulla base dellecaratteristiche morfologiche, del corpoceramico, del colore, dello spessore e del trat-tamento delle superfici il numero minimo diesemplari riconoscibili per ogni forma. L’estremaframmentazione del vasellame ha purtroppotuttavia impedito di giungere a determinazionimorfologiche precise per tutti i frammenti,anche in considerazione del fatto che, su 60chilogrammi di cocci, 31 chilogrammi abbon-danti sono costituiti da pareti.Del totale degli individui determinati (Grafico3) il 71% è riferibile a boccali, l’8% a olle, l’8%
84
a bacili tipo Temù, un altro 8% a teglie tipoLappenbecken, mentre solo un 4% è rappre-sentato da tazze e coppe, rientranti nel tipoFritzens-Sanzeno da un lato e nelle tipologietardoceltiche dall’altro. La tipologia delvasellame attestato e una valutazione dell’indicedi presenza delle diverse forme lasciano ragio-nevolmente ipotizzare quindi che il rituale pre-vedesse l’uso selettivo di alcuni recipientilibatori, in particolare boccali, per i più raf-finati dei quali è possibile addirittura pensarea una produzione mirata ad assolvere speci-fiche esigenze e funzioni cultuali215. Dal V al
(215) Così è stato ipotizzato ad esempio anche per (217) La stessa osservazione per i Campi Neri di Cles
Stenico (MARZATICO 2002, p. 716) e per Este (GRE-GNANIN 2002, p. 166).(216) MARZATICO 2007, p. 179.
I secolo a.C. prevalgono infatti nettamente con-tenitori con funzione potoria, non di rado fine-mente decorati con motivi a stampiglia e/o conuna sovradipintura rossa, come per altro avvieneanche in altri luoghi di culto di area alpina, frai quali Stenico e Monte San Martino216. I mate-riali non registrano soluzioni di continuità, masono esemplificativi di tipologie che copronotutta la forbice temporale compresa tra VI-Vsecolo a.C. ed età augustea. Una valutazionesui dati ponderali dei frammenti recuperati
consente inoltre di notare come dai livelli piùantichi a quelli più recenti ci sia una continuacrescita delle presenze ceramiche, con un nettoaumento dall’US 1177 (livelli di V-III secoloa.C.) e il picco più elevato nell’US 1129 (livellidi III-I secolo a.C.), con questo denotando diriflesso la progressiva crescita di importanzadel santuario a livello territoriale (Grafico 4).La maggior parte dei frammenti non riportasegni di esposizione diretta e prolungata a tem-perature elevate, lasciando quindi intuire unimpiego estraneo all’accensione dei roghi e allacottura, ma piuttosto coinvolto in gesti cerimo-niali217 che si traducevano in libagioni nelle
Grafico 2. Le principali forme vascolari attestate nelle diverse fasi cronologiche.
Grafico 3. Sono indicate le presenze percentuali delle singole forme vascolari. Grafico 4. Sono indicate le presenze ceramiche distinte per US di provenienza.
1
VI - V secolo a.C. V - III secolo a.C. III - I secolo a.C.
85
quali l’acqua, data la natura del luogo, giocavaevidentemente il ruolo da protagonista.Un discreto quantitativo di recipienti ha motividecorativi, concentrati principalmente su orlo,spalla e ansa: esclusiva dei boccali (e forse dialcune coppe tipo Fritzens-Sanzeno) appare ladecorazione a stampiglia a cerchielli impressi (inun caso a fiore a quattro petali), che caratterizzaframmenti dei gruppi ceramici 1=1F, 3=8F e5=5F. La sovradipintura rossa che contraddi-stingue numerosi frammenti è propria solo direcipienti con corpo ceramico micaceo (1F) ein particolare, in tutti i casi riconoscibili, diboccali tipo Breno e tipo Dos dell’Arca. I bacilitipo Temù riflettono il gusto per l’orlo ripiegatoe ondulato e la rifinitura a fitte striature apettine, tipica anche di altre zone centroalpinee che riporta, come del resto l’usanza didipingere i vasi, particolarmente all’ambientetardohallstattiano dei Grigioni.Le forme e i tipi ceramici attestati testimonianocome la media Valcamonica nella seconda etàdel Ferro gravitasse culturalmente, se pure inmaniera originale, verso l’area centroalpina,con influssi del gruppo Fritzens-Sanzeno e diquello tardohallstattiano della valle del Reno.La massiccia presenza di boccali con appiatti-mento o inflessione della parete in corrispon-denza dell’ansa, nei tipi Breno, Dos dell’Arca eLovere, conferma l’autonomia del territorio e
(CIURLETTI, DEGASPERI, ENDRIZZI 2004, p.454).
(221) DE MARINIS 1986, p. 134. Lo stesso fenomenoè stato osservato ad esempio a Brescia (ONGARO 1999,p. 49) e nell’area trentina (MARZATICO 1992b, p.334; MARZATICO 2001, p. 512).(222) Sull’argomento si veda anche quanto esposto inPOGGIANI KELLER 2004, pp. 8-10.
(218) DE MARINIS 1989, DE MARINIS 1992 e DEMARINIS 1999; POGGIANI KELLER 2001 e POG-GIANI KELLER 2004, pp. 8-10.(219) POGGIANI KELLER 1999, in particolare p. 171per Grosio e pp. 183-184 per Parre.(220) Sui materiali ceramici di Brescia preromana sivedano FRONTINI, ONGARO 1996; ONGARO1999; ROSSI 1999; ROSSI 2001.
l’esistenza di una specifica facies culturale, estesanelle vicine Valtellina e Valli Giudicarie, acco-munate anche da una certa omogeneità lingui-stica ed epigrafica preromana218. Produzionitipicamente alpine sono anche i bacili tipoTemù, le teglie tipo Lappenbecken e le tazzecon profilo a S.Mancano invece, come per altro già osservatoda R. Poggiani Keller per contesti camuni evaltellinesi della seconda età del Ferro, influenzesignificative dall’ambiente padano-golasec-chiano, diffuse invece nei siti collinari e pede-montani fra Oglio e Adda e attestate anche nelsito di Parre219. Diversa è quindi la situazionedella valle rispetto a quella di Brescia, dove imateriali ceramici di VI-V secolo a.C. sonocaratterizzati in maniera evidente da una com-ponente golasecchiana e da una etrusco-padana,mostrando come l’insediamento cenomane sitrovasse a essere un punto di incontro tra ilmondo golasecchiano e quello etrusco del Man-tovano, e dove dal IV secolo a.C. prevalgonoproduzioni galliche220. Nei materiali di Spinera,coppe e vasellame di ispirazione tardocelticasono presenti, se pure sempre in maniera spo-
radica e mai rilevante quantitativamente, soprat-tutto dalla fine del II secolo a.C. e verosimil-mente sono spia del graduale processo di roma-nizzazione che investe il territorio, che si mani-festa nella comparsa sempre più evidente diprodotti di importazione, collegati al fenomenodi quella “koiné culturale gallo-romana” dellaTranspadana che secondo De Marinis avviò nelI secolo a.C. il livellamento e il superamentodelle precedenti differenze etnico-culturali221.Nonostante l’apertura alle novità, la Valca-monica mantenne a lungo, per lo meno fino allafine del I secolo d.C., una sua fisionomia spe-cifica tanto nella scrittura e nella lingua, quantonella cultura materiale, rappresentata princi-palmente dai boccali tipo Dos dell’Arca e tipoLovere, dalle olle situliformi tipo Wattens edalle teglie tipo Lappenbecken222. Prova evi-dente del radicamento della cultura di sostratosono produzioni di età romana di chiara ispi-razione protostorica, quali i boccali tipo Hen-keldellenbecher e le teglie, che con diverse solu-zioni sopravvivranno fino alla tarda età romana.
Tav. XI. Materiali di incerta attribuzione cronologica. 1-3. Colini; 4-6. Coppe (scala 1:3) (dis. A. Massari).
1
2
3
4
5 6
86
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE
ANATI E. 1968, Origini della civiltà camuna, Capodi Ponte.
APPLER H., ALTENBURGER A., ZEISLER J.1997, Beiträge zur Archäologie im Inntal /, 1. Teil,in “Heimatkundliche Blätter”, 7, Wattens-Volders, pp. 1-56.
ARDOVINO A.M. 2009, La Lombardia nell’etàdel Ferro e la Valcamonica, in Dalegno, pp. 89-94.
ARSLAN E.A., MORANDINI F., RAGAZZI L.,ROSSI F. 2008, I Celti nel bresciano. Indizi diviaggi e contatti nel corredo di un guerriero, inArcheotrade. Antichi commerci in Lombardiaorientale, a cura di M. Baioni e C. Fredella,Milano, pp. 251-274.
BARFIELD L., BUTEUX S., BOCCHIO G. 1995,Monte Covolo: una montagna e il suo passato,Stafford.
BIANCHIN CITTON E. 1989, S. Martino diLupari (Padova) - Castello di Godevo (Treviso): ilsito arginato de “Le Motte di Sotto”. Relazione delleprime indagini di scavo, in “QuadAVen”, V, pp.216-261.
BIONDANI F., CORRENT G., SALZANI L.2000, Montorio (Verona). Ricerche di superficiesul Colle del castello, in “QuadAVen”, XVI, pp. 61-74.
BONINI A., FELICE M., GUGLIELMETTI A.2002, La ceramica comune, in Nuove Ricerche sulCapitolium di Brescia. Scavi, studi e restauri, Attidel Convegno (Brescia, 2001), a cura di F. Rossi,Milano, pp. 239-271.
BRUNO B., CAVALIERI MANASSE G. 2000,Peschiera del Garda: scavi recenti nel vicus diAcrilica, in “QuadAVen”, XVI, pp. 78-83.
BRUSCHETTI A. 1999, L’insediamento retico deldosso di S. Ippolito a Castel Tesino, in Reti, pp.39-58.
CAVADA E. 1992, Ceramica comune romana e tar-doantica delle Giudicarie Inferiori. Un recupero aBondo, in Per Aldo Gorfer: studi, contributi arti-stici, profili, bibliografia in occasione del settan-tesimo compleanno, Trento, pp. 375-396.
CIURLETTI G., DEGASPERI N., ENDRIZZIL. 2004, I Campi Neri di Cles: un luogo di cultodalla protostoria alla tarda romanità. Le ricerchein corso, in Archeologia del territorio. Metodi, mate-riali, prospettive. Medjerda e Adige: due territoria confronto (Labirinti, 73), a cura di M. De Vos,Trento, pp. 453-466.
CONRADIN E. 1978, Das späthällstättische Urnen-gräberfeld Tamins-Unterm dorf in Graubunden,in “JbSchwUrgesch”, 61, pp. 65-155.
CORTESE C. 2003, Le ceramiche comuni. Formee produzioni tra l’età augustea e il III secolo d.C.,in Ricerche archeologiche nei cortili dell’UniversitàCattolica. Dall’Antichità al Medioevo. Aspetti inse-
diativi e manufatti, Atti delle Giornate di Studio(Milano, 2000 e 2001), a cura di S. LusuardiSiena, M.P. Rossignani, Milano, pp. 67-83.
CROCE DA VILLA P. 1996, Musile di Piave, in LaProtostoria tra Sile e Tagliamento. Antiche gentitra Veneto e Friuli, Catalogo della Mostra (Piazzolasul Brenta, Padova, 1996), Padova, pp. 81-96.
Culti nella Preistoria delle Alpi 2002, Kult der Vorzeitin den Alpen. Opfergaben, Opferplätze, Opfer-brauchtum / Culti nella Preistoria delle Alpi. Leofferte, i santuari, i riti, a cura di L. ZemmerPlank, Bolzano.
CUOMO DI CAPRIO N. 1985, La ceramica inarcheologia. Antiche tecniche di lavorazione emoderni metodi di indagine, Roma.
Dalegno 2009, La Magnifica Comunità di Dalegno.Dalle origini al XVIII secolo, a cura di E. Bressan,Breno (Brescia).
DAL RI L. 1992, Note sull’insediamento e sullanecropoli di Vadena (Alto Adige), in Reti, pp. 475-522.
DE MARINIS R.C. 1982a, Preistoria e protostoriadella Valcamonica nel quadro dell’ambiente pre-alpino e alpino della Lombardia centro-orientale,in Il caso Valcamonica. Rapporto uomo-territorionella dinamica della storia, a cura di E. Anati,Milano, pp. 73-99.
DE MARINIS R.C. 1982b, La protostoria, inArcheologia in Lombardia, Milano, pp. 83-106.
DE MARINIS R.C. 1986, L’età gallica in Lom-bardia (IV-I sec. a.C.): risultati delle ultime ricerchee problemi aperti, in La Lombardia tra protostoriae romanità, Atti del 2° Convegno ArcheologicoRegionale (Como, 1984), Como, pp. 93-173.
DE MARINIS R.C. 1988, Le popolazioni alpinedi stirpe retica, in Italia Omnium terrarum alumna,a cura di G. Pugliese Carratelli, Milano, pp. 99-155.
DE MARINIS R.C. 1989, Preistoria e protostoriadella Valcamonica, Valtrompia e Valsabbia. Aspettidella cultura materiale dal Neolitico all’età delFerro, in Valtellina, pp. 101-119.
DE MARINIS R.C. 1992, Il territorio prealpino ealpino tra i Laghi di Como e di Garda dal Bronzorecente alla fine dell’età del Ferro, in Reti, pp. 145-174.
DE MARINIS R.C. 1997, La tomba gallica diCastiglione delle Stiviere (Mantova), in “NotizieArcheologiche Bergomensi”, 5, pp. 115-177.
DE MARINIS R.C. 1999, La cultura Breno-Dosdell’Arca e il problema degli Euganei, in Atti del IIConvegno Archeologico Provinciale (Grosio, 1995)(Quaderni del Parco delle incisioni rupestri diGrosio, 3), a cura di R. Poggiani Keller, Sondrio,pp. 117-125.
DEODATO A. 2006, La necropoli della DomaRossa: sepolture e corredi, in La necropoli dellaDoma Rossa. Presenze romane nel territorio di
Pinerolo, a cura di F. Barello, Borgone di Susa, pp.35-72.
ENDRIZZI L. 1990, “Ai Paradisi”. Una necropoliromana a Trento, Catalogo della Mostra (Trento,1990), Trento.
Este preromana 2002, Este preromana: una città e isuoi santuari, a cura di A. Ruta Serafini, Treviso.
FAILLA A., GUERMANDI M.P., SANTOROBIANCHI S. 1994, La ceramica grezza romana:definizione di un problema attraverso le analisiarcheometriche, in Ceramica romana e archeo-metria. Lo stato degli studi, Atti delle GiornateInternazionali di Studio (Firenze, 1993), a curadi G. Olcese, Firenze, pp. 183-187.
FRONTINI P., ONGARO G. 1996, Brescia tral’età del Bronzo e l’età gallica, in Carta Archeo-logica della Lombardia. Brescia. La città. Saggi, acura di F. Rossi, Modena, pp. 23-71.
GAMBARI F.M. 2001, Aspetti del rito nella necropolidi Pombia, in La birra e il fiume. Pombia e le viedell’ovest Ticino tra VI e V secolo a.C., a cura di F.M.Gambari, Torino, pp. 93-98.
GLEIRSCHER P. 1987, Die Kleinfunde von derHohen Birga bei Birgitz. Ein Beitrag zur Fritzens-Sanzeno-Kultur, in “BerRGK”, 68, pp. 181-351.
GLEIRSCHER P., NOTHDURFTER H.,SCHUBERT E. 2002, Das Rungger Egg. Unter-suchungen an einem eisenzeitlichen Brandopfer-platz bei Seis am Schlern in Südtirol (Römisch-Germanische Forschungen, 61), Mainz am Rhein.
GREGNANIN R. 2002, La ceramica, in Este pre-romana, pp. 164-179.
GUGLIELMETTI A., LECCA BISHOP L.,RAGAZZI L. 1991, La ceramica comune, in ScaviMM3. Ricerche di archeologia urbana a Milanodurante la costruzione della Linea 3 della Metro-politana 1982-1990, a cura di D. Caporusso,Milano, vol. 3.1, pp. 133-257.
HÖCK A., ZANIER W. 2002, Neues zum frührö-merzeitlichen Fundplatz “Südwestecke” vonInnsbruck-Wilten, in “Tiroler Heimatblätter”, 2,pp. 38-44.
JORIO S. 1986, La necropoli di Borno, in La ValleCamonica in età romana, Catalogo della Mostra(Breno, 1986) (“Quaderni Camuni”, 7), Brescia,pp. 95-101.
JORIO S. 1999, Un esempio di continuità culturalenella permanenza di modelli protostorici in corredidi età romana, in Atti del II Convegno Archeo-logico Provinciale (Grosio, 1995) (Quaderni delParco delle incisioni rupestri di Grosio, 3), a curadi R. Poggiani Keller, Sondrio, pp. 237-248.
LEITNER S. 2004-2005, Der raetische Henkeldel-lenbecher. Ein Beitrag zur alpinen Kulturgeschichteder römischen Kaiserzeit, in “BerBayDenkmPfl”,45/46, pp. 173-194.
LEONARDI G., RUTA SERAFINI M.A. 1981,L’abitato protostorico di Rotzo (altipiano di Asiago),
87
in “PreistAlp”, 17, pp. 11-75.LEONARDI P. 1991, La Val di Fiemme nel Trentino
dalla preistoria all’alto Medioevo, Calliano (Trento).MAHLKNECHT M. 2002, (Toten-) Kultplatz am
Noafer Bühl, in Il sacro angolo. La conca di Bolzanotra la tarda età del Bronzo e la romanizzazione(XIII-I sec. a.C.) (Schriften des Südtiroler Archäo-logiemuseums, 2), a cura di U. Tecchiati, Bolzano,pp. 125-138.
MARZATICO F. 1991, I resti archeologici mobilidi Tesero, località Sottopedonda, in Per Padre Fru-menzio Ghetta, in occasione del settantesimo com-pleanno, Vigo di Fassa, pp. 383-420.
MARZATICO F. 1992a, Il gruppo Fritzens-Sanzeno,in Reti, pp. 213-246.
MARZATICO F. 1992b, Il complesso tardo la Tènedi Stenico nelle Valli Giudicarie: nuovi dati sullaromanizzazione in Trentino, in Festchrift zum50jährigen Bestehen des Institutes für Ur- undFrühgeschichte der Leopold-Franzens-UniversitatInnsbruck, a cura di A. Lippert, K. Spindler,Bonn, pp. 317-348.
MARZATICO F. 1993, Sanzeno. Scavo nel fondoGremes. Con note topografiche preliminari sull’as-setto protourbano dell’abitato “retico”, in “Archeo-logia delle Alpi”, 1, pp. 31-73.
MARZATICO F. 1995a, Massimeno (loc. S. Gio-vanni), in “StEtr”, LX, serie III, pp. 520-523.
MARZATICO F. 1995b, Nomi (loc. Bersaglio), in“StEtr”, LX, serie III, pp. 523-529.
MARZATICO F. 1999a, I Reti in Trentino: ilGruppo Fritzens-Sanzeno, in Reti, pp. 467-504.
MARZATICO F. 1999b, L’abitato di Fai della Paga-nella e i modelli insediativi retici in Trentino, in Attidel II Convegno Archeologico Provinciale (Grosio,1995) (Quaderni del Parco delle incisioni rupestridi Grosio, 3), a cura di R. Poggiani Keller, Sondrio,pp. 151-164.
MARZATICO F. 2001, La seconda età del Ferro, inStoria del Trentino. I. La preistoria e la protostoria,a cura di M. Lanzinger, F. Marzatico, A. Pedrotti,Bologna, pp. 479-573.
MARZATICO F. 2002, Stenico, località Calferi(Giudicarie Esteriori, Trentino), in Culti nellaPreistoria delle Alpi, pp. 713-719.
MARZATICO F. 2007, Testimonianze preromane,in Fra il Garda e le Alpi di Ledro, Monte S.Martino. Il luogo di culto (ricerche e scavi 1969-1979), a cura di G. Ciurletti, Trento, pp. 169-194.
Mezzocorona 1994, Archeologia a Mezzocorona.Documenti per la storia del popolamento rusticodi età romana nell’area atesina, a cura di E. Cavada,Bolzano.
MORANDINI F. 2008, Le ceramiche comuni dal-l’età preromana al V secolo d.C., in L’area del Capi-tolium di Verona. Ricerche storiche e archeologiche,a cura di G. Cavalieri Manasse, Verona, pp. 431-450.
MOREL J.P. 1992, Ex-voto par transformation, ex-voto par destination, in “Mélanges P. Lévêque”, 6,pp. 221-232.
NOLL R. 1963, Das römerzeitliche Gräberfeld vonSalurn (Archäologische Forschungen in Tirol, II),Innsbruck.
ONGARO G. 1999, Il materiale preromano, in S.Giulia di Brescia. Gli scavi dal 1980 al 1992.Reperti preromani, romani e alto medievali, a curadi G.P. Brogiolo, Firenze, pp. 25-54.
PEACOCK D.P.S. 1982, Pottery in the roman world:an ethnoarchaeological approch, London.
PERINI R. 1969a, Un deposito protostorico a Steniconelle Giudicarie esteriori, in “Studi Trentini diScienze Naturali”, XLVI, 2, pp. 178-194.
PERINI R. 1969b, Risultato degli scavi eseguiti nel1965 e 1966 ai Montisei di Serso, in “StudiTrentini di Scienze Naturali”, XLVI, 2, pp. 195-246.
PERINI R. 1970, Ciaslir del Monte Ozol (Valle diNon). Scavo 1968, in “Studi Trentini di ScienzeNaturali”, XLVII, 2, pp. 150-234.
PERINI R. 1973, Montisei di Serso - Lo scavo del1968: settore VI. La successione cronologica del-l’abitato dei Montisei di Serso, in “PreistAlp”, 9,pp. 91-111.
PERINI R. 1978, Vigo Lomaso, dalla fine dell’età delBronzo all’insediamento romano, “StTrentStor”,LVII, II, pp. 353-376.
PERINI R. 1979, Area cultuale preistorica sullaGroa di Sopramonte (Trento), “StTrentStor”, LVIII,II, pp. 41-65.
PERINI R. 1983, Stenico-Calferi, in Sulle traccedelle antiche genti giudicariesi. Mostra di docu-mentazione archeologica (Castello di Stenico,1983), Trento, pp. 34-46.
PERONI R. 1996, L’Italia alle soglie della storia,Roma-Bari.
POGGIANI KELLER R. 1989a, I siti dell’età delFerro: gli abitati su altura, in Valtellina, pp. 66-68.
POGGIANI KELLER R. 1989b, L’area valliva edalpina delle Orobie nella preistoria, in Valtellina,pp. 76-96.
POGGIANI KELLER R. 1992, Risultati dell’in-dagine in corso nell’insediamento del Castello diParre (provincia di Bergamo), in Reti, pp. 309-330.
POGGIANI KELLER R. 1995, Grosio (SO), Dossodei Castelli e Dosso Giroldo. Un insediamento pro-tostorico sotto i castelli e altri resti dell’età del Bronzoe del Ferro, Sondrio.
POGGIANI KELLER R. 1999, Aspetti culturalidell’arco alpino lombardo centro-occidentale nell’etàdel Ferro: i siti di Parre (BG) e Grosio (SO) e altridi recente indagine, in Reti, pp. 157-199.
POGGIANI KELLER R. 1999-2000, Il sito cultualedi Cemmo (Valcamonica): scoperta di nuove stele,
in “RScPreist”, L, pp. 229-259.POGGIANI KELLER R. 2001, Un abitato dell’età
del Ferro a Temù (Valcamonica-BS), Guida allaMostra (Temù, 2001), Breno.
POGGIANI KELLER R. 2002, Il sito con stele emassi-menhir di Ossimo-Pat in Valcamonica(Italia): una persistenza di culto tra età del Rameed età del Ferro?, in Culti nella Preistoria delleAlpi, pp. 377-389.
POGGIANI KELLER R. 2004, Un passato di13.000 anni. Cenni sul popolamento pre-proto-storico, in Il teatro e l’anfiteatro di CividateCamuno. Scavo, restauro e allestimento di un parcoarcheologico, a cura di V. Mariotti, Firenze, pp. 5-10.
POGGIANI KELLER R. 2006a, Cevo (BS), Dos delCurù. Abitato protostorico, in “NSAL”, pp. 57-58.
POGGIANI KELLER R. 2006b, Malegno (BS),via Cavour. Abitato pluristratificato dal NeoliticoMedio/Recente ad epoca romana, in “NSAL”, pp.65-66.
POGGIANI KELLER R. 2009, Un passato mille-nario. L’abitato dell’età del Ferro di Temù (ValleCamonica), in Dalegno, pp. 7-76.
POGGIANI KELLER R., DE VANNA L. 1999-2000, Temù, loc. Desert. Resti di una casa deiCamunni, in “NSAL”, pp. 46-50.
Ponte S. Marco 1994, Il villaggio preistorico e lefornaci di Ponte S. Marco. Scavi archeologici 1990-91 tra media età del Bronzo e prima età del Ferronel comune di Calcinato, Catalogo della Mostra(Calcinato, 1994), a cura di R. Poggiani Keller,Calcinato (Brescia).
PROSDOCIMI A.L. 1971, Graffiti alfabetici diDos dell’Arca, in “Bollettino del Centro Camunodi Studi Preistorici”, 6, pp. 45-54.
RAGETH J. 1989, I Grigioni nella Preistoria, inValtellina, pp. 156-178.
RAGETH J. 1992, Zur Eisenzeit in Alpenrheintal,in Reti, pp. 175-211.
RAGETH J. 1999, Die eisenzeitlichen Alpenrhein-talgruppen aus bündnerischer Sicht, in Reti, pp.436-466.
Reti 1992, Die Räter/I Reti, a cura di I.R. Metzger,P. Gleirscher, Bolzano.
Reti 1999, I Reti/Die Räter, Atti del Simposio(Stenico, Trento, 1993), a cura di G. Ciurletti, F.Marzatico, Trento.
RITTATORE VONWILLER F. 1966, La necropolipreromana della Ca’ Morta (scavi 1955-1965),Como.
ROSSI F. 1999, Brescia tra età del Ferro e romaniz-zazione: i nuovi dati, in Atti del Seminario diStudi “Insubri e Cenomani tra Sesia e Adige”(Milano, 1998), in “NotMilano”, LXIII-LXIV,pp. 89-99.
ROSSI F. 2001, Tra età del Ferro e romanizzazione:alcune considerazioni sui nuovi dati dal Bresciano,
88
in La Protostoria in Lombardia, Atti del 3° Con-vegno Archeologico Regionale (Como, 1999),Como, pp. 439-449.
ROSSI F. et alii 1999, La casa camuna di Pescarzodi Capo di Ponte, in Studio e conservazione degliinsediamenti minori romani in area alpina, Attidell’Incontro di Studi (Forgaria del Friuli, 1997),a cura di S. Santoro Bianchi, Bologna, pp. 143-170.
ROSSI F., PORTULANO B. 1994, Nuovi scavinell’area della villa romana 1988-1990, in Studisulla villa romana di Desenzano, Milano, pp. 145-181.
SALZANI L. 1992, Scavo archeologico, in SanGiorgio di Valpolicella. Scavi archeologici e sistema-zioni museali, a cura di P. Brugnoli, L. Salzani,Vago di Lavagno (Verona), pp. 27-68.
SANTORO BIANCHI S. 1993, Un nuovo para-digma interpretativo per la ceramica grezza alpina,in “Ocnus”, pp. 175-184.
SOLANO S. 2006-2007, Forme minori del popola-mento della Valcamonica fra tarda età del Ferro eromanizzazione. Insediamenti e luoghi di culto,Tesi di Dottorato di Ricerca in Storia e Civiltà delMediterraneo Antico, Università degli Studi diPavia.
SOLANO S. 2008, I materiali, in S. Solano, F.Simonotti, Berzo Demo. Un abitato alpino fra etàdel ferro e romanizzazione, Esine (Brescia), pp.51-82.
SOLANO S., BASSO E., RICCARDI M.P. c.s.,Studio archeologico e petro-archeometrico delle tegliecon prese a linguetta (Lappenbecken) nell’arco alpinocentro-orientale, in 3rd International Conference onLate Roman Coarse Wares, cooking wares andamphorae in the Mediterranean: archaeology andarchaeometry, Atti del Convegno (Parma, Pisa,2008), in stampa.
STEINER H. 2007, Die befestigte Siedlung am Gan-glegg in Vinschgau-Südtirol, in Forschungen zurDenkmalpflege in Südtirol, Band 3, pp. 259-361.
STÖCKLY W.E. 1975, Chronologie der JüngerenEisenzeit im Tessin, Basel.
TIRELLI M. 2002, Il santuario di Altino: ALTNO-e i cavalli, in Este preromana, pp. 311-316.
TIZZONI M. 1984, I materiali della tarda età delFerro nelle Civiche Raccolte Archeologiche di Milano(“NotMilano”, Suppl. III), Milano.
TIZZONI CUCINI C., FERRARIO A., MORIND., IXER R.A., RUFFA M., TIZZONI M.,ZAHOVA A. 2001, Campolungo (Bienno-Collio,Brescia): Campagna di scavi anno 2000, in“Notizie Archeologiche Bergomensi”, 9, pp. 113-150.
TOMEDI G., HYE S., LACHBERGER R.,NICOLUSSI CASTELLAN S. 2006, Denkmal-schutzgrabungen am Heiligtum am Demfeld inAmpass 2006, in “Kleine Schriften”, 5, pp. 116-
122.Valtellina 1989, Valtellina e mondo alpino nella prei-
storia, Catalogo della Mostra (Milano, 1989), acura di R. Poggiani Keller, Milano.
VITRI S., LEONARDI G., CORAZZA S.,BALISTA C., MIZZAN S. 1992, Gli impiantiproduttivi seminterrati di Pozzuolo del Friuli, inTipologia di insediamento e distribuzione antropicanell’area veneto-istriana dalla protostoria all’altoMedioevo, Atti del Seminario di Studio (Asolo,1989), Mariano del Friuli (Gorizia), pp. 17-32.