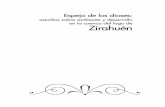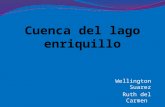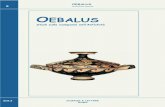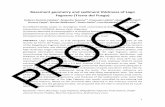L' ETÀ DEL B RONZO NELLE PALAFITTE DEL LAGO DI VARESE
Transcript of L' ETÀ DEL B RONZO NELLE PALAFITTE DEL LAGO DI VARESE
L'ETÀ DEL BRONZO NELLE PALAFITTE DEL LAGO DI VARESE
Raffaele C. de Marinis
La scoperta delle palafitte dei laghi varesini risale all 'alba degli studi di preistoria in Italia 29 . L'impulso all' avviodi ricerche indirizzate alla verifica dell'esistenza di abitati
lacustri anche nell'Italia settentrionale, dopo le eclatantiscoperte verificatesi a partire dall' inverno 1 8 53 -4 lungole rive dei laghi svizzeri, venne da due studiosi stranieri,lo svizzero Emile Desor e il francese Gabriel de Mortil
let, entrambi soci corrispondenti della Società Italiana diScienze Naturali . Il 27 aprile 1 863 l'abate Antonio Stoppani insieme a Desor e de Mortillet parti alla volta del lago diVarese, dove li aspettava il signor Benz, un pescatore svizzero collaboratore di Desor nella ricerca e il recupero diantichità lacustri . Lungo il lato sud-orientale dell'Isolinofu subito scoperta una palafitta che si estendeva per 200 mdi lunghezza e 30-40 m di larghezza . Da quel momento nelvolgere di qualche anno furono identificati tutti i principalisiti palafitticoli dei laghi di Varese, Monate e Comabbio,nonché quelli delle torbiere della palude Brabbia tra Cazzago e Varano Borghi e della Pustenga in comune di Daverio. Gli autori di queste scoperte furono, dopo le pionieristiche ricognizioni dell'abate Stoppani, i fratelli Angelo eGiuseppe Quaglia, il loro cugino Benesperando Quaglia,il capitano Angelo Angelucci, l ' abate Giovanni Ranchet,il prof. Innocenzo Regazzoni di Como, il prof. PompeoCastelfranco di Milano. Sponsor - per usare una paroladel linguaggio contemporaneo - e mecenati di alcune diqueste ricerche furono Andrea Ponti, dal 1 865 proprietario del lago di Varese, suo figlio Ettore Ponti 3° e NapoleoneBorghi, proprietario del lago di Monate.
I materiali recuperati tra il 1 8 63 e il 1 879 , il periododi più intense ricerche nei laghi e nelle torbiere varesine, entrarono a far parte di diverse raccolte pubbliche eprivate : il civico museo di Storia Naturale di Milano, ilMuseo Patrio di Varese, il museo Preistorico-Etnograficodi Roma, il museo d'Artiglieria di Torino, le raccolte Regazzoni di Como, Quaglia di Varese, Ponti , Castelfrancoe Borghi di Milano .
A parte gli scavi Regazzoni al centro dell ' Isolino nel1 8 8 5 , per oltre un ventennio non vi furono altre ricerchenei siti lacustri del lago di Varese. Una breve ripresa siavrà tra il 1 902 e il 1 904 ad opera di R Castelfranco perconto di Ettore Ponti e poi per quasi mezzo secolo le ricerche cessarono del tutto .
Agli inizi del ' 900 le raccolte preistoriche del museodi Storia Naturale di Milano passarono alle civiche raccolte archeologiche del Castello Sforzesco, dove confluìanche la collezione Castelfranco . Quella Regazzoni fu acquistata dal museo civico B. Giovio di Como, la raccolta di Giuseppe Quaglia fu ceduta al museo PreistoricoEtnografico di Roma . La collezione Ponti fu dapprimaordinata nel museo di Villa Ponti all ' Isolino, in seguito,nel 1 924, tutti i materiali vennero donati al comune di Va
rese e confluirono quindi nel civico museo archeologicodi Villa Mirabello . Della collezione Borghi si ignora qualisiano state le vicende.
Una prima carta con l'ubicazione delle palafitte sommerse del lago di Varese fu pubblicata da Camillo Marinoni nel 1 868 , cui hanno fatto seguito carte più precise edettagliate di Innocenzo Regazzoni nel 1 878 e di Giuseppe Quaglia nel 1 8 84 3 .Gli insediamenti palafitticoli si trovano soltanto lun
go le rive meridionali e occidentali del lago di Varese (fig .1 ) . A sud abbiamo le palafitte della palude Brabbia presso il punto in cui il canale Brabbia si immette nel lago,Ponti , Desor-Maresco , Bodio centrale e Keller-Gaggio,ad ovest l ' Isolino e le palafitte Stoppani e Ranchet rispettivamente a destra e a sinistra del punto in cui iniziail suo corso l ' emissario Bardello . Lungo il lato settentrionale del lago non sono mai state segnalate palafittesommerse.
La palafitta Ponti presso Cazzago Brabbia, a distanza di 30-40 m dalla linea attuale di riva, comprendevadue aree rettangolari orientate nord-ovest - sud-est , la
29 Per una storia delle ricerche cfr. CASTELFRANCO 1 9 1 3 , p. 9 S S. e DEMARINIS 1 9 82 .
3o Ettore Ponti ( 1 8 55- 1 9 1 9) fu senatore del Regno e nel 1 906 ebbeper decreto reale il titolo di marchese.
2/
3 1 REGAZZONI 1 878 , tavv. I-II ; QUAGLIA 1 8 84, tav. I . Il Regazzoni hapubblicato anche una mappa topografica della distribuzione dei pali delle palafitte di Ponti-Cazzago e Stoppani-Bardello e di quella lungo il latosud-orientale dell 'Isolino .
1 . I musei civici di Varese. Preistoria e Pro tostoria 1 25
1
2 kmJ
Fig. 1 - Carta degli insediamenti palafitticoli dei laghi varesini . 1 . Isolino di Varese ; 2 . Palude Brabbia; 3 . Palafitta Ponti ; 4 . Palafitta Desor-Maresco ;5 . Palafitta di Bodio Centrale ; 6 . Palafitta Keller o del Gaggio ; 7 . Palafitta Ranchet ; 8 . Palafitta Stoppani; 9 . Torbiera di Biandronno ; 1 0 . Palafittadell 'Occhio ; 1 1 . Palafitta del Sabbione ; 1 2 . Palafitta di Pozzuolo .
maggiore di 80 x 5 3 m circa, la minore di 46 x 26 m, perun'estensione comples siva di poco più di mezzo ettaro .I materiali recuperati nelle ricerche ottocentesche comprendono industria litica , in particolare cuspidi di frecce a peduncolo e alette ed elementi di falcetto, punteruoli e spatole in osso, fusarole e poche ceramiche, oltrea una quindicina di oggetti di bronzo, che più di tutti glialtri reperti consentono di definire meglio la cronologiadel sito .
Quattro spilloni sono del tipo a capocchia laminare aforma di losanga con estremità arrotolata 32, due dei qua
li , frammentati , sono uniti tra loro per ossidazione (fig .2 : 4) . Un esemplare è completo e presenta, come i dueprecedenti, una decorazione a borchiette a sbalzo (fig . 2 :1 ) . Il quarto è un frammento limitato alla capocchia (fig .2 : 2) . Gli spilloni a losanga sono diffusi principalmentelungo il versante alpino nord-occidentale, in particolarenella Svizzera occidentale, soprattutto nel Vaud e nel Vallese, fino al Giura e all 'Alsazia . In base ad alcuni contestisi datano alle fasi centrali dell 'antica età del Bronzo 33 .
In Italia la maggiore concentrazione del tipo si riscontranell 'area dei laghi varesini 34 .
32 CASTELFRANCO 1 9 1 3 , tav. VI : 1 , 2 , 5 ; CARANCINI 1 975 , nn. 28 , 3 1 ,3 3 ; BANCHIERI 1 9 86 , fig. 1 8 ' 7 , 8 , 1 1 .
33 Cfr. il ripostiglio di Castione d'Arbedo nel Canton Ticino e le
tombe di Eguisheim e Riedisheim.
34 Per la diffusione di questi spilloni cfr. DAVID Et, BIALI 2000 , p. 1 53SS . e carta 27 .
1 26 Alle origini di Varese e del suo territorio
1
Fig. 2 - Palafitta Ponti . 1 -5 . spilloni ; 6-7 . lame di pugnale ; 8 . lesina; 9 . ascia a m.r. con taglio espanso. 1 -3 , 5 da Carancini 1 975 , 4 ridisegnato da Castelfranco 1 9 1 3 , 6-7 da Bianco Peroni 1 994 . Bronzo. Riduzione a 1 ' 2 della gr.nat .
Altri spilloni dalla palafitta Ponti appartengono altipo a capocchia arrotolata, un tipo di lunga durata equindi di scarso valore cronologico 35 . Di grande interesseè, invece, uno spillone a capocchia cruciforme con apicearrotolato e tre borchie prominenti lungo il braccio orizzontale, fuse e non a sbalzo (fig . 2 : 5) 36 , un tipo definitodagli studiosi francesi a cabochons 37 . Un confronto moltopuntuale è con lo spillone rinvenuto nella sepoltura centrale del tumulo di les Gardes, a Montjaux, nell 'Aveyron,
e con quello del dolmen la Macelle a Saint-Hyppolytedu-Fort , nel Gard . La sepoltura del tumulo di les Gardes era in posizione rannicchiata sul fianco destro, conla testa verso est . Lo spillone si trovava all ' altezza delcollo e di fronte al volto era stato collocato un vaso an
sato a corpo carenato. È questo l'unico contesto chiusoche permette di datare lo spillone a cabochons alla fasefinale dell ' antica età del Bronzo 38 e di considerarlo un
tardo sviluppo degli spilloni a capocchia trilobata (à tYte
35 REGAZZONI 1 878 , tav. VI, 1 0 ; CARANCINI 1 975 , nn . 80 , 1 09 , 298 ;
BANCHIERI 1 986 , fig . 1 8 : 6 , 1 0 .36 REGAZZONI 1 878 , tav. X, 1 5 - 1 6 ; MUNRO 1 890 , fig. 49 : 28 ; CASTEL
FRANCO 1 9 1 3 , tav. VI, 4 (con indicazione Bodio) ; CARANCINI 1 975 , n . 1 5 ;BANCHIERI 1 986 , fig . 3 : 7 (con indicazione Bodio) . Sembra preferibileseguire l ' indicazione del Regazzoni, che è la più antica, rispetto a quella
del Castelfranco, di 3 5 anni posteriore.
37 Sugli spilloni a cabochons cfr. SPINDLER 1 973 , pp. 28-29 e carta didiffusione a p. 30 ; AuI)OUZE, GAUCHER 1 98 1 , pp. 2 1 -22, con bibliografiaprecedente.
38 Cfr. AUDIBERT, DELORD 1 959 , p. 8 e fig. 1 : 1 -2 e 6 ; SPINDLER 1 973 ,
fig . 1 7 : 6-7 .
1 . I musei civici di Varese. Preistoria e Protostoria 1 27
tréflée, Fliigetnadetn) , caratteristici della fase centrale delBronzo Antico 39 .
Dalla palafitta Ponti provengono due lame di pugnale. Una presenta larga base semplice ad arco dicerchio con tre fori per i ribattini e lama triangolarecorta a lati inflessi e sezione lenticolare (fig . 2 : 6) 4° .Dall ' analisi della composizione del metallo effettuatanel laboratorio di Halle da Otto e Witter è risultato che
si tratta di un bronzo con alto tenore di stagno 1 5%, eun forte tasso di impurità , arsenico , antimonio, nickele argento, che insieme assommano al 2 , 3% e indicanola provenienza del rame da minerali di Fahlerz 4 1 . Unsecondo pugnale (fig . 2 ' 7) presenta base semplice stretta e leggermente arcuata , con due fori per i ribattini , elama triangolare lunga con sezione a losanga . Si trattadi un tipo genericamente attribuibile alla media età delBronzo 42 .
Una bella lesina, lunga 1 2, 5 cm, presenta un ampio rigonfiamento mediano a losanga (fig . 2 : 8) 43 . Lesine similisono ampiamente conosciute negli insediamenti lacustrinordalpini 44 .Dalla palafitta Ponti proviene anche un'ascia a mar
gini rialzati, con tallone fornito di incavo ad occhiello,corpo piuttosto largo e taglio fortemente espanso pocopiù che semicircolare (fig. 2 ' 9) 45 . Anche in questo casodisponiamo dell ' analisi del metallo effettuata da Otto eWitter : il tasso dello stagno è del 14%, mentre le impuritàdi arsenico, antimonio, argento e nickel assommano allo0 , 8% 46 . L'ascia della palafitta Ponti è una varietà delleasce a m.r. con taglio semicircolare del tipo LodigianoBaragalla, diffuse specialmente nella regione benacense,e da cui si distingue per il corpo più corto e più largo e iltaglio un po ' più espanso, avvicinandosi per questi aspettialle asce con taglio espanso a paletta . Le asce a tagliofortemente espanso sono caratteristiche dell'ultima fasedell'antica età del Bronzo (BA II , fase A 2b a nord delleAlpi) 47 . Dalla stessa palafitta un'ascia a m.r. con tagliofortemente espanso, del tipo Langquaid, è stata recuperata nel 1 973 ed è attualmente conservata al museo di
Gallarate 48 .
Uno spillone con testa biconica è l 'oggetto di bronzopiù recente proveniente dalla palafitta Ponti 49 . Il tipo èpiuttosto generico e privo di appigli cronologici sicuri ,tuttavia in base alla sua presenza nelle palafitte di Peschiera si può assegnare al Bronzo Recente (XIII secoloa .C. ) .
Tra le ceramiche vi sono alcuni frammenti di scodelle
carenate, a parete distinta, che riportano alla media etàdel Bronzo 50 , mentre un'olletta ansata con orlo a tortiglione potrebbe risalire al Bronzo Recente 5 . Un ugellodi terracotta documenta l 'attività metallurgica in loco 52 .
Sulla base degli oggetti di bronzo e delle scarse ceramiche conservate si può concludere che la palafitta Pontidi Cazzago è stata attiva nelle fasi centrali e finali dell ' antica età del Bronzo e ancora agli inizi della media età delBronzo. Poi la vita dell'abitato si interrompe per qualchesecolo, fino a quando nel Bronzo Recente la frequentazione del sito è documentata solo da rari reperti .
Ad est della punta del Pizzo di Bodio la prima palafitta che si incontra è quella del Mareseo , denominataanche Desor in onore dell 'eminente paletnologo svizzero.Fu individuata da Stoppani e poi dal capitano Angeluccie vi fecero ricerche anche I . Regazzoni nel 1 875 ed EttorePonti nel 1 876- 1 877 .
Tra le palafitte del lago di Varese è quella che ha restituito il maggior numero di frammenti ceramici , tanto chelo Stoppani la defini "una vera fabbrica di terraglie" . Trai reperti più interessanti vi sono due vasi biconici frammentari con piccole prese lungo la massima espansionee una decorazione eseguita a incisione e punteggiature 53(fig . 4 : 1 -2) . Non hanno confronti, se non nel frammentodi un altro vaso biconico del tutto simile dalla palafitta diBodio centrale (fig . 7 : 3) e la loro datazione precisa rimane ancora problematica, ma con ogni verosimiglianza èda collocare verso la fine del Bronzo Antico o gli inizi delBronzo Medio. Dalla palafitta proviene anche un frammento di capeduncola con ansa ad ascia del tipo MonateMercurago, raffigurato da I . Regazzoni, ma attualmenteirreperibile (fig . 3 : 7) .
39 Sugli spilloni a capocchia trilobata cfr. l ' ampio studio di SPINDLER1 973 e DAVID EL-BIAL1 2000 , p. 1 50 e ss.
40 Mt RO 1 890 , fig . 49 : 2 1 ; CASTELFRANCO 1 9 1 3 , tav. VI, 1 4; BANCHIERI 1 986 , fig. 1 8 : 1 3 . In BIANCO PERONI 1 994, n . 25 1 , è indicato erroneamente come Isolino.
4 1 OTTO, WITTER 1 952 , n . 996 .
42 BIANCO PERONI 1 994, n . 8 3 6 (con provenienza errata Bodio) , loattribuisce al suo tipo S. Ambrogio, varietà B.
43 REGAZZONI 1 878 , tav. VII, 1 ; MUNRO 1 890 , fig. 49 : 1 3 ; CASTELVRANCO 1 9 1 3 , tav. VI, 7 (con provenienza Bodio) .
44 Cfr. ad es. M6rigen, Auvernier, Grandson-Corcelettes in HAFNER1 995 , tavv. 1 6 : 9 , 1 0 , 1 5 - 1 7 ; 25 : 1 0 ; 29 : 6-7 .
45 MVNRO 1 890 , fig. 49 : 20; MONTELIUS 1 895 , tav. 3 : 1 7 ; CASTELFRANco 1 9 1 3 , tav. V, 2 ; BANCHIERI 1 986 , fig . 1 8 : 1 4 .
46 OTTO, WITTER 1 952, n . 523 .
47 Sulle asce con taglio fortemente espanso, semicircolare, cfr. DEMARINIS 1 998 , p. 1 60 SS. , fig. 14 1 .
48 Cfr, DE MARINIS, infra, pp. 669-670 .49 CARANCINI 1 975 , n . 1 594; BANCHIERI 1 986 , fig . 1 9 : 8 .50 BANCHIERI 1 986 , fig. 1 9 : 3 , 6 . » .J5 1 REGAZZONI 1 878 , tav. IX, 1 1 .
52 REGAZZONI 1 878 , tav. IX, 1 2 .
53 MARINONI 1 868 , tav. IV, 4, 6 ; MUNRO 1 890 , fig. 49 : 39 ; BANCHIERI1 986 , fig. 4 : 1 (indicato come Bodio centrale) e 6 : 22 .
1 28 Alle origini di Varese e del suo territorio
- ©
1 4
i\
7 8
Fig . 3 - Palafitta Desor-Maresco. 1 -3 . spilloni; 4-6 . lame di pugnale ; 7 . frammento di capeduncola con ansa ad ascia; 8 . ascia a m.r. con taglio fortemente espanso. N. 7 ceramica, i rimanenti numeri bronzo. 1 -3 da Carancini 1 975 , 4-6 da Bianco Peroni 1 994 con modifiche, 7 ridisegnato da Regazzoni1 878 . Ceramica a 1 ' 3 , bronzi a 1 ' 2 della gr.nat .
Gli oggetti di bronzo comprendono due spilloni con capocchia laminare a losanga 54 (riE. 3 : 1 -2) , del tipo già discusso più sopra, tre lame di pugnale a base semplice arcuatacon due fori per i ribattini 55 (riE. 3 ' 4-6) e un'ascia a marginirialzati con taglio fortemente espanso a paletta a tre quartidi cerchio 56 (riE. 3 : 8) . Gli spilloni sono databili alle fasi cen
trali dell'antica età del Bronzo, le lame di pugnale a quellecentrali o finali . L'ascia appartiene al tipo Desor-Robbio,documentato oltre che nella palafitta Desor, nei ripostiglidi Robbio e della Cascina Ranza 57 . E un tipo strettamenteaffine alle asce a m.r. con taglio fortemente espanso a paletta 58 e alla variante Savièse del gruppo Les Roseaux 59 , asce
54 RmAZZONI 1 878 , tav. VI, 7 , 1 2; MUNRO 1 890, fig. 49 : 22; CASTELFRANCO 1 9 1 3 , tav. VI, 1 0 ; CARANCINI 1 975 , nn. 32, 34; BANCHIERI 1 986, riE.6 : 1 9 , 20 .
55 RmAZZONI 1 878 , tav. VI, 4-6; CASTELFRANCO 1 9 1 3 , tav. VI , 1 7 (con
indicazione Bodio) ; BIANCO PERONI 1 994, nn . 32 1 , 328 , 3 3 1 ; BANCHIERI1 986 , riE . 6 : 1 0 , 1 4 .
56 REGAZZONI 1 878 , tav. VI , 3 ; CASTELFRANCO 1 9 1 3 , tav. V, 1 ; BAN
CHIERI 1 986 , riE. 6 : 1 3 . /57 Cfr. DE MARINIS 1 975 , fig . 22 : 8 - 1 0 .
58 Cfr. DE MARINIS 1 975 , riE. 22 : 7 e carta di diffusione riE. 24; ID .
1 998 , pp. 1 62- 1 63 e riE. 143 .59 DAVID ELBIALI 2000 , p. 1 09 SS. , fig. 3 1 : 1 -7 .
1 . I musei civici di Varese. Preistoria e Pro tostoria 1 29
i
2 J
Fig . 4 - Palafitta Desor-Maresco. 1 -2 . frammenti di vasi biconici . Da Banchieri 1 986 . Ceramica . Riduzione a 1 ' 3 della gr.nat .
che precedono direttamente il tipo MGhlin, con tagliofortemente espanso semi-ellissoidale. Queste asce sono,quindi, da collocare verso la fine del Bronzo Antico - inizi del Bronzo Medio. Dell 'ascia della palafitta Desor conosciamo la composizione chimica grazie all ' analisi dellaboratorio di Halle : il tenore di stagno è del 1 4%.
La palafitta di Bodio centrale è stata denominata anche"delle monete" , poiché nello spazio di soli 3-4 m2 furonorinvenute 1 99 monete d'argento di età repubblicana ed antico imperiale. Ubicata a circa 800 m dalla palafitta Desore a 20 m dalla riva, sembra avesse una forma quasi a ferrodi cavallo, attorno a un punto rilevato del fondo lacustre.
Vi fecero ricerche l'abate Stoppani, il capitano Angeluccie nell'inverno 1 878- 1 879 I . Regazzoni per conto di EttorePonti . I materiali recuperati si conservano nei musei di Varese, di Como, di Milano e nel museo Pigorini di Roma.
Fra le ceramiche sono documentate tazze-attingitoioa corpo carenato e con ansa a nastro leggermente sopraelevata (riE . 7 ' 5 -6) o con ansa ad ascia di tipo MonateMercurago (riE . 7 : 4) , oltre a un frammento di vaso biconico simile a un esemplare della palafitta Desor (riE . 7 " 3 ) .Dalla palafitta provengono lame di pugnale 60 , spillo
ni 6 1 , due cuspidi di lancia 62, ami, forme di fusione perasce 63 , cuspidi di freccia ed elementi di falcetto in selce 64 .Tra gli spilloni ve n'è uno del tipo con capocchia laminare
60 MARINONI 1 868 , tav. II , 26 , 27 ; QUAGLIA 1 8 84, tav. IV, 30 ; MUNRO 1 890 , riE. 49 : 8 , 1 0 , 1 1 , 40 ; CASTELFRANCO 1 9 1 3 , tav. VI, 1 1 , 1 2 , 1 5 ;BANCHIERI 1 986 , riE . 3 : 9 - 1 1 , 1 3 - 1 4 ; BIANCO PERONI 1 994, nn . 275 , 276 ,293 , 3 30 , 3 32 , 3 3 3 , 3 6 1 .
6 1 MARINONI 1 8 68 , tav. III , 25 ; ANGELUCCI 1 87 1 , tav. B, a, b ; MUNRO1 890 , riE. 49 : 1 2 ; CASTELFRANCO 1 9 1 3 , tav. VI, 3 ; CARANCINI 1 975 , nn . 4 1 ,8 96 , 8 98 , 899 , 900 ; BANCHIERI 1 986 , riE. 3 : 5 , 6 . Il pezzo raffigurato daREGAZZONI 1 878 alla tav. VII, 4 , è attualmente irreperibile e quindi non
si può stabilire se sia la capocchia di uno spillone del tipo Scheibenkopfnadel o più verosimilmente un pendaglio.
62 REGAZZONI 1 878 , tav. VI, 2 ; MUNRO 1 890 , riE. 49 : 24, 43 ; CASWECFRANCO 1 9 1 3 , tav. VI , 1 6 ; BANCHIERI 1 986 , riE. 3 : 1 6 ; 4 : 7 . /
63 REGAZZONI 1 878 , tav. VI , 1 8 -20 ; MUNRO 1 890, riE. 49 : 3 1 ; BANCHIERI 1 986 , fig. 3 : 1 5 , 1 8 .
64 MAmNOYI 1 868 , tav. II, 1 -8 , 1 3 , 14, 23-24; AYGELUCCI 1 87 1 , tav. D, 8 , 9;REGAZZO 1 878, tav. IV, 8 , 1 2; QUAGLIA 1 884, tav. IV, 3 , 4, 14, 1 5 , 1 8 , 1 9, 23 .
1 30 Alle origini di Varese e del suo territorio
1
6 7 9 1 0
Fig. 5 - Palafitta di Bodio centrale. 1 - 5 . spilloni ; 6- 1 0 . lame di pugnale. 1 -5 da Carancini 1 975 , 6- 1 0 da Bianco Peroni 1 994 con modifiche. Bronzo.Riduzione a 1 ' 2 della gr.nat .
a losanga (fig. 5 : 1 ) , mentre sono rappresentati da quattroesemplari gli spilloni con capocchia globosa cava perforata obliquamente (fig . 5 : 2-5) , appartenenti alla varietà Bsecondo G.L . Carancini , che in Italia è la più antica dellaserie ed è documentata anche nella regione benacense enell'Europa centrale. La datazione è da porre verso gliinizi del Bronzo Medio 65 . Le lame di pugnale sono tuttea base semplice con due fori per i ribattini e genericamente databili alle fasi centrali e avanzate dell' antica età del
Bronzo (fig . 5 : 6- 1 0 ; 6 : 2- 3) .
Di notevole importanza sono le cuspidi di lancia .Una presenta forma della lama leggermente fiammata, ma poco slanciata, avendo la parte prossimale largae quella distale stretta e breve, anche la parte libera delcannone è corta (fig . 7 : 1 ) . La base del cannone, a sezionecircolare, è decorata da linee orizzontali e trattini vertica
li . Confronti precisi per questo tipo, a parte le dimensioniche sono maggiori nella cuspide di Bodio, si possono trovare a Bor di Pacengo, al Porto di Moniga, a Peschierapalafitta centrale, all ' Isolone del Mincio e a Viverone 66 .
65 A questo proposito cfr. DE MARINIS 2002, p. 42 e ss. , figg . 1 6- 1 9 .Questi spilloni sono spesso datati alla fine del Bronzo Antico, ma a Bodman Schachen I C il tipo è datato dalla dendrocronologia verso il 1 6 1 11 59 1 BC e il contesto del Lavagnone, settore B, conferma una datazioneagli inizi del Bronzo Medio.
66 Bor di Pacengo : AspEs, FASANI 1 968 , fig . 1 8 : 5 ; Peschiera : MONTELIUS 1 895 , tav. 9 : 2 ; Isolone del Mincio : GUERRESCHI, LIMIDO, CATALANI
1 98 5 , tav. XXI, n . st8966 (proviene dallo strato II del settore A-B, ma loscavo è privo di attendibilità , comunque dallo stes so strato provengonouno spillone con testa a tre anelli , un pendaglio imbutiforme, una lamadi pugnale a base semplice con tre fori per i ribattini) ; Viverone : BERTONE, FOZZAVI 2004, p. 59 fig. 1 5 in basso a destra e in alto a destra . Lecuspidi di Ledro e della palafitta di Moniga (recuperi A. Garro) sonoinedite.
1 . I musei civici di Varese. Preistoria e Pro tostoria 1 3 1
1
2
3 -==
4
Fig. 6 - Palafitta di Bodio centrale. 1 , 4 . forme di fusione per asce a taglio fortemente espanso ; 2-3 .lame di pugnale. 2-3 da Bianco Peroni 1 994 con modifiche. Riduzione a 1 ' 3 della gr.nat .
\
Le cuspidi di lancia di Viverone, anche se provengonoda recuperi non scientifici , sono comunque databili allefasi centrali della media età del Bronzo, come tutte le
ceramiche e gli altri bronzi della palafitta (a parte i materiali di BronzoFinale) . La seconda cuspide di lancia ha invece lama stretta, con alettea profilo convesso e larghezza massima verso metà lunghezza, mentrela parte libera del cannone è lunga(fig . 7 : 2) . Cuspidi di lancia abbastanza simili sono presenti a Cisano,a Peschiera e con un solo esemplarenel ripostiglio della Cascina Ranzadi Milano 67 .
Le cuspidi di lancia in bronzo deltipo con innesto a cannone compaiono per la prima volta nell 'Europasud-orientale, in particolare nel bacino carpatico, dove iniziano a farparte dei corredi funerari fin da unafase centrale dell ' antica età del Bron
zo 68 . Nelle fasi avanzate del Bronzo
Antico (A 2-b) le cuspidi di lanciasono frequentemente documentatecon diversi tipi in un vasto territoriodal bacino carpatico fino all 'altopiano svizzero in tombe, abitati e ripo
_ stigli 69 . Con il passaggio dal BronzoAntico al Bronzo Medio la diffusio
ne delle cuspidi di lancia si estendeulteriormente, in particolare versol'Europa settentrionale all 'epoca delperiodo Montelius I (tipo Bagterp) ,
_ e verso le regioni atlantiche (tipoTréboul) 7° .
In Italia le cuspidi di lancia nonsono mai presenti nei corredi funerari prima del Bronzo Finale, a partepochissime eccezioni , che concernono la cultura di Canegrate 7 1 e unatomba di Bellaguarda presso Viadana (MN) 72, inoltre non sono presenti nei ripostigli dell ' antica età del
Bronzo e compaiono per la prima volta in due ripostiglidel Bronzo Medio, la Cascina Ranza, deposto nella fasecentrale del Bronzo Medio ma contenente anche mate
67 FASANI 1 980; Peschiera : DE STEFANI , Atlante inedito, tav. VII d;Cascina Ranza : nn. MPA 2892 , 2902 .
68 Cfr. PRIMAS 1 977/a, p. 1 66 e 1 977/b, p. 1 6 e fig. 5 . M. Primas hasegnalato il caso della tomba 3 5 della necropoli di Battonya, in un'areadi confine tra le culture di Perjamos e di Fiizesabony/Gyulavarsfind, lacui posizione cronologica corrisponde all'incirca al Bz A 2-a dell'Europacentrale.
69 Sull' evoluzione delle cuspidi di lancia in bronzo e la loro primacomparsa e diffusione in Europa cfr. JACOB-FP,IESEN 1 967 ; PaIMAS 1 977a,fig. 2 (carta che comprende anche i ritrovamenti delle fasi iniziali delBronzo Medio) e 1 977b ; I-IOVSK 1 996 ; TAP,OT 2000 , p. 2 ss.
7o Sul tipo Tréboul cfr. HANSEN 1 990 .7 1 RITTATORE 1 957 , p. 24 e tav. XIII (tomba 1 1 0) .72 DE MARINIS, SALZANI 1 997 , p. 706, fig. 406 .
1 32 Alle origin i di Varese e del suo territorio
i i
riali più antichi , e Ello, deposto allafine del Bronzo Medio 73 . Le cuspididi lancia sono frequenti negli abitati ,ma si tratta di abitati di lunga durata, con più fasi cronologiche, peri quali mancano dati di scavo attendibili . Non è quindi chiaro se esistao no un décaIage cronologico nelladiffusione delle cuspidi di lancia traItalia ed Europa centrale. Da questasituazione delle fonti deriva l ' importanza dei ritrovamenti di Bodio, perché anche se mancano dati di scavo,
nel complesso, come vedremo, gliabitati palafitticoli del lago di Varesesembrano cessare la loro attività nel
corso del primo periodo della mediaetà del Bronzo. Quindi per le cuspidi di Bodio è possibile proporre unadatazione o alla fase più avanzatadel Bronzo Antico o agli inizi delBronzo Medio.
Le cuspidi di lancia con la parteprossimale della lama larga e il cannone relativamente corto rappresentano la forma base delle più antiche cuspidi di lancia in bronzo, chenelle prime fasi della loro diffusionesono ancora di dimensioni corte, in
genere comprese tra 1 1 e 1 8 cm dilunghezza totale. Già nella primafase del Bronzo Medio nell 'Europacentrale e settentrionale compaiono lance di grandi dimensioni, peres. nella tomba di Weichering inBaviera (28 ,7 cm) 74 o nel ripostiglio di Valsomegle in Danimarca(43 , 5 cm) 75 , ma è soltanto nel Bronzo Recente e Finale che diventano frequenti lance di grandi dimensioni .Dalla palafitta di Bodio provengono due forme di fu
sione, spezzate e lacunose, attualmente conservate al museo Pigorini di Roma (riE . 6 : 1 , 4) . Entrambe servivanoper la fusione di asce a m.r. con taglio fortemente espanso. Dalle forme di fusione si otteneva un prodotto grezzo,che con la lavorazione a freddo e a caldo assumeva la sua
forma definitiva, è quindi difficile stabilire con esattezzaquale tipo sarebbe stato prodotto, ma considerando la
3 4
L
5 6
Fig. 7 - Palafitta di Bodio centrale. 1 -2 . cuspidi di lancia; 3 . frammento di vaso biconico ; 4 . frammento di capeduncola con ansa ad ascia; 5 -6 frammenti di tazze carenate con ansa leggermentesopraelevata . 3 -6 da Banchieri 1 986 . Riduzione a 1 ' 4 della gr.nat .
forma e la lunghezza del taglio è del tutto probabile chequeste forme servissero per asce del tipo MGhlin, un tipodiffuso tra il corso superiore del Reno e Milano 76 .
Dalla palafitta del Gaggio o Keller proviene una minore quantità di materiali, a parte l' industria litica anche inquesto caso documentata da cuspidi di freccia in selce conpeduncolo e alette, tipiche dell'antica età del Bronzo, soprattutto di fasi avanzate. Tra i bronzi abbiamo tre lame dipugnale a base semplice 77 (riE. 8 : 1 -3) e un'ascia a m.r. con
73 Sul ripostiglio di Ello cfr. I E MARINIS 1 994, p. 59 SS. , figg. 34, 3 5 , 40-42.74 Cfr. JOCKENHOVEL 1 97 1 , nr. 4 e tav. 52 B.
75 JACOB-FRIESEN 1 967 , tavv. 26-27 .
76 Cfr. carta di diffusione in DE MARINIS 1 994, riE . 37 .
77 QUAGLIA 1 8 84, tav. IV, 29 , 36 , 4 1 ; BANCHIERI 1 9 86 , riE. 1 3 : 5 , 6 ;BIANCO PERONI 1 994 nn . 299 , 3 63 , 1 026 .
1 . I musei civici di Varese. Preis toria e Pro tostoria 1 3 3
1
4
Fig. 8 - Palafitta Keller-Gaggio . 1 -3 . lame di pugnale ; 4 . ansa ad ascia ; 5 . ascia a m. r. con tagliofortemente espanso a paletta . 1 -3 da Bianco Peroni 1 994 con modifiche, 4 da Banchieri 1 9 86 .Bronzo riduzione a 1 : 2 , ceramica a 1 : 3 della gr.nat .
lago e a diverse profondità : ceramiche, fusarole, asce e scalpelli di pietra levigata , lame di selce, cuspidi difreccia in selce, due arpioni in osso,manufatti di legno, ossi animali , corna di cervo, un'ascia piatta di rame,due goliere di bronzo, spilloni e fibule di bronzo, perle d'ambra . In questa località si trovarono anche i resti
di una palafitta . I materiali rinvenutispaziano su un vasto arco cronologico, dal Mesolitico - inizi Neoliticofino all ' età del Ferro . Altre scopertefurono effettuate in altri punti della palude Brabbia, in vicinanza delFosso di Mezzo, in comune di Caz
zago, ai Quadri in comune di Biandronno e alla palude Lia in comunedi Ternate, in queste ultime due località per opera di Napoleone Borghi .
Secondo I . Regazzoni in più partidella torbiera si rinvennero "pali infitti nel fondo melmoso e nella torba
taglio fortemente espanso a paletta (fig. 8 : 5) , un tipo caratteristico del Bronzo Antico II, tra la ceramica un frammen
to di capeduncola con ansa ad ascia tipo Monate-Mercurago (fig . 8 " 4) conferma la sistematica presenza di questoorizzonte cronologico nelle palafitte del lago di Varese.
La torbiera della palude Brabbia si estende a sud dellago di Varese nei comuni di Cazzago, Biandronno, Ternate e Varano Borghi .
Le torbiere a sud di Cazzago Brabbia sono menzionate da A. Stoppani ( 1 863) in quanto ricchissime di "antichità lacustri" e per le ricerche ivi condotte da A. Quaglia . Qualche anno dopo C. Marinoni ( 1 868) distinguei depositi torbosi a sud di Cazzago, dei quali ricorda eillustra alcuni ritrovamenti , dalla torbiera della Brabbia
posta più a ovest e lungo la sponda del lago di Varese.La stessa distinzione è operata da I . Regazzoni ( 1 8 7 8) ,secondo cui vi sono due vaste torbiere presso CazzagoBrabbia, una a sud di Cazzago e discosta dal lago, l' altra lungo le due sponde della Brabbia e costeggiante illago (torbiera della Brabbia) . Una descrizione più ampiaè fornita nel 1 8 84 da G. Quaglia, che ricorda le scoperte effettuate dal fratello Angelo a partire dal 1 8 56 nellalocalità detta Mara, a circa 500 m dalla riva attuale del
e disposti nel modo proprio delle palafitte" . A parte i materiali recuperati nella località Mara da Angelo Quaglia,per tutti gli altri non si conosce il preciso luogo di rinvenimento. Inoltre, è da sottolineare il fatto che con la provenienza generica palude Brabbia si conservano spilloni, unpugnale e un'ascia in bronzo databili al Bronzo Recente ediverse fibule della prima età del Ferro e in qualche casodel I secolo a .C. , che per il loro stato di conservazione farebbero pensare a una provenienza di carattere funerario .
Il materiale della palude Brabbia si trovava riunitoprincipalmente nella collezione Quaglia e in quella Regazzoni . La prima fu donata nel 1 89 1 al museo preistorico di Roma, dove tuttora si conserva . La seconda confluìnel civico museo P. Giovio di Como, ma alcuni oggetti
che all 'epoca del Munro ( 1 890) erano indicati come presenti nella collezione Regazzoni furono ceduti al MuseoPonti all' Isolino Virginia ed ora sono al museo civico diVarese 78 . Pochi oggetti entrarono a far parte delle collezioni del Museo di Storia Naturale di Milano, da cui
sono poi confluiti nelle civiche raccolte archeologiche alCastello Sforzesco. Inoltre, altri materiali della paludeBrabbia devono essere pervenuti al museo di Varese nelcorso del tempo, presumibilmente all 'epoca della primaguerra mondiale o successivamente, poiché non sono né
v8 Ad es. , uno spillone (MUNRO 1 890 , fig . 50 n . 28 , CASTELFRANCO1 9 1 3 , p. 3 5 n . 8 3 73 , CARANCINI 1 975 , n . 1 3 1 3) , una fibula ad arco serpeggiante ed una fibula La Tène (MUNRO 1 890 , fig . 50 nn . 1 2 e 1 3 ; CASTEL
FRANCO 1 9 1 3 , p. 36 , n . 8 375 ; BANCHIERI 1 9 86 , figg. 1 5 n . 1 1 A e B, 29 n .1 0) , un' ascia ad alette (MUNRO 1 890 , fig . 50 n . 2 1 ; CASTELFRANCO 1 9 1 3 ,tav. V, 3 ; BANCHIERI 1 9 86 , fig . 1 5 n . 3) .
1 34 A lle origini di Varese e del suo territorio
raffigurati né citati nelle pubblicazioni del Regazzoni, delQuaglia, del Munro e del Castelfranco . È questo il caso ditre asce a m.r. , che con ogni probabilità devono aver fattoparte di un ripostiglio .
Le tre asce a m. r. di tipo Savignano conservate al museo civico di Varese con la generica provenienza "paludeBrabbia" (fig . 9 : 1 - 3 ) , hanno la stessa patina, è probabilequindi che siano state trovate insieme e che costituissero
un ripostiglio . Non si hanno dati circa l ' epoca della scoperta . Le asce tipo Savignano si caratterizzano per il corpo a lati concavi ma non rientranti , tallone semicircolarecon incavo di forma rettangolare, taglio largo espanso adarco di cerchio. Si datano alle fasi centrali dell ' antica età
del Bronzo 79 . Prima della seconda guerra mondiale duedelle asce (MV 1 0 1 5 e 1 022) furono analizzate da H . Ottoe W. Witter al laboratorio di Halle 80 .
n. cat. n. anal. Cu
1 0 1 5 O-W 96 . 00
1 222
1 022 O-W 96 . 50
1 230
Sn Pb As Sb Ag Ni Bi Au Co Zn Fe3 . 80 tr. tr. tr. tr.
3 . 00 0 . 20 tr. 0 . 05 0 . 0 1 tr. tr. tr. tr.
i ii! i i
I risultati indicano che le asce sono in bronzo a basso
tenore di stagno, come di norma si verifica per le ascetipo Savignano. Gli altri elementi sono presenti in minime tracce.
Alla palude Brabbia, e precisamente nella localitàdetta Mara, Angelo Quaglia, sindaco di Cazzago, ritrovòalcune goliere di bronzo, oltre a una notevole quantitàdi materiali archeologici riferibili al Neolitico Antico,Medio e Recente, all ' antica età del Bronzo e alla primae seconda età del Ferro . La notizia più precisa su questoritrovamento, almeno per quanto riguarda la località,sembra essere quella del fratello, arch . Giuseppe Quaglia,che tra i ritrovamenti effettuati alla località Mara, ricorda "due oggetti in bronzo ritenuti da alcuni spallacci ,da altri ornamenti da testa e da molti ancora ignoti ' ' 8 1 .Il termine spallacci ci assicura che la citazione si riferisce proprio alle goliere, poiché così erano state definitedall 'Angelucci .A. Angelucci e A . Stoppani sono i primi a menzio
narle, nel 1 863 . L'Angelucci , dopo avere descritto l ' esemplare in suo possesso, così prosegue ' "Di questi arnesine furono trovati quattro nelle torbiere di Brabbia pressoil lago di Varese, ed il signor Angelo Quaglia di Cazzago possessore di essi , me ne donò gentilmente uno ' ' 82 .A . Stoppani nel suo secondo resoconto sulla scopertadi abitazioni lacustri nei laghi di Lombardia , raccontadi aver visitato le torbiere a sud di Cazzago Brabbia , ricchissime di "antichità lacustri" , insieme a E . Cornalia e
A . Bellotti , e che qui vi fece molte scoperte il signor Angelo Quaglia . I tre studiosi ebbero la possibilità di esaminare i materiali recuperati dal Quaglia, fra cui ancheuna goliera definita "un oggetto stranissimo" , ma cheviene accuratamente descritto . Inoltre, l ' abate Stoppaniaggiunge che "di tale oggetto il signor Quaglia possiedediversi esemplari ' ' 8 3 .
Pochi anni dopo C. Marinoni trattando brevementedei depositi torbosi a sud del lago di Varese, ricorda lequattro goliere del signor Benesperando Quaglia rinvenute nella torbiera della Brabbia e ne raffigura una 84riportando l'opinione già espressa in merito dall 'Angelucci .
Nel 1 878 I . Regazzoni cita il singolare oggetto inbronzo formato da 1 4 collari rinvenuto nella stazione palustre di Cazzago-Brabbia e raffigurato dal Marinoni , eche "fa bella mostra di sé nel Museo varesino" . Il Regazzoni prosegue ricordando l' opinione espressa dall 'Angelucci circa la funzione di questo oggetto (uno spallacciodi armatura) e inoltre aggiunge che l 'Angelucci avrebbeaccennato "a quattro consimili oggetti rinvenuti dal signor Quaglia nella stazione palustre di Bardello" , fattonon vero , poiché l 'Angelucci indica come località di provenienza delle quattro goliere la torbiera Brabbia .
Il disegno del Marinoni sarà ripreso da R . Munro 85e da O. Montelius 86 . Quest 'ultimo, alla luce di quantoscritto dal Regazzoni, conclude che le goliere ritrovatenelle torbiere presso il lago di Varese sono cinque, cioèquattro al Bardello e una alla palude Brabbia .
79 CfI'. DE MARINIS 2005 , p. 253 SS. , annexe 4, tab. I , fig . 7 .8o OTTO, WITTER 1 950 , analisi nn . 1 222 e 1 230 .
8 1 QUAGLIA 1 8 84, p. 80 .s2 A . ANGELUCCI , Le s tazioni lacustri del lago di Varese , 1 8 63 , ristam
pato in ANGELUC« 1 87 1 , pp. 5 - 1 1 , cfr. p. 1 1 .
83 STOPPANI , in ASISN, V, 1 863 , p. 432 .84 MARINONI , 1 868 , pp. 30-3 1 , e tav. VII , 1 6 .85 MuNP,O 1 890 , p. 1 98 e fig . 50 n . 1 8 .86 MONTELIUS 1 895 , CO1 . 5 1 -52 e tav. 4, n . 9 .
1 . I musei civici di Varese. Preistoria e Pro tostoria 1 3 5
1 2
ii
i: : .
I t.,!!
i ' ii ii,i
i7 i 7
! li i :: ii
3
I .: : vi .,' : :!
i li': : !
í !.i i
i f i , ::;
! i7::,
!! ! i i
i fi ! i
4 5
Fig. 9 - 1 -3 . Asce a m.r. tipo Savignano dalla palude Brabbia; 4-5 . Goliere dalla palude Brabbia . Bronzo. 1 -3 riduzione a 1 ' 2 , 4-5 a 1 ' 3 della gr.nat .
M . Bertolone nel 1 948 puntualizzò la situazionetopografica dei ritrovamenti avvenuti nelle torbiere asud di Cazzago Brabbia, descrivendo anche il materiale della collezione Quaglia conservato al museo Pigorini di Roma, fra cui una delle goliere in bronzo, chevenne pubblicata per la prima volta . Una confusione
ancora maggiore è stata aggiunta recentemente da D.Banchieri , che mentre considera proveniente dalla torbiera Brabbia la goliera conservata al museo Pigorinidi Roma, "inventa" una frase attribuendola a Robert
Munro, sulla cui base poi afferma che l 'Angelucci rinvenne personalmente quattro goliere alla palude del
1 36 Alle origini di Varese e del suo territorio
Bardello 87 . Sulla scia della Banchieri T. Urban attribu
isce una goliera alla Palude Bardello e una alla PaludeBrabbia 88 .
Da questa breve rassegna emerge con chiarezza chenessuna goliera proviene dalla palude Bardello . Si trattadi un errore del Regazzoni, che riporta in maniera sbagliata una affermazione dell'Angelucci .Dalla bibliografia riportata e discussa non è del tut
to chiaro se le goliere ritrovate alla palude Brabbia sianodue, come afferma G. Quaglia ( 1 8 84) o quattro, come afferma A. Angelucci ( 1 863) . Ma che quest 'ultima sia laversione giusta si può comprendere dalla frase dell ' abateStoppani precedentemente ricordata : se le goliere fosserostate soltanto due, non avrebbe scritto che il Quaglia nepossedeva "diversi esemplari" . Forse due erano le goliereche erano rimaste nella collezione Quaglia nel 1 8 84 .
Infatti , una goliera fu donata da A. Quaglia all 'Angelucci fin dal 1 863 e si conserva al Museo nazionaled'Artiglieria 89 . Una delle goliere rimaste nella collezione è passata al museo preistorico di Roma, quando fuacquisita la collezione Quaglia, e li ancora si conserva .Dove siano finite le altre due non si sa . Il Regazzoni nel1 878 scrive che una delle goliere "fa bella mostra di sé nelMuseo varesino" , ma attualmente al museo di Varese siconserva solo il calco in gesso di una goliera e un collarea capi aperti che Bertolone giudica "probabilmente della Brabbia' ' 9° . È possibile che una delle goliere sia quellaattualmente al museo nazionale di Antichità di Torino
senza indicazioni di provenienza .La goliera conservata al museo Pigorini è formata da
1 4 collari a capi aperti (fig . 9 ' 4) . Il collare superiore equello inferiore hanno sezione quadrangolare, tutti glialtri circolare. Quella del museo dell' artiglieria di Torinoè formata da 1 5 collari a capi aperti (fig . 9 : 5) . Anche inquesto caso il collare superiore e quello inferiore hannosezione quadrangolare, tutti gli altri circolare.
Le goliere della palude Brabbia trovano il confrontopiù stringente con due goliere di Robbio per il numeroelevato di collari con cui sono formate e per la presenza di collari a sezione quadrangolare. È presumibile chela datazione sia la stessa del ripostiglio di Robbio 9 , incui le goliere sono associate a un'ascia a m.r. con tagliofortemente espanso a paletta pressoché circolare, un tipo
! ii
8 7 La frase di MUNRO 1 890 , p. 1 98 : "and a curious object made ofbronze rings (No. 18) , supposed to be an epaule tte, is also fivm this station" [la torbiera di Cazzago Brabbia] diventa nel testo della BANCHIERI1 9 86 , p. 96 : "Il Munro cita quattro goliere : ' quattro curiosi oggetti similiad uno della torbiera di Cazzago Brabbia sono stati trovati qui ' (MUNRO1 890 , p. 1 98) andate poi disperse" .
88 URBAN 1 993 , p. 98 carta fig . 52, nr. 89 a p. 4 1 4-4 1 5 e nr. 1 0 1 a p.463-464 .
vicino a quello presente nella palafitta Desor e prossimoalle asce tipo M6hlin degli inizi del Bronzo Medio .
Presso l ' inizio dell 'emissario del lago di Varese furonoscoperti due siti palafitticoli , denominati Stoppani quelloposto a oriente e Ranchet quello a occidente dell ' imboccatura del Bardello . Regazzoni ha pubblicato una planimetria della palafitta Stoppani . Gli allineamenti dei palipartendo dalla riva si prolungavano per poco più di uncentinaio di metri , mentre la larghezza massima sembraessere stata di circa 1 60 m. A parte i materiali risalentiad età neolitica, i reperti dell 'età del Bronzo provenienti dalle palafitte Stoppani e Ranchet non sono moltoabbondanti . Dalla palafitta Ranchet proviene un'asciadi bronzo del tipo ad alette allungate databile al Bronzo Finale, mentre dalla palafitta Stoppani abbiamo unospillone con capocchia laminare a losanga, che indica unorizzonte cronologico delle fasi centrali del Bronzo Antico, e alcuni frammenti di scodelle o di tazze-attingitoio acorpo carenato, ma privi dell ' ansa 92 .
Infine, altri ritrovamenti dell'età del Bronzo sono avvenuti nella torbiera Bardello presso la riva settentrionaledel laghetto di Biandronno, fra cui frammenti di tazze oscodelle a corpo carenato e una tazza-attingitoio a corpobiconico, ma priva della sopraelevazione dell'ansa, che probabilmente era del tipo ad ascia, e un frammento decoratoa solcature in serie continua 93 . Dalla sponda del laghetto diBiandronno proviene una spada di bronzo, pubblicata perla prima volta da R Castelfranco 94 . Non sappiamo quandosia stata scoperta, ma quasi certamente dopo il 1 890, dalmomento che non è mai menzionata non solo da C. Mari
noni, I . Regazzoni e G. Quaglia, ma neppure da R. Munro.La spada è in perfetto stato di conservazione a parte
una piccola lacuna alla punta (fig . 1 0 : 1 ) . La lama è ditipo corto e leggermente foliato, con massima larghezzaverso la punta, la sezione è a losanga, con i margini formanti un gradino lungo tutta la lunghezza del taglio . Labase della lama ha forma triangolare e un ricasso a profilo leggermente concavo . Tra codolo e base della lamavi è un'espansione romboidale. Il codolo ha sezione rettangolare e termina con un ingrossamento a mazzuolo asezione ottagonale.
89 ANGELUC« 1 863 , p. 1 1 .90 BERTOLONE 1 948 , p. 1 72 .
9 1 PATRONI 1 9 1 2, figg . A-D.92 Cfr. REGAZZONI 1 878 , tav. VI , 1 1 ; CARANCINI 1 975 , n. 3 5 ; BANCHIE
RI 1 986 , figg . 22 : 7 e 23 : 1 0 , 1 1 e 1 6 .93 Cfr. BANCHIERI 1 9 86 , fig . 2 1 : 3 -5 , 8 .
94 CASTELFRANCO 1 9 1 3 , p. 3 1 e tav. VII , 1 ; cfr. , inoltre BIANCO PERONI1 970 n . 8 3 .
1 . I musei civici di Varese. Preistoria e Pro tostoria 1 37
0
1 2 3
Fig. 1 0 - 1 . spada con codolo a mazzuolo dal lago di Biandronno ; 2 . spada dalla tomba 92 diCanegrate ; 3 . spada tipo Pépinville dall 'Imboccatura del Mincio di Peschiera . 1 da Bianco Peroni1 970 . Riduzione a 1 ' 4 della gr.nat .
Tutte queste spade provengono,quando siano note le circostanzedella scoperta, quasi esclusivamente dal letto dei fiumi, o da laghi etorbiere. Soltanto tre spade provengono da tombe (Pépinville, La Colombine e Canegrate t . 92) , mentrealcune spade tipo Arco e Terontolaprovengono da ripostigli (Sassello inprovincia di Savona, Nocaj Salag inVoivodina) o da depositi votivi (Corte Lazise di Villa Bartolomea e Pila
del Brancon in provincia di Verona) .Questa famiglia di spade è dif
fusa nelle regioni padana e alpina,qualche esemplare verso nord-ovestraggiunge i corsi della Senna e dellaMosella e verso sud l' Italia centrale.
Isolato appare il ritrovamento delripostiglio di Nocaj Sala lungo laDrava . Per quanto riguarda la distribuzione geografica dei singoli tipi siregistrano delle marcate differenze.Il tipo Arco è ampiamente diffusoa nord del Po nella pianura veneta edella Lombardia orientale, nel Trentino e nelle Alpi occidentali . Diversiesemplari sono stati ritrovati nel corso della Senna poco a sud di Parigi ,mentre una spada tipo Arco proviene dal lago di Mezzano in provinciadi Viterbo . Il tipo Terontola ha unadiffusione un po ' più circoscritta :Lombardia orientale, Veneto, Trentino, cantone dei Grigioni e di Berna, oltre a due esemplari dall ' Italia
La spada di Biandronno rientra in una famiglia dispade caratterizzate dal codolo con ingrossamento amazzuolo e lama maggiormente espansa verso la punta .Nell 'ambito di questa famiglia sono stati individuati alcuni tipi . I tipi Arco e Terontola si differenziano tra loroper la presenza di due fori per i ribattini alla base dellalama nel primo e la loro assenza nel secondo. In entrambiil raccordo tra il codolo e la base della lama ha forma
campanulata . Il tipo Pépinville si caratterizza per la terminazione del codolo non solo ingrossata ma anche ripiegata a uncino. Infine, il tipo Biandronno si caratterizza perl 'espansione romboidale tra codolo e base della lama 95 .
centrale (Terontola e lago Trasimeno) . Il tipo Biandronno conta pochi esemplari : oltre al ritrovamento eponimo,Casalbuttano e dal Po presso Casalmonferrato. A1 tipoBiandronno o a quello Pépinville apparteneva la spadadella tomba 92 di Canegrate (riE . 1 0 : 2) , purtroppo priva dell ' impugnatura, ma soltanto nelle spade tipo Biandronno e in alcuni esemplari del tipo Pépinville, come ades. la spada da Peschiera (riE . 1 0 : 3) , vi sono il ricassoa profilo leggermente concavo, la base triangolare dellalama e l'espansione romboidale tra codolo e base dellalama . Il tipo Pépinville è diffuso soprattutto nei Grigioni, nel Mittelland elvetico e lungo la Senna e la Mosella .
95 Sulle spade con codolo terminante a mazzuolo cfr. BIANCO PERONI 1 970 ; SCHAUER 1 97 1 ; REIM 1 974; DE MARINIS 1 972 e 1 98 5 ; DAVID EL BIALI2000 , p. 8 8 SS . , riE. 1 7 .
1 3 8 Alle origin i di Varese e del suo territorio
In area padana se ne hanno tre esemplari : dal Po pressoCaorso, da Peschiera-Imboccatura del Mincio e da Vol
tabr,usegana presso Padova .E sorprendente l ' assenza di spade con codolo termi
nante a mazzuolo nell ' area terramaricola stric to sensu,
cioè tra il Po e gli Appennini .Per quanto riguarda la datazione, la spada della ne
cropoli de La Colombine proviene da scavi non controllati ed è priva di associazioni . La tomba di Pépinville haun corredo tipico dell' orizzonte di Binningen (fase recente del Bronzo D e inizi Ha A 1 ) , corrispondente alla finedel Bronzo Recente in Italia . La tomba 92 di Canegrate sidata al Bronzo Recente, come tutta la necropoli . I ripostigli di Sassello e di Nocai Salag sono stati deposti agli inizidel Bronzo Finale, ma contengono anche materiali piùantichi e lo stesso vale per il ripostiglio o deposito votivodi Pila del Brancon .
Cercando di delineare un quadro generale delle fasidi occupazione durante l ' età del Bronzo dei siti lacustrinell ' area del lago di Varese, dobbiamo constatare l ' assenza di un orizzonte iniziale del Bronzo Antico (BA I
A) , documentato soltanto dal ripostiglio di asce dell' Isolino Virginia . Le fasi centrali del Bronzo Antico sonorappresentate dalle tre asce tipo Savignano dalla paludeBrabbia e dagli spilloni con capocchia a losanga, mentrel ' orizzonte più recente dell'antica età del Bronzo è documentato dalle asce con taglio fortemente espanso. La
datazione precisa delle lame di pugnale è problematica,poiché a tipologie apparentemente arcaiche corrispondeuna composizione del metallo con buone percentuali distagno, che indicano un'età più avanzata .
Le analisi della composizione del metallo dei manufatti provenienti dalle palafitte varesine mostrano che sitratta sempre di una lega rame-stagno, lo stagno è presente con tassi variabili dal 4 fino al 1 5% per le lame dipugnale, inoltre sono sempre presenti impurità abbastanza elevate di arsenico, antimonio, argento e nichel , chesembrano indicare il riutilizzo di manufatti più antichifabbricati con rame ridotto da minerali di Fahlerz . Fa
eccezione a questo quadro lo spillone con capocchia alosanga da Bodio, che ha appena lo 0 , 5 8% di stagno eche con quasi il 98 , 5 di rame può considerarsi di ramepiù che di bronzo.
Le ceramiche sono caratterizzate principalmentedalle capeduncole tipo Monate-Mercurago, che si collocano alla fine del Bronzo Antico e agli inizi del BronzoMedio . Quindi il periodo di più intensa fioritura degliinsediamenti palafitticoli del lago di Varese si estendelungo l' arco cronologico dal Bronzo Antico II al Bronzo Medio I , in termini di cronologia assoluta tra 1 800e 1 500 a .C . circa, fatto che si accorda bene con le datazioni dendrocronologiche ottenute dalla palafitta delSabbione di Monate.
Bodio
Bodio
Gaggio
GaggioPonti
Lago Varese
Lago Varese
Lago Varese
museo n. anal.
Asce di tipo Savignano
Palude Brabbia Varese
Palude Brabbia Varese
Lame di pugnale
Pigorini
Milano
Pigorini
PigoriniVarese
Pigorini
Pigorini
Pigorini
SpilloniBodio Torino SAM 807 1
Goliere
Palude Brabbia Pigorini SAM 20308
Asce a taglio fortemente espanso
Ponti Varese O-W 523
Gaggio Pìgorini SAM 2033 3Desor Varese O-W 867
O-W 1222
O-W 1230
SAM 20523
SAM 1 338
SAM 20525
SAM 20524
O-W 996
SAM 2052 1
SAM 20520
SAM 20522
Cu [ Su I Pb ] As
96 . 00 3 . 80 tr.
96 . 50 3 . 00 0 .20 tr.
82,4
6, 1 0 0 , 64
5 , 00 0,46
6 ,20 0 , 1 1 0 , 80
4,00 0,04 0 ,62
1 5 ,00 0 ,05 1 ,00
7 , 1 0 Tr. 0 , 8 8
6 ,20 0 ,06 0 , 76
7 ,40 Tr. 0 , 5 1
0 , 58 0 ,0 1 0 ,44
6 ,40 0 ,07 0 ,70
84 . 9 1 4 . 00 0 . 05 0 . 30
7 . 90 tr. 1 . 3 5
84 .4 1 4 . 00 0 . 06 0 . 30
Sb Ag Ni Bi I Co I zn I F
tr. tr. tr.
0 . 0 5 0 . 0 1 tr. tr. tr. tr.
0 ,24 0 , 1 6 0 ,40 Tr. Tr.
0 ,24 0 ,05 0 , 1 3 0 ,00 1
0 , 3 3 0 ,2 1 0 ,46 0 ,009 Tr.
0 , 3 6 0 , 1 5 0 , 34 0 ,006 Tr.
0 , 60 0 , 30 0 ,40 Tr. Tr. Tr.
0 ,2 1 0 , 1 3 0 ,46 Tr.
0 , 59 0 , 1 5 0 , 52 0 ,006 Tr.
0 ,47 0 , 36 0 , 1 1 0 , 028 Tr. Tr.
0 , 1 7 0 , 1 5 0 , 1 7 0 ,007 Tr.
0 ,4 1 0 ,04 0 ,24 0 ,005 <0 ,03 Tr.
//
0 . 30 0 . 1 3 0 . 07 tr. tr.
0 . 1 8 0 . 07 0 . 77 0 . 007
0 . 50 0 . 30 0 . 1 7 tr. tr.
1 . I musei civici di Varese. Preistoria e Pro tostoria 1 39
BIBLIOGRAFIA
ANGELUCCI 1 87 1 = A. ANGELUCCI , Lepalafitte del lago di Varese e le armidpietra del Museo Nazionale d Artiglieria, ristampa con aggiunte,Torino 1 87 1 .
AUDIBERT, DELORD 1 959 = J. AUDIBERT, L . DELORD, Essai de synchronisation entre l'dtge du Bronze du Mic et celui du nord-est de la France,in RAE, X, 1 , 1 9 59 , pp. 7-23 .
AUDOUZE, GAUCHER 1 98 1 = E AUDOUZE, G. OAUCHER Typologie desobjets de l'dge du Bronze en France, VI. Épingles, SPF, Paris 1 98 1 .
BANCHIERI 1 9 86 = D.G. BANCHIERI , Preistoria dei laghi varesini, Pisa1 986 .
BERTONE, FOZZATI 2004 = La civiltà d Viverone. La conquista d una nuovafrontiera nell'Europa del II millennio a. C. , a cura di A. BERTONE,L . FOZZATI , Can&lo, Biella 2004 .
BIANCO PERONI 1 970 = V. BIANCO PERONI, Die Schwerter in Italien. Le
spade nell 'Italia continentale , PBF, IV, 1 , Mfinchen 1 970 .
BIANCO PERONI 1 994 = V. BIANCO PERONI, Ipugnali nell'Italia con tinentale , PBF, VI , 1 0 , Stuttgart 1 994 .
CARANCINI 1 975 = G.L . CARANCINI , Die Nadeln in Italien / Gli spilloninell 'Italia continentale , PBF, XIII , 2 , Mfinchen, 1 975 .
CASTELFRANCO 1 9 1 3 - E CASTELFRANCO, Cimeli delMuseo Pon ti nell 'Iso
la VirgMa (Lago di Varese) , Milano 1 9 1 3 .DAVlD ELBIALI 2000 = M. DAVlD ELBIALI , La Suisse occidentale au II«
millénaire av. J. - C. Chronologie, culture, in tégmtion européenne, Cahiers d'Archéologie romande, 80 , Lausanne 2000 .
DE MARINIS 1 972 = R .C. DE MARINIS, Nuovi dati sulle spade della tardaetà del Bronzo nell'Italia settentrionale, in PreistAlp VIII , 1 972 , pp.73 - 1 05 .
DE MARINIS 1 975 = R .C. DE MARINIS, Ripostiglio dell 'an tica età del Bronzo dal Lodigiano , in BCamuno, 1 2 , 1 975 , pp. 6 1 -8 3 .
DE MARINIS 1 982 = R .C. DE MARINIS 1 982, Storia della scoperta dellepalafitte varesine , in Palafitte." mito e realtà , Verona 1 982, pp. 7 1 - 8 3 .
DE MARINIS 1 98 5 = R .C. DE MARINIS, Tre nuove spade della tarda età delBronzo , in NotALomb 1 984, Milano 1 985 , pp. 46-47 .
DE MARINIS 1 994 = R .C. DE MARINIS, Preistoria e pro tostoria del territorio di Lecco. Dal Paleolitico allafine dell ' e tà del Bronzo , in Cartaarcheologica della Lombarda. La provincia di Lecco , Modena, 1 994,pp. 1 8 -80 .
DE MARINIS 1 998 = R .C. DE MARINIS, La metallurgia dell 'antica e mediaetà del Bronzo in Piemonte , in Archeologia in Piemon te. La preistoria , a cura di L . MERCANDO, M . VENTURINO GAMBARI , Torino 1 998 ,pp. 1 57- 1 86 .
DE MARINIS 2002 = R .C. DE MARINIS 2002, Towards a Relative and Ab
solute Chronology of the Bronze Age in Northern Italy , in Not. Arch.Berg. , 7 , 1 999 (2002) , pp. 23 - 1 00 .
DE MARINIS 2005 - R .C. DE MARINIS, Évolution et variation de la composition chimique des objets en mé tal pendant les dges du Cuivre et duBronze Ancien dans l 'Balie septen trionale , in Lapremière métallurgieen France et dans lespays limitrophes, Actes du colloque in ternationalde Carcassonne, 28-30 septembre 2002 , éd . E AMBERT, J. VAQUEP
Mémoire de la Société Préhistorique Fran aise, XXXVII , 2005 , pp.249-264 .
DE MARINIS, SALZANI 1 997 = R .C. DE MARINIS, L . SALZANI, Le necropolidel Bronzo Medio e Recen te nella Lombardia orientale e nel Veneto
occidentale , in Le Terminare. La più an tica civiltà padana, a cura diM . Bernabò Brea, A . Cardarelli , M . Cremaschi , Milano 1 997 , pp.703 -707 .
FASANI 1 980 - L . FASANI, Imateriali preistorici della stazione palafitticola di Cisano ( Verona) , Collez . e Musei archeol , del Veneto, Venezia1 980 .
GUERRESCHI, LIMIDO, CATALANI 1 985 = G. GUERRESCHI , C. LIMIDO, P. CATALANI, L'insediamentopreistorico dell'Isolone delMincio , Brescia 1 985 .
HAFNER 1 995 = A. HAFNEP Die J?idhe Bronzezeit in der Westschweiz,Ufersiedlungen am Bielersee, Band 5 , Bern 1 995 .
HANSEN 1 990 = S. HANSEN, Eine westeuropiiische Lanzenspitze aus dereRhein bei Mainz, in ArcUiologische Korrespondenzblatt, 1 990 , pp.3 87-395 .
JACOB-FRIESEN 1 967 = G. JACOB-FRIESEN, Bronzeze itliche LanzenspitzenNorddeutschlands und Skandinavien, I-II . Hildesheim 1 967 .
JOCKENHOVEL 1 97 1 = A. JOCKENHOVEL, Die Rasiermesser in Mitteleuro
pea, PBF, VIII , 1 , Mfinchen 1 97 1 .
MARINONI 1 868 = C. MARINONI , Le abitazioni lacustri e gli avanzi diumana industria in Lombardia, Memorie Società Italiana di Scienze
Naturali , IV, 3 , Milano 1 868 .
MONTELIUS 1 895 = O. MONTELIUS, La civilisation primitive en Italie, LBalie sep tentrionale , Stockholm 1 895 .
MUNRO 1 890 = R. MUNRO, The Lake Dwellings ofEurope , London 1 890 .OTTO, WITTER 1 952 - H. OTTo, W. WITTER, Handbuch der ?lltesten vorge
schichtlichen Metallurgie in Mitteleuropa, Leipzig 1 952 (J.A. Barth V.) .PATRONI 1 9 1 2 = G. PATRONI , Nuovi oggetti di bronzo dalla Lomellina, in
BPI, XXXVIII , 1 9 1 2 , pp. 84-9 1 , figg . A-D.
PRIMAS 1 977a = M. PRIMAS, Zur Informationausbreitung im sfddlichenMitteleuropa, in Jahresberich t cl. Instituts f Vorgeschichte der Universitii t Frankfurt A. M. , 1 977 , pp. 1 64- 1 84 .
PRIMAS 1 977b = M. PRIMAS, Untersuchungen zu deh Bestattungssitten derausgehenden Kupfer- undfriihen Bronzezeit , in Bericht d. R. - GK. , 5 8 ,1 , 1 977 , pp. 1 - 1 60 .
QUAGLIA 1 8 84 = G. QUAGLIA, Laghi e torb iere del circondario di Varese ,Varese 1 8 84 .
REGAZZONI 1 878 = I . REGAZZONI , L'uomo preistorico nella provincia diCorno, Milano 1 878 .
P IM 1 974 = H. RZ M, Die spiitbronzezeitlichen Griffplatten-, Griffdornund Griffangelschwerter in Ostfrankreich , PBF IV, 3 , Mfinchen 1 974 .
HOVSKí 1 996 - J. RíHOVSK , Die Lanzen-, Speer- und Pfeilspitzen inMiihren , PBF, Stuttgart , 1 996 .
RITTATORE 1 957 = E RITTATORE, La necropoli di Canegmte, in Sibrium,III , 1 956- 1 957 , pp. 2 1 -3 5 , tavv. B-B6 e IX-XIV.
SAM - S. JUNGHANS, E . SANGMEISTEP M. SCHRODER Metallanalysenkupferzeitlicher und f!'iihbronzezeitlicher Bodenfunde aus Europa,Studien zu den Anfiingen der Metallurgie, Band 1 , Berlin 1 960 ;Kupfer und Bronze in derf!'iihen Metallzeit Europas, Studien zu denAnf ingen der Metallurgie, Band 2, Teil 1 -3 , Berlin 1 968 ; Kupfer undBronze in der friihen Metallzeit Europas, Studien zu den Anffingender Metallurgie, Band 2, Teil 4 , Berlin 1 974 .
SCHAUER 1 97 1 = P SCHAUER 1 97 1 , Die Schwerter in Siiddeutschland,
Osterreich und der Schweiz, I , PBF, IV, 2 , Mfinchen 1 97 1 .SPINDLER 1 973 = K. SPINDLER, Die friihbronzezeitlichen Flidgelnadeln , in
JbSchw Urgesch , 57 , 1 972- 1 973 , pp. 1 7 -8 3 .STOPPANI 1 8 63a = A. STOPPANI , Prima ricerca di abitazion i lacustri nei
laghi di Lombardia, in A tti della Socie tà Italiana di Scienze Naturali,V, 1 863 , pp. 1 5 3 - 1 63 .
STOPPANI 1 863b, Rapporto sulle ricerchefatte a spese della socie tà italianadi scienze naturali nelle palafitte del lago di Varese, in A tti della Socie tà Italiana di Scienze Naturali, V, 1 863 , p. 422 ss.
STOPPANI 1 864 = A. STOPPANI , Sulle antiche abitazioni lacustri del lagoJdiVarese , in A tti della Socie tà Italiana di Scienze Naturali, VI , 1 864,
p. 1 8 1 ss.
TAROT 2000 = J. TAROT, Die bronzezeitlichen Lanzespitzen der Schweiz,UFzPA, 66 , Habelt , Bonn 2000 .
, i
' i i