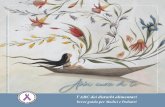Percezioni Alimentari. Tendenze e consumi a Varese
Transcript of Percezioni Alimentari. Tendenze e consumi a Varese
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di Laurea in
Antropologia del mondo contemporaneo
PERCEZIONI ALIMENTARI.
TENDENZE E CONSUMI A VARESE
Tesi di:
Erica Risoli
Relatore:
Stefano Boni
Correlatore:
Vallori Rasini
Anno Accademico 2011/2012
2
"L'epoca in cui viviamo esige un gran risparmio di tempo e di danaro per ogni cosa, cucina compresa; alla quotidiana vita di trepidazione, di elettricità, di dinamismo è necessario uniformare anche ciò che riguarda l'andamento della casa. Non vi è più nessuno che rimanga a tavola per ore ed ore come usavasi nei tempi antichi. Non vi è più nessuno che possa avere tempo d'aspettare che sia pronto il tale od il tal altro difficile manicaretto per il pranzo o per la cena. Bisogna che tutto sia ben fatto, gustoso e specialmente bisogna che ciò avvenga con la massima rapidità: la più caratteristica delle esigenze della vita moderna."
(Casadoro. Piccolo consigliere della signora moderna, 1931, p. 4.)
3
INDICE OGGETTO DI STUDIO E ORGANIZZAZIONE DELLA TESI ................................................................... 4 1. IL CONTESTO DI RICERCA ............................................................................................................................................. 5 2. LA METODOLOGIA DI RICERCA .................................................................................................................................... 6
I. L’ASCESA DEL SUPERMARKET IN ITALIA .......................................................................................... 9 1. DALLA FINE DELL’OTTOCENTO AL BOOM ECONOMICO NELL’ALTO MILANESE ................................................. 9 2. STORIA DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ALIMENTARE IN ITALIA ...................................................................... 12 3. IL LUOGO FISICO E IL NONLUOGO .............................................................................................................................. 16 4. PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RIVENDITORI ALIMENTARI ......................................................................................... 23 5. PERCHÉ RECARSI AL SUPERMERCATO: RAGIONI ECONOMICO-‐SOCIALI ............................................................. 27 6. CONCLUSIONI ............................................................................................................................................................... 33
II. LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI: UN NUOVO RAPPORTO .................. 35 1. GRADO PREDILETTO DI LAVORAZIONE DEGLI ALIMENTI ..................................................................................... 38 2. I SURGELATI: NASCITA, LAVORAZIONE, CONSUMO ................................................................................................ 45 3. ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI: DOVE SI TROVANO E QUALI RISCHI COMPORTANO .................. 53 4. COLORANTI E METODI INDUSTRIALI DI LAVORAZIONE ........................................................................................ 59 5. ADDITIVI E SOFISTICAZIONI ...................................................................................................................................... 62 6. SIAMO QUEL CHE MANGIAMO .................................................................................................................................... 64
III. CAMBIAMENTO DELLE MODALITÀ SENSORIALI E DI RAPPORTO CON L’AMBIENTE .... 66 1. CRITERI UTILIZZATI PER L’ACQUISTO DI VERDURA AL SUPERMARKET ............................................................. 71 2. LA STAGIONALITÀ AL BANCO ORTOFRUTTICOLO .................................................................................................. 79 3. MODALITÀ DI SCELTA DI UN PRODOTTO CONFEZIONATO .................................................................................... 86 4. L’ETICHETTA ................................................................................................................................................................ 91 5. IL PACKAGING .............................................................................................................................................................. 95 6. DIVERSI CRITERI PER DIVERSE SITUAZIONI ............................................................................................................ 99 7. DUE RICETTE A CONFRONTO .................................................................................................................................. 102
IV. DIFFERENZE, PREFERENZE E PERCEZIONI DI PRODOTTI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI ............................................................................................................................................. 105 1. GENUINO CLANDESTINO ......................................................................................................................................... 114 2. LA RICHIESTA DEL PRODOTTO ITALIANO ............................................................................................................. 120 3. LA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA: METODI, PRINCIPI, LEGISLAZIONE .............................................................. 122 4. COME VENGONO ACCOLTI I PRODOTTI BIO .......................................................................................................... 128 5. ALTERNATIVE DI CONSUMO A VARESE: CAMPAGNA AMICA, PGS E GAS ...................................................... 133
CONCLUSIONI ............................................................................................................................................. 142 BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................................... 148 APPENDICE ................................................................................................................................................. 159
4
OGGETTO DI STUDIO E ORGANIZZAZIONE DELLA TESI
Il presente lavoro, basato su una ricerca sul campo, ha lo scopo di metter in luce le differenti
tendenze alimentari che riguardano, nello specifico, la città di Varese, ma che possono essere
illustrative di un contesto più ampio.
Il primo capitolo di carattere storico analizza le motivazioni economico-ambientali che, dalla
fine dell'Ottocento alla fine degli anni Cinquanta, hanno portato all'avvento della grande
distribuzione, nella forma dei supermercati. Al Nord questa ha trovato un terreno più fertile
rispetto al resto del paese grazie ad un clima industrializzato e concentrato nelle grandi città
ampliate nel periodo del boom economico. In seguito ho descritto la struttura del
supermercato, dove è ubicato e come si presenta ai suoi avventori. L'anonimato che lo
differenzia dalla piccola bottega di quartiere è una delle caratteristiche che ricorda i
nonluoghi descritti da Augé (1992). Le motivazioni per cui questo sistema distributivo si è
consolidato riguardano la mancanza di tempo a disposizione e la comodità di trovarvi tutto
ciò che occorre. La qualità dei prodotti invece non ha influito particolarmente secondo le
opinioni che ho raccolto confrontate con l'indagine effettuata negli anni Settanta dalla
Generale Supermercati.
Il secondo capitolo riguarda il mutato rapporto con i generi alimentari industriali e
confezionati. La fiducia che la gente ripone nelle nuove tecniche di produzione e
conservazione degli alimenti sono state analizzate tramite il rapporto con lo scatolame e i
surgelati. Inoltre ho presentato il caso OGM in cui la tecnologia ha modificato il corredo
genetico per produrre alimenti sofisticati all'origine, e poco graditi a gran parte della
popolazione, che sottolinea la propria sfiducia verso qualsivoglia tipo di manipolazione del
prodotto. Questo clima è dovuto in particolar modo, agli scandali alimentari, recenti e non,
che spesso godono di grande risonanza mediatica decisamente allarmistica.
Nel terzo capitolo analizzo i criteri di scelta del prodotto, sia fresco (la verdura acquistata al
supermercato) che confezionato (prodotti in cui l'alimento è celato dalla confezione). In
5
entrambi i casi il senso più utilizzato è quello della vista, che implica distanza, che Le Breton
(2003) descrive come peculiare della modernità. Come la verdura deve sembrare fresca a
prima vista, il prodotto inscatolato deve contenere tutte le informazioni possibili in etichetta. I
nuovi criteri europei, tra l'altro, enfatizzano la grandezza dei caratteri e il contrasto cromatico
necessari per una buona lettura. Le informazioni che vi si trovano però sono svariate e non
tutte hanno la stessa importanza per i consumatori, che ne prediligono alcune come gli
ingredienti, facendone passare altre in secondo piano. La stagionalità della verdura invece è
stata quasi dimenticata e il rapporto con le coltivazioni della terra si è spostato a favore del
riconoscimento della verdura stagionale tramite il rapporto tra il prezzo e la qualità di questa,
riscontrata in un determinato periodo.
L'ultimo capitolo invece raccoglie le alternative di consumo che sono emerse e gli orizzonti
verso cui la popolazione si sta dirigendo o vorrebbe dirigersi. La grande sfiducia verso la
certificazione biologica e la richiesta sempre crescente di prodotti genuini e non sofisticati
hanno portato alla nascita di diverse possibilità di consumo, come i mercati cittadini di
prodotti agricoli a km 0, oppure i gruppi di acquisto solidale. La modalità dell'acquisto diretto
sta prendendo piede in un clima di sfiducia in cui la trasparenza e la località (in particolar
modo la filiera corta e il made in italy) offrono maggiori rassicurazioni anche se non sempre
giustificate.
1. Il contesto di ricerca
Varese è un città lombarda di 81.683 abitanti1, capoluogo dell'omonima provincia e ottavo
comune della regione per popolazione. Il primo supermercato Standa sorse nel 1961 in una
posizione centrale di fronte alle Ferrovie Nord Milano. La cucina è quella tipica lombarda,
con la cassouela, gli ossibuchi, il risotto alla milanese (allo zafferano), la cotoletta alla
milanese (impanata), le minestre di verdura e riso, insieme ad alcuni piatti "di lago" come il
risotto con il pesce persico o con l'anguilla. Tipico anche il bruscitt, carne di manzo a pezzetti
con semi di finocchio e vino rosso. I dolci della zona sono invece i Brutti&Buoni e gli
amaretti. La cucina di lago è abbastanza diffusa, ciò è dovuto alla presenza di sette laghi
distribuiti all'interno della provincia, anche se ultimamente non tutti sono balneabili a causa
dell'inquinamento industriale. I numerosi altopiani e le montagne della zona Prealpina
1 DATI ISTAT 2011 http://demo.istat.it/bilmens2011gen/query.php?lingua=ita&Rip=S1&Reg=R03&Pro=P012&Com=133&submit=Tavola (Data di accesso 04/03/2013).
6
impedirono lo sviluppo di un'agricoltura estensiva. Fu favorita invece l'industria
manifatturiera (Calzaturificio di Varese) o la migrazione e il pendolarismo verso la Svizzera
(la città si trova al confine con la Svizzera italiana) e il capoluogo lombardo spostato di circa
50 km a sud.
2. La metodologia di ricerca
La maggior parte delle interviste è stata svolta all'esterno di un grande centro commerciale
(Iper) al cui interno si trova il primo ipermercato aperto in città nel 1988 posto al limitare del
centro della città. Le restanti interviste sono state effettuate all'esterno di un altro piccolo
supermercato Sisa (superette) del quartiere di San Fermo, al centro del rione di Valle Olona
in cui sono ancora concentrati alcuni piccoli esercizi commerciali come un panettiere, una
gastronomia e un fruttivendolo e alcune al mercato cittadino. Inoltre ho intervistato tre
fruttivendoli situati in una posizione centrale della città. Le interviste al supermercato sono
state effettuate rigorosamente all'eterno, nel parcheggio, per evitare reprimende dal settore
direttivo. Infatti, quando feci richiesta di lavorare anche all'interno di tre grandi catene di
supermercato ricevetti risposte poco entusiasmanti. Esselunga mi ha negato l'accesso
adducendo due motivazioni: l'impossibilità di soddisfare la sovrabbondanza di richieste di
tirocini e collaborazioni, a cui la politica aziendale impone di dare risposta negativa e la
scarsità di dati che l'azienda in ogni caso decide di divulgare. Per quanto riguarda Coop
invece, oltre a richiedere un resoconto sui dati che avrei raccolto insieme alle motivazioni
della ricerca e a una garanzia da parte dell'università, ha chiesto la riformulazione del
questionario, ottenendo un rifiuto. Per quanto riguarda Iper invece non ho ricevuto alcuna
risposta. Le sessanta interviste sono state effettuate seguendo il modello del questionario
semi-strutturato (in appendice).
Il questionario si compone di alcune domande a risposta chiusa come quella in cui viene
chiesto se si predilige utilizzare la passata, il sugo pronto oppure i pomodori quando si
prepara il sugo per la pasta. Ogni domanda a risposta chiusa veniva commentata e spiegata.
La maggior parte invece è a risposta aperta come quelle che richiedono il proprio parere in
merito, ad esempio, alla questione OGM, oppure alla certificazione biologica: non si
suggerivano risposte e si prendeva nota del flusso del discorso dell'intervistato.
Successivamente le risposte sono state organizzate per gruppi di affinità tematica. Ho ritenuto
importante mostrare anche le opinioni che portavano ad una determinata risposta per evitare
7
di analizzare i dati in maniera statistica. Ogni intervista infatti si trasformava più in un
dialogo sulle proprie abitudini alimentari in cui le domande strutturate venivano usate come
traccia per spostare l'argomento sulle diverse tematiche indagate piuttosto che come
questionario anonimo e formale. Tutte le domande, (a parte quella sulla conoscenza della
stagionalità di tre ortaggi) non richiedevano conoscenze specifiche, ma analizzavano le
diverse abitudini.
E' importante ricordare che le interviste rivelano l'autorappresentazione, il che non comporta
una precisa sovrapposizione con i dati effettivi di vendita o con le pratiche dichiarate nel
colloquio. Credo che spesso gli intervistati abbiano preferito discostare lievemente le proprie
risposte dal comportamento effettivamente assunto, facendole propendere in parte verso le
proprie aspirazioni: in pratica si enfatizzavano e amplificavano, nelle risposte, le prassi che si
desideravano, orientate verso genuinità, autogestione e località. L'ho notato in particolar
modo dalle differenze che intercorrevano tra le dichiarazioni e la spesa effettivamente
contenuta nel carrello. Avevo infatti l'occasione di analizzarla nel dettaglio in quanto molti,
durante le interviste, la caricavano nel bagagliaio per non perdere troppo tempo. Ciò non
implica una scarsa attendibilità dei dati raccolti, ma un modello interpretativo in grado di
tener conto di tali manipolazioni, utili peraltro per individuare i desideri e le tendenze che
stanno emergendo.
Per quanto riguarda l'ultimo capitolo, quello sulle alternative alla grande distribuzione,
invece, ho seguito un modello di intervista più libero in quanto ho voluto approfondire le
tematiche emerse dal questionario analizzate principalmente nel secondo e nel terzo capitolo.
Ho dunque intervistato alcuni partecipanti a GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) per capirne
meglio la struttura organizzativa. Inoltre per il progetto PGS (Participatory Guarantee
Systems) ho seguito una visita ad una piccola azienda agricola della provincia che si occupa
della produzione di formaggio di capra e dunque dell'allevamento ovino. In tale contesto ho
avuto modo di parlare con il proprietario che mi ha illustrato più da vicino alcune realtà
agricole territoriali. Ho inoltre seguito alcune riunioni di organizzazione del progetto, ancora
in fase sperimentale, e conclusosi nel febbraio 2013 con un ottimo seguito e la creazione di
un comitato del Varesotto. Per il progetto Campagna Amica invece ho parlato con alcuni
produttori presenti al mercato per capire quanto la direzione di consumo si stesse orientando
in quella direzione. Infine ho parlato dell'argomento con parenti, conoscenti e amici, persone
al supermercato con cui ho scambiato informazioni e che mi hanno suggerito differenti punti
di vista sull'argomento.
Le interviste realizzate attraverso il modello del questionario sono state in totale sessanta e
8
sono state ripartite in tre fasce di età: venti giovani (dai 20 ai 40 anni), venti adulti (dai 40 ai
60 anni) e venti anziani (dai 60 agli 80 anni). Sotto i vent'anni le abitudini alimentari sono da
ricondursi ancora a quelle riguardanti il nucleo familiare originario, per cui ho preferito
evitare questa fascia mentre sopra gli ottanta non è facile incontrare molta gente che ancora si
reca autonomamente a fare i propri acquisti. Nonostante la casualità con cui venivano
effettuate le interviste non mi è mai capitato di incontrare ragazzi sotto i venti anni, mentre ho
incontrato una sola donna di ottantasei anni che ho comunque fatto rientrare nella categoria
anziani. Una ulteriore divisione è stata fatta per quanto riguarda il genere. Sono state
intervistate circa lo stesso numero di uomini (29) e di donne (31) per valorizzare anche la
variabile di genere. In tutti i casi in cui non viene specificato nulla, i grafici si riferiscono alla
totalità delle persone, mentre, nei casi opportuni sono state prese in considerazione le due
variabili di età o di genere. Nei casi in cui non sono state prese in considerazione queste due
variabili, significa che esse non assumevano un ruolo rilevante. I grafici presenti, non
corredati da alcuna didascalia sono frutto delle interviste effettuate, mentre le citazioni “tra
virgolette” riguardano i commenti forniti da tutte le persone con cui ho parlato.
9
CAPITOLO PRIMO
L’ASCESA DEL SUPERMARKET IN ITALIA
1. Dalla fine dell’Ottocento al boom economico nell’Alto Milanese
A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta dell’Ottocento, durante un grave periodo di
crisi agraria, nacque una profonda spaccatura tra lavoro agricolo e manifatture locali da cui
dipendevano fino a quel momento le famiglie contadine. Questo avvenne in particolar modo
nella zona a nord di Milano che sentì l’influenza della grande città, meta ambita in cui
emigrare per cercare di scampare alla miseria che offriva la campagna. Anche la Svizzera fu
vista come meta importante di migrazione soprattutto per le famiglie agricole del comasco e
del varesotto colpito dalle difficoltà della coltivazione del gelso alla fine degli anni Novanta
(Corner 1993, p. 84). Nel Novecento i cambiamenti si fanno sempre più marcati. L’interesse
per la terra andò attenuandosi in quanto il lavoro nell’industria manifatturiera, finora visto
come un sostentamento offerto alla povertà di capitale di cui disponevano le famiglie
contadine, acquisì maggiore importanza. Il cambiamento divenne evidente quando anche gli
uomini (generalmente i figli più giovani) cominciarono a cercare un impiego in industrie
diverse da quelle tessili attirati da salari più elevati. La famiglia passò dunque da un assetto
contadino-operaio ad uno operaio-contadino.
Fino alla fine dell’Ottocento invece, nell’alta Brianza l’industria serica e cotoniera ebbe un
ruolo di rilievo grazie alla suddivisione del lavoro che rispecchiava la divisione dei ruoli
all’interno del nucleo famigliare. L’uomo svolgeva ancora i lavori agricoli considerati più
idonei al ruolo maschile di pater familias, mentre la donna poteva lavorare nell’industria
serica, vicina al compito prettamente femminile della tessitura, per assicurare maggiore
liquidità. «La distinzione dei ruoli permise alle famiglie rurali di seguire due vie – quella
agricola e quella industriale – senza vincolarsi irrimediabilmente all’una o all’altra.
10
Contemporaneamente, la natura specificamente femminile della filatura della seta
(determinata in parte dalla tradizione e in parte dal fabbisogno di lavoro dell’agricoltura)
assicurava che le aspirazioni maschili non venissero contaminate dal contatto con l’industria
manifatturiera» (Corner 1993, p. 81). Per questo motivo molte donne, e in seguito anche i
figli minori, cominciarono a lavorare nell’industria pur rimanendo legati ad un contesto
rurale. Il che permise un lento, ma graduale ed inesorabile sviluppo dell’industria insieme ad
un quadro agricolo pressoché immobile. Le due fonti di reddito, agricola ed industriale, non
risultarono dunque in competizione, ma complementari, poiché l’unica alternativa sarebbe
stata l’emigrazione o la miseria (Corner 1993, p. 82). D’importanza fondamentale per un
incremento dello sviluppo industriale fu anche l’introduzione, nell’Alto Milanese, del fitto
monetario anziché del fitto a grano2 che lasciò le famiglie più libere di decidere come
impiegare i propri terreni. Nel periodo precedente la Grande Guerra, i vantaggi della
polivalenza produttiva familiare, cominciarono a diminuire, come di conseguenza l’impiego
nel gravoso e sempre meno redditizio lavoro nei campi.
«Le famiglie protoindustriali abbandonarono gradualmente le loro attività agricole, a misura
che cresceva la loro dipendenza dalle manifatture. Di fatto l’espansione delle manifatture
creò un’incompatibilità tra lavoro agricolo e lavoro industriale in seno alle famiglie,
costringendole a scegliere; e le famiglie naturalmente scelsero l’attività che appariva più
redditizia» (Corner 1993, p. 100). Durante la guerra tra il ‘40 e il ‘45 molte piccole imprese
dovettero chiudere a causa della chiamata alle armi, della dislocazione economica e
dell’occupazione nemica. È anche vero che le piccole aziende familiari, in seguito,
costituirono la base dell’industrializzazione regionale e in questo periodo il modello della
pluriattività rimase ancora la chiave della sopravvivenza. Anche se il lungo cordone
ombelicale che legava ancora le famiglie alla terra fu reciso definitivamente solo con il boom
economico nato dalle ceneri della seconda guerra mondiale.
Il 26 aprile del 1945 nacque a Roma la Confcommercio, una delle prime associazioni di
commercianti. In un periodo di pesante inflazione e crisi economica il calmieramento dei
prezzi non fu una manovra attuata a livello nazionale, nonostante venisse particolarmente
richiesta, in quanto il governo temeva di provocare l’effetto opposto. Le uniche direttive
vennero attuate solamente a livello regionale procurando gravi squilibri all’interno del paese.
In questo contesto si moltiplicarono «enti, cooperative e istituti che, agendo senza scopo di 2Affitto di un terreno agricolo pagato non attraverso la moneta corrente, bensì tramite una quantità fissa di grano. Questo metodo impediva agli agricoltori una scelta più libera rispetto alla coltivazione dei terreni a causa della fluttuazione delle variabili che impediscono all’agricoltura di produrre invariabilmente la stessa quantità di frutti.
11
lucro si proponevano di sovvenire ai bisogni della popolazione o di gruppi particolari»
(Scarpellini 2001, pp. 36 - 37). Queste associazioni erano le Acli, gli enti comunali di
consumo, i punti vendita di artigiani e gli spacci aziendali privati, i quali offrivano prezzi
agevolati per quanto riguardava l’approvvigionamento alimentare per fornire degli aiuti alla
popolazione ancora provata dallo strascico bellico. Nacque dunque un problema tra i
commercianti dovuto alla sottrazione di fasce sempre crescenti di acquirenti ai servizi
commerciali ordinari. Nel secondo dopoguerra si parlò di uno sciopero del consumatore a
causa della modesta capacità di acquisto che la distruzione bellica portò con sé.
L’apertura del primo supermercato però dovrà aspettare ancora una dozzina d’anni in quanto
le condizioni economiche e sociali che avrebbero potuto supportare l’avvento della grande
distribuzione non si erano ancora manifestate. «Lo sviluppo consiste essenzialmente in una
crescita economica di tipo quantitativo, che porta ad un più alto standard di consumi,
migliora la qualità della vita, diminuisce la disoccupazione e la conflittualità sociale»
(Scarpellini 2008, p. 131). I prerequisiti per questo tipo di sviluppo erano la crescita di redditi
e consumi in grado di determinare una vivace domanda di nuovi prodotti. Il pesante
inurbamento e la terziarizzazione dell’occupazione portarono ad una concentrazione di
potenziali acquirenti all’interno delle grandi città impedendo il protrarsi di un regime di
autoproduzione, possibile soltanto in un contesto rurale (Eminente 1983, p. 66). Inoltre
l’accostarsi delle donne al mondo del lavoro sottraeva loro tempo da dedicare alla famiglia e
dunque alla cucina. La domanda di prodotti alimentari crebbe notevolmente, ma restò
vincolata alle difficoltà dovute all’ottenimento delle licenze per aprire nuovi esercizi
commerciali nel settore. Il nodo della questione era da attribuire ad una legge fascista del
19263 (Scarpellini 2001 p. 45). Questa legge stabiliva che solo il comune interessato avrebbe
potuto rilasciare l’autorizzazione per aprire un emporio sulla base di una effettiva necessità
della popolazione del quartiere considerando appunto fattori quali la presenza o meno di
mercati rionali e gli aspetti demografici e urbani (Zamagni, 1981 p. 89). «La legge era stata
emanata con l’intento di contenere i prezzi e di esercitare un maggiore potere di controllo
sulla categoria di commercianti» (Scarpellini, 2007 p. 19). Soprattutto in seguito all’avvento
dei nuovi grandi magazzini a prezzo unico come ad esempio la Upim4 nata nel 1928 che
poteva offrire ai suoi avventori uno stock di 4000 articoli a prezzo fisso: ossia a 2, 3, o 4 lire
attuando una pesante strategia concorrenziale. Ma l’apparizione in Italia dei primi
supermercati e il parallelo rapido sviluppo dei grandi magazzini iniziò solo dagli anni del 3 (R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174). 4 Unico Prezzo Italiano di Milano.
12
miracolo economico. Questi ultimi erano presenti sul territorio dalla fine dell’Ottocento, ma
dovettero aspettare la comparsa della grande distribuzione alimentare per innescare la crescita
e la trasformazione che interessò l’intero settore (Scarpellini 2001, p. 13).
2. Storia della grande distribuzione alimentare in Italia La grande distribuzione organizzata in Italia, per quanto riguarda il settore alimentare si
sviluppò in seguito alla diffusione su territorio nazionale di numerosi supermercati e punti
vendita a libero servizio. Il termine “libero servizio” tra l’altro è stato soppiantato dal termine
inglese self service grazie all’importazione americana di un nuovo modello di rapporto con la
merce, e in particolare con il cibo, all’interno di un negozio di alimentare. Alcuni negozi a
libero servizio erano già presenti sul territorio, ma in generale essi si riferivano ad una
piccola parte degli empori tradizionali che lasciavano il cliente libero di servirsi
autonomamente di alcuni prodotti confezionati. Tendenzialmente questo non succedeva però
anche perché la presenza di prodotti confezionati era limitata e le merci erano perlopiù sfuse
o necessitavano di un intervento del commerciante. Il primo Supermarket infatti ottenne la
licenza solo per la vendita a libero servizio «al quale Boogaart5 avrebbe voluto giungere
gradualmente, in due o tre anni, soprattutto per alcuni settori» (Scarpellini 2007, p. 46).
Il primo supermercato self service degno di questo nome fu aperto nel 1916 a Memphis6, ma
la diffusione di questo modello di vendita si ebbe soltanto in seguito alla crisi del ’29.
In Italia invece, paese in cui la capacità di acquisto era nettamente inferiore, la grande
distribuzione trovò terreno fertile solamente a partire dal 1957 principalmente nella zona
urbana di Milano. Non mancarono però alcuni tentativi precedenti, poco apprezzati, come
quello di Quirino Pedrazzoli che il 12 dicembre del 1949 aprì il primo negozio “Self Service
American System”. Questo trovò un riscontro soltanto momentaneamente e fu costretto a
chiudere nell’arco di un breve periodo anche a causa di numerose difficoltà di gestione. Un
altro esempio fallimentare è da attribuire alla società «Supermercato S.p.a.» con sede a Roma
che ritirò le moderne attrezzature utilizzate in un’esposizione nella capitale per farne un
nuovo supermercato. Nel giugno del 1956, infatti, in occasione di un congresso
internazionale sulla distribuzione alimentare fu allestito un supermercato dimostrativo da
parte del dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti per esportare il tanto ammirato 5 Manager tecnico di origine statunitense, membro dell’Ibec ed esperto nel settore dei supermercati a livello internazionale, coordinò lo sviluppo dei nuovi supermercati in Italia per conto della «Supermarkets Italiani S.p.A» fondata a Milano il 13 aprile del 1957. 6 Si tratta del «Piggly Wiggly Store» di Clarens Suanders.
13
American way of life (Scarpellini 2001, pp. 81 - 86), ufficializzando così la nascita di un
nuovo modello di distribuzione alimentare. Nonostante l’entusiasmo mostrato da parte della
popolazione vi furono però notevoli difficoltà di gestione ed approvvigionamento. I principali
problemi dei nuovi negozi furono dovuti all'immagazzinamento della merce; al rifornimento
da parte di produttori; al rilascio delle licenze e alle proteste da parte dei piccoli
commercianti che vedevano nel supermercato un pericoloso ed inaspettato rivale.
Fu solo dal 1957 che cominciò a diffondersi il modello americano in una società in cui la
guerra è ormai un brutto ricordo e la crescita economica offriva delle prospettive del tutto
inaspettate. Il metodo organizzativo venne promosso grazie all’iniziativa di una famosa
azienda finanziariamente solida e con alle spalle una decennale esperienza nel campo dei
supermercati: la Ibec7 (Scarpellini 2001, p. 127). In seguito ad uno studio europeo sulla
possibilità dell’esportazione di una nuova catena di supermercati, Belgio ed Italia risultarono
i candidati migliori ed in particolare la seconda risultò molto accattivante nella zona in
espansione della provincia di Milano. Fondamentale fu il supporto d’investitori locali che
avrebbero meglio compreso le esigenze della popolazione, affiancato ad una gestione
americana che avrebbe fatto fronte a problemi strutturali inerenti al nuovo tipo di
organizzazione. Il modello del supermercato a libero servizio, infatti, permette un notevole
abbattimento dei costi grazie ad un metodo organizzativo ed una gestione strategica molto
efficiente e standardizzata, oltre che alla minore presenza di manodopera rispetto al
potenziale di vendita per metro quadrato.
Indubbiamente però anche questo nuovo esperimento incontrò le stesse difficoltà iniziali
affrontate dai poco fortunati tentativi precedenti. Innanzitutto uno dei problemi era quello
della reperibilità di strutture adeguatamente grandi da poter gestire lo spazio in maniera
ottimale sia per quanto riguarda il magazzino che in secondo luogo per il reparto vendite.
Secondo la definizione ancora attuale del Ministero dell’Industria: «Esercizio di vendita al
dettaglio operante nel campo alimentare (autonomo o reparto di grande magazzino)
organizzato prevalentemente a libero servizio e con pagamento all'uscita, che dispone di una
superficie di vendita superiore a 400 mq e di un vasto assortimento di prodotti di largo
consumo e in massima parte preconfezionati nonché, eventualmente, di alcuni articoli non
alimentari di uso domestico corrente8».
7 International Basic Economy Corporation. Società fondata nel 1946 a New York per conto di Nelson A. Rockfeller con il principale intento di promuovere attività filantropiche e di sviluppo nei settori basilari delle economie locali in America Latina. 8 DEFINIZIONI STATISTICHE ESERCIZI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA (CAMERA DI COMMERCIO) http://images.ca.camcom.gov.it/f/studiestatistica/de/def_eser_gdo2012.pdf
14
Secondariamente farei notare le proteste dei piccoli commercianti la cui paura più che
motivata di perdere buona parte della clientela contribuì alla nascita di alcuni manifestazioni
di protesta. Emblematiche furono le vicende di Firenze del 1961 come quella che il 10 marzo
vide l’intera produzione di latte della centrale cittadina ritirata dal supermercato lasciando
sfornite tutte le altre attività. Le macellerie invece, una delle categorie più colpite dal nuovo
assetto commerciale, lamentavano la mancata chiusura il giovedì pomeriggio, a cui i
supermercati non erano tenuti, oltre alla svalutazione dei prodotti venduti a causa dei prezzi
inferiori proposti dai supermercati (Scarpellini 2007, pp. 88-89). Ci furono dunque numerose
proteste che andarono dai picchetti al lancio di uova o al blocco dei camion che garantivano il
rifornimento dei magazzini. Vi furono anche richieste formali presentate ai comune per
cercare di evitare l’ottenimento delle licenze che avrebbero condotto all’apertura di nuovi
punti vendita. «Si tentò anche di contrastare l’impatto dei supermercati organizzandosi nei
mercati locali in modo che ogni bancarella, a turno, vendesse un articolo a prezzo di costo o
sottocosto» (Scarpellini 2007, p. 49). Proteste a cui la direzione dei supermercati rispose
sempre in maniera moderata per evitare uno scontro diretto che avrebbe inimicato la
popolazione, non ancora sopraffatta da questa diversa gestione alimentare.
Ma il problema principale fu quello dell’approvvigionamento. Come possiamo infatti notare
dal caso della centrale del latte di Firenze, i produttori locali erano del tutto impreparati a
rispondere alle specifiche esigenze del supermercato e alle grandi quantità di prodotti che
necessitavano di ritirare. Grande importanza viene data alla quantità di merce esposta di gran
lunga maggiore a quella che viene acquistata per evitare che gli scaffali rimangano vuoti
dando un senso di pochezza. Questo tipo di presentazione in un negozio self service è
fondamentale, infatti è necessario che un prodotto occupi uno spazio notevole sugli scaffali
per essere notato e attirare l’attenzione del cliente (Caglini 1991). Se in una piccola bottega
l’avventore può chiedere al commesso la tipologia di merce richiesta, qui è la merceologia
che deve presentarsi in maniera invitante tanto da essere scelta per l’acquisto. «La soluzione
al problema dell’approvvigionamento fu dunque quella di realizzare un’integrazione verticale
per poter controllare il processo di produzione e lavorazione delle merci, sia per motivi di
contenimento dei costi, sia per garantire le caratteristiche desiderate dei prodotti ...La grande
distribuzione si assicurava così un ruolo che andava ben oltre quello attribuitole
tradizionalmente di mero canale di distribuzione, ma che si espletava nell’influenzare
l’industria di trasformazione alimentare nelle sue scelte» (Scarpellini 2007, p. 54, 72). Per
(Data di accesso 24/02/2013).
15
questo motivo la Supermarkets Italiani stabilì di avviare una produzione propria, già a partire
dal 1959, di pane a cui si unì quella di gelato e nell’anno successivo di caffè e a un
magazzino per la lavorazione e lo stoccaggio di salumi e formaggi (Scarpellini 2007, p. 53).
Inoltre i primi supermercati passarono ad una politica di importazione diretta dall’estero per
garantire qualità a prezzi inferiori, grazie all’azzeramento degli intermediari. Questa strategia
fu anche utile a garantire un imballaggio di prodotti freschi igienici e controllati effettuata
direttamente in sede di produzione e dunque molto più funzionale.
Negli anni Sessanta dunque le maggiori catene commerciali di supermercati si diffusero su
tutto il territorio nazionale (con una netta prevalenza nel nord del paese) sconvolgendo
l'egemonia delle piccole botteghe di quartiere. Nella zona di Varese il primo supermercato
aperto fu la Standa, nel 1961, in una posizione centralissima di fronte alla stazione, che con il
suo slogan “alla Standa c’è tutto” unì le caratteristiche di un grande magazzino a quelle di un
supermercato. I piccoli empori erano facili da raggiungere anche a piedi mentre il
supermercato si sposa con la sempre crescente meccanizzazione. I piccoli negozi alimentari
svolgevano un’importante ruolo sociale in quanto la gente in fila, spesso conosciuta poiché
era solita fare la spesa nello stesso posto di fiducia, si scambiava opinioni e pettegolezzi e il
commerciante, diversamente dall’anonimato delle cassiere, che cambiavano frequentemente,
diventava “quasi un amico”. Il supermercato invece esprime la tendenza all'anonimato
individualista della modernità liquida.
Secondo lo schema postulato da Tedlow (1993) riguardante le fasi che caratterizzano il
marketing, si può notare come nella prima, di frammentazione geografica, i prodotti sfusi di
origine locale giungevano ai consumatori tramite una fitta rete di intermediari e la filosofia
dominante era di alti prezzi e scarso volume di produzione. Dopo il 1880 iniziò la fase del
mercato unificato in cui ferrovia e telegrafo costruirono un territorio e dunque un mercato più
omogeneo. La fase del mercato frammentato invece ebbe origine negli anni Cinquanta
quando si cominciò a dare rilievo ad una certa differenziazione dei consumi, mostrando
particolare attenzione al target cui si associa inevitabilmente un’enorme crescita di varietà e
quantità di nuovi prodotti specifici per ogni evenienza, lasciando alla televisione il compito di
rendere familiare un modello di vita basato sul consumismo (Scarpellini 2001, pp. 123 -124).
In Italia si può dire però che la seconda e la terza fase si sovrapposero temporalmente in
maniera quasi totale in quanto fu la grande distribuzione a porre sullo stesso scaffale le
tipiche differenze regionali postulando l’unificazione della frammentarietà geografica molto
marcata nel territorio nazionale. Fu la stessa esposizione di una quantità sovrabbondante di
prodotti nuovi e differenti che differenziò i consumi indirizzandoli verso differenti fasce di
16
persone, sempre minori e più specifiche, per rispondere ad ogni tipo di esigenza palesata o
indotta. È per questo che le differenze tra i supermercati italiani, rispetto a quelli statunitensi
o di altre parti d’Europa, in cui comparvero con netto anticipo, furono così marcate e che il
coinvolgimento di partners stranieri risultò indispensabile affinchè potesse consolidarsi
velocemente anche nel nostro paese.
3. Il luogo fisico e il nonluogo
«L’etnologo ha sempre a che fare con almeno due spazi: quello del luogo che studia (un
villaggio, un’azienda) e quello, più vasto, in cui questo luogo si inscrive e da dove si
esercitano influenze e vincoli che non sono privi di effetti sul gioco interno delle relazioni
locali (l’etnia, il regno, lo Stato). L’etnologo è così condannato allo strabismo metodologico:
non deve perdere di vista il luogo immediato della sua osservazione, e nemmeno le sue
esternalità, le connessioni significative con il suo esterno» (Augé 1992, p. 104). È dunque
doverosa una breve presentazione del luogo fisico da cui ha inizio la ricerca che andrò a
presentare: il supermercato.
L’odierno supermercato si presenta spesso come un capannone prefabbricato quadrangolare
dalle dimensioni molto ampie, in una zona poco centrale della città, per supportarne le grandi
dimensioni. Entrando nel parcheggio, il quale fornirà subito una notizia fondamentale come
l’affluenza di gente, si potrà notare la grande insegna disposta sopra l’entrata principale. Se
l’interno può risultare spaesante, il parcheggio esterno lo è ancora di più poiché diviso in
eguali settori correlati da un numero o da una lettera colorata che faciliteranno la successiva
localizzazione della propria vettura. Oggigiorno risulta infatti poco usuale recarsi a fare la
spesa senza automobile, divenuta indispensabile a causa della quantità di spesa da caricarvi in
seguito. Molte donne anziane che non guidano preferiscono infatti aspettare il fine settimana
per farsi accompagnare da figli o parenti in auto e usare l’autobus per recarsi a fare solo
piccoli acquisti, magari in altri punti vendita meno assortiti, ma più vicini. La comodità
dell’auto si unisce a quella dei distributori di carrelli esterni che, con il sistema di sgancio
previa introduzione monetaria (poi restituita), ha portato un ordine maggiore e una
diminuzione dei furti di questi. Infatti, nei primi supermercati i carrelli spesso non venivano
riconsegnati perché si pensava dovessero essere riportati per la spesa successiva. Ciò era
possibile anche grazie alla posizione centrale che questi centri inizialmente occupavano. Oggi
risulterebbe più scomodo impossessarsi di carrelli se si ha l’abitudine di raggiunge il luogo in
17
auto. A volte i supermercati si trovano racchiusi in grandi centri commerciali (Underhill
2004) per offrire all’interno dello stabile una maggiore varietà di negozi. La contropartita
sarebbe data dalla possibilità di trascorrere un intero pomeriggio all’insegna di un
consumismo smodato che va dai prodotti alimentari, all’abbigliamento, alla telefonia, etc…
L’insegna è molto grande e luminosa, visibile dalla strada per attirare clienti sempre
differenti e passanti casuali.
L’interno è invece moderno e luccicante deve sottostare ad alcune regole ben precise di
struttura, gestione ed esposizione affinché tutti gli ingranaggi risultino ben oleati. Partendo
dall’ambientazione, che si riferisce in particolar modo all’arredamento, alle luci e alle
decorazioni dello stabile, essa deve rispecchiare le qualità su cui un negozio o una catena
vorrebbe puntare. Queste possono essere ad esempio la convenienza dell’offerta, l’ampio
assortimento di articoli biologici oppure la preferenza rivolta alle grandi marche a dispetto di
quelle meno conosciute. L’unica “regola generale” è che l’ambiente sia il più accogliente ed
invitante possibile, tale da non mettere a disagio nessun potenziale cliente e da stimolare il
pensiero di un piacevole periodo di tempo da spendervi all’interno. L’ambientazione, ad
esempio, sarà piuttosto scarna qualora si volesse creare un’immagine di convenienza (Caglini
1991, pp. 140 - 141), nonché modello adottato nel primo supermercato Esselunga (allora
Supermarket). L’arredamento è stato, infatti, notevolmente ridimensionato rispetto a quello
tipico dei supermercati americani in cui luci, colori e scaffali risultavano molto più invadenti.
Questa linea sobria e rigida è stata utilizzata principalmente per non scoraggiare gli acquirenti
italiani, abituati fino ad allora ad un clima di maggiore austerità e minore ricchezza di
consumi. L’importazione della struttura americana in toto, avrebbe forse avuto un effetto
troppo dirompente e sfacciato mettendo in imbarazzo i piccoli acquirenti del ceto medio che
non l’avrebbero più trovato un luogo confortevole ed accogliente in cui trascorrere alcune ore
con il resto della famiglia. «È l’intera famiglia a partecipare al rito della spesa, dato che il
supermercato estende al settore alimentare l’abbinamento consumo-divertimento iniziato
molto tempo prima. È per questo che l’ambiente è curato e ogni dettaglio è studiato per
rendere piacevole ed eccitante la permanenza all’interno» (Scarpellini 2008, p. 231). Superata
la prima impressione data dall’arredamento e dall’atmosfera, inizia un giro tra gli scaffali
muniti di carrello o cestello da portare a mano e riempire. Il percorso da seguire però non è
affatto casuale, bensì predeterminato dalla disposizione degli scaffali. Questi guidano il
cliente attraverso un giro turistico tra i prodotti che il supermercato può offrire: «La clientela
deve poter vedere l’assortimento nella maniera più ampia possibile, senza saltare delle corsie
e nello stesso tempo senza avere il senso dell’obbligatorietà del percorso» (Caglini 1991 p.
18
57). Il tragitto viene segmentato in settori comprendenti «l’insieme dei prodotti necessari per
soddisfare un bisogno di tipo generico, come potrebbe essere, ad esempio, il bisogno
generico “pulizia della persona”» (Caglini 1991 p. 54). Solitamente il primo reparto è
dedicato ai prodotti ortofrutticoli di prima gamma (prodotti freschi). Questi sono
generalmente disposti in cassette o grosse casse in cui tutti i singoli ortaggi si presentano in
maniera più o meno disordinata, ma pronti per essere imbustati autonomamente dal cliente
tramite appositi guanti e sacchetti di cellophane. La disposizione “alla rinfusa” permette un
minore impiego di tempo e manodopera utile alla sistemazione dei prodotti. Inoltre l’impatto
visivo dà un maggiore risalto alla genuinità e alla freschezza del prodotto poiché risulta
similare a quello dei banchi del mercato o dal fruttivendolo, oggi decretato come sinonimo di
maggiore qualità. Superata la zona della verdura fresca, dunque, si trovano in genere i
prodotti di quarta gamma, ossia verdure già lavate, tagliate e confezionate. Queste sono già
pronte per essere utilizzate e risultano chiaramente molto più comode, ma spesso hanno
dovuto subire dei processi che permettono alle stesse di mantenere forma, colore, e sapore
per un tempo molto più lungo rispetto al normale deperimento a cui sarebbero andate
incontro. I prodotti di quarta gamma stanno subendo una rapida crescita nel settore delle
vendite grazie al minor tempo che viene dedicato alla preparazione casalinga di pietanze. C’è
però anche chi non li gradisce particolarmente: spesso mi è stato riferito che i prodotti di
questo genere, una volta aperta la confezione, si trovano schiacciati gli uni sugli altri in
vaschette di plastica trasparente da cui si può vedere il contenuto esterno, ma la parte interna
non visibile è già marcia o poco ci manca. Per quanto riguarda le verdure confezionate in
atmosfera protetta, come le insalate, nonostante siano vendute come pronte per essere
condite, nascondono sulla superficie uno strato oleoso che può essere eliminato solo
attraverso un nuovo lavaggio, come descrisse un uomo intervistato all’uscita di un negozio
ortofrutticolo dove preferisce recarsi per l’acquisto di verdura.
Dopo questo reparto abbiamo i frigoriferi contenenti latte e latticini, formaggi, affettati, pasta
fresca, etc… Tutto quello che deve rigorosamente rimanere a temperatura piuttosto bassa o
andrà incontro ad un rapidissimo deterioramento. Il reparto centrale è il più ampio e riguarda
principalmente lo scatolame. Si trova appunto nei banchi centrali e comprende una serie di
prodotti che vanno dalla pasta al tonno in scatola, alle merendine, ai
biscotti…tendenzialmente imballati in un involucro che non ne permette la visione. È in
questa prospettiva che il cliente non può che affidarsi a criteri differenti rispetto a quelli che
riguardano confezioni in cui è possibile osservare il contenuto. In questo caso la sensibilità
viene mediata dalle etichette che dovrebbe fornire tutte le indicazioni utili alla scelta. In
19
ultima analisi, prima dei surgelati, troviamo il reparto casalinghi (piccoli oggetti per la cucina
e per la casa) preceduto da una sezione di cibi confezionati per animali domestici. Di recente
questi ultimi sono diventati la quasi esclusiva fonte di nutrimento somministrato a questi
animali. Da notare infatti che una volta proposto questo tipo di cibo essi se ne abitueranno
subito, rifiutando spesso altri tipi di carne. Inoltre il prezzo di questi è direttamente
proporzionale al grado di dipendenza che provocano nell’animale che spesso lo porterà a
rifiutare quelli più economici.
Il reparto dei detersivi occupa grande spazio e colpisce la diversificazione dei vari prodotti,
ognuno specifico per ogni tipo di sporco. È molto apprezzato ed è stato più volte menzionato
da alcune signore di una certa età come uno dei reparti dotati di grande attrattiva. Ora il
bucato non viene più fatto a mano e i detersivi per la lavatrice si trovano tendenzialmente
solo al supermercato. Inoltre le facoltà disinfettanti e antisettiche dell’aceto pare che siano
state dimenticate sotto dozzine di flaconi di detergenti specifici per gli usi più disparati.
Finalmente arrivati quasi in fondo, con il carrello strabordante di confezioni colorate, ci
apprestiamo ad affrontare il banco dei surgelati. Questi sono stati posti alla fine del percorso
in quanto devono rispettare la catena del freddo o potrebbero andare incontro ad uno
scongelamento che ne altererebbe le proprietà nutritive oltre all’atto pratico e poco
rassicurante dello sgocciolamento delle confezioni per tutto il supermercato. Anche gli
alimenti presenti all’interno del banco frigo non dovrebbero superare una certa temperatura,
ma questo viene spesso posto all’inizio per ingolosire il cliente, allo stesso modo della
verdura. Solitamente questi reparti sono posizionati in modo tale da costruire un passaggio
obbligato più difficile da ignorare e dunque anche più trafficato. È posto all’inizio e serve a
veicolare gli acquisti effettuati d’impulso. Infatti nei primi reparti, ossia quelli in cui il
passaggio di persone è superiore lo saranno anche gli acquisti solitamente proporzionali
all’affluenza (Caglini 1991, p. 56).
L’ufficio marketing all’interno di un supermercato, infatti, studia i prodotti in relazione
all’andamento del mercato per definire l’ assortimento ottimale da proporre per quanto
riguarda prezzi e profondità garantendo una risposta efficace alle richieste del consumatore.
Inoltre gestisce i rapporti con i fornitori, le attività promozionali e pubblicitarie oltre a
garantire il controllo di qualità e assortimento (Eminente 1983, p. 103). Un’indagine che
spesso viene proposta per questo tipo di monitoraggio è quella dei supermercati Coop
all’interno della regione Lombardia, ogni anno, in cui vengono somministrati dei questionari
all’interno del punto vendita per testare la qualità dell’offerta, la cortesia e l’efficienza del
personale. La parte finale, oltre i surgelati invece, è spesso occupata dall’acqua. Questa è
20
molto ingombrante, per cui si preferisce tenerla alla fine per evitare che occupi “la miglior
parte” del carrello o che debba essere portata in giro a mano rendendo faticoso e poco
agevole il proprio itinerario. L’esposizione della merce occupa un ruolo fondamentale. I
prodotti verranno generalmente disposti in una maniera tale per cui nella zona arretrata del
punto vendita, la cui affluenza è minore rispetto a quella d’ingresso saranno situate quelle
merceologie che «…presumibilmente verranno ricercate dai clienti in quanto questi hanno già
programmato il loro acquisto» (Caglini 1991 p. 57). Ed è anche questo uno dei motivi per cui
generalmente l’acqua in bottiglia è posta in fondo, in quanto, se viene utilizzata abitualmente
al posto di quella del rubinetto, come afferma un addetto al settore marketing dei
supermercati Tigros, “la gente la cerca, e se è terminata la richiede. Stai sicuro che non si
dimentica di comprarla”.
I banchi serviti si trovano di fronte alle casse e possono essere: macelleria, salumeria,
gastronomia, pescheria e panetteria, e fino ad una ventina di anni fa c’è chi ricorda che anche
il reparto ortofrutticolo era considerato un banco a tutti gli effetti, in cui un addetto aiutava la
clientela nella scelta, non come oggi in cui il servizio è divenuto libero. Questi banchi non
sono presenti contemporaneamente in tutti i supermercati, ma di solito solo negli ipermercati
il cui spazio dedicato alla vendita supera i 400mq. In altri negozi spesso alcuni banchi sono
accorpati, mentre nei discount è più facile che siano del tutto assenti in quanto si predilige
assicurare una vasta scelta di merci confezionate che permettono un risparmiare di personale,
attrezzature e che diminuiscano le difficoltà inerenti allo smercio di prodotti freschi. Possono
trovarsi di fronte alle casse per agevolare il passaggio degli altri carrelli in caso di fila
(organizzata tramite il ritiro dei biglietti numerici) e perché si trovano vicino alle pareti in
quanto spesso direttamente collegati ad un laboratorio di produzione o confezionamento.
Le casse non sono altro che l’ultimo ostacolo prima dell’uscita. Sono ben segnalate e grazie
alla presenza di numerose cassiere verranno aperte in base alla quantità di clienti in coda.
Registrano gli acquisti cosicché si potrà procedere con il pagamento e il trasporto delle buste
tramite carrello alla propria automobile. Oggigiorno stanno nascendo alcuni metodi
automatizzati per velocizzare questo passaggio eliminando la componente umana. Nelle casse
automatizzate è il cliente medesimo a ricoprire il ruolo di cassiere, oppure si possono trovare
i cosiddetti “salvatempo”, apparecchi grandi quanto telefoni cellulari che permettono di
passare il codice a barre delle confezioni ancora prima di essere messe nel carrello e
presentando infine il totale da pagare. Novità apprezzata dalla clientela più giovane, ma meno
da quella un poco più matura abituata ad una gestione differente. Un anziano infatti mi ha
confidato di non utilizzare appositamente questi dispositivi “per non rubare il lavoro di
21
nessuno, soprattutto oggigiorno!”. Giustificazione che viene data anche per motivare
l’acquisto di prodotti di provenienza italiana, ossia l’importanza di risollevare l’economia
sostenendo le imprese presenti nel nostro paese a dispetto di quelle straniere. Va anche
ricordato il sempre maggiore incentivo verso l’utilizzo di carte promozionali specifiche, una
diversa per ogni supermercato, stimolato da alcune promozioni e raccolte punti che in realtà
permettono all’azienda un monitoraggio individuale degli acquisti.
Secondo Augé «con il termine nonluogo stiamo indicando due realtà complementari, ma
distinte: quegli spazi costituiti in rapporto a certi fini (trasporto, transito, commercio, tempo
libero) e il rapporto che gli individui intrattengono con questi spazi» (Augé 2009, p. 87).
Questa loro caratterizzazione è tipica del doppio aspetto della modernità che rappresenta la
perdita del soggetto nella folla, o all’inverso il potere assoluto rivendicato dalla propria
individualità. (Augé 2009, p. 86). Ed è questo il motivo per cui i supermercati vengono
definiti dei nonluoghi in cui la propria identità viene perduta e si affonda nel luogo
dell’eccezione (Agamben 1995), dell’eterno presente, dove le regole che intercorrono tra il
luogo fisico e i suoi visitatori risultano compromesse.
«Il consumatore medio, una volta entrato nel negozio ed una volta che ha iniziato a passare in
rassegna i prodotti, entra in una specie di leggera trance, paragonabile sotto certi aspetti alla
prima fase dell’ipnosi. In queste condizioni le persone subiscono una leggera diminuzione del
controllo normale e possono essere acquistati dei prodotti, di cui non si ha particolare
bisogno, solo perché sono presentati in modo particolarmente invitante» (Caglini 1991, p.
33). Il supermercato dunque risulta un luogo sovrastimolante ricco di imput sensoriali che
cercano di indirizzare il cliente verso il più alto numero di prodotti. Il nonluogo comunica
all’individuo tramite scritte, ambienti, messaggi rivolti a lui in prima persona. Individuali, ma
non individualizzanti. Il layout degli scaffali rispecchia lo stesso criterio utilizzato per la
scelta della locazione delle merceologie all’interno del punto vendita: sistemare i prodotti più
richiesti nelle zone meno visibili rispetto a quelli che devono essere spinti che si trovano nelle
mensole centrali dello scaffale, all’altezza dello sguardo del cliente. Questo metodo vuole gli
scaffali centrali (i più disponibili sia a livello visivo che di comodità di prelevamento del
prodotto) ricolmi di generi alimentari di produzione del supermercato rispetto alle marche più
conosciute sistemate nello scaffale superiore. In quello inferiore invece verrà esposto
l’articolo che offre un minore margine di guadagno o con il prezzo inferiore indicato con un
cartellino speciale. Anche questo prodotto, infatti, essendo già ricercato automaticamente dal
consumatore viene messo in una posizione di minore visibilità. Non sempre la ricerca del
risparmio però è così agevole. In uno studio di Miller (1998) sui criteri che indirizzano i
22
compratori durante lo shopping, inteso come un generico atto di acquisto e non solamente
come spesa voluttuaria e superflua, è riportato l’esempio del supermarket Wood Green di
Londra. Questo ha adottato una strategia commerciale basata sulle forme e i colori delle
diverse etichette che ne faceva risaltare alcune piuttosto che altre. Tra questi prodotti
segnalati, alcuni erano in promozione o ribassati, mentre altri presentavano solo una scritta:
“occhio al prezzo” che attirando lo sguardo del cliente lo induce a credere che sia presente
un’offerta (Miller 1998, p. 74). Questo accade perché fra tutti gli acquisti effettuati all’interno
di un supermercato, una parte considerevole viene effettuata sotto l’impulso momentaneo che
si forma nel momento stesso in cui il cliente vede il prodotto (Caglini 1991, p. 32). Infatti
spesso ci si trova nella condizione di essere andati al supermercato “per comperare una
sciocchezza e si esce dalle porte scorrevoli con il carrello pieno”. Ad ogni modo il
consumatore ha imparato a gestire gli stimoli sia visivi che uditivi selezionandoli ed
applicando una difesa percettiva del tutto istintiva: «solo una piccola parte degli stimoli
ricevuti dagli organi di senso provocano una risposta da parte del soggetto percipiente.
Questa tendenza sembra accrescersi nel comportamento del consumatore e può spiegare
come molte “emissioni” del negozio vadano perdute o non vengano percepite anche se molto
evidenti (cartelli, scritte per informazioni, annunci radio, ecc.)» (Caglini 1991, p. 34).
Il nonluogo, infatti, comunica attraverso testi scritti, icone o messaggi subliminali, persone
morali od istituzionali, annunciatori la cui presenza si indovina soltanto vagamente. (Augé
1992, p. 89). Ne sono una prova i cartelloni pubblicitari cartonati o le nuove casse in cui la
presenza umana è del tutto superflua già resa meno utile dalla modalità di vendita a libero
servizio. Il consumatore, all’interno del supermercato non si trova affatto in un luogo
imbricato di tradizioni e di rapporti umani che hanno senso e danno senso ad una collettività.
«I nonluoghi mediatizzano tutto un insieme di rapporti con sé e con gli altri che deviano dai
loro fini solo indirettamente: se i luoghi antropologici creano un sociale organico, i nonluoghi
creano una contrattualità solitaria» (Augé 2009, p. 88). Questo genere di contrattualità (ossia
le modalità d’uso del nonluogo) trabocca in ogni momento della propria permanenza come è
l’esempio del carrello o del cestino fornito appositamente dal supermercato in cui non è
permesso aggirarsi con un proprio sacchetto. Questo contratto si rinforza col riconoscimento
individuale che avviene al momento del pagamento tramite l’utilizzo della carta fedeltà che
suggella il patto tra supermercato e cliente. L’identificazione risulta infatti un’altra peculiare
caratteristica dei nonluoghi. La possibilità di entrare in uno spazio d’eccezione è data
dall’identificazione che da diritto ad una sorta di libertà. Libertà di scelta e di movimento,
sempre all’interno del campo di gioco delineato dalle regole che al momento dell’accesso
23
vengono sottoscritte. Questo non è infatti luogo d’incontri poiché nessuno fa caso alle altre
persone se non durante la fila alle casse in cui solo raramente capita di scambiare qualche
parola.
Il supermercato è dunque il luogo della modernità in cui i rapporti spazio-temporali sono
gestiti in maniera distorta, priva di storia, di un passato e di un futuro. Il tempo dell’hic et
nunc in cui si sperimenta un presente perpetuo e un incontro con se stessi dato
dall’accostamento di più solitudini che si sfiorano, come i carrelli tra le strette corsie, ma che
evitano accuratamente uno scontro. Ognuno può manifestare liberamente ciò che è e non ciò
che rappresenta grazie all’indifferenza di cui gode. Un’indifferenza che permette a ognuno di
essere a contatto con se stesso senza curarsi degli altri, presi anch’essi dalla propria
singolarità. Il supermercato, prodotto e caratteristica della modernità, si è dimostrato una
risposta vincente rispetto alle nuove esigenze, alimentari e non, che portano avanti il sistema
di pensiero dell’abbondanza di consumi da cui è nato.
4. Principali tipologie di rivenditori alimentari
L’apparizione in Italia dei primi supermercati e il parallelo rapido sviluppo dei grandi
magazzini iniziò solo dagli anni del miracolo economico, anche se quanto avvenne per mezzo
dei supermercati che presero il posto di piccoli empori e negozi tradizionali era già avvenuto
nel settore delle confezioni con l’avvento dei grandi magazzini che avevano segnato il
declino delle sartorie artigianali (Scarpellini 2001, pp. 13 e 117). Se il supermercato si è
dimostrato una risposta vincente nei confronti della piccola bottega tradizionale, non è solo
grazie alle peculiarità di uno spazio che incarna i valori della modernità, ma ad una serie di
fortunate caratteristiche che gli hanno permesso di prevalere nel campo delle scelte alimentari
individuali.
Innanzitutto le principali differenze tra grande e piccolo dettaglio sono:
SUPERMERCATO a) Ampia superficie di vendita b) Catena di negozi c) Despecializzazione merceologica d) Gestione di tipo societario e) Grandi dimensioni degli
assortimenti
f) Approvvigionamento presso fonti produttive
g) Libero servizio
24
EMPORIO a) Piccola superficie di vendita b) Negozio individuale c) Specializzazione merceologica d) Gestione di tipo familiare e) Dimensione ridotta degli
assortimenti f) Approvvigionamento presso
grossisti g) Servizio tradizionale
25
All’interno della tipologia del “supermercato” inteso come negozio alimentare self-service
troviamo altre differenziazioni in base all’ampiezza della superficie di vendita o alla tipologia
di assortimento proposto. I minimarket o superettes sono esercizi alimentari in cui si effettua
la vendita a libero servizio, ma differenziati dai supermercati per la superficie di vendita che
deve essere inferiore ai 400 mq con relativo restringimento dell’assortimento. Negli anni
Ottanta sono incominciati a sorgere invece gli Ipermercati, la cui superficie invece non deve
essere inferiore ai 2500 mq, come quello aperto a Varese nel 1988, il cui nome è appunto
Iper. Questo ipermercato è stato ulteriormente ampliato per ben due volte e ora è ospitato
all’interno di un centro commerciale, caratteristica piuttosto diffusa. I discount invece
rappresentano una nuova formula distributiva il cui assortimento è costituito quasi
esclusivamente da prodotti alimentari non deperibili. Inoltre la disposizione interna è gestita
diversamente in quanto spesso non tutte le merci sono offerte dagli scaffali, ma vengono
lasciate negli stessi cartoni in cui si trovano in magazzino per evitare ulteriore impiego di
manodopera per la sistemazione. L’assortimento comprende prodotti perlopiù stranieri di
marche meno pubblicizzate e conosciute che permettono l’abbattimento ulteriore del prezzo
finale (Eminente 1983, pp. 86 - 89). Il discount differisce dalle altre tipologie descritte non
solamente per le dimensioni al contrario di supermercati, ipermercati e superettes, ma rientra
in una tipologia sui generis. Una differenza che, tra supermercati e superettes, è andata
sviluppandosi nel corso degli anni è la questione dell’ubicazione e del parcheggio.
Inizialmente, la gestione americana della novissima “Supermarkets Italiani S.p.A.” (che
diventerà poi l’attuale Esselunga in quanto la parte superiore dell’iniziale della scritta
Supermarket era lunga quanto l’intera parola) non aveva valutato il parcheggio come
componente fondamentale poiché alla fine degli anni Cinquanta gli italiani non erano ancora
in possesso di autovetture per recarsi a fare compere. I primi supermercati si trovavano
perlopiù in zone centralissime della città. In seguito, invece, all’interno del centro cittadino
vennero aperte principalmente superettes, mentre supermercati si spostarono verso la
periferia per poter permettere una maggiore facilità di parcheggio una volta che l’automobile
divenne un mezzo di trasporto presente nella maggior parte delle famiglie di ceto medio.
Oggigiorno le auto sono diventate un bene durevole indispensabile, soprattutto durante gli
acquisti al supermercato in quanto la spesa non viene più effettuata tutti i giorni, ma
principalmente una o due volte la settimana come risulta dalle mie interviste. Inoltre solo il
capiente bagagliaio della vettura potrebbe consentire un comodo trasporto della merce fino
alla propria abitazione. La spesa in automobile si spiega anche con il deciso aumento della
quantità di acquisti effettuati dagli anni Cinquanta ad oggi. Molto spesso infatti mi è stato
26
detto che tutta la merce acquistata a volte non la si fa in tempo a consumare e viene gettata.
Solo una persona anziana mi ha fatto notare che lui e sua moglie comprano poco perché non
amano avere il frigorifero ingombro di cose che si fa in tempo a consumare. I carrelli, il più
delle volte, sono abbastanza colmi di cose che a mano sarebbe impossibile trasportare, o
addirittura, se la famiglia è numerosa, questi possono essere anche un paio. Negli anni
Sessanta i carrelli per la spesa invece, di dimensioni ridotte rispetto a quelli statunitensi, non
venivano mai riempiti completamente, e per evitare l’immagine di penuria del carrello vuoto,
vennero introdotti i piccoli cestelli da portare a mano. Questa è stata una delle risposte
vincenti della gestione congiunta italo-americana che ha saputo coniugare il modello
statunitense alle esigenze nazionali. Le piccole spese negli empori tradizionali venivano
effettuate quasi ogni giorno e il passaggio dall’acquisto di poche cose ad una spesa
decisamente maggiore in termini di volume sarebbe stato difficile da proporre. Molte
pubblicità del periodo hanno cercato dunque di promuovere il supermercato come luogo
perfetto per effettuare anche i piccoli acquisti quotidiani e non soltanto ingenti e sporadici.
Questa politica di vendita risultò estremamente efficace, infatti, l’aumento del fatturato del
1959 presso il punto vendita di viale Regina Giovanna a Milano, la cui apertura risale al 1957
non era imputabile alla media di ogni spesa (che in realtà era diminuita subito dopo
l’entusiasmo iniziale), ma dal maggior numero di scontrini effettuati anche se per somme
inferiori (Scarpellini 2007 p. 52).
Secondo Emanuela Scarpellini, storica occupatasi delle grandi trasformazioni che hanno
coinvolto l’Italia del Novecento, la concessione delle licenze ha creato numerosi squilibri
all’interno del panorama nazionale. «Le difficoltà connesse all’ottenimento delle licenze
furono quindi alla base di uno sviluppo del tutto peculiare. Mentre le grandi società
riuscirono in genere a conseguire l’obiettivo prefissato, le piccole ditte o i negozianti che
intendevano trasformare in self service i propri negozi trovarono spesso delle difficoltà
insormontabili. Il risultato fu che allo sviluppo dei grandi supermercati non corrispose affatto
una uguale crescita nel segmento inferiore dei minimarket» (Scarpellini 2001, p. 178).
Questa situazione creò una frattura che pose a capo del settore le aziende più grandi. La legge
italiana difatti prevedeva la classificazione nella categoria dei supermercati per qualsiasi
negozio alimentare che prevedesse la vendita a libero servizio al contrario della normativa
internazionale che prevedeva anche il discrimine della metratura. Questo impedì la
trasformazione di piccoli empori in minimarket o superettes che avrebbero potuto soddisfare
buona parte della clientela delle zone limitrofe alle grandi città. Dunque le grandi società
commerciali con un elevato capitale a disposizione, legislatori attenti alle loro esigenze, e
27
finanziatori simpatetici, puntarono all’apertura di grandi supermercati. I privati, invece,
disponendo di un minore capitale iniziale spesso non riuscirono a far fronte alle perdite
dovute alla difficoltà di ottenimento della licenza e alle proteste dei commercianti
tradizionali. Un esempio emblematico è quello della «Supermercati Lombardi», una società
per azioni costituitasi a Milano nel 1959, che aveva l’intenzione di aprire una superette nel
legnanese, ma fu posta in liquidazione e chiusa definitivamente nel 1973 dopo quasi 14 anni
di attese infruttuose. Questo favorì la diffusione sul territorio di grandi catene di distribuzione
rispetto alla piccola iniziativa privata, che dalla metà degli anni Sessanta conobbe una
maggiore espansione, ma che non riuscì più a ricucire il gap creatosi (Scarpellini 2001, pp.
176 - 179). Le grandi imprese infatti si trovavano nelle condizioni più fertili per stabilire un
legame diretto con i rappresentanti delle istituzioni. Mentre i piccoli negozi forti del loro
associazionismo sindacale agirono a discapito delle piccole e medie imprese andando a creare
un dualismo tipico del settore industriale (Scarpellini 2001, pp. 240 - 241).
5. Perché recarsi al supermercato: ragioni economico-sociali
I prezzi furono un notevole punto di forza della grande distribuzione soprattutto quando
furono pubblicizzati su scala nazionale attraverso una pagina del Corriere della Sera che
confrontava quelli del Supermarket con quelli rilevati dall’ufficio statistico del comune di
Milano. La pubblicità fece molto scalpore all’interno del paese anche perché la diffusione dei
supermercati era ancora ridotta e non tutti ne avevano sotto gli occhi la differenza. I prezzi
erano mediamente inferiori del 15-25% rispetto a quelli concorrenti del settore. Questo poté
avvenire grazie ad una politica d’importazione diretta e di confezionamento esclusivo di una
serie di prodotti sotto il particolare marchio del supermercato che aggiunse un risparmio dal
10 al 50%.
Il prezzo ribassato non fu l’unica attrattiva: la forte curiosità, sia all’interno che all’esterno,
segnò un nuovo modo di rapportarsi ai consumi non più visti solamente come prima
necessità, ma come ludica componente del paesaggio urbano moderno (Scarpellini 2001, p.
157). Fu questo il motivo principale che inizialmente provocò delle vendite altissime
all’apertura di ogni nuovo centro. Inoltre il supermercato sembrava sconvolgere le radicate
abitudini sociali che vedevano occuparsi principalmente le donne dell’approvvigionamento
alimentare. Se infatti avevano da sempre ricoperto il ruolo principale nella cucina domestica,
dagli anni Cinquanta le donne cominciarono ad uscire dal proprio appartamento per recarsi al
28
lavoro, in particolar modo come impiegate. Questo presuppone una minore quantità di tempo
da dedicare alle cosiddette tipiche attività femminili, grazie anche alle ridotte dimensioni
degli appartamenti in cui viveva ormai soltanto una famiglia nucleare, e ingombri di
elettrodomestici che sopperivano ad alcune lente operazioni da compiere manualmente.
«Andare al supermercato a molti non sembra lo stesso che sobbarcarsi la routine quotidiana
della spesa: solletica la curiosità, fa scoprire prodotti sconosciuti, esotici, nuovi
“tecnicamente” (surgelati, sotto vuoto ecc.)» (Scarpellini 2008, p. 230). È anche per la
curiosità verso un luogo nuovo, confortevole ed innovativo che gli uomini cominciarono ad
accostarsi all’approvvigionamento alimentare.
Secondo i calcoli della Supermarkets Italiani, sui 70.000 clienti che ogni settimana vi si
recavano a fare la spesa il 35% (Scarpellini 2001, pp. 118-119) era composto da uomini soli,
o accompagnati dal resto della famiglia. Anche gli uomini anziani solitari non mancano, e
spesso vengono mandati la mattina, dalla moglie che non guida, ad effettuare i pochi acquisti
quotidiani. Capita infatti che il largo utilizzo dell’automobile e l’allargamento dei cosiddetti
quartieri residenziali limitrofi alle grandi città abbia portato all’isolamento di chi non
possiede i mezzi meccanici per recarsi a fare la spesa, non potendo più disporre di piccoli
negozi più vicini. Gli uomini però non erano l’unica nuova categoria di persone che iniziò a
rivolgersi con interesse al supermercato. Si potevano trovare anche anziani che amavano
spezzare la loro routine, giovani sempre aperti alle innovazioni e numerosi immigrati. Questi
ultimi vi trovavano quel tipo di integrazione che li rendeva parte di una metropoli moderna e
al di fuori dei pregiudizi di quartiere. Ogni classe sociale dunque trovava una giustificazione
più che legittima per frequentare i nuovi e futuristici luoghi di consumo. La zona in cui
s’innescò questo tipo di trasformazione fu quella di Milano e provincia, grazie alla densa
concentrazione urbana e all’elevato reddito medio. Alla fine degli anni Sessanta, i vecchi
quartieri della città restavano costellati di piccoli esercizi artigianali che offrivano una vasta
gamma di prodotti diversificati, i quali avrebbero dovuto affrontare una ricollocazione
all’interno del sistema commerciale non necessaria in altri paesi europei (Scarpellini 2001,
pp. 283 - 284). In questo periodo infatti «il commercio si sottrasse a quel ruolo passivo di
semplice intermediario tra produttori e consumatori assolto per molto tempo, per presentarsi
come un elemento dinamico in grado di condizionare il mercato» (Scarpellini 2001, p. 111,
cfr. Spranzi 1990). Infatti, la maggior parte delle imprese produttrici di beni di consumo era
costretta ad appoggiarsi all’intermediazione commerciale soprattutto per prodotti a basso
valore unitario. I supermercati invece poterono rappresentare un’alternativa riguardante la
quantità di prodotti ritirati per la vendita.
29
Il problema del parcheggio mi è stato fatto presente da un ragazzo il quale decide di
accordare la sua preferenza ad un supermercato piuttosto che ad un altro grazie alla facilità e
comodità di parcheggio. Questo luogo è spesso sottovalutato, ma un buon parcheggio che
permette una maggiore facilità di accesso, soprattutto durante l’inverno o in caso di pioggia,
potrebbe condizionare anche implicitamente molte più persone di quante si creda. Questo
aspetto è stato messo alla luce anche da Underhill ( 2004, pp. 26- 33) durante la sua ricerca
riguardante i centri commerciali americani. Il parcheggio fornisce la prima indicazione sul
(non)luogo che andremo a visitare, ossia la quantità di gente che ha avuto la stessa nostra idea
nello stesso momento. «I centri commerciali considerano i parcheggi come un male
necessario. Vorrei invece che le imprese di costruzione riflettessero sull’uso creativo che
spesso facciamo di questa distesa d’asfalto» (Underhill 2004, p. 30). Questo parcheggio,
tanto necessario quanto poco valorizzato, risulta dunque anonimo e sede poco invitante di
incontri soltanto fugaci. Nonluogo per eccellenza, questo spazio anonimo diviene
l’anticamera obbligata al nostro supermercato.
Secondo la Scarpellini (2007), in un testo in cui ricostruisce la storia dei supermercati
Esselunga, rivela che una questione fondamentale per l’affermazione della società a livello
nazionale è dovuta all’innalzamento della qualità degli alimenti prodotti per conto del
supermercato. Questo aspetto però verrà invece contraddetto dall’indagine di mercato svolta
nel 1974 per conto della Generale Supermercati (GS) (Eminente 1983 pp. 133 ss), che
annovera la scarsa qualità dei prodotti tra le ragioni principali per evitare di recarsi al
supermercato. L'auto celebrazione dei supermercati attiva il riferimento alla qualità dei
prodotti come strategia di marketing. In un’indagine del 1974 svolta per conto della Generale
Supermercati si è cercato di individuare le caratteristiche e le esigenze del consumatore
medio.
Queste sono:
• Attenzione verso quello che si spende • Desiderio di trovare ampia scelta • Autonomia nella scelta • Rassicurazione offerta dai prodotti di marca • Gratificazione nell’essere riconosciuti sul punto di vendita
È importante notare che in quel periodo il passaggio dal negozio tradizionale al supermercato
era ancora in fieri in quanto il 33,6% degli intervistati aveva dichiarato di recarsi soltanto nei
piccoli negozi; il 7,5% dichiarò di servirsi solo dei supermercati; mentre il restante 58,9%
30
preferiva usarli entrambi (Eminente 1983 p.132). Gli aspetti positivi riconosciuti dai clienti
dei supermercati invece sono innanzitutto la comodità di poter acquistare tutto in un solo
posto, la possibilità di scelta, lo stimolo alle idee dato dalla disposizione dei prodotti e
l’informazione sicura sui prezzi.
Le ragioni più citate per preferire il supermercato sono in ordine d’importanza:
• Convenienza • Assortimento • Possibilità di scelta • Risparmio di tempo • Comodità di esposizione • Prezzi fissi e chiari • Vicinanza
Quelle per decidere di evitarlo sono invece:
• Lontananza • Coda alle casse • Si compra più del necessario • Mancanza di consegna a domicilio • Perdita di tempo • Cattiva qualità dei prodotti • Mancanza di fiducia
Nella ricerca che ho condotto invece sembra che la scelta del supermercato sia più dettata
dalla necessità e dalla mancanza di alternative, anche se oggigiorno la qualità dei prodotti
proposti dai supermercati a Varese viene percepita come abbastanza buona in una scala di
quattro possibilità (molto – abbastanza – poco – per niente).
31
Nonostante ciò, gli intervistati hanno dichiarato di procurarsi generi alimentari non solamente
al supermercato, anche se, in genere, vi si affidano quasi completamente in termini di
quantità.
Il supermercato si afferma come scelta e si impone, ai giorni d'oggi, come necessità, avendo
surclassato le altre modalità di commercializzazione alimentare. La tendenza si nota
soprattutto nei giovani i quali hanno conosciuto principalmente questo modello di
distribuzione. Spesso purtroppo non avrebbero idea di dove poter trovare tutti i generi di
“prima necessità” presenti nei supermercati a cui sono abituati e che vivono come necessari.
Solo pochi adulti si azzardano a qualche critica come quella per cui “hai lo sconto da una
parte e ti alzano il prezzo del resto per cui ti sembra di risparmiare, ma spendi sempre
uguale”, oppure che “la maggior parte di quello che compri non ti serve”, confermando
motivazioni già presenti tre decenni or sono
La seguente tabella riguarda invece tutte le motivazioni che mi sono state fornite alla
domanda aperta “perché sceglie di recarsi al supermercato?” Alcune sono di semplice
comprensione, mentre altre lo sono meno. Andrò di seguito ad analizzarle in dettaglio.
GIOVANI M
GIOVANI F
ADULTI M
ADULTI F
ANZIANI M
ANZIANI F
TOT
NON HO TEMPO 5
2 3 2 1 13
RISPARMIO 3 3 2 4 1
13
ALIMENTI DI DIFFICILE TRASFORMAZIONE 2
1 1 1 1 6
32
COMPRO COSE GIÀ PRONTE 1
1
PIÙ COMODO 1
1 4 2
8 MANCANZA DI ALTERNATIVA 1 1 1 1 2 2 8 PARCHEGGIO 1
1
SCELTA 1
1 1 3 VOGLIA 2
1
3
VICINANZA
1 1 1
1 4 DETERSIVI
1
1
2
"C'È TUTTO"
1
1 4 2 8 PIÙ IGIENE
1
1
NON HO PASSIONE PER LA CUCINA
1
1 SONO INTOLLERANTE
1
1
PASSARE IL TEMPO
1 1 SONO VECCHIA
3 3
PER RUBARE 1
“NON HO TEMPO” (17%) sta ad indicare la mancanza di tempo da dedicare alla spesa
rispetto ai propri impegni giornalieri. La risposta parte dall'assioma che altre forme di
acquisto sarebbero più dispendiose temporalmente: si fa più veloce al supermercato rispetto
ad un acquisto al dettaglio di prodotti. Insieme alla mancanza di tempo, il RISPARMIO
(17%) risulta la ragione principalmente addotta per la preferenza accordata al supermercato.
Gli ALIMENTI DI DIFFICILE TRASFORMAZIONE (8%) sono quelli come ad esempio il
panettone oppure l’affettato che non si possono preparare a casa al contrario di conserve e
marmellate e vengono acquistati già pronti e confezionati. La risposta presuppone che ci sia
la competenza e la predisposizione di attivarsi nella preparazione alimentare di altri prodotti.
Chi ha detto: “NON HO PASSIONE PER LA CUCINA” (1%) ha invece fornito una risposta
similare a chi ha confidato “COMPRO COSE GIÀ PRONTE” (1%), oppure “SONO
INTOLLERANTE” (1%), per cui il supermercato risponde alle esigenze di trovare prodotti
molto specifici oppure già preparati e pronti per essere consumati.
Il fatto che sia PIÙ COMODO (10%) invece lascia ampio spazio di discussione in quanto
questo può esserlo perché offre più servizi come un ampio PARCHEGGIO (1%), i
DETERSIVI (3%), una SCELTA (4%) più ampia di prodotti: "C'È TUTTO" (10%) quello
che serve!
Infine emergono dichiarazioni che indicano un’insoddisfazione che allontanerebbe dal
supermarket se non ci fossero delle difficoltà nel trovare alternative per ragioni strutturali di
offerta, e soggettive di preferenze del singolo acquirente. La VOGLIA (4%) di recarsi a fare
33
compere al di fuori dei supermercati, a volte manca poiché non si è più abituati ad acquisti
sparsi e sporadici come quelli effettuati nei primi supermercati, bensì all’unica e abbondante
spesa settimanale contenuta tutta in un carrello (o due). Il piccolo negozio viene percepito
come scomodo, non abituale, e la MANCANZA DI ALTERNATIVE (10%) è riferita
appunto alla mancanza di voglia e di tempo per cercarle. Essendo meno pubblicizzate, visibili
o conosciute, non vengono prese in considerazione, innescando una sorta di circolo vizioso
che porta ad un sempre maggiore grado di fidelizzazione verso la grande distribuzione,
nonostante le richieste della popolazione pare si stiano spostando verso altre direzioni.
La VICINANZA (5%) alla propria abitazione è comunque sempre una buona motivazione
per recarsi a fare la spesa al supermercato. L’IGIENE (1%) del locale e degli scaffali per
alcuni è una componente fondamentale. Legati alle persone più anziane sono invece
motivazioni quali PASSARE IL TEMPO (1%) in un luogo accogliente e riscaldato, pieno di
colori e di persone, oppure, dietro la risposta “SONO VECCHIA” (4%), data soltanto da
alcune donne anziane, si manifesta la mancanza di forze per recarsi in giro per la città a fare
acquisti, coltivare l’orto e tenere le galline, come si faceva in gioventù. È da notare che anche
la risposta già menzionata "C'È TUTTO" è stata piuttosto usuale tra le persone anziane.
Questa peculiarità potrebbe ricordare l’influenza dello slogan vincente: “alla Standa c’è
tutto” dei supermercati Standa, i quali erano nati come grandi magazzini e negli anni Sessanta
vi hanno affiancato il reparto alimentare. Infine un ragazzo mi ha confidato di recarsi al
supermercato perché è molto semplice rubare alcuni generi alimentari di cui non dispone a
causa della mancanza di liquidità dovuta alla scelta di vita compiuta. Egli vive in una casa
occupata insieme ad altri giovani, senza lussi, ma senza neanche l’angoscia di essere
accettato da una società a cui si sente di non appartenere.
6. Conclusioni
Le principali differenze tra gli aspetti positivi riscontrati nelle due ricerche, quella del 1974 e
quella da me condotta, sono l’assortimento, la comodità di esposizione e la maggiore libertà
di scelta. Queste caratteristiche sono state dunque particolarmente apprezzate negli anni
Settanta, ma ora non sono più state prese in considerazione in quanto risultano ormai
qualcosa di necessario e dato per scontato. Anche i prezzi fissi e chiari sono una differenza
rispetto alla bottega tradizionale, ma entrati ormai nell’orizzonte collettivo, e quindi non più
menzionati come dei vantaggi. Inoltre, la gratificazione nell’essere riconosciuti sul punto di
34
vendita non è mai stata menzionata nella mia ricerca perché in un grande supermercato risulta
una cosa pressoché impossibile e non assume dunque valenza positiva, sostituita
dell’anonimato e dalle solitudini descritta da Augé (1992). Sono invece la convenienza e il
risparmio di tempo ad essere ancora le ragioni principali che vedono la grande distribuzione
come la scelta preferita in una società che non aspetta chi si reca a piedi alla bottega del
quartiere. Le ragioni dell’affermazione della grande distribuzione alimentare sulla piccola
bottega restano comunque molteplici, ma la ricerca di un’alternativa, quale era il
supermercato negli anni Sessanta rispetto al negozio tradizionale, sta cominciando ad
emergere in maniera sempre più netta.
35
CAPITOLO SECONDO
LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI: UN NUOVO RAPPORTO
«È evidente che l’esigenza di nutrirsi sia un fattore vitale, ma, oltre a ciò, l’antropologia
considera l’alimentazione come un fatto sociale e culturale totale, che unifica le procedure di
selezione, acquisizione, conservazione e preparazione degli alimenti, i saperi – inclusa la
dietetica –, le condotte, le rappresentazioni, i miti ecc.» (Hubert 2006 p. 50).
Risulta dunque chiaro come società ed alimentazione siano strettamente correlate e si
influenzino reciprocamente. L’alimentazione è sempre stata legata alla disponibilità sul
territorio delle risorse alimentari, agricole ed animali, dipendenti da fattori climatici ed
ambientali. Nonostante un determinato cibo possa esser presente sul territorio non significa
necessariamente che esso entri di diritto a far parte della categoria degli alimenti presenti
sulla tavola, come si può notare dalla storia della patata che venne usata come fonte di
alimentazione animale per i primi due secoli dal suo arrivo in Europa. L’introduzione di
nuovi alimenti infatti (tendenzialmente agricoli, quali ad esempio il mais o il pomodoro dalle
Americhe) ebbero un decorso particolarmente lungo. La cosiddetta dieta mediterranea,
famosa ed esportata in tutto il mondo è il frutto di un lento processo di integrazione e
sedimentazione di nuovi alimenti combinati tra loro anche grazie al mercato globale che
elimina una serie di regionalismi inserendo un regime dietetico più vario (Guigoni 2009).
Non tutto ciò che è commestibile però viene considerato un alimento. Infatti la distinzione tra
ciò che è commestibile e ciò che non lo è si riferisce ad una classificazione di origine
biologico-naturale, mentre a livello sociale possiamo parlare più propriamente di cibi
permessi e cibi proibiti. Mary Douglas (1970) distingue due categorie, il puro e l’impuro,
analizzando una serie di tabù alimentari presenti nel Levitico. La cucina kasher ebraica e la
cucina halal musulmana infatti si regolano su una serie di interdizioni non comprendenti
36
affatto ragioni nutrizionali. Le ragioni ecologiche di Marvin Harris (1985) spesso però non
sono sufficienti a giustificare qualunque tipo di interdizione. Oltre ai tabù religiosi però ve ne
sono altri di carattere sociale, come la scarsa preferenza accordata dal popolo americano nei
confronti della carne di cavallo oppure in Algeria per quella d’asino che invece sono molto
apprezzate in Europa. Queste potranno però cadere in periodi alcuni periodi d’eccezione
come guerre oppure carestie. Un esempio è lo stesso uso divenuto abbastanza comune di
nutrirsi di gatti randagi nell’Italia del nord durante la guerra, che è andato poi scomparendo
con essa. Dunque, da una disponibilità di piante ed animali presenti sul territorio si avrà una
prima selezione tra ciò che non è ritenuto commestibile, e ciò che invece lo è, e da questa
seconda categoria si sceglierà poi cosa sarà permesso o non permesso mangiare.
I periodi di crisi, i cambiamenti sociali dei modi di produzione, nonché l’introduzione di
nuovi alimenti porteranno dunque a cambiamenti alimentari più o meno temporanei. Oggi,
l’incremento delle nuove tecnologie, legate al modello capitalistico di produzione ha portato
un cambiamento delle abitudini alimentari Occidentali da un secolo e mezzo a questa parte. Il
capitalismo dunque risulta essere un sistema di produzione nato dal processo di
industrializzazione che ha ridefinito i rapporti tra gli uomini, influenzandone i valori, gli stili
di vita e dunque anche l’alimentazione, con una velocità impressionante.
Come sistema basato sulla generalizzazione della produzione e dello scambio delle merci ha
sicuramente avuto la capacità di incidere a fondo sull’esistenza di un numero sempre
crescente di persone, resa possibile grazie allo sviluppo delle conoscenze scientifiche unite
alla loro applicazione. La meccanizzazione sempre più spinta in campo agricolo iniziata nella
seconda metà dell’Ottocento negli Stati Uniti ha incrementato in maniera esponenziale la
produzione di derrate alimentari riducendo sensibilmente il numero degli addetti. La
campagna dunque si trasformerà in una risorsa da sfruttare di fianco al numero sempre più
elevato di popolazione che deciderà di trasferirsi verso la città, addensando così il numero di
“bocche da sfamare” in uno spazio sempre più ristretto e senza che queste si occupino della
produzione alimentare a loro necessaria. Se la casa contadina similare all’oikos greco può
dividersi in una zona abitativa interna ed un terreno esterno coltivabile per soddisfare il
fabbisogno alimentare dei suoi abitanti, con la rivoluzione industriale e conseguente esodo
dalle campagne ormai non più fonte di reddito. La zona abitativa si è ampliata andando a
comprendere tutta la città con i suoi quartieri residenziali e relegando a fonte di cibo la
campagna circostante, per molti non più sede abitativa a causa dell’inutilità del lavoro
manuale ora meccanizzato. Sono infatti le necessità alimentari espresse da masse crescenti di
lavoratori non addetti alla produzione agricola che impongono l’uso di rivoluzionarie
37
tecniche di produzione alimentare. Il problema nasce soprattutto dalla necessita della
distribuzione di derrate alimentari che coinvolge territori molto distanti da quelli di
produzione. Occorrerà dunque un rapido e capillare sistema di consegne unito a idonee
strutture di immagazzinamento in grado di assicurare scorte per tempi molto lunghi in modo
da scongiurare qualsiasi rischio di penuria alimentare, temuto in passato, e quasi
inconcepibile oggi. Attualmente il pericolo sarebbe pernicioso perché comporterebbe il
rallentamento o il blocco della produzione industriale che, sia per convenienza economica
che per principio, non dovrebbe in nessun caso interrompersi.
Il contributo fondamentale per sopperire alle esigenze di conservazione e trasporto è dato
dalla moderna scienza alimentare supportata dalle nuove tecnologie in grado di superare i
lunghi e passati metodi di essicazione e salatura, come sostenuto da Serino.
«L’inscatolamento prima e la congelazione poi rappresenteranno una autentica rivoluzione
tecnologica che contribuirà all’ulteriore crescita del già avviato processo di
industrializzazione» (Serino 2003 p. 126).
Oltre ai metodi di distribuzione, come il supermercato sovrabbondante di merceologie, e a
quelli di conservazione, i cambiamenti più sostanziali sulle tavole occidentali si avranno con
la considerevole introduzione di carni rosse importare dai vasti territori americani non
coltivati e destinati all’allevamento (ranching) e con l’introduzione di alimenti artificiali.
Questi alimenti, non presenti in natura e producibili soltanto attraverso l’uso di sofisticate
tecnologie, realizzabili in serie, vengono progettati all’interno di laboratori allo scopo di
soddisfare le esigenze del palato a costi contenuti. Un esempio di questo processo che ha
portato all’introduzione di una nuova sostanza alimentare è stata l’invenzione della margarina
che risale al 1870 per opera del francese Hyppolyte Mege-Mouries. Egli combinò sugna
animale con latte e mammella di mucca tritata creando così una sorta di burro dei poveri (che
inizialmente non ebbe affatto il successo sperato) (Serino 2003 p. 127). La creazione di nuovi
alimenti, per così dire a tavolino però necessita anche di una potente strategia di campagna
pubblicitaria per divulgare il nuovo prodotto il cui esempio sembra ben accostarsi al caso
della Coca Cola nata ad Atlanta nel 1886.
Ma la società del tempo perduto che si distingue da ogni altra manifestazione precedente per
la sovrabbondanza di alimenti prodotti in serie, come si rapporta con i nuovi prodotti già
lavorati? E qual è il rapporto tra questi e la mancanza di tempo disponibile per
l’alimentazione? Per rispondere a questa domanda sono andata ad analizzare il grado di
lavorazione degli alimenti preferito attraverso alcune domande riguardanti prodotti d’uso
38
quotidiano come sughi, pesce e dolci, per stabilire quanto la tecnologia9 sia presente sulle
nostre tavole. Insieme a questo ho preso in considerazione il consumo di prodotti surgelati, i
quali sono concepibili solo grazie alla nuova tecnica di surgelazione. «Le maggiori resistenze
vennero dal preconfezionamento di alcuni prodotti usualmente preparati al momento (il caso
tipico era la carne) o dalla novità già ricordata dei surgelati. Proprio questi ultimi sollevavano
la maggiore riprovazione da parte di quanti temevano la perdita non solo di certi cibi e di
antiche abitudini, ma vi scorgevano quasi il segno di un mondo nuovo» (Scarpellini 2001, p.
117).
1. Grado prediletto di lavorazione degli alimenti I cibi inscatolati e conservati in barattoli invece hanno avuto la loro origine nella prima metà
dell'Ottocento, e una più ampia diffusione nella seconda metà del secolo. Nel 1795 il
Direttorio della Prima Repubblica Francese, preoccupandosi del numero di vittime che lo
scorbuto mieteva fra gli equipaggi imbarcati, promise un premio di 12.000 franchi a chi
avesse inventato un buon metodo di conservazione degli alimenti. Il premio andò a Nicolas
Appert (1750-1841), cuoco francese che nel 1810 pubblico un libro sui processi di
conservazione dei cibi e nel 1819 impiantò il suo primo stabilimento per la conservazione
degli alimenti. Il Processo inventato da Appert, di cui non diede alcuna spiegazione
scientifica, consisteva nella sterilizzazione degli alimenti per mezzo del calore. Gli agenti che
alterano i composti organici infatti venivano uccisi portando le temperature di cottura, previo
inscatolamento, a circa 70/80 °C. Gli alimenti venivano poi riposti in recipienti ermetici e
sterilizzati, che non rimanessero a contatto con l'aria neutralizzando così l'azione di
microrganismi sia interni che esterni. Appert, per quanto riguarda i recipienti usò dei vasi di
vetro chiusi con tappi di sughero sterilizzati in acqua bollente. Questo sistema riuscì a
soddisfare tre obiettivi: evitare la decomposizione dei cibi, mantenere le caratteristiche il più
possibile invariate e offrire numerosi vantaggi di trasporto. La produzione di conserve
alimentari prese avvio in Inghilterra qualche anno più tardi. I vasi di vetro vennero però
sostituiti da scatolette di latta, più resistenti e facilmente manipolabili brevettate nel 1810 da
9 «La tecnologia è lo studio delle attività impiegate dall'uomo per acquisire e trasformare gli elementi organici e inorganici del mondo naturale. Queste attività comprendono sia i saperi e le tecniche, sia i gesti e gli attrezzi e si dispongono in rapporti che sono contemporaneamente tecnici e sociali» (Dizionario di antropologia e etnologia 2006, p. 766, voce Tecnologia). In questo caso specifico, come tecnologia intendo il grado di manipolazione che un alimento subisce prima di essere commercializzato in quanto la produzione massificata di grandi quantità di prodotti prevede una lavorazione standardizzata che avviene tramite l'utilizzo di nuovi saperi congiunti ad una manipolazione meccanizzata non individuale.
39
Peter Durand. Verso il 1820 l'industria della conservazione prese piede anche in USA
principalmente per quanto riguardava il pesce. La prima industria di carne in scatola sorse
invece solo nel 1868 a Chicago, ma nella seconda metà dell'Ottocento un'ondata di scatolame
cominciò ad invadere il mondo (Caporali - Lauro 2001). Un interrogativo legittimo
all’interno del panorama del supermercato ricco di cibi preconfezionati, già cotti e pronti per
essere mangiati riguarda il grado di lavorazione degli alimenti che vengono utilizzati per
l’alimentazione quotidiana. I prodotti che si trovano sugli scaffali dei supermercati possono
essere offerti al consumatore sotto forma di cibi non lavorati, semilavorati e lavorati.
Notevole è il cambiamento di forma che il prodotto subisce partendo dal primo stadio in cui
pesce, pomodori e uova o farina hanno ancora forma e caratteristiche originarie, mentre
nell’ultimo stadio, in particolar modo per quanto riguarda tonno in scatola o merendine, essi
avranno assunto la forma cilindrica o rettangolare. Nel secondo stadio la materia prima viene
in parte lavorata prima di essere presentata sugli scaffali, ma necessita di una lavorazione
casalinga ulteriore affinché possa essere consumata. Il terzo stadio invece si riferisce a
prodotti che, per essere consumati necessitano al massimo di una “scaldata” che spesso viene
suggerita tramite appositi disegni ed immagini sul retro della confezione; il forno a
microonde è l'espressione più compiuta per quanto riguarda il risparmio di tempo. Così si
permette anche a chi non è in grado di cucinare di deliziarsi con “gustosi manicaretti proprio
come quelli cucinati in casa con ingredienti genuini”. In questo stadio, gli alimenti non
possiedono più le caratteristiche delle materie prime, ma semplicemente quelle della
confezione in cui sono contenuti.
40
Questo schema si riferisce al totale degli intervistati che in genere dichiara di prediligere il
prodotto fresco, ossia non lavorato, che nella maggior parte dei casi viene comunque
acquistato al supermercato. La voce “altro” è stata inserita in quanto alcuni, soprattutto
anziani, confidavano di essere diabetici o di soffrire di colesterolo alto per cui i dolci non
concordano con la loro dieta. Alcune volte invece il pesce non viene valutato in quanto “non
piace” e dunque non viene consumato, mentre in due casi, tra i giovani, esso non ha
riscontrato particolare successo in quanto vegetariani. Solo una signora anziana ha detto che
cucina il pesce di lago che solitamente pesca il marito. Si può quindi notare che il totale delle
dichiarazioni di consumo sono a favore dei prodotti freschi ancora da cucinare e che hanno
subito la minore manipolazione possibile prima di essere immessi sul mercato. Prendendo in
considerazione le tre sezioni separatamente invece possiamo notare che, per quanto riguarda
il sugo, in realtà viene prediletta la passata che ormai ha soppiantato la raccolta o l’acquisto
dei pomodori per fare la salsa.
Il 35% degli intervistati però dichiara di preparare ancora la salsa in casa e la maggior parte
di queste persone ammette di avere un orto e di preferire i propri pomodori rispetto a quelli
acquistati per questo genere di operazione. I pomodori che crescono nel proprio orto, o in
quello di amici e parenti, vengono trasformati in salsa d’estate per poi essere usati durante
l’inverno fino ad esaurimento scorte. Per quanto riguarda il pesce invece, che deve essere
consumato fresco, le dichiarazioni sono lievemente differenti in quanto il prodotto acquistato
direttamente al banco o in pescheria è maggiore rispetto agli altri due.
41
Prima della diffusione dei frigoriferi infatti, afferma Pirovano (Mariani - Pirovano 2012, p.
105), il consumo del pesce avveniva solitamente nell'arco della giornata di pesca e soprattutto
sulle coste dove veniva pescato. Per ovviare a queste ingombranti limitazioni sono nati alcuni
metodi di lavorazione e preparazione che ne consentono una conservazione a lungo temine
come la salatura, l'essiccazione. Oggi invece con l'ausilio del frigorifero e soprattutto del
congelatore la “freschezza” del pesce è garantita anche per periodi molto lunghi per cui
questi metodi hanno spesso perduto la loro ragion d'essere e vanno via via diminuendo. In
aumento è invece la ricerca di filetti privi di lische e cucinabili rapidamente.
42
Per quanto riguarda i dolci si può notare che la metà degli intervistati dichiara di preferire la
preparazione di questi a partire dagli ingredienti, ricorrendo meno spesso al prodotto lavorato
finito come possono essere le merendine già confezionate. In questo caso però si può notare
come la percentuale di donne che acquista ingredienti per fare i dolci risulta quasi il doppio
rispetto a quella degli uomini, per cui la componente di genere in ambito culinario domestico
gioca ancora un ruolo fondamentale.
Questo lo si può notare anche dal fatto che alcuni anziani hanno riferito tendenzialmente ciò
che la moglie era solita cucinare ammettendo di non entrare in cucina che per mangiare.
Oppure il caso di un paio di uomini rimasti vedovi che ora acquistano solo prodotti già pronti
in quanto non si sono mai interessati alla cucina, nonostante ricordino con piacere i piatti a
cui erano abituati.
43
Affrontando il discorso più in generale tra le tre fasce di età si può notare che la differenza
sostanziale tra prodotti lavorati o meno è molto marcata tra le due fasce estreme, ossia
giovani ed anziani, in cui i primi prediligono i prodotti semi lavorati, mentre i secondi
preferiscono le materie prime. Questo può essere indice di una incapacità di svolgere certe
operazioni oppure della volontà di non dedicarvi il tempo necessario.
44
Si può quindi notare che tendenzialmente il totale delle dichiarazioni di consumo restano a
favore dei prodotti ancora da cucinare interamente per quanto riguarda gli anziani, mentre ci
si riferisce ai prodotti semi lavorati per i giovani i quali raramente mi hanno parlato di ricette
o pietanze particolari a differenza delle altre due face di età. Solo un ragazzo mi ha spiegato
che in estate egli prepara la salsa insieme ai suoi amici, considerandolo un momento ludico e
che gli permette di “mangiare naturale” rispetto ai prodotti confezionati. L’alto tasso di
prodotti confezionati, lavorati e semilavorati ha dunque inciso sulle abitudini alimentari
soprattutto dei giovani, i quali non hanno vissuto l'ultimo stadio del cambiamento in ambito
alimentare, convivendo quasi esclusivamente con questo specifico modello distributivo. Il
fatto che comunque non vi siano particolari differenze a livello di preferenza tra le tre
categorie di prodotti per quanto riguarda i giovani indica che la differenza viene percepita
diversamente. Più semplicemente viene operata una scelta che dipende dall’alimento e dal
suo utilizzo a seconda delle circostanze. Questo perché più volte mi è stato fatto notare come
la risposta si riferisse al prodotto maggiormente scelto, ma che anche le altre due tipologie
venivano comunque utilizzate. Adulti ed anziani prediligono invece il prodotto non lavorato e
con una spiccata maggioranza tra le persone che hanno più di sessant’anni di età per le quali
il legame con ciò che mangiavano da giovani è ancora forte: l'abitudine culinaria è un habitus
incorporato intimamente. Per quanto riguarda gli anziani questo avviene anche perché il
tempo a disposizione da dedicare alla cucina è maggiore, nonostante la vecchiaia impedisca
la preparazione di piatti che si era soliti preparare fino a pochi anni prima. Alcune signore
infatti hanno accordato la loro preferenza ad alcuni prodotti del supermercato come la passata
45
adducendo la singolare motivazione: “sono vecchia”.
La nuova scienza tecnologica che si sviluppa non soltanto per quanto riguarda le
biotecnologie, ma anche la preparazione meccanizzata di conserve e prodotti alimentari in
genere, lavorati e semi lavorati ha dunque assunto il ruolo di cuoca sostitutiva.
L’alimentazione non è più vista infatti come fonte di godimento e salute, ma come pericolo
per la propria salute in caso di sovrappeso ed obesità. La preparazione di piatti elaborati ed
abbondanti richiede una buona dose di tempo e oggi avviene principalmente in occasione di
ricorrenze particolari, ma non se ne sente più una necessità fisica grazie alla sovrabbondanza
quotidiana di cibo a cui siamo abituati. Inoltre quotidianamente non sono più necessari tempi
molto lunghi per la preparazione di alimenti.
Anche l’importanza del focolare acceso in casa o di una stufa a legna utile anche per il
riscaldamento altrimenti impossibile da sostenere è stato sostituito da una separazione dei due
apparati. L’impianto di riscaldamento e dalla tecnologia del fornello a fiamma, ma sempre
più spesso anche elettrico e sempre disponibile (a differenza del focolare che necessita di
cure costanti), oppure con forno e forno a microonde. Quest’ultimo in particolar modo ha
supportato la diffusione di cibi pronti e confezionati che se consumati freddi hanno un sapore
e una consistenza poco gradevoli. La cottura e la sua tecnologia ha dunque rivoluzionato il
rapporto coi cibi e il loro godimento. Il passaggio dal crudo al cotto è ora divenuto il
passaggio da ciò che viene cucinato a ciò che necessita soltanto di una rapida scaldata in
quanto l’industria tecnologica alimentare l’ha già cucinato per te!
2. I surgelati: nascita, lavorazione, consumo
I surgelati sono alimenti che subiscono un particolare tipo di trattamento per garantirne una
migliore e più duratura conservabilità senza che questi, una volta riportati a temperatura,
abbiano subito particolati modificazioni nutritive, fisiche ed estetiche. L’alimento viene
portato a temperature molto basse, intorno ai -40/-50°C, per un periodo di tempo che va dai
30 minuti ad un massimo di quattro ore. Successivamente questo verrà fatto risalire alla
temperatura costante di -18°C e mantenuto a tale valore fino al consumo. Mi è stato chiesto
più volte, come delucidazione, se per surgelati s’intendono solo quelli acquistati oppure se si
possono definire tali anche gli alimenti che vengono congelati autonomamente a casa propria,
come ad esempio la carne acquistata fresca, oppure i ravioli fatti in casa. In realtà il processo
di surgelazione è differente e molto più rapido del congelamento effettuato tra le mura
domestiche perché in questo secondo caso il raffreddamento avviene in tempi più lunghi
46
portando la temperatura dell’alimento sotto la soglia di congelamento (da -5 a -15°C). Inoltre
questo procedimento comporta la formazione di macro cristalli di ghiaccio derivanti
dall’acqua contenuta negli alimenti e che, distruggendo le pareti cellulari provocando una
perdita di vitamine e principi nutritivi in fase di scongelamento. Per quanto riguarda i
surgelati invece, i cristalli che si formano sono minutissimi: in questo modo la perdita dei
principi nutritivi è minima e anche le caratteristiche organolettiche dei cibi si mantengono in
modo migliore. È importante però sottolineare che il mantenimento della catena del freddo
che parte dai magazzini di stoccaggio, arrivando fino al luogo di rivendita, incluse tutte le fasi
di trasporto, se spezzata, porterebbe ad una massiccia proliferazione di microrganismi che
trovano nel liquido di scongelamento un ottimo carico di nutrienti utili alla loro crescita
(Villarini 2011, pp. 37-38). Il surgelamento, come metodo di conservazione è indicato per
semilavorati, piatti pronti, carni o pesci sfilettati o parzialmente lavorati, preparazioni a base
di verdura (Stella 2010).
Clarence Birdsey fu lo "scopritore" dei surgelati. Egli intuì che il sistema migliore per
conservare gli alimenti stava nella velocità di raffreddamento più che nel raggiungimento di
basse temperature. Il principio dei surgelati fu messo a punto in laboratorio ponendo alcune
fette di carne tra due piastre metalliche a temperature molto basse. La prima vendita al
dettaglio di surgelati fu effettuata nel 1930 a Springfield, nel Massachussetts. Questa metodo
di conservazione ha reso possibile lo spostamento di cibi a grandi distanze allungando ancora
di più i tempi di naturale deperimento. (Caporali – Lauro 2001 p. 74). La necessità dello
sviluppo di efficaci metodi di conservazione risulta necessario dalla sovrabbondanza di
prodotti alimentari immessa sul mercato. Inoltre dalla parte dei produttori, questi prodotti a
lunga conservazione regalano una maggiore stabilità economica rispetto alla variabile
incognita dei prodotti freschi e velocemente deperibili.
Contrariamente al Nord Europa e agli Stati Uniti, i surgelati in Italia risultavano del tutto
sconosciuti ancora negli anni Cinquanta. Questi cominceranno a diffondersi nei primi anni
Sessanta incontrando inizialmente forti pregiudizi. La gente apparve prevenuta definendo
questi prodotti un cibo non “naturale” o “tradizionale”. Questi alimenti appaiono come
l’antitesi assoluta del cibo “fresco e genuino” poiché fisicamente si presentano in uno stato
differente da quello originale. Ci vorrà dunque del tempo prima che la gente si abitui a queste
nuove forme alimentari e che cominci a dotarsi di frigoriferi, i quali passeranno da 370.000
nel 1959 a 1,5 milioni nel 1963 (Scarpellini 2001, p. 12). Per garantire una maggiore garanzia
igienico/sanitaria/qualitativa per il consumatore, va reso noto che i prodotti surgelati sono
47
regolati in Italia dal Decreto Legislativo n. 110 del 27 Gennaio 199210, il quale recepisce una
Direttiva Europea che ha validità in tutti i paesi dell'Unione. Tale Decreto Legislativo regola
minuziosamente la produzione, la distribuzione e la vendita degli alimenti surgelati.
Il consumo dei prodotti surgelati nel nostro paese è nettamente aumentato nell’arco degli
ultimi trent’anni, come dimostrano i dati forniti dall’Istituto Italiano Alimenti Surgelati
(I.I.A.S.).
11
La ricerca da me condotta è volta ad indagare se questo consumo avviene “spesso”, ossia più
di due volte a settimana, per mettere in luce il grado di manipolazione del cibo scelto per
l’alimentazione quotidiana poiché questi prodotti hanno subito il trattamento sopra descritto
prima di essere commercializzati. La verdura è il prodotto di punta dei surgelati, come ad
esempio i piselli che vengono ritenuti da un intervistato migliori di quelli nei barattoli (ma
peggiori di quelli secchi). Mentre in costante aumento sono quei piatti già pronti che
necessitano solo di essere scaldati e spesso traducono in vaschetta, i migliori piatti delle
tradizioni regionali. Secondo alcuni, il processo di refrigerazione altera la concezione di
freschezza del prodotto. La verdura è fresca solo se appena colta, e non se colta mesi prima e
poi surgelata. Un intervistato ad esempio, parlando di freschezza della verdura si lamenta del
10 DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 110. http://www.salute.gov.it/alimenti/resources/documenti/sicurezza/D_Lvo_27_gennaio_1992_%20n_110.pdf (Data di accesso 03/03/2013) 11 http://www.istitutosurgelati.it/images/consumi/retail%20+catering%202011.pdf (Data di accesso 03/03/2013)
48
fatto che quella surgelata, quando viene scongelata si presenta ancora bene, ma rimane
comunque vecchia: “come una signora anziana che si 'trucca' da diciottenne. Sono truccate
uguali, ma la prima è meno fresca”. Le risposte fornitemi a questa domanda mostrano che chi
consuma spesso surgelati è un terzo rispetto a chi invece ne fa un uso più sporadico.
Questo risultato, se messo in correlazione con i risultati espressi dal grado di lavorazione
degli alimenti indica che la tendenza generale è quella di privilegiare anche in questo caso i
prodotti che hanno subito un minore trattamento preliminare alla vendita.
Nelle tre fasce di età le risposte si equivalgono, ma spicca una variabile di genere per cui il
doppio degli uomini rispetto alle donne dichiara di consumare spesso prodotti surgelati
perché più semplici da preparare. Lo stesso risultato lo si può ritrovare nelle risposte fornite
49
per quanto riguarda la scelta degli ingredienti volti alla preparazione dei dolci in cui vi è una
netta preponderanza femminile. La differenza di genere espressa nelle attribuzioni culinarie
genera una maggiore dipendenza maschile dai prodotti più lavorati industrialmente perché
dispensano da conoscenze specifiche.
Infatti, per la loro praticità gli Italiani consumano ogni anno circa 625.000 tonnellate di
prodotti surgelati (Villarini 2011, p. 364) «I gusti alimentari, come si sa hanno una storia, e la
domanda dei cibi è condizionata anche dal tempo che si può dedicare alla cucina per la loro
preparazione» (Mariani - Pirovano 2012, p. 106).
L'Istituto Italiano Alimenti Surgelati (I.I.A.S.), costituitosi nel 1963 al momento del decollo
dei consumi di surgelati in Italia, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con
D.P.R. 11 ottobre 1983, n° 1281. Il suo ruolo istituzionale consiste nella tutela e nella
valorizzazione dell'immagine dei prodotti surgelati, nel promuovere i corretti princìpi della
tecnica della surgelazione, della conservazione e della distribuzione del prodotto sino al
consumatore finale. Il 23 novembre 2011 si è svolta a Milano la Conferenza stampa I.I.A.S.
dedicata alla presentazione dei risultati della ricerca Astarea12: “il ruolo degli alimenti
surgelati nelle scelte alimentari degli italiani”. I risultati dimostrano che oggi circa il 92%
degli italiani dichiara di consumare surgelati (intesi sia come alimenti di base che dovranno
poi essere cucinati, sia prodotti già pronti per l'uso).
12 Milano, 23 Novembre 2011 - Il ruolo degli alimenti Surgelati nelle scelte alimentari degli italiani - Ricerca commissionata dall’Istituto Italiano Alimenti Surgelati (IIAS) ad Astarea. http://www.istitutosurgelati.it/component/content/article/31-area-riservata/63-contenuti-area-riservata-documenti.html (Data di accesso: 21/02/13, ore 17.14).
50
13
Per quanto riguarda i consumi infrasettimanali, le dichiarazioni qui riportate coincidono con
quelle della ricerca che ho svolto, infatti solo il 31% della popolazione dichiara di farne un
uso più frequente durante la preparazione dei pasti.
14
Secondo la suddetta ricerca le famiglie con un più alto consumo di questi prodotti sono quelle
13 http://www.istitutosurgelati.it/component/content/article/31-area-riservata/63-contenuti-area-riservata-documenti.html (Data di accesso: 21/02/13). 14 http://www.istitutosurgelati.it/component/content/article/31-area-riservata/63-contenuti-area-riservata-documenti.html (Data di accesso: 21/02/13).
51
con figli piccoli e l’incremento del consumo dei surgelati negli ultimi 5 anni riguarda in
primis la categoria più consigliata dai nutrizionisti, i vegetali (zuppe e minestroni in
particolar modo). A seguire sono presenti differenti tipologie di prodotto: patate
fritte/preparate e pizza oppure pesce. I valori funzionali di praticità e di sicurezza alimentare,
percepita per questa tipologia di conservazione sono tra i più riconosciuti, secondo questa
fonte che mira a promuovere i surgelati.
Secondo Siri, (Siri – Ghiselli 2012) sono cinque le principali ragioni che incentivano il
consumo di alimenti surgelati che, dalla loro nascita hanno sempre avuto un aumento nel
settore delle vendite. La prima e più robusta ragione di successo sta ovviamente nella
funzione di praticità di utilizzo. Questi alimenti infatti possono trovarsi sia sotto forma di
ingredienti (verdure, filetti di pesce) che fungono da base per la propria preparazione, sia
come piatti pronti. Fondamentale è il fattore per cui in questo modo è possibile avere a
disposizione ingredienti come il pesce già pulito o le verdure già lavate e sbucciate, alimenti
oggi ritenuti faticosi da preparare, ma resi decisamente indispensabili dalle pressioni
salutistiche che li vogliono inseriti nella dieta tradizionale. La seconda ragione del successo
di questo metodo di conservazione sta nella “scarsa manipolazione” della surgelazione che la
posiziona, come livello di gradimento subito sotto il prodotto fresco. La surgelazione (così si
pensa) non necessita di aggiunte di conservanti o l’immersione in olio, sale o altro, nel senso
che il prodotto è intatto così come viene “raccolto”15. Nonostante la percezione diffusa, molto
in realtà dipende dal tipo di alimento che viene surgelato. Ad esempio le paste precotte, come
i piatti pronti hanno un elevato numero di coloranti e conservanti e un alto grado di
manipolazione. Inoltre i prodotti, prima di essere sottoposti al processo di surgelazione
vengono puliti, lavati, tagliati e leggermente scottati. Questo rende il prodotto surgelato
altamente manipolato, prima della sua commercializzazione. La caratteristica positiva della
“scarsa manipolazione” però diventa vincente rispetto al trend degli ultimi anni in cui la
sensibilità all’artificiosità si è fatta più acuta e l’immagine del ghiaccio che permette di
congelare il tempo offrendo un prodotto fresco, è cresciuta se comparata a tecniche di
conservazione più invasive. Inoltre la proprietà di “surgelato appena raccolto, senza
aggiunte” crea un alone di freschezza e di naturalità, alimentata dalla comunicazione sulla
refrigerazione dell’“appena pescato”, che ha fatto guadagnare forte credibilità al pesce
surgelato. In realtà la verdura surgelata, una volta riportata a temperatura ambiente è ormai
15 Secondo l'articolo 5 del DLS del 27 GENNAIO 1992, N 110 - attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana - i mezzi criogeni che possono essere usati per il contatto diretto con gli alimenti da surgelare sono aria, azoto, anidride carbonica.
52
morta, allo stesso modo di quella secca, non più in grado di riprendere caratteristiche vitali
che guardandola gli potrebbero essere attribuite. Inoltre appassirà in tempi molto brevi se non
verrà utilizzata nell’immediato. Una terza ragione del gradimento sta nella velocità e facilità
di preparazione di un piatto ponderando le caratteristiche di facilità, rapidità, scelta e
completezza anche in situazioni in cui non si ha voglia o tempo di impegnarsi nella
preparazione di un pasto completo. Il quarto motivo di attrazione risulta essere, per Siri la
capacità del surgelato di offrire un “mondo” di prodotti, destagionalizzati e delocalizzati,
permettendo l’esercizio di quel gusto dell’esotismo e dell’internazionalità che conta numerosi
estimatori, così come poter mangiare funghi “freschi” fuori stagione. Importante, infine, resta
l’“effetto dispensa” che trasforma il frigorifero/freezer nell’equivalente moderno della
cantina o della dispensa in cui si riponevano cibi da non utilizzare nell’immediato, con la
funzione di scorta alimentare. La disponibilità di una “riserva” di risorse alimentari non
costituisce solo una comodità (“non devo uscire a fare la spesa”) ma anche una sicurezza
psicologica coerente con il concetto di “casa- rifugio”.
L’offerta più articolata, della gamma di prodotti stimolanti che hanno intercettato i trend
sociali del momento come l’individualismo, ma anche il cosmopolitismo e la ripresa delle
tradizioni alimentari regionali si sono dimostrati dei punti di forza notevoli che hanno
ampliato l’interesse per la categoria. Tuttavia, vi sono anche alcuni “punti critici” del settore
che non vanno sottovalutati poiché di tendenza opposta al livello di tecnologia e
manipolazione sempre minore che la popolazione sta cercando. Un’area di relativa debolezza
è costituita infatti, dalla qualità di gusto e sapore su cui incide la competizione dei prodotti
freschi (e di veloce utilizzo), come il reparto gastronomico o le verdure di V gamma16. Il
fascino del prodotto “fresco” è grande e sta crescendo allo stesso modo del complesso salute -
natura - semplicità, che potrebbe rendere più difficile la vita ai piatti pronti surgelati. Infatti il
limite del surgelato che poteva essere inteso come il più comodo sostituto alla preparazione
dei pasti ha di contro lo scongelamento che per giovani e single inizia a risultare fastidioso e
garantisce maggiore attrattiva verso prodotti scongelabili direttamente in padella (Siri –
Ghiselli 2012).
Anche il prezzo viene definito un po’ troppo alto secondo quanto mi è stato suggerito, infatti,
mi è stato riportato più volte come venga di gran lunga preferito l’acquisto di prodotti freschi
da congelare autonomamente. Questo succede probabilmente perché non si conosce la
16 Alla V gamma appartengono i prodotti ortofrutticoli che, dopo una lavorazione preliminare (selezione, lavaggio, taglio o pelatura) vengono precotti, sterilizzati e confezionati sottovuoto oppure cotti al vapore, grigliati o lessati e confezionati in atmosfera protettiva.
53
differenza tra congelazione e surgelazione per quanto riguarda il mantenimento dei principi
nutritivi che comunque rimangono qualcosa di non percepibile in maniera sensibile. Visibile
rimane però la confezione scura e di plastica che non permette il passaggio della luce contro
la pellicola, o anche l’assenza di questa dell’alimento fresco che viene congelato
autonomamente. Dalla ricerca emerge che questa categoria di prodotti siano una comoda, ma
saltuaria alternativa per spezzare la monotonia e avere una scorta di verdure che non devono
essere consumate in tempi brevi. Gli unici casi entusiasti sono stati un paio di giovani ragazzi
che ne elogiano le comodità soprattutto per quanto riguarda pizza e hamburgers o una madre
che li trova comodissimi e ne fa un ampio uso.
Attraverso i surgelati si possono ritrovare due richieste molto presenti nel moderno settore
alimentare quali la velocità di preparazione e la “freschezza destagionalizzata”. Tuttavia la
“vera” ricerca di freschezza non si va a trovare nel banco freezer, secondo i due terzi degli
intervistati e la percentuale di persone che ne fa un utilizzo poco ampio e diversificato è alta
anche grazie all’hobby per la cucina naturale che sta prendendo piede.
3. Organismi Geneticamente Modificati: dove si trovano e quali rischi comportano
Agricoltori e allevatori hanno sempre selezionato sementi e animali da riproduzione, basta
pensare alle razze dei cani o alla varietà di grano. Fino al diffondersi di tecniche di
microbiologia e di alterazione artificiale del patrimonio genetico a partire dal 1972 quando
venne annunciata la possibilità di modificare il patrimonio genetico di un batterio (Mele 2002
p.78). Con gli OGM la capacità invasiva e manipolatrice dell’uomo viene amplificata
notevolmente riuscendo a plasmare e determinare il patrimonio genetico, prescindendo dalle
dinamiche riproduttive fisiologiche. Il caso OGM è qualcosa di completamente nuovo e
rivoluzionario, nonché particolarmente discusso in ambito scientifico ed internazionale.
Questo tipo di tecnologia applicata all’agricoltura viene spesso giustificata e presentata dalle
aziende multinazionali che se ne occupano come l’unico futuro possibile per un mondo in cui
le stime di crescita della popolazione diventano sempre più allarmanti. C’è stato infatti chi mi
ha detto che questo tipo di coltivazioni “servono per dar da mangiare a tutti” in quanto tra
una decina d’anni non ci sarà più spazio sul pianeta per le normali coltivazioni che rendono
decisamente meno, oppure che: “sono il futuro, perché nella coltivazione vengono usati meno
pesticidi. Andranno tutti su quello!”. Il minore utilizzo di pesticidi è infatti una delle carte
vincenti utilizzate dalle grandi multinazionali che producono questo genere di modificazioni
54
nel corredo genetico delle piante per promuovere i loro prodotti. Le sementi OGM
(Organismi Geneticamente Modificati) sono state geneticamente modificate per resistere
meglio a pesticidi o ad agenti infestanti, come può essere ad esempio l’insetto piralide per il
mais. La Roundup Ready Soybeans, una soia OGM, infatti è stata la prima coltura GM
introdotta liberamente nell’ambiente per la coltivazione industriale negli Stati Uniti nel 1996.
Significa letteralmente che la soia è pronta per essere vaporizzata di Roundup, potente
erbicida di produzione della Monsanto, come le sementi. La Monsanto infatti prima di
occuparsi di biotecnologie si occupava innanzitutto di chimica applicata all’agricoltura. La
soia modificata è stata progettata per resistere al glyphosate il quale stermina indistintamente
tutte le sementi non appositamente progettate per resistervi. Ammesso e non concesso che
questo tipo di soia sia del tutto identica per il nostro organismo alla soia tradizionale, la
modifica del patrimonio genetico è stata utile ad aumentare la mole di pesticidi trattenuta
senza che la coltura subisca danni visibili (Robin 2008).
Una risposta molto frequente quando ho cercato di toccare l’argomento OGM è stata: “non
mi interessa” o anche: “non so dove si trovano, ma mi interessa poco”. Nel campo della
bioetica e delle biotecnologie la ricombinazione genetica fino a non molto tempo fa era
imputabile soltanto a qualcosa di sovrumano, oggi sembra un evento quasi ordinario.
L’interesse che però questo argomento attualmente suscita tra la popolazione risulta
decisamente basso, forse perché nel nostro paese il “pericolo” OGM sembra ancora lontano
55
anche se si sta avvicinando. In Italia infatti non sono presenti alimenti contenenti Organismi
Geneticamente Modificati se non specificatamente segnalati in etichetta (es: in un olio di
semi vari la segnalazione è riportata tra gli INGREDIENTI: olio di semi di soia OGM, olio di
semi di girasole. Prodotto da semi vari geneticamente modificati). Queste etichette però non
si trovano facilmente, e quando ciò accade è possibile che nascano alcune campagne come
quelle condotte da Greenpeace per evitare che in Italia vengano prodotti e commerciati
alimenti geneticamente modificati. La campagna condotta nel 2004 contro l’olio di semi
“Giusto” ha infatti portato alla cessazione di tale produzione, mentre quella riguardante un
altro olio pugliese “Dentamaro” è ancora attiva17.
In Italia, dal 2013, sarà permessa la coltivazione di una sola tipologia di mais, il MON810 per
l’alimentazione animale. L’introduzione di queste coltivazioni nei nostri campi ha origine
con una sentenza della Corte di giustizia europea del 6 settembre 2012 che decreta
l’impossibilità di vietare la coltivazione di varietà di piante approvate dall’Unione Europea
ed inserita nel catalogo delle sementi. In mancanza della normativa che, in base al decreto
legge n. 279/2004, dovrebbe regolare la coesistenza tra semi OGM e semi tradizionali sul
territorio nazionale, l’Italia si era opposta alla vendita da parte dell’azienda multinazionale
Pioneer la quale ha fatto ricorso con esito positivo18. Resta da ribadire che la stessa Corte di
Giustizia ha imposto il principio per cui i cittadini devono conoscere in quali aree del loro
comune siano presenti coltivazioni GM affinché non avvengano contaminazioni tra colture
GM, tradizionali e soprattutto biologiche.
In Europa è permessa la coltivazione di numerose varietà che si possono raggruppare in sei
specie differenti di piante quali cotone, mais, colza, patata, soia, barbabietola da zucchero e
due tipi di microrganismi con la funzione di agenti lievitanti19, mentre sono in fase di
sperimentazione altre tre varietà di mais e due di colza.
Alcuni stati membri20 hanno applicato la “clausola di salvaguardia” che vieta la coltivazione
sul suolo nazionale di colture modificale secondo la direttiva comunitaria21. La tracciabilità
sull’etichetta di prodotti alimentari contenenti carne di animali allevati con mangimi 17 CAMPAGNA GREENPEACE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DI ALIMENTI OGM http://www.greenpeace.org/italy/it/campagne/ogm/Allarme-OGM/ (Data di accesso: 15/02/13). 18 SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SULLA COLTIVAZIONE DI MAIS OGM MON810 IN ITALIA. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126437&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1195160 (Data di accesso: 15/02/13). 19 LISTA COMPLETA DELLE VARIETA OGM PRESENTI SU SUOLO EUROPEO, SIA COLTIVABILI CHE IN FASE DI SPERIMENTAZIONE. http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm (Data di accesso: 15/11/2012). 20 Austria, Francia, Grecia, Ungheria, Germania, Lussemburgo. 21 (Art. 23 Dir. 2001/18/EC)
56
geneticamente modificati non risulta ancora obbligatoria. Rimane dunque impossibile averne
una stima approssimativa. Inoltre da un’intervista effettuata ad un contadino della provincia
di Varese che alleva capre per produrre formaggi nella piccola azienda agricola di famiglia
risulta che durante l’acquisto di mangimi22 dal rivenditore che fornisce tutti gli allevatori
della zona gli veniva consegnata indistintamente metà soia nazionale (N) e metà
geneticamente modificata (OGM) senza specificarne la differenza. Vi era solo una piccola
scritta sull'etichetta e per averne solo di nazionale sarebbe stato necessario, innanzitutto
accorgersi della differenza, informarsi e richiederla anticipatamente. Le grandi multinazionali
esercitano numerose pressioni per evitare che le norme europee obblighino l’etichettatura di
alimenti contenti OGM poiché potrebbero portare ad un rifiuto a causa dei dubbi e delle
incertezze nei riguardi di questi alimenti come la campagna portata avanti da Greenpeace.
C’è invece chi sostiene che: “li buttano dentro dappertutto. Meno del 50% dei prodotti ha
dentro quello che c’è scritto in etichetta” (come in effetti risulta dal recente caso della carne
di cavallo), o anche che: “noi li mangiamo già, ma non lo sappiamo”. In base alla normativa
europea gli alimenti che contengono una percentuale superiore allo 0,9% di cibi
geneticamente modificati (soglia ammessa per regolare la presenza accidentale di questi
ultimi) deve essere segnalata sull’etichetta e rintracciabile in tutti gli stadi della filiera. Da
notare però che la soglia dello 0,9% è inferiore anche a quella del 2% per quanto riguarda la
presenza accidentale di cibi ritenuti nocivi come ad esempio la colza HEAR. Anche in campo
agricolo le sementi utilizzate hanno una soglia di tolleranza dello 0,9%, ossia, in ogni
sacchetto di semi venduto è possibile che lo 0,9% sia geneticamente modificato e finito
casualmente nel sacchetto di semi non modificati. La soglia di tolleranza però permette il
diffondersi involontario di organismi geneticamente modificati nonostante in Europa questi
siano tendenzialmente respinti da quasi tutti i paesi dell’Unione. Il pericolo di una diffusione
involontaria con conseguente minaccia per la biodiversità è stato percepito da chi li ha
paragonati agli scoiattoli canadesi23.
Secondo Zaghi (2009 p. 40) «un altro aspetto molto rilevante riguarda poi l’incertezza insita
al processo di analisi d’acquisto del prodotto geneticamente modificato. Le modalità di
22 Mangimi somministrati per un totale del 20% rispetto al fieno che occupa l'80% dell'alimentazione della capra. 23 Lo Scoiattolo grigio è stato introdotto in Piemonte nel l 948 e in Liguria nel 1966 ed attualmente risulta presente nelle due regioni con popolazioni naturalizzate. La presenza nel nostro Paese di tale specie alloctona pone attualmente concreti rischi biologici legati principalmente alla competizione con lo Scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris), all'introduzione di fattori patogeni ed al danneggiamento di boschi di latifoglie forestali, pioppei, noccioleti, frutteti e colture cerealicole. (Progetto di eradicazione dello Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis) dal territorio piemontese, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Università degli Studi di Torino. DiVaPRA - Entomologia e Zoologia applicate all'Ambiente, Aprile 1997).
57
conoscenza del consumatore rispetto all’ingegneria genetica non sono quasi mai dirette e
sono, anzi, quasi sempre mediate da altri attori (scienziati, fonti d’informazione, politici,
imprese multinazionali delle sementi ecc.), così come accade solitamente, peraltro, per le
innovazioni scientifiche. Si tratta, in altri termini, di un caso di asimmetria informativa, per il
quale il consumatore deve effettuare una valutazione del rischio associato, in base alla
propria personale propensione». Molti infatti mi hanno risposto che non conoscono bene
l’argomento, ma che vorrebbero saperne di più per avere un’opinione più precisa: “Non so da
che parte stare perché c’è poca informazione”, “Non saprei, non c’è informazione”.
Altri invece, mentre stavo cercando di affrontare il discorso, si sono trovati spiazzati e hanno
preferito tergiversare fornendo brevi risposte fugaci o poco inerenti come: “ho un problema
di intolleranza, per cui non li prendo” Ciò che però è emerso chiaramente è che nel dubbio è
sempre meglio starne alla larga: “non sto molto attenta, ma preferirei evitarli, non mi fido
delle cose pasticciate” , “nel dubbio li evito” , “se li riconosco li evito!”
È vero che c’è anche chi si è dimostrato favorevole, pur essendo una minima parte, e molto
fiducioso sulle nuove tecnologie proposte: “potrebbero essere una buona invenzione, li
mangerei” , “ne so poco, ma credo possano essere una valida alternativa” , “Se sono
controllati si possono anche mangiare” , “Non sono talebani che bisogna fargli la guerra,
diamogli una possibilità, possono nutrire il pianeta” , “Paure infondate, sì li prenderei!”.
Queste persone potrebbero dunque riscoprirsi sostenitore di Giorgio Fidenato 24 , un
agricoltore che, il 2 ottobre 2010 ha reso pubblica la sua coltivazione di cinque piante di mais
MON810 in provincia di Pordenone per affermare la libertà di poter scegliere cosa coltivare
nei propri campi in quanto registrate nel catalogo europeo delle sementi, esattamente come
successe con la Pioneer. Purtroppo per lui però l’esito non fu così fortunato e dovette pagare
un a multa di 25.000 euro nonché aspettare la sentenza della multinazionale per poter piantare
liberamente mais OGM senza più rischiare di incappare in sanzioni molto salate. Nel nostro
paese dunque questo tipo di coltivazioni tendenzialmente non sono così ben accette in quanto
la maggior parte delle risposte è stata decisamente negativa: “non li voglio!” , “fanno
malissimo!!” , “Non vorrei che anche i miei figli fossero geneticamente modificati anche
loro” , “non dovrebbero esistere” , “io mangio solo frutta e verdura di stagione. Di cose
modificate non ne voglio sapere!”.
24OGM, SEQUESTRATI L’AZIENDA E I CAMPI DI GIORGIO FIDENATO. http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2011/04/05/news/ogm-sequestrati-l-aziendae-i-campi-di-giorgio-fidenato-1.48751 (Data di accesso: 15/02/13, ore 23.12).
58
Il vero problema per il consumatore che si nutre di questi organismi geneticamente modificati
è che i rischi per la propria salute sono assolutamente ignoti a causa dell’assenza di ricerche
indipendenti. Gli studi svolti in questa direzione sono stati spesso boicottati in itinere con
l’insorgere delle prime manifestazioni di presunta pericolosità dell’alimento, mentre altre
ricerche dirette dalle multinazionali sono risultate poco scientifiche e molto dubbie a causa
della mancanza di dati, della terminologia scarsamente scientifica e dell’utilizzo di cavie
troppo vecchie per poter avere una panoramica accurata sui possibili disturbi che potrebbero
causare (Robin 2008). Le cavie sono dunque risultati essere i consumatori, in particolar modo
quelli americani che non possono tutelarsi dall’ingerire questi cibi in quanto risulta
impossibile individuarli, non essendo segnalati sulle confezioni alimentari.
Solo la California è stato l’unico paese negli Stati Uniti in cui è stato svolto un referendum in
merito alla segnalazione in etichetta della presenza di OGM che ha però non ha però raccolto
il quorum sperato. Negli Stati Uniti la prima legge relativa agli OGM risale al 29 maggio
1992 e si basa essenzialmente sul principio di sostanziale equivalenza.
«Nella maggior parte dei casi, le sostanze che dovrebbero diventare componenti degli
alimenti risultanti dalla modificazione genetica di una pianta saranno gli stessi, o
sostanzialmente equivalenti alle sostanze comunemente trovate nel cibo, come ad esempio
proteine, grassi, olii e carboidrati25» Il principio di equivalenza sostanziale (ES) però non
definisce qual è il grado per cui questi organismi dovrebbero o potrebbero discostarsi
dall’“originale”. È proprio questo carattere fumoso e poco risolutivo di equivalenza
sostanziale (ES) a sollevare i maggiori dubbi presso gli oppositori a questo regime
alimentare.
C’è stato anche chi mi ha risposto che le nuove coltivazioni “sono il male di chi non sta
bene” e anche: "non sono molto convinto che siano la panacea di tutti i mali”. In India infatti
le coltivazioni di cotone cresciute da semi geneticamente modificati, che hanno favorito di
un’ottima pubblicità sono diventate la condanna di molti piccoli coltivatori. I debiti contratti
per l’acquisto delle sementi miracolose che non avrebbero dovuto più avere bisogno di
erbicidi e cure particolari non sono stati estinti a causa della non veridicità delle promesse
25 “In most cases, the substances expected to become components of food as a result of genetic modification of a plant will be the same as or substantially similar to substances commonly found in food, such as proteins, fats and oils, and carbohydrates”. Vol. 57 No. 104 Friday, May 29, 1992 p 22984 DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, Food and Drug Administration [Docket No. 92N-0139] - Sezione I. Background and Overview of Policy. http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/Biotechnology/ucm096095.htm (Data di accesso : 07/11/2012).
59
fatte e del maggiore indebitamento di questi ultimi per cercare di salvare il raccolto
(Mastrantonio - Tecchio 2012).
Un altro grave danno alle popolazioni riguarda la possibilità di brevettare tipi di sementi
ibride grazie al “protocollo brevetti” secondo cui è possibile appunto brevettare scoperte fatte
in altre località del pianeta purché negli USA non sia ancora depositato il brevetto rende
possibile quello che Vandana Shiva (2000, cfr., Lanternari 2003) denuncia con il nome di
biopirateria. Oltre a questo, la famosa attivista indiana denuncia anche la riduzione della
biodiversità globale che l’introduzione di questo nuovo tipo di piante provoca a causa del
regime d’illegalità in cui cadono gli agricoltori tradizionali che mettono da parte un buon
raccolto per scambiare sementi e ibridano piante attraverso tecniche millenarie.
In più la tossicità degli erbicidi utilizzati stermina insetti e piante spontanee che crescono nei
campi. Piante che favoriscono la concimazione del terreno una volta raccolti i frutti dei campi
e che in alcuni paesi quali appunto l’India venivano utilizzate come un solido costituente
dell’alimentazione rurale. Quelle che Lanternari chiama “erbacce super infestanti”
(Lanternari 2003), non sono altro che erbe spontanee che si sono naturalmente combinate
tramite impollinazione ad organismi OGM e che possono costituire una minaccia per la
difficoltà che si riscontra nell’estirparle.
4. Coloranti e metodi industriali di lavorazione
La paura per la propria salute fisica causata dalle odierne abitudini alimentari è un tema di
grande attualità e coinvolge un numero sempre crescente di persone: “dimmi cosa mangi e ti
dirò cosa ti verrà”.
Le dichiarazioni pessimistiche in merito coinvolgono il 55% delle persone intervistate:
60
Due persone si sono riferite ad una dieta troppo ricca di grassi che può essere nociva, oppure
una ha detto che tutti noi siamo differenti, per cui “una cosa fa male a me e una cosa fa male
a te”. Il resto degli intervistati ha parlato invece della paura derivante dall’uso sempre
crescente di additivi, coloranti e conservanti presenti negli alimenti e dall’alto grado di
sofisticazione congiunta all’insufficiente trasparenza che coinvolge tutti i processi della
catena produttiva. La fiducia sui controlli effettuati risulta piuttosto alta, ma spesso correlata
da altrettanti dubbi.
Attraverso questo quesito infatti mi sono state fornite numerose risposte identiche che
riguardavano casi di sofisticazione scoperti dai N.A.S. La maggior parte degli intervistati
61
dunque parlava di “mucca pazza” e “pollo alla diossina”, per fare un esempio dei casi più
noti, ma in realtà mi sono stupita dell’alto numero di casistiche differenti riportatemi. Tutte
erano correlate ad una sfiducia nell’industria alimentare che sta prendendo in giro il
consumatore facendogli vedere solo l’etichetta di un prodotto che in realtà potrebbe
contenere tutt’altro: “per quel che ne sappiamo noi… se ne sentono di tutti i colori”. Spesso
ho dovuto ripetere la domanda alla fine degli esempi riportati perché le conclusioni che la
gente ne traeva potevano essere completamente differenti. Alcuni mi hanno mostrato questi
casi come ottimi esempi di efficienza dei controlli effettuati (soprattutto nel nostro paese): “i
controlli sono buoni, hai visto quanti ne hanno presi?” Oppure, al contrario “con tutti quelli
che hanno preso come faccio a fidarmi dei controlli che ci sono?” , “Per uno che ne
prendono ce ne sono altri nove che la fanno franca”. La maggior parte di queste informazioni
proviene dalla televisione: “ho visto alla televisione…” , “ho sentito al telegiornale…” , “ho
visto un servizio… l’ha visto anche lei?”. È possibile che la sovrabbondanza di servizi a
riguardo abbia portato la questione in primo piano. Per restare in salute i tre consigli più
gettonati sono: non fumare, fare attività fisica e mangiare sano. Ma “com’è possibile
mangiare sano con tutto quello che si sente in giro?” Per quanto riguarda la preoccupazione
per la propria salute c’è stato chi ha detto: “mi fido, certo, se no certe cose mica le mangerei”
oppure “se no non mangerei più niente, però con quello che si sente qualche dubbio ti viene”.
Il recentissimo scandalo della “mucca di cavallo” sta suscitando ancora una volta numerosi
interrogativi e mi sembra emblematico da analizzare per spiegare quali siano le paure diffuse
e i punti oscuri della filiera. La vicenda è nata agli inizi di febbraio 2013 partendo ancora una
volta dalla Gran Bretagna dove sono state scoperte tracce di carne di cavallo (superiori
all’1% consentito) in alcuni prodotti surgelati della Findus, immediatamente ritirati dal
mercato. I casi però sono stati anche più numerosi e hanno coinvolto diversi paesi europei in
quanto gli alimenti venivano distribuiti da grandi multinazionali come Findus, Buitoni, Star,
Ikea. È stato scoperto inoltre che la carne di cavallo può contenere tracce di fenibultazone, un
medicinale dopante usato per cavalli da corsa la cui macellazione sarebbe vietata.
Il problema di questi allarmi alimentari innanzitutto coinvolge la distribuzione su ampia
scala. I rischi alimentari non sono più circoscritti all’area di produzione e vendita, per cui la
grande distribuzione di alimenti si accompagna ad una grande distribuzione di epidemie
causate da cibi contraffatti. Secondo Jaillette (2000 p. 9) all’inizio del secolo decine di
migliaia di persone morivano d’intossicazione alimentare, mentre ora i casi stanno
decisamente diminuendo, ma la situazione allarmistica rimane alta, anzi cresce sempre di più.
Tutte le derrate alimentari ritirate perché possibilmente contaminate, se da un lato fanno
62
crescere la fiducia nei controlli effettuati dall’altra fanno pensare alla possibilità che una
scatoletta di tutta quella carne ritirata sarebbe potuta anche finire sulla “mia” tavola
aumentando l’allarmismo oltre che lo spreco. Un altro punto focale è che inizialmente il caso
della carne di cavallo non riguardava un problema propriamente di salute, ma di
informazione. Infatti la carne presente non veniva presentata come nociva, ma soltanto non
segnalata in etichetta. Le norme sulla tracciabilità non furono dunque rispettate impedendo di
individuare la provenienza delle carni. Vero è che la mancanza di trasparenza non è un buon
sinonimo di garanzia, infatti le carni di cavallo macinate contenevano tracce di antibiotici e
trattamenti ormonali vietati. Il “trucco” della carne macinata però era fin troppo semplice ed
evidentemente è stato utilizzato anche troppo di frequente dalle industrie di tutta Europa. La
carne macinata è un alimento manipolato che viene spesso usato per la preparazione di piatti
(polpette, hamburger) o sughi pronti (come le lasagne surgelate da cui è partita lo scandalo).
La presenza dunque di una percentuale più alta di un alimento non dichiarato sarebbe stata
possibile solo in questi casi perché ovviamente una bistecca non potrà che essere totalmente
bovina o equina. Questa risulta una grande differenza rispetto ai casi di intossicazione. Con lo
scandalo della carne equina viene sottolineata la rottura del patto di fiducia tra la descrizione
degli ingredienti in etichetta e il contenuto della confezione. Le moderne tecniche di
trasformazione hanno dunque permesso questo tipo di frode, ma è anche vero che per
scovarla era necessaria una tecnica altrettanto moderna quale il controllo del DNA. In altro
modo non sarebbe stato possibile distinguere la carne bovina da qualsiasi altra macinata
all’interno di una confezione di ragù. Se dunque, per quanto riguarda il caso delle mozzarelle
blu della Germania in cui il pericolo era più che palese, ora, per la maggior parte dei casi
l’effetto sembra più quello della “mela di Biancaneve” in cui alimenti bellissimi possono
contenere sorprese inaspettate.
Il pericolo dell’intossicazione alimentare è tanto sentito perché potrebbe arrivare dappertutto,
è invisibile e non si sa chi incolpare. La mancanza di un referente fisico univoco a cui
imputare la colpa permette uno scarico di responsabilità troppo grande per concedere
soddisfazione a chi si sente frodato dall’industria alimentare oltre ad impedirne una corretta
identificazione.
5. Additivi e sofisticazioni
Un altro invisibile nemico dei consumatori è costituito da tutte quelle sigle scritte sulle
63
confezioni che non corrispondono ad alimenti, ma ad aggiunte, sofisticazioni e prodotti non
necessari per la salute, anzi, che definirei dannosi nella maggior parte dei casi. Soltanto un
ragazzo, in tutta la mia ricerca li ha definiti come “utili” , ma solo per quanto riguarda i
metodi di conservazione. La metà delle persone che hanno indicato come criterio di selezione
di un prodotto confezionato la scadenza maggiormente dilatata nel tempo sono le stesse che
hanno risposto in maniera perentoria: gli additivi “fanno male” , “non ne voglio”, “cerco di
evitarli”. Il problema è che la scadenza dilatata è una caratteristica rintracciabile solo in
alimenti trattati e con una massiccia presenza di conservanti. La comodità unita alla genuinità
forse non è possibile soprattutto quando vengono proposti con convinzione alcuni esempi
paradossali. Una donna anziana riferendosi all’acquisto di un barattolo di ciliegie sciroppate
dal colore molto tenue, si è lamentata del fatto che le avessero colorate di grigio per
“bellezza”. “Le ciliegie sono rosse – mi ha detto – non possono mica colorarle così, è una
vergogna!” Purtroppo non ha specificato la marca, per cui non è stato possibile reperire la
confezione, ma molto spesso le ciliegie, soprattutto sciroppate o candite, impiegate
principalmente come decorazione, hanno un rosso vivido perché colorate artificialmente,
mentre quelle dal colore più slavato, che si trovano raramente sul mercato, non hanno subito
questo trattamento.
Chi mi ha risposto con indecisione invece è stato il 18% e ha principalmente espresso
l’ineluttabilità di questo stile di consumo: “non mi piacciono, ma che ci vuoi fare, li mettono
dentro dappertutto ormai” oppure “non li vorrei, ma danno ai cibi un aspetto migliore”, o
ancora “spero che non facciano male”. Per cui sarebbe più corretto parlare di un quasi totale
rigetto nei confronti di questi, nonostante ormai vengano ricercate le caratteristiche specifiche
64
che inferiscono al cibo, come conservabilità e colore.
Secondo un articolo di Pollan (2003) la quantità di cibo che una persona riesce ad ingerire è
comunque limitato a sette quintali l’anno nonostante si stia cercando con crescente successo
di oltrepassarlo. L’industria alimentare però ha come fine ultimo il profitto, per cui, per
aumentare il “valore del cibo” che non è possibile ingerire ad oltranza ha cominciato una
massiccia serie di esportazioni oltre alla sempre crescente industria della sofisticazione e
manipolazione. I cibi già lavorati infatti costano di più e inoltre ci sono quelli addizionati di
principi nutritivi per regalare un senso di salute laddove questo non sarebbe presente. Sempre
Pollan racconta la paradossale scoperta per cui alcuni principi nutritivi non sono efficaci al di
fuori degli alimenti stessi da cui sono estratti avvalorando la tesi per cui un alimento non è
soltanto la somma di grassi, proteine, carboidrati e vitamine di cui è composto, ma queste
devono trovarsi nel giusto equilibrio. Inoltre la tesi per cui gli OGM sono stati considerati
innocui poiché il segmento di DNA inserito è costituito dagli stessi amminoacidi di cui è
composto qualsiasi altro segmento di DNA potrebbe essere messa in discussione.
6. Siamo quel che mangiamo
Il cibo è sempre stato collegato alla salute del nostro organismo. La pellagra e la gotta, sono
tipiche malattie oggi sconfitte grazie alla scoperta dei principi nutritivi, grassi, carboidrati,
vitamine e ai loro effetti sull’organismo. Si è dunque scoperta l’importanza di una dieta più
bilanciata, oltre ad aver raggiunto i mezzi economici per poterla soddisfare. I problemi
nutrizionali odierni sono derivati dall’abbondanza di cibo a disposizione che provoca obesità
e malattie cardiovascolari note a tutti, ma secondo i miei intervistati non solo da quello.
La biodiversità, nettamente in calo, ha creato un vuoto alimentare che è stato supplito da
alimenti artificiali in sostituzione a quelli naturali. Entrando in un supermercato infatti
l’ultima idea che il luogo suggerisce è quella della scarsità. Una ragazza, durante
un’intervista mi parlò della sua recente scoperta della carruba, e di come questa sapesse di
Nutella (la carruba infatti è uno degli ingredienti della crema). Questa sostituzione del gusto
naturale con quello artificiale avviene soprattutto perché è molto più facile trovare in
commercio un barattolo di Nutella piuttosto che qualche carruba, addirittura difficile da
riconoscere per i più giovani.
La sostituzione del mondo naturale, con quello artificialmente costruito dall’uomo si può
notare infatti dall’ignoranza riguardante i processi di maturazione degli ortaggi sostituiti dalla
65
conoscenza sempre maggiore di marchi e loghi. I nuovi alimenti, come gli additivi vengono
utilizzati per la preparazione di cibi e vivande, ma non tutti sono salutari quanto si credeva
(come l’aspartame o il glutammato monosodico). Nella migliore delle ipotesi questi saranno
innocui, ma è facile anche che possano risultare dannosi, e secondo la mia ricerca la
popolazione ne diffida in buona parte. Lo stesso discorso varrà dunque anche per gli alimenti
geneticamente modificati. Il pericolo dunque parrebbe arrivare direttamente dal cibo e non
dalla mancanza o abbondanza di questo, soprattutto perché i nostri sensi non saranno in grado
di capirlo in quanto un pomodoro OGM risulterà in tutto e per tutto identico ad uno
biologico.
66
CAPITOLO TERZO
CAMBIAMENTO DELLE MODALITÀ SENSORIALI E DI RAPPORTO CON L’AMBIENTE
«Al di là dei rumori e degli odori sgradevoli, l’esperienza sensoriale dell’uomo di città si
riduce essenzialmente a quella della vista. Lo sguardo, senso della distanza, della
rappresentazione, se non della sorveglianza, è il vettore essenziale dell’appropriazione da
parte dell’uomo dell’ambiente a lui circostante» (Le Breton 2000 p. 117). Dal lungo processo
di evoluzione naturale della nostra specie abbiamo ereditato un sistema sensoriale che si è
affinato adattandosi alle mutevoli condizioni ambientali. Avvenne un perfezionamento
fisiologico sull’efficacia delle proprie funzioni nel mettere in contatto il nostro organismo
con il mondo esterno, con le persone, con il corpo, con i suoi meccanismi interni e le sue
funzioni (Marazzi 2010, p 15). L’apparato sensoriale permette di relazionarci col mondo da
cui viene condizionato e modificato secondo il processo darwiniano di evoluzione. Ciò ha
portato, in ogni specie, allo sviluppo di qualche sistema sensoriale attraverso cui captare gli
stimoli selezionando quelli maggiormente significativi per la propria conservazione. Un
esempio può essere riportato da quello che tra i sensi viene considerato il più ottuso: l’olfatto.
La sua utilità è stata massima all’inizio dell’evoluzione umana, quando esso veniva utilizzato
per il riconoscimento di pericoli come un incendio, per captare messaggi sessuali e valutare la
commestibilità o meno di determinati cibi col supporto del gusto. In seguito, gradualmente,
con il cambiamento dell’habitat e dello stile di vita, la sua funzione sarebbe diminuita,
nonché, la reazione agli stimoli odorosi si sarebbe in parte atrofizzata. Quest’idea è stata
condivisa da Gehlen che supportato da alcuni studi biologici sulla struttura morfologica
dell’uomo parla di tracce di arresto nello sviluppo filogenetico dimostrato dalla presenza di
"primitivismi" e "ritardamenti" che difficilmente avrebbero potuto agevolarlo durante il
processo di selezione naturale (Rasini 2008). Dietro l’idea che una scarsa sensibilità
67
rappresenti una mancanza però, si nasconde una logica secondo la quale avere a disposizione
più strumenti risulta sempre meglio che averne in numero minore. Secondo Marazzi (2010,
pp. 93 - 94) questa teoria che si potrebbe definire “efficientista” spesso sottovaluta
l’importanza che una scarsa sensibilità di questi due sensi ha portato nell’introdurre una dieta
più diversificata. Anche Herder si riferisce ad una scarsa dotazione sensoriale già menzionata
da Platone nel Protagora. Il mito racconta di come Epimeteo, abbia distribuito le diverse
facoltà in maniera ineguale, lasciando l’uomo sprovvisto di vantaggi morfologici o dotazioni
naturali originarie. Il che non pose però l'uomo in una posizione di svantaggio poiché la
compensazione avvenne sul piano tecnico che non riguarda soltanto l'uso di strumenti
meccanici, ma anche con la facoltà del linguaggio su cui si soffermò anche Herder. Si tratta
del prometeico furto del fuoco che rende l’uomo partecipe del divino. Secondo Plessner, la
corporeità è una realtà ”fenomenologica” che non può essere esaminata astrattamente,
separata dai meccanismi in cui operano i meccanismi delle sue funzioni primarie (Plessner
1948). In base alla fenomenologia infatti noi non possiamo astrarre le nostre azioni e i nostri
pensieri dal contesto in cui viviamo, il quale sarà a sua volta plasmato dalla cultura e dalla
società che l’ha prodotta. Indi per cui essi sono strumenti indispensabili per aprirci al mondo
dialogando con esso in un rapporto simbiotico in cui l’uomo recepisce gli stimoli esterni
agendo di conseguenza e allo stesso tempo modella il mondo circostante rendendolo il più
possibile gradevole e dunque gradito a questi.
Secondo David Le Breton lo sguardo è senza dubbio il primo dei cinque sensi di cui l’uomo
dispone all’interno del panorama moderno (Le Breton 2000). Questo avviene soprattutto nel
contesto urbano, specificatamente conformato per dar luogo ad una predominanza visiva
prettamente occidentale. «Gli alti grattacieli che s’innalzano sopra e grandi città, o sopra le
banlieues sono le sentinelle anacronistiche di un mondo che, in ogni modo, non sembra avere
più nulla da nascondere» (Le Breton 2000 p.115). Vediamo il mondo attraverso degli
schermi, che non vanno intesi semplicemente come quelli tecnologici di computer e
televisioni, ma anche del parabrezza della nostra automobile, delle vetrine dei negozi, e
ancora della pellicola trasparente che permette di schermare e proteggere gli alimenti. Questi
ultimi vengono sempre protetti da confezioni trasparenti che ne permettono la visibilità a
discapito della genuinità in quanto la conservazione di un alimento avviene in maniera più
efficace senza la presenza di luce. Con la luce che filtra direttamente dalla trasparenza degli
involucri invece, la quantità di conservanti aumenta sensibilmente (Mariani - Pirovano 2012).
La trasparenza della confezione però risulta spesso moto importante ai fini dell’acquisto: “Se
non si vede preferisco non comprarlo” senza parlare dei coloranti, assolutamente
68
indispensabili per far assumere agli alimenti un aspetto più invitante: “di solito preferisco
comprare quello che mi ispira, che mi sembra più buono, anzi, direi più che quando lo vedo
mi viene voglia di mangiarlo”. Nei primi supermercati frutta, verdura, e carne erano
rigorosamente confezionate, ma comode da ispezionare poiché permettevano di prendere in
mano le confezioni. Il cliente si sentiva così più libero di maneggiare i prodotti senza avere
comunque un contatto diretto con questi. Differenza sostanziale dal “vecchio” esercizio
commerciale che vedeva l’esercente come referente principale a cui era permesso “toccare”
la merce. Questa caratteristica è stata infatti moto apprezzata e menzionata nella ricerca di
mercato della GS di cui ho parlato in fondo al primo capitolo. Anche i guanti di plastica usati
invece oggi nel reparto frutta e verdura in realtà permettono solo un’apparente avvicinamento
al prodotto in quanto comunque la vista rimane il criterio principale di scelta della verdura.
Solo una persona mi ha detto “la tasto”, mentre nessun ha detto di annusarla. L’assaggio
invece è una pratica del tutto vietata a differenza del negozio tradizionale in cui questo era
possibile grazie ad un’interazione con il commerciante e con il prodotto sfuso. In realtà mi ha
colpito come in un ipermercato, in una situazione di leggera confusione l’uva non rientra in
questi criteri, ma ne viene assaggiato qualche acino prima della scelta. Il gesto di levare
qualche acino risulta molto rapido, e magari si preferisce allontanarsi dal banco per
consumarlo, ma sembra una pratica piuttosto comune, anche se poi magari la verdura non
verrà scelta. Sembra in realtà più un piccolo omaggio del supermercato offerto a chi
“furbescamente” decide di contravvenire ad alcune regole implicite e non. L’apertura delle
confezioni invece, è possibile solo in caso di un successivo acquisto, ma non è consigliata.
L’assaggio è permesso solo in presenza di particolari stand promozionali all’interno del
supermercato dove i prodotti solitamente confezionati verranno offerti al consumatore che ne
potrà saggiare direttamente le caratteristiche. La presenza di questi stand risulta lievemente
più frequente all’interno di ipermercati e supermercati di grandi dimensioni, ma comunque
generalmente assai rara rispetto all’enormità di prodotti in commercio. Gli stand infatti non
potranno essere sparsi copiosamente all’interno di ogni punto vendita a causa delle difficoltà
di collocamento e di gestione (Eminente 1992). Verranno posizionati invece in alcuni punti
strategici di maggiore passaggio per catturare l’attenzione della clientela, ma solitamente non
superano i due stand a supermercato per non infastidirla eccessivamente poiché «per l’uomo
in spostamento è importante solo lo sguardo, il suo corpo è ciò che ostacola la sua avanzata»
(Le Breton 2000 p. 119) durante la spesa settimanale compiuta in tutta fretta: “odio andare al
supermercato, ci mando sempre mio marito Egidio!”.
«Divisi, in lui, i sensi: l’occhio /correva avanti, come un cane, /roteava all’intorno e poi
69
ancora avanti /fino alla prima svolta,/dove si fermava ad aspettare – /restava indietro
l’udito,/come un alito» (Rilke 1992 pp. 121 - 122).
L’olfatto è il più indecifrabile di tutti i sensi e spesso è spregiativo. Con questo si intende che
ci è più facile riconoscere e descrivere qualcosa che ha un cattivo odore, una puzza, piuttosto
che la natura di un profumo piacevole. Forse perché l’ odore viene ricondotto a qualcosa di
vivo, in evoluzione, più forte rispetto a quello emanato da una superficie sterile. Tutto ciò che
non è asettico produce odore, ed è per questo motivo che all’interno di un supermercato
questo deve essere completamente eliminato. Sono tollerati solamente odori chimici di
detersivo, deodorante, ammorbidente, spesso definiti con un generico “odore di pulito” in
quanto il vocabolario olfattivo risulta notevolmente scarno. Ormai l’olfatto è uno dei sensi
meno utilizzati. Nessuno l’ha menzionato come discrimine per la scelta della verdura
nonostante non sia ancora vietato accostarla al viso per inalarne gli effluvi. Questo anche
perché le basse temperature a cui sono tenuti gli ortaggi e gli ampi spazi dispersivi ne
impediscono una vivida decifrazione. C’è anche da dire anche che i prodotti acerbi (più
frequentemente esposti rispetto a quelli molto maturi), oppure quelli non di stagione tendono
ad avere un odore meno marcato rispetto a quelli con le caratteristiche opposte. “Mio marito
mi dice sempre, non comprare più i pomodori in inverno che non sanno di niente”, oppure mi
hanno detto che “al Nord” la verdura e la frutta sono diverse da quelle che si trovano negli
stessi supermercati “del Sud” in cui il sole è più caldo e la frutta matura meglio: “la frutta e
la verdura che trovi nei supermercati qui al nord fa schifo!”
Il reparto ortofrutticolo, pur essendo un banco fresco similare al banco del pesce o dei salumi,
permette la scelta del prodotto da parte del singolo cliente contrariamente agli altri banchi in
cui non è possibile “toccare con mano” ciò che si desidera acquistare. La scelta viene dunque
portata avanti sulla base di alcuni criteri che sono andata ad indagare e che da un lato sono
simili a quelli utilizzati per l’acquisto di scatolame e prodotti confezionati perché la scelta
avviene singolarmente, mentre si differenziano perché frutta e verdura sono considerati
prodotti freschi e chiaramente tra loro differenti, diversamente dalle serie di scatole identiche.
Sul “toccare con mano” la frutta che si sceglie invece la questione risulta più complessa in
quanto la nostra mano non arriva a toccare la superficie della verdura che si desidera
acquistare, ma deve sempre essere ricoperta da un “super-igienico” guanto di cellophane per
evitare contaminazioni durante la fase di scelta. Il mancato utilizzo del guanto comporterebbe
riprovazione sociale da parte degli altri clienti, per cui in genere viene utilizzato nelle quasi
totalità dei casi. Frutta e ortaggi possono dunque venire spostati, scelti, tastati con delicatezza
per saggiarne il grado di maturazione, ma non possono essere toccati esternamente con le
70
mani. Questo potrebbe sembrare un controsenso in quanto frutti come le mele esternamente
lucidate con della cera, risultano già manipolate (Stella 2010), mentre altre volte la parte
esterna come la buccia, spessa e dura, aiuta la conservazione e protezione dell’alimento. In
altri casi, come per cocomeri o banane dove la buccia non è commestibile, l’uso dei guanti
non viene richiesto. La modalità di scelta dunque si rifà ad alcuni criteri che sono
completamente differenti da quelli utilizzati generalmente per la scelta della stessa frutta o
verdura nel caso dovessimo trovarci in una condizione in cui il rapporto con questi non è
mediato, come davanti ad un albero in un campo. In un contesto di questo genere, oltre allo
sguardo, per scorgere il colore, come ad esempio il rosso di un pomodoro, dovremo tastarlo
per saggiarne la consistenza, annusarlo, e avvicinarlo alla bocca per assaggiarlo. Ci
avvicineremo maggiormente ad un alimento tramite i sensi che andremo ad utilizzare in una
sequenza particolare.
Immaginiamo di trovarci in un prato sconosciuto di un paese straniero. L’albero in questione
potrebbe ricordare molto bene un pero, ma non ne siamo completamente sicuri. Non
conosciamo questo tipo di varietà, ma la fame è molta e vorremmo proprio riuscire a
mangiarne i frutti. Tra i tanti presenti dunque ne sceglieremo uno, il più bello e invitante.
Questo verrà dapprima ispezionato attraverso la vista che ne scorgerà colore e gradevolezza,
poiché potremo subito notare se una pera è acerba, marcia, oppure bacata, per cui sarà inutile
procedere al passaggio successivo. La vista permette di mantenere una certa distanza che
garantisce una via di fuga nel caso in cui si avverta un pericolo per la nostra salute già molto
alto, come ad esempio la presenza di aghi o spine. Superato il primo “ostacolo si passa ad una
ispezione manuale che coinvolgerà il senso del tatto. Si tasterà dunque la pera, stabilendo un
contatto con ciò che vorremmo ingerire e se la consistenza sarà abbastanza convincente, tale
da non essere troppo dura per poter essere masticata, la si annusa. Annusando il frutto lo si
avvicinerà ancora di più al viso, la parte più delicata del nostro corpo, solitamente la prima
che viene protetta. Inoltre i profumi spesso si percepiscono solo riducendo sensibilmente la
distanza che intercorre tra la fonte di questi e il nostro organo recettivo. Infine si avrà il
passaggio finale ossia verrà introdotta una piccola parte dell’alimento, verrà assaporato
saggiandone consistenza e sapore. Quest'ultimo passaggio è il più intimo e attento in quanto
potrebbe compromettere la nostra salute e nel caso vi siano dubbi particolari l’alimento verrà
sputato e dunque la pera in questione non sarà consumata. La prova della verità consiste nel
confronto diretto tra l’aspetto esteriore dell’alimento e la sua interiorità, ciò che in bocca
sparisce e genera il sapore. Questo processo avviene quando il cibo a cui vogliamo attentare
non è “sicuro”, ossia non ci viene offerto da qualcuno che ha già affrontato i vari gradi di
71
avvicinamento sensoriale descritto come nel caso della vendita. In un supermercato i controlli
atti a garantire la totale salubrità dell’alimento sono già stati effettuati e al cliente sta soltanto
il compito di appropriarsi dei prodotti migliori. Come avviene dunque questa scelta, se
l’utilizzo di tutti i sensi coinvolti è impedito da norme igienico-sociali che ne ostacolano una
più accurata selezione?
1. Criteri utilizzati per l’acquisto di verdura al supermarket
GIOVANI M
GIOVANI F
ADULTI M
ADULTI F
ANZIANI M
ANZIANI F
TOT
LA TASTO 1
1
2
NON LA MANGIO 2
1
3
PROVENIENZA 2
1
3
FRESCHEZZA 1 3 2 2
5 13
DI STAGIONE 1 1 2 3 2 3 12
LA GUARDO 1 1
2
4
72
COLORE 1
1
SEMBRA BUONA 1 1
2
PREZZO
1
1
2
NON LA COMPRO (HO L'ORTO) 1 1 1 2 2 7
NON SONO ESPERTA, NON SO 1 1
1
3
NON MI PIACE QUELLA DEL SUPERMERCATO 1 1 1
3
BIOLOGICA
1
1
DIPENDE DA QUANTO SI CONSERVA
1
1
CHE SIA ITALIANA
1
1
NON LA COMPRO
1
1
QUELLA CHE CI DANNO 1
1
DI FACILE PREPARAZIONE 1
1
73
Da questo grafico si può notare che i criteri utilizzati per una scelta ottimale sono
decisamente numerosi, ma fra tutti spiccano due risposte più frequenti quali: “freschezza” e
“stagionalità”. Ho deciso di utilizzare l’espressione poco felice “la guardo” in quanto mi è
stata riportata esattamente in questo modo e soprattutto con lo stupore di chi non saprebbe
quale altro criterio utilizzare.
Poiché i criteri specifici sono numerosi, mi sembra più consono raggrupparli in aree
tematiche quali:
• TATTO: "la tasto".
• VISTA: comprende tutti i criteri che utilizzano preminentemente l'uso della vista
ossia: "la guardo", "sembra buona", colore, freschezza.
• CRITERI DI VENDITA: questa sezione comprende la provenienza, il prezzo,
l'italianità e il marchio biologico. Queste voci sono state raggruppate in quanto dipendenti
dalle scelta merceologiche del supermercato e riguardano una serie di informazioni “di
etichetta” che esulano dalla verdura in questione.
• NON LA COMPRO: "non la mangio", "ho l'orto", "non mi piace quella del
supermercato".
• STAGIONALITÀ
74
• ALTRO: "non so" , "dipende da quanto si conserva" , "quella che ci danno" , "di
facile preparazione", dipende dalle dimensioni della “confezione”.
Con la percentuale maggiore, la vista rimane il criterio più utilizzato per la scelta della
verdura seguito in ordine dalla stagionalità. Sulla seconda modalità di scelta mi soffermerò in
seguito, mentre, per quanto riguarda la vista, la divisione di questo campo risulta dunque
essere la seguente: freschezza, “la guardo”, colore, “sembra buona”.
75
La freschezza è il criterio più utilizzato e riunisce in sé gli altri criteri in quanto, per essere
fresca, la verdura deve avere un colore intenso e brillante, deve essere turgida e sembrare
buona da mangiare, traducibile dunque nell’espressione “da mangiare con gli occhi”. Tutto
ciò però rimanda al rapporto visivo che però spesso risulta ingannevole perché insufficiente:
“la frutta sembra bella, e poi non sa di niente”. Una prova per capire se alcuni tipi di verdura
sono freschi oppure sono stati trattati mi è stata insegnata da una ragazza: “prendi le verdure
col gambo lungo, come il sedano, le coste o anche la menta e li metti in un vaso con l’acqua
come se fossero dei fiori. Se sono freschi rinvengono subito, altrimenti non si riprendono
più!”. I vegetali che sono semplicemente stati raccolti e messi in vendita riacquisteranno
subito un certo turgore e dureranno molto a lungo, al contrario di quelli che avranno subito un
processo di lavorazione o congelamento. Questi metodi ne permetteranno la conservazione
soltanto grazie al frigorifero. Rimane il fatto che comunque la freschezza si rivelerà
solamente dopo l’acquisto.
I criteri di vendita si divideranno invece in: provenienza, prezzo, biologica, italiana.
76
Il prezzo ha il peso maggiore in quanto l’aumento del costo dei prodotti di origine vegetale
viene visto con sospetto. La verdura, in ambiente rurale, prima dell’urbanizzazione in un
clima di autosussistenza, era di gran lunga l’alimento più consumato. Mi è stato riportato che
ciò che è un dono della terra non dovrebbe essere venduto così a caro prezzo. Di ciò non ne
sono responsabili i coltivatori che fanno un lavoro duro oltre che sottopagato, ma delle
lavorazioni subite e degli intermediari commerciali. Certi alimenti infatti, se non sono di
stagione o provengono da paesi extra europei possono raggiungere la soglia di 4/5euro al
chilo. Un’altra teoria interessante sul rincaro della verdura invece mi è stata data da un
ragazzo: anche questo genere alimentare segue le leggi della domanda e dell’offerta. Se la
rarità della carne lo faceva percepire come bene di lusso, la maggiore richiesta di verdura
degli ultimi anni incentivata dal martellante slogan che ne raccomanda l’assunzione di
almeno cinque porzioni al giorno insieme alla sempre più remota possibilità di coltivarla
autonomamente portano ad un inevitabile innalzamento dei prezzi. “Adesso i fighetti
mangiano solo verdura”. L’immagine del grasso borghese opulento che animava le vignette
dei giornali dell’Ottocento è stato infatti sostituita da modelle anoressiche la cui imitazione
non sarebbe possibile se non con l’esclusivo consumo di verdure durante i pasti.
Per quanto riguarda la “provenienza”, questa è stata intesa in maniera differente a seconda
dell’intervistato, nascondendo svariate motivazioni. Un cliente spagnolo infatti ha detto di
preferire le arance provenienti dalla penisola iberica in quanto più vicine al suo gusto e a ciò
77
a cui è abituato. C’è invece chi sostiene che distanze maggiori ne compromettono il sapore in
quanto frutta e verdura devono essere raccolte molto prima del tempo per non arrivare già
compromesse a destinazione e che il trasporto aumenta l’inquinamento globale. C’è invece
chi mi ha parlato del rapporto tra paese di produzione e ortaggio in questione portando
l’esempio dei “tipici” peperoni invernali in quanto non potrebbero crescere che in serra e di
cui è meglio diffidare al contrario delle banane che è giusto che provengano da un paese
equatoriale. Pochi hanno menzionato prodotti biologici i quali perlopiù si trovano
confezionati (verdure di quarta gamma), mentre la provenienza italiana si rifà più a motivi
economici interni.
Il tatto invece è stato analizzato singolarmente pur restando inferiore al 3% del totale.
Tramite la consistenza infatti sarà più facile immaginare il sapore scegliendo il grado di
maturazione prediletto: “a me piacciono i pomodori un po’ indietro, quasi che sono ancora
verdi. Mio marito invece preferisce quelli che si spappolano in mano che neanche riesci a
tagliarli”. «Sono le diverse consistenze a modulare la qualità del gusto. Gli alimenti possono
essere molli o duri, appiccicosi o croccanti, cremosi o capaci di sciogliersi in bocca… Nella
vita quotidiana la consistenza degli alimenti è un dato essenziale per apprezzarli; a volte un
frutto lo si sceglie palpandolo» (Le Breton 2006 pp. 336 - 337). Secondo Leroi-Gourhan
inoltre «il gusto gastronomico è legato al sapore e alla consistenza, e a volte più alla seconda
che al primo. Alcuni popoli sviluppano l’una e l’altra tendenza e ciò può condurre a forme
molto singolari nella percezione del cibo» (Leroi-Gourhan 1994 p. 120). Nonostante ciò però
possiamo notare che il tatto non ha comunque riscosso particolare successo come criterio di
scelta, anche perché se tastata vivacemente la frutta potrebbe marcire prima e dunque recare
danno agli altri acquirenti. Infatti in prossimità del reparto ortofrutticolo di negozi e
supermercati sono spesso presenti alcuni cartelli che invita la gente a non esagerare.
C’è stata anche una parte di persone che mi ha confidato di non acquistare verdura al
supermercato in quanto: non piace come alimento, viene utilizzato principalmente l’orto di
casa oppure viene preferito il mercato o il fruttivendolo di fiducia spesso vicino a casa o al
posto di lavoro. Questa sezione sarà analizzata più approfonditamente nel quarto capitolo che
descrive le alternative di acquisto.
78
Con la voce altro sono stati indicati invece alcuni criteri che ritengo abbastanza singolari e
dunque poco frequenti oltre ad un più generale "non so". Questi sono nati dalle poche
specificazioni in merito alla domanda che lasciava una libera interpretazione dell’argomento
da affrontare. "Dipende da quanto si conserva" e "di facile preparazione" stanno ad indicare
la scelta della tipologia di verdura che nel primo caso può riferirsi all’insalata che ha un
rapido deperimento rispetto ad esempio alle patate. Mentre nel secondo l’insalata potrebbe
essere preferita a verdure come i carciofi che hanno bisogno di essere cotti e puliti. Per cui in
base alla dieta settimanale vengono scelte le verdure da acquistare. “Dipende dalle
dimensioni della confezione” indica una preferenza particolare per le verdure di quarta
gamma già tagliate e confezionate che restano comunque scomode se messe in vaschette
troppo grandi. Spesso sono le persone sole che dedicano il minore tempo possibile alla cucina
e che si avvalgono dell’acquisto di questi prodotti “già pronti”, per cui preferirebbero delle
porzioni più moderate. “Quella che ci danno” al mercato (per cui questa non verrà acquistata
al supermercato) invece sta ad indicare la verdura sfatta del mercato non più passibile di
vendita che viene regalata a chi ne richiede. Essa è particolarmente passa e gialla, per cui
difficile d mangiare cruda. Cotta invece acquista lo stesso sapore, non viene scelta, ma risulta
gratuita.
Come si è potuto dunque notare, la vista occupa il ruolo dominante anche perché oltre ad un
criterio specifico di scelta del singolo prodotto, essa si ricollega alla lettura delle informazioni
quali prezzo, provenienza o certificazioni e diviene l’unico senso utilizzato quando si decide
79
di mettere della frutta o della verdura nel proprio carrello.
2. La stagionalità al banco ortofrutticolo
Frutta e verdura sono componenti fondamentali della nostra dieta. Contengono acqua, fibre,
vitamine e minerali e tutti sappiamo quanto siano importanti per mantenere in salute il nostro
organismo. Svolgono una funzione antiossidante stimolando il sistema immunitario, motivo
per cui il consumo di cinque razioni di frutta o verdura, equivalenti circa a 600 grammi sono
una delle dieci raccomandazioni utili alla prevenzione dei tumori pubblicate dal Fondo
Mondiale per la Ricerca sul Cancro (WCRF) nel 2007 e sottolineato dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS). Non tutti i tipi di frutta e verdura però hanno le medesime
caratteristiche. Queste si possono riconoscere dal colore della parte commestibile, e
principalmente sono cinque: il verde, il giallo, l’arancione, il rosso e il viola. Il contenuto
delle sostanze fitochimiche nelle piante però è influenzato da diversi fattori quali la
stagionalità, le modalità di coltivazione, conservazione e le qualità del terreno. I lunghi tempi
di conservazione infatti, oltre che la cottura in molta acqua e per lungo tempo impoveriscono
queste fonti naturali di energia, come del resto la pelatura e la scottatura comunemente usate
per ridurre la carica microbica durante la lavorazione industriale (Stella 2010, p. 70). Il
metodo migliore per la lunga conservazione di questi alimenti è la surgelazione ,mentre
recentemente è stato introdotto sul mercato un sacchetto ermetico di plastica trasparente
saturo di anidride carbonica e azoto che mantiene un prodotto, come l’insalata già tagliata
(che appassirebbe nell’arco di un pomeriggi al massimo), ancora fresco per giorni e senza
necessità di un ulteriore lavaggio. Questo metodo di conservazione viene utilizzato
principalmente per ortaggi come insalate o carote e zucchine pronte per il consumo. Un
problema però è che l’alimento frammentato può perdere numerose sostanze nutritive oltre
che costare di più e marcire più velocemente rispetto al suo corrispettivo integro. Inoltre un
uomo da me intervistato ha parlato della sporcizia ancora presente all’interno di queste buste
poiché la terra di cui è naturalmente sporca l’insalata viene fissata alla foglia tramite
l’anidride carbonica e il prodotto, che si presenta così, bello alla vista, se lavato perderà
ancora terra e olio residuo. Importante è anche il terreno su cui avvengono le coltivazioni che
deve essere ricco di microorganismi e non impoverito dallo sfruttamento cosicché possa
permettere uno scambio continuo di nutrienti e sali minerali con le colture (Shiva 2000).
Innanzitutto la verdura, al supermercato, non si trova solo fresca e sciolta, ma col tempo ha
80
acquisito diverse tipologie di vendita. Oggigiorno questa è caratterizzata e distinta in ben
cinque gamme differenti che indicano il processo di lavorazione che queste hanno subito.
Essi possono distinguersi in ortaggi e verdure di:
• I GAMMA: fresche;
• II GAMMA: conservate sott'olio o sotto aceto;
• III GAMMA: surgelate;
• IV GAMMA: pulite, tagliate, confezionate in vaschette e pronti per il consumo;
• V GAMMA: semilavorate e già cotte.
Entrando nel supermercato, di norma, nel primo reparto troveremo solamente la prima
gamma, di seguito la quarta e infine la quinta. La seconda appartenente alle conserve si
troverà insieme a tutti i prodotti inscatolati all’interno degli scaffali, solitamente vicino al
tonno anch’esso conservato sott’olio, mentre la terza gamma riguarda le verdure surgelate
che si trovano nel banco freezer. Si noti che l’invenzione di più gamme di prodotti vegetali
sono da valutare cronologicamente con la diffusione di diversi metodi di conservazione. Una
signora moto anziana infatti mi parlava della casa in campagna con cui viveva con il marito e
i figli e poiché non sono stati in possesso di un congelatore fino agli inizi degli anni Ottanta
era solita utilizzare tutti gli ortaggi più piccoli cresciuti nel loro orto per le conserve sotto olio
e sotto aceto. La seconda gamma rappresenta tra tutti il metodo più antico per permettere la
conservazione di alcuni tipi di verdura, mentre l’avvento dei prodotti di terza gamma, ossia i
surgelati, in Italia risale alla diffusione dei supermercati, ma soprattutto dei congelatori
casalinghi che avvenne in maniera abbastanza estensiva alla fine degli anni Sessanta
(Scarpellini 2006). La quinta invece è di recentissima introduzione ed è assimilabile alla
quarta gamma con l’aggiunta della cottura e della lavorazione, come lo possono essere le
patate piccole già cotte o le carote cotte tagliate a rondelle e conservate sottovuoto.
Ovviamente, il prezzo è maggiore, fino a quattro o cinque volte quello di un ortaggio
tradizionale di prima gamma. Il servizio di lavaggio e confezionamento, rappresentano un
valore aggiunto che trasforma il prodotto da agricolo a industriale sotto tutti i punti di vista.
La crescita di ortaggi fuori stagione, in serra, comporta un maggiore uso di fitofarmaci e deve
essere portata avanti il più velocemente possibile, affinché il costo della sua produzione non
aumenti considerevolmente il prezzo di mercato che per colture non stagionali e a terra risulta
in ogni caso maggiorato. Inoltre non avverranno una serie di processi dovuti al naturale ciclo
81
di maturazione, motivo per cui frutta e verdura non di stagione risulterà essere “meno
saporita, più dura anche se a volte è anche più bella”. La bellezza degli ortaggi richiama
infatti il criterio della vista su tutti gli altri. Verranno infatti scelti gli ortaggi che sembrano
più belli, e vengono creati apposta in questo modo eliminandone ogni imperfezione.
“Sembrano di plastica” mi ha confidato un fruttivendolo parlando dei suoi bellissimi
peperoni coltivati in serra di cui però non aveva particolare fiducia.
Il periodo migliore per il consumo di vegetali sarebbe la maturazione completa che avviene
in diversi periodi dell’anno a seconda dell’ortaggio e della provenienza in quanto alcuni frutti
come ad esempio quelli tropicali vengono colti ancora acerbi per facilitarne il trasporto. La
frutta infatti continua a manifestare una certa attività vitale anche dopo la raccolta. È per
questo motivo che verrà colta prima della completa maturazione, conservata a temperatura ed
umidità costante e portata a completa maturazione poco prima dell’immissione in commercio
tramite gas etilene che accelera il processo di invecchiamento dei tessuti vegetali. Inoltre
l’aspetto lucido e il colore uniforme possono essere ottenuti non solo tramite un buon metodo
di coltivazione, ma tramite modalità artificiali. (Stella 2010, p. 73). Lo stesso fruttivendolo
mi parlava delle banane che quando vengono raccolte sono “più verdi dei cetrioli” in quanto
devono essere trasportate per nave e il tragitto dura parecchi giorni. “Le vere banane
dovrebbero essere trasportate in aereo per arrivare qui in tempo quando le cogli che sono
mature. Ma allora costerebbero 25€/Kg e non le comprerebbe più nessuno!”. Inoltre il
contenuto di nitriti e nitrati (tossici se in quantità elevate) dipendente da concimi e pesticidi
utilizzati, vengono neutralizzati tramite l’esposizione al sole poiché impiegati per la sintesi
delle proteine vegetali. Detto ciò risulta chiara l’importanza di consumare frutta e verdura di
stagione e che abbia percorso poca strada in quanto ciò che è di stagione in Italia non è detto
che lo sia in Olanda, a meno che non venga coltivato in serra. Quando una verdura non è di
stagione ha meno sapore, meno colore ed è anche più cara. Ho dunque verificato la
conoscenza della stagionalità di tre ortaggi (cipolle, asparagi e porri) particolari ed
emblematici per alcune caratteristiche territoriali.
La cipolla dorata, caratteristica del periodo estivo è una delle verdure che grazie alla dieta
mediterranea solitamente non manca mai nelle case italiane in quanto ingrediente
fondamentale per il soffritto del sugo per la pasta, oltre che ottima per zuppe e vellutate o
anche cruda, in insalata. Per cui, come invece è avvenuto spesso per i porri nessuno ha avuto
il coraggio di dirmi: “non ne faccio uso”, “non li gradisco” o “non li conosco”. La
stagionalità degli asparagi è invece tipica del periodo primaverile ed essendo molto diffusi
nella zona Prealpina nonché protagonisti di numerose sagre (le quali però non sempre si
82
svolgono durante il periodo di fioritura) dovrebbero essere meglio conosciuti e legati al
territorio e alla cultura locale. Infatti gli asparagi sono risultati essere i più conosciuti rispetto
ai porri che invece hanno avuto una media molto bassa. Questi ultimi, tipici del periodo
autunnale, sono stati comparati più volte alle cipolle per via del sapore ritenuto similare, per
cui alle volte le risposte stagionali di questi due ortaggi venivano anch’esse assimilate. I porri
sono un tipo di verdura a quanto pare sottovalutata e poco utilizzata o gradita. Mi è stato
infatti detto più volte (sempre quando la risposta sulla loro stagionalità veniva ignorata) “non
mi piacciono”, “ho l'orto, ma non li pianto più” e “noi non li comperiamo” mentre una
signora piuttosto anziana è stata l'unica a darmi indicazioni precise sulla loro coltivazione: “i
porri vengono buoni con la prima gelata – mi ha suggerito – io li colgo adesso che sono più
succosi e saporiti, come le verze”. La medesima notizia sulle verze mi era stata data anche da
un altro informatore che supera i sessanta anni di età, mentre per quanto riguarda i giovani
nessuno ha saputo fornirmi indicazioni specifiche riguardanti orto e ortaggi: mi trovavo
invariabilmente di fronte sguardi allibiti dopo aver posto la domanda (che ho dovuto spostare
alla fine del questionario per non demotivare i miei interlocutori trovatisi spesso in
difficoltà).
Contando che sia rispondere in maniera scorretta, sia ammettere la propria ignoranza
significa non conoscere la giusta risposta, la situazione forse potrebbe risultare più chiara in
questo modo:
83
CONOSCE QUANDO MATURANO…?
La parte BLU sta ad indicare la conoscenza della stagionalità della verdura in questione,
mentre quella ROSSA una mancata conoscenza. Dunque la conoscenza della stagionalità di
questi tipi di verdura risulta superiore al 50%, ma di un soffio solamente per quanto riguarda
gli asparagi grazie alle caratteristiche stagionali e territoriali di cui godono. Mentre per
quanto riguarda i porri siamo ancora molto distanti rispetto ad una via mediana che riguarda
le cipolle. Da questo possiamo chiaramente dedurre che il rapporto con la terra è ormai
notevolmente cambiato, tanto da non sapere quando andrebbero coltivate la maggior parte
delle verdure di cui ci nutriamo, anche perché è diventato ormai superfluo. Tutte le
merceologie sono presenti tutto l’anno grazie appunto alle coltivazioni in serra, senza
l’ausilio di terreno. Analizzando però il particolare risultato di questa domanda molto
specifica possiamo notare alcune differenze sostanziali tra le due fasce di età estreme, ossia
giovani e anziani per cui, la conoscenza dei processi stagionali dei primo risulta grandemente
inferiore a quella dei secondi, come si può ben notare dai seguenti grafici.
84
Come si può dunque notare, la conoscenza dei processi stagionali e la cura dell'orto interessa
prevalentemente una fascia di età più matura che però, a quanto pare non è riuscita a
tramandare il loro sapere appreso in gioventù. Come diceva Zonabend (1980), nella sua
ricerca svolta nel nord della Francia erano gli anziani che si dedicavano all'insegnamento
della cura dell'orto ai più giovani. Nella mia intervista infatti solo tre giovani hanno
dichiarato di avere l'orto e nessuno ha ammesso di curarsene: “se ne occupa mio padre, lui lo
sa quando crescono i porri!” ha detto una ragazza che comunque conosceva la stagionalità
delle altre due verdure. Questa domanda, che è l'unica richiedente delle conoscenze
specifiche che non si basa semplicemente sulla propria opinione o sulle proprie abitudini
alimentari. È stata infatti vista come una sorta di quiz a cui era importante rispondere
correttamente e per fare ciò sarebbe stato possibile, anzi doveroso, chiedere aiuto a terzi per
evitare brutte figure. Durante un’intervista svolta all'interno di un negozio di frutta e verdura,
il giovane commesso, figlio del proprietario, non aveva idea della stagionalità di nessuno dei
tre ortaggi nominatigli, ma mi ha fatto aspettare che il padre tornasse per potermi dare una
risposta più precisa. La risposta in realtà per quanto mi riguarda non è arrivata come speravo,
in quanto il proprietario mi ha riferito che escludendo il primaverile asparago, porri e cipolle
ci sono tutto l'anno. Ignorando le motivazioni che lo hanno spinto ad una risposta così
approssimativa, forse di natura commerciale, la situazione non mi è sembrata così differente
dalla completa estraneità agli eventi naturali che possono facilmente ritrovarsi nei commessi
dei supermercato in quanto non viene assunto personale con una formazione specifica in
merito. Una risposta di questo tipo mi è stata data anche da un paio di giovani che mi hanno
85
chiesto se esiste una stagione per le cipolle poiché sul banco del supermercato sono sempre
presenti.
Per quanto riguarda adulti e anziani invece, è stato molto più frequente che essi dichiarassero
di occuparsi dell’orto, manifestando anche alcune competenze a riguardo e una passione che
non ho mai notato in un interlocutore più giovane. Questo evidentemente non ne sente la
necessità, non ne ha il tempo o lo spazio, oppure una guida da seguire e da cui imparare. Il
problema infatti riscontrabile nel tramandare un determinato tipo di sapere legato alla terra e
alle stagioni è che risulta essere sempre differente. Presenta un numero talmente elevato di
variabili da tenere in considerazione per cui non è possibile una trattazione manualistica
sufficientemente esauriente soprattutto per quanto riguarda questa specifica area di sapere.
Zonabend (1980) ha a lungo parlato dell’importanza delle erbe selvatiche spontanee
indispensabili per l’alimentazione quotidiana a cui, fin da bambini si era abituati a prestare
attenzione. Questo tipo di piante che recentemente hanno riscontrato una nuova ondata di
successo vengono ora catalogate in diversi manuali acquistabili in ogni libreria per cercare di
recuperare questo antico sapere. (Forni 2012). Il problema, una volta acquistato il manuale
rimane quello della differenza che intercorre, tra un’immagine o un disegno che raffigura
un’erba e la sua manifestazione fisica che ricorda il rapporto platonico che un’idea
immutabile intrattiene con le proprie molteplici manifestazioni fenomeniche. La difficoltà di
riconoscimento infatti ne impedisce la conoscenza specifica e dunque l’impossibilità di
mantenere vivo questo sapere. Innanzitutto perché l’acquisizione di un sapere pratico, come
quello agricolo necessita l’utilizzo di tutti i sensi con cui toccare, assaporare, odorare e
immergersi in un mondo che al contrario non potrà dischiudersi. «I ricordi si aggrovigliano
intorno a odori e sapori differenti e una particolare vicinanza dell'uomo al territorio che
sapeva come gestirlo ed interpretarlo» (Di Pasquale 2009, p. 10). In epoca attuale invece la
vista è diventata, l’unico senso utilizzabile. Il senso preminente, quello che permette un
determinato tipo di conoscenza pur mantenendo un certo distacco prossemico da ciò che
viene osservato. Una sorta di “fobia del contatto”, caratteristica fondamentale della civiltà
contemporanea che ha influenzato una serie di rigide norme di etichetta che la regolano. (Le
Breton 2007, p. 78)
86
Vale la pena notare due elementi che sono emersi riguardo alla stagionalità intesa come
criterio discriminante per l’acquisto di verdura. La prima è che la maggior parte delle persone
che hanno indicato la stagionalità come primo criterio di scelta molto spesso non hanno
saputo dare una risposta corretta a questo quesito il che però non significa necessariamente
che non viene utilizzato questo criterio di acquisto. Sono stati infatti sviluppati diversi metodi
di riconoscimento. Quando furono aperti i primi supermercati in effetti la verdura proposta,
seppur sotto plastica era solo quella di stagione con l’aggiunta di qualche nuovo frutto esotico
che oggi invece occupa sempre maggiore spazio sugli scaffali. Una metodologia utilizzata
oggi per acquistare il tipo di verdura di stagione sta nel controllare a casa il calendario o il
poster in cui è segnalata le stagionalità e decidere preventivamente quale tipologia comprare.
Mentre quella più utilizzata sta nel riconoscere la verdura in offerta che non è stata ribassata
perché scadente o troppo matura, bensì quella migliore, ma più economica perché di stagione
e dunque prodotta in maggiori quantità. Il che risponde, oltre ad un criterio di migliore qualità
anche a quello economico. La stagionalità della verdura non è conosciuta a priori, ma viene
riconosciuta all’interno del supermercato individuando appunto il prezzo più basso della
verdura che sembra migliore. Per cui non sarebbe corretto parlare di ignoranza, ma di utilizzo
di una metodologia di riconoscimento più consueta ad un panorama urbano.
3. Modalità di scelta di un prodotto confezionato
In ogni supermercato sono presenti una buona parte di cibi confezionati ed inscatolati, il
87
cosiddetto scatolame. Questi alimenti nella maggior parte dei casi non sono freschi e
differiscono da quelli confezionati direttamente dal supermercato che non hanno una marca
commerciale apposta sulla confezione, ma solamente una data di confezionamento. Questi
prodotti comprendono pasta, biscotti, patatine, cereali o , negli scaffali frigoriferi, formaggi,
come mozzarella e ricotta, oppure yogurt o affettati. Costituiscono la quasi totalità della
scelta alimentare presente in questo luogo: «è noto come i supermercati abbiano contribuito
alla diffusione di cibi preconfezionati, inscatolati e surgelati, sostenendo anche l’evoluzione
in campo alimentare da prodotti anonimi e sfusi a prodotti industriali di marca, imposti da
una vivace pubblicità» (Scarpellini 2001, p. 115).
La scelta alimentare della maggior parte degli avventori andrà a cadere almeno su alcuni di
questi prodotti di cui tendenzialmente non si ha alcuna informazione se non quelle riportate
in confezione. Non utilizzando la vendita diretta in cui i produttori possono fornire
informazioni dettagliate su materie prime, tecniche di produzione e lavorazione, tali
informazioni vengono fornite direttamente dal prodotto stesso tramite il suo involucro. La
vendita diretta è possibile solo per piccole produzioni, come il movimento “Genuino
Clandestino” che sta prendendo piede nei mercati cittadini italiani e incompatibile con la
scala di rifornimento richiesta dai supermercati. Questi hanno bisogno di grandi quantità di
prodotti che si presentano da soli per tagliare i costi di personale e garantire prezzi più
agevoli. Insieme ai surgelati e alla diffusione delle marche commerciali infatti, i prezzi bassi
del supermercato, sono uno degli elementi che hanno portato ad un cambiamento delle
abitudini alimentari nella rivoluzione avvenuta con la grande distribuzione organizzata. Essa
avrà origine grazie ad una differente modalità di scelta del prodotto. La sovrabbondanza di
merceologie a basso prezzo rende la scelta degli alimenti ancora più difficile in quanto viene
meno l’acquisto di cibo per necessità, sostituito da ciò che Ivan Illich (Illich 2009) definisce
“bisogno”. Se ancora nella seconda metà dell’Ottocento, come analizzato da Corner (1993),
la spesa alimentare copriva quasi il 90% del totale delle spese mensili, oggi questa si è
pressoché dimezzata (Scarpellini 2007). Una così forte predominanza della spesa alimentare
sul bilancio familiare porterà senza dubbio ad acquisti più specifici ed oculati e ad uno spreco
di risorse inesistente (Zonabend 1980). La grande sovrabbondanza di merceologie a basso
prezzo e l’aumento della disponibilità monetaria hanno trasformato dunque la modalità di
acquisto introducendo nuovi generi alimentari nella dieta quotidiana. La possibilità di variare
gli acquisti grazie anche ad una più ampia scelta di prodotti e alla specificità dei target cui
sono indirizzati ha stimolato in maniera ancora maggiore la variabilità dell’offerta. Tant’è che
oggi troviamo il medesimo articolo sotto forma di un numero spropositato di marche
88
commerciali.
La meccanizzazione di processi di trasformazione del cibo ha portato alla diffusione in serie
di prodotti che possiedono, o quantomeno che dovrebbero possedere le medesime
caratteristiche, manifestate dalle confezioni identiche del medesimo prodotto. Il modo
migliore per esprimere il concetto sta però nell’affidarsi alla pop art. Questa corrente nacque
all'inizio degli anni Sessanta e si diffuse nel panorama occidentale in particolar modo negli
USA rivolgendo la propria attenzione agli oggetti e al linguaggio della società dei consumi in
cui l'appellativo popolare: "pop" deriva dal concetto di arte di massa, cioè prodotta in serie.
Poiché la massa non ha un volto specifico, l'arte che la esprime deve trasmettere un senso di
perdita di identità espresso emblematicamente dalle confezioni identiche affiancate sugli
scaffali dei supermercati. In un mondo dominato dal consumo, la pop art rivolge uno sguardo
al mondo esteriore ed in particolar modo al complesso di stimoli visivi che circondano l'uomo
contemporaneo: il cosiddetto "folclore urbano", servendosi dunque di fumetti e pubblicità
nati appunto in quel periodo come forme di comunicazione di massa. A questa omologazione
dei prodotti servirà dunque una presentazione omologata. Per districarsi in questo mare di
confezioni di plastica di latta o di cartone, in cui il contenuto viene rigorosamente celato sono
state introdotte alcune normative che disciplinano le informazioni che devono essere
esplicitate per facilitarne la scelta e renderla più consapevole.
Il problema maggiore, ora, agli occhi del consumatore, sta dunque nella scelta, oltre che dei
generi alimentari in sé, proprio tra le varie marche commerciali proposte, tutte affiancate,
spesso con variazioni minime di prezzo o di ingredienti. In base a quali criteri dunque si
predilige un prodotto rispetto ad un altro molto similare? In particolar modo, la scelta diviene
ancora più impegnativa nel caso in cui il prodotto non è visibile dalla confezione come
avviene abbastanza spesso, e dunque l’unica informazione che abbiamo su di esso sta nel suo
involucro. Nella mia ricerca ho indagato i vari criteri di utilizzati per districarsi in questo
campo.
I criteri in questione, sono:
89
GIOVANI
M GIOVANI
F ADULTI
M ADULTI
F ANZIANI
M ANZIANI
F TOT
IL PIÙ COSTOSO 1 1 GIÀ PROVATO 2 2 1 3 1 9 PREZZO 2 3 2 1 2 10 COLORE DELL A CONFEZIONE 2 2
SCADENZA LONTANA 1 2 1 2 3 9
INGREDIENTI 1 2 1 5 2 2 13 PROVENIENZA 2 1 1 4 MARCA 3 3 1 1 2 4 14 GRAFICA DELLA CONFEZIONE 1 1 2
TABELLA NUTRIZIONALE 1 2 3 DATA RAVVICINATA DI PRODUZIONE 1 1 2
CURIOSITÀ 1 1 1 3 PUBBLICITÀ 1 1 2 SCADENZA RAVVICINATA 1 1 NON LO COMPRO 1 1 2 1 3 8 POCHI CONSERVANTI 1 1
90
BIOLOGICO 1 1 DIMENSIONI CONFEZIONE 2 2 COSA C'È SCRITTO 1 2 3 NON LO SO 1 1 L'IMMAGINE 1 1 QUALITÀ 1 1
La marca commerciale si riconferma dunque come criterio di scelta primario soprattutto per
giovani e anziani. I giovani infatti danno molta importanza a questo fattore, congiunto al
prezzo, mentre per gli anziani è preferibile la scadenza maggiormente dilatata nel tempo. Gli
adulti invece, in particolar modo le donne, preferiscono prestare maggiore attenzione agli
ingredienti, forse perché più avvezze al mondo della cucina e forse disilluse da tutto ciò che
non riguarda la qualità del prodotto.
Alcuni di questi item, sono raggruppabili sotto un unico criterio di scelta. In questo modo ho
deciso di riassumerli secondo lo schema seguente per una visione globale.
PACKAGING: colore, grafica, pubblicità, cosa c'è scritto, marca. Questa suddivisione è
caratterizzata dalla enfasi sulla commercializzazione piuttosto che sul prodotto.
ETICHETTA: ingredienti, provenienza, tabella nutrizionale, data di produzione, presenza di
conservanti, scadenza, dimensioni confezione. Questo raggruppamento si distingue per
un'attenzione alle caratteristiche merceologiche.
ALTRO: biologico, il più costoso, qualità, non lo so. In quanto questi criteri mi sono stati
menzionati un’unica volta.
Sarà dunque possibile riformulare lo schema nel modo seguente:
91
4. L’etichetta Come primo criterio di valutazione per la scelta di un prodotto avremo dunque l’
“ETICHETTA”. La prima direttiva che regolamentava uniformemente informazioni,
presentazione e pubblicità presenti sulle confezioni dei prodotti alimentari in Europa è la dir.
79/112/CEE26. Il nuovo regolamento UE27 sull’informazione al consumatore relativa al
26 Direttiva consolidata in dir. 2000/13/CEE e successive, da ultimo dir. 2008/5/CEE (recepite in Italia con d.lgs. 27.1.92 n. 109 e seguenti modifiche) 27 REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25
92
prodotti alimentari del 25 ottobre 2011 non si discosta in maniera sostanziale introducendo
solo alcune novità da applicarsi dopo tre anni dalla sua entrata in vigore. Il testo vuole portare
una semplificazione normativa che detti alcune regole di omologazione all’interno
dell’unione che si estendano alla “protezione della salute e degli interessi dei consumatori”
(art. 3.1). Un punto importante riguardante questa normativa sarà volto a chiarire i margini di
responsabilità degli operatori economici sulle informazioni pubblicitarie.
Un’etichetta dovrebbe contenere alcuni requisiti essenziali quali:
• elenco degli ingredienti in ordine decrescente;
• il peso netto e se presente un liquido di conservazione
• la data di scadenza o il termine minimo di conservazione (TMC) ossia l’indicazione
“da consumarsi preferibilmente entro…”;
• la denominazione di vendita (nome con cui il prodotto è presentato al cliente)
accompagnato dalle condizioni fisiche o trattamento subito dal prodotto: (scongelato,
ingrediente sostitutivo, carne o pesce “ricomposti”, acqua aggiunta a carne o pesce,
involucro non edibile per gli insaccati, qualora non lo sia;) N.I.28
• la ragione sociale, sede della ditta produttrice e dello stabilimento di produzione e
confezionamento;
• modalità specifiche di conservazione;
• titolo alcolometrico se presente;
• luogo d’origine o provenienza e se il prodotto ha una denominazione d’origine (DOP,
DOC, IGP…) oppure se c’è il rischio che il consumatore sia tratto in inganno nel caso
in cui manchi;
• data del primo congelamento (per carni o preparazioni di carni e prodotti ittici non
lavorati) N.I.
• presenza di allergeni N.I.
• lotto di produzione.
(Stella 2010, cfr., Dongo 2012)
Ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n.1924/2006 e (CE) n.1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il Regolamento (CE) n.608/2004 della Commissione http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:IT:PDF (Data di accesso 10/02/2012). 28 N.I. è una sigla che si riferisce alla “Nuova Introduzione” di questo tipo di informazione in base al nuovo regolamento in materia di etichettature alimentari.
93
Tutte queste informazioni devono comunque sottostare al criterio di leggibilità che è stato
nuovamente modificato inserendo il carattere minimo utilizzabile seguito da una serie di
indicazioni cromatiche che rendono le informazioni visibili, soprattutto per le piccole
confezioni. Un’importante introduzione dovuta alla nuova riforma è stata l’obbligatorietà
della dichiarazione riguardante la presenza di possibili allergeni secondo la direttiva
europea29 che stima come i soggetti intolleranti si aggirino intorno al 3-4% della popolazione
adulta e il 7-8% dei bambini. Anche la tabella nutrizionale con la composizione dell’alimento
in principi nutritivi e l’apporto calorico è stata resa obbligatoria dalla nuova normativa per un
migliore controllo della propria dieta ed un caldo invito a diminuire la presenza di grassi
nell’alimentazione quotidiana che oltre ad appesantire l’organismo iniziano anche a pesare
sul sistema sanitario nazionale a causa delle malattie a cui l’obesità è connessa. Nonostante
queste informazioni siano ormai rese obbligatorie non tutte vengono prese in considerazione
allo stesso modo dal consumatore.
Come prima informazione letta tra tutte le scritte e sigle presenti sulla confezione sono però
gli ingredienti apposti in ordine decrescente in base alla quantità di quella specifica materia
prima presente: “guardo gli ingredienti, se ci sono conservanti o grassi idrogenati” , “guardo
29 Dir. 2003/89/CEE e successive modifiche.
94
se ci sono molti conservanti, ma di solito sono abitudinaria”. Gli ingredienti principalmente
sono controllati per valutare la dose di conservanti e coloranti presenti, la percentuale di
grassi oppure la quantità di materia prima presente, come ad esempio nelle marmellate
“bisogna guardare se il primo ingrediente è lo zucchero oppure la frutta e bisogna preferire
le seconde”. Anche la data di scadenza ravvicinata è un metodo utilizzato da una signora
ucraina per controllare la presenza di conservanti: “non prendo cose con la data di scadenza
troppo lontana perché sono piene di conservanti” oppure viene valutata la freschezza del
prodotto a partire dalla data di produzione: “se sono stati prodotti da poco è meglio perché
sono più freschi”, oppure c’è anche chi, semplificando, guarda se sono presenti “troppe sigle
con lettere e numeri che non capisco; preferisco mangiare solo quello che riconosco come
alimento”. La data di scadenza, molto più frequentemente però verrà valutata in maniera
opposta, ossia non come indicatore per la quantità di conservanti presenti, ma nel momento in
cui questa si trova il più possibile distante dalla data di acquisto per una maggiore comodità e
la possibilità di tenerla nella dispensa-frigo il più a lungo possibile: “la scadenza più lontana
è più comoda”.
Anche la provenienza specifica di una determinata area geografica risulta importante per
alcuni prodotti: “guardo la provenienza in base al prodotto, come la mozzarella, preferisco
prendere quella della Campania piuttosto che del Belgio”. Questo in quanto la provenienza
italiana relativa ad alcune marche o prodotti specifici come la pasta viene data per scontata, e
lo stabile di confezionamento può trarre in inganno. Con la nuova normativa invece dovrà
essere citata anche l’origine o la provenienza dell’ingrediente primario se questo non
coinciderà con l’origine del prodotto. Questa diverrà una importante distinzione per evitare di
trarre in inganno i consumatori più attenti. Spesso invece l’accostamento marca italiana-
materia prima italiana è fin troppo scontato e continuerà probabilmente a confondere buona
parte dei consumatori. La provenienza italiana degli alimenti in particolar modo per quanto
riguarda i prodotti freschi risulta infatti fondamentale per l’83% degli intervistati. Questa
specifica introduzione è nata per contrastare il fenomeno del cosiddetto italian sounding,
ossia della presentazione di prodotto “made in Italy” solo grazie all’evocazione di simboli o
immagini nonostante siano stati prodotti altrove (Dongo 2012).
La tabella nutrizionale invece è stata presa in considerazione veramente poco, è stata
menzionata tramite il nome specifico una sola volta da una ragazza: l’apporto calorico degli
alimenti è qualcosa che viene completamente ignorato. C’è infatti chi ha detto che “le calorie
non si vedono”, oppure che non sono necessarie per sapere che un alimento fa bene, come la
verdura al contrario del cioccolato. Particolare invece è stata l’attenzione specifica per questo
95
tipo di informazioni nel nuovo regolamento. Queste scelte sono state fatte per fornire alla
popolazione una più corretta informazione che potrà portare ad una dieta più sana ed
equilibrata indicando anche in caratteri “semplici” e colorati il GDA ossia il Guideline Daily
Amount relativa ad una porzione di prodotto stabilita sulla base dei parametri definiti da
Eurodiet e convalidati dall’Efsa30.
5. Il packaging
La confezione risulta determinante nella scelta d’acquisto non solo per quanto riguarda le
informazioni relative al prodotto alimentare in sé, ma che sono semplicemente utili a
catturare l’attenzione per far sì che un prodotto venga acquistato. È importante come questo
debba catturare l’attenzione e far parte di quelli che Eminente (1991) considera gli acquisti
d’impulso, che nascono nel momento stesso in cui il cliente nota il prodotto. Secondo alcune
ricerche infatti pare che l’occhio della donna sia «attratto immediatamente dai prodotti
contenuti in involucri rossi, mentre lo sguardo dell’uomo sarebbe maggiormente attratto dal
colore blu» (Eminente 1991, p. 33). Sebbene siano in buona parte meccanismi subliminali,
alcune persone mi hanno confermato di essere attratte dal colore o dalla combinazione di
30 European Food Safety Authority, Autorità europea per la sicurezza alimentare. Reg (CE) n. 178/02.
96
colori presenti sulle confezioni, dalla grafica e dalle immagini a scopo dimostrativo (che
solitamente rimangono ben distanti dal contenuto stesso della confezione). La pubblicità
invece non è presente sulla confezione, ma si rifà ad una politica commerciale ben definita.
Resta però uno stimolo esterno che non ha nulla a che vedere con le qualità specifiche del
prodotto. Il modello persuasivo utilizzato è occulto, anche se attualmente il suo intento risulta
palese. Con “quello che c’è scritto” sulla confezione viene intesa una breve descrizione
dell’alimento in termini di qualità e possibile utilizzo specifico, che risulta come un piccolo
riassunto ben romanzato di tutte le caratteristiche nutrizionali e commerciali vincenti. Un
uomo infatti, mostrandomi una confezione di fette biscottate mi ha confessato di averle
acquistate in quanto sulla confezione era scritto che sarebbero state un ottimo sostituto del
pane. La grandezza della confezione inoltre è una scelta commerciale dovuta alla
parcellizzazione per fasce di destinazione che possono offrire confezioni “gran risparmio” per
famiglie numerose: “prendo le confezioni risparmio che spendo meno e ce n’è di più perché
abito lontano dal supermercato e devo fare la scorta”. Confezioni più piccole invece stanno
prendendo piede soprattutto per i prodotti che hanno una data di scadenza ravvicinata adatte a
persone che vivono in nuclei familiari più piccoli: “scelgo le confezioni piccole di pasta
fresca o ravioli perché sono da solo. Se le compro più grandi è vero che costano meno, ma la
metà la devo buttare…”
Infine la marca commerciale è stata il criterio più menzionato singolarmente. Non si rifà
sempre al binomio marchio – fiducia, che in taluni casi è presente: “scelgo la marca, mi fido
molto”, ma in altri invece: “parto prevenuto o no a volte, dipende dal marchio e dalle
informazioni che ho sulla politica aziendale” , oppure “controllo sempre se un prodotto è
della Nestlé. In tal caso non lo compro!” Un’altra differenziazione specifica riguarda le
marche di prodotti biologici, ancora non così tanto presenti nei supermercati convenzionali e
ancora meno nei discount. Se l’orientamento personale seguirà quella direzione si cercherà di
preferire marche che trattano alimenti biologici scegliendo magari l’unica disponibile relativa
a un determinato prodotto la cui variante non biologica è presente in quantità molto più
elevate. «La produzione di massa a livello nazionale determinò per la prima volta la
comparsa di marche che, contrariamente ai prodotti generici, erano in grado di fornire
preventivamente, ai consumatori, informazioni specifiche sulle caratteristiche dell’oggetto e
sul produttore. Le prime aziende a conquistare rilevanti posizioni di mercato acquistarono
vantaggi tali da mantenere per decenni la leadership del settore utilizzando in maniera
aggressiva la pubblicità e esercitando un ruolo attivo per un’ulteriore espansione»
(Scarpellini 2001, p. 123). La parola “marca” deriva dal germanico marka, che significa
97
segno di confine, marcatura. È un segno che indica appartenenza. La marca non è né un
soggetto fisico né una persona giuridica, bensì una società che trae la sua esistenza proprio
dalla marchiatura delle merci e dall’attività di comunicazione che ne consegue. Ecco perché
merci e marche nel mondo contemporaneo sono così legate. Inoltre non vi è marca senza
comunicazione ed in particolar modo senza pubblicità, infatti nonostante ogni prodotto
confezionato abbia una propria marca di riconoscimento, solo quelle che hanno lavorato
molto nell’ambito pubblicitario risultano note, nonché passibili di tale nominativo. Per
modificare radicalmente il valore economico della merce risulta fondamentale utilizzare il
valore simbolico che la marchiatura le mette a disposizione. Tale dispositivo sarà fiorente
finché il consumatore privilegerà questi valori alla mera utilità pratica che nel caso alimentare
si riferisce alla qualità del prodotto, come chi pensa che: “se è di una grande marca è
migliore. Penso…” Spesso si parla di marca come di mondo possibile, attribuendo ad essa
funzioni che sono state spesso esercitate dalla letteratura dalla religione dalla politica: infatti
quando la pasta Barilla parla di casa oppure quando la Coca Cola parla di pace e amicizia
esse non esplicano una qualità del loro prodotto né un possibile uso.
La pubblicità di una marca può così essere considerata come un sistema confermativo che
detta i valori presenti all’interno della società occidentale contemporanea, rinforzandone allo
stesso tempo la loro credenza. È un costo aggiuntivo che viene scaricato sul prodotto. I
commenti a questo riguardo infatti sono stati: “fanno solo aumentare i prezzi, anche se le
cose sono prodotte qui dietro”, oppure “il 50% è per gli ingredienti l’altro 50% per il
marchio che ci mettono su”. La diffusione che ne consegue determina la notorietà di un
prodotto e risulta inoltre una “garanzia di sicurezza” in quanto anche altri hanno compiuto la
medesima scelta, infatti: “preferisco se qualcosa è prodotto in grandi quantità”, “penso che
ci sia un motivo se sono così famosi”.
L'ultima motivazione per cui è “bene” fidarsi di una marca è perché essa aiuta ad accettare il
contratto fiduciario implicito che un acquirente sottoscriva in sede di acquisto. Infatti, nel
caso in cui si conosce l’autore o l’origine di un prodotto si sarà più facilmente portati alla
fiducia. Secondo Augé lo straniero smarrito in un paese che non conosce troverà particolare
rassicurazione nell’incontrare qualcosa di conosciuto. «L’insegna di una marca di benzina
costituisce per lui un punto di riferimento rassicurante ed è con sollievo che ritrova sugli
scaffali del supermercato i prodotti sanitari e alimentari, o i casalinghi consacrati dalle
marche multinazionali» (Augé 2002 p. 96).
Nonostante tutte queste caratteristiche però la fiducia nelle grandi marche, come sinonimo di
garanzia comincia a vacillare, anche se rimane il criterio singolare di scelta più utilizzato.
98
Oggi il consumatore si sente sommerso da una quantità di marche commerciali da cui, più
che fidarsi, è bene difendersi.
I commenti positivi all’interno del 38% degli intervistati che dichiarano di fidarsi della marca
restano comunque pochi: “sì, ho sempre preso cose di grandi marche”, “sono più garantite” ,
“dove c’è Barilla c’è casa”. Il clima di sfiducia che in realtà si traduce meglio con una sorta
di scetticismo diffuso per quanto riguarda il settore alimentare invece è dilagante. Si rifà al
settore biologico, alle nuove biotecnologie, ai metodi di allevamento, e in particolar modo al
settore commerciale e distributivo che per massimizzare il profitto nasconde una buona parte
delle magagne rispetto alla qualità dei prodotti offerti. C’è chi pensa infatti che “le grandi
marche non ti dicono davvero come funzionano le cose” e che “sono le prime che si
approfittano della fiducia dei consumatori”, “non so quanto credere a certe cose”, “sono
tutte una fregatura” fino ad arrivare ai più pessimisti che temono un avvelenamento. La
percentuale degli adulti che si fida della marca ritenendola un sinonimo di garanzia è molto
più bassa rispetto alle altre due fasce di età. Le persone adulte, spesso attente all’economia
familiare e all’alimentazione dei figli piccoli cercano di puntare alla qualità degli ingredienti.
99
L’insorgere di nuove marche commerciali poco conosciute e meno pubblicizzate invece
comincia a riscuotere maggiore successo riscontrabile nelle parole: “alle volte alcune marche
del discount sono più buone di una marca conosciuta” , “le grandi marche non sono buone”,
“alcune marche minori sono più buone e costano meno”. Fiducia accordata ovviamente solo
dopo aver assaggiato il prodotto. E stato scritto anche un libro in merito, Discount or die
(Brignani 2011), nato da un blog di recensioni riguardanti i prodotti del discount, molto
economici, ma buoni come quelli più costosi.
6. Diversi criteri per diverse situazioni
Il prezzo (11%) è sicuramente una discriminante molto importante e spesso, nonostante non
sia il principale criterio di scelta rimane determinante per far pendere l’ago della bilancia
verso un prodotto. Prezzo significa più semplicemente prezzo inferiore, per sottostare al
criterio della parsimonia utilizzato in numerose varietà di acquisti secondo Miller (1998). La
politica del prezzo più basso infatti è stata adottata come componente fondamentale per la
scelta di una spesa al supermercato rispetto a quella negli empori o nei negozi specializzati, e
la nascita di numerosi discount specialmente negli ultimi anni ne è una prova. Il supermercato
tradizionale tenderà così ad abbassare ulteriormente i prezzi dei prodotti per rimanere
all’interno di un regime concorrenziale. Sta nascendo anche in Italia infatti, da non più di tre
anni a questa parte, una categoria di prodotti ancora più economici rispetto al tradizionale
marchio del supermercato che già doveva ricoprire il ruolo del prodotto meno caro del
settore. Questi marchi, come può essere ad esempio un prodotto Carrefour rispetto a quello
100
denominato “Carrefour discount”, sono caratterizzati da una totale mancanza di colori e
grafica sulla confezione che spesso si rivela bianca oppure trasparente per poter risparmiare
anche sotto questo aspetto o per dare voce pubblicitaria a quella fetta di consumatori
sovraccarichi di pubblicità. Abbassando ulteriormente il prezzo del prodotto della marca
classica del supermercato, per renderla più concorrenziale, il cliente avrebbe potuto sentirsi
truffato dal costo maggiore propostogli in precedenza. Queste nuove linee di prodotti portano
con sé due effetti benefici al supermercato che le offre. Viene ampliata l’offerta di prodotti
con il marchio del supermercato (sia discount che tradizionale) sottraendo inevitabilmente
spazio ad altri prodotti e rendendo più facile che la scelta ricada su almeno uno di essi. Inoltre
fa assurgere a livello di una marca commercialmente nota quella del supermercato
tradizionale non ponendola più sullo stesso piano dei prodotti più economici, ma lasciandole
comunque un prezzo abbastanza concorrenziale. Spesso però le due marche sono prodotte
nello stesso stabilimento, il che rende dubbia la differenza specifica a livello qualitativo.
Questa rimane comunque una domanda aperta anche per quanto riguarda il confronto tra altre
marche più note. C’è chi dice infatti: “risparmio sul prezzo perché alla fine sono fatti tutti
allo stesso modo” , oppure anche chi dice che “non cambio tanto, prendo sempre quello se mi
piace”.
Il 9% degli intervistati ha invece dichiarato di non voler comprare prodotti completamente
coperti dalla confezione che ne impedisce la visione (“se non vedo non compro”), ovvero
rifiutano in blocco tutto lo scatolame se non è trasparente almeno in parte. La vista infatti è
uno dei criteri di scelta maggiormente utilizzati per quanto riguarda la scelta delle verdure e
rimane un punto fondamentale per cercare di evitare troppe brutte sorprese una volta scartato
il prodotto: “compro poco confezionato, cerco di evitarlo. Preferisco non comprare quello
che non vedo” , “se non vedo cosa c’è dentro lo lascio lì”. Non è sempre vero però che una
confezione trasparente è anche sinonimo di trasparenza a proposito di ingredienti,
lavorazione e politica aziendale. Inoltre, per una migliore conservazione la luce non è sempre
particolarmente indicata, e spesso le confezioni più rigide e coprenti hanno i loro vantaggi in
termini di qualità. Il confezionamento svolge un ruolo importante, principalmente per quattro
aspetti:
• Contenimento: la necessità emerge soprattutto per quanto riguarda prodotti liquidi o in polvere;
• Conservazione: l'imballaggio protegge l'alimento da possibili contaminazioni e ne prolungala conservazione in condizioni ottimali;
101
• Commercializzazione: in quanto su di esso vengono stampate tutte le informazioni obbligatorie ed accessorie possibili;
• Trasporto: cosicché i prodotti finiti non subiscano danneggiamenti durante questa fase delicata.
Secondo il Regolamento europeo n. 1.935/2004 l'etichetta deve riportare che tipo di
imballaggio è stato utilizzato per proteggere l'alimento (Villarini 2011 p. 74).
Un altro criterio di valutazione che riguarda le caratteristiche sensoriali olfattive e gustative è
quello che riguarda la dicitura “già provato”(10%), ossia un alimento che è stato consigliato,
o ancora meglio si è già sperimentato di persona. “Mi fido del prodotto già acquistato, non mi
piacciono le cose nuove”. L'entrata di un nuovo prodotto nelle abitudini alimentari può
avvenire a casa di parenti e amici, oppure quando viene portato un dolce o un alimento
particolare per preparare una cena comune magari molto abbondante. Ciò che è già stato
provato risulta sicuro in termini di gradimento e non vi è il rischio di un acquisto impulsivo,
che andrà a prender muffa in fondo alla credenza una volta aperto e assaggiato. Rimane un
metodo molto sicuro in termini di gradimento, ma è anche vero che a volte non capita di
ritrovarsi in situazioni in cui è possibile un assaggio, ma si sentirà comunque l’esigenza di
variare acquistando qualcosa di nuovo, che in un supermercato non manca mai. La strategia
della promozione è molto utile per questo motivo: “uso le promozioni per variare un po’”.
Con questa strategia infatti vengono messi in offerta prodotti più costosi che normalmente
avrebbero delle difficoltà di vendita a prezzo pieno, oppure in scadenza, e vengono proposti
ad un prezzo ribassato. La speranza del supermercato sarebbe quella di fidelizzare il cliente
facendo sì che una volta assaggiato il prodotto lo acquisti anche a prezzo intero. La stessa
tecnica viene utilizzata anche dalle aziende produttrici in caso di lanci sul mercato di nuovi
prodotti che hanno bisogno di una categoria di persone che si fidelizzerà nell’acquisto
abbandonando un prodotto precedente. C’è però chi ritiene di non farsi ingannare da questi
“trucchi” acquistando i prodotti in offerta solo se realmente più economici di quelli
consumati abitualmente. Per operare questo tipo di scelte resta comunque necessaria un po’
di curiosità (“prendo quello che mi ispira di più”) da parte del consumatore e una buona
presentazione in sede di vendita. La curiosità occupa il 3% del ventaglio di risposte fornitemi.
Queste risposte invece mi sono state fornite una volta soltanto e sono state raggruppate sotto
la voce “altro”(5%). Riguardano l’acquisto di prodotti biologici che ha cominciato a suscitare
numerosi dubbi e sfiducia da parte di chi ha sentito parlare di frodi e di poca serietà del
settore. La qualità invece viene menzionata come criterio da seguire e varia da ciò che può
102
essere più costoso a ciò che lo può essere meno e riassume numerosi fattori quali gli
ingredienti oppure averlo già assaggiato. Il più costoso viene invece “preso” da un ragazzo, il
quale aveva dichiarato di far visita ai supermercati principalmente per rubare, per cui, la
scelta del prodotto ricade su un criterio di dimensione/prezzo. Viene scelto il più
maneggevole in termini di confezione in rapporto al prezzo più elevato. In caso di acquisto
vero e proprio invece la scelta ricadrà indubbiamente sul prodotto meno costoso, come il sale
grosso, oppure una bottiglia d’acqua. Prodotti “civetta” che vengono pagati a fronte di un
minore sospetto da parte dei commessi durante i giri di furto. Un’altra modalità d’”acquisto”
degna di nota invece è quella di mandare avanti qualche ragazzo con molti orecchini o
pettinature particolarmente vistose, vestiti sudici e un modo di fare sospettoso che attirerà
l’attenzione di commessi e clienti, lasciando gli altri liberi di riempirsi le tasche con maggiore
tranquillità. Questo racconto, singolo, su sessanta interviste, serve anche per mettere in luce
la diffidenza che viene rivolta verso particolari clienti che si abbigliano in maniera poco
convenzionale. Lo stesso atteggiamento rivolto agli immigrati all’interno delle piccole
botteghe agli inizi degli anni Sessanta, motivo per cui questi preferivano uno spazio più
moderno e informale come quello del supermercato (Scarpellini 2001). La stessa situazione
avviene oggi invece per quanto riguarda la differenziazione tra supermercati e discount.
Non lo so invece è stato risposto da un uomo anziano che porgendomi la lista della spesa fatta
dalla “signora moglie” ha ammesso di non sapere nulla riguardo ai vari prodotti che gli
vengono messi nel piatto. La scelta ricade sempre sulle medesime marche e confezioni che
vede in casa e che ormai ha imparato a riconoscere a suon di lamentele dicendo sconsolato:
“non lo so, io mangio e basta!”
7. Due ricette a confronto (1931) “PUREA DI PISELLI31”
Sgranate e lessate 1 chilo di piselli e passateli caldi al setaccio; rimettete il passato a fuoco
dolce con gr. 50 di burro, aggiungendo a poco a poco un bicchiere di latte caldo (o, meglio
ancora, di panna) sempre bene rimestando con la spatola di legno. Amalgamatevi infine un
cucchiaio di Sàpis32 ed una grossa noce di burro, aggiustate di sale e tenete in caldo a
bagnomaria fino al momento di servire, perché il riscaldamento diretto ne altererebbe il
31(1931) Casadoro. Piccolo consigliere della signora moderna, Omaggio della Compagnia Italiana Liebig, Milano p. 62. 32 Sàpis: estratto di carne e di vegetali della comp. italiana Liebig S. A. - Milano. L’ingrediente è stato aggiunto in quanto la ricetta deriva dal ricettario Casadoro distribuito gratuitamente dall’azienda Liebig.
103
sapore.
N.B. - Seguire lo stesso procedimento per le puree di lenti, spinaci, fagioli, ecc.
(2013) “CREMA CON PISELLI DOLCI BONTÀ DELL'ORTO33”
Minestra preparata disidratata. (una busta contiene100 g di polvere per tre porzioni di crema)
Ingredienti: Piselli (44%), olio e grassi vegetali, fiocchi di patate, amido di patata, sale da
cucina, lattosio, farina di grano tenero, proteine del latte, cipolla, zucchero, prezzemolo,
aromi. Può contenere tracce di uova e sedano.
COME PREPARARE UNA BUONA CREMA
1. Versa il contenuto della busta in 750 ml di acqua fredda (circa 3 bicchieri da cucina colmi).
Mescola con cura e porta a bollore.
2. Fai cuocere a fuoco lento per 3 minuti, mescolando di tanto in tanto.
Le due ricette, sono entrambe valide all’ottenimento di una vellutata di piselli, ma i
procedimenti sono decisamente differenti. In molte ricette contenute nel breviario della
casalinga degli anni Trenta, molti passaggi utili alla preparazione dei piatti vengono saltati,
come per preparare delle lasagne verdi in cui la ricetta inizia con un semplice “fate la pasta”.
“Fare la pasta” è un procedimento che oggi è diventato particolarmente complesso perché
spesso non si possiedono manualità e capacità che vengono sostituite da fogli di pasta, secca
già preparata. Tuttavia questo rimane un procedimento recuperabile in quanto chiunque
voglia preparare e mano della pasta con uova e farina potrà farlo tranquillamente. Inoltre le
dosi degli ingredienti saranno variabili e necessitano di un certo “occhio” come spiega mia
nonna tutte le volte che le chiedo una ricetta. La crema di piselli disidratata invece presenta
alcune caratteristiche particolari. Innanzitutto è venduta già divisa in buste su cui è
contrassegnato il numero delle porzioni. Le modalità di preparazione sono semplicissime e
spiegate dettagliatamente per evitare confusioni anche a chi non è pratico. Preparare questo
tipo di crema però non sarebbe stato possibile negli anni Trenta, e non lo sarebbe nemmeno
oggi senza l’ausilio di istruzioni molto precise contenenti quantità d’acqua da aggiungere e
tempo di cottura. Inoltre il sapore rimarrà il medesimo, sia che venga riscaldata a bagnomaria
o al microonde. Se infatti la polvere di cui è composto il preparato venisse ritrovata sfusa in
dispensa, in un barattolo, avremmo serie difficoltà a riconoscerlo come alimento e a capirne
l’utilizzo. Le istruzioni saranno, in questo caso, indispensabili per una corretta preparazione.
33 Busta di crema di piselli Knorr contenente 100 gr di polvere utile alla prepatazione di tre porzioni di crema.
104
Il rapporto con l’alimento non risulta più essere diretto, bensì mediato. Il contatto avviene
attraverso schermi, pellicole e istruzioni scritte. Non serve vedere e toccare la consistenza
della pasta per capire come preparare meglio le lasagne, serve saper leggere le istruzioni
mediante le quali, in solitaria, sarà possibile preparare qualsiasi piatto. Utilizzando questo
nuovo tipo di alimenti, la cui preparazione risulta essere lo svolgimento meccanico di
semplici istruzioni, sarà però necessario saperle leggere. In un paese straniero, in cui la
lingua, ci sarà completamente sconosciuta, avremo sicuramente un rapporto più agevole con
alimenti immediatamente ed istintivamente commestibili, dovendo lasciare da parte, almeno
inizialmente questi alimenti polverosi, a meno che non ci sia qualcuno che ci mostri il
procedimento utile a cucinarli.
105
CAPITOLO QUARTO
DIFFERENZE, PREFERENZE E PERCEZIONI DI PRODOTTI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI
Secondo lo studio da me condotto risulta che la percezione verso i prodotti alimentari
industriali gode di minore gradimento rispetto a quelli autoprodotti (un esempio può essere
quello di una marmellata preparata a casa) oppure rispetto ai prodotti di una piccola azienda
agricola del territorio (qui come esempio ho utilizzato un formaggio). L’indagine è stata
condotta secondo quattro criteri di scelta che sono rispettivamente: l’igiene dei prodotti
trasformati; i principi nutritivi in essi contenuti ossia quanto fanno bene e sono “salutari”;
quanto sono “buoni” e dunque rispecchiano il proprio gusto personale e quale si preferirebbe
mangiare nel caso in cui venissero offerti entrambi.
Le risposte date a questi item non necessitano di conoscenze particolari come quelle sula
stagionalità, ma si riferiscono al proprio gusto personale e mostrano delle tendenze sociali.
Secondo Bourdieu (1995) infatti i gusti sono delle vere e proprie pratiche culturali:
comportamenti che incorporano la cultura e la società, perché tramite essi si manifestano
valori etici e giudizi estetici sfatando il mito dell’individuo libero da condizionamenti. Per
quanto riguarda la questione di igiene e salute, molti mi hanno chiesto se le risposte fornitemi
fossero “giuste” per ricercare delle conferme dovute alla mancanza di informazioni chiare
disponibili. In realtà non è possibile confermare alcuna teoria in merito perché, anche da
quanto emerso, le differenze riguardano e i singoli prodotti per cui il livello di igiene di una
piccola azienda potrebbe essere superiore a quello di una grande industria o viceversa. Per
quanto riguarda le norme igienico-sanitarie da seguire invece, queste saranno le medesime
nel caso in cui i prodotti siano passibili di vendita. Per cui per quanto riguarda l’aspetto
legislativo, gli standard igienici sono i medesimi e dovrebbero dunque portare a medesimi
risultati. Per quanto riguarda invece una produzione casalinga come quella delle conserve
106
risulta chiaro che non verranno seguiti minuziosamente gli standard igienici industriali in
quanto non necessari perché il prodotto non sarà venduto, ma verranno seguiti quelli del
cosiddetto buonsenso. Per cui sarà possibile ottenere un prodotto migliore in quanto la cura
seguita nel procedimento potrà essere maggiore o minore a seconda dei casi. La mia indagine
risulta dunque volta ad indagare la percezione diffusa riguardante la produzione industriale e
le alternative come la piccola produzione o l’autoproduzione e le motivazioni per cui si
propende da un lato piuttosto che dall’altro.
Premesso questo i dati dimostrano una maggiore fiducia nella produzione non standardizzata
pur essendo quello igienico l’unico criterio in cui il prodotto industriale ha raccolto
abbastanza consensi. Dal 1° gennaio 2006, in materia d’igiene della produzione e delle
commercializzazione degli alimenti, sono entrati in applicazione i regolamenti attuativi
previsti dal Reg. (CE) 178/2002 (principi e requisiti generali della legislazione alimentare), in
particolare il Regolamento (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari. La legislazione
alimentare si occupa degli aspetti igienico-sanitari relativi all'alimento in tutte le fasi, ossia:
produzione, lavorazione, confezionamento, distribuzione, deposito, vendita,
somministrazione. Questo avviene attraverso l'analisi dei pericoli e dei punti critici del
sistema HACCP utilizzato come strumento di analisi e controllo delle condizioni di igiene e
sicurezza delle produzioni alimentari, la promozione e la divulgazione di manuali di buona
prassi igienica comunitari e nazionali (manuali GHP) e la consultazione, per un parere,
dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare nel caso l'applicazione del Regolamento
abbia un impatto significativo sulla salute pubblica34.
La novità sostanziale è che contrariamente alla vecchia normativa, il Regolamento (CE)
852/2004 interessa tutte le attività della filiera di produzione alimentare, di origine animale o
vegetale, compresa la produzione primaria35.
34 MINISTERO DELLA SALUTE: SEZIONE RIGUARDANTE L’IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI. http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/paginaMenuSicurezzaAlimentare.jsp?menu=igiene&lingua=italiano (Data di accesso: 01/03/2013). 35 I prodotti della produzione primaria sono "i prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia e della pesca”(Reg. 852/2004 art. 2, comma 2, lettera b). In particolare essi sono prodotti d'origine vegetale come cereali, frutta, ortaggi, erbe, funghi - prodotti d'origine animale, come uova, latte crudo, miele - prodotti della pesca, molluschi vivi e prodotti selvatici di origine animale o vegetale come funghi, bacche, lumache ecc. I prodotti della pesca rimangono prodotti primari anche dopo la macellazione, il dissanguamento, la decapitazione, l’eviscerazione, lo spinnamento, la refrigerazione e la collocazione in contenitori per il trasporto a livello di produzione primaria. I prodotti risultanti da un’ulteriore manipolazione dei prodotti della pesca (per es. filettatura, imballaggio sotto vuoto ecc.) non sono prodotti primari. La carne fresca non è un prodotto primario perché è ottenuta dopo la macellazione.
108
In questo caso i prodotti industriali godono della stessa fiducia di quelli prodotti in luoghi
differenti. Le opinioni espresse in merito restano molteplici.
Una donna che lavora in una stabilimento industriale in cui si producono generi alimentari è
fortemente convinta della mancanza di igiene peculiare delle grandi produzioni in quanto
nello stesso luogo, insieme agli alimenti, è presente un alto numero di lavoratori che, a volte,
non possono permettersi di stare a casa in malattia. Ella dunque preferisce la piccola
produzione o l’autoproduzione anche perché: “se nella marmellata ci finiscono dentro dei
germi, quantomeno sono i miei” . Mi è stato fatto notare che l’autoproduzione potrebbe
essere più igienica solo nel caso in cui questa sia fatta autonomamente o da persone fidate di
cui si conosce il livello di igiene personale che si potrà trasporre al prodotto lavorato. C’è chi
pensa che in una piccola azienda la cura sia maggiore e l’alimento più controllato perché
prodotto in minore quantità e con meno personale. Inoltre la cura messa nella lavorazione del
prodotto sarà differente rispetto ad una produzione anonima in cui la responsabilità non cadrà
direttamente sul singolo operaio della catena poco interessato alla qualità dell’amplissima
produzione. Differente è un proprietario, trasformatore e venditore che ha forte interesse a
rendere migliore il proprio prodotto per avere un riscontro nelle vendite e per esserne
orgoglioso.
I prodotti primari (inerenti alla produzione primaria, vedi nota) possono essere trasformati
nell'azienda agricola in altri prodotti trasformati. Queste operazioni non rientrano tra le
attività che costituiscono la produzione primaria e ad esse si applicano quindi le prescrizioni
di igiene alimentare previste dall'allegato II del regolamento (CE) 852/2004 (per quanto
riguarda i prodotti alimentari d'origine animale, si applicano anche le prescrizioni previste dal
regolamento (CE) n. 853/2004). Nel caso della produzione di formaggio, questo essendo
ottenuto dalla trasformazione del latte, crudo o trattato termicamente, non si può considerare
un prodotto primario, anche se è prodotto nell'azienda agricola. Di conseguenza, la
produzione di formaggio nell'azienda agricola deve essere conforme alle prescrizioni in
materia di igiene alimentare stabilite dal regolamento (CE) n. 852/2004 e da quelle stabilite
per le produzioni animali dal regolamento (CE) n. 853/2004. Quest’ultimo però esclude in
generale dal suo campo d'applicazione il dettaglio (cioè il trattamento e/o la trasformazione di
prodotti alimentari e il loro immagazzinamento nel punto di vendita o di consegna al
consumatore finale). Questo significa che quando un prodotto come appunto il formaggio è
fabbricato e venduto interamente nell'azienda agricola ai consumatori finali, queste attività
dovranno essere svolte in conformità alle prescrizioni stabilite dall’allegato II del
109
regolamento (CE) n. 852/2004, ovvero, non saranno applicabili le prescrizioni del
regolamento (CE) n. 853/2004, fatta eccezione per quelle relative al latte crudo. C’è però
anche chi dichiara di fidarsi maggiormente del servizio igienico di una grande azienda in
quanto si pensa sia maggiormente controllata soprattutto grazie ai moderni metodi di
sterilizzazione e trattamento degli alimenti. Un’altra donna infatti ha parlato della fiducia nei
numerosi controlli effettuati in azienda per garantire la qualità del prodotto e nella rigida
regolamentazione vigente. Da sottolineare è il fatto che viene percepita una non necessaria
corrispondenza tra legislazione e pratiche di produzione. Nella percezione diffusa dei
consumatori, il criterio di maggiore soddisfazione della produzione industriale concerne il
grado di igienizzazione, che comunque non prevale in maniera significativa sulla produzione
artigianale. Per quanto concerne le altre variabili indagate, la produzione artigianale viene
sensibilmente più apprezzata.
Analizzando il criterio salutistico, ossia quanto il prodotto sia benefico per la propria salute le
opinioni propendono vertiginosamente verso la piccola produzione in cui la percentuale di
preferenza per quanto riguarda le conserve passa dal 47 all’82%, mente per quanto riguarda
la produzione di formaggio va dal 47 al 78% soprattutto a causa della presunta mancanza di
additivi chimici e aromi artificiali. Questi ultimi rimangono qualcosa di pressoché
sconosciuto all’interno della cucina casalinga, non è possibile tenerli in dispensa, ma sono
utilizzati soltanto nelle grandi produzioni industrializzate per uniformare il gusto e garantire
una migliore conservazione. Inoltre è opinione diffusa associare la bontà ad una minore
manipolazione dei prodotti primari, non soggetti a trattamenti che ne alterano le
caratteristiche, ma che sono prodotti come “potresti farli tu a casa tua se ne avessi gli
strumenti”. La maggior parte delle persone ha addotto come motivo principale della scelta
non industriale la maggiore genuinità degli ingredienti. Il termine “genuino” ha origini latine
(genuinus), derivato di genu (ginocchio) ed era originariamente riferito al figlio che veniva
riconosciuto dal padre con il gesto di prendendolo sulle proprie ginocchia. Il significato
odierno si riferisce a qualcosa di non alterato, non sofisticato, quindi autentico, naturale, e le
preferenze sono andate accordandosi in questo modo:
110
Le preferenze riguardano soprattutto l’autoproduzione di conserve grazie all’utilizzo di
ingredienti freschi e selezionati di persona. Per quanto riguarda la piccola azienda agricola
invece il livello di gradimento risulta lievemente più basso in quanto è stata riportata
l’immagine di alcune aziende molto sporche che non garantiscono livelli di igiene adeguati e
quindi forniscono prodotti facilmente contaminati. Questo perché il latte per produrre il
formaggio deriva dagli animali che in una piccola azienda non vivono in ambiente sterile. Per
cui l’associazione animale-sporco viene da sé. All’interno di una grossa industria di
trasformazione invece il latte arriva già munto e il contatto diretto con gli animali non
avviene. Forse rimane oscuro a molti il fatto che il latte alla fine arriva sempre e comunque
dagli animali in questione e spesso viene prelevato da consorzi di piccoli produttori uguali a
111
quelli in cui è presente anche un laboratorio di lavorazione. Una donna, a questo proposito mi
ha fatto notare quanto fosse schizzinosa e che mangia e mangerebbe solo prodotti
confezionati in quanto: “l’odore degli animali mi fa schifo. Il solo pensiero di mettere piede
in una azienda agricola mi nausea. Meglio i prodotti confezionati o le marmellate che faccio
solo io”. Alle volte infatti il criterio di salute è assimilato a quello igienico in quanto la salute
deriva dalla minore presenza di batteri. Altre volte però questi due aspetti sono dissociati
come mostra la non completa sovrapposizione delle colonne relative ai due criteri di igiene e
di salute su cui ho chiesto di esprimere un’opinione. In questo caso la salute deriva dalla
maggiore presenza di nutrienti correlata alla minore presenza di additivi e sofisticazioni
nonché dalla differente manipolazione della materia prima. Viene comunque inteso come
“migliore” e dunque preferibile ciò che è percepito come più prossimo rispetto al
consumatore finale. Una piccola azienda regala forse un’idea di maggiore trasparenze e
minore distanza dalla popolazione che spesso ignora perfino i nomi di procedimenti
industriali atti a preparare il cibo che viene abitualmente consumato.
Per quanto riguarda il “gusto” dunque la competizione risulta inesistente in quanto quasi tutti
(l’88% per quanto riguarda l’autoproduzione e il 95% per la trasformazione in una piccola
azienda) preferirebbero evitare i prodotti confezionati che si trovano nei supermercati. Anche
per quanto riguarda la componente preferenziale, ossia quale tra i due prodotti viene
preferito, le percentuali, rispettivamente del 92% e dell’88% propendono sempre in quella
direzione.
112
Questo potrebbe far pensare ad una propensione d’acquisto che segue maggiormente il
criterio del gusto rispetto ai criteri igienico-sanitari o a quelli salutistici, come chi dice “se c’è
dentro un filo d’erba non fa mica niente” , oppure “più è zozzo più è buono”. Dunque il
prodotto “del contadino” ha superato quello industriale per quanto riguarda tutte e quattro le
proposte di valutazione.
La gratificazione nel gusto, tra l’altro, non è sfuggita, secondo Serino (Serino 2003),
all’occhio attento dell’imprenditore volto a scoprire i trend del momento per la creazione di
nuovi prodotti o semplicemente la riproposta di quelli già presenti sul mercato in una chiave
grafica differente e più vicina alle richieste della popolazione. Si sta infatti sviluppando una
singolare passione per la cucina campagnola e per il modo di mangiare sano del contadino
che si distingue per la genuinità dei prodotti, rustici e di stagione. «Sono nate così, nel nostro
paese, come in molte altre contrade che vivono la dimensione postindustriale, iniziative
commerciali legate alla messa in commercio del “pollo del contadino”, del “formaggio del
pastore”, del “cavolo dell’ortolano”. Tutte operazioni condotte all’insegna del recupero della
vera genuinità ma che, in realtà, nascondono, quasi sempre, intenti molto meno nobili e
più…commerciali» (Serino 2003, p. 135). Vengono sfornati dunque prodotti con confezioni
che ritraggono bellissimi paesaggi di campagna per richiamare il luogo in cui vengono
prodotti alcuni alimenti. Un esempio è dato dai legumi in scatola che in realtà spesso arrivano
da orti coperti dove “vengono fatti crescere in spugnette imbevute di acqua e fertilizzante. La
terra, certe verdure neanche la vedono”.
113
Questo trend nasce dal tentativo – in parte riuscito e in parte no – di rivestire la produzione
industriale di retoriche e immagini che evocano naturalità e genuinità che il consumatore
(come emerge dalla mia analisi) sente sia stata compromessa. L'operazione mira quindi a
114
conservare la filera industriale e trasformare principalmente l'immagine attraverso strategie di
marketing “verdi”.
Spesso vengono anche riproposti gli stessi prodotti con una chiave grafica particolarmente
vicina alla natura e diversa dai colori psichedelici offerti fino a pochi anni fa pur non avendo
apportato sostanziali differenze al prodotto. L’esempio più emblematico a mio avviso
riguarda l’arredamento interno della catena di fast food più famosa al mondo, ossia Mc
Donald. I vividi colori giallo e rosso che dovrebbero stimolare il senso dell’appetito sono stati
cambiati con dei colori più tenui sulle tonalità del marrone che richiamano la genuinità dei
prodotti e la vicinanza alla terra da cui dovrebbero provenire insieme a stampe di mani
sporche di terra che raccolgono bellissimi pomodori. Da aggiungere al paradossale
mutamento del punto di ristorazione che si trova a Milano in piazza Duomo in cui le pareti
interne sono state costruite in doppio vetro con all’interno dei vasi di carote (ovviamente in
plastica, anche perché se fossero in terra come sarebbe più opportuno se fossero fresche,
l’ortaggio neanche sarebbe visibile). Nonostante tutto la grande distribuzione continua ad
assumere un ruolo fondamentale all’interno delle abitudini alimentari di un vastissimo ceto
medio che in occidente sta uniformando i propri modelli culinari caratterizzati da una sempre
minore manipolazione necessaria dall’acquisto al consumo.
Vero è anche, però, che il trend del momento per la cosiddetta “cucina campagnola” e locale,
a km 0 poco ha a che fare con l’industria alimentare. A Varese stanno così sorgendo, al di
fuori di grande distribuzione, numerose iniziative come Campagna Amica che cercano di
contrastare l’industrializzazione seguendo l’esigenza di un’offerta di prodotti tipici unita a
quella di località e trasparenza. Questo tipo di iniziative sono nate un po’ ovunque su
territorio nazionale e mi sembra doveroso citare la campagna Genuino Clandestino, nata da
un mercato di produttori simile a quella di Campagna Amica. Questa iniziativa da la
possibilità di uscire dal circuito legislativo corrente anche in materia di prodotti trasformati e
venduti poiché nonostante non rispettino gli standard igienici delle normative europee sono
comunque garantiti da chi questi alimenti li produce.
1. Genuino Clandestino
Il progetto Genuino Clandestino36 è una campagna per la libera lavorazione dei prodotti
contadini promossa dall'associazione Campi Aperti di Bologna. Alcuni contadini che sono
36 GENUINO CLANDESTINO http://genuinoclandestino.noblogs.org/ [Data di accesso: 13/12/2012].
115
anche trasformatori, o semplicemente trasformatori non possono vendere i loro prodotti in
quanto necessitano di un laboratorio di lavorazione a norma di legge, molto dispendioso
rispetto al fatturato annuo ricavato dalla vendita dei prodotti stessi.
Dal 1° gennaio 2006 infatti, in materia di igiene della produzione e delle
commercializzazione degli alimenti è entrato in vigore il Regolamento (CE) 852/200437
sull’igiene dei prodotti alimentari citato nel paragrafo precedente. Esistono numerose
disposizioni normative specifiche per i vari generi e prodotti alimentari, con indicazioni
particolari per le diverse esigenze produttive. Il punto fondamentale del regolamento resta
comunque l'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo del sistema HACCP38 «L’obiettivo
principale è istituire un sistema documentato con cui l’impresa sia in grado di dimostrare di
aver operato in modo da minimizzare il rischio. Tuttavia, in alcuni casi come nelle piccole
imprese, l’applicazione del sistema HACCP può risultare complessa39.» Nonostante questo
tipo di ammissione da parte del Ministero Italiano della Salute sono state sfornate norme
come quelle che ad esempio fissano le dimensioni minime delle cucine; che escludono
l'utilizzo, negli esercizi alimentari, di piani di marmo che andranno sostituiti con quelli in
acciaio; che vietano l'utilizzo di taglieri in legno in favore di quelli in plastica. L'applicazione
di questo tipo di normative, di cui quella sull'igiene è solo una parte, mette in una posizione
di debolezza, potenzialmente soggetta a sanzioni, la produzione di piccola scala, artigianale,
familiare, condotta con uno scarso ricorso alla tecnologia avanzata. L’invadenza da parte del
governo contemporaneo nella vita del cittadino sta raggiungendo livelli sempre più alti,
dichiarando fuori legge pratiche comunemente accettate. «Sono stati vietati innumerevoli
alimenti di produzione casalinga o artigianale, tra cui la bistecca con l’osso e il salame
tagliato a mano, attraverso normative che rendono illegali certe composizioni e modalità di
produzione del bene; ad esempio, sono stati regolamentati in maniera restrittiva i fermenti
lattici utilizzabili per fare il formaggio» (Boni 2011 p. 141). Per seguire le normative
andrebbero ristrutturati gli ambienti, cambiati gli strumenti, rinnovate le attrezzature in senso
ipertecnologico e meccanizzate le tecniche. In pratica si pretende dalla piccola produzione
grandi investimenti e un cambiamento complessivo del sistema di produzione e trattamento
degli alimenti che le piccole imprese semplicemente non possono permettersi: si mettono al
37 REGOLAMENTO (CE) 852/2004 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:it:PDF (Data di accesso: 13/12/2012). 38 Hazard Analysis and Critical Control Points. 39 MINISTERO DELLA SALUTE: Autocontrollo e HACCP http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/paginaInternaMenuSicurezzaAlimentare.jsp?id=1225&lingua=italiano&menu=igiene (Data di accesso: 13/12/2012).
116
bando le specificità locali e i saperi tramandati che attivano una scarsa complessità
tecnologica. Si colpisce, la produzione minuta e familiare già marginalizzata dalle difficoltà
di competizione con i potentati del settore alimentare che riescono a produrre a prezzi più
bassi.
A fronte di tutto ciò è nato questo movimento a partire da un collettivo studentesco a Bologna
che ha promosso la creazione di un mercato autogestito in uno spazio sociale (XM24) che poi
è sfociato nel mercato cittadino tenuto tre volte la settimana dal nome Campi Aperti.
Il riscontro che ha avuto questo progetto e la calorosa accoglienza da parte di chi preferisce
un consumo critico degli alimenti ha fatto nascere il marchio Genuino Clandestino come
provocazione rispetto al fatto che alcuni prodotti non sono garantiti a norma di legge, bensì
da altri contadini e da chi decide di verificare di persona la lavorazione facendo visita
direttamente ai produttori. L'esperienza plurisecolare dei produttori ha saputo affinare e
consolidare un procedimento assolutamente efficace, anche dal punto di vista igienico, come
è stato provato nel 1996 con l'esito positivo dell'ispezione igienico-sanitaria fatta ai produttori
di lardo di Colonnata. Essi erano soliti far stagionare il lardo all'interno di casse di marmo
cosparse di aglio e spezie e chiuse con lo stucco secondo tradizione, contrariamente
all'utilizzo di materiali di plastica ritenuti più igienici dal Parlamento Europeo40. Questo
genere di polemica nei confronti dello snaturamento dei prodotti tipici con particolare
riferimento all'episodio del lardo di Colonnata è stato citato più di una volta all'interno della
ricerca che ho svolto e indica la voglia di un'alternativa di semplice attuabilità a livello
pratico, ma impossibile a livello burocratico e legislativo. Questo perché i prodotti contadini
vengono assimilati a quelli delle grandi industrie e perciò resi fuorilegge dalla legislazione
che norma queste ultime.
Il riscontro a tale proposito risulta particolarmente a favore dei produttori però per quanto
riguarda il 58% degli intervistati, mentre invece soltanto il 30% è a favore della rigida
normativa vigente. Il 12% invece non sa decidere da che parte schierarsi trovando valide
motivazioni per entrambi gli schieramenti.
40IL SOLE 24 ORE: “OLTRE 4500 LE «SPECIALITÀ» RICONOSCIUTE DAL MINISTERO” http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2010-07-19/oltre-4500-specialita-riconosciute-080441_PRN.shtml (Data di accesso 24/02/2013). DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ IGP "LARDO DI COLONNATA" http://www.agroqualita.it/_files/dc_colonnata_rev04_lardo_macinato_affettato.pdf (Data di accesso 24/02/2013).
117
Le motivazioni che sono emerse sono molto varie, ma in questo caso tutti hanno espresso la
loro opinione in maniera molto precisa e dettagliata. Chi ha trovato questa legge ingiusta ha
detto: “penso che ognuno possa vendere ciò che vuole. Non vedo perché le grandi industrie
possano e il cittadino singolo no. Poi sta a chi compra. La gente è ancora in grado di
scegliere… spero”; “non è giusto che i contadini debbano buttare via il latte, come capita
vicino a casa mia solo perché non lo possono vendere. Dovrebbe esserci un giorno in cui si
vendono tutti i prodotti dei contadini non controllati, li comprerei più volentieri”; “io mi fido
di più di una persona se la vedo al contrario della grande distribuzione in cui non vedo
nessuno e di cui non mi fido!” ; “Quanta gente è cresciuta senza norma di legge e sta meglio
di me!”. Le risposte degli intervistati svelano una consapevolezza dell'utilizzo di strategie
igienico-legislative per penalizzare la piccola produzione. «La moltiplicazione di normative
burocratiche, europee oltre che nazionali, rende la vita e il lavoro sempre più inutilmente
complessi, tarpando la creatività individuale e rendendo la produzione, anche quando
finalizzata al consumo personale, soggetta a improbabili standard di sicurezza… Tali
direttive sono pensate e redatte per i grandi potentati produttivi che, operando su larga scala
hanno una relativa facilità a conformarsi a minuziose prescrizioni che invece strangolano
inesorabilmente il piccolo produttore, perché rendono la piccola impresa autogestita
eccessivamente costosa e quindi difficilmente praticabile» (Boni 2011, p. 148) “Mi dispiace
tantissimo perché per adattarsi agli standard comuni sono indispensabili sforzi economici
impossibili per chi comincia dal basso”; “se uno coltiva per se stesso io mi fido di più dei
suoi prodotti”; “le cose alla fine le puoi vendere lo stesso, basta che non ti fai vedere”; “è
118
vergognoso perché non vogliono far vendere le cose ai contadini”; “è un’ingiustizia, i
contadini sono persone serie”; “così si devono riunire in cooperative per sopravvivere e non
essere schiacciati dalle grandi industrie che tolgono il lavoro e fanno morire le piccole
realtà”; “c’è tanta roba buona che viene buttata, uno spreco!”
Di seguito invece ho raccolto i commenti più significativi riguardanti la parte opposta che
ritiene giusto questo tipo di normative: “dura lex, sed lex”; “se ci sono delle leggi non sono
mica state fatte a caso”; “non dovrebbero venderli, sono necessari dei test microbiologico
per avere maggiori garanzie”; “la legge è uguale per tutti, non può tenere conto dei casi
particolari”; “è meglio se i prodotti sono controllati, ho sentito delle pizze surgelate con
dentro i ragni, per questo la pizza non la prendo più”; “siamo nella comunità europea
adesso, dobbiamo attenerci ai suoi standard”; “mi fido dei controlli, ed è bene che li facciano
anche loro”; “è giusto perché se non sono a norma non possono vendere, per cui vorrà dire
che venderanno in nero, e questo non va bene”.
Ho notato che le motivazioni più diffuse riguardanti l’ingiustizia di una legge che non tiene
conto di piccole realtà sono dovute allo spreco di cibo genuino che deve per forza essere
trattato per arrivare al consumatore, impacchettato, stoccato e standardizzato. Lo step in cui
le materie prime debbano passare dalla grande industria non risulta particolarmente gradito a
chi non vede la necessità di: “far fare ad una mela un giro infinito prima che arrivi a me,
quando potrei coglierla dall’albero e mangiarla”. Inoltre salta all’occhio la credenza in una
maggiore genuinità dei prodotti offerti ed altre all’inutilità di screditare alcune figure
professionali. La parte che sostiene questo tipo di normativa invece sembra molto più
fiduciosa verso il sistema economico e distributivo della società occidentale. La fiducia nelle
leggi e nei controlli (che nessuno ha dichiarato di conoscere specificatamente) è piuttosto alta
(il 57% degli intervistati dichiara di essere soddisfatto dei controlli effettuati sugli alimenti),
ed è il motivo principale per cui viene ritenuto giusto seguire la legge ovunque essa porti. Nel
caso questa dovesse essere modificata probabilmente molte persone non avrebbero da
obiettare nonostante si parli degli stessi prodotti a cui mi sono riferita oggi. La grande
differenza sta dunque nella fiducia verso il sistema di vita occidentale e sulle leggi che
impone in materia alimentare e non solo. La messa in discussione di valori ad esso
riconducibili, come gli enti di controllo super partes e l’importanza di un livello di igiene
divenuto ormai altissimo è molto bassa e si limita spesso ad atti sporadici di resistenza. Ciò è
dovuto all’introiezione dell’importanza di legiferare sopra ogni aspetto della vita pubblica e
privata che, con la falsa pretesa di equità e giustizia sta minando l’effettiva libertà
individuale. Dall’altra parte c’è chi spera in un cambiamento poiché non si sente
119
rappresentato da alcune leggi che minano causa la possibilità di scegliere più liberamente il
proprio destino alimentare. In questo contesto di resistenza contadina vorrei utilizzare alcune
delle parole che si trovano nel manifesto esplicativo del movimento Genuino Clandestino,
utili a dare il quadro della situazione di alcuni produttori e le rivendicazioni che portano
avanti.
Siamo produttori biologici. Utilizziamo risorse abbondanti come il tempo e il lavoro umano e
risparmiamo quelle preziose come l'acqua e la terra. Non abbiamo i mezzi necessari per
affrontare la spesa di messa a norma di un laboratorio, ma non vogliamo essere considerati
fuorilegge... Con la campagna Genuino Clandestino, noi di Campi Aperti denunciamo un
insieme di norme ingiuste che, equiparando i nostri prodotti trasformati a quelli delle grandi
industrie alimentari, li rende fuorilegge. Facendolo rinnoviamo la politica di trasparenza che da
sempre manteniamo nei confronti dei nostri consumatori. Indichiamo loro quali sono, nei nostri
mercati, i prodotti non a norma secondo la legge italiana, e li invitiamo a difenderli e a
diffonderli, perché tutti sappiamo che sono genuini e affidabili.
Questi contadini hanno comunque passato un iter, similare a quello utilizzato dai PGS, come
la certificazione partecipata data da altri contadini della zona che conoscono il loro lavoro e
che possono così giudicare affidabile quello di altri o in caso contrario aiutarli a raggiungere
tale obiettivo. Certo è che vengono tagliati completamente i costi di trasporto, stoccaggio e
confezionamento poiché la filiera è molto più corta e si saltano tutti i passaggi intermedi che
possono essere fino a tre o quattro utili soltanto a far lievitare il prezzo finale del prodotto.
Questi contadini decidono dunque di utilizzare un prezzo definito da loro “equo”: che non
sminuisca il loro lavoro e che gli permetta di portare a casa il tanto che basta a far andare
avanti l'attività che hanno creato poiché una scelta di questo genere non è stata fatta su base
economica, ma etica.
Un'altra questione che il movimento ha portato alla luce è l'etichetta che potrebbe
considerarsi inutile in un contesto di vendita diretta in cui il produttore sta di fronte al cliente
per spiegare e dissipare ogni dubbio sugli ingredienti e sulla lavorazione, con l'invito a
constatare di persona quanto gli è stato detto. Inoltre molte delle informazioni solitamente
riportate in etichetta risulterebbero inutili come ad esempio la scadenza. Questi alimenti
scadranno quando il prodotto non sarà più buono da mangiare, e per accorgercene dovremo
affidarci ai nostri sensi anziché alla data garantita a norma di legge e riportata sulla
confezione.
120
Il luogo di provenienza di questi prodotti solitamente è molto vicino in quanto non avrebbe
senso un lungo trasporto per poterne vendere al dettaglio una quantità minima. Infatti in
queste occasioni, come il mercato di Campi Aperti, la campagna torna ad invadere la città, e
non è più il cittadino a doversi spostare fuori città per poter raggiungere i grandi centri
commerciali dovendo utilizzare mezzi di trasporto da caricare con tutta la spesa che si riesce
a stiparci dentro. Attualmente i mercati in cui si possono trovare questo genere di prodotti
sono più di venti in tutta Italia, per offrire un'alternativa alla grande distribuzione organizzata
che spesso non rispecchia i desideri di tutti.
2. La richiesta del prodotto italiano
L’esigenza di località si nota anche dall’importanza della provenienza italiana degli alimenti.
Nei supermercati spesso si trovano prodotti stranieri, soprattutto per quanto riguarda ortaggi e
frutta esotica o fuori stagione. Qui non è possibile trovare alimenti locali a km 0, per cui il
prodotto più locale che si riesce a reperire è quello italiano. Questo aspetto è importante per
l’83% degli intervistati ed è emerso in itinere poiché mi veniva menzionato molto spesso in
riferimento a qualsiasi contesto.
121
In questo caso la differenza generazionale è importante perché sono stati soprattutto i giovani
a non definirla fondamentale in sede d’acquisto. In particolar modo perché c’è chi ha detto di
acquistare alghe che non vengono prodotte nel nostro paese, oppure altre specialità estranee
al panorama alimentare italiano. Tra i giovani ho notato questa indifferenza rispetto
all’italianità del prodotto principalmente perché “italiano” non è ritenuto come sinonimo di
“superiore”, ma c’è grande fiducia anche in metodi di produzione extraeuropei. Quella dei
giovani sembra più la constatazione che i prodotti che si trovano nei supermercati sono
diventati tutti uguali e che non c’è motivo di avere paura dei cibi stranieri controllati da
persone straniere come invece ha fatto ben capire una signora anziana: “sono stata in Spagna
e ho visto questi mari di plastica. Distese di capannoni di plastica dove coltivano la verdura,
piene di extracomunitari che ci lavoravano, non mi fido proprio” oppure “almeno so da dove
arrivano, mica come il pesce dell’India. Qui so come sono lavorati” e anche “ho più fiducia,
soprattutto per quanto riguarda la carne. Si sentono certe storie all’estero…”
Il 100% delle persone anziane infatti lo ritiene un punto fondamentale. Le motivazioni per
preferire una provenienza italiana restano comunque molte per tutte le fasce di età.
Fondamentale è la fiducia verso qualcosa che si crede di conoscere meglio perché più vicino
rispetto ad una realtà europea o globale: solo tre persone hanno dichiarato di avere qualche
informazioni legislative in ambito alimentare, ma tutti dicono di fidarsi di più delle leggi e
dei controlli effettuati nel nostro paese: “in Italia ci sono leggi severissime che gli altri paesi
non hanno”; “mi fido dei controlli e della qualità italiane”; “per i controlli igienici che ci
122
sono, al massimo prendo roba europea se devo scegliere”.
I prodotti italiani sono più buoni: “tutti dovrebbero mangiare italiano”. Sono più freschi: “le
cose fresche lo sono di più se arrivano da vicino” e inoltre “inquinano meno per quanto
riguarda il trasporto”. La tipicità invece dipende dalla specificità di un prodotto rispetto alla
sua provenienza: “se compro il formaggio grana voglio che sia italiano!”. Infine un aspetto
molto rilevante che è emerso è la difficoltà di trovare e mantenere un lavoro in questi tempi
di crisi. La solidarietà verso i propri connazionali e verso le sorti del paese sembra che stiano
a cuore a molte persone che scegliendo produzioni italiane sentono di compiere una scelta
etica: “diamo lavoro ai giovani”; “diamo da mangiare agli italiani”; “facciamo girare
l’economia”.
3. La certificazione biologica: metodi, principi, legislazione
L’offerta di prodotti biologici all’interno dei supermercati è da considerarsi piuttosto esigua
rispetto a quella che distingue invece quelli tradizionali. Ad esempio, alimenti di largo
consumo come i formaggi certificati biologicamente, in un negozio non specializzato come
può essere Coop o Esselunga, sono quasi del tutto assenti, mentre sono offerti all'interno di
supermercati specializzati nel settore come ad esempio Natura sì. Nei cosiddetti discount
invece questi prodotti si trovano molto raramente. I prodotti etichettati come biologici devono
rispettare le normative per la produzione di tali alimenti.
123
Il movimento biologico comincia ad ipotizzare i propri principi alla fine degli anni Settanta,
ma inizia a prendere piede come metodo di coltivazione nella seconda metà degli anni
Ottanta dopo il boom economico che ha caratterizzato la crescita e lo sviluppo economico
spropositato del secondo dopoguerra (Mariani - Pirovano 2012). Questo per contrastare i
nuovi metodi agricoli utilizzati per la semina, la raccolta e la coltivazione, che utilizzano un
grande quantitativo di pesticidi chimici e macchinari molto poco utilizzati nel territorio prima
delle due guerre. Il diffondersi di un metodo di coltivazione biologico si basa su taluni
principi generali che nascono da un paradigma culturale critico nei confronti del classico
sistema produttivo. Questo metodo di coltivazione dovrebbe essere caratterizzato non solo
dall'assenza di fertilizzanti chimici, ma dovrebbe basarsi sul rispetto della natura e sulla
ridotta intromissione dell'uomo all'interno dell'ecosistema. La principale differenza tra un
campo coltivato tramite i mezzi dell'agricoltura tradizionale e quelli biologici è l'immissione
di energia ausiliaria all'interno dell'agrosistema. L'agrosistema è un ecosistema con una forte
connotazione antropica in cui si decide di mantiene una situazione di squilibrio in termini di
biodiversità, fondamentale per ottenere una produzione economica significativa. Infatti
nell'agricoltura tradizionale o convenzionale il quantitativo di energia ausiliaria utile allo
sviluppo della coltura deriva ingentemente da processi chimico-industriali, come un maggior
uso di pesticidi sintetici che aiutano ad aumentare la produzione o a salvare il raccolto in
periodi di crisi dovuto ad alcuni agenti infestanti. Nell'agricoltura biologica, infatti, pur
essendo sostenuta anch'essa da energia ausiliare di sintesi chimica, soprattutto in talune
circostanze (come quando il raccolto viene minacciato da agenti infestanti che vanno
debellati obbligatoriamente a causa della possibilità che essi si propaghino distruggendo
anche altre coltivazioni vicine), si basa principalmente sul reimpiego di materiale organico e
sulla rotazione dei terreni per permettere una maggiore produttività41. Secondo alcuni questo
non è così, infatti il premio Nobel Norman Borlaug sostiene che usando tecniche tradizionali
come la rotazione dei terreni e la concimazione naturale, sarebbe stato necessario triplicale le
terre destinate all'agricoltura per triplicare la produzione globale come è avvenuto negli
ultimi cinquant'anni grazie a pesticidi chimici e un aumento del terreno coltivato solo del
10%. Inoltre sostiene che l'immissione di energia nell'ambiente per tonnellata di prodotto sarà
maggiore perché le produzioni sono più scarse e le erbe infestanti sono tenute a bada
41 L'uso di materiale organico autoprodotto però è ancora estremamente limitato in quanto spesso non sono presenti allevamenti biologici sufficienti alla concimazione dei campi della stessa azienda. Per cui se l'azienda non produce stallatico sufficiente è costretta a comprarlo, ma anch'esso dovrà essere biologico.
124
manualmente o con l'aratro42.
L'agricoltura biologica è l'unica forma di agricoltura in cui i metodi di produzione sono
regolamentati in base alle normative europee e nazionali. Non sono controllate, infatti, né
l'agricoltura convenzionale né l'agricoltura integrata. È stata regolamentata per la prima volta
a livello comunitario nel 1991 con il Reg. (CEE) n° 2092/91 relativo al metodo di produzione
biologico di prodotti agricoli. Solo nel 1999 con il Reg. (CE) n° 1804/99 sono state normate
anche le produzioni animali. Nel giugno del 2007 è stato adottato un nuovo regolamento CE
per l'agricoltura biologica, Reg. (CE) n° 834/200743, che abroga i precedenti ed è relativo
all'etichettatura dei prodotti biologici di origine sia vegetale che animale. Queste norme
dovrebbero garantire che le componenti derivino quasi esclusivamente da agricoltura
biologica nonché abbiano subito un particolare tipo di lavorazione. «I prodotti biologici
trasformati dovrebbero essere ottenuti mediante procedimenti atti a garantire la persistenza
dell’integrità biologica e delle qualità essenziali del prodotto in tutte le fasi della catena di
produzione... gli alimenti trasformati dovrebbero essere etichettati come biologici solo
quando tutti o quasi tutti gli ingredienti di origine agricola sono biologici. Si dovrebbero
tuttavia prevedere disposizioni speciali di etichettatura per gli alimenti trasformati
comprendenti ingredienti di origine agricola che non si possono ottenere con metodi
biologici, come nel caso dei prodotti della caccia e della pesca44». La semina, il raccolto, il
terreno, i fertilizzanti, i pesticidi e i metodi di allevamento utilizzati dunque devono essere
conformi a determinati criteri.
La certificazione è garantita dal marchio comunitario unico infatti: «nell’etichettatura e nella
pubblicità non sono inoltre ammessi termini, compresi i termini utilizzati in marchi, o
pratiche che possono indurre in errore il consumatore o l’utente suggerendo che un prodotto o
i suoi ingredienti soddisfano le prescrizioni del presente regolamento45». Il marchio è unico
in tutta Europa ed è volto ad impedire qualsivoglia contraffazione che inducano in dubbio o
in errore il consumatore. «Nell’etichettatura e nella pubblicità di un prodotto agricolo vivo o
non trasformato si possono usare termini riferiti al metodo di produzione biologico soltanto 42 (2007) “Votare al supermercato” in: Internazionale, n° 684, pp. 32 – 33. Tratto da The Economist, Gran Bretagna. 43 UNIONE EUROPEA – legislazione riguardante i principi della coltivazione, allevamento e acquacoltura biologica. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:IT:PDF [Data di accesso: 11/12/2012]. 44 REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. Paragrafo 19 e 20, considerazioni preliminari. 45 REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. Articolo 23, paragrafo 2.
125
se, oltre a tale metodo, anche tutti gli ingredienti di tale prodotto sono stati ottenuti
conformemente alle prescrizioni di cui al presente regolamento46». Pertanto nell’etichettatura
o nella pubblicità di una derrata alimentare si può fare riferimento, nella denominazione di
vendita del prodotto, al metodo di produzione biologico unicamente se il prodotto contiene
per almeno il 95% ingredienti ottenuti col metodo di produzione biologico. Tali prodotti
possono quindi contenere fino al 5% di ingredienti prodotti secondo il metodo convenzionale,
purché si tratti di prodotti non disponibili (come ad esempio alcuni frutti esotici) o disponibili
in quantità insufficienti sul mercato comunitario. L’elenco dei prodotti autorizzati figura nel
regolamento (CEE) n. 2092/91. I prodotti che contengono dal 70 al 95% di ingredienti
biologici possono beneficiare di un’indicazione relativa a tale metodo di produzione purché
le indicazioni compaiano solamente nell’elenco ingredienti senza che essi abbiano una
maggiore visibilità rispetto agli altri e affiancati dalla percentuale presente, ma non nella
denominazione di vendita. Nel primo dei quaranta punti presi in considerazione dal Consiglio
dell'Unione Europea, quali principi generali del movimento viene infatti specificato che: «la
produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione
agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di
biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia
di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori
per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico
esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico
che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall’altro, fornendo beni
pubblici che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo
sviluppo rurale47».
A volte però è possibile che alcune logiche volte verso il profitto spingano aziende certificate
biologicamente a dimenticare l'etica sottostante questo tipo di produzioni e a badare solo al
fatturato. Infatti, se è vero che il minore utilizzo di prodotti di sintesi riduce l'impatto
ambientale legato all'immissione di molecole tossiche nell'aria, nel terreno e nelle falde
acquifere, risulta altresì vero che la produzione ha rese inferiori rispetto a quelle
convenzionali per unità di superficie di terreno coltivato. Il settore di produzione alimentare
infatti non è chiaramente stabile poiché risente degli influssi climatici e delle epidemie e
malattie che possono decimare allevamenti e raccolti. È vero anche che comunque una
maggiore produzione alza i profitti per cui, l'utilizzo di pesticidi che aiutano ad aumentare la 46 Ibid. Articolo 23, paragrafo 1. 47 Ibid. Considerazione preliminare (1).
126
quantità di raccolto risulta necessaria a fronte della decisione di perseguire una coltivazione
tradizionale che senza di essi non potrebbe avere prezzi competitivi sul mercato. Importante è
dunque chiarire che la certificazione viene condotta da un manipolo di organizzazioni di
certificazione, costosi e spesso ritenuti arbitrari dai coltivatori.
Alcuni contadini intervistati da Nicola Angrisano per la realizzazione del documentario
Genuino Clandestino. Movimento di resistenze contadine invece hanno deciso di dedicarsi
alla coltivazione biologica avendo dubbi sulla qualità della frutta e la verdura da loro prodotta
nonostante fosse bella e pronta per essere venduta e dunque mangiata, in quanto conoscevano
il trattamento subito dalle stesse e non si fidavano per non mettere a repentaglio la loro salute.
La differenza fondamentale per quanto riguarda l’allevamento invece sta nelle condizioni di
vita degli animali maggiormente tutelate. È impedito l’uso di strumenti volti ad aumentare
appetito e dunque produzione di uova, latte o carne, (oltre all’impedimento di mutilazioni
come può essere il taglio del becco delle galline ovaiole che impedirà atti di cannibalismo
dovuti al regime di vita innaturale a cui sono sottoposte negli allevamenti in batteria) e nello
spazio di vita disponibile48 a loro concesso.
Nel biologico non ci si basa su dichiarazioni dell'azienda, ma su un Sistema di Controllo
uniforme in tutta l'Unione Europea e stabilito, sia per la coltivazione delle piante che per
l'allevamento degli animali, da appositi regolamenti della Comunità europea. L'azienda che
vuole avviare la produzione biologica notifica la sua intenzione alla Regione e a uno degli
organismi di controllo autorizzati (nove in tutta Italia). L'organismo procede alla prima
ispezione con propri tecnici specializzati, che esaminano l'azienda e prendono visione dei
diversi appezzamenti, controllandone la rispondenza con i diversi documenti catastali, dei
magazzini, delle stalle e di ogni altra struttura aziendale. Se dall'ispezione emerge il rispetto
della normativa, l'azienda viene ammessa nel sistema di controllo, e avvia la conversione, un
periodo di disintossicazione del terreno che, a seconda dell'uso precedente di prodotti chimici
e delle coltivazioni, può durare due o più anni. Concluso questo periodo di conversione, il
prodotto può essere commercializzato con l’apposito marchio. L'organismo provvede a più
ispezioni l'anno, anche a sorpresa, e preleva campioni da sottoporre ad analisi. Solo le
aziende controllate da organismi autorizzati possono definire le loro produzioni come
provenienti da agricoltura biologica. Gli organismi di controllo che sono autorizzati dal
Ministero delle Politiche Agricole dovrebbero effettuare controlli almeno una volta l'anno,
48 In un allevamento intensivo a batteria lo spazio disponibile per una gallina ovaiola è di 550cmq (un normale foglio A4 misura circa 620cmq) a fronte dei 4m di manto erboso da sommarsi ad una parte coperta di pollaio per un totale di circa 5mq.
127
nonché dovrebbero rispettare il principio di "terzietà" non intrattenendo altri rapporti
commerciali o di consulenza con le aziende certificate. Un problema che però sorge dagli
organi di certificazione privati è che questi devono essere pagati autonomamente dalle
singole aziende che decidono di essere certificate, per cui il processo di certificazione viene
comunque inserito in logiche monetarie che possono invalidare una serena valutazione, come
ammette un contadino da me intervistato.
Nonostante l'agricoltura biologica sia praticata in tutti i paesi del mondo e viene definita
“biologica per necessità”, la certificazione di questi risulta alquanto costosa a causa degli enti
di accreditamento privati e spesso si decide di non aderirvi nonostante siano presenti i
requisiti necessari. Un esempio può essere quello del mercato turco di prodotti biologici che
faticano a soddisfare i criteri delle nuove normative europee in materia di certificazione a
causa dei costi troppo alti delle ispezioni nonostante il potenziale del terreno da sfruttare
risulta notevole e di ottima qualità49. Il consumo di questi prodotti certificati è inoltre quasi
esclusivo dei cosiddetti paesi industrializzati, come Europa e Nord America in quanto
l’apporto calorico giornaliero è quasi totalmente coperto da prodotti confezionati che
necessitano appunto di questo marchio per essere riconosciuti come tali a differenza di paesi
in cui il prodotto sfuso è ancora molto presente. Inoltre questa differenziazione viene
richiesta sull’etichetta dei prodotti per poter garantire una migliore conoscenza del prodotto
che all’interno di un sistema di grande distribuzione non sarebbe possibile. La certificazione
biologica risulta dunque un differente criterio di scelta “etica” sottoposto ormai alle leggi del
mercato, nonostante sia nato come movimento indipendente volto a contrastare
l’industrializzazione e lo sfruttamento indiscriminato delle risorse rinnovabili dovuto a questo
sistema di valori. Spesso ormai quando si parla di biologico per molte produzioni agricole
ingenti, che lavorano con metodi industriali, si tratta dell'adeguamento alle norme per
ricevere una certificazione più spendibile ed economicamente fruttuosa che snatura l'idea
originaria di coltivazione “naturale” e a impatto zero per il pianeta. La produzione di cibo
biologico su vasta scala ha scatenato una forte reazione, e anche il movimento biologico è
stato accusato di essersi venduto l'anima. Si teme che i suoi ideali originari siano stati
dimenticati sotto le pressioni delle grandi aziende. Nonostante inquini meno, viene accusato
di non essere produttivo e di sfruttare una maggiore quantità di terra aumentando l'impatto
ambientale. Inoltre da quando le grandi catene di distribuzione danno più spazio al biologico
gli standard sono divenuti quelli industriali con il risultato di enormi distese di monocolture
49 (2008) "Il granaio biologico dell’Europa" in: Internazionale, n° 766, p. 78. Tratto da: Zaman, Turchia.
128
delocalizzate. Risulta sempre più difficile trovare chi, immerso fino al collo nella logica di
mercato con cui si scontra tutti i giorni decide di praticare ancora l'agricoltura biologica
seguendo principi etici da cui è nato questo movimento.
4. Come vengono accolti i prodotti bio
Il riscontro che ho avuto sondando infatti la percezione che ha la gente nei confronti di questo
tipo di alimenti infatti è decisamente scarso, soprattutto per quanto riguarda alcune fasce di
età.
129
Si può notare infatti che la percentuale di persone che ha espresso un parere positivo nei
confronti dei prodotti a marchi biologico è appena il 37% degli intervistati con una netta
predominanza nella fascia giovanile. I commenti positivi soprattutto dei giovani riguardano la
minore presenza di additivi e la maggiore genuinità. In sostanza sono migliori rispetto a
quelli offerti dal mercato tradizionale. Mi è stato riportato che questi prodotti “sono
migliori”; “frutta e verdura sono migliori rispetto alle altre”; “acquisto tramite GAS [Gruppo
di acquisto solidale], per cui prendo molte cose biologiche”; “molto buoni e li acquisto
perché sono anche vegetariana”; “sembrano più invitanti, soprattutto la verdura”;
“potrebbero essere il futuro”; “li prendo perché sono più buoni, il prezzo è secondario,
l’importante è che sia più sano”. In questo ultimo commento però si riscontra un problema
notevole per chi acquista, o vorrebbe acquistare prodotti biologici, ossia il prezzo. Il costo
infatti, che deve compensare le spese per la certificazione e una produzione più lenta e molto
meno abbondante si riversa sul consumatore finale: “sono buoni, ma li uso poco. dovrei
comprarne di più, ma costano troppo”; “sono migliori, più genuini e con meno additivi, ma
costano di più, la differenza te la fanno pagare!”; “sono un’ottima mossa per l’ambiente, ma
per potersi diffondere dovrebbero costare meno”; “sono migliori, ottimi per la salute, ma
troppo cari”; “troppo cari anche se più buoni”; “a inizio mese sono ecobio, a fine mese
divento Eurospin”. Il limite del prezzo però è del tutto secondario a fronte dell’alto grado di
sfiducia che il marchio “biologico” ormai porta sulle spalle.
130
Risulta chiaro dunque che i dubbi in merito sono numerosi, soprattutto per quanto riguarda la
verità che si nasconde dietro al simbolo con la foglia verde composta dalle dodici stelle quale
marchio unico adottato dall’Unione. In particolare i dubbi riguardano l’autenticità di quello
che viene certificato come biologico perché le truffe alimentari sono sempre più frequenti.
Alcuni articoli infatti minano la fiducia che un consumatore ripone in questo settore
particolare e più in generale nell’industria alimentare. “Scandalo alimentare: Cosa c’è dietro
il falso Bio: la scoperta di una banda di truffatori italiani fa tremare il settore dei prodotti bio
e preoccupa i consumatori. I truffatori hanno piazzato anche sul mercato tedesco prodotti
alimentari spacciandoli per biologici, spesso agevolati nei loro sporchi traffici da connivenze
con le autorità competenti mentre controlli più severi ricadrebbero sui consumatori50”. Un
altro articolo allarmistico invece riguarda l’intrusione di OGM nel mercato biologico, che i
sostenitori di questo tipo di prodotti temono particolarmente: “Cibo biologico, sequestrate in
tutta Italia 1700 tonnellate di soia "modificata" - Intervento della Guardia di finanza da
Ravenna a grossisti di varie regioni. La certificazione falsificata attestava la qualità "naturale"
del prodotto proveniente dall'Est europeo, ma dai controlli è risultata una quantità ben oltre i
50 LA TRUFFA DEI PRODOTTI “BIO” http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/12/13/truffa-prodotti/177141/ (Data di accesso: 28/02/13).
131
limiti di organismi geneticamente alterati. Una dozzina gli indagati51”.
Articoli come questi infatti non faranno certo salire le quotazioni di questo mercato che
spesso viene definito un business dando un parere negativo in merito alla questione: “non li
prendo, costano di più e non mi fido, non so da dove arrivano”; “a volte li prendo. io ci metto
un po’ di fiducia, ma ho sentito che spacciano per biologiche cose che non lo sono”; “è facile
mettere su la certificazione; poi bisogna vedere se seguono effettivamente certe regole; tu
vedi solo che costano di più”; “non mi fido di niente io; in giro c’è sfiducia, in tutti i campi
andrebbero bene se solo fossimo sicuri che siano veramente biologici”; “mi fido poco, con le
truffe che si sentono in giro secondo me non c’è differenza”; “li prendo, anche se sono un
business; voglio crederci perché se il campo biologico è in mezzo all’autostrada di bio c’è
ben poco”. Frodi come queste tra l’altro mi sono state raccontate anche da chi lavora in
campo agricolo come un contadino e allevatore che durante l'intervista ha parlato dello
scandalo per cui per una stessa azienda è possibile produrre il medesimo prodotto sia con la
certificazione biologica sia senza. Egli infatti fa l'esempio di un suo “vicino di campo” che
possiede alcune terre che producono foraggio secondo i parametri biologici, per cui una volta
raccolto quello prodotto dai campi bio egli decide di metterci dentro anche il ricavato degli
altri campi sicuro che l'inganno non possa venire scoperto. Un fruttivendolo invece mi ha
detto: "sono una buffonata, non esistono, se vedessi veramente cosa sono… lo scarto della
roba bella. Al mercato generale di Milano prendono la frutta e verdura meno bella e la
spacciano per biologica. Ormai è diventata una truffa anche troppo facile da organizzare. Se
produci biologico dovresti lavorare tre mesi l’anno, d’inverno non cresce niente, e tu cosa
fai? Non lavori?” Secondo un altro intervistato infatti sono una fregatura, costano molto e
non sono tutti veramente biologici. “Ti danno gli scarti della frutta normale piena di pesticidi
ed è pure più brutta” oppure “mio figlio ha fatto agraria e mi dice che del biologico
prendono anche cose che non sono bio e le vendono lo stesso”.
Oltre infatti alla sfiducia sul fatto che le coltivazioni siano certificate in maniera
approssimativa nasce anche l’impotenza riguardante l’alto tasso di inquinamento globale e
soprattutto dei paesi industrializzati per cui, usare pesticidi chimici o meno non fa molta
differenza poiché l’inquinamento del terreno, dell’aria e dell’acqua è già molto alto. C’è chi
dice dunque: “sono proprietaria terriera e so che ci vogliono centinaia di anni prima che il
terreno non butti più fuori residui tossici”; “li prendo, anche se sono un business. Voglio
51 CIBO BIOLOGICO, SEQUESTRATE IN TUTTA ITALIA 1700 TONNELLATE DI SOIA"MODIFICATA" http://www.repubblica.it/cronaca/2012/06/14/news/sequestro_falsa_soia_biologica-37163100/?ref=search (Data di accesso: 28/02/13).
132
crederci perché se il campo biologico è in mezzo all’autostrada di bio c’è ben poco”; “io ho
l’orto e le cose bio me le faccio io. Se hai un campo bio e la bagni con l’acqua del Tevere di
biologico rimane poco”. Tanti infatti dichiarano di avere il proprio orto e di fidarsi solo di
quello perché sanno cosa c’è dietro e come vengono coltivate le cose: “io di prodotti
biologici non ne compro, preferisco quelli del mio orto che sono bio al 100%”. Durante
queste interviste però mi sono resa conto che nessuno, a parte una ragazza giovane ha parlato
di animali. Tutti si sono riferiti esclusivamente alla verdura. La carne proveniente da
allevamenti biologici non è stata presa in considerazione forse anche per la bassa percentuale
presente nei supermercati. La ragazza, vegetariana, ha detto che compra le uova per tutelare
le galline “non riesco a mangiare le altre se penso a quelle povere bestiole!” In ultima analisi
ho riscontrato che secondo alcuni, tra prodotti bio e tradizionali non ci sia reale differenza.
L'agenzia francese per la sicurezza sanitaria degli alimenti ha condotto un'indagine sulle
differenti proprietà organolettiche degli alimenti biologici52. Lo scarto tra un metodo e l'altro
di coltivazione è minimo, e le varianti sono molto numerose. Per esempio il tenore vitaminico
dei vegetali biologici non è superiore tranne che per la vitamina C nelle patate. A volte
contengono un po' meno acqua come insalate, carote e cavoli e non vi è nessuna differenza
per quanto riguarda minerali e oligominerali. Infatti il regolamento europeo stabilisce che i
prodotti biologici non possano vantare alcuna garanzia di qualità organolettica, nutrizionale o
sanitaria superiore.
Nonostante ciò però, come esposto sopra, c’è chi sostiene che siano più buoni. Forse perché
un alimento non è semplicemente la somma dei suoi principi nutritivi e ha bisogno di essere
pensato come buono prima di essere considerato tale. Un aneddoto che mi è stato raccontato
forse può chiarire la questione: un uomo parlava di un amico la cui moglie gli fornisce una
cassetta da riempire con le mele biologiche vendute da un camion vicino al supermercato
dopo essersi recato a fare la spesa. Il marito, pigro e diffidente nei confronti della
certificazione, decide di acquistare le mele (ovviamente quelle un po’ più bruttine) al
supermercato riponendole poi nella cesta. La donna, felice del suo acquisto, gli confessa
quanto più buone siano rispetto a quelle che compra di solito, non conoscendo il volgare
tranello che sta dietro. Come per la ragazza che acquista uova biologiche infatti, risulta più
importante fidarsi, sperando di aver compiuto una buona azione nei confronti degli animali e
del pianeta permettendo di assaporare meglio una pietanza rendendola più gradevole.
Purtroppo è in questo clima di sfiducia nei confronti di un marchio e di una certificazione
52 (2003) “Mangiare Biologico” in: Internazionale n° 506, p. 55, Tratto da: La Recerche.
133
ormai snaturati, metaforicamente ed effettivamente, che nascono alcuni movimenti alternativi
di resistenza. Questi intendono portare avanti la loro idea di biologico prescindendo
dall'adeguamento alle norme, ma con il criterio per cui fiducia e trasparenza nella relazione
con l'acquirente rimangono i punti fondamentali. Queste realtà nascono da piccoli produttori
che faticano a sopravvivere all'interno della grande distribuzione e si affidano alla vendita
diretta o tramite gruppi di acquisto solidale che prediligono il sostegno a realtà che altrimenti
andrebbero a morire.
5. Alternative di consumo a Varese: Campagna Amica, PGS e GAS
Attualmente il livello di sfiducia nei confronti del mercato globale alimentare sostenuto dalla
grande distribuzione è piuttosto alto. Si può infatti riscontrare una scarsa fiducia nei confronti
della certificazione biologica che ormai è stata completamente assorbita dalle odierne logiche
di mercato. Inoltre la paura diffusa riguardante la possibilità di un’intossicazione alimentare
iniziata con il clamorosa caso della “mucca pazza” è in crescita. L’utilizzo di conservanti e
additivi che si stanno rivelando sempre meno salutari, ma volti ad un’uniformazione del
gusto e delle caratteristiche estetiche hanno portato ad una maggiore esigenza di chiarezza
all’interno della filiera alimentare. L’importanza assegnata alla rintracciabilità grazie alle
nuove norme europee riguardanti le informazioni presenti in etichetta traduce questa
diffidenza. A questo va aggiunta l’importanza della provenienza italiana riscontrata nelle
interviste grazie alla fiducia accordata a piccole produzioni in quanto percepite come più
controllate e soprattutto “locali” rispetto alla globalità dell’offerta presente sul mercato. Con
queste premesse sembra chiaro che la direzione verso la quale è il consumatore vorrebbe
orientarsi.
In questo contesto, sono nate a Varese due iniziative particolarmente degne di nota. La prima
riguarda il progetto PGS (Sistema Partecipativo di Garanzia) che è ancora in fase di
costruzione e vuole proporsi come metodo sostitutivo rispetto all’ormai poco affidabile
certificazione biologica. La secondo invece riguarda l’ampliamento del mercato di
Campagna Amica promosso dalla Coldiretti e che porta in città i prodotti delle campagne
circostanti. Inoltre la rete di Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) sta riscoprendo un numero
sempre crescente di partecipanti e la seconda domenica del mese è nato circa dieci anni fa un
mercatino di prodotti tipici e locali nella via principale del centro storico.
134
GIOVANI M GIOVANI F ADULTI M ADULTI F ANZIANI M ANZIANI F TOT MERCATO 2 4 1 5 12 MACELLERIA 3 1 4 PESCHERIA 1 1 1 3 PANETTERIA 1 1 3 5 PASTICCERIA 1 1 ORTO 1 2 1 2 1 7 14
135
GAS 1 1 MERCATINO 1 2 3 PRODUTTORI 2 2 1 1 6 FRUTTIVENDOLO 2 1 1 4 CAMION 1 1 2 1 5 BOTTEGA 1 1 PESCATO 1 1
Il luogo prescelto per gli acquisti al di fuori del supermercato è principalmente il mercato,
superato di poco dall’orto il quale è molto apprezzato e utilizzato, ma principalmente dalle
donne anziane. Per loro rimane un’abitudine che le ha accompagnate per tutta la vita, mentre
per quanto riguarda i più giovani, l’orto rimane quello di casa dei genitori. Nessuno tra i
giovani ha dichiarato infatti di seguirlo in maniera particolare, ma solo di ricevere in omaggio
frutta e verdura da genitori e parenti che se ne occupano. Il mercato cittadino invece non dà
spazio a molti generi alimentari e la posizione, nonostante sia molto centrale, spesso
scoraggia gli avventori che riscontrano numerose difficoltà di parcheggio. Molto apprezzato
risulta il mercato mensile dei produttori, la domenica mattina nelle vie del centro storico, e
quello più piccolo a cadenza settimanale, vicino allo stadio, dotato di comodissimo
parcheggio. Sono inoltre stati menzionati i camion stanziati lungo le strade periferiche o
quelli itineranti che girano per i rioni della città spostando “il negozio” sotto casa. In questo
modo vengono ottimizzate le tempistiche di acquisto e l’offerta è di prodotti “di qualità
superiore” perché arrivano direttamente dalle piccole produzioni del Sud dichiara un
intervistato. Anche i produttori sono stati citati, soprattutto per quanto riguarda aziende vicine
alla propria abitazione e dunque facile da raggiungere. Per quanto riguarda i negozi
tradizionali specializzati, invece, il più citato è senza dubbio il panettiere in quanto il pane,
alimento base della dieta mediterranea, viene preferito fresco. Le alternative sarebbero il
pancarrè, trattato con alcool etilico che gli conferisce un retrogusto pungente, oppure quello
che si trova in alcuni supermercati, già scongelato, e dunque con l’indicazione specifica di
non essere ricongelato. Questo pone dei limiti alla congelazione che è oggi un metodo
piuttosto utilizzato per assicurarsi del pane fresco nonostante non si provveda ad un acquisto
quotidiano.
Campagna amica è un’associazione nazionale volta a promuovere una filiera agroalimentare
più corta, la provenienza dei prodotti agricoli dai territori circostanti, la stagionalità, il km 0 e
l’assenza di OGM, per una spesa alimentare più consapevole. Nel terzo articolo dello statuto
della Fondazione si pone l’accento sulla promozione della qualità e salubrità nei processi di
136
sviluppo coinvolgenti il territorio, il clima, l’uomo e l’ambiente. «Sono funzionali allo scopo
della Fondazione le attività volte a dar forza alle diverse aree geografiche nazionali,
esaltandone le specificità, le tradizioni produttive e culturali, le peculiarità storico-
paesaggistiche nonché ad alimentare responsabilità e competenze del cittadino-consumatore
inteso come referente e beneficiario delle biodiversità, delle tradizioni e delle culture dei
territori53». Il mercato cittadino si svolge da 4 anni, e lo scorso 28 giugno ha ampliato la sua
sede di attività inserendo un nuovo punto di incontro in centro, in piazza Giovine Italia (il
giovedì mattina) oltre agli a quello di piazza De Gasperi a Masnago (il venerdì mattina).
Un produttore di formaggi di capra D.O.P. del Luinese mi ha spiegato l’importanza di
localizzare il mercato in più punti strategici. Il venerdì serve il parcheggio per rendere più
agevole il trasporto di prodotti grossi e pesanti come le damigiane di vino o di olio. Il giovedì
invece è possibile offrire anche in centro una differente tipologia di prodotti e dare più
visibilità all’iniziativa. Il riscontro è stato molto positivo da parte della popolazione tant’è che
è appena nata la seconda proposta del giovedì. Secondo un produttore di miele questo
mercato era necessario perché risulta molto più comodo rispetto alla vendita in sede di
produzione, scomoda da raggiungere soprattutto per l’acquisto di piccole quantità di prodotti.
Un allevatore di conigli, che vende carni macellate mi ha raccontato che spesso finisce tutto
quello che aveva portato: “oggi mi tocca tornare a casa alle undici anziché all’una perché
non ho più niente da vendere. L’altra settimana c’era la neve e non siamo venuti, e oggi i
nostri clienti, che settimana scorsa non hanno potuto comprare, ci hanno finito le scorte”.
Molti produttori parlano di clienti abituali che una volta scoperto questo metodo di acquisto
lo preferiscono al supermercato Esselunga che si trova lontano poche centinaia di metri.
Capita spesso che vengano finiti alcuni generi come la carne, i formaggi freschi e alcuni tipi
di verdura che hanno prezzi decisamente inferiori. Finora i produttori e trasformatori
coinvolti sono quattordici e offrono: orto-frutta, vini e aceti, formaggi e latticini, carni fresche
e salumi, conserve vegetali e prodotti trasformati, piante e fiori, uova, cereali, riso, farina e
pasta, latte fresco e miele. L’ampliamento e le nuove partecipazioni sono sempre possibili,
anzi, auspicate sia dai produttori che possono contare su una maggiore offerta, sia dai
consumatori, che avranno la possibilità di fare sempre meno acquisti al supermercato. Una
signora mi ha detto: “vengo qua da quando c’è questo mercato; posso venirci anche a piedi
perché abito vicino e al supermercato adesso ci vado molto meno anche perché non mi piace,
53 STATUTO FONDAZIONE CAMPAGNA AMICA http://www.campagnamica.it/fondazione/chi-siamo#statuto-fondazione (Data di accesso: 03/03/13).
137
c’è sempre troppa gente ammassata”.
«I Sistemi Partecipativi di Garanzia (PGS – Participatory Guarantee Systems) sono sistemi
di assicurazione della qualità che agiscono su base locale. La certificazione dei produttori
prevede la partecipazione attiva delle parti interessate (stakeholders) ed è costruita basandosi
sulla fiducia, le reti sociali e lo scambio di conoscenze54».
I Sistemi Partecipativi di Garanzia sono una risposta dal basso ad una domanda di garanzia
che non si basa su modelli di certificazione uniformi e standardizzati che non tengono conto
delle specificità locali. Sono un tipo di certificazione orizzontale e partecipativa in cui ogni
tassello, costituito da un produttore, forma il nodo di una rete di connessioni che si espandono
sul territorio. Questa rete funziona da organismo di controllo in cui il lavoro del singolo viene
valutato da chi, come lui, svolge lo stesso lavoro e conosce le problematiche legate al
territorio, come il clima o le caratteristiche del terreno, potendo così scegliere con maggiore
accuratezza l'importanza che si preferisce attribuire ad alcune problematiche rispetto che ad
altre. Ad esempio in una zona in cui la presenza di terreno agricolo è limitata, come la
Brianza, questo assumerà un ruolo chiave nella lista delle priorità. Oppure è possibile basarsi
su un criterio di equità del lavoro o di utilizzo delle risorse. Il procedimento dà dunque la
possibilità di parlare direttamente con i produttori, cosa che in un sistema di certificazione in
parte terza risulta impossibile. Permette di stabilire rapporti interpersonali tra colleghi da cui
si può trarre un proficuo scambio di opinioni, tecniche di produzione e coltivazione.
Il metodo è costituito da una garanzia in parte seconda differente dalla classica certificazione
di parte terza. «Con il termine "certificazione" si indica l'atto mediante il quale una terza
parte, indipendente dalle parti interessate, attesta che un prodotto, un servizio, un sistema
organizzativo aziendale è conforme ad una specifica tecnica (norma tecnica o regola
tecnica). Questo atto è opera di un organismo, detto organismo di certificazione, che rilascia
un certificato e/o il diritto d'uso di un marchio. E' prevista anche la certificazione di
personale55». In particolare la certificazione dei prodotti si svolge secondo l'«attestazione di
una terza parte indipendente della conformità riferita ad un particolare prodotto o servizio. Si
basa sul controllo del prodotto e del suo processo produttivo, che devono adeguarsi a norme
specifiche, relative a quel tipo di prodotto o servizio: non è applicabile se queste norme non
54 DEFINIZIONE IFOAM - INTERNATIONAL FEDERATION OF ORGANIC AGRICULTURE MOVEMENTS (2008). 55 BOLLETTINO DIPARTIMENTO DI BIOINGEGNERIA – UNIVERSITÀ DI BARI (norme di certificazione). http://www.bioingegneria.uniba.it/bollettino/certificazione/generalita.html (Data di accesso: 11/11/12).
138
esistono56». La certificazione di parte terza infatti fa capo ad una “terza parte indipendente”
che giudica l’idoneità o la non idoneità del sottoposto. Il rilascio di un bollino di garanzia
opera secondo un criterio di esclusione per cui o si è dentro o si è fuori secondo un sistema
binario che non permette gradazioni intermedie. La garanzia di parte seconda invece si basa
su un concetto di fiducia che accetta la presenza di zone meno definite come facenti
inevitabilmente parte del processo produttivo che valorizza le differenti specificità.
Il Sistema Partecipativo di Garanzia dunque vuole essere una sorta di alternativa alla
certificazione biologica in cui i criteri di garanzia sono molto simili, ma si basano su un
differente metodo di controllo meno burocratizzato cercando di superare gli ostacoli che si
possono creare all'interno di un modello di certificazione verticale.
Questo progetto, che comprende i tre Distretti di Economia Solidale (DES) di Varese, Como
e Brianza è ancora in fase sperimentale. Il regolamento e i criteri di valutazione si stanno
perfezionando a seconda delle esigenze e dei problemi sorti in itinere durante le visite svolte
nelle aziende. Queste visite alle piccole aziende che richiedevano di partecipare al progetto
sono cominciate nel 2012. Sono state utili ad assicurarsi di persona che pur non essendo
quelle aziende conformi alle norme europee in materia di biologico, lo siano invece per
quanto riguarda un modello etico e qualitativo condiviso. Le visite si svolgono con una
commissione di persone volontarie e competenti formata da un tecnico dell'azienda sanitaria
locale che definisce gli standard d’igiene, da un altro agricoltore e da un moderatore che si
occupa della parte burocratica. Inoltre sono presenti in numero variabile alcuni uditori
interessati a conoscere più da vicino diverse realtà. Lo scopo del progetto, ancora in fase di
sperimentazione, è quello di garantire le aziende agricole ed inserirle in un circuito di GAS
(Gruppo di Acquisto Solidale). Con i PGS si predilige un consumo critico che implica anche
il sostegno economico a realtà più piccole da chi è disposto a pagare un poco di più per avere
un prodotto che rispecchia maggiormente il proprio modello etico di consumo. Spesso il cibo
viene prodotto e acquistato seguendo il criterio economico. In questo modo invece viene
riqualificato ed inserendo l'alimentazione in una categoria su cui non si è disposti a
risparmiare. Rispecchia la scelta di guardare in faccia la persona a cui vengono dati i soldi
che si sono guadagnati poiché vengono presi in considerazione diversi fattori non solo
economici. Per concludere citerei un intervistato che lamentandosi della scarsa qualità dei
prodotti nei supermercati ha esclamato «i miei soldi sono buoni, e con questi voglio comprare
56 BOLLETTINO DIPARTIMENTO DI BIOINGEGNERIA – UNIVERSITÀ DI BARI (norme di certificazione). http://www.bioingegneria.uniba.it/bollettino/certificazione/generalita.html (Data di accesso: 11/11/12).
139
qualcosa di buono!».
Per GAS s’intendono i Gruppi di Acquisto Solidale che, rispetto ai gruppi di acquisto tout
court si distinguono per l’aggiunta della “S” finale che pone la solidarietà come criterio guida
nella scelte quotidiane di consumo. Questa solidarietà è intesa in senso ampio a partire dagli
stessi membri del gruppo fino a toccare i piccoli produttori ad essi associati che forniscono i
prodotti, passando per la salvaguardia dell’ambiente e delle condizioni di lavoro specifiche.
questi gruppi di acquisto dunque permettono di svolgere un consumo critico acquistando
prodotti di cui si conosce la storia e il metodo di produzione in quanto i fornitori sono scelti
in base a criteri molto precisi e condivisi dal resto del gruppo. Permettono una
riappropriazione ed utilizzo del proprio potere d’acquisto che non viene affidata all’usuale
supermercato rifornito dalle grandi produzioni globalizzate e delocalizzate, come chi ha
detto: “preferisco pagare di più, ma almeno decido io a chi dare i miei soldi”.
Alla base di questa esperienza sta la criticità verso un modello dominante di consumo e la
ricerca di un’alternativa concreta difficile da praticare singolarmente. I GAS infatti sono
costituiti da gruppi di persone che si associano per riuscire ad affrontare acquisti più ingenti a
fronte di una spesa minore. A volte però la spesa non è neanche così bassa, ma si preferisce
appunto accordare la propria preferenza a produttori di fiducia con cui la collaborazione dura
da diverso tempo e che magari già riforniscono un altro gruppo di gasisti che ne garantisce la
qualità: “quando compro lo shampoo mi sveno perché va bene che è un litro, ma costa trenta
euro. Però preferisco questo perché ormai conosco il produttore, siamo amici e non mi va di
togliergli il lavoro” oppure “il nostro GAS preferisce continuare a rifornirsi dallo stesso
produttore di arance anche se ora ne abbiamo trovato uno un po’ più vicino ed economico,
lo consiglieremo al gruppo appena formatosi che ha ancora una rete di produttori poco
ampia”. La scelta dei produttori infatti è molto delicata. Si parte da persone di fiducia che si
conoscono, si consultano siti internet relativi, in genere, a produzioni biologiche che offrono
questo servizio, oppure a volte sono i produttori stessi a farsi vivi. La scelta comunque viene
fatta in genere a seguito di una visita da parte di qualche membro della rete a cui gli altri
membri accordano la loro fiducia. I criteri generali della scelta sono principalmente quattro e
comprendono la grandezza dell’azienda che deve essere abbastanza piccola in modo da
impedire la concentrazione del potere economico nelle mani di pochi. La località della
produzione (soprattutto ortofrutticola a causa del veloce deperimento della merce) per poter
osservare di persona il comportamento dell’azienda ed evitare inutili sprechi energetici e di
trasporto che oltre che essere inquinanti riducono la freschezza del prodotto. Il rispetto delle
condizioni di lavoro che in una piccola azienda vedono un monte maggiore di lavoro manuale
140
che necessita di essere “giustamente” retribuito. Infine il rispetto nei confronti dell’ambiente,
per cui si preferisce supportare la produzione biologica. Una netta differenza, infatti, rispetto
ai criteri di acquisto utilizzati da chi invece preferisce rifornirsi al supermercato è una
differente fiducia nel settore biologico che viene preferito rispetto alla produzione
tradizionale. La fiducia, minata a causa dell’entrata nel settore di grandi multinazionali che
snaturano la concezione originaria resta comunque alta, ma si riferisce principalmente ai
piccoli produttori che ancora seguono i criteri originari. Il progetto PGS analizzato nel
capitolo precedente indica comunque una retrocessione per quanto riguarda la fiducia
originaria accordata a questo tipo di certificazione. “Non è detto che tutte le aziende
biologiche rispecchino i nostri criteri di scelta, come non è detto che tutte le produzioni non
biologiche maltrattano gli animali e usano troppi pesticidi chimici. È vero però che se
compro qualcosa al supermercato preferisco comunque i prodotti biologici come quelli della
linea verde della Coop”. Al supermercato vengono acquistati principalmente prodotti non
alimentari come fazzoletti, alcuni tipi di detersivo, che non vengono forniti dalla lista di
produttori a cui settimanalmente o più sporadicamente (dipende dal prodotto) vengono
presentati gli ordini. Gli acquisti dipenderanno comunque dalla rete di produttori a cui un
GAS è associato e variabile da un gruppo all’altro. Vero è che più un GAS è longevo e
duraturo, maggiore sarà la sua lista di produttori, e quindi di alimenti e non, disponibili. “Il
nostro GAS ha praticamente quasi tutto, mentre a quello di Induno mancano ancora un sacco
di cose perché è appena nato. A breve faremo una riunione in cui gli consiglierò alcuni
produttori che ho scoperto da poco, ma da cui noi non possiamo rifornirci perché abbiamo
già i nostri” mi ha detto una signora. I gruppi della stessa zona infatti hanno una buona
comunicazione anche perché spesso sono fondati da persone che già facevano parte di un
GAS, ma che hanno spostato la loro residenza e deciso di fondarne uno nuovo. A Varese città
i gruppi sono solamente due, ma la nascita di nuovi gruppi è auspicabile, mentre se contiamo
anche quelli dell’intera provincia sono in tutto cinquantacinque al momento.
Differente è anche il criterio di scelta della verdura che è rigorosamente di stagione, infatti la
conoscenza della stagionalità è risultata sensibilmente maggiore rispetto a chi si avvale della
grande distribuzione. Quasi assente tra l’altro l’uso di prodotti confezionati e soprattutto di
surgelati, ai quali viene preferito il metodo casalingo del congelamento di alimenti che
vengono acquistati in quantità più elevate per evitare inutili trasporti. Vengono inoltre
utilizzati metodi tradizionali di conservazione come le marmellate per la frutta o la salsa per
il sugo che spesso viene fatta da più famiglie riunite e non soltanto dal singolo nucleo
famigliare: “a volte facciamo grossi acquisti di frutta proprio per questo motivo”. Il tempo
141
dedicato alla cucina e alla preparazione del cibo può infatti ritenersi un poco più elevata in
quanto aderendo a questo modello vengono scartati per principio una serie di cibi
confezionati precotti e già preparati prediligendo magari preparazioni di piatti meno
elaborati, ma “più buoni e più sani”.
Anche la qualità dei prodotti viene ritenuta superiore: “preferisco spendere di più per il
formaggio di capra perché so da dove arriva, e poi è più buono”. Questa affermazione
effettivamente riassume lo spirito che sottende al consumo critico effettuato dai partecipanti
ai GAS con cui mi è capitato di parlare. Essi danno molta importanza all’alimentazione che
vedono come punto fondamentale dello sviluppo della persona da intendersi sia in termini
meramente biologici che in termini di scelta consapevole e dunque di formazione del
carattere.
142
CONCLUSIONI
In questa tesi analizzo il rapporto quotidiano con l'alimentazione attraverso alcune tendenze
di consumo riscontrate a Varese. Le interviste svolte, non hanno valore puramente statistico,
ma illustrano diversi punti di vista in merito alla questione alimentare. Tramite alcune
conversazioni preliminari ho cercato di catturare gli atteggiamenti e le problematiche più
frequenti nel rapporto con il cibo e nelle logiche di mercato sottostanti. Il modello
distributivo del supermercato, nato alla fine degli anni Cinquanta e impostosi dalla seconda
metà degli anni Sessanta ha ricoperto un ruolo fondamentale per soddisfare le esigenze
alimentari di un crescente numero di persone riversatosi nelle città.
Questo è stato il suo punto di forza: rispondere alle nuove esigenze di un ceto medio urbano
in espansione, ormai non legato all'autosussistenza. L'innovazione è stata accolta con
notevole successo, e non sarebbe potuto accadere altrimenti in quanto altri paesi
industrializzati (in particolar modo gli Stati Uniti) l'avevano già sperimentata e reputata
vincente. La qualità degli alimenti presenti risulta oggi un tema piuttosto dibattuto. Il cibo del
supermercato viene elogiato nel testo della Scarpellini (2007) in cui si racconta la nascita
della catena di supermercati Esselunga, senza che la tesi sia supportata da alcuna
documentazione in merito. Lo studio degli anni Settanta invece, promossa dalla Generale
Supermercati, e quello da me condotto, non individuano la qualità del cibo come causa
principale nella trasformazione della distribuzione, che appare, piuttosto, un passaggio quasi
obbligato.
La direzione che ha assunto la mia ricerca ha sottolineato quanto il modello distributivo
occidentale stia alla base di una scelta del consumatore spesso percepita come obbligata.
Infatti sebbene siano presenti alcune alternative, come i mercati cittadini dei produttori
oppure i gruppi di acquisto solidale, vengono percepite come scomode e non sempre
143
praticabili. Il motivo per cui il supermercato ha prevalso sulla piccola bottega risulta infatti la
mancanza di tempo a disposizione e la comodità di trovare tutto ciò che occorre. Nei mercati
di produttori a volte non è possibile ritrovare tutti i prodotti di cui si ha necessità, per cui un
ulteriore passaggio al supermercato sarebbe necessario, ma purtroppo il tempo a disposizione
per effettuare gli acquisti in due sedi differenti spesso non è concesso. Anche per alcuni GAS
il problema risulta il medesimo perché a volte non sono associati ad un numero sufficiente di
produttori. Inoltre, utilizzando questa modalità di acquisto sarà necessario pianificare il
proprio consumo alimentare settimanale e mensile. Scelta che potrebbe spaventare i meno
avvezzi alla gestione domestica degli acquisti oltre che i single e le famiglie poco numerose,
in cui il consumo alimentare è frammentato e scarso. Inoltre, le distribuzioni alternative non
offrono i piatti pronti, le verdure già tagliate, gli inscatolati ed i surgelati, sempre meno
apprezzati a detta di molti (il 44% degli intervistati predilige il prodotto fresco non lavorato),
ma ugualmente piuttosto utilizzati. Il desiderio di comodità è dunque un elemento cruciale
nel plasmare la tendenza alimentare odierna che, ovviamente, alimenta l'industria
agroalimentare, produttiva e tecnologica. La distribuzione si è adeguata agli standard imposti
dal mercato e regolamentati dalle normative europee, sempre più numerose e specifiche,
assottigliando il margine lasciato alla libera iniziativa individuale. Nell'ultimo capitoli si può
notare come questo ampliamento dell'apparato burocratico abbia messo sotto scacco alcune
piccole produzioni artigianali e familiari a favore di quelle industriali. La progressiva
estensione delle normative ha condannato all’illegalità buona parte della produzione
artigianale; queste leggi risultano poco gradite al 58% degli intervistati che preferirebbe
togliere ai potentati industriali il monopolio sulla propria alimentazione.
La presenza sul mercato di cibi altamente manipolati come i surgelati, i piatti pronti, le
verdure di quarta o quinta gamma che permettono la comodità del risparmio di tempo hanno
però generato una risposta che riguarda la richiesta di cibo più genuino e meno sofisticato.
Questa richiesta è stata accolta, negli anni Ottanta dall'avvento del biologico che sottende un
differente rapporto con la natura. Lo sfruttamento indiscriminato di terreni e animali è stato
riletto in una logica di coesistenza pacifica tra le specie e l'uso di pesticidi e tecniche di
allevamento disumane sono mutate nel rispetto del ciclo di vita di tutti gli organismi viventi.
Vero è però che la crescente richiesta di questi prodotti ha innescato delle devianze all'interno
del progetto originario, tramutandolo in un altro ingranaggio che sottostà alle leggi
economiche della competizione. Nato come alternativa sistemica, attualmente a parere di
molti (solo il 37% gli ha dato fiducia), è stato inglobato nelle logiche di mercato
snaturandone gli intenti originari e passando per una truffa ben organizzata in cui prodotti
144
non biologici vengono venduti come tali. Ecco perché la modalità dell'acquisto diretto e la
richiesta del prodotto locale stanno aumentando: per evitare sofisticazioni e passaggi poco
chiari all'interno della filiera, utili soltanto ad un aumento del prezzo finale. La fiducia negli
alimenti bio risulterà dunque minata anche dai prezzi più elevati che raggiungono in sede di
acquisto. Se la gente è infatti disposta a pagare di più per i prodotti locali e artigianali in un
contesto di vendita diretta, lo sarà di meno per cibi biologici trovati al supermercato in cui i
dubbi sulla reale differenza con quelli tradizionali sono stati ampliati mediaticamente. Inoltre,
la maggiore bontà e genuinità percepita nei prodotti artigianali rispetto a quelli industriali
porterebbe a pensare ad un cambio di tendenza, purtroppo però difficilmente attuabile a causa
della scomodità delle alternative.
L'esigenza di località è riscontrabile anche in una maggiore fiducia nei prodotti di origine
italiana, ritenuti più affidabili rispetto ai corrispettivi stranieri, nonostante queste percezioni
non rispecchino sempre la realtà dei fatti. In queste due tendenze generali però, la voce dei
giovani è stata leggermente dissonante rispetto alle altre due fasce di età. Vi è maggiore
fiducia nel biologico, visto ancora come scelta utile al pianeta ormai prosciugato delle sue
risorse, mentre la provenienza italiana è messa in secondo piano dall'abbassarsi della
diffidenza verso ciò che è straniero nel rispetto della multiculturalità anche alimentare.
Ristoranti etnici e pietanze esotiche sono infatti entrati a far parte della dieta quotidiana,
come kiwi e banane sono divenuti frutti familiari anche a chi li ha visti in commercio soltanto
dopo la fine del secondo dopoguerra. La località dunque risponde principalmente ad una
richiesta di trasparenza dei processi produttivi, per i quali la fiducia sta sfumando, in un
contesto globale ed industrializzato in cui risulta altresì difficile rinunciare alla comodità e
alla lunga conservazione degli alimenti.
La dinamica del rapporto umano con il cibo può essere problematizzata anche attraverso il
rapporto dell'uomo col tempo, ossia con la stagionalità dei prodotti alimentari, con i ritmi
annuali di crescita di piante e animali ormai sconosciuti a più della metà dei miei
interlocutori. Armonizzare i propri ritmi di vita con quelli della natura è un'esigenza primaria
per l'uomo, che però, al tempo stesso persegue l'obiettivo di controllare, modificare e
contrastare i tempi naturali. Sia il Paradiso Terrestre che il Paese della Cuccagna godono di
un'eterna primavera che consente di avere ininterrottamente l'intera gamma di cibi freschi a
disposizione. Scienza e tecnica sono sempre state al servizio di questo progetto, ossia
prolungare o fermare il tempo. L'obiettivo è stato inizialmente perseguito tramite la
biodiversità che permetteva di diversificare i tempi di crescita rendendo alcuni frutti
disponibili durante tutto l'anno come ad esempio le pere nel giardino di Luigi XIV. Le
145
numerosissime qualità presenti gli permettevano di averne di sempre fresche in tavola in ogni
stagione. Oggi le varietà di pere coltivate e commercializzate sono infinitamente minori, ma è
sempre possibile trovarne di fresche grazie alle moderne tecniche di coltivazione e di
trasporto da paesi con un clima più favorevole. Inoltre la conservazione degli alimenti, che
avveniva sotto sale, aceto, olio, o zucchero, oppure tramite essiccazione mediante sole o
fumo, è stata trasformata in maniera tale da non condurre necessariamente ad una
modificazione totale del sapore e della consistenza degli alimenti conservati. Questo è il caso
della surgelazione descritta nel secondo capitolo, in cui l'idea del tempo che viene fermato nel
momento stesso in cui viene attuato il procedimento, per ripartire una volta scongelato il
prodotto, ne è l'esempio più calzante. Anche in altri casi è possibile prolungare i tempi di
conservazione, come per le insalate già tagliate e pronte per l'uso. Se Aristotele infatti
consigliava di evitare il contatto con l'aria per gli alimenti freschi, proponendo la
conservazione di mele nell'argilla (Montanari 2005, p. 20), i sacchetti di insalata sigillati in
atmosfera protetta hanno al loro interno dell'anidride carbonica che ne rallenta il processo di
invecchiamento. L'utilizzo di conservanti mantiene gli alimenti sempre freschi e di
bell'aspetto, ma a discapito della salute individuale, come ha dichiarato l'83% degli
intervistati.
La biodiversità si sta nettamente riducendo a causa delle normative che controllano l'utilizzo
delle sementi (Shiva 2000). Come per le razze canine, anche le specie di animali da
allevamento e le colture sono state ibridate per fornire all'uomo varietà più resistenti e
produttive. Oggi questo modello è stato enfatizzato tramite prodotti di sintesi chimica che
minano la salute delle coltivazioni, degli animali, e degli uomini che se ne nutrono. Inoltre
ono state create in laboratorio delle nuove specie vegetali dai nomi poco naturali (NK603 o
MON810... due varietà di mais), gli OGM, che incrementeranno il patrimonio genetico
immesso nell'ambiente. I problemi che a questo punto sorgono sono numerosi e iniziano con
la diffidenza che si riscontra a livello locale (a Varese solo il 13% delle persone esprime un
parere favorevole agli OGM) e globale. Diffidenza nutrita nei confronti di tutto ciò che non è
“naturale”, nel senso di completamente derivante dalla natura, ritenuta innocua, rispetto ai
metodi di lavorazione e produzione ipertecnologici che utilizzano pesticidi e ormoni per la
crescita animale (rBGH). La paura sta nell'invisibilità del rischio a cui si potrebbe andare
incontro.
Anders (1980) descrive questa situazione come dislivello prometeico. Come per la
costruzione della bomba atomica, anche oggi l'uomo è antiquato rispetto alle sue produzioni
di cui non è in grado di prevederne gli effetti. Il livello di compromissione della salute umana
146
causato da conservanti e OGM è tuttora ignota. Mancano ricerche e studi approfonditi sui
loro effetti a lungo termine a causa dell'immissione preventiva sulla nostra tavola. Inoltre le
variabili sono talmente elevate che l'insorgere di alcune patologie non potrà essere
scientificamente correlata ad un'alimentazione geneticamente modificata e sofisticata.
L'insorgenza di sempre più frequenti casi di intolleranza alimentare è stata ricondotta, da
alcuni intervistati, allo smisurato livello di manipolazione che subisce la maggior parte del
cibo che si trova al supermercato. E la mancanza di dati in merito non fa che incrementare
paure fondate o meno, ponendo l'accento sull'importanza dei controlli effettuati e sulle
normative di sicurezza. La richiesta di cibo genuino sembra aumentare anche a causa
dell'allarmismo diffuso da scandali alimentari all'ordine del giorno resi possibili da una lunga
serie di passaggi intermedi. Il modello tecnologico di produzione del cibo inoltre genera
numerosi dubbi: il 55% di persone dichiara di temere per la propria salute principalmente a
causa di coloranti e additivi presenti negli alimenti, reputati dannosi dall’ 80% degli
intervistati.
La tendenza tecnologica dell'uomo, animale carente, che ha dovuto supplire alle sue
mancanze con efficaci strumenti esterni al proprio organismo, supporta ideologicamente la
cultura dominante dell'uomo al di sopra della natura. L'essenza tecnica dell'uomo (Ghelen
1957) ha trovato un suo corrispettivo nella visione positivistica della natura che ne ha
profondamente influenzato il rapporto. Questa necessità tecnologica ha però portato con se
delle conseguenze negative come un sempre maggiore allontanamento dal mondo empirico
che produce una parcellizzazione ed un'astrazione del sapere nonché una “diminuzione
dell'evidenza e dell'accessibilità al mondo” (Rasini 2008 p. 102). L'idea che l’uomo possa
disporre indiscriminatamente della materia prima naturale è contrastata però dalla visione
opposta, ecologico-culturale, dell'essere umano che non gode di una posizione privilegiata
rispetto agli altri animali, devalorizzati da una lettura semplicistica dell'evoluzionismo
darwiniano (Rivera 2000 p. 35). Neanche Voltaire temette infatti di abbassare la dignità
umana ponendo l'uomo come parte integrante del cosmo e prospettando un senso di
appartenenza comune a tutto ciò che è vivente. In quest'ottica gli animali non sono macchine
per la produzione di latte e altre “merci” in cui la reificazione è totale e il corpo viene usato
come strumento per procacciare all'uomo la dose proteica raccomandata dai nutrizionisti. La
logica di sfruttamento animale risulta possibile grazie all'eliminazione di quel disagio morale
seguito alla loro uccisione che riaffiora nei rituali di compensazione (Bloch 1992): la
mercificazione ipertecnologica dell'animale infatti non lo pone più sul piano dell'essere
vivente e senziente, legittimando trattamenti dannosi sia per l'animale stesso che per l'uomo.
147
Il caso forse più eclatante è quello della mucca pazza.
Due differenti concezioni dell'uomo (come essenzialmente tecnologico o pienamente
collocabile all'interno della natura) saranno dunque rispecchiate dai due differenti modelli di
consumo che ho precedentemente analizzato: lo sviluppo e la decrescita. La prima rispecchia
il modello distributivo dominante, mentre la seconda si rifà alle nuove controtendenze
nascenti dovute alla richiesta di località e naturalità. In ultima analisi, l’esigenza principale
emersa dalla ricerca risulta essere quella del rispetto. Rispetto per il pianeta, per gli animali,
per il lavoro, per il proprio corpo e la propria salute. Salute derivante dalla minore presenza
di sofisticazioni. Rinuncia verso l'abbondanza di cibi, artificiali e ricchi di grassi, che
sformavano il corpo opulento del ricco borghese. Rispetto per il lavoro che necessita
un'adeguata retribuzione a fronte di una diminuzione degli espedienti chimici volti a
massimizzare la produttività. Rispetto per gli animali che non rientrano più nella logica
meccanicistica cartesiana, ma sono visti come nostri simili, dotati di mezzi comunicativi
altrettanto efficaci come quelli descritti da Voltaire (Rivera 2000). Infine rispetto per il
pianeta, la terra, la biodiversità, sconvolta dall'applicazione delle biotecnologie, in cui si
intravede il dislivello prometeico di Anders (1980), congiunte all'illegalità di seminare ciò
che non è sulla lista del catalogo delle sementi. La tendenza alla crescita tecnologica
esponenziale, e apparentemente irrefrenabile, di questi ultimi secoli dovrà dunque
confrontarsi con questi valori, in quanto la fiducia verso l'illimitato sviluppo tecnologico
inizia a vacillare. Le alternative possibili stanno emergendo in forma embrionale ma sempre
più numerose: il quesito che rimane aperto è se queste saranno in grado di resistere o saranno
anch'esse inglobate nella logica del profitto, come è successo per il settore biologico. Inoltre
sarà possibile un compromesso tra il valore che hanno assunto tempo e velocità e la genuinità
degli alimenti locali preparati con cura solo attraverso un più lento processo produttivo?
Una più ampia partecipazione verso iniziative come i mercati cittadini dei produttori o i
gruppi di acquisto solidale, che meriterebbero una maggiore tutela, potrebbero favorire
questo passaggio.
148
BIBLIOGRAFIA
• AGAMBEN G. (1995) Homo sacer: il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino.
• AMBROSIO G. (2002) Siamo quel che diciamo. Il pensiero di qualità in pubblicità, Meltemi, Roma.
• ANDERS G. (1980) L'uomo è antiquato. Sulla distruzione della vita nell'epoca della
terza rivoluzione industriale, Bollati Boringhieri, Torino, 1992.
• ANDERS G. (2013) "Il proletariato è antiquato" in: MicroMega-Almanacco di Filosofia, 1/2013, (pp. 129-150).
• AUGÉ M. (1992) Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità.
Elèuthera, Milano, 2010.
• BASALLA G. (1988) L'evoluzione della tecnologia, Rizzoli, Milano, 1991.
• BAUMAN Z. (2000) Modernità liquida, Laterza, Bari, 2008.
• BAUMAN Z. (2007) Consumo, dunque sono, Laterza, Roma-Bari 2008.
• BAUMAN Z. (2008) L'etica in un mondo di consumatori, Laterza Bari 2010.
• BIANCHI C. (2005) Spot. Analisi semiotica dell'audiovisivo pubblicitario, Carrocci, Roma.
• BLOCH. M. (1992) Da preda a cacciatore. La politica dell’esperienza religiosa,
Cortina, Milano, 2005.
• BOLOGNA G., a cura di; (2010) State of World 2010. Trasformare la cultura del consumo. Rapporto sul progresso verso una società sostenibile, Edizioni Ambiente, Milano.
• BONI S. (2011) Culture e poteri. Un approccio antropologico, Elèutera, Milano.
149
• BOURDIEU P. (1979) La distinzione: critica sociale del gusto, Il mulino, Bologna, 1995.
• BOVONE L. - MORA E., a cura di; (2007) La spesa responsabile. Il consumo
biologico e solidale, Donzelli, Roma.
• BRIGNANI V. (2012) Discount or die: la sublime arte di fare la spesa al discount, Nottetempo, Roma.
• BRILLAT-SAVARIN A. (1825) Fisiologia del gusto, Sellerio, Palermo, 1998.
• BRISEBARRE A.-M. (1991) “Allevamento” in: Dizionario di antropologia e
etnologia, Bonte P. e Izard M., a cura di; Einaudi, Torino, 2006.
• CAGLINI G. (1991) La presentazione dei prodotti nella vendita a libero servizio. Guida pratica per i gestori di superette, supermercati, grandi magazzini, FrancoAngeli, Milano.
• CAPORALI F – LAURO G. (2001) Invenzioni e scoperte. Dalle Origini ai giorni
nostri, Giunti, Milano.
• CAPROTTI B. (2007) Falce e Carrello. Le mani sulla spesa degli italiani, Marsilio, Venezia.
• CARLINI R. (2011) L’economia del Noi. L’Italia che condivide, Laterza, Bari.
• CHIOATO E. (2010) Cibo, corporeità e saperi. Le trasformazioni dell’esperienza
sensoriale nella società delle tecnologie di massa, Prova finale in scienze della cultura, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.
• CODELUPPI V. (2002) Iperpubblicità. Come cambia la pubblicità italiana,
FrancoAngeli, Milano.
• COLOMBO S., a cura di; (1977) Varese. Vicende e protagonisti, Edison, Bologna.
• CORNER P. R. (1993) Contadini e industrializzazione. Società rurale e impresa in Italia dal 1840 al 1940, Laterza, Bari.
• CRESSWELL R. (1991) "Tecnologia" in: Dizionario di antropologia e etnologia,
Bonte P. e Izard M., a cura di; Einaudi, Torino, 2006.
• DECARTES R. (1641) Meditazioni metafisiche, Bompiani, Milano, 1998.
• DIGARD J.-P. (1979) “La Technologie en anthropologie : fin de parcours ou nouveau souffle?”, L'Homme, Vol. 19, No. 1, pp. 73 – 104.
• DI PASQUALE C. (2009) “Dall'automobile al Barroccio: il boom economico e il
ricordo di chi c'era”, Lares. Quadrimestrale di studi demoetnoantropologici, volume LXXV, n°1, gennaio - maggio 2009, pp. 7 – 41, Leo S. Olschki, Firenze.
150
• DIODATO L. - MANNELLI S. (2001) Il linguaggio del cibo. Simboli e significati del
nostro comportamento alimentare, Rubettino, Catanzaro.
• DONGO D. (2011) L’Etichetta. Origine, tabella nutrizionale, ingredienti. Tutte le novità del regolamento europeo, Ilfattoalimentare, Milano.
• DOUGLAS M. (1970) Purezza e Pericolo. Un'analisi dei concetti di contaminazione
e tabù, Il Mulino, Bologna, 2003.
• ELLUL J. (1954) La tecnica. Rischio del secolo, Multa Paucis, Varese, 1969.
• EMINENTE G. (1983) La gestione strategica nelle aziende di grande distribuzione. L’esperienza Generale Supermercati, il Mulino, Bologna.
• FABIETTI U. (2010) Elementi di antropologia culturale, Mondadori Università,
Milano.
• FOUCAULT M. (1975) Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino, 2005.
• FORNI G. (2012) “Produrre. Analisi funzionale e significato dell’agricoltura” in: Il cibo e gli uomini, Mariani L - Pirovano M., a cura di; Rebèl, Cremona, pp. 18 – 32.
• GELEN A. (1957) L’uomo nell’era della tecnica, Armando, Roma, 2003.
• GHISELLI A. - SIRI G. (2012) Surgelati: amici di famiglia. 10 anni dopo... La storia
continua, IIAS - Istituto Italiano Alimenti Surgelati, sl.
• GUIGONI A. (2009) Antropologia del mangiare e del bere, Altravista, Pavia.
• HARRIS M. (1985) Buono da mangiare. Enigmi del gusto e consuetudini alimentari, Einaudi, Torino, 1990.
• HUBERT A. (1991) "Alimentazione" in: Dizionario di antropologia e etnologia,
Bonte P. e Izard M., a cura di; Einaudi, Torino, 2006, p. 50.
• ILLICH I. (1992) Nello specchio del passato, Boroli, Milano, 2005.
• ILLICH I. (2009) La perdita dei sensi, Libreria editrice fiorentina, Firenze.
• INGOLD T.(2001) Elogio della cultura. Meltemi, Roma, 2004.
• IZARD M. (1991) "Tempo" in: Dizionario di antropologia e etnologia, Bonte P. e Izard M., a cura di; Einaudi, Torino, 2006.
• JAILLETTE J.-C. (2000) Il cibo impazzito. Il caso europeo della contraffazione
alimentare, Feltrinelli, Milano, 2001.
151
• LANTERNARI V. (2003) Ecoantropologia. Dall'ingerenza ecologica alla svolta etico-culturale, Dedalo, Bari.
• LATOUCHE S. (2000) La fine del sogno occidentale. Saggio sull'americanizzazione
del mondo, Elèuthera, Milano, 2010.
• LAVENDA R. H. - SCHULTZ E. A. (2010) Antropologia culturale, Zanichelli, Bologna.
• LE BRETON D. (2003) Antropologia del corpo e modernità, Giuffrè, Milano, 2007.
• LE BRETON D. (2006) Il sapore del mondo. Un’antropologia dei sensi, Cortina,
Milano, 2007.
• LEROI-GOURHAN A. (1945) “Ambiente e tecniche”, Volume secondo in: Evoluzione e tecniche, Jaca Book, Milano, 1994.
• LEROI-GOURHAN A. (1964) Il gesto e la parola. Tecnica e linguaggio. Volume
primo, Einaudi, Torino, 1977.
• LEROI-GOURHAN A. (1965) Il gesto e la parola. La memoria e i ritmi. Volume secondo, Einaudi, Torino, 1977.
• LEVI STRAUSS C. (1949) Le strutture elementari della parentela, Feltrinelli,
Milano, 2003.
• LEVI STRAUSS C. (1964) Il crudo e il cotto, Net, Milano, 2004.
• LEVI STRAUSS C. (1968) Le origini delle buone maniere a tavola. Miti, usanze, comportamenti: le loro strutture comuni fra i popoli, EST, Milano, 1999.
• MARAZZI A. (2010) Antropologia dei sensi. Da Condillac alle neuroscienze,
Carrocci, Roma.
• MARIANI L. - PIROVANO M., a cura di; (2012) Il cibo e gli uomini, Rebèl, Cremona.
• MAUSS M. (1965) Teoria generale della magia e altri saggi, Einaudi, Torino, 2000.
• MELE V. (2002) Organismi geneticamente modificati e bioetica, Cantagalli, Siena.
• MILLER D. (1998) Teoria dello shopping, Editori Riuniti, Roma.
• MONTANARI M., a cura di; (2002) Il mondo in cucina. Storia, identità, scambi,
Laterza, Roma.
• MONTANARI M. (2004) Il cibo come cultura, Laterza, Bari 2005.
152
• MONTEDORO G., a cura di; (1985) Definizione ed analisi delle caratteristiche olfattive e gustative degli alimenti, Chiriotti, Torino.
• MOROSINI M. - SACHS W. (2008) Futuro sostenibile. Le risposte eco-sociali alle
crisi in Europa, Edizioni Ambiente, Milano, 2011.
• PELLEGRINI L. (1990) Economia della distribuzione commerciale, Egea, Milano.
• PIROVANO M. (1995) “Aspetti di storia dell’alimentazione popolare nella Brianza lecchese tra Otto e Novecento”, Storia in Lombardia, anno XIV, n.3 pp. 33 - 55.
• PLESSNER H. (1948) Antropologia dei sensi, Cortina, Milano, 2008.
• POLLAN M. (2003) "Il pranzo del futuro" in: Internazionale n° 493, pp. 32 - 35.
• RASINI V. (2008), “Tecnica e natura. Un esempio negativo" in: Ecologia e
sostenibilità. Aspetti filosofici di un dibattito. La Vergata A. - Ferrari G., a cura di; FrancoAngeli, Milano, pp. 95 – 106.
• RILKE R. M. (1992), "Orfeo. Euridice. Hermes", in: Nuove poesie, Einaudi, Torino,
pp. 121 - 122.
• RIVERA A., a cura di; (2000) Homo Sapiens e mucca pazza. Antropologia del rapporto con il mondo animale, Dedalo, Bari.
• ROSSI P. (2011), Mangiare, Il Mulino, Bologna.
• RUSSELL SHARMAN A. (2005) Fame. Una storia innaturale, Codice edizioni,
Torino, 2006.
• SCARPELLINI E. (2001) Comprare all'americana. Le origini della rivoluzione commerciale in Italia 1945 – 1971, il Mulino, Bologna, 2002.
• SCARPELLINI E. (2007) La spesa è uguale per tutti. L'avventura dei supermercati in
Italia, Marsilio, Venezia.
• SCARPELLINI E. (2008) L'Italia dei consumi. Dalla Belle Epoque al nuovo millennio. Laterza, Bari.
• SCHOPENHAUER A. (1831) L'arte di ottenere ragione, Adelphi, Milano 1991.
• SEPPILLI T. (1994) “Per una antropologia dell’alimentazione. Determinazioni,
funzioni e significati psico-culturali della risposta sociale a un bisogno biologico”, in: La Ricerca Folklorica n° 30, Antropologia dell’alimentazione, pp. 7 - 14, Grafo, Brescia.
• SERINO V. (2003) L'umanità a tavola. Visioni del mondo e culture alimentari.
Elementi per una storia sociale del cibo. Pontecorboli, Firenze.
153
• SORCINELLI P. (1992) Gli italiani e il cibo. Appetiti digiuni e rinunce dalla realtà contadina alla società del benessere, CLUEB, Bologna.
• SHIVA V. (2000) Vacche sacre e mucche pazze. Il furto delle riserve alimentari
globali, DeriveApprodi, Roma, 2001.
• SPRANZI A. (1991) "Il processo di ammodernamento del sistema distributivo in Italia. in: Il cammino del commercio dal baratto al codice a barre, Leonardo-De Luca, Milano.
• STELLA M., a cura di; (2010) Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e
vendita di prodotti alimentari. Merceologia, Promovarese, Varese.
• TESTA A. (2004) La pubblicità, il Mulino, Bologna.
• UNDERHILL P. (2004) Antropologia dello shopping. Il fascino irresistibile dei centri commerciali, Sperling & Kupfer, Torino.
• VERGANI, G. (2012) Verso una garanzia dal basso: il cibo prodotto dietro casa,
Cesate (MI), Conferenza del 09/11/2011, Ufficio Ambiente Cesate.
• VIALE G. (1994) Un mondo usa e getta. La civiltà dei rifiuti e i rifiuti della civiltà, Feltrinelli, Milano.
• VILLARINI A. (2011) Scegli ciò che mangi. Guida ai cibi che aiutano a proteggere
la salute. Sperling & Kupfer, Milano.
• VOLLI U. (2003) Semiotica della pubblicità, Roma, Laterza.
• ZAGHI A. (2009) OGM e consumatore: il ruolo della conoscenza e della fiducia nelle fonti d’informazione attraverso la Teoria del Comportamento Pianificato. Tesi di dottorato in Economia e statistica agroalimentare. Università degli Studi di Bologna.
• ZONABEND F. (1980) La memoria lunga. I giorni della storia, Armando, Roma,
2001.
• (s. a.), (1931) Casadoro. Piccolo consigliere della signora moderna, Omaggio della Compagnia Italiana Liebig, Milano.
• (s. a.), (2003) “Mangiare Biologico” in: Internazionale n° 506, p. 55, Tratto da: La
Recerche, Francia.
• (s. a.), (2007) “Votare al supermercato” in: Internazionale, n° 684, pp. 32 - 33. Tratto da: The Economist, Gran Bretagna.
• (s. a.), (2008) "Il granaio biologico dell’Europa" in: Internazionale, n° 766, p. 78.
Tratto da: Zaman, Turchia.
154
SITOGRAFIA
ACCREDIA – ENTE NAZIONALE DI ACCREDITAMENTO. http://www.accredia.it/UploadDocs/384_LS_11rev06.pdf [Data di accesso: 11/11/12]. BIOSAFETY CLEARING HOUSE ITALIANA – MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. http://bch.minambiente.it/IT/Legislazione/index.asp [Data di accesso: 16/11/12]. CAMPAGNA GREENPEACE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DI ALIMENTI OGM. http://www.greenpeace.org/italy/it/campagne/ogm/Allarme-OGM/ [Data di accesso: 15/02/13]. CIBO BIOLOGICO, SEQUESTRATE IN TUTTA ITALIA 1700 TONNELLATE DI SOIA "MODIFICATA". http://www.repubblica.it/cronaca/2012/06/14/news/sequestro_falsa_soia_biologica-37163100/?ref=search [Data di accesso: 28/02/13]. DATI ISTAT 2011 http://demo.istat.it/bilmens2011gen/query.php?lingua=ita&Rip=S1&Reg=R03&Pro=P012&Com=133&submit=Tavola [Data di accesso 04/03/2013]. DEFINIZIONI STATISTICHE ESERCIZI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA (CAMERA DI COMMERCIO). http://images.ca.camcom.gov.it/f/studiestatistica/de/def_eser_gdo2012.pdf [Data di accesso 24/02/2013]. DIPARTIMENTO DI BIOINGEGNERIA - UNIVERSITÀ DI BARI. http://www.bioingegneria.uniba.it/bollettino/certificazione/generalita.html [Data di accesso: 11/11/12]. DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ IGP "LARDO DI COLONNATA"
155
http://www.agroqualita.it/_files/dc_colonnata_rev04_lardo_macinato_affettato.pdf [Data di accesso: 24/02/13]. EFSA – EUROPEAN FOOD AND SAFETY AUTHORITY. http://www.efsa.europa.eu/ [Data di accesso: 16/11/12]. EUROPEAN COMMISSION HEALTH AND CONSUMERS. http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm [Data di accesso: 16/11/12]. GENUINO CLANDESTINO. http://genuinoclandestino.noblogs.org/ [Data di accesso: 13/12/2012]. GRAFICO CONSUMI RETALI SURGELATI http://www.istitutosurgelati.it/images/consumi/retail%20+catering%202011.pdf [Data di accesso 03/03/2013]. GRAFICO FREQUENZA CONSUMO SURGELATI http://www.istitutosurgelati.it/component/content/article/31-area-riservata/63-contenuti-area-riservata-documenti.html [Data di accesso 21/02/13]. IFOAM – INTERNATIONAL FEDERATION OF ORGANIC AGRICULTURE. MOVEMENTS. http://www.ifoam.org/index.html [Data di accesso: 10/11/12]. INTERNATIONAL WORKSHOP ON ALTERNATIVE CERTIFICATION. http://www.ifoam.org/about_ifoam/standards/pgs/pdfs/InternationalWorkshopOnAlternativeCertification_Torres_en.pdf [Data di accesso: 11/11/12]. ISAAA – INTERNATIONAL SERVICE FOR THE ACQUISITION OF AGRI-BIOTECH APPLICATIONS. http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/xx/executivesummary/default.asp [Data di accesso: 11/11/12]. LISTA COMPLETA DELLE VARIETA OGM PRESENTI SU SUOLO EUROPEO, SIA COLTIVABILI CHE IN FASE DI SPERIMENTAZIONE. http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm [Data di accesso: 15/11/2012].
156
MINISTERO DELLA SALUTE: AUTOCONTROLLO E HACCP. http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/paginaInternaMenuSicurezzaAlimentare.jsp?id=1225&lingua=italiano&menu=igiene [Data di accesso: 13/12/2012]. MINISTERO DELLA SALUTE: IGIENE GENERALE DEGLI ALIMENTI. http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/paginaInternaMenuSicurezzaAlimentare.jsp?id=1160&lingua=italiano&menu=igiene [Data di accesso: 13/12/2012]. MINISTERO DELLA SALUTE: L’IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI. http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/paginaMenuSicurezzaAlimentare.jsp?menu=igiene&lingua=italiano [Data di accesso: 01/03/2013]. OGM, SEQUESTRATI L’AZIENDA E I CAMPI DI GIORGIO FIDENATO http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2011/04/05/news/ogm-sequestrati-l-aziendae-i-campi-di-giorgio-fidenato-1.48751 [Data di accesso: 15/02/13]. IL*RUOLO DEGLI ALIMENTI SURGELATI NELLE SCELTE ALIMENTARI DEGLI ITALIANI. http://www.istitutosurgelati.it/component/content/article/31-area-riservata/63-contenuti-area-riservata-documenti.html [Data di accesso: 21/02/13]. IL*SOLE 24 ORE: “OLTRE 4500 LE «SPECIALITÀ» RICONOSCIUTE DAL MINISTERO” http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2010-07-19/oltre-4500-specialita-riconosciute-080441_PRN.shtml [Data di accesso: 24/02/13]. STATUTO FONDAZIONE CAMPAGNA AMICA http://www.campagnamica.it/fondazione/chi-siamo#statuto-fondazione [Data di accesso: 03/03/13]. LA*TRUFFA DEI PRODOTTI “BIO”. http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/12/13/truffa-prodotti/177141/ [Data di accesso: 28/02/13]. UNIONE EUROPEA – SEZIONE LEGISLATIVA. http://eur-lex.europa.eu/it/tools/about.htm
157
[Data di accesso: 11/11/12]. U.S. FDA – FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. http://www.fda.gov/ [Data di accesso: 07/11/12].
DOCUMENTI GIURIDICI
Vol. 57 No. 104 Friday, May 29, 1992 p 22984 DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, Food and Drug Administration [Docket No. 92N-0139] http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/Biotechnology/ucm096095.htm [Data di accesso : 07/11/12]. REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO, DEL 24 GIUGNO 1991. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991R2092:IT:HTML [Data di accesso: 11/11/12]. DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 110. http://www.salute.gov.it/alimenti/resources/documenti/sicurezza/D_Lvo_27_gennaio_1992_%20n_110.pdf [Data di accesso 03/03/2013]. REGOLAMENTO (CE) 852/2004. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:it:PDF [Data di accesso: 13/12/2012]. REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO, DEL 28 GIUGNO 2007. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:01:IT:HTML [Data di accesso: 11/11/12]. REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE, DEL 5 SETTEMBRE 2008. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:01:IT:HTML [Data di accesso: 11/11/12]. REGOLAMENTO (CE) N. 1235/2008 DELLA COMMISSIONE, DELL’ 8 DICEMBRE 2008.
158
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:334:0025:01:IT:HTML [Data di accesso: 11/11/12]. REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 Ottobre 2011. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:IT:PDF [Data di accesso: 01/02/13]. SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 06/09/2012 IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SULLA COLTIVAZIONE DI MAIS OGM MON810 IN ITALIA. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126437&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1195160 [Data di accesso: 15/02/13].
FILMOGRAFIA
Baraka (1992) Documentario, diretto da Ron Fricke, USA. Behind the label. The double face of indian cotton (2012) Documentario, diretto da Sebastiano Tecchio e Cecilia Mastrantonio, Italia. Genuino Clandestino. Pratiche di resistenze contadine (2011) Documentario, diretto da Nicola Angrisano, Italia. Le monde selon Monsanto (2008) Documentario, diretto da Marie-Monique Robin, Francia. Super Size Me (2004) Documentario, diretto da Morgan Spurlock, USA.
159
APPENDICE
Sono state realizzate 60 interviste ripartite in tre fasce di età:
• Giovani: dai 20 ai 40 anni;
• Adulti: dai 40 ai 60 anni;
• Anziani: dai 60 agli 80 anni.
•
Un'ulteriore divisione è stata fatta in base al genere:
• Uomini: 29 interviste;
• Donne: 31 interviste.
Le interviste sono state effettuate nel periodo che va da novembre 2012 a gennaio 2013.
I luoghi di somministrazione del questionario sono stati:
• Parcheggio centro commerciale Belforte al cui interno si trova l'ipermercato Iper;
• Piazzale di fronte ad un piccolo supermercato Sisa;
• Centro di un piccolo quartiere (Valle Olona) in cui si trovano ancora alcune botteghe
tradizionali;
• Mercato cittadino.
QUESTIONARIO UTILIZZATO PER LA RICERCA
a. PER FARE IL SUGO SOLITAMENTE UTILIZZA:
(pomodori - passata - sugo pronto)
b. COSA PREDILIGE UTILIZZARE PER PREPARARE I DOLCI:
(ingredienti - torte semilavorate - dolci confezionati)
160
c. QUALE TIPO DI PESCE CONSUMA MAGGIORMENTE:
(pesce fresco - filetto già tagliato e confezionato - tonno in scatola o surgelato)
1. CONSUMA SPESSO57 LE COSE DEL BANCO FREEZER / SURGELATI?
2. QUALI CRITERI UTILIZZA QUANDO ACQUISTA LA VERDURA?
3. QUALI CRITERI UTILIZZA PER LA SCELTA DI UN PRODOTTO CONFEZIONATO IN
CUI NON SI VEDE COSA C’È DENTRO? (ES: BISCOTTI)
4. È IMPORTANTE PER LEI LA PROVENIENZA ITALIANA DEGLI ALIMENTI?
5. SI FIDA DELLE MARCHE PRESENTI SULLE CONFEZIONI COME SINONIMO DI
GARANZIA?
6. COSA NE PENSA DEI PRODOTTI BIOLOGICI?
7. COSA NE PENSA DEGLI OGM?
8. QUANTO È SODDISFATTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI NEI SUPERMERCATI?
(molto - abbastanza - poco - per niente)
9. SI PROCURA GENERI ALIMENTARI ANCHE ALTROVE OLTRE CHE AL
SUPERMERCATO? E SE SÌ DOVE?
10. TRA UN PRODOTTO INDUSTRIALE E UNO PREPARATO IN CASA (ES:
MARMELLATA) QUAL È:
• più igienico?
• più salutare?
• più buono?
• quale preferirebbe se potesse scegliere?
11. TRA IL FORMAGGIO CONFEZIONATO DEL SUPERMERCATO E QUELLO
PRODOTTO DA UNA PICCOLA AZIENDA AGRICOLA QUAL È:
• più igienico?
• più sano?
• più buono?
• quale preferirebbe se potesse scegliere?
12. PERCHÉ SCEGLIE DI RECARSI AL SUPERMERCATO?
13. È SODDISFATTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI SUGLI ALIMENTI?
57 Almeno due volte la settimana.
161
14. COSA NE PENSA DEI COLORANTI E DEGLI ADDITIVI PRESENTI NEGLI
ALIMENTI?
15. HA PAURA CHE QUELLO CHE MANGIA POTREBBE DANNEGGIARE LA SUA
SALUTE?
16. SE UN PRODOTTO CHE HA IN CASA È SCADUTO:
(valuta se mangiarlo - lo elimina direttamente)
17. CONOSCE QUANDO MATURANO:
• le cipolle?
• gli asparagi?
• i porri?
18. È AL CORRENTE CHE ALCUNI CONTADINI NON POSSONO VENDERE I LORO
PRODOTTI PERCHÉ NECESSITANO DI UN LABORATORIO DI LAVORAZIONE A
NORMA DI LEGGE: COSA NE PENSA?
APPROFONDIMENTI DOMANDE
• a, b, c, sono domande a risposta chiusa utili per valutare la preferenza di un prodotto
fresco, semilavorato o lavorato.
1. La frequenza di acquisto dei prodotti surgelati è utile per valutare il rapporto con un
alimento che non conserva le caratteristiche originarie e la cui produzione necessita di
tecnologie avanzate non riproducibili autonomamente
2. Con questa domanda intendo quali tra tutte le tipologie di ortaggi proposti al
supermercato sceglie, e una volta deciso, come fa a scegliere quelli da mettere nel
proprio carrello. Questione utile a vagliare le modalità sensoriali attivate.
3. Qui si chiede in che modo avviene la scelta di un alimento che non viene visto
direttamente e la fiducia riguardante le informazioni in etichetta.
4. Questa domanda riguarda l’esigenza di località che nel supermercato si traduce con la
provenienza italiana rispetto ai prodotti di provenienza europea o extraeuropea.
5. Quanto conta la marca commerciale nella scelta di un prodotto e qual è il livello di
fiducia che le viene attribuito?
162
6. Vuole vagliare il rapporto con un tipo di produzione che si presenta diversamente da
quella industriale tradizionale.
7. Gli OGM sono prodotti ancora poco diffusi in Italia, ma come verrebbero accolti se i
supermercati dovessero cominciare a distribuirne grandi quantità?
8. Anche questa domanda è a risposta chiusa e le quattro possibilità offerte si riferiscono
a come viene percepita la qualità dei prodotti offerti dalla grande distribuzione e qual
è il grado di soddisfazione di chi se ne nutre.
9. Il supermercato non è l’unico luogo per reperire generi alimentari. Quali altri canali
alternativi o complementari vengono utilizzati da chi si serve anche della grande
distribuzione?
10. Questa domanda, si divide in altre quattro sotto-questioni riguardanti l’igiene, quanto
il prodotto “fa bene” all’organismo e quale viene preferito in termini sia gustativi che
di scelta finale (nel caso entrambi fossero posti davanti). La questione valuta le
qualità del prodotto artigianale rispetto a quello industriale su questi quattro fronti.
11. Vedi spiegazione domanda n°10.
12. Quali sono le motivazioni principali che spingono le persone a recarsi al supermercato
piuttosto che scegliere una diversa forma d’acquisto?
13. La scarsa trasparenza che la lavorazione industriale offre in molti passaggi della
filiera presuppongono dei controlli ben organizzati che tutelano il consumatore. Come
vengono effettuati questi controlli e qual è la fiducia che in essi si ripone?
14. Qual è l’opinione sulle sofisticazioni quali additivi, coloranti e conservanti
addizionate agli alimenti per modificare ed uniformare gusto e colore, utili a
perseguire una produzione standardizzata?
15. Premettendo che l’alimentazione condiziona notevolmente il nostro livello di salute
fisica, il tipo di alimentazione odierna può mettere a rischio la salute del
consumatore?
16. Anche questa domanda è a risposta chiusa e vuole indagare i sensi attivati nel
rapporto col cibo e la fiducia nelle informazioni presenti in etichetta come la data di
scadenza.
17. Questa domanda è l’unica che presuppone delle conoscenze specifiche e non si basa
sulle proprie percezioni o dichiarazioni. È volta ad indagare la conoscenza del
processo di crescita di alcuni ortaggi emblematici a causa di alcune loro
caratteristiche. La cipolla è stata scelta poiché è uno degli ortaggi più utilizzati e
sempre presenti in casa come utile base per ogni tipo di soffritto. L’asparago è tipico
163
della zona Prealpina, mentre i porri essendo meno conosciuti presuppongono delle
conoscenze più specifiche. Valuta le informazioni riguardanti alcuni processi naturali
rese inutili dalla sovrabbondanza di prodotti ortofrutticoli disponibili in ogni stagione.
18. Quest’ultima domanda solleva una questione giuridica in rapporto alla pericolosità
degli alimenti non controllati secondo i canoni tradizionali. Valuta la richiesta di
potersi affidare ai produttori e non alle istituzioni di controllo per quanto riguarda le
piccole produzioni. Infatti i prodotti sono ugualmente garantiti grazie ad alcune
modalità come la vendita diretta e la possibilità di verificare personalmente metodi e
ingredienti utilizzati.
164
Lo studio analizza le percezioni riguardanti prodotti alimentari, industriali ed artigianali, ed il
rapporto che intercorre tra la preparazione industriale del cibo e le nuove tecnologie che la
supportano. Inoltre analizza aspetti positivi e negativi della grande distribuzione confrontata
con alcuni metodi alternativi di acquisto e certificazione esterni a questo circuito. La ricerca
condotta a Varese, basata su sessanta questionari e interviste libere, tocca anche la questione
salute per quanto riguarda i timori derivanti dall'assunzione di alcuni alimenti sofisticati o
contaminati. Le tendenze emerse inoltre sottolineano la richiesta di “località” unita alla
trasparenza all'interno della filiera alimentare e in tutte le fasi di lavorazione del prodotto.
The essay hereafter inspects the perceptions about foodstuffs, both industrial and handcraft
foods, and the relation between alimentary's industrial production and the new technologies
involved. It also analyses different aspects of mass distribution compared to alternative
markets free from current regulations and certifications. The study, that has been carried out
in Varese and based on sixty questionnaires and pubblic interviews, mentions also health
issues, particularly the fears and doubts raised by adulterated and contaminated foods
consumption. The emerging tendencies highlight the need of more transparency within the
food's production process, as well as a rising inclination for locally-made products.