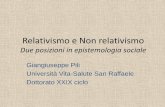Riconoscersi. Corpo e gender tra individuale e sociale
Transcript of Riconoscersi. Corpo e gender tra individuale e sociale
verificheAnno XLII, N. 1-3 Gennaio-Settembre 2013
Dir. Responsabile: Mario Rigoni • Amministrazione: Casella postale 269 - 38100Trento - c.c.p. 16677387 • Autorizzazione Tribunale di Trento n. 168 del 13.7.72 •
Spedizione in abbonamento postale gr. IV - Pubblicità inf. al 70% • Composizione estampa: Litocenter s.r.l. - Piazzola sul Brenta (PD) - Via G. Rossa, 17 • A. XLII N. 1-3 2013
Riconoscersi.Corpo e gender tra individuale e socialeA cura di Valentina Chizzola e Stefanie Knauss
3 Introduzionedi Valentina Chizzola, Stefanie Knauss
SAGGI
9 Circumcisions. Jacques Derrida and the Tensionsbetween Particularism and Universalismby Luca Di Blasi
33 Recognition. Reflections on a Contested Conceptby Boris Rähme
61 Che cosa viene perso nella costituzione di un’identità sessuale?di Catherine Malabou
75 Corpo, gender e costituzione del soggetto. Fichte e la questione della neutralità del corpo umanodi Benedetta Bisol
93 L’intersessualità in famiglia. La chirurgia genitale (in età pediatrica) è l’unica via possibile?di Vera Tripodi
119 Transgender Trouble. A Transdisciplinary Approach to Transsexual Rightsby Gloria Origgi, Sandra Martini Vial
139 Is There Any Problem with Gender-specific Medicine?by M. Cristina Amoretti, Nicla Vassallo
157 Resistenze. L’enigma dei corpi disabili tra spazio pubblico e pratica religiosadi Marcello Neri
183 It’s All About Sex. The Peculiar Case of Technology and Genderby Alexander D. Ornella
215 The Bride of Christ and the Church Body Politicby Susan Ross
231 The Work of Pleasure. Technologies of Gender and Neoliberal Subjectsin the Age of Reaganby Barbara Antoniazzi
Verifiche XLII (1-3), 2013, pp. 3-8.
RICONOSCERSI. CORPO E GENDER TRA INDIVIDUALE E SOCIALE INTRODUZIONE di Valentina Chizzola e Stefanie Knauss
I saggi qui raccolti declinano, ciascuno a modo loro, l’in-
treccio tematico che si snoda attorno al concetto di corpo in relazione a ciò che del corpo è (e resta) individuale e ciò che invece lo caratterizza nella sfera pubblica e sociale. Nella com-plessità del panorama filosofico contemporaneo, una delle tesi più discusse è quella che vede il singolo da un lato come il prodotto della socializzazione, del linguaggio, dei simboli in cui vive, dall’altro invece come persona individuale, unica e quindi porta-trice di diritti particolari, che, a loro volta, debbono essere rispet-tati e tutelati dalla collettività. Questa fitta trama si compone di un elemento indispensabile, ovvero quello della necessità di ricono-scere l’individuale nel collettivo e, viceversa, essere riconosciuti/e come individualità all’interno della molteplicità che caratterizza il nostro essere sociali. La stretta relazione tra riconoscimento e identità viene infatti alla luce prendendo in considerazione un aspetto cruciale dell’esistenza umana, ovvero il suo carattere fon-damentalmente dialogico: «diventiamo degli agenti umani piena-mente sviluppati, capaci di comprendere noi stessi e quindi di definire la nostra identità, attraverso l’acquisizione di un ricco linguaggio espressivo umano»
1. È attraverso lo scambio con altre
persone che apprendiamo e acquisiamo i linguaggi necessari per la nostra autodefinizione, che non è affatto un processo solitario, ma avviene attraverso il dialogo che instauriamo con il mondo esterno
2.
Tale dialogo prende talvolta le vesti di una lotta tra ciò che noi definiamo la nostra propria identità e ciò che gli altri invece
1 C. TAYLOR, La politica del riconoscimento, in J. HABERMAS - C. TAYLOR, trad. it., Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, Milano 1998, p.17. 2 Cfr. ibidem.
Valentina Chizzola e Stefanie Knauss Introduzione 4
vedono o vogliono vedere in noi. Nonostante si possano mettere in atto tentativi di emancipazione e di isolamento dalle/dagli altre/i, il contributo esterno nella definizione di noi stessi/e, continua in maniera inevitabile. Il processo di riconoscimento allora, inteso come stretta e incessante relazione reciproca tra noi come individui e il resto del mondo (che a sua volta si declina in altri individui, in stato, in norme, leggi, religioni, linguaggi tecno-logici ecc.) può essere considerato uno dei fili rossi sottesi a tutti gli interventi qui proposti.
Se la relazione tra individuale e collettivo rappresenta un elemento comune a tutti i contributi qui raccolti, denominatore comune è esplicitamente il corpo inteso come l’ambito in cui vengono ad essere i significati fondamentali e primari della sfera dell’umano (nascita, vita, morte, malattia, piacere, dolore, salute ecc.), e contemporaneamente esso si caratterizza di una struttura intrinsecamente bivalente, binaria e, talvolta, ambigua. Il corpo è infatti contemporaneamente soggetto e oggetto, ciò che ci per-mette la relazione con il mondo, ma anche ciò che ci distingue dal mondo e che ci separa da esso. Esso è oggetto di ‘esplorazione’ per quanto riguarda la sua ‘materialità’ da parte delle scienze, ma contemporaneamente è il soggetto dell’unica esperienza possibile, ed è condizione necessaria per qualsiasi esperienza.
L’attribuzione di un genere al corpo gioca un ruolo fonda-mentale nella creazione di relazioni intersoggettive, di riconosci-mento di sé come appartenente ad un gruppo e di formazione di gerarchie sociali. Il corpo in quanto corpo genderizzato contras-segna in modi differenti sia l’immaginario individuale, che quello collettivo. Se da un lato l’intreccio tra il corpo individuale e la creazione di identità ha una lunga storia all’interno del panorama concettuale definito dalla filosofia, dalle scienze religiose, dalle discipline sociali, biologiche ecc., lo stesso non si può dire per quanto concerne il legame tra la corporeità e il sociale, ovvero per l’indagine del corpo individuale come già da sempre costituito relazionalmente. Basti solo pensare come esempio che la rivista Body and Society, una delle più rilevanti per gli studi sociali sul corpo, ha origini alquanto recenti.
In questa raccolta di saggi, che originano, in parte, da un se-minario tenutosi presso il Centro di Scienze Religiose della Fon-
Introduzione Riconoscersi 5
dazione Bruno Kessler nel dicembre 2011, abbiamo quindi cerca-to di focalizzare l’attenzione sulla dinamica relazionale che emer-ge nel momento in cui il corpo viene compreso e osservato all’interno del suo essere nel collettivo e nelle relazioni reciproche tra individuo e collettivo focalizzate spesso nel corpo, sia reale che metaforico. I saggi qui raccolti possono apparire quindi molto diversi tra loro, ma li accomuna, come già notato, l’analisi della corporeità nelle sue molteplici sfaccettature: come corpo sessuato, come corpo neutro, come corpo individuale, come corpo sociale, come corpo riconosciuto ecc.
Luca Di Blasi, partendo dal giudizio del tribunale di Colonia di considerare la circoncisione sui bambini alla pari di una lesione corporale, attraverso una discussione dei testi di Jacques Derrida su questo tema, mette in luce le simbolizzazioni della circoncisio-ne e le inevitabili tensioni tra particolarismo (religioso) e universa-lismo (di diritti) che, nel caso specifico della circoncisione, si intrecciano proprio nel corpo individuale. Tensioni tra particolare e universale si evidenziano anche nel testo di Boris Rähme che, analizzando il riconoscimento nelle sue varie dimensioni (come attitudine, relazione e atto), mostra come riconoscere l’altro e il diverso richieda una reciprocità ermeneutica ed epistemica. Pren-dendo come punto di partenza la teoria del riconoscimento di Axel Honneth, mette in discussione il tentativo di Robert Brandom di spiegare il Selbstbewusstsein in termini di un riconosci-mento riflessivo mediato da relazioni sociali. Rähme
propone
infine una critica dell’uso che Judith Butler fa del concetto di riconoscimento nella sua riflessione etica.
Con il saggio di Catherine Malabou entriamo più esplicita-mente in una discussione del corpo sessuato e genderizzato. Nel prendere in considerazione la teoria di Judith Butler sullo svilup-po dell’identità sessuale come una perdita da elaborare, Malabou si chiede se non vi sia, nell’individuo, una predisposizione al lutto, alla perdita che si sostituisce alla disposizione maschile-femminile. Secondo l’autrice, questa predisposizione potrebbe indurci a superare la dicotomia sessuale pensata da sempre come iscritta nei corpi.
Anche Benedetta Bisol discute il corpo sessuato, riferendosi all’interpretazione fichtiana del corpo come infinita capacità di
Valentina Chizzola e Stefanie Knauss Introduzione 6
movimento e di azione all’interno del mondo. In quest’ottica concettuale il corpo diviene neutro, non soggetto a determinazio-ni di tipo sessuale, né maschio né femmina. E a tutto ciò ben si collega la critica contemporanea nei confronti della binarietà del genere e delle implicazioni della consolidata distinzione maschi-le/femminile. Il saggio di Vera Tripodi ci apre uno scorcio sul tema dell’intersessualità: muovendosi sullo sfondo di alcune polemiche sulle differenze sessuali, Tripodi prende in analisi gli aspetti etico-culturali degli interventi chirurgici su bambine e bambini intersessuali riconsiderando le tradizionali distinzioni di sesso biologico e genere culturale. Il problema dell’intersessualità, suggerisce Tripodi, può fungere da luogo eccezionale per proble-matizzare concetti apparentemente statici e consolidati, come, ad esempio, quello di binarietà sessuale, quello di corpo sessuato ecc.
Sesso e genere, talvolta radicalmente distinti, talaltra conside-rati unificabili nella loro costruzione sociale, come ha proposto Judith Butler, sono oggetto privilegiato di indagini interdisciplina-ri. È quest’altro un ulteriore filo rosso che scorre in tutti i saggi e, in particolare, nel saggio di Gloria Origgi e Sandra Martini Vial: le studiose sottolineano quanto la scarsa considerazione del concet-to di gender da un punto di vista interdisciplinare comporti con-seguenze pesanti anche sulle decisioni politico-giuridiche in mate-ria di riconoscimento dei diritti dei/delle transessuali. Una considerazione a tutto tondo della transessualità porta infatti a riconsiderare radicalmente i disordini concettuali che caratterizza-no differenti interpretazioni sull’identità sessuale. D’altra parte, la considerazione dell’aspetto biologico delle differenze sessuali – e l’integrazione di esso con ciò che di culturale può modificare il nostro essere biologico – risulta fondamentale anche all’interno della medicina di genere che indaga, tra l’altro, il rapporto esisten-te tra l’appartenenza ad un genere sessuale e l’efficacia di deter-minate terapie mediche. Cristina Amoretti e Nicla Vassallo valuta-no criticamente questa recente disciplina dal punto di vista epistemologico, cercando di individuare strategie volte al miglio-ramento della considerazione medica del genere.
All’interno della critica al tentativo più o meno evidente della società contemporanea di appiattire le differenze e di neutralizzar-le, si colloca il saggio di Marcello Neri che presenta la disabilità
Introduzione Riconoscersi 7
come un esempio magistrale di misconoscimento delle ‘limitazio-ni’ del corpo da parte della società tecnologica contemporanea. Limitazioni corporee, che qui vengono intese sotto l’aspetto concettuale di differenze, potrebbero sembrare distanti dalla considerazione, per lo più accettata, della tecnologia come un qualcosa di neutro, che non fa differenze e che non ha alcun legame con il sesso. In realtà, come suggerisce Alexander Ornella, osservando da vicino il linguaggio adottato nei discorsi delle tecnologie informatiche, ci possiamo rendere conto di quanto esso sia intriso di stereotipizzazioni di genere. Molto spesso, infatti, afferma Ornella, la tecnologia diviene un veicolo per rafforzare gli stereotipi tradizionali ed è quindi assai lontana dall’intento innovativo e progressivo di superare le differenze su cui si fonda, o da cui, per lo meno, è originata.
La forza delle immagini che divengono sessuate e che contri-buiscono all’organizzazione della società e dei corpi che la costi-tuiscono, viene analizzata anche da Susan Ross che prende in considerazione gli ultimi scritti ufficiali del magistero della chiesa cattolica. L’utilizzo, in questi, della metafora nuziale (la chiesa come ‘sposa di Cristo’) non è solo un mezzo retorico ma contri-buisce all’organizzazione di una comunità in modo gerarchico e patriarcale. Anche nel saggio di Barbara Antoniazzi il corpo ses-suato viene considerato sul crocevia tra individuo e società. Antoniazzi propone una critica, dal punto di vista degli studi di genere, alla concezione neoliberale della soggettività. Collegandosi al lavoro della drammaturga statunitense Paula Vogel, evidenzia le tensioni tra l’interpretazione aporetica della libertà insita nel credo neoliberista, le pressioni del capitalismo economico e l’erosione dell’ideale democratico.
I saggi qui raccolti offrono un contributo concettuale all’ampia discussione su corpo, individualità e collettività. Essi, lontani dal voler essere esaustivi, aprono una strada interpretativa di tipo interdisciplinare che ci auguriamo possa continuare anche altrove.
Innanzitutto ringraziamo le autrici e gli autori per la loro vo-lontà di discutere insieme e la loro disponibilità e pazienza nella preparazione di questo volume. Grazie anche a Sergio Soresi per aver tradotto dal francese il saggio di Catherine Malabou, renden-