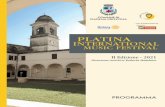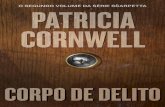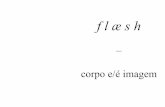Cronologia di vetri protostorici veneti mediante indagini archeometriche
Corpo e anima nei testamenti veneti della Controriforma
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Corpo e anima nei testamenti veneti della Controriforma
in C. Maltezou, G. Varzelioti, «Oltre la morte. Testamenti di Greci e Veneziani durante la venetocrazia nei sec. XIV-
XIX». Venezia 2008, pp. 33-58.
Sergio Lavarda
Corpo e anima nei testamenti veneti della Controriforma1
Introduzione
Tra Cinque e Seicento la commendatio animae dei testamenti – in genere rivolta a
Dio, alla Madonna e a tutti i santi – spesso si completava con una commendatio
corporis: “Raccomando l’anima a Dio e il corpo alla terra”. Altre volte, mediante la
formula “lascio l’anima a Dio e il corpo alla terra”, all’immaterialità dell’anima si
opponeva la materialità del corpo. Ciò che comunque univa corpo e anima era quel
tratto indissolubile che faceva del primo lo strumento di redenzione dell’altra.
Anima e corpo possono essere considerati metafore delle due parti di quell’unico
documento legale che è il testamento: la spirituale, che fissa modi e strumenti per
capitalizzare i propri meriti da presentare all’estremo giudizio, e la materiale, rivolta
ai rapporti patrimoniali. Nel testamento anima e corpo esprimono quindi le ultime
volontà con riguardo a sepoltura e suffragi, ma anche gli investimenti per la propria
eternità ultraterrena e per quella, prosaicamente terrena, della propria memoria e della
propria discendenza.
Il testamento è un negozio unilaterale, revocabile e solenne. Unità (quando si inizia si
deve anche finire), nella Terraferma presenza di cinque (nei codicilli) o sette
testimoni – ne bastano due a Venezia – e nomina di erede non vi possono mancare.
1 Abbreviazioni: ASPD = Archivio di Stato di Padova; ACVI = Archivio della Curia vescovile di
Vicenza; ASVI = Archivio di Stato di Vicenza; N = fondo notarile. Relazioni dei rettori veneti in
terraferma, a cura dell’Istituto di Storia economica dell’Università Di Trieste = REL; Podestaria e
Capitaniato di Padova, Milano 1975 = PD; Podestaria e Capitaniato di Vicenza, Milano 1976 =
VI. Dai riferimenti bibliografici sono esclusi i sottotitoli. Ringrazio la prof. Chryssa Maltezou,
direttrice dell’istituto Ellenico, per avermi offerto la possibilità di riprendere un tema di ricerca che
mi è particolarmente caro, oggetto come fu dei miei esordi nella ricerca.
Lo completano le formalità da includere nel protocollo e la clausola codicillare, esse
pure necessarie e sostanziali, a cui si possono associare legati a laici, sostituzioni di
erede, nomina di esecutori e riconoscimento di figli naturali. Elezione della sepoltura,
prescrizioni per le esequie e legati pii ne costituiscono le disposizioni religiose, tutte
volontarie. La fonte si configura pertanto come una “miniera di informazioni”
spirituali, patrimoniali e giuridiche, che pongono diversi problemi di interpretazione.2
Occorre brevemente ricordare che le fortune di cui ha goduto il testamento come
fonte storiografica quantitativa dall’inizio degli anni ’70 del secolo scorso erano
legate quasi esclusivamente alle disposizioni pro anima.3 Michel Vovelle prima,
Pierre Chaunu e Jacques Chiffolleau poi, ne avevano dimostrato le potenzialità nel
campo della storia del sentimento religioso studiando invocazioni, disposizioni per la
sepolture e legati pii in decine di migliaia di testamenti;4 dal canto loro gli storici del
diritto e i filologi privilegiavano l’analisi qualitativa, concentrandosi sugli aspetti
formali di quello che è innanzitutto un negozio giuridico, e criticando la
spensieratezza, giuridica e filologica, di buona parte degli storici quantitativi. Posto in
relazione con altri documenti notarili (atti di compravendita, inventari post mortem,
arbitrati), il testamento era infine visto dalla storiografia anglosassone dell’epoca
come uno strumento fondamentale per conoscere, attraverso i meccanismi della
devoluzione, le strategie patrimoniali delle famiglie.5
La disputa tra storici quantitativi e qualitativi aveva però posto in secondo piano il
problema delle interrelazioni tra la parte spirituale e la parte patrimoniale del
documento.6 Alla fine degli anni ’80 Samuel Cohn superò tale limite con un nuovo
approccio di lungo periodo in un lavoro che a sua volta suscitò un vivace dibattito.7 2 M. Vovelle, Piété baroque et décristianisation en Provence au XVIII siècle, Paris 19782, p. 27.3 P. Chaunu, “Un nouveau champ pour l’histoire sérielle. Le quantitatif au troixième niveau”,
Méthodolgie de l’histoire et des sciences humaines, Toulouse 1973, t. 2, 105-125.4 M. Vovelle, Pieté baroque, cit.; P. Chaunu, La mort à Paris, XVI, XVII, XVIII siècles, Paris 1978;
J. Chiffoleau, La comptabilité de l’au-delà, Roma 1980.5 Si vedano al proposito i saggi pionieristici della miscellanea Family and inheritance, a cura di J.
Goody, J. Thirsk, E. P. Thompson, Cambridge 1976. 6 Limite che già era stato denunciato da J. Chiffoleau, La comptabilité de l’au-delà, cit., pp. 33-35.
Naturalmente non va generalizzata la suggestione della sfida che il testatore
lancerebbe agli eredi – molti testamenti non fanno che riprodurre la devoluzione ex
lege, e sarebbero inutili se non contenessero talvolta modeste disposizioni pie –, ma
non si può nemmeno ignorare che il testamento “il più delle volte altera l’ordine
stabilito dalla successione legittima” a danno degli eredi naturali, magari solo
attraverso la profusione di legati, pii e non, che contiene.8
Il mezzo secolo che circoscrive la mia ricerca (1575-1631) rappresenta un periodo
cruciale, un’epoca in cui, è stato detto, nei paesi cattolici la morte venne posta al
centro della vita come il cimitero al centro del villaggio, in cui la “pastorale della
paura” si rese più che mai pervasiva.9 In quei decenni a cui fanno da cornice le due
grandi pestilenze dell’età moderna, la predicazione accentuò il messaggio terrifico
che affiancava a un Dio padre autoritario l’immagine del Cristo sanguinante in croce,
al punto che anche gli spiriti più santi sentirono l’enorme peso delle proprie
debolezze.10 Ebbene, erano allora intervenuti dei cambiamenti nel modo di intendere
la propria ultima volontà e la propria posizione nei mondi terreno e ultraterreno?
Come era penetrata nelle coscienze dei fedeli veneti la pastorale cattolica post
tridentina, e quanto questa penetrazione aveva influenzato un mutamento dei rapporti
famigliari?
All’estremo della vita, la Chiesa accorre in soccorso del cristiano mediante l’ultimo
passaggio di una collaudata strategia di redenzione: dopo il “terrificante messaggio ...
7 S. K. Cohn Jr., Death and Property in Siena, considerazioni metodologiche e bibliografiche a p.
247 e passim. T. C. Kuehn, Law, Family and Women, Chicago and London 1991, p. 15. Il lavoro
denuncia la trascuratezza circa la sensibilità giuridica dei testatori, per i quali l’atto altro non
sarebbe che una sfida lanciata agli eredi legittimi. 8 Per la cit. A. Lorenzoni, Instituzioni del diritto civile privato per la provincia vicentina, Vicenza
1785, tomo 2 pp. 107-108.9 J. Delumeau, Il peccato e la paura, Bologna 1987 (ed. or. 1983), pp. 109, 599-631.10 P. Camporesi, Il sugo della vita, Milano 1984, pp. 38-50.
di un Dio la cui giustizia aveva la meglio sulla misericordia”11, ai fedeli è offerta
l’ancora di salvezza della buona morte. Le artes moriendi, volgarizzate in centinaia di
edizioni e divulgate da parroci e sacerdoti renstituiscono infatti, a determinate
condizioni, il perdono di Dio.12
Occorrerebbe pensare sempre alla propria morte, testando in stato di salute e lucidità
e rendendo di fatto “la vita ... un testamento senza fine”,13 ma se invece, come quasi
sempre avviene, il testatore si trova in pericolo, sarà il confessore/confortatore a
consigliare le volontà confuse dei moribondi per traghettarli ai lidi di un oltretomba
che certo incute timore – si finisce pur sempre “davanti il tremendo giuditio di Sua
Divina Maestà” – ma non più angoscia disperata.14
Nel momento di fare un “passo sì strano” prende quindi corpo la “pastorale del
testamento”. Una pastorale che esalta le istanze dell’anima a detrimento di quelle del
corpo e che nella contingenza drammatica dell’epidemia di peste, la cui “causa
principale ... non è altro che i peccati”, dovrebbe sublimarsi.15
11 J. Delumeau, Il peccato e la paura, cit., p. 601.12 D. Roche, “La mémoire de la mort, XVII-XVIII siècles”, Annales E. S. C., 1, (1976), 80 segg.13 A. Tenenti, Il senso della morte e l’amore della vita nel Rinascimento, Torino 1957, p. 91.14 J. Delumeau, La peur en Occident, Paris 1978, p. 10; E. Tasso, Il confortatore, Bergamo 1595. S.
Lavarda, L’anima a Dio e il corpo alla terra. Scelte testamentarie nella terraferma veneta (1575-
1631), Venezia 1998, pp. 98-112. La cit. in ASVI, N, b. 8817, 1617-9.3; testamento del notaio
Giacomo Brogia.15 Così scriveva nel luglio del 1630 il vicario vescovile Francesco Alzano nell’invitare i parroci di
Vicenza ad organizzare processioni penitenziali persuadendo i fedeli a digiunare per tenere lontano
il morbo dalla città. ACVI, Actorum diversorum, b. 90/090, 1630-20.6. A Vicenza tra agosto 1630 e
marzo 1631 sarebbero morte 11.000 persone di circa 30.000 che vi risiedevano . G. Imperiali,
Pestis anni MDCXXX, Vicenza 1631, pp. 8, 70. Nel giugno del 1631 sarebbero stati censiti poco più
di 14.000 abitanti. S. Lavarda, “In questo calamitoso tempo di contagio”, Studi veneziani, N. S. XIX
(1990), 87. Padova tra aprile 1576 e maggio 1577 perse 10.000 dei circa 36.000 abitanti che vi
risiedevano: REL, PD, p. 73.
Le città di Padova e Vicenza facevano parte del dominio di terraferma della
Repubblica veneta; un territorio non omologato, in cui specifici caratteri costitutivi,
differenti autonomie concesse all’atto della dedizione, diseguale presenza proprietaria
del patriziato veneziano, difformi pulsioni politiche dei ceti dirigenti locali, rivalità
vecchie e nuove, rendevano molto meno periferiche di oggi rispetto ad un centro,
Venezia, che non da ieri la storiografia definisce concordemente città-stato, piuttosto
che capitale di uno stato regionale.16 Centri, ancora, dove era stata fertile la
propaganda riformata cui solo la dura repressione avviata con pertinacia sul finire
degli anni ‘40 del Cinquecento, e ancora attiva negli anni ‘80, aveva potuto mettere la
sordina.17
CAMPIONE TESTAMENTI
anni 1575 1576 1577 1590 1606 1607 1608 1617 1629 1630 1631 TotaliPadova 17 74 12 35 25 12 18 37 60 43 25 358Vicenza 22 13 57 17 19 8 25 14 41 99 17 332Totali 39 87 69 52 44 20 43 51 101 142 42 690
Se “maximun honor est inter homines cum testamento decedere, et maximum dedecus
decedere ab intestato”, la libertà del testatore deve essere ponderata dalla ragione e
dal riconoscimento dei legami di sangue, altrimenti diviene libidine o cupidigia ed è
radice di tutti i peccati.18 Il testamento deve essere quindi giusto e legittimo, libero
cioè, ma non contrario alle leggi che definiscono la successione volontaria e
16 B. Dudan, Sindicato d’oltremare e di terraferma, Roma 1935, p. 6 e bibliografia ivi citata.17 Anche nella direzione di una ricerca sull’eterodossia religiosa i testamenti possono essere
proficuamente indagati. Per un significativo esempio veneto, si veda Federica Ambrosini,
“Ortodossia cattolica e tracce di eterodossia nei testamenti veneziani del Cinquecento”, Archivio
Veneto, n. 171 (1991), 5-64.18 Il virgolettato in D. Spino Caceres, Speculum testamentorum, Venezia 1598, p. 76; per la
ponderatezza del testatore: F. Mantica, Tractatus de conjecturis ultimarum voluntatum, Venezia
1607, p. 3.
controllano la libertà di testare.19 Solo per comodità espositiva possiamo perciò
distinguere nel testamento il religioso dal patrimoniale.
Si deve testare, lo si deve fare in salute, si deve garantire al corpo un degno distacco
dal mondo mediante le disposizioni per le esequie e per la sepoltura e nel contempo
attrezzare l’anima all’estremo decisivo viaggio utilizzando le proprie facoltà a fini
caritativi.20
A questo proposito il notaio era tenuto a interrogare il testatore sulla propria
intenzione di beneficiare luoghi pii.21 Mentre a Padova si trova solo quattro volte e la
risposta è sempre negativa, la domanda del notaio è presente in circa l’85% dei
testamenti vicentini dei trienni 1575-77 e 1629-31. Le risposte affermative dei
testatori documentano una significativa evoluzione: si passa dal 23% al 65%, in una
dinamica che, attraverso misurazioni intermedie di controllo (41% nel 1590, 58% nel
1605-07, 62% nel 1617), dimostra un’evoluzione chiara, anche se grezza, nella
direzione di una adesione massiccia ai valori promossi dalla chiesa tridentina. Dato
che assume particolare valore sia in considerazione del fatto che nei periodi tardi la
domanda è spesso superflua per la già avvenuta disposizione sia, soprattutto, a causa
del famoso provvedimento che nel 1605 la Repubblica aveva emanato al fine di
controllare la devoluzione di beni stabili alla Chiesa.22 Ancora, sembra interessante
segnalare come nello scorcio del XVI secolo i ricorrenti “nolo, minime, respondit que
19 Statuti municipali ntegrati dovunque, meno che a Venezia e dogado, dallo jus commune. G.
Cozzi, Repubblica di Venezia e stati italiani, Torino 1982, p. 262.20 La rinascita duecentesca del diritto romano, ma ancor più la capillare predicazione degli ordini
mendicanti, spiegano la democratizzazione bassomedioevale del testamento. A. Bartoli Langeli,
“Nota introduttiva”, Nolens intestatus decedere, Perugia 1985, p. XVI; per il ruolo dei nuovi ordini
nella Padova medioevale, A. Rigon, “Influssi francescani nei testamenti padovani del Due e
Trecento”, Le venezie francescane, NS, 2, 106 segg. Una stima dei testamenti rogati nel territorio
vicentino e padovano nel XVII secolo fa supporre che la pratica fosse diffusissima e riguardasse
tutti i ceti sociali. S. Lavarda, L’anima a Dio, cit. p. 157-158.21 G. Pedrinelli, Il notajo istruito nel suo ministero secondo le leggi e la Pratica della Serenissima
Repubblica di Venezia, Venezia 1768, p. 128. Talvolta erano esplicitati, più spesso la domanda era
posta genericamente.
non, Signor no” non siano quasi mai accompagnati da giustificazioni, mentre in
seguito il testatore si senta in obbligo di presentarle, e la principale di queste sia la
povertà.
Il legato pio sembra transitare, nel comune sentire dei protagonisti, da una possibile e
niente affatto vincolante integrazione caritatevole del testamento, tutto concentrato
sulla successione, ad un elemento fondante dell’atto di ultima volontà, il cui
baricentro pare spostarsi nel tempo su una enfatizzazione dei contenuti religiosi, pur
nella difficoltà di stabilire con precisione che cosa i contemporanei intendessero per
luoghi pii.23
Esequie e sepoltura
La lunghezza e la complessità degli atti di ultima volontà aumenta col passare degli
anni, e a questo contribuiscono in modo rilevante le disposizioni per le esequie.
L’ansia, e per converso il richiamo ai doveri di esecutori e/o eredi, offre sia il senso
di una maggiore chiusura nella sfera individuale, che la coscienza di appartenere a un
particolare ceto, contraddistinto da una determinata rappresentatività sociale. Talvolta
si trascura il rito di passaggio per qualcosa di più duraturo che testimoni
dell’individuo, oltre che del lignaggio. Il primo settembre 1630, Simon Bevilacqua,
nobile padovano, chiede che il suo corpo, vestito con il saio da cappuccino, sia
seguito da un solo parroco e tre preti della chiesa di Sant’Anna, lasciando ai
commissari l’incombenza di decidere il peso delle quattro candele che lo avrebbero
dovuto accompagnare ma poi, oltre alle rituali tre messe privilegiate da celebrare
22 E che il papa avrebbe dimostrato di non gradire affatto dando avvio alla crisi dell’Interdetto. B.
Cecchetti, La Repubblica di Venezia e la corte di Roma nei rapporti della religione, Venezia 1874,
vol.1, p. 126; G. Benzoni, Venezia nell’età della Controriforma, Milano 1973, pp. 68-69.23 Dal 1636 non si sarebbero più dovuti intendere per tali scuole, confraternite o compagnie,
mediante i quali i testatori garantivano la mutua assistenza dei famigliari. Bigaglia, Capitulare
legum notariis publicis, Venezia 1689, p. 169.
immediatamente,24 stanzia ben 150 ducati perché sia costruito un altare a Sant’Anna
con una pala in cui rappresentare la Vergine e San Carlo.25
Ma non sempre la modestia delle disposizioni del testatore veniva osservata. Qualora,
molto raramente, si abbia la possibilità di confrontarla con le esequie che poi
effettivamente si svolsero, si scoprono differenze notevoli. Eclatante è l’esempio
della pompa funeraria del vescovo Giulio Contarini nella Belluno del 1575, che
contrasta nettamente con i contenuti del suo testamento.26 Nella Vicenza del 1630 il
conte Paolo Emilio Ghellini, fratello del venerabile Gellio di cui all’epoca era ancora
in corso il processo di canonizzazione, scriveva nel suo atto di ultima volontà:
Prohibisco obito di spesa, né intendo che nel far portare il mio corpo alla sepoltura siino chiamati
altri che doi mansionari del domo, parochiano di San Faustino, li mendicanti, li orfani, le convertite,
le monache di Santa Chiara, sei padri delle Gratie, et sei da San Biasio, e comando che il mio corpo
sii vestito con l’abito de cappuccino con il cordone di San Francesco mio protettore et ... siino
portate sei torze avanti [al feretro] et sei dappoi de libre tre l’una.27
24 Eufemia Pigafetta, nobile vicentina, chiede le siano celebrate 400 messe subito dopo morta.
ASVI, N, b. 8817, 1629-1.1. Cosroe Savorgnan distribuisce il carico delle circa 50 messe immediate
in 10 chiese della città. ASPD, N, 4612, 1630-4.11. Nel tempo i testatori chiedono sempre più
affannosamente che si celebrino messe prima dell’inumazione, sia per la crescente consapevolezza
che tra il momento della morte e quello del giudizio intercorre un lasso di tempo (fino a tre giorni)
in cui è ancora possibile accumulare meriti e forse anche per il timore che col tempo lo zelo degli
esecutori possa affievolirsi. A. Elli, Specchio spirituale del principio et fine della vita humana,
Venezia 1604, p. 75; Gabriella Zarri, “Purgatorio ‘particolare’ e ritorno dei morti”, Quaderni
storici, 50 (1982), 466-467.25 Un crescente numero di aristocratici, sia vicentini che padovani, chiede esequie modeste e
inumazione con abito da cappuccino. ASPD, b. 4612, 1630-1.9.26 Nel proprio olografo, redatto nel 1572, il vescovo chiedeva di essere accompagnato senza
processione dal vescovado alla Cattedrale per essere sepolto sotto una lastra tombale con una
semplice iscrizione, accompagnato da solo quattro torce, il clero e i famigliari senza che fossero
suonate campane. Tuttavia gli sarebbero state tributate grandiose esequie. S. Lavarda, L’anima a
Dio, cit. pp. 169-170. 27 ASVI, N, b. 8816, 1629-24.10, aperto e pubblicato 1630-14.3.
Non stupisca che una simile richiesta sia intesa dal testatore come un limite allo
sfarzo; nel 1606 Cornelia Ghellini, a margine di un lungo elenco di ordini religiosi e
istituti i cui membri avrebbero dovuto partecipare alle esequie (diverse centinaia di
persone), aveva indicato in 60 ducati il limite massimo di spesa.28
Ciò mentre nel 1629 il prezzo del funerale di Giacomo Magon, comandante residente
a Padova e più preoccupato di diseredare il figlio che delle proprie esequie, ci
dimostra come con poco più di sei ducati un cittadino di medie condizioni potesse
ottenere un funerale più che dignitoso.29
La modestia che talvolta caratterizza i testamenti dei nobili può quindi anche essere
generata dalla consapevolezza che il rifiuto di esibizionismi sia legittimato nel vivo,
ma che gli esecutori non si sentiranno poi obbligati per il morto. Del resto al corpo
era assegnata una diversa natura a seconda che condividesse, o avesse travalicato, i
confini della vita terrena. Dapprima ricettacolo di tutti i mali e degno di ogni
mortificazione era, una volta trapassato, meritevole di rappresentare al meglio la virtù
dell’individuo e della propria parentela, come scriveva un gesuita francese in
occasione della morte di Anna d’Austria (1666).30
28 ASVI, N, b. 8816, 1606-25.4.29 Giacomo aveva solo chiesto che gli fossero celebrate tre messe di suffragio, ASPD, N, b. 4612,
1629-29.7. Il riepilogo delle spese è Ivi, 1629-4.8. Le tre messe privilegiate erano costate 3 lire;
cera e cassa 4 soldi; il prete del duomo che aveva accompagnato il morto 1 lira; 2 lire quattro altri
preti; i padri agostiniani 6 lire e 4 soldi (1 ducato), i poverelli del Rosario e del Nome di Dio (luoghi
pii) “per far portar le steche” 1 lira e 4 soldi; gli orfani 2 lire; il sacerdote officiante 1 lira; i quattro
putti con le torce 4 soldi; il panno rosso in duomo 1 lira e 10 soldi; 8 soldi erano stati spesi per
portare il candelotto a casa; per il trasporto del feretro e per la pietra della sepoltura 8 lire; il cursore
che aveva invitato preti, frati, orfani e stendardi e la pubblicazione del testamento 12 lire e 8 soldi;
infine la tassa sui testamenti 1 lira e 5 soldi. In totale si erano spese per esequie e sepoltura 40 lire e
7 soldi, ossia 6 ducati e mezzo (1 ducato corrente = 6 lire e 4 soldi).30 «La modestia è una virtù lodevole nelle persone che vivono; ma, lungi dall’essere modesti in loro
nome dopo la loro morte, noi dobbiamo rendergli il merito che hanno affettato di ricusare durante la
loro vita». Cit. in M. Vovelle, La morte e l’Occidente, Roma-Bari 1986, p. 290.
Per tutto il Cinquecento l’Italia sarebbe stata il luogo di elezione dei grandi rituali
funerari; rituali la cui rilevanza è testimoniata dalle numerose tracce che se ne
conservano nelle cronache contemporanee. Nonostante che le leggi suntuarie si
fossero da tempo concentrate sulla sanzione di comportamenti ostentatori, e che la
promulgazione del rituale funerario del 1614 avrebbe posto l’accento su messa e
benedizione del feretro in antitesi a tutto quanto precedeva e seguiva la cerimonia in
chiesa, si affermò in quei decenni il grande cerimoniale delle esequie barocche.
Nell’arco di tempo considerato l’elezione della sepoltura è in costante aumento in
entrambe le città – nel 1575-77 dispone per le proprie esequie il 24% dei testatori a
Vicenza e il 42% a Padova, mentre nel triennio 1629-31 le percentuali salgono
rispettivamente a 47% e 67% – nonostante che durante la pestilenza la ritualità
funebre subisca un drammatico ridimensionamento, e che il destino di molti sia la
carretta dei pixegamorti e la fossa comune.31
Oltre che disporre con precisione per il rito, si può raccomandare il rispetto degli usi,
richiamare il proprio status, proibire pompe, oppure delegare l’organizzazione della
cerimonia a eredi e/o esecutori. Non è necessario ricorrere a complesse categorie
sociologiche per spiegare la distanza che esiste tra chi elenca il numero di
partecipanti, il peso dei ceri, le campane che avrebbero dovuto suonare, e chi invece
si affida con fiducia ai propri congiunti. Con più circospezione occorre invece
valutare la scelta di chi non intende che il proprio rango sia offuscato da funerali non
all’altezza, o richiama le consuetudini locali, data la ripetitività di una formula che
potrebbe essere suggerita dal notaio.
Mentre nel tempo aumentano le richieste dirette, si assottiglia il dato di coloro che
chiedono esequie umili. Il richiamo a usi e status resta marginale a Padova, per contro
nella città berica rappresenta quasi il 20% del campione relativo al primo periodo e il
14% di quello del triennio 1629-31.
La delega a commissari testamentari ed eredi aumenta sensibilmente passando a
Vicenza da circa il 30% ad oltre il 70% degli atti che contengono indicazioni, e a
31 A Vicenza 22 testatori su 92 e a Padova 43 su 103 nel primo periodo; 73 su 156 e 86 su 128 nel
secondo.
Padova dal 50 al 60%. In entrambe le città si assiste alla diminuzione di investitura
generica all’erede, contro un crescente ruolo dei commissari e soprattutto del
coniuge. Una fiducia che sono specialmente i mariti a rivolgere alle mogli e ciò,
significativamente, a detrimento del rinvio alla parentela più allargata.
A Vicenza 26 nobili su 52 (50%) chiedono le esequie, a Padova 34 su 39 (87%). A
Padova il 47% dei testatori nobili definisce con precisione il proprio obito, mentre a
Vicenza solo il 35%. La differenza tra le due città è ancor più rilevante se si
confrontano le dinamiche interne al dato cetuale. A Vicenza diminuisce la quota di
nobili ed aumenta quella artigiana, esattamente l’opposto si verifica nella città del
Santo.
A Padova il numero di coloro che si preoccupano delle proprie spoglie mortali
ammonta all'88% (316 su 358) e il 70% circa del totale dei testatori indica con
esattezza il luogo dove vuol essere inumato. A Vicenza le percentuali sono in
entrambi i casi sensibilmente inferiori: 228 testatori su 331, il 69%, rappresentano il
gruppo più ampio, solo in 175 casi (53%) vi è l'electio corporis sepulturae. Se il
silenzio rende eloquente la certezza dei legami di solidarietà per i quali, ed in forza
della legge, è implicito che il defunto deve essere inumato in sepulchro maiorum e
che, in assenza di tomba di famiglia, sarà provveduto al riguardo nella parrocchiale di
appartenenza, perché una parte così rilevante di testatori si preoccupa di ricordare la
sepoltura? Se si esclude l’esistenza di una prassi notarile di esplicite richieste sulla
sepoltura, non imposta dalle leggi,32 evidentemente il testatore intende richiamare alla
responsabilità parenti/eredi, spesso singolarmente identificati.
Vicenza e Padova sono due centri con vocazioni molto diverse. Padova ha lo Studio,
una popolazione residente meno dedita alla principale industria di terraferma della
vicentina;33 i nostri documenti lasciano intuire per Padova una cittadinanza più
cosmopolita e fluttuante, e una consistente immigrazione che stimolerebbe aggrega-
32 Nei formulari più comunemente presenti ai notai vicentini, dopo la commendatio animae si passa
subito alla domanda sui luoghi pii, escludendo quindi la domanda sulla sepoltura. A Padova, come
detto, il riferimento ai luoghi pii è quasi assente. Se ne deduce che il riferimento del testatore è per
lo più volontario.
zioni di solidarietà extrafamiliari, uno spunto che merita di essere tenuto presente
anche in quanto giustificherebbe il bisogno di esplicitare un'appartenenza, di
sollecitare una solidarietà, o quantomeno di testimoniare un’affinità.34
La crescente attenzione al problema, particolarmente durante l’epidemia, testimonia
dell'ansia che affligge quest’umanità: essere sepolta in terra consacrata. Partendo per
Loreto, Isabetta Forti “prega la maestà d'Iddio che l'ossa sue non rimangano
insepolte”. Natale Spezzato chiede il cimitero di Carmignano “Overo altrove
mancando fuori di essa villa, mentre sia sepolto in luoco sacro”. Francesca Muttoni,
colpita dal contagio, destina tutte le sue poche sostanze al fine di essere seppellita in
chiesa. La forza con cui si manifesta tale sentimento si spinge al punto da creare resi-
stenze a tentativi di revisione della gerarchia del sacro.35
Il nobile Nicolò Camposampiero chiede che gli sia costruita una nuova tomba nella
chiesa di Tramonte però “prohibendo al tutto che si faccia alcuna memoria della mia
persona sopra la preda”. Si badi bene, una nuova tomba, non la tomba di famiglia in
cui la traccia del singolo componente può essere assorbita dal prestigio del casato.
Non è un caso unico e ci sembra che la sua lettura debba spingersi oltre l’ostentazione
di un normale sentimento di umiltà per il quale si sono trovati vari esempi nell'ambito
del discorso sulle esequie. Sembra cioè che i Sepolcri non abbiano in molti casi altra
funzione che quella di un generico memento mori per i frequentatori delle chiese. Un
messaggio che diventa funzionale alla pastorale dei cotidie morior, degli estote
parati, lanciata con vigore da mille rivoli diversi nel mondo cattolico post tridentino,
e così ampiamente recepita nei preamboli dei testamenti.
33 M. Knapton, “Tra dominante e dominio (1517-1630)”, G. Cozzi, M. Knapton, G. Scarabello, La
Repubblica di Venezia nell’età moderna, Vol. 2, Torino 1992, 455-456; P. Preto, Peste e società a
Venezia nel 1576, Vicenza 19842, p. 25.34 Sono questi i passaggi con cui Jacques Chiffoleau ha motivato il cambiamento della morte nella
Avignone tardomedioevale. J. Chiffoleau, “Perché cambia la morte nella regione di Avignone alla
fine del Medioevo”, Quaderni storici, 50 (1982), 460-463.35 ASPD, N, b. 5835, 1590-18.3; ASVI, N, b. 10332, 1630-21.4; Ivi, b. 9760, 1630-26.9.
Il padovano Giulio Forte, affermata la vanità delle “cose del corpo .. che vano come il
fumo”, vi affianca la richiesta di una pompa funeraria piuttosto elaborata al termine
della quale, però, desidera essere inumato nella tomba dei frati della chiesa di San
Francesco grande con abito dell'ordine. Anche Girolamo Gloria, ultimo
rappresentante del suo casato, chiede per sé solo una piccola pietra con essenziale
epitaffio nella cappella della Madonna nella chiesa dei Teatini “prohibendo ogni
superfluità d'ambitioso mortorio”. All'angoscia di restare insepolti non pare quindi si
affianchi un sentimento correlativo per la mancanza della memoria del luogo di
sepoltura: la tendenza escatologica poteva avere insomma il sopravvento sulla
volontà commemorativa.36
Va altresì detto che spesso ricchi parvenus si sforzano di emulare i costumi nobiliari.
Il mercante Simone Ceffi chiede per il suo cadavere una cassa “ben chiusa et
impegolata [sigillata con pece]” nella propria parrocchiale di Santa Lucia, dove gli si
sarebbe dovuta costruire una tomba in pietra con “l'arma, nome et casata”. Tale
atteggiamento coinvolge anche artigiani il cui ultimo atto testimonia difficoltà
economiche: Vincenzo Altissimo, filatore vicentino, “attesa le forze della sua pocha
facultà” non dispone legati pii e chiede pazienza al conte Caldogno per il pagamento
di un debito; ordina però che venga scolpita sulla sua sepoltura l'arma della sua
famiglia sul modello dalla borchia che ha attaccata alla borsa.37
L’iconografia della peste obbedisce a canoni retorici molto precisi e consolidati e nel
ricco catalogo di una celebre mostra veneziana del 1979 si trova un’unica eccezione:
un capitello di montagna sopravvissuto sino a noi in cui sono ingenuamente
rappresentati i pixegamorti al lavoro. Arpionati da questi ultimi, i cadaveri degli
appestati vengono scaraventati in un burrone.38 Un destino simile non è lontano
36 ASPD, N, b. 1546, 1607-20.6. Ivi, b. 3896, 1617-1.10. P. Ariès, L’uomo e la morte dal Medieovo
ad oggi, Bari 1980, pp. 233-238.37 ASVI, N, b. 9583, 1630-2.5.38 L’immagine del capitello di Sorriva, presso Feltre, è analizzata da Stefania Mason Rinaldi, “Le
immagini della peste nella cultura figurativa veneziana”, Venezia e la peste, Venezia 19802, 220.
dall’immaginazione di Libera Negrin, abitante a Vicenza, che con fatalistico realismo
“sepeliri iussit quo placuerit omni potenti Deo et quo reperietur”. Il suo non è un
caso isolato nei mesi di settembre e ottobre 1577, in cui Vicenza è preda del
contagio.39 Si raccomanda insomma il destino del proprio corpo alla volontà divina,
rompendo l’equilibrio degli opposti e stravolgendo la prassi di affidare “l’anima a
Dio e il corpo alla terra”.40
Se una dinamica dell'atteggiamento ora visto possiamo cogliere, questa sembra
attestare una crescente attenzione al destino del proprio corpo. Solo quattro casi di
affidamento del corpo a Dio si presentano nel cospicuo campione della peste
successiva, ben più grave per la mortalità cittadina, che colpisce Vicenza fra luglio e
novembre 1630.41
Molto più frequenti sono i casi in cui il testatore indica un luogo accettando che si
deroghi alla sua disposizione a causa delle difficoltà contingenti. Ma se nella città di
Vicenza in soli 12 casi – 9 dei quali nel 1577 – vi è l’affidamento del proprio corpo
alla sorte o a Dio, a Padova questi ammontano a 38, 28 dei quali sono distribuiti nei
due anni 1576 e 1577. La condizione comune è quella dei sequestrati in casa,
generalmente di modesta fortuna: fruttivendoli, venditori di fieno, ortolani, le mogli
di un candelaio e di uno spadaio, facchini, calzolai ecc.; il più socialmente qualificato
è il cerusico Matteo Bortolotto che testa sequestrato in casa, colpito da febbre, il 14
39 ASVI, N, b. 7893, 1577-25.9; in un campione di 57 testamenti ho contato altri otto casi analoghi
in città (14%). Si tratta di persone di modesta condizione: due vedove di tessitori, un cimatore, un
calzolaio. 40 Sul rapporto mistico anima-corpo, parallelo a quello alto-basso, mi permetto di rinviare al mio
L’anima a Dio, cit., pp. 3-9.41 P. Preto, Peste e società, cit., pp. 15, 19. S. Lavarda, “In questo calamitoso”, cit. Nel settembre
del 1630 la pizzochera Francesca Zanotto, “agognata di febre", chiede di essere “sepolta secondo si
potrà in queste congionture contagiose”; la domestica Domenica Menegatto vuole che “il suo corpo
sii sepolto dove piacerà a sua Divina Maestà in questo tempo di peste”. “Quanto al mio corpo, lasso
la cura al Signor Iddio Benedetto in questi tempi di lacrime” dice Andrea Moschino. ASVI, N.
9761, 1630-16.9; b. 9584-1630-10.9 e 29.9.
settembre 1576.42 La contrazione del dato nel passaggio fra il primo ed il secondo
termine di paragone, collegata alla maggior presenza di una opzione certa
chiaramente indicata, fa senz'altro pensare che fra 1629 e 1631 non basti ormai più
rimettersi ad altri, tacere, e forse neanche raccomandarsi a Dio, ma che invece sia
necessario non rassegnarsi nemmeno di fronte al più tragico destino. Solo un simile
stato d'animo può aver mosso la mente di Antonio Thiene, appartenente ad una delle
più prestigiose famiglie nobili vicentine, che nell'ottobre del 1630 chiede di essere
sepolto nella chiesa di San Marcello, o in quella di San Giacomo ma che poi, passata
la procella, si preoccupa di far sì che non venga troppo differita la traslazione del suo
corpo alla tomba di famiglia nel Duomo di Vicenza.43
Chi delegava a terzi esequie e sepoltura intaccava con meno larghezza il proprio asse
ereditario. Rispetto alla media generale, questi testatori riducevano le liberalità del
37% a Vicenza e del 52% a Padova.44 Tuttavia i meno sacrificati erano a Vicenza i
legati pii per suffragio, quelli cioè che documentano maggior apprensione per il
destino ultraterreno, mentre la diminuzione del valore unitario del singolo legato, nel
favorire gli eredi universali, vincolava maggiormente questi ultimi alla riconoscenza
e al senso di responsabilità. A Padova invece diminuiscono proporzionalmente sia i
legati che i valori degli stessi, quasi a testimoniare una maggior confidenza verso i
propri congiunti eredi.
Mentre la gerarchia cattolica post tridentina si sforzava di limitare la presenza delle
tombe infra ecclesiam, insisteva nel tentativo di sacralizzare gli spazi cimiteriali,
42 ASPD, N, b. 3569, 1576-14.9.43 ASVI, N, b. 9761, 1630-5.10.44 La media generale dei legati per testamento è di 4,56 legati a Vicenza e 4,58 a Padova; i testatori
in questione inseriscono rispettivamente 3,33 e 3,02 legati nei loro testamenti. Dettagli e tabelle nel
mio, L’anima a Dio, cit., pp. 209-211.
isolandoli dal contesto profano.45 Nel 1624 il vescovo di Vicenza Dionisio Dolfin
ordinò che si provvedesse a chiuderli con mura, la canonica vi dovesse essere
prossima per meglio custodirli e non vi crescessero alberi. Marco Corner vietò
severamente ai chierici padovani di coltivarci frumento o altre cose sordide, vi si
dovevano rimuovere le immondizie, non li si doveva usare come latrine, per stendere
la biancheria o per giocare a palla o a dadi. I cimiteri dovevano però essere disadorni
e privi di memorie individuali, a Padova si proibiva di erigervi croci lignee a segnare
spazi riconoscibili.46
Evidentemente il cimitero era ancora un luogo sospeso a metà fra sacro e profano, e
questo elemento spingeva i testatori, in cui con l’ansia cresceva il desiderio di
avvicinarsi quanto più possibile al Santissimo Sacramento, a privilegiare lo spazio
interno della chiesa nella scelta della sepoltura. Le direttive provenienti dal centro
cozzavano con la pratica. Da qui i severi limiti, ma non le chiusure totali che
l'autorità ecclesiastica locale adottava. I nuovi sepolcri fatti costruire all'interno di
chiese delle diocesi vicentina e padovana avrebbero dovuto essere posti in alto e
lontani dall'altare, non si sarebbero più potuti costruire sul pavimento se non di pietra
e con licenza vescovile.47
All'interno delle mura consacrate, più o meno vicini al coro e nonostante i formali
divieti canonici, potevano accedere alla sepoltura in molti, non solo i titolati o i più
abbienti. L'obbligo della pietra e le restrizioni alla costruzione di tombe orizzontali
possono essere letti come due senz'altro non decisive, ma tuttavia non poco vinco-
lanti, condizioni restrittive all'accesso in chiesa.
45 Il rituale del 1614 riconosceva eccezioni, escludendo la prossimità agli altari. G. Baruffaldo, Ad
Rituale Romanum Commentaria, Venezia 1763, p. 122. Sul tentativo di espulsione delle tombe
dalle chiese cfr. anche M. Vovelle; Piété baroque, cit. p. 100.46 D. Dolfin, Constitutiones et Decreta alias promulgata ...anno a nativitate domini MDCXXIV,
Vicenza 1625, p. 85; N. Giustinian, Constitutiones et Decreta ... in sua septima Diocesana Synodo
promulgata anno MDCXXIV, Padova 1793, pp. 48-4947 D. Dolfin, Constitutiones ..., Vicenza 1611, pp. 78-79; N. Giustinian, Decreta 1624, cit. pp. 188-
189.
Un espediente per aggirare gli impedimenti a farsi inumare in chiesa pare fosse dive-
nuta la tomba collettiva dell'altare della confraternita alla quale, spesso in punto di
morte e con questo preciso scopo, si chiedeva di entrare a far parte. Altre volte si
dichiarava di appartenervi da molto tempo, quasi a legittimare un diritto, altre ancora
il dato silenzioso della richiesta di inumazione in chiesa si accompagna a benefici per
suffragio a compagnie. Al di là dei singoli statuti, vale la pena ricordare che il vesco-
vo padovano Marco Corner individuava come compito precipuo delle istituende
confraternite la pia sepoltura dei defunti.48 Il lieve, ma generalizzato, aumento dei
lasciti a confraternite condizionati al suffragio documenta così la tacita
remunerazione del servizio funebre.
Le tombe delle confraternite separavano i due sessi. Laura Venturati nominava la
tomba “delle done” della confraternita del Gonfalone in Duomo.49 Cambia qualcosa
nel modo di intendere i rapporti sociali se si trascura la vicinanza fisica con i parenti,
della famiglia naturale o acquisita, pur di avere accesso alla sepoltura in chiesa?50
Le cifre della richiesta di inumazione in chiesa fanno dubitare che ci sia stato un
momento, alla fine del XVI secolo, in cui non erano ancora state trovate le forme per
aggirare le nuove limitazioni. Nel 1590 a Vicenza solo il 38% dei testatori che
chiedono la sepoltura si indirizzerà alla chiesa, contro una media per gli altri periodi
del 64%.
A Padova le alternative alla chiesa (cimitero, sagrato, monumento confraternale) sono
insignificanti, e sembra che nessuno si ponga il problema di non vedere soddisfatta la
richiesta. Se consideriamo come vengono beneficiate le compagnie, dovremmo
concludere che i padovani non conoscono uno sviluppo del movimento confraternale
48 N. Giustinian, Decreta 1624, cit. pp. 193. Coloro che chiedono l'inumazione nel monumento
confraternale sono di condizione sociale inferiore. 49 ASVI, N, 8180, 1606-6.11. La donna è al servizio della nobile Franceschina Repeta, della cui
famiglia si sente evidentemente parte e nella cui tomba chiede in prima istanza di essere accolta.50 Giorgio Tommasini indica il cimitero di San Silvestro, immediatamente contrappuntato dalla
moglie, che per sé chiede la sepoltura nella cappella della Vergine incoronata in Duomo. ASVI, N,
9583, 1629-24.9 e 1630-4.8
simile a quello vicentino, ma sbaglieremmo. Certo, alla parsimonia dei periodi
precedenti, in cui contiamo in totale due soli legati, si affianca il dato del triennio
1629-31: su 128 testamenti rogati a Padova, in 87 c'è la richiesta di inumazione in
chiesa (68%), e ben 81 testatori prevedono legati per suffragio (93%). Solo cinque
però lasciano a confraternite una somma complessiva di 2.430 lire, mentre per
esempio ai soli conventi maschili vengono destinati negli stessi anni 30.215 lire e ad
altari 4.538. I frequenti richiami agli altari del Rosario, del Santissimo Sacramento,
del Crocifisso, e la moltitudine di altari dedicati alla Madonna sono senz’altro
collegabili ad istituzioni che posseggono tombe confraternali. Il legato destinato ad
altari viene quindi ad assumere, forse anzi amplificandolo, il valore che per Vicenza
era stato attribuito al beneficio a confraternite.
Specialmente dopo che i cimiteri erano stati ridefiniti come specifici spazi per le
sepolture dai provvedimenti tridentini, il sagrato, quello spazio di terra benedetta che
circonda la chiesa, sembra possedere un grado di sacralità intermedio fra chiesa e
cimitero. I motivi per cui vi si ricorre possono essere vari, manifestazione di umiltà
come nel caso di Leandro Monegatto, che si fa seppellire vicino alla porta di San
Felice a Vicenza, ma sembra evidente che la causa fondamentale per cui si chiede
l'inumazione nel sagrato è data dalla temporanea impraticabilità della scelta
privilegiata. A Padova nei tremendi mesi centrali del 1576 il 29% dei testamenti lo
indica come luogo di sepoltura, in seguito nessun testatore rinuncerà a chiedere per sé
la chiesa. L’indicazione in tali circostanze è molto incerta, appare come
un’esortazione e spesso è velata dal pessimismo; si chiede il tal sagrato se sarà
possibile, oppure non se ne indica uno preciso, e l'unica condizione diventa che sia a
Padova, per finire con l'accettarne uno qualsiasi.
Al di là della contingenza epidemica, la scomparsa del sagrato dalle scelte dei
testatori attesta come ad una limitazione, con preciso indirizzo delle scelte, da parte
del vertice cattolico post tridentino, si contrapponga una reazione emotiva contraria:
al timore di vedersi abbandonate memoria individuale e istanze dell’anima, che i resti
mortali ricordano, in un terreno neutro e anonimo, i testatori risposero con i compor-
tamenti sempre più uniformi che abbiamo visto.
Anche nella scelta che da prevalente diventa dominante, la chiesa, avviene una
contraddizione delle volontà della gerarchia cattolica. Le chiese parrocchiali non
assumeranno mai il ruolo eminente che per loro era stato pensato, e i testatori
continueranno a preferire nelle due città le chiese degli ordini regolari. A Vicenza
Santa Maria dei Servi, Santa Lucia dei camaldolesi, San Michele degli agostiniani e
sopratutto Santa Corona dei domenicani, che ospita la confraternita del Rosario, la
più popolare presso i testatori del Seicento. A Padova la chiesa di Sant’Agostino dei
domenicani è la preferita, seguita da quella della Madonna dei Carmini.51
Legati pii
Nel suo trattato, il giurista spagnolo Diego Spino inseriva una sottile distinzione tra i
legati per l'anima, di cui i contemporanei avevano certo piena consapevolezza:
esistevano legati atti ad ottenere suffragio e altri “sine aliqua conditione vel
gravamine relicto”.52
Nel cinquantennio che qui consideriamo sempre più centrale diviene lo scambio tra
vivi e morti e le richieste, ad esempio, di messe all'altare del Rosario di Santa Corona
a Vicenza, via via più numerose, hanno uno scopo ben preciso: “cadauna libera
un’anima del Purgatorio”. 53 La pressione psicologica del predicatore o, all'estremo,
del confessore, può essere facilmente immaginata, ma può anche succedere che il
legato pio sia imposto per penitenza.54 La misura dei legati pii, sia in termini
51 Il dato è esposto analiticamente nel mio L’anima a Dio, pp. 224-228.52 D. Spino, Speculum testamentorum, cit., p. 148. La distinzione fra i due generi di legato era
scontata dal comune sentire. Per esempio la vicentina Lucrezia Bertele lasciava 10 ducati al parroco
di San Pietro precisando: “sive cinque amore Dei et per altri cinque li dica tante messe per salute
dell'anima sua”. ASVI, N, b. 8817, 1617-7.4.53 ASVI, N, b. 10332, 1630-25.1; a Padova, mandando una persona a San Marco di Venezia “per
anno uno intiero, ... si libera una anima del purgatorio per privilegio concesso a detta chiesa da sua
santità”ASPD, N, b. 5845, 1630-5.8.
qualitativi che monetari, ci testimonia quindi le strategie messe in atto al fine di
raggiungere la serenità interiore necessaria per poter affrontare la morte.
In totale sono presenti legati pii nel 33% (65 su 195) dei testamenti del triennio 1575-
77 e nel 78% (220 su 284) del triennio 1629-31.
Fra i legati pii sono quelli liberi e senza condizioni a configurarsi più direttamente
quale espressione di carità, mentre chi paga per un servizio che sente necessario alla
sua anima – i legati per suffragio – non sembrerebbe altrettanto ispirato.55 Vi sono
poi molti testatori che impongono un preciso termine dalla propria morte entro cui
pagare, mentre altri approfittano del proprio testamento per ordinare l'esecuzione di
disposizioni altrui, alla soddisfazione delle quali si erano sottratti.56
I testatori sono preoccupati che i legati non si paghino, gli eredi di vedere intaccato il
patrimonio familiare da eccesive liberalità. Oltre che una misura dell’angoscia
individuale, questo passaggio del documento testimonia quindi anche della coesione
del gruppo parentale. Ne risulta il dato che più testimonia l’evoluzione dei
comportamenti dei testatori. A Vicenza si passa da un investimento di 78 lire per
legato per suffragio, con una presenza di 0,33 legati per testamento (totale 26 lire) nel
1575-77, a 202 lire per legato e a 1,58 legati per suffragio nel 1629-31 (320 lire per
testamento) mentre l’investimento in legati pii liberi passerà da 120 lire a 117 per
testamento. Il dato padovano risulta ancora più clamoroso poiché i legati per
suffragio passano da 19 lire per testamento a 301 lire e quelli liberi da 22 a 92 lire.57
54 Paolina Zuccato, che testa a Padova nel 1617, afferma di ordinare i sei pellegrinaggi contenuti nel
documento “per soddisfatione ... della penitentia che mi è stata data dal mio confessore" ASPD, N,
b. 3896, 1617-6.2.55 Le differenze vanno sfumate; molti dei legati che si presentano come incondizionati si rivolgono
ad istituzioni devote i cui membri pregano per i benefattori. Del resto è da ritenere che le vedove
usufruttuarie, o gli eredi, pur se non vincolati direttamente, rispettino la consuetudine di fare
celebrare messe di requiem per il defunto.56 Esempi nel mio L’anima a Dio, cit. pp. 262-26357 Con un investimento complessivo in legati pii di lire 146 contro 437 a Vicenza e 41 contro 393
lire a Padova. Le cifre sono indicizzate e scontano gli effetti inflazionistici. Per un maggior
dettaglio analitico, illustrato da tabelle e grafici, cfr. L’anima a Dio, cit. pp. 269-270.
Si assiste quindi a una costante progressione dei legati pii che privilegia nettamente
quelli per suffragio. Il testamento diviene così sempre più lungo e complesso, e
sempre più orientato in senso spirituale – i legati a laici passano da 2,33 a 2,39 per
testamento.58 Una spiritualità in cui i testatori “contano le messe e soppesano i ceri”
nei gesti di una pratica religiosa sempre più quantitativistica.59
Nei valori prevalgono i legati laici, nonostante che in questa fattispecie sia più
rilevante il peso del legato non monetario, documentando solidarietà che hanno in
tutto il periodo un ruolo preminente. Vi si evidenziano rapporti di vicinato, di
conoscenza e fiducia, di affinità affettive che il testatore sente come vincolanti
rispetto a parenti la cui “voracità” viene anzi spesso tacitata con formule di
diseredazione che prevedono l’assegnazione di 5 o 10 soldi.
L’istituzione di erede
Come si diceva il testamento medio dell'ultimo scorcio di Cinquecento è
relativamente meno complesso di quello dei primi decenni del Seicento, e ciò vale
anche per il suo elemento fondamentale, l’istituzione di erede. Raramente vi sono
comprese raccomandazioni, vincoli e diseredazioni. Si assiste poi ad una crescita
consistente di tali inserti testuali, che sono particolarmente accentuati nei testamenti
delle donne. Il crescente ruolo femminile, già sottolineato nella Siena della
Controriforma,60 si biforca; talvolta contraddice il principio patrilineare del ceppo
familiare, talaltra le madri svolgono un ruolo di puntello dell’apparente declino
dell'autorità paterna. Un’autorità che molti figli contestano, come testimonia il caso
di Girolamo Alazzo, che vive “spenado [dissoluto?]... senza alcuna obedientia ... et
quel ch’è pegio ha sparso parole di voler amazzare il ... padre [e che] lo vuole
abbruscire in casa”.61 Più ancora delle impertinenze, o delle violenze, che i padri
58 Con una diminuzione del valore per testamento da 774 a 502 lire, cfr. L’anima a Dio, cit. p. 335,
344.59 M. Vovelle, La morte in Occidente, cit. p. 265.60 S. K. Cohn jr., “Donne e controriforma a Siena”, Studi storici, 1, (1989), 203-224. 61 ASVI, N, b. 8422, 1607-11.4. Testamento del padre Giacomo Alazzo.
denunciano spesso di aver subito da figli ribelli, si segnala il crescente fenomeno
dell'emancipazione e dell'abbandono del tetto comune. In questo caso il rammarico di
un padre per il figlio lontano, che spesso è accusato di dilapidare le sostanze, si
accompagna all’indignazione per la perdita di autorità.62 Unico è invece il caso di
quel figlio che, assegnati al padre un letto, alcuni capi di vestiario e altri mobili –
tutte cose guadagnate, fa scrivere al notaio, “con li suoi propri sudori”, e che
testimoniano quindi generosità, non riconoscenza – , ne denuncia la prodigalità che lo
ha condotto a dilapidare tutta la dote della madre e invita i fratellastri, per ogni
pretesa di legittima, a chiedere conto al genitore.63
I lignaggi nobiliari più di altri si trovano ad affrontare il dilemma della
conservazione del patrimonio, che è indissolubilmente legato all’onore famigliare.
Le strategie messe in atto dalle famiglie fanno riferimento costante a fedecommesso e
primogenitura. Se si prospetta il rischio di estinzione si cooptano rami collaterali,
infine si giunge ad imporre all’erede istituito di adottare il cognome del testatore.64 Se
la prospettiva diviene quella di un esaurimento delle sostanze, si arriva ad un
allargamento dell'idea di nobiltà, espediente adottato da Girolamo Chiericati,
appartenente a una delle prime famiglie di Vicenza, che impone ai figli eredi un
matrimonio con “donna nobile ... dichiarando però che sii nobile anche quella che gli
desse in dote molti beni”.65
A Vicenza la prevalente nomina a eredi di figli maschi è scontata, ma essendo
mediamente del 50% pone qualche problema. Considerato che le norme statutarie
delle due città prescrivono la successione dei figli maschi e della loro discendenza
maschile, chi testa intende quindi alterare la successione legittima anche nell’aspetto
che del testamento è il più vincolante.
62 Diversi esempi in L’anima a Dio, cit. pp. 372-373.63 ASPD, N, b. 920, 1606-7.8.64 ASPD, N, b. 3896, 1617-1.10. Girolamo Gloria, ultimo maschio della sua casata, nomina erede la
nipote Bettina e le impone il matrimonio con Giovanni Capodilista, purché questi assuma il
cognome del testatore.65 ASVI, N, b. 8814, 1628-27.12
La forbice che divide l’investitura dei figli maschi da altri possibili eredi –
collaterali/ascendenti, nipoti, coniuge, luoghi pii – si attenua nel 1629-31 quando le
figlie femmine sono nominate ben 13 volte contro le 20 dei maschi. Certo, la nomina
di femmine può essere suppletiva all'altra; è infatti impossibile che un padre
sostituisca ad un figlio ingrato una figlia, piuttosto inventerà altre soluzioni punitive
per l'erede. Va però ricordato che anche in questo caso gli Statuti dettavano una
precisa alternativa nella successione a chi non avesse avuto figli: l'ascendenza e la
collateralità agnatizie.
I vicentini dimostrano un’attenzione crescente ai luoghi pii quali possibili destinatari
dell’eredità, tanto che nell’ultimo periodo (1629-31) sono nominati da quasi il 10%
dei testatori. Nel frattempo vi è una fievole diminuzione della parentela ascendente e
collaterale. A genitori, e soprattutto fratelli, si preferiscono mogli e figlie femmine al
punto che qualche studioso ha spiegato la diffusione del testamento presso le classi
sociali meno abbienti proprio attraverso la devoluzione a figlie, che coopta all’interno
della casa il lavoro dei cognati.66
Quanto detto vale per i maschi; le testatrici, quasi mai nubili, dovrebbero essere
completamente condizionate nelle loro scelte verso mariti o figli, ma la percentuale
dei figli maschi non raggiunge il 30%. I dati confermano l’assunto che “le società
letterate producono insiemi di norme in forma scritta che possono essere molto
lontane dalla pratica”.67
Ciò spiega perché i figli, nel loro insieme, non raggiungono mai il 50% delle
istituzioni di erede mentre la nomina di ascendenti e collaterali è in lento declino.
66 Si chiami eredità o dote, l’aspetto costitutivo del sistema successorio europeo è che tutti i figli
condividono la ricchezza. In Europa e in Asia le femmine erano di regola preferite ai maschi di
grado più lontano. J. Goody, “Introduction”, Family and inheritance, cit., 2-8.67 J. Goody, Famiglia e matrimonio in Europa, Milano 1984, p. 219. “Contro la rete formale dei
legami di sangue ... giocava la strategia complessa delle scelte, delle esclusioni, delle integrazioni
che rendevano elastico l’organismo familiare. Strutture familiari, meccanismi protettivi di carità,
una impalpabile rete di amicizie, vincoli, protezioni dovevano colmare un quadro che i calcoli
strettamente economici non rappresentano che in modo distorto e parziale”. G. Levi, L’eredità
immateriale, Torino 1985, pp. 50-51.
L'investitura dell'eredità alla moglie segnala un chiaro riconoscimento di affetto che
spesso doveva essere rafforzato da severi ammonimenti verso i figli. La nomina del
marito invece si può inscrivere in una più normale esigenza di tutela della di-
scendenza. Il marito pare sia visto dapprima come scelta alternativa ai parenti
collaterali, poi ai figli. Parte sostanziale della famiglia nucleare affettiva all’inizio, lo
si percepirebbe più avanti come una sorta di paladino degli interessi del suo ceppo di
provenienza. Una supposizione che spiegherebbe molto delle crisi familiari così
presenti nei testamenti del Seicento, soprattutto alla luce di quella che appare come
una solidarietà femminile strisciante, testimoniata da legati a donne, dalla nomina ad
erede delle figlie – anche se in questo caso possiamo pensare ad una trasmissione
della dote – soprattutto alla non episodica investitura ad amiche.
Nel gruppo di testamenti rogati a Padova le percentuali di figli maschi nominati eredi
dai padri sono inferiori alle vicentine, mediamente del 35%, mentre le femmine sono
per tutto il periodo nominate nel 15% dei casi, con un unico sensibile calo nell'ultimo
periodo. Il modello patrilineare legato al lignaggio ed alla discendenza maschile si
presenta perciò molto più evidente a Vicenza rispetto a Padova e ciò, va ricordato, in
presenza di Statuti cittadini molto più vincolanti nella città euganea. Una
interpretazione che si correggere in parte con piccole variazioni che testimoniano per
la città del Santo un lievissimo aumento tendenziale di nomina di collaterali.
La nomina di figli maschi è crescente nelle femmine, ma passa dal 10% a circa il
26%. Anche la nomina di figlie, oscillante intorno al 10% e la nomina congiunta di
figli e figlie, mediamente intorno al 5%, aprono la strada ad una maggior presenza
delle scelte alternative nelle testatrici padovane. Il marito fa registrare un lieve calo,
ma parte da quote percentuali molto alte, circa il 20%. Importante è la nomina di
nipoti, che raggiunge quote medie simili a quelle già registrate per le testatrici
vicentine (circa 20%).
Le testatrici padovane partono da una preferenza consuetudinaria rivolta ai mariti
superstiti. Nel periodo si verifica però una lenta inversione di tendenza: aumenta
l'investitura a figli e nipoti e diminuiscono le nomine di mariti.
La sostituzione di erede
La scelta di nominare un sostituto al primo erede dipendeva in molta misura
dall'ansia di mantenere intatto il patrimonio familiare. La minaccia alla proprietà
poteva derivare da dissipatezze degli eredi futuri, o da attacchi esterni che, in un
futuro lucidamente immaginato dal testatore, avrebbero potuto intaccare, con i beni,
lo status familiare. Il problema della sostituzione era considerato con grande
attenzione dai giuristi, poiché attraverso di essa venivano strutturati per molte
generazioni – per sempre con il fedecommesso – i destini delle famiglie. Un
condizionamento così forte avrebbe dovuto essere esattamente precisato in
considerazione del fatto che andava a toccare interessi non ancora venutisi a
costituire. La soluzione più comune adottata dai testatori era il fedecommesso,
attraverso cui l’erede designato, con l’accettazione dell’eredità, si impegnava a
restituire ad altri, in genere la propria discendenza, una parte o tutto l’asse ereditario.
La necessità della restituzione imponeva la conservazione dei beni con conseguenti
vincoli di inalienabilità e indivisibilità. Spesso gli Statuti riconoscevano all’erede così
condizionato la libera disponibilità della trebellianica che corrispondeva ad un quarto
dell'eredità.
Una prima lettura del documento va appunto nella direzione di verificare quanto
fosse in uso l'istituto e con che dinamica si evolvesse nel periodo. Vi sono poi da
considerare i vincoli di priorità che il testatore stabiliva: cosa infatti il capofamiglia
decideva di sostituire alla scelta logica dei figli maschi? Il ceppo di origine di cui egli
stesso era diramazione, o il nucleo di cui invece era provvisorio capostipite?
La questione è importante perché se nei momenti di crisi demografica si è di fronte al
tentativo del testatore di impedire che l'espressione della propria volontà possa essere
annullata dal morbo, in periodo di tregua epidemica la sostituzione di erede assume
un più evidente carattere di tentativo di controllo sulle generazioni future. L'esempio
più lampante di ciò è dato dalla gran parte dei testamenti in cui è istituito il
fedecommesso: in tali documenti la nomina dell'erede, le sostituzioni per linee, il
tentativo di prevenire qualsiasi accidente che impedisca l'osservanza dei vincoli
imposti rendono questa parte del testamento, altrimenti insignificante, la più lunga e
complessa.
Se il testatore non avesse provveduto alle sostituzioni, nel momento in cui fosse de-
caduto l'erede testamentario vi si sarebbe sostituto quello legittimo secondo il dettato
dagli Statuti, ferme restando le altre parti del testamento. Una delle chiavi
interpretative della contrastata vicenda di Girolamo Dal Mulo, nobile padovano che
redige due testamenti a distanza di un anno l'uno dall'altro, sta principalmente nella
necessità di ovviare alla dimenticanza di nomina di un sostituto al figlio Valerio il
quale, nominato erede nel primo testamento del 1589, morì subito dopo. La
dimenticanza avrebbe permesso alla figlia Giulia, rinnegata dal testatore, di avanzare
diritti sul patrimonio paterno; nel secondo testamento Girolamo nominava eredi i figli
di un cugino e la loro discendenza.68
A Vicenza vi è una media costante intorno al 60% dei testamenti in cui è presente un
unico erede. Se nella nomina di erede è pur sempre la scelta della linea maschile a
prevalere, nelle seconde scelte vi è dapprima un equilibrio fra agnazione e
cognazione caratterizzato in misura prevalente da un ritorno alla famiglia di origine
attraverso la nomina dei fratelli. Alla svolta del secolo si assiste ad uno
sbilanciamento in direzione ancora della linea di discendenza patrilineare, che
stavolta però si caratterizza molto più fortemente dall'indicazione della discendenza
maschile degli eredi primi nominati. Sembra esservi in generale un'evoluzione che,
partendo da un senso di generica appartenenza ad un ceppo familiare, si sposta verso
una patrilinearità che vede nel testatore una sorta di capostipite, che tenta di
strutturare le sue successioni a partire da se stesso. Le donne invece dimostrano una
crescente attenzione all'agnazione.
A Padova, per fare solo un esempio, diventa da questo punto di vista significativo
confrontare le scelte di Girolamo Bacco e Angela Pasini. Il primo, alla fine del 1577,
“volendo, avanti vadi in galia ad essequir la sententia contra lui fatta, preveder delli
suoi beni”, di fatto nomina erede la figlia naturale Angioletta (cui assegna una 68 Sulla vicenda rinvio al mio “Sempre parati al combatter”, Studi Veneziani, XXX (1995), 79-107.
rendita, una dote al matrimonio e tutti i livelli), alla sua morte assegna una rendita di
sei ducati l'anno a Faustina, madre di Angioletta, e le sostituisce due fratelli, un
maschio ed una femmina. Trent’anni più tardi Angela nominerà eredi tre figli maschi
e la loro discendenza legittima “et non legitimadi in qual si voglia modo ne anco per
sussequente matrimonio usque in infinitum”. A questi sostituisce, “volgarmente,
pupillarmente et per fidecommisso (ossia prevedendo ogni possibile forma di
sostituzione)”, le nipoti femmine figlie dei figli maschi; al terzo livello nomina eredi i
nipoti maschi figli della figlia Prosdocima ed infine, solo come quarto erede, il nipote
maschio figlio del fratello Giacomo.69 Angela, il cui testamento è confrontabile con il
precedente per l'atteggiamento opposto verso i figli naturali, dimostra anche un
concetto dell'agnazione piuttosto generalizzato nel Seicento anche a Vicenza: la linea
di discendenza maschile si privilegia anche a costo di interromperne fin da subito la
continuità con le nipoti femmine nate da figli maschi. La scelta suggerita dagli Statuti
in alternativa a questa, i fratelli maschi, è relegata al quarto grado, quando la scelta di
patrilinearità è già precedentemente caduta con la nomina dei nipoti figli di figlie.
Anche Girolamo Bacco, nella situazione esistenziale molto particolare in cui si trova,
ha in mente la discendenza. Alla figlia naturale sostituisce infatti non già la madre,
ma i fratelli, un maschio e una femmina. Ancora una volta le scelte reinterpretano la
cultura successoria trasmessa dagli Statuti e considerano altri fattori come affetti,
meriti, contiguità. Ma se con la nomina del primo erede è possibile deviare dalle linee
guida per la forza del sentimento, il persistere di tali deviazioni nella sostituzione fa
intravedere l’emersione di un nuovo concetto di famiglia. Un dato tendenziale sembra
in tal senso essere dato dall'aumento delle scelte della linea femminile.
Conclusione
I testamenti dell’età della Controriforma di due grandi città della terraferma veneta
rivelano strategie familiari, patrimoniali e devozionali molto dissimili. Ciò rende
ancor più significativo il generale aumento, sia nel numero che nei valori medi, degli
investimenti in legati pii destinati all’ottenimento di suffragi. Esiste quindi, e nel 69 ASPD, N, b. 4599, 1577-28.9; b. 4444, 1608-30.12 (ma 1607).
periodo se ne enfatizzano i caratteri, un “testamento spirituale” contraddistinto da una
forte spinta alla necessità morale da un lato di provvedersi di suffragi, dall’altro di
organizzare dettagliatamente, in termini si potrebbe dire contabili, il transito ed il
soggiorno ultraterreno. Il testamento medio è progressivamente allungato da legati di
varia natura, e complicato da clausole sempre più minuziose. Tutto questo comporta
però conseguenze negative sulle dinamiche dei rapporti interni alle famiglie, tanto
che le resistenze degli eredi alla puntuale soddisfazione dei legati sono pesantemente
denunciate nelle Costituzioni sinodali dei primi vescovi post conciliari. Nel
testamento veneto della Controriforma hanno ancora un ruolo determinante i legati
“laici”, i cui destinatari sono in misura crescente scelti al di fuori della cerchia dei
parenti.
Lo scollamento tra le generazioni non si coglie solo in relazione ai legati, ma anche
nelle disposizioni più vincolanti. Il caso di Padova è emblematico: tanto più gli
Statuti restringono la libertà di disporre, imponendo l'agnazione ascendente e
collaterale anche ai testatori, quanto più vengono disattesi dai testatori.
Vi è una crescente attenzione verso le donne da parte dei maschi, in modo particolare
a Padova dove l’istituto della controdote – denaro o beni assegnati alla vedova in
aggiunta alla restituzione della dote –, quasi del tutto assente a Vicenza, spinge verso
una accentuata valorizzazione del nucleo neolocale in aperta dialettica, soprattutto nei
lignaggi aristocratici, con la famiglia di origine della sposa. Altre volte la centralità
della donna sembra fondarsi sull'autorità di cui la vedova è investita nel tentativo di
conservare intatte proprietà e unità della famiglia.
Le tombe degli altari confraternali, presso cui i testatori chiedono di essere inumati
anche per aggirare le limitazioni alla sepoltura in chiesa, comportano un distacco che
rompe l’unità dei consanguinei, quell’unità che invece fa parte integrante del modello
familiare agnatizio. Anche i più doviziosi, ai quali le deroghe sono generosamente
concesse, talvolta dimostrano di non riconoscersi nei valori tradizionali.
L'istituzione di erede conferma l'ipotesi di uno scollamento progressivo e costante
dall'agnazione a favore della cognazione. La quota di testatori che nomina eredi i figli
maschi è naturalmente maggioritaria, ma sono ben rappresentate altre categorie.
Ulteriore conferma di ciò viene dalle sostituzioni dove alle linee agnatizie più lontane
è spesso preferita la nomina delle figlie.
La Chiesa rinnovata nel suo impegno di disciplinamento della società che esce dal
Concilio di Trento trasforma i caratteri del popolo dei testatori nelle forme che
abbiamo sommariamente delineato, e il testatore veneto della Controriforma sente di
essere più solo dei suoi antenati di fronte alla morte. La “morte di sé” di Philippe
Ariès assume però un valore che travalica l'ambito meramente spirituale in cui lo
storico francese l'aveva collocata. La vita del testatore della fine del Cinquecento
riflette esperienze e valori preconciliari, ma egli comincia a intuire le differenze fra il
suo intimo sentire e quello dei suoi figli. L’angosciosa attesa del giudizio divino e,
dall'altro lato, la definizione dei rapporti venutisi a costituire durante la sua esistenza
si strutturano in un testamento che riflette le pulsioni di una società inquieta e
disorientata di fronte alle sfide del tragico Seicento.