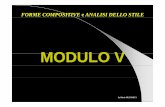Ascesa e declino dello Stato Sociale: crisi economica e malessere dello Stato
Transcript of Ascesa e declino dello Stato Sociale: crisi economica e malessere dello Stato
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Facoltà di Lingue e Letterature straniere
Corso di Laurea Triennale in Comunicazione
interculturale per la cooperazione
internazionale, l'impresa e l'ambiente
ASCESA E DECLINO
DELLO STATO
SOCIALE
Relatore: Prof. Giovanni A. Scirocco
Autore: Andrea Sem Castelli 1012877
Anno accademico 2012-2013
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 2
SOMMARIO
INTRODUZIONE 4
CAPITOLO I: CRISI ECONOMICA E MALESSERE DEL MERCATO 8
1.La crisi economica del 2008 8
1.1. Le origini 10
1.2. Lo scoppio 12
CAPITOLO II: IL MALESSERE DELLO STATO 17
1. APOLOGIA DELLA CRESCITA ECONOMICA 18
2. L’EVOLUZIONE DEL CONSUMO E LE SUE CONSEGUENZE SUL
PIANO SOCIALE 23
3. CRISI DELLA RAPPRESENTATIVITÀ E DEL SENSO DI COMUNITÀ 26
CAPITOLO III: L’ASCESA E DECLINO DELLO STATO SOCIALE 32
1.Definizione di Welfare State 32
2.Prime esperienze di lotta al pauperismo 33
2.1. Le prime lotte 33
2.2. l’illuminismo, l’età delle rivoluzioni e la Speenhamland Law 34
3.Nascita dello Stato Sociale 36
3.1. Il modello Bismarckiano 36
3.2. Liberali e socialisti: dalle riforme alla Grande Guerra 37
4.Ascesa dello Stato Sociale 39
4.1. Il new deal 40
4.2. Lo Stato sociale totalitario 41
5.L’apogeo del Welfare State 42
5.1. La costruzione dello Stato Sociale dal 1945 al 1970 43
5.2. L’assistenza sanitaria pubblica 45
5.3. Lavoro, Casa e Istruzione 46
5.4. Il sessantotto e l’ultima spinta riformatrice 46
6.Il Declino del Welfare State 48
CONCLUSIONI: IL TRAMONTO DEL WELFARE STATE? 51
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 3
L’uomo è divenuto un superuomo […] Ma
il superuomo col suo sovrumano potere non
è pervenuto al livello di una sovrumana
razionalità. Più il suo potere cresce, e più
egli diventa anzi un pover’uomo […] Le
nostre coscienze non possono non essere
scosse dalla constatazione che, più
cresciamo e diventiamo superuomini, e più
siamo disumani.
Albert Schweitzer
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 4
INTRODUZIONE
Siamo in un periodo storico unico, in cui le società mondiali, specialmente quelle
occidentali, presentano troppo spesso una natura incomprensibile e le persone che la
abitano incontrano grandi difficoltà nell'attribuire loro dei significati. Il Progresso in
filosofia indica una trasformazione per gradi, ciascuno dei quali costituisce un
miglioramento rispetto a quello precedente e tutti insieme si inscrivono in un processo
lineare e continuo. A questa definizione è sottintesa una concezione della storia
universale per la quale essa tenderebbe verso un miglioramento continuo e illimitato –
inteso come accumulo di conoscenze, di avanzamenti nel campo delle condizioni
materiali oppure morali dell'umanità – che non esclude momenti di stasi o di parziale
regresso, senza che ne sia però intaccata la tendenza di fondo. È già successo nel corso
della storia che l'idea di Progresso sia stata criticata e rifiutata, basti pensare a Nietzsche
e la scuola di Francoforte. Oggi questo interrogativo si ripropone sotto altre sfumature:
la crisi economica riflette una situazione ben più grave che intacca numerosi altri
ambiti. In primis la crisi delle ideologie e della politica, non più riconducibile alla sua
etimologia originaria e cioè l'amministrazione della città, ha atrofizzato la
partecipazione dei cittadini nell'interesse dei beni comuni.
Finanziaria o borsistica, la crisi che oggi ci scuote, probabilmente in superficie, nasconde e
rivela rotture che travalicano nel tempo la durata stessa della storia [...] Se viviamo
veramente una crisi nel senso forte e medico del termine, allora non c'è nessun ritorno
indietro e i termini rilancio o riforma sono fuori luogo.1
Michel Serres ha colto con queste frasi il senso originario dell'etimo "crisi" e cioè
«perturbazione o improvvisa modificazione nella vita di un individuo o di una
collettività con effetti più o meno gravi e duraturi o situazione di disagio determinata sul
piano sociale dalla mancata corrispondenza tra valori e modi di vita, perlopiù sintomo o
conseguenza di profondi mutamenti organici e strutturali».2
1 M. SERRES, Tempo di Crisi, Bollati Boringhieri, Torino, 2010, p.11
2 G. DEVOTO, G. C.OLI, Vocabolario della Lingua Italiana 2011, Le Monnier –
Mondadori, Milano, 2011
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 5
Tuttavia, non meno importante, la parola rappresenta un prestito latino di origine greca:
krisij e cioè il separare o la scelta, giudizio, capacità di discernimento da krinw
separare, scegliere, valutare, risolvere una causa in senso giuridico3.
Quindi nonostante oggi l'accezione negativa emergente dall'opinione pubblica e dai
mass media, la parola è a tutti gli effetti ambivalente e offre a noi la possibilità di una
scelta che può diventare anche opportunità; pensiamo anche al cinese, wēi-jī, che ha
anche in questo caso una duplice valenza, pericolo e appunto opportunità.
Nel 1955 Albert Einstein diceva queste parole:
Non pretendiamo che le cose cambino, se facciamo sempre la stessa cosa. La crisi è la
migliore benedizione che può arrivare a persone e Paesi, perché la crisi porta progresso. La
creatività nasce dalle difficoltà nello stesso modo che il giorno nasce dalla notte oscura. È
dalla crisi che nasce l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera
se stesso senza essere superato. Chi attribuisce alla crisi i propri insuccessi e disagi, inibisce
il proprio talento e ha più rispetto dei problemi che delle soluzioni. La vera crisi è la crisi
dell'incompetenza. La convenienza delle persone e dei Paesi è di trovare soluzioni e vie
d'uscita. Senza crisi non ci sono sfide, e senza sfida la vita è una routine, una lenta agonia.
Senza crisi non ci sono meriti. È dalla crisi che affiora il meglio di ciascuno, poiché senza
crisi ogni vento è una carezza. Parlare della crisi significa promuoverla e non nominarla
vuol dire esaltare il conformismo. Invece di ciò, dobbiamo lavorare duro. Smettiamola
definitivamente con l'unica crisi che ci minaccia, cioè la tragedia di non voler lottare per
superarla.4
Con il perpetrarsi delle logiche di consumo, unico modello di cittadinanza offerto, da
qualche decennio è in discussione l'identità stessa delle categorie sociali e del confine
tra pubblico e privato. Identità fragili in un mondo sempre più complesso: nella società
si sono diffusi nuovi malesseri e nuove sofferenze5 al posto del miracoloso benessere
che il marketing contemporaneo cerca di inculcare nelle menti di ciascuno. Non meno
importante al tema della cittadinanza si lega la crisi del welfare e dell'Unione Europea.
Il modello europeo è stato fin dall'inizio un nuovo modo di pensare la coesione tra stati
aventi come minimo comun denominatore una cultura europea che ha avuto il modo di
crescere, di innovarsi e di affermarsi in questi decenni.
3 F. MONTANARI, GI: Vocabolario della Lingua Greca. Loescher, Torino, 2004
4 Discorso di Albert Einstein 1955
5 Cfr. M. BENASAYAG E G. SCHMIT, Les Passion tristes: souffrance psychique et
crise sociale, La Découverte, Paris, 2003
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 6
“L’uomo onnipotente”6, in possesso di una potenza che non è mai stata così grande, è al
contempo angosciato da un senso di “inquietudine”; l’umanità è agitata da acute
incertezze e dubbi crescenti, che vanno di pari passo con l’aumento della sua potenza,
del suo controllo sul mondo.
Tutte queste crisi ci costringono giustamente a ripensare sia l'idea di uno sviluppo
appiattito sulla crescita, sia il ruolo della collettività e dei singoli. È tempo di rinnovare
la cultura politica di tutti i cittadini, basata sull'onestà intellettuale, capace di non
confondere sempre i mezzi con i fini, ma di educare e educarsi a capire il valore
collettivo delle proprie azioni e ciò che ne conseguirà.
Vorrei dunque ripercorrere e analizzare la cronologia di quello che è stato chiamato
welfare state, o meglio "stato sociale" per comprenderne il significato odierno.
Ritengo infatti che capire i malesseri dello Stato e del mercato, a cui far subentrare idee
nuove per un riscatto non più solamente locale ma globale, sia un buon esercizio per
ritrovare un senso di civiltà che da troppo tempo si è dimenticato.
Un esercizio difficile ma essenziale, oggi, avendo la consapevolezza della
modificazione della struttura dei rischi derivante dalla concorrenza dei Paesi emergenti,
dalla riorganizzazione dei processi produttivi, dalla frammentarietà del mercato del
lavorativo, dalla maggiore instabilità dei nuclei familiari, dall’invecchiamento della
popolazione, ecc.
I sistemi di welfare state ci stanno permettendo una protezione dai rischi del mercato? È
arduo oggi mantenere separati i due tempi tipici del fordismo su cui si basava la società
capitalistica occidentale dei primi anni del ‘900 (le imprese producono e lo Stato si
occupa del sociale) e i due fattori principali su cui si era costruito anche il welfare
europeo, cioè ricchezza e territorio, “poiché questo sistema si è incrinato sotto
l’incedere della globalizzazione dei mercati. […]. L’interesse dello Stato a conservare la
sua quota di sovranità non coincide più necessariamente con l’interesse delle imprese a
muoversi liberamente nei mercati internazionali alla ricerca di migliori opportunità di
profitto, né con l’interesse dei cittadini ad ottenere qualità migliori dei prodotti che
domandano e ad ottenere più ampi spazi di autogoverno del territorio.”7
6 Cfr. M. SALVADORI, Le inquietudini dell'uomo onnipotente, Laterza, Roma, 2003
7 L. BRUNI E S. ZAMAGNI, Economia Civile. Efficienza, equità, felicità pubblica Il
Mulino, Bologna, 2004, p. 19
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 7
Perciò questa prova finale vuole essere una ricerca discorsiva con il fine di
riappropriarmi della consapevolezza, sempre più sfuggevole, dei processi quotidiani
sociali, collettivi ed economici della nostra realtà.
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 8
CAPITOLO I: CRISI ECONOMICA E MALESSERE DEL MERCATO
Non occorrerebbe una grande elaborazione per arrivare
alla conclusione che un processo di cambiamento
indiretto il cui passo è ritenuto troppo rapido dovrebbe
essere rallentato, se possibile, per salvaguardare il
benessere della comunità. Tali verità familiari alla
tradizionale arte di governo, le quali spesso riflettevano
semplicemente gli insegnamenti di una filosofia sociale
ereditata dagli antichi, vennero cancellate nel
diciannovesimo secolo dalle menti della gente colta, dalla
corruzione di un brutale utilitarismo combinato ad una
fiducia acritica nelle presunte virtù autoterapeutiche della
crescita inconsapevole.8
Karl Polanyi
1. LA CRISI ECONOMICA DEL 2008
Questo primo capitolo è dedicato all’analisi della crisi economica, borsistica e
finanziaria sviluppatasi negli Stati Uniti d’America nel 2007 e diffusasi quasi
immediatamente in tutto il mondo occidentale con notevoli ripercussioni sulla politica
oltre che sull’economia reale.
Credo, infatti, sia opportuno ripercorrere le tappe di quella che è stata più volte definita
una crisi sistemica, cioè dell’intero sistema del capitalismo.
8 K. POLANYI, La Grande Trasformazione,Giulio Einaudi Editore, Torino, 1974, p.65
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 9
Come possono sopravvivere i modelli di welfare state che si sono via via sviluppati,
come vedremo in seguito, se ora l’umanità è alle prese con un’economia non più al
servizio dei cittadini come strumento regolatore di coesione sociale o di prosperità ma
come fine corrotto e volto alla prevaricazione del prossimo attraverso l’accumulo
indistinto di capitali finanziari?
Bisogna partire dal presupposto che la rivoluzione capitalistica consiste nella
differenziazione del sistema sociale in un sistema politico e in un sistema economico,
ciascuno dotato di una propria autonomia e di una propria logica, ma intimamente e
inestricabilmente interconnessi.
Semplificando lo schema che ci fornisce Angus Maddison, economista britannico, lo
sviluppo del capitalismo è influenzato da tre variabili:9
a) La prima è la struttura dei rapporti internazionali, e in particolare il
rapporto tra la potenza capitalistica dominante e le altre potenze capitalistiche.
Ad esempio il capitalismo moderno ha sempre avuto un fulcro mondiale:
l'Olanda, poi l'Inghilterra e infine gli Stati Uniti d'America.
b) La seconda variabile è quella dei rapporti tra le classi e i gruppi sociali.
Qui il fulcro del sistema è costituito dalla classe dominante e dalle grandi
imprese capitalistiche.
c) La terza variabile infine riguarda il fulcro tecnologico-produttivo del
sistema: il tipo dominante della sua organizzazione tecnica e la sua base
energetica.
Questi tre fulcri assicurano l'equilibrio e la prosperità del sistema e quando la loro
capacità di svolgere la loro funzione si attenua si determinano condizioni di crisi latente,
che shock esterni, in parte occasionali, in parte determinati da queste stesse condizioni
di crisi, trasformano in crisi manifesta.
Secondo questo schema quindi si possono facilmente suddividere periodi storici
caratterizzati da prosperità e crisi.
L’umanità ha già conosciuto nel corso della storia numerose crisi di natura anche
economica. Una delle più studiate è la grande depressione, la crisi economica e
finanziaria del 1929 che fu capace di sconvolgere l’economia mondiale con fortissime
ripercussioni sociali e politiche. Non furono posti limiti alle attività speculative delle
9 Cit. in G. RUFFOLO, La qualità sociale, Laterza, Roma, 1990, p.13
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 10
banche e della borsa valori. All’aumento del valore delle azioni industriali non
corrispose un effettivo aumento della produzione e della vendita di beni tanto che,
accresciuto per la speculazione diffusasi in quegli anni, scese rapidamente costringendo
i possessori ad una massiccia vendita che provocò il noto crollo della borsa. L’uscita dal
mercato della media borghesia, che da tempo sosteneva la domanda di beni di consumo
durevoli, innescò una reazione a catena producendo un blocco dell’economia americana
attraverso una crisi di liquidità. La popolazione immediatamente dopo il crollo della
borsa valori si precipitò a recuperare i risparmi nelle banche e il calo dei consumi,
l’aumento della disoccupazione e il conseguente indebolimento della domanda fecero
assumere alla crisi i connotati di una crisi di sovrapproduzione.
Un esempio più vicino a noi è stata la crisi degli anni Settanta in cui si percepiscono già
i primi segnali di una situazione ben più grave i cui effetti e interrogativi si sono
protratti, in molteplici forme, fino ai nostri giorni.
1.1. LE ORI GINI
A partire dagli anni Settanta infatti una serie di riforme economico-finanziarie
contribuirono a plasmare un nuovo delicato sistema internazionale. La prima fra tutte fu
nel 1971 con l’interruzione del sistema di Bretton Woods e cioè la fine della
convertibilità aurea del dollaro. La deregolamentazione finanziaria, la creazione di
nuovi strumenti finanziari, i progressi tecnologici nel campo dell'informatica, l'aumento
della frequenza dei flussi finanziari e della liquidità nell'economia internazionale,
accanto all'aumento del costo del petrolio, hanno prodotto un rafforzamento del ruolo
della finanza internazionale all'interno del sistema economico tanto che, ad oggi, il peso
economico dei prodotti finanziari risulta ampiamente superiore a quello della
produzione mondiale di beni e servizi.10
Per comprendere meglio la situazione degli
anni Settanta possono essere utili le parole dello storico J.K. Galbraith:
Alla fine degli anni Settanta l'inflazione persisteva. Aumenti delle tasse, riduzione della spesa
pubblica, intervento diretto sui salari e prezzi furono tutti esclusi come rimedi. Come è stato osservato
a sufficienza, rimaneva solo la politica monetaria. Perciò nell'ultima parte del decennio
l'amministrazione dichiaratamente liberale del presidente Jimmy Carter negli Stati Uniti e il governo
dichiaratamente conservatore del primo ministro Margaret Thatcher in Gran Bretagna avviarono una
10
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2011-08-06/finanza-derivati-otto-
volte-203127.shtml?uuid=Aae9BSuD
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 11
forte azione monetaristica. La Rivoluzione keynesiana fu messa in soffitta. Nella storia dell'economia
l'età di John Maynard Keynes cedette il passo all'età di Milton Friedman. 11
Grazie all’inconvertibilità aurea gli Stati Uniti riuscirono a operare una serie di
svalutazioni monetarie fino al 1973, favorendo un veloce aumento delle esportazioni e
della circolazione monetaria che fu tra le cause del forte irrobustimento dei fenomeni
inflattivi. Questo fenomeno fu determinato, tra le altre cose, anche da uno shock di
natura geopolitica legata a squilibri nell'area mediorientale e dai conseguenti rialzi dei
prezzi delle commodities, vale a dire i beni per cui c'è domanda e che sono offerti sul
mercato da più produttori senza differenze qualitative, come ad esempio il petrolio che
come vediamo dal grafico triplicò il suo costo12,13
:
Come abbiamo visto il capitalismo ha radicalmente cambiato forma negli ultimi decenni
del Novecento. Alcuni esempi sono la mondializzazione dei flussi finanziari, la
velocizzazione di quelli informativi, monetari e informatici, la flessibilità del lavoro,
11
J.K. GALBRAITH, Storia Economica, BUR, Milano, 1990, pp. 302-303 12
C. R. MORRIS, Crack. Come siamo arrivati al collasso del mercato e cosa ci
riserva il futuro, Elliot, Roma, 2008, p.13 13
http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wtotusaw.htm
Figura 1: Dollari per barile di petrolio, periodo Gennaio 2003 – Novembre 2008.
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 12
l'aumento dell'ineguaglianza globale e non da ultimo l'avvento di un’industria proiettata
nel post-fordismo, che supera il modello produttivo fordista-taylorista fondato sulla
grande impresa e sulla catena di montaggio, sostituito dalle industrie fondate sui
distretti, sulle reti produttive e sulla delocalizzazione.
Si è aperta una fase storica in cui gli investimenti finanziari oltre ad apparire preferibili
rispetto a quelli produttivi, hanno acquisito sempre più importanza a discapito di
vulnerabili Stati-nazione in seria difficoltà nel risolvere i problemi socio-economici,
inabili al controllo e alla regolazione del mercato finanziario.
1.2. LO SCO PPIO
La crisi che stiamo conoscendo sta ridefinendo i confini tra
stato e mercato costringendoci ad ammettere la nostra
incapacità di gestire la sostenibilità finanziaria, sociale e
ambientale dell’economia globale. 14
Nel libro Prosperità senza Crescita pubblicato Tim Jackson si interroga sulla miccia
che ha innescato lo scoppio della crisi economico finanziaria, i cui segnali erano già
lampanti qualche anno prima. Alcuni hanno sottolineato come i credit default swap,
usati per impacchettare i titoli tossici e nasconderli così dai bilanci, fossero impossibili
da gestire; altri hanno puntato il dito contro gli avidi speculatori e gli investitori senza
scrupoli che hanno cercato facili guadagni ai danni di istituzioni vulnerabili.
Già nel 1999 Paul Krugman, economista della Princeton University in un saggio dal
titolo Il ritorno dell’economia della depressione aveva analizzato le crisi che hanno
devastato diverse economie in Asia e in America Latina, quasi ignorate dai paesi
occidentali.
Nei primi anni del XXI secolo il boom di Wall Street e il trionfo della finanza
sembravano smentire la previsione di una crisi sistemica come aveva annunciato
Krugman:
[…] l’implosione di una bolla immobiliare paragonabile a quella che si è creata in
Giappone alla fine degli anni ’80; un’ondata di corse agli sportelli paragonabile a quelle dei
14
T. JACKSON, Prosperità senza crescita. Economia per il pianeta reale, Edizioni
Ambiente, Milano, 2011, p. 63
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 13
primi anni Trenta; un grosso problema di liquidità negli Stati Uniti, analogo a quello che si
era presentato in Giappone; e ultimamente una discontinuità dei flussi internazionali di
capitale e un’ondata di crisi valutarie, fin troppo simile a quella che si è avuta in Asia alla
fine degli anni Novanta.15
Il “grande crack” del sistema si è poi verificato nel settembre 2008, e nelle stesse
settimane Paul Krugman ha vinto il Premio Nobel per l'Economia.
È comunque ritenuta comunemente valida l’ipotesi che la grande recessione che la
maggior parte dei paesi industrializzati sta vivendo oggi sia la conseguenza della crisi
finanziaria che ha avuto inizio nell’agosto del 2007 in seguito a una bolla immobiliare
speculativa caratterizzata da un rapido aumento dei prezzi immobiliari e amplificata dai
cosiddetti mutui subprime.
I mutui subprime prevedevano, infatti, un tasso d’interesse molto basso per i primi anni
e un aumento ingente nei successivi e oltretutto senza preoccuparsi della solvibilità dei
clienti. L’indebitamento ipotecario americano, che ha raggiunto più del 70% del PIL,
per un indebitamento totale delle economie domestiche pari al 93%, ha costituito così il
motore della bolla immobiliare.16
L'esplosione di tale bolla fu amplificata ulteriormente dal fatto che le banche
statunitensi, al fine di ridurre l'esposizione rispetto a questi prodotti finanziari molto
rischiosi, vendevano a terzi i mutui stessi attraverso diversi strumenti finanziari (come
la cartolarizzazione) parcellizzandoli e riassemblandoli con altri prodotti finanziari
(come ad esempio CDO, CMO, CLO, ABS).
In questo modo le banche scaricavano su altri soggetti, inizialmente investitori
istituzionali, ma poi anche banche e risparmiatori, i rischi e li distribuivano in tutto il
mondo. Tali processi hanno infettato l'intero sistema finanziario mondiale. La forte
svalutazione di questi strumenti innescò difficoltà gravissime in alcuni fra i più grandi
istituti di credito americani (Bear Sterns, Lehman Brothers e AIG). Nessuno sembrava
sapere di chi fossero questi debiti “senza valore” e così, improvvisamente, le banche
non erano più disposte a finanziarsi a vicenda. Questa situazione provocò tra il 2007 e il
2008 il collasso delle banche e delle banche finanziarie determinando in alcuni casi i
fallimenti di tali istituti, in altri una forte riduzione dei valori borsistici con una
15
P. KRUGMAN, Il ritorno dell’economia della depressione, stiamo andando verso
un nuovo ’29?, Garzanti, Milano, 1999, p.168 16
A. FUMAGALLI E S. MEZZADRA (a cura di), Crisi dell’economia globale,
mercati finanziari, lotte sociali e nuovi scenari politici, Ombrecorte,Verona, 2009, p.28
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 14
conseguente contrazione della capacità di consumo e risparmio della popolazione,
aprendo, di fatto, la recessione di cui accennato prima.
Infine oggi, nel 2013, si può parlare anche di stagflazione e cioè la combinazione dei
termini stagnazione ed inflazione indicando la situazione nella quale sono
contemporaneamente presenti - su un determinato mercato - sia un aumento generale dei
prezzi (inflazione), sia una mancanza di crescita dell'economia in termini reali
(stagnazione economica):
Devono esserci altri motivi che spieghino come il debito non garantito sia diventato elemento
dominante dell’economia o perché i governi abbiano volutamente ignorato, se non addirittura
incoraggiato questa “età dell’incoscienza”. La reazione politica alla crisi ne offre qualche indizio: […]
i governi di tutto il mondo hanno dedicato ben 7000 miliardi di dollari di debito pubblico per
garantire beni a rischio, mettere al sicuro risparmi e ricapitalizzare banche in fallimento.17
Dal 2009 a oggi molti Stati europei, tra cui anche l’Italia, hanno dovuto varare numerosi
pacchetti anticrisi per fare fronte alla crescente disoccupazione e stimolare la crescita.
Secondo Jackson la dura realtà è che i politici non avevano scelta, dovevano intervenire
per proteggere il sistema bancario. Attraverso iniezioni di capitale per le banche e
maggiore sicurezza per chi presta denaro, i leader mondiali speravano di risanare la
liquidità, dare nuovo vigore alla domanda e porre fine alla recessione: “Il loro scopo
ultimo era proteggere il perseguimento della crescita economica”.18
Dopo aspre discussioni è stato varato il cosiddetto “Fondo Salva-Stati” in grado di
erogare aiuti economici ai Paesi con problemi di rifinanziamento del proprio debito; si è
accelerata la riforma della governance europea nell’ottica del rafforzamento del patto di
stabilità, nonché del coordinamento delle politiche di bilancio tra i vari membri
dell’Unione. Contemporaneamente la Banca Centrale Europea ha intensificato
l’acquisto sul mercato secondario di titoli governativi e ha lanciato un programma
d’iniezione di liquidità a sostegno della solvibilità del sistema bancario:
Far riprendere la crescita è stato il fine che ha giustificato interventi impensabili fino a pochi mesi
prima, e nessun politico l’ha messo seriamente in discussione. Eppure la fedeltà alla crescita ha
plasmato l’architettura dell’economia moderna, ha motivato la libertà concessa al settore finanziario,
17
T. JACKSON, Prosperità, cit., p. 65 18
Ibidem
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 15
è stato almeno in parte responsabile dell’allentamento delle regole e della proliferazione ingestibile
dei derivati finanziari.19
Tim Jackson si interroga su che cosa abbia portato la politica dei paesi occidentali a
riprendere senza spirito critico la via della crescita. È indubbio che la crisi che stiamo
conoscendo abbia sovvertito gran parte delle fondamenta su cui si era costruita la
società industrializzata capitalista.
Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, la crisi economico-finanziaria del 2007
differisce dalla Grande Depressione anche perché oggi nei paesi colpiti c’è un insieme
d’istituti in grado di proteggere, almeno parzialmente, i più vulnerabili dai rischi del
mercato, a livello sia del reddito (indennità di disoccupazione, reddito minimo per i
poveri) sia della possibilità di soddisfare bisogni essenziali al di fuori del mercato,
quindi della disponibilità di reddito.
Secondo la sociologa Chiara Saraceno, i sistemi di protezione sociale disponibili nei
confronti della disoccupazione insieme a quelli diretti ai poveri e all’esistenza di
protezione sanitaria universale hanno impedito, soprattutto in Europa, che milioni di
persone e famiglie precipitassero direttamente nella povertà e perdessero il diritto
all’assistenza sanitaria.20
Il protrarsi della crisi economica, ha offerto nuovi spunti al dibattito in corso già da
diversi anni sulla sostenibilità del welfare state in società le cui economie sono sempre
più esposte alla competizione internazionale e la cui demografia è fortemente
modificata dal doppio fenomeno dell’invecchiamento della popolazione e dei processi
migratori.
La risposta alla crisi economica sicuramente non è stata favorevole alla ristrutturazione
dello stato sociale europeo, ma anzi i popoli sono costretti a pagare il conto con le
pensioni, la riduzione del numero dei dipendenti pubblici o il taglio dei servizi. Scrive a
proposito Susan George, presidente di ATTAC21
Francia:
19
Ivi, p. 67 20
C. SARACENO, Il Welfare: modelli e dilemmi della cittadinanza sociale. Il Mulino,
Bologna 2013, pp. 9-10 21
Associazione per la Tassazione delle Transizioni finanziarie e per l'Aiuto ai Cittadini
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 16
“Siamo dunque anche in piena crisi morale, una situazione in cui vengono ricompensati i
colpevoli e puntiti gli innocenti: basti pensare che in Occidente abbiamo speso 16 000
miliardi di dollari in favore di banche americane e straniere”. 22
Nel prossimo capitolo si analizzeranno le scelte politiche adottate per far fronte a questa
delicatissima situazione, confrontandole con le idee alla base dello Stato sociale.
22
S. GEORGE in Dove Va il Mondo, Bollati Boringhieri, Torino, 2013 p. 67
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 17
CAPITOLO II: IL MALESSERE DELLO STATO
Un essere che non abbia ancora preso coscienza del
proprio io non può essere in grado di sviluppare né un
pensiero astratto né un linguaggio, né una coscienza o
una morale responsabile. Un essere che non riflette più
corre il rischio di perdere tutte queste qualità
specificatamente umane.23
K. Lorentz
Dopo aver chiarito il malessere che sta attraversando l’economia occidentale, ritengo
utile passare a quelli che possono facilmente essere definiti i malesseri dello Stato e
della politica intesa qui come amministrazione della polis.
Ho, infatti, individuato nella crescita economica e nelle pratiche di consumo odierne
assunte dagli Stati occidentali, come fine per ottenere il benessere, e nella crisi della
rappresentatività politica i possibili campanelli d’allarme per una più generale crisi della
collettività.
Questi due aspetti stanno minando come vedremo le basi del welfare state, ovverossia
l’espressione più articolata e la concreta attuazione di un benessere comunitario.
23
K. LORENZ, Gli otto peccati capitali della nostra civiltà, Adelphi, Milano, 1974
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 18
1. APOLOGIA DELLA CRESCITA ECONOMICA
Come abbiamo visto nel precedente capitolo, gli anni Settanta del Novecento
rappresentano l’origine delle scelte che hanno portato alla delicata situazione del
mondo contemporaneo. Per capire meglio l’essenza della crescita economica e i motivi
per cui hanno spinto i paesi occidentali ad intraprendere questa via, il sociologo Mauro
Magatti scrive che “già verso la fine degli anni Sessanta si cominciò a parlare di
saturazione dei mercati […] Una volta soddisfatti i bisogni materiali di larga parte dei
cittadini, raggiunto il culmine della spinta demografica e ridottasi la capacità di
influenza e sfruttamento dei paesi terzi, che cosa è la crescita economica?”.24
È quindi già a partire dall’inizio degli anni Settanta che le politiche degli Stati
occidentali si indirizzarono verso la ricerca di nuove strategie capaci di aumentare la
produttività e i consumi di beni materiali.
Come scriveva Karl Polanyi nel suo libro La Grande Trasformazione del 1944, la
formazione di un’economia di mercato non è un evento spontaneo ma è il risultato di
una precisa volontà politica, attivamente tesa a creare le condizioni istituzionali coerenti
con un determinato progetto. Ciò che accadde negli anni Ottanta del ventesimo secolo è
molto simile a quello che si è verificato nell’Inghilterra dei primi decenni
dell’Ottocento.
Se fino agli anni Settanta la cornice keynesiana, costruita alla fine della seconda guerra
mondiale, aveva contrastato la speculazione di breve termine per favorire gli
investimenti di medio-lungo termine fornendo un modello basato su regole
internazionali, limiti sulla mobilità di capitali e rapporti stabili tra le monete, negli anni
Ottanta tale struttura apparve obsoleta. Soprattutto gli Stati Uniti e l’Inghilterra, guidati
rispettivamente d Ronald Reagan e da Margaret Thatcher, sostenitori delle teorie
dell’economista austriaco Von Hayek, furono i maggiori interpreti della liberalizzazione
del mercato utile a trovare risposte a quella situazione di stallo di cui scrive Magatti.
Dal 1980 in poi la teoria keynesiana è stata sepolta dalla cosiddetta deregulation, vale a
dire una serie di deregolamentazioni dei sistemi finanziari tra cui l’abolizione delle
norme sul commercio di derivati non regolamentati e la soppressione del Glass-Steagall
Act che prevedeva la separazione tra banche commerciali e banche di investimento.
24
M. MAGATTI, La Grande Contrazione, Feltrinelli Editore, Milano, 2012, p. 42
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 19
Tali provvedimenti furono presi dall’amministrazione statunitense per facilitare la
creazione di un mercato globale in grado di assorbire la crescita degli anni Ottanta e
Novanta. Questo obiettivo fu facilitato in modo del tutto inaspettato dalla caduta del
muro di Berlino e dalla fine del socialismo reale, che eliminò ogni concreta alternativa
al capitalismo neoliberista.25
Le nuove condizioni legislative nazionali e internazionali, costruite appositamente per il
mercato globale, non solo hanno permesso l’esplosione di opportunità prima
sconosciute, ma hanno soprattutto reso possibile lo sradicamento dell’economia dai
vincoli keynesiani sociali e istituzionali che la limitavano.
Infatti, di fronte ai contesti irrigiditi, a mercati saturi, a culture in ebollizione presenti
negli anni Settanta, la liberalizzazione del mercato fu l’opzione più attraente per i
governi nazionali in termini economici e politici, aprendo inoltre nuove possibilità di
rilancio per il ruolo politico dei Paesi anglosassoni. Magatti ci fornisce una definizione
di questi fini politico-economici:
Il neoliberismo ha agito su due piani: ha predicato il mercato come luogo della scelta, in
contrapposizione allo Stato, presentato come il regno oppressivo della spesa pubblica della
corruzione e della burocrazia. “La società non esiste”, frase coniata dal primo ministro
inglese Margaret Thatcher esemplifica il concetto sopraesposto.26
In tal modo l’economia mondiale ha avuto a disposizione risorse finanziarie crescenti e
tendenzialmente infinite; la finanziarizzazione dell’economia, che si traduce nella rapida
diffusione dell’uso delle carte di credito e di debito, ha permesso una crescita dei
consumi superiore a quella altrimenti impossibile. Dal momento che la leva finanziaria
è un vincolo fondamentale per la crescita economica, ciò significa che nulla di quanto è
accaduto con la globalizzazione avrebbe potuto avere luogo senza tale disponibilità di
capitali finanziari.
Nel 1992 il politologo Francis Fukuyama scrisse nel suo saggio The end of history and
the last man che la fine della storia era prossima dato che ora si poteva parlare della
nascita di una nuova società globale di mercato. Nel settembre 2001 la Repubblica
Popolare Cinese entra a far parte del World Trade Organisation, ex General Agreement
on Tariffs and Trade (Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio, meglio
25
Cfr. P. KRUGMAN, Il ritorno, cit., p. 8 26
M. MAGATTI, La Grande Contrazione, cit., p. 29
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 20
conosciuto come GATT), dopo ben quindici anni di trattative, aprendo di fatto la nuova
stagione politico-economica internazionale di mercato che conosciamo oggi.
In questa situazione di crescita dei capitali finanziari, di speculazione a breve termine e
di politiche economiche volte all’incremento quasi esponenziale dei consumi, si sono
realizzate contemporaneamente due profezie che come vedremo nel capitolo successivo
mettono in crisi le basi dello stato sociale. La prima è rappresentata dal “feticcio della
liquidità”27
teorizzata dallo stesso Keynes secondo cui, potendo ottenere profitti
consistenti nel breve termine, l’orizzonte temporale dell’attività economica si accorcia
progressivamente e pericolosamente lasciando dominare lo shortermismo. La seconda
invece di Georg Simmel, uno dei più importanti sociologi del XX secolo, il quale
prevedeva che, all’interno di un quadro di istituzioni transnazionali, il denaro avesse la
capacità di essere “mezzo universale” per perseguire qualsivoglia scopo in qualunque
parte del mondo.
L’eliminazione delle regole previste dal sistema keynesiano, che vedevano lo Stato
come unico soggetto di regolazione politica ed economica, non hanno però condotto ai
risultati di benessere e di prosperità tanto auspicati dai neoliberali, bensì hanno portato
all’esplosione della tragica crisi del 2007-2013.
La crisi economica che stiamo vivendo rappresenta il rallentamento economico e lo
scacco all’idea di espansione continua, fattore chiave per un modello sociale che fa
dipendere la conservazione dei suoi equilibri tanto dinamica, quanto instabili, dalla
crescita; da questo punto di vista siamo di fronte a una crisi strutturale che segna la fine
del modello politico ed economico che ha preso corpo negli anni Ottanta e che ha
trionfato negli anni Novanta.
Tim Jackson esplicita in modo critico questa idea di modello di benessere adottato dagli
Stati occidentali:
La formula tradizionale per raggiungere la prosperità e benessere si è basata sul
perseguimento della crescita economica, partendo dall'assunto che maggiori redditi portano
a un maggiore benessere e quindi alla prosperità di tutti. Si mette oramai in dubbio che la
crescita economica sia ancora un obiettivo legittimo per i paesi ricchi, considerate le enormi
disparità di reddito e benessere che continuano a persistere nel mondo e considerato che
27
J.M. KEYNES, Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta,
Utet, Torino, 1978, p. 315
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 21
l'economia globale deve fare i conti con i limiti imposti dalle risorse naturali e le capacità di
sopportazione dei sistemi naturali.28
La crisi economica del 2008 ha ridefinito i confini tra Stato e mercato, costringendoci
ad ammettere la nostra incapacità di gestire la sostenibilità finanziaria, per non parlare
di quella sociale e ambientale, dell'economia globale. La fiducia dei consumatori è
crollata, gli investimenti si sono bloccati e la disoccupazione sta registrando una forte
impennata.
Figura 2: Tasso di disoccupazione in Europa 2000-201029
28
T. JACKSON, Prosperità senza crescita - Economia per il pianeta reale, Edizioni
Ambiente, Milano, 2011, p. 26 29
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31082010-BP/EN/3-31082010-BP-
EN.PDF
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 22
Figura 3: Tasso percentuale di disoccupazione negli stati Uniti d’America 2003-201330
Figura 4: Real GDP growth rate - volume - Percentage change on previous year -
Eurostat31
30
Bureau of Labor Statistics, United States department of Labor,
http://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000 31
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tec00115
&language=en&toolbox=data
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 23
Le nostre tecnologie, la nostra economia e le nostre aspirazioni sociali sono tutte male
allineate rispetto a qualsiasi manifestazione significativa di prosperità. Siamo guidati da
una visione di progresso sociale basata sull'espansione continua delle esigenze materiali.
Senza un modo realistico per trasformare le speranze di una società migliore per i nostri
figli, la prosperità rimane un'illusione e perdere la speranza significa spegnere il senso
di collettività.
Oggi nel perseguire il buon vivere stiamo sistematicamente erodendo le basi del
benessere di domani: stiamo davvero correndo il rischio di perdere ogni possibilità di
realizzare una prosperità condivisa e duratura.
2. L’EVOLUZIONE DEL CONSUMO E LE SUE
CONSEGUENZE SUL PIANO SOCIALE
Un altro aspetto importante legato alla crescita economica è il conseguente aumento del
consumo.
Il consumo rappresenta una delle caratteristiche della società contemporanea; molti
studiosi, infatti, hanno definito il Novecento come il “secolo dei consumi”.32
Subito
dopo la seconda Rivoluzione industriale, le nuove condizioni di vita delle popolazioni
che subirono queste trasformazioni produttive, economiche e sociali, causarono un
ampliamento delle possibilità di consumo, dilatando la piramide dei bisogni di Maslow,
e procedendo dunque all’acquisto non solo di beni di prima necessità ma anche di
prodotti secondari e superflui.
È negli anni Sessanta che l'economia degli Stati Uniti e delle nazioni dell'Europa
occidentale, Italia inclusa, attraversarono un periodo di espansione. In quel periodo nel
nostro Paese si è verificato il cosiddetto “miracolo economico”, possibile grazie al
raggiungimento, nel settore industriale e terziario, di un livello di sviluppo tecnologico e
una diversificazione produttiva tali da consentire loro di reggere l'ingresso dell'Italia nel
mercato internazionale. Inoltre questo positivo sviluppo economico-sociale fu possibile
per il basso costo del lavoro dovuto agli alti livelli di disoccupazione degli anni
Cinquanta che fecero in modo che la domanda di lavoro eccedesse abbondantemente
l'offerta, con le prevedibili conseguenze in termini di andamento dei salari.33
Le
disuguaglianze sociali diminuirono grazie allo sviluppo del welfare state.
32
Cfr. S. CAVAZZA, F. SCARPELLINI, Il secolo dei consumi, Carocci Editore,
Roma, 2006 33
Cfr. P. VIOLA, Il Novecento, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2000, pp. 358-359
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 24
Secondo il sociologo Vanni Codeluppi si è dunque progressivamente passati dalla
società della produzione alla società del consumo, individuando l’obiettivo odierno
nell’educazione al consumo e nella produzione di consumatori. Ciò è particolarmente
efficace perché non soltanto i media, l’economia e la politica l’hanno assunta come
modus operandi, ma anche perché tutte le istituzioni sociali sono sempre più interessate
a una logica di tipo consumistico. A tal proposito Codeluppi afferma nel suo Il potere
del consumo: “Prosegue, infatti, quel processo tipico delle società capitalistiche che il
filosofo Karl Marx aveva già individuato come "mercificazione" della società e
"feticismo del prodotto".34
Il consumatore è attratto dal gioco di costruzione della sua identità attraverso le merci,
dalla libertà apparentemente infinita di scegliere i prodotti che gli sono offerti, con il
risultato che l'attività di scelta diventa più importante di ciò che si è scelto e il piacere
insito nello shopping è maggiore di quello che può procurare la merce una volta
acquistata. Il consumo sembra funzionale all’attribuzione di senso alle cose che ci
circondano in un mondo dominato da una confusione crescente. Al consumatore si cerca
quindi di far credere che sta vivendo in un mondo ideale dove le condizioni di vita
migliorano continuamente e dove tutti i suoi desideri possono essere appagati.
Secondo il sociologo polacco Bauman “lo scopo del gioco del consumo, non è tanto la
voglia di acquisire e possedere né di accumulare ricchezze in senso materiale, tangibile,
quanto l'eccitazione per sensazioni nuove, mai sperimentate prima”.35
Il consumo è diventato il presupposto di cittadinanza e l’essere consumatore diviene
l'identità principale presa in considerazione dalle politiche di rigenerazione urbana.36
Considerare l'evoluzione della città come luogo da visitare, spettacolarizzato e in
continua concorrenza l'una con l'altra, significa che la popolazione urbana prima che da
cittadini è formata da consumatori. Il loro accesso alle risorse della città si realizza non
in quanto portatori di doveri e diritti a prescindere dalle loro capacità economiche, ma in
quanto portatori di specifiche domande di consumo da soddisfare. Ciò ha comportato
l'esclusione di molte persone e un grave problema di coesione sociale. L’indebitamento
che oggi conosciamo nei Paesi industrializzati è il risultato della continua espansione
34
V. CODELUPPI, Il potere del consumo, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, p. 8 35
Z. BAUMAN, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Laterza,
Roma, 2001, p. 93 36
A. MAZZETTE, E. SGROI, La metropoli consumata, Franco Angeli, Milano, 2007,
pp. 122-123
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 25
della domanda di beni, e il loro conseguente consumo. Tale situazione è stata possibile
per mezzo della pubblicità, evolutasi sempre di più nelle pratiche di marketing e
diffusasi in tutti i luoghi della vita quotidiana, e attraverso la diffusione di strumenti di
credito al consumo, come la carta di credito.
Soprattutto in Italia la costruzione di senso e d’identità dei cittadini, ora diventati
consumatori, attraverso l’accumulazione di beni materiali ha prodotto già a partire dagli
anni Settanta l’indebolirsi progressivo dei protagonisti istituzionali nazionali “lasciando
spazi sempre più larghi all’azione dei nuovi attori economici, da cui è germogliata la
crisi degli anni Ottanta e Novanta: divario tra Nord- Sud, situazioni settoriali, regionali,
e sociali di arretratezza e ritardo economico”.37
In altre parole, come vedremo nel prossimo paragrafo dedicato alla crisi della politica,
in Italia è mancato insieme all’evoluzione materiale, sociale, economica della società un
eguale sviluppo etico, civico e sostenibile per le generazioni future.
Il Censis già nel 1974 parlava di “crisi progressiva delle istituzioni, sempre meno capaci
di corrispondere alle proprie funzioni e alle esigenze della collettività”.38
Indubbiamente la crescita economica e l’aumento dei consumi hanno migliorato le
condizioni di vita delle popolazioni dei Paesi industrializzati, incrementando lo sviluppo
della classe media: tuttavia questo sviluppo ha spostato progressivamente il suo fulcro
sulla quantità piuttosto che sulla qualità. Se il desiderio di beni materiali era alimentato,
in un primo momento, dallo sviluppo di un sistema di valori all’interno del quale il
consumo poteva essere visto come portatore di benessere e dell’utile collettivo, ora
invece l’estremizzazione dell’economia e della crescita hanno corrotto l’individuo a tal
punto che:
all’homo oeconomicus della prima modernità, prudente e lungimirante, capace di coniugare
interesse individuale e il bene comune, subentra l’homo psichologicus alla ricerca di
autenticità che lo spinge a psicologizzare la realtà, riducendola a puro specchio dei propri
desideri, nonché a estraniarsi dalla sfera pubblica e sociale.39
In conclusione, la progressiva crescita economica e il conseguente sviluppo del
consumismo sono uno dei protagonisti del Novecento, per il numero di attori coinvolti,
37
G. CRAINZ, Il Paese reale, Donzelli Editore, Roma, 2013 pag. 6 38
Ivi, pag. 8 39
E. PULCINI, L’individuo senza passioni, Bollati Boringhieri, Torino, 2001, p.161
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 26
materiali distribuiti, spostamento di capitali finanziari e per la sua dimensione globale.
Indubbiamente senza questo protagonista lo stato sociale, che ha avuto modo di
svilupparsi dagli anni Cinquanta fino ai Novanta, non sarebbe stato possibile. Questo
perché entrambi questi fattori hanno fatto in modo che gli Stati disponessero di una
quantità mai vista prima di utili.
Tuttavia, come abbiamo visto nel precedente paragrafo, l’estremizzazione della
finanziarizzazione ha condotto ad una crisi economica i cui effetti si stanno ancora
avvertendo. Unire questo fattore all’alienazione del cittadino-consumatore proposta
dalla sociologa Elena Pulcini, produce una sorta di collettivismo riluttante40
, per usare le
parole dell’economista Fred Hirsch, i cui risultati sono facilmente percepibili anche
nella crisi della rappresentatività e del rapido aumento dell’astensionismo in politica.
3. CRISI DELLA RAPPRESENTATIVITÀ E DEL SENSO DI
COMUNITÀ
Partiamo dal presupposto che la pratica di cittadinanza si esprime attraverso il voto. È
risaputo, infatti, che recarsi alle urne oltre ad essere l’esercizio di democrazia più
concreto è anche un dovere civico prescritto dalla Costituzione della Repubblica
Italiana.41
Trovare un indicatore adatto ad esprimere la cittadinanza attiva è piuttosto difficile.
Tuttavia ho deciso di utilizzare i dati forniti dall’Istat e dalla fondazione Cattaneo circa
l’astensionismo elettorale che caratterizza il nostro Paese.
L’apatia politica che serpeggia tra i cittadini, non solo italiani ma anche europei e dei
paesi industrializzati è aumentata notevolmente e le ragioni non sono del tutto scontate.
Basti pensare come la politica si sia adattata nel corso degli ultimi tempi alle più inedite
strategie di marketing per accaparrarsi voti e il sostegno di cittadini sempre più confusi
e in balia dei malesseri del mercato. La dimensione del consumo si è appropriata anche
della sfera politica: a partire dalla campagna elettorale di Ronald Reagan nel 1980 il
marketing della comunicazione usato per i prodotti di consumo è stato pienamente
applicato nei discorsi elettorali. Il sociologo Vanni Codeluppi ci propone una attenta
analisi circa l’esperienza italiana:
40
Cfr. F. HIRSCH, I limiti sociali allo sviluppo, Bompiani, Milano, 2001 41
Art. 48 della Costituzione della Repubblica Italiana: “Sono elettori tutti i cittadini,
uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale,
libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. […]”
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 27
Gli spot elettorali costituiscono uno strumento comparso a partire dal 1993. Silvio
Berlusconi, un imprenditore che in precedenza operava al di fuori del campo politico ha
saputo ottenere, con la sua campagna elettorale, un chiaro successo ed è stato nominato
presidente del consiglio dei ministri. Ma a farlo vincere non è stato soltanto il pur eccellente
lavoro che ha condotto sul piano comunicativo nei pochi mesi precedenti le elezioni, come
normalmente si ritiene, bensì soprattutto l’intensa azione che ha sviluppato durante gli anni
precedenti, nel corso dei quali ha saputo dare una risposta alla storica fame di benessere
degli italiani.42
Collegandomi a quello che sostiene Vanni Codeluppi, è risaputo che l’Italia non avendo
avuto nell’Ottocento una vera rivoluzione industriale di conseguenza non ha conosciuto
lo sviluppo di una classe e di una cultura borghesi. Ciò avrebbe permesso il verificarsi
di una progressiva acculturazione della popolazione, come in tutte le società più
avanzate, evitando di abbracciare in modo acritico il modello consumistico. Subito dopo
la seconda guerra mondiale, infatti, il popolo italiano ha potuto finalmente entrare in
contatto con il mondo dei consumi attraverso un adesione totale incondizionata e priva
di qualsiasi filtro culturale. Ecco cosa scrisse nel 1994 il giornalista Eugenio Scalfari:
La grande mutazione genetica si colloca alla fine degli anni Sessanta e coincide con la
prima vera fase di benessere che il nostro paese abbia mai vissuto. Ci sarebbe voluta una
classe dirigente moralmente e professionalmente capace di utilizzare quella ricchezza per
costruire una società giusta, civile e agiata. Abbiamo invece assistito e partecipato ad una
grande abbuffata nel corso della quale tutti i valori sono andati dispersi, tutte le regole
calpestate, tutti i rapporti imbarbariti.43
Anche lo scrittore Pierpaolo Pasolini attraverso un acuto spirito d’osservazione critico si
fece interprete dell’anomala transizione italiana:
Io continuo a sperimentare un'Italia che [...] non è cambiata. La miseria, l'indigenza, lo stato
di ingiustizia, l'ansia, la corruzione, non sono affatto diminuiti: anzi, sono aumentati.
42
V. CODELUPPI, Il potere del consumo, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, p. 55 43
E. SCALFARI, Comincia il gioco dei quattro cantoni, in “la Repubblica”, 16
gennaio 1994
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 28
Parlare di benessere (di quel relativo benessere che consiste poi nel non morire di fame, nel
possedere un minimo di dignità economica) è un insulto.44
Tornando all’analisi della mancata partecipazione civica, è importante considerare
anche la rivoluzione che dagli anni Ottanta sta investendo il concetto stesso di partito
politico. Come sostiene lo storico Marco Revelli, l’indifferenza alla politica è dovuta a
un cambiamento di paradigma fiduciario tra elettori e partiti politici che si è generato
già dagli anni Sessanta negli Stati Uniti:
il primo riconoscimento della crisi di fiducia nelle istituzioni politiche americane coincide
con un discorso del presidente Jimmy Carter che nel 1979 in un drammatico appello
televisivo al popolo americano asserì l’esistenza di una crisi ben più importante di quella
energetica o dell’inflazione e cioè la crescente disistima delle istituzioni di governo.45
Nel suo ultimo libro, Finale di Partito, Revelli sostiene che è in atto una mutazione del
tradizionale partito politico apparentemente incapace di rispondere tempestivamente alle
necessità dei cittadini. Sulle ragioni della continua diminuzione di fiducia nelle
istituzioni e soprattutto nelle tradizionali organizzazioni politiche, dopo quasi un secolo
di indiscussa fortuna della forma-partito, si sono misurati molti studiosi, individuando le
cause in una serie di mutazioni: tecnologiche (nel campo delle comunicazione e del
sistema dei media), cognitive e formative (la diffusione di elevati livelli di
scolarizzazione e dunque di autonomia dei cittadini), cambi di paradigma economici (il
ruolo del benessere crescente e poi dell’ingresso nella società dell’incertezza) e a quelli
di tipo geopolitico connesse alla rivoluzione spaziale denominata globalizzazione.
Infine un’altra ipotesi può essere anche dovuta alla trasformazione dell’organizzazione
del partito, passato da un’impostazione di tipo fordista e quindi gerarchicamente
verticale ad una post-fordista e cioè aperta, policentrica e quindi orizzontale.46
Anche Fabrizio Barca, economista ed ex ministro per la coesione territoriale del
governo Monti (2011-2013) ha espresso nel suo documento, Memoria politica dopo 16
mesi di governo, il malessere della forma-partito tradizionale:
44
Cit. in G. SAPELLI, Modernizzazione senza sviluppo: il capitalismo secondo
Pasolini, Bruno Mondadori, Milano, 2005, pag.18 45
M. REVELLI, Finale di partito, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2013, p.29 46
Ivi p. 32
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 29
Ovunque si pone il problema di una nuova forma partito. In Italia questo obiettivo ha
rilievo e urgenza straordinari di fronte alla sfiducia radicale e al risentimento che circonda i
partiti, alla persistente incapacità di buon governo, alla crisi culturale, prima ancora che
economica e sociale, che il paese attraversa. […] Viviamo un momento di grave crisi,
internazionale, europea e ancor più italiana. Che richiede un forte presidio di governo. Non
ci sono dubbi. Tuttavia, questo presidio avrà effetto solo se contemporaneamente sarà
avviato il ridisegno dei partiti. Senza esitazioni o l’alibi che altre sono le urgenze. Si deve
cambiare, perché la crisi è figlia anche della crisi dei partiti. 47
Passando invece ai dati che ben rappresentano la situazione odierna, l’istituto Cattaneo
ci ha fornito i dati che illustro qui sotto. Per la prima volta nella storia repubblicana
italiana, nelle ultime elezioni politiche del 2013, meno di 8 elettori su 10 48
si sono
recati alle urne.
Questo trend negativo, come spiega il rapporto, è in aumento dagli anni Settanta; come
vediamo dal grafico il dato ottenuto nelle ultime elezioni è il più alto poiché quasi il
20% degli aventi diritto di voto non lo hanno esercitato.
Figura 5: Grafico percentuale di votanti in Italia per le elezioni politiche della camera
dei deputati, periodo 1948-2008 49
47
F. BARCA, Memoria politica dopo 16 mesi di governo,
http://www.fabriziobarca.it/un-partito-nuovo-per-un-buon-governo-fabrizio-barca/ 48
Dati della Fondazione di Ricerca Carlo Cattaneo http://www.cattaneo.org/it/ 49
Elaborazione personale basata su dati pubblicati dal Ministero dell’Interno
http://elezionistorico.interno.it/
80,0%
82,0%
84,0%
86,0%
88,0%
90,0%
92,0%
94,0%
96,0%
1940 1960 1980 2000 2020
Votanti
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 30
Figura 6: Grafico percentuale di votanti in Italia per le elezioni politiche del Senato
della Repubblica, periodo 1948-2008 50
I dati sull’astensionismo italiano possono essere facilmente comparati con i dati delle
ultime rispettive elezioni nei Paesi europei:
Si può notare che nonostante l’alto tasso italiano, ci sono paesi come Gran Bretagna,
Grecia e Portogallo che possiedono un astensionismo di gran lunga maggiore.
Tabella 1: Percentuali della popolazione votante alle ultime elezioni politiche nei
principali Stati europei.51
Stato % votanti (ultima elezione)
Belgio (2010) 89,2%
Danimarca (2011) 87,7%
Svezia (2010) 84,6%
Austria (2008) 81,7%
Francia (2012) 80,3%
Italia (2013) 75,1%
Olanda (2012) 74,6%
Germania (2009) 70,8%
Irlanda (2011) 70,0%
Spagna (2011) 68,9%
Finlandia (2011) 67,3%
Gran Bretagna (2010) 65,8%
Grecia (2012) 62,5%
Portogallo (2011) 58,0%
50
Ivi 51
Dati della Fondazione di Ricerca Carlo Cattaneo http://www.cattaneo.org/it/
78,0%
80,0%
82,0%
84,0%
86,0%
88,0%
90,0%
92,0%
94,0%
96,0%
1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
Votanti
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 31
Figura 7: Grafico con le percentuali dei votanti nei rispettivi paesi europei nelle ultime
elezioni politiche effettuate.52
Questi dati dimostrano come una parte, piuttosto grande negli ultimi anni, abbia deciso
di non prendere parte alle decisioni politiche del proprio Paese.
Non prendere parte a questo tipo di confronto può significare da una parte la delusione
dei cittadini nei confronti di una politica svuotata dai suoi principi democratici e di
benessere collettivo. Dall’altra, questa insoddisfazione prodotta dalla politica, aiutata
dall’illusoria ricerca del benessere attraverso le estremizzate pratiche di consumo, ha
inevitabilmente rotto i legami tra le persone, ora non più inclini alla socialità. Una delle
prerogative dello stato sociale, che vedremo nel prossimo e ultimo capitolo, è anche
l’esistenza di una comunità. Questo presupposto aiuta, infatti, lo Stato a svilupparsi e a
rispondere in modo più completo e articolato alle necessità dei suoi cittadini.
52
Ivi
0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0%
Be
lgio
(2
01
0)
Dan
imar
ca (
20
11
)
Svez
ia (
20
10
)
Au
stri
a (2
00
8)
Fran
cia
(20
12
)
Ital
ia (
20
13
)
Ola
nd
a (2
01
2)
Ger
man
ia (
20
09
)
Irla
nd
a (2
01
1)
Spag
na
(20
11
)
Fin
lan
dia
(2
01
1)
Gra
n B
reta
gna
(20
10
)
Gre
cia
(20
12
)
Po
rto
gallo
(2
01
1)
% votanti (ultima elezione)
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 32
CAPITOLO III: L’ASCESA E DECLINO DELLO STATO SOCIALE
Ogni uomo è libero di potersi appropriare
di beni che la natura gli offre a patto che ne
lasci in quantità sufficiente a tutti gli altri
per il loro sostentamento, sia impegnato
direttamente nella sua proprietà o
nell’attività che ha scelto di svolgere e non
sprechi le risorse che la natura gli offre e di
cui si è appropriato.53
Dopo aver passato in rassegna i malesseri del mercato, attraverso l’ultima crisi
economica del 2008-2013 e dopo aver chiarito le contraddizioni delle politiche
realizzate dai Paesi occidentali, rappresentate dalla crescita economica e dal
consumismo, questo capitolo si occuperà invece di illustrare la nascita e lo sviluppo del
welfare state.
1. DEFINIZIONE DI WELFARE STATE
In tutte le società sono presenti, oggi come in passato, forme di sostegno caritatevole da
parte di istituzioni religiose o di beneficienza. Anche l’intervento delle Stato ha origini
lontane in alcuni Paesi come, ad esempio, l’Inghilterra, che nel XVI secolo introdusse le
prime Poor Laws, per regolamentare l’assistenza alle persone bisognose. Tuttavia per
parlare di Stato sociale bisogna aspettare il XX secolo, quando gli Stati-nazione si
assunsero in modo più o meno sistematico la responsabilità di soddisfare i bisogni
fondamentali dei suoi cittadini e non solo per alcune categorie, redistribuendo le risorse
e distinguendosi dalla solidarietà mutualistica e caritatevole.
Lo "Stato del benessere" o anche "Stato Sociale" fu concepito nella seconda metà
dell’Ottocento da Adolph Wagner che espresse la necessità di un maggiore
interventismo statale per ovviare alle diseguaglianze create dal mercato e dal censo.
53
J. LOCKE, Due trattati sul governo 1690, cit. in P. GILA, Capitalesimo, Bollati
Boringhieri, Torino, 2013, p.1
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 33
Il primo ad utilizzare il termine welfare policy invece fu l'inglese John A. Hobson,
attribuendogli il significato di un intervento diretto dello Stato per il miglioramento
della qualità della vita soprattutto nei confronti dei lavoratori e dei poveri.
Lo storico inglese Asa Briggs sostiene che il welfare state sia nato al fine di modificare
le forze di mercato almeno in tre direzioni:
1. garantire agli individui e alle famiglie un reddito minimo indipendentemente dal
valore di mercato del loro lavoro o delle loro proprietà;
2. ridurre l’ampiezza dell’insicurezza, mettendo individui e famiglie nelle condizioni
di affrontare taluni rischi (disoccupazione, malattia, vecchiaia) che altrimenti
produrrebbero crisi individuali e familiari;
3. garantire che a tutti i cittadini, senza distinzione di status o classe, vengano offerti
servizi della migliore qualità disponibili in settori consensualmente definiti.
E’ possibile distinguere tuttavia una duplice concezione di welfare state: una
concezione allargata che definisce una società in cui lo Stato interviene nei meccanismi
di riproduzione economica e di redistribuzione per riallocare le opportunità di vita tra
gli individui e le classi sociali, dando luogo a politiche sociali indirizzate da una
particolare forma di Stato, governo e società stessa. Oppure una concezione ristretta di
welfare, corrispondente ad uno specifico insieme di politiche sociali determinate. In
questo capitolo passerò in rassegna gli sviluppi dello Stato sociale, puntando
l’attenzione sul Novecento, secolo in cui si conobbe contemporaneamente l’ascesa di
questo particolare sistema economico e sociale, ma anche il suo progressivo declino.
2. PRIME ESPERIENZE DI L OTTA AL PAUPERISMO
2.1. LE PRIME LO TTE
Nel Medioevo la figura del sovrano era legata al perseguimento di molti fini tra cui la
pace, il bene comune e la giustizia. La povertà, come dettava la morale cristiana,
rappresentava per certi versi una vera e propria virtù e Francesco d’Assisi fu uno dei
migliori interpreti di questa filosofia di vita: la povertà avvicinava colui che la praticava
al Vangelo perché offriva la possibilità di redimersi ai ricchi che si prestavano per opere
di carità. Si occupavano dei poveri le confraternite religiose e poco a poco crebbero
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 34
anche quelle laiche, vi erano gli ospedali e le casate nobiliari che operavano con finalità
filantropiche.
Durante il Rinascimento per via della crescita demografica, dovuta ai miglioramenti
sociali ed economici, ci fu un incremento esponenziale del numero di vagabondi e di
mendicanti e ciò modificò l'atteggiamento nei loro confronti. L'avvento del capitalismo
mercantile e l'etica del lavoro mutarono l'idea dell'assistenza ai poveri: è da qui infatti
che si cominciò a distinguere tra mendicanti meritevoli o poveri vergognosi.54
L'esercizio o meno di un lavoro divenne presto un criterio sostanziale di distinzione tra
chi era in grado di procacciarsi autonomamente i mezzi necessari al proprio
sostentamento e chi andava tecnicamente considerato come un povero. Gli istituti di
lavoro destinati ai poveri abili, chiamati workhouses, in soli sette anni triplicarono il
loro numero sul territorio inglese e istituti simili crebbero in Francia, Prussia, Austria e
anche nel capoluogo lombardo.
Le misure di regolamentazione del lavoro in rapporto alla povertà avvennero a partire
dal 1536 ad opera di Enrico VIII, ma fu con la regina Elisabetta I che l’Inghilterra si
dotò di alcune leggi per il controllo organico del fenomeno del pauperismo. Fu così che
nel 1601 l’intero impianto legislativo, opportunamente organizzato, confluì nella Poor
Law, destinata a rappresentare il punto di riferimento per molte delle successive
legislazioni sui poveri di altri Paesi europei.
Tutti questi provvedimenti tuttavia continuarono a essere erogati attraverso carità
private, istituzioni religiose, attività filantropiche; il concetto della tassazione statale per
la presa in carico della collettività rimase raro e poco frequente.
2.2. L ’ILL UMINISM O , L ’E TÀ DELLE RIV OLUZION I E LA SPEENHAMLA ND LA W
Nonostante la povertà fosse ancora concepita come una questione essenzialmente di
ordine pubblico, le trasformazioni sociali prodotte dallo sviluppo del capitalismo
mercantile e manifatturiero contribuirono a far emergere l’esigenza di modalità
d’intervento più organiche anche grazie alla necessità di un mercato del lavoro a basso
costo per le nuove attività produttive.
In pochi decenni si conobbero importanti rivoluzioni sociali, economiche, tecnologiche
e politiche: ad esempio nel 1789 attraverso la rivoluzione francese viene emanata la
Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino a tutela del principio di eguaglianza
54
Pubblicato nel 1525 da JEAN LUIS DE VIVES, il De subventione Pauperis, fu uno
dei primi trattati ad occuparsi di politiche assistenziali ai poveri.
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 35
e di democrazia; nello stesso anno entra in vigore la Carta costituzionale degli Stati
Uniti d’America che assicura il diritto alla vita, alla libertà e al raggiungimento della
felicità. Nel 1793 attraverso la Carta costituzionale giacobina la libertà si ottiene anche
attraverso il lavoro e l’indipendenza economica o per coloro che non erano in grado di
lavorare attraverso l’assistenza.
Nel 1792 fu emanata la Speenhamland Law (o sistema dei sussidi) grazie alla quale i
fondi della Poor Tax (contenuta nella Poor Law) dovevano essere determinati attraverso
una scala collegata all’andamento del prezzo del pane, in modo da garantire un reddito
minimo indipendente dai guadagni. Le conseguenze di questo provvedimento furono
ambivalenti. Da un lato questa legge, voluta per arginare l’eco dei moti rivoluzionari
francesi, rappresentò inizialmente uno strumento di contenimento dei salari e venne
incontro ai proprietari terrieri e ai primi industriali bisognosi di forza lavoro a basso
costo. Fu altresì un rinnovamento positivo per le persone in difficoltà, ma col procedere
degli anni tale legge fece sprofondare la produttività del lavoro fornendo ai padroni
un'altra ragione per non aumentare i salari al di sopra della scala. La Speenhamland
Law era destinata a prevenire la proletarizzazione della gente comune o almeno a
rallentarla. Il risultato fu semplicemente l'impoverimento delle masse. Di fatto,
la Speenhamland Law trasferiva interamente il peso dei salari sulla comunità. La
situazione divenne particolarmente grave quando, in seguito alle guerre napoleoniche,
la Corn Law (legge protezionista sul grano) ebbe l'effetto di far aumentare il prezzo del
grano, cui era agganciata la scala Speenhamland. L'assurdità di questa situazione
fomentò le posizioni favorevoli all'abolizione di ogni forma di assistenza e alla
liberalizzazione dei salari.
Dal 1650 al 1850 gli abitanti dell’Europa crebbero da 105 a 256 milioni, le rivoluzioni
tecnologiche influirono sulla stratificazione sociale dei vari paesi, determinando anche
l’esodo dalle campagne alle città.
La “questione operaia” conseguente al rapido decollo dell’industria, diventò
progressivamente un tema assai spinoso nell’opinione pubblica inglese; si verificarono
in alcuni casi rivolte e sollevazioni ma più di tutto cominciarono a nascere le prime
aggregazioni associative di matrice operaia. Di fatto tali organizzazioni offrirono fin
dall’inizio uno strumento di natura previdenziale, con il quale i settori più evoluti delle
classi popolari cercarono di supplire alle carenze del sistema assistenziale pubblico.
Inoltre nel 1833 avvennero le prime conquiste normative a tutela del lavoro minorile e
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 36
femminile. Con l’avvento delle rivoluzioni del 1848 l’associazionismo continuò ad
affermarsi su scala europea.
In Italia all’alba della nascita del Regno nel 1861 il settore della beneficienza era
demandato alle Opere Pie, associazioni private volontaristiche e agli uffici pubblici di
beneficienza. Lo stato liberale italiano si limitò alla gestione della salute pubblica e alla
tutela sanitaria dei poveri o all’assistenza a limitate categorie sociali.
In questi decenni infine si svilupparono da una parte i sindacati dei lavoratori, che
assunsero progressivamente un valore anche politico con una capacità accresciuta di
pressione sui governi e parlamenti. Dall’altra anche i primi partiti socialisti su scala
nazionale: nel 1875 il partito socialdemocratico tedesco, nel 1879 il partito socialista
operaio spagnolo e nel 1880 partito operaio francese e poi quello belga.
3. NASCITA DELLO STATO SOCIALE
L’intervento dello Stato nelle condizioni di vita dei cittadini ha le sue prime spiegazioni
e origini in quella che Karl Polanyi ha definito la Grande Trasformazione che come
abbiamo visto nel precedente capitolo, durante l’ultimo decennio dell’Ottocento ha
interessato molti Paesi europei modificandone profondamente e progressivamente sia le
condizioni di vita, sia le forme di solidarietà tradizionale.
Fenomeni come l’industrializzazione, seguita da urbanizzazione, crescita della
popolazione, fenomeni migratori, cambiamenti del mercato e del lavoro fecero
aumentare senza dubbio le opportunità ma anche i rischi, mentre indebolivano le
tradizionali agenzie di solidarietà come famiglie, opere pie, associazioni mutualistiche.
3.1. IL M ODELLO BIS M ARCKIAN O
Il primo vero e proprio esempio di Stato sociale moderno si ebbe con l’introduzione nel
1883 di uno schema di assicurazioni obbligatorie in caso di malattia per la tutela dei
lavoratori a basso livello di salario, ampliate poi agli infortuni, alla vecchiaia e
all’invalidità da parte del cancelliere tedesco Otto Von Bismark.
Nell’Europa di fine Ottocento, nonostante le differenze esistenti fra paese e paese, sul
piano delle politiche previdenziali i vari meccanismi di tutela erano imperniati su due
pilastri: il primo, di natura pubblica, era costituito dalle assicurazioni occupazionali
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 37
(obbligatorie o su base volontaria); il secondo, di carattere privato, era rappresentato
dalla rete delle società mutualistiche.
Anche in ambito assistenziale da un lato vi era la carità legale erogata da varie
istituzioni di natura pubblica facenti capo allo Stato e alle amministrazioni locali;
dall’altro la beneficenza privata, offerta da numerose organizzazioni filantropiche a
carattere volontaristico, di impostazione laica o confessionale.
Attraverso le riforme bismarckiane avvenne la definitiva istituzionalizzazione delle
assicurazioni occupazionali con finalità più ampie rispetto a quelle semplicemente
sociali, rivolgendosi principalmente ai lavoratori di sesso maschile appartenenti al
settore industriale avanzato e puntando a garantirne il reddito anche in presenza di
condizioni sfavorevoli.
Inoltre per la prima volta questa legislazione produsse una differenza tra questioni
previdenziali, cioè quelle che ricadevano nella nuova disciplina sulle assicurazioni
obbligatorie e quelle meramente assistenziali a discrezione delle istituzioni locali. A
proposito di questo aspetto lo storico Gerhard A. Ritter scrisse:
Con l’assicurazione sociale si riconobbe implicitamente che esistevano cause sociali di
bisogno di cui il singolo non era responsabile, e che il perseguimento del benessere
individuale, rispettoso della dignità e della libertà del singolo, era compito della società.55
L’ampiezza di questo sistema di assicurazione, almeno per le società dell’epoca, e il
numero degli assicurati resero la Germania il primo Stato con un moderno sistema di
sicurezza sociale al mondo, rappresentando un modello adottato dagli altri Stati europei.
Bisogna però ricordare che le finalità politiche di questi provvedimenti si collocarono
nel quadro della legislazione antisocialista degli anni 1878-1890, volendo erodere il
consenso del movimento operaio, in un’ottica di incentivazione del mercato del lavoro
dato dall’espansione di industrializzazione ed urbanizzazione.
3.2. LIBE RALI E SO CI ALIS TI : D ALLE RIFO RME ALL A GRANDE GUE RRA
Uno dei casi particolari d’inizio secolo fu la legislazione sociale promossa in Inghilterra
dai governi liberali guidati da Herbert H. Asquith e David Lloyd George.
55
Cit. in F. CONTI, G. SILEI, Breve storia dello Stato sociale, Carocci, Roma, 2005,
p. 43.
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 38
In primo luogo si affrontò il problema della disoccupazione aumentando l’offerta dei
posti di lavoro con il diretto coinvolgimento dello Stato. Fu varata anche una riforma
del sistema delle pensioni di vecchiaia con due elementi radicalmente innovativi: tale
sistema era totalmente a carico dello Stato attraverso un incremento della contribuzione
fiscale e in secondo luogo questa disposizione era universalistica. Nonostante ci fossero
dei vincoli ben articolati e il contributo versato fosse esiguo, questa legge ebbe un
grande valore simbolico.
Anche in Italia si crearono i presupposti per una collaborazione tra forze liberali e
progressiste. Questi governi, compreso quello presieduto da Giolitti (1903-1905),
promossero una legislazione favorevole alla popolazione meno agiata, dal lavoro
femminile e minorile alla creazione di case popolari accessibili alle masse operaie. Gli
interventi in questo ambito continuarono a delineare in Italia un embrionale sistema
pubblico senza però avere dei risultati brillanti, come scrive il sociologo Enzo Bartocci:
il modesto peso della cultura riformistica all’interno della borghesia e il disinteresse e
l’opposizione della maggioranza della classe dirigente liberale giocarono un ruolo di freno
in questa partenza decisamente stentata del sistema italiano di sicurezza sociale.56
Con il nuovo secolo quindi, con le dovute differenze tra Stato e Stato, crebbe il numero
della popolazione coperta dalle assicurazioni contro gli infortuni, la disoccupazione,
l’invalidità e la vecchiaia.
Un dato molto interessante è l’ulteriore espansione del ruolo dello Stato favorito dallo
scoppio della Prima Guerra Mondiale. A seguito della massimizzazione della
produzione imposta dallo sforzo bellico, la tutela dei ceti meno abbienti fu una
necessità. L’emergenza legata al razionamento del cibo, al peggioramento delle
condizioni igieniche e alla diffusione di epidemie, non fece altro che evidenziare le falle
e la precarietà dell’assistenza pubblica.
Le prime risposte a questa situazione furono ad esempio l’allargamento dei beneficiari
delle politiche di assistenza, aiuti a determinate categorie lavorative, impossibilitate a
svolgere le loro mansioni, e la disposizione di fondi per i banchi del mutuo soccorso.
Il protagonismo statale che caratterizzò il periodo del primo conflitto mondiale plasmò
quello che poi si sarebbe prodotto nel dopoguerra in concomitanza con la Grande
Depressione del 1929.
56
E. BARTOCCI, Liberali, socialisti e cattolici nella formazione del nucleo originario
dello stato Sociale Italiano in F. Conti, G. Silei, Breve storia, cit., p.64
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 39
4. ASCESA DELLO STATO SOCIALE
In buona parte degli Stati europei la protezione sociale che si venne a creare con la
Prima Guerra Mondiale proseguì e si perfezionò ulteriormente per una serie di fattori:
1. innanzitutto dagli anni Venti del Novecento, il contesto sociale dei Paesi che
avevano conosciuto il processo di industrializzazione fu caratterizzato
dall’affermazione della cosiddetta società di massa, data dal miglioramento delle
condizioni di vita e dal conseguente incremento demografico;
2. una volta concluso il conflitto, lo Stato si fece promotore della progressiva
riconversione industriale ed economica, estendendo il suo controllo a pressoché
tutti i settori lavorativi. Questo fatto fu incentivato dalla preoccupazione della
crescente e diffusa disoccupazione a cui i governi risposero con l’importante
conversione delle forme di assicurazioni dei lavoratori a sistemi di assicurazioni di
tipo sociale, che ampliavano di fatto la copertura anche ai familiari degli stessi. In
Italia il governo operò nel 1919, congiuntamente alla gestione dei sussidi alla
disoccupazione, una riforma del sistema di collocamento, istituendo un Ufficio
centrale di collocamento e una rete di uffici a livello locale gestiti dai Comuni o
dalle organizzazioni lavorative;
3. il concetto di cittadinanza politica crebbe notevolmente in seguito all’ampliamento
del diritto di voto, attraverso l’introduzione del suffragio universale maschile e in
casi isolati anche di quello femminile e al diverso atteggiamento delle correnti
riformiste del movimento operario e sindacale le quali operarono da sole o in
coalizione con le forze liberali per mitigare le storture del sistema capitalistico;
4. le riforme furono portate avanti anche come strumento per arginare o prevenire la
conflittualità sociale e le prospettive rivoluzionarie verificatesi ad esempio in
Russia;
5. infine l’attenzione ai diritti del cittadino fu emblematicamente rinnovata nella Carta
della Repubblica di Weimar, in cui si stabiliva che l’ordinamento della vita
economica dovesse corrispondere ai principi della giustizia, “con l’obiettivo di
garantire a tutti un’esistenza dignitosa (art. 151), il diritto alla salvaguardia della
salute e della capacità lavorativa, la tutela della maternità e alla prevenzione delle
conseguenze economiche della vecchiaia, dell’indebolimento fisico e delle
circostanze negative della vita (art. 161)”.57
57
G. PROCACCI, Storia del XX secolo, Milano, Mondadori Editore, 2000, pag. 81.
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 40
In sintesi a metà degli anni Venti tutti i principali Stati europei si erano ormai dotati di
un sistema di protezione sociale imperniato su assicurazioni che coprivano quattro
tipologie di rischio: gli infortuni sul lavoro, l’invalidità-vecchiaia, la malattia o la
maternità e la disoccupazione. Alcune di queste assicurazioni erano a copertura
occupazionale, finanziate cioè attraverso il versamento di contributi accantonati in
speciali fondi e volte ai lavoratori; le altre invece a copertura statale, finanziate dallo
Stato, erano ispirate a principi universalistici e puntavano a fornire a tutti i cittadini,
generalmente dietro attestazione dello stato di bisogno, un reddito minimo.
Lo Stato si fece garante e regolatore, anche se non sempre i risultati furono quelli
previsti, del benessere sociale sia da un punto di vista legislativo ma anche con un
preciso principio di redistribuzione della ricchezza.
Il crollo della borsa newyorkese di Wall Street, nell’ottobre 1929, con le sue
ripercussioni inevitabili sull’economia europea ebbe un effetto dirompente anche sui
sistemi di protezione sociale.
4.1. IL NE W DE AL
Il New Deal, o nuovo corso, rappresenta la risposta alla crisi economica scatenatasi nel
1929 negli Stati Uniti d’America. Negli immediati anni successivi (dal 1933 al 1937)
infatti, il presidente americano Franklin Delano Roosvelt varò una serie di riforme
economiche e sociali con lo scopo di arginare le conseguenze del default di un Paese
sull’orlo del baratro. Fu grazie a queste riforme che gli Stati americani, in ritardo
rispetto al continente europeo, conobbero la previdenza sociale, attraverso il Social
Security Act il quale prevedeva la copertura assicurativa obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia, i superstiti e i disoccupati. In un primo momento la copertura finanziaria di
questo provvedimento era un fondo predisposto grazie alla capitalizzazione, cioè
l’accumulo dei contributi versati. In seguito questo criterio fu sostituito dalla
ripartizione dei contributi versati da tutti i lavoratori per pagare coloro che usufruivano
delle prestazioni, in modo da avere sempre una quantità abbondante di risorse.
Questa versione di welfare state, potenzialmente universalistica, fece degli Stati Uniti
una nazione all’avanguardia, ma non riuscendo a radicarsi nel territorio, rimase un
approccio valido per una situazione di emergenza. Le riforme sociali, infatti, non si
evolsero progressivamente come vedremo invece avvenne in Europa.
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 41
4.2. LO STATO S OCI ALE TO TALI TARI O
Gli schemi di copertura elaborati dai governi liberaldemocratici d’inizio secolo
apparvero inefficaci e fragili di fronte alla disoccupazione di massa e alla stagnazione
dell’economia.
In Italia dopo l'ascesa al potere del fascismo ed il dissolvimento definitivo dello Stato
liberale, i provvedimenti sociali vennero pressoché mantenuti in un primo momento per
poi invece essere oggetto di riforma.
Con il cosiddetto patto di palazzo Vidoni, con scopi clientelari e volti ad indebolire ogni
possibile alternativa al regime, il PNF assunse il monopolio del sindacato dei lavoratori
e della Federazione nazionale del mutuo soccorso. L’interventismo statale assunse da
questo momento fino alla fine del secondo conflitto mondiale un’impronta ambivalente:
da un lato furono istituiti grandi enti nazionali per l’assistenza della maternità,
dell’infanzia, dell’adolescenza, del dopolavoro, per la prevenzione degli infortuni ma lo
stampo universalistico era adottato solo dietro l’esibizione della tessera di partito e un
controllo diretto o indiretto dagli organi di partito. Vi furono settori della produzione
avvantaggiati rispetto ad altri, come ad esempio quello dell’industria avanzata a scapito
del settore arretrato dell’agricoltura.
In sintesi lo Stato fascista rimase caratterizzato da una frammentazione delle prestazioni
e disparità di trattamento da individuo ad individuo. Nonostante questi importanti limiti,
le deboli istituzioni previdenziali liberaldemocratiche d’inizio secolo furono
ammodernate.
La visione corporativistica dello stato sociale, che utilizzava le politiche sociali come
strumento per la creazione del consenso, fu utilizzata anche nel Terzo Reich della
Germania nazista.
Negli altri Paesi europei, durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, le politiche
sociali furono proseguite da governi di stampo socialdemocratico. In particolare una
grande trasformazione interessò la Svezia, la quale riuscì a intrecciare il tema
dell’assistenza sociale a un preciso concetto di cittadinanza:
Mentre lo schema ortodosso presuppone che il welfare e il benessere possono emergere
soltanto dopo la socializzazione della produzione, il revisionismo svedese sostiene che le
riforme politiche e sociali possono creare le condizioni, passo dopo passo, per una
trasformazione dell’economia. La “cittadinanza politica” deve precedere la “cittadinanza
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 42
sociale” ed entrambe a loro volta sono indispensabili per la terza fase, quella della
“cittadinanza economica”.58
Si verificò quindi un patto sociale tra l’economia di mercato, i sindacati e lo Stato in
modo da tutelare tutti i cittadini con una “pensione popolare”.
Questa riforma, precorritrice dei moderni sistemi di welfare, rimase prerogativa degli
Stati dell’Europa del Nord. Nel Regno Unito invece William Beveridge pubblicò un
documento, il Report of the Inter-Departmental Committee on Social Insurance and
Allied Services, con l’obiettivo di completare la trasformazione delle strutture statali per
la costituzione di un sistema di erogazione dell’assistenza statale in modo uniforme,
universalistico ed adeguato. Questo rapporto non fu preso alla lettera dal partito
laburista dell’epoca ma sicuramente servì a declinare meglio il concetto di social
security, aprendo di fatto la grande stagione del Welfare State moderno.
5. L’APOGEO DEL WELFARE STATE
Sono molti i fattori che nel secondo dopoguerra condussero gli Stati industrializzati ad
avere tra gli obiettivi quello della sicurezza sociale. Con la costituzione dell’Assemblea
delle Nazioni Unite nel 1945, memori dell’atrocità dei due conflitti mondiali, fu
riconosciuto nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (approvata il 10
dicembre 1948) anche la tematica delle politiche sociali:
Art. 25:
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il
benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al
vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto
alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o
in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua
volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini,
nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.59
58
G. ESPING-ANDERSEN, Politics Against Markets. The Social Democratic Road to
Power, in F. CONTI, G. SILEI, Breve storia, cit. p. 96. 59
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 43
Un altro fattore che contribuì alla costruzione dello Stato Sociale fu la ricostruzione dei
paesi europei, che alimentò l’avvento dei consumi di massa e la diffusione del sistema
fordista di produzione industriale. Il sistema economico basato sull’accordo di Bretton
Woods, come abbiamo visto nei precedenti capitoli, fece da cornice a questo consenso.
Inutile non pensare che uno dei fini ultimi dell’azione politica del welfare state, assieme
alle nazionalizzazione, alla democrazia industriale, alle politiche di piena occupazione,
era perseguire gli ideali di giustizia sociale e di uguaglianza per arginare la depressione
economica e il suo violento esito polarizzante della politica estrema del fascismo e del
comunismo. Per capire le ragioni dell’evoluzione del welfare state, Giorgio Ruffolo nel
suo libro La qualità sociale, scrive:
Questi fenomeni si sarebbero poi consolidati nel secondo dopoguerra, con il vantaggio
derivante dallo sviluppo economico, che rendeva disponibile il surplus necessario al livello
di redistribuzione richiesto dal welfare state. Per certi versi il welfare state rappresenta la
conseguenza logica, razionale dell’industrializzazione nei sistemi capitalistici democratici.
La crescita economica e le sue conseguenze demografiche e organizzative sono le cause
ultime dell’emergere del welfare state inteso come rafforzamento delle capacità di consumo
dei cittadini, come indiretto sostegno al mercato stesso.60
5.1. LA COS TRUZIONE DELL O STATO SO CIAL E DAL 1945 AL 1970
Nel 1946 in Gran Bretagna fu approvato il National Insurance Act, con il quale si operò
un importante riassetto del sistema previdenziale e assistenziale tendenzialmente
universalistico. Questa legge prevedeva tra le altre disposizioni anche due diverse
tipologie di pensioni di vecchiaia: quella statale a contribuzione occupazionale (a 65
anni per gli uomini e a 60 per le donne) e la pensione sociale di importo fisso riservata
ai cittadini al di sopra dei 70 anni di modeste condizioni economiche. Tali pensioni
potevano essere reversibili in caso del decesso del titolare.
In Italia l’universalismo non si affermò subito poiché il piano socio-economico del
dopoguerra a differenza delle realtà nordeuropee era ancora arretrato, con un tessuto
industriale poco organizzato e con una quota di lavoratori dipendenti molto più bassa
rispetto ai Paesi anglo-scandinavi. Anche la politica italiana rappresentata dalla
radicalizzazione dello scontro tra schieramento centrista della Democrazia Cristiana e
60
G. RUFFOLO, La qualità sociale, Editori Laterza, Roma 1990, p.43
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 44
quello frontista del Partito Comunista e Socialista, impedì la concertazione di riforme
sociali di largo respiro.
Mentre in Svezia negli anni Cinquanta si andava plasmando uno stato sociale popolare
sempre più imperniato sui diritti di cittadinanza piuttosto che sull’appartenenza a una
categoria produttiva, in Germania ci fu una lunga transizione dal dopoguerra alla
riforma delle assicurazioni obbligatorie. Nel 1957 le pensioni mantenevano il carattere
occupazionale e obbligatorio attraverso le Casse categoriali, erogando dunque una
somma in linea ai salari della vita lavorativa dell’individuo. L’assistenza sociale invece
si occupava di fornire i redditi minimi ai cittadini meno abbienti e la copertura ai rischi
di infortuni, invalidità e morte.
Anche in Italia le strutture della previdenza subirono una lenta evoluzione. Nel 1950 si
estese l’assicurazione delle pensioni obbligatorie a tutti i lavoratori dipendenti, nel 1957
vi fu un analogo provvedimento per i coltivatori diretti e nel 1959 per gli artigiani. La
ripartizione che scelsero i governi italiani fu quella classica a capitalizzazione. In questi
anni si verificò inoltre una pratica di mutualità fra le categorie che andava a trasferire i
fondi in caso di disavanzi per garantire disponibilità finanziaria.
Negli anni Sessanta il welfare state conobbe un’ulteriore espansione: sul piano
previdenziale ciò si tradusse con un ampliamento della copertura e anche
dell’ammontare delle pensioni, sempre più vicine a quello dell’ultimo salario percepito.
Anche sul piano dell’assistenza, fu parzialmente corretto il sistema della “prova dei
mezzi” con l’obiettivo di garantire ai cittadini in difficoltà una sorta di reddito minimo
garantito.
Nel 1966, con l’avvento della Gande coalizione, che vedeva il partito cristiano-sociale
alleato con il leader socialdemocratico, si ebbe un rilancio dell’intervento statale
nell’economia e un incremento delle prestazioni previdenziali, assistenziali e sanitarie.
Anche in Italia la nascita dell’alleanza di centro-sinistra aiutò a proseguire le riforme
sociali. Una prima disposizione fu l’aumento delle pensioni contributive e delle pensioni
di invalidità e di vecchiaia degli ultra sessantacinquenni. Soltanto nel 1965 però si riuscì
ad armonizzare in un Testo Unico le varie disposizioni di legge sugli infortuni e le
malattie professionali. All’interno dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) fu creato inoltre un Fondo sociale per l’erogazione di una pensione slegata dalle
contribuzioni professionali. Non si ebbe dunque una grande riforma ispirata alla
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 45
sicurezza sociale come negli altri Paesi europei ma una progressiva estensione degli
schemi assicurativi occupazionali alle categorie ancora escluse.
Nel 1968-69 in Italia la riforma previdenziale fu concretamente posta nell’agenda di
governo dal socialista Brodolini, secondo cui doveva essere imperniata su tre direttrici:
1. la pensione sociale per tutti i cittadini indigenti finanziata dalla fiscalità
generale;
2. la pensione di vecchiaia di base in parte contributiva e in parte finanziata;
3. una pensione integrativa a importo variabile a seconda dell’anzianità
contributiva e del livello di retribuzione raggiunto.61
Nonostante la portata di queste novità, questa riforma rimase una forma compromissoria
tra lo stampo universalistico voluto dal PSI e quello invece graduale voluto dalla DC.
5.2. L’ASSIS TENZ A S ANI TARI A PUBBLI CA
L’apogeo della costruzione dello Stato sociale avvenne con l’ingresso dell’assistenza
sanitaria pubblica nella rosa di provvedimenti sociali progressivamente ottenuti
attraverso l’evoluzione dell’interventismo statale.
Il governo britannico già nel 1946 aveva votato la legge del Servizio sanitario nazionale
affidato alle strutture pubbliche finanziato attraverso il prelievo fiscale e gratuito per
tutti i cittadini. Tale sistema fu integrato sul territorio con l’adozione di una rete di
strutture decentrate incaricate di armonizzare l’assistenza sociale con quella sanitaria.
Questo tipo di assistenza fu adottata anche dai Paesi nord europei mentre per la
Germania e l’Italia ci vollero ancora diversi anni prima che si arrivasse ad una
equiparazione con gli Stati anglo-scandinavi.
In Italia, in particolare, la situazione ingessata del welfare state, con le sue forme
categoriali e clientelari, non fu d’aiuto all’idea di un sistema sanitario nazionale. Inoltre
la mancanza di risorse rallentò questa evoluzione, passando prima per una
democratizzazione degli organi amministrativi e la riqualificazione delle strutture
ospedaliere arrivando nel 1968 alla legge Mariotti che comportava la trasformazione
degli ospedali in enti di prevenzione e riabilitazione, cominciando a pianificare i bisogni
della popolazione. La mancata attuazione del regionalismo, in cui le regioni avrebbero
61
F. CONTI, G. SILEI, Breve storia, cit., p.18
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 46
coordinato la gestione del costituendo Sistema sanitario nazionale, fece in modo da
rimandare quasi completamente la creazione di quest’ultimo.
5.3. LAVO RO , CAS A E IS TRUZIO NE
La crescita economica pressoché interrotta dalla fine del secondo dopoguerra agli anni
Settanta, l’aumento delle aspettative di vita media e l’aumento del benessere nei Paesi
industrializzati fecero in modo di allargare i confini del welfare al diritto di lavoro, casa
e istruzione.
L’idea del pieno impiego utilizzata dai governi per arginare le frange estreme, servì
anche per delineare il diritto al lavoro, per altro già rivendicato nell’articolo 1 e 4 della
Costituzione della Repubblica Italiana del 1948.
Se fino agli anni Sessanta le politiche della casa furono pensate più per i lavoratori
dell’industria e per il ceto medio emergente che non per le categorie sociali realmente
bisognose, favorendo il radicamento del modello economico, familiare e sociale
d’impronta fordista, negli anni Settanta nel Regno Unito, in Germania e in Italia furono
promosse riforme urbanistiche volte a concedere finanziamenti per la casa o abitazioni a
basso costo.
A completare il quadro delle riforme sociali furono le politiche per l’istruzione,
caratterizzate dall’aumento degli anni di scuola obbligatori. In Gran Bretagna la riforma
scolastica fu ritenuta importante come quella dell’assistenza sanitaria e fu riformata in
tempi rapidi e precoci rispetto agli altri Stati europei; in Italia invece si dovette attendere
il 1962 perché il governo varasse la legge che istituiva la scuola media unificata,
innalzasse l’obbligo scolastico ai 14 anni di età e introducesse assegni per gli studenti
universitari meno abbienti.
5.4. IL SESS AN TO TTO E L ’ULTIM A S PIN TA RIF ORM ATRICE
L’ultima spinta riformatrice si ebbe nel 1968 con le agitazioni che si svilupparono in
quasi tutto il mondo. Questi movimenti nacquero originariamente a metà degli anni
Sessanta negli Stati Uniti e raggiunsero la loro massima espansione nel 1968
nell'Europa occidentale col suo apice nel Maggio francese. Nel campo occidentale
(Europa e Stati Uniti d'America) un vasto schieramento di studenti e operai si
schierarono contro l'ideologia dell'allora nuova società dei consumi, che proponeva il
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 47
valore del denaro e del mercato come punto centrale della vita sociale e il principio
dell'autorità. Nelle scuole gli studenti contestavano i preconcetti dei professori, della
cultura ufficiale e del sistema scolastico classista e obsoleto. Nelle fabbriche invece gli
operai rifiutavano l'organizzazione del lavoro e i principi dello sviluppo capitalistico che
mettevano in primo piano il profitto a scapito dell'elemento umano.
Anche la famiglia tradizionale fu investita dal rifiuto dell'autorità dei genitori e del
conformismo dei ruoli: ebbero inizio, infatti, i movimenti che mettevano in discussione
le discriminazioni in base al sesso, ad esempio il femminismo e il movimento di
liberazione omosessuale, oltre alla parificazione dei diritti civili contro la
discriminazione razziale.
Gli obiettivi comuni ai diversi movimenti erano la riorganizzazione della società sulla
base del principio di uguaglianza, il rinnovamento della politica in nome della
partecipazione di tutti alle decisioni, l'eliminazione di ogni forma di oppressione sociale
e l'estirpazione della guerra come forma di relazione tra gli Stati.
Il Sessantotto italiano fu caratterizzato dalla presenza di giovani operai a fianco degli
studenti e si accese in seguito ad un malessere sociale profondo, dovuto al fatto che il
cosiddetto boom economico aveva giovato specialmente alla borghesia e non era stato
accompagnato da un adeguato aumento del livello sociale ed economico delle classi
meno abbienti.
L'esplosione degli scioperi degli operai in fabbrica si saldò con il movimento degli
studenti che contestavano i contenuti arretrati e parziali dell'istruzione e rivendicavano
l'estensione del diritto allo studio anche ai giovani di condizione economica disagiata.
All’inizio del 1969 furono quindi adottati i primi provvedimenti concreti per rispondere
a queste agitazioni: fu riformata la modalità degli esami di maturità, furono varate
alcune norme riguardanti l’attribuzione degli assegni di studio, la liberalizzazione degli
accessi alle università e lo statuto dei lavoratori che rimise in discussione le condizioni
fuori e dentro le fabbriche.
Il risultato del Sessantotto fu un generalizzato rilancio delle riforme sociali destinato a
caratterizzare i primi anni Settanta e a interrompersi soltanto quando i primi effetti di
una nuova crisi internazionale si manifestarono in tutta la loro gravità.
Il dato più rilevante di questi ultimi anni fu l’espansione generalizzata degli schemi di
protezione sociale che in Europa giunsero a coprire la quasi totalità della popolazione.
Si distinsero due tipi di welfare: uno a carattere universalistico, finalizzato a garantire
una protezione minima a tutti i cittadini e l’altro a carattere occupazionale, volti a
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 48
tutelare i contribuenti che finanziavano i vari schemi di protezione sociale attraverso il
lavoro. Tale suddivisione può essere divisa ulteriormente in schemi occupazionali puri,
adottati da Austria, Germania, Francia e Belgio, con copertura prevista prevalentemente
per gli occupati, poi di tipo misto, in Italia, Paesi Bassi e Irlanda, con aspetti
occupazionali e universalistici, e gli schemi universalistici puri, dei Paesi scandinavi, i
quali prevedevano una copertura a tutti i cittadini senza prova di mezzi. Lo schema
adottato da Gran Bretagna, Nuova Zelanda e Canada invece prevedeva un’impostazione
universalistica mista che prevedevano anche schemi integrativi occupazionali a carattere
privato.62
L’equilibrio del Welfare State si reggeva su basi precarie, minacciato dalle
trasformazioni sociali, dal cambiamento dei processi di produzione e dall’avvento di
una nuova crisi economica-energetica, aprendo una fase di profonda revisione
ideologica.
6. IL DECLINO DEL WELFARE STATE
Lo Stato non è la soluzione ai nostri
problemi. Lo Stato è il problema.63
A metà degli anni, Settanta come abbiamo visto nei precedenti capitoli, una serie di
fattori concomitanti determinarono forti ripercussioni sul piano sociale, economico e
politico.
Il boom del settore dei servizi, legato sempre di più all’utilizzo delle tecnologie,
l’aumento del prezzo del greggio generato dal primo shock petrolifero per la guerra del
Kippur del 1973, la fine del sistema di Bretton Woods con la conseguente
liberalizzazione delle monete e del mercato sono alcuni esempi che si possono fare per
delineare il clima di insicurezza di questi anni.
Questa serie di sconvolgimenti innescò una serie di crisi a catena del settore produttivo,
energetico ed economico. L’aumento dell’inflazione portò ad una situazione di
stagflazione, cioè di stagnazione e di inflazione, che fu tra le cause di un’alta
percentuale di disoccupazione, con bassi tassi di crescita dopo un trentennio di crescita
ininterrotta. La spesa pubblica, infatti, per tutto il dopoguerra era cresciuta in modo
esponenziale nei paesi più avanzati, raggiungendo l’apice proprio negli anni Settanta.
62
M.FERRERA, Modelli di solidarietà. Politica e riforme sociali nelle democrazie.
1993, Il Mulino, Bologna, p. 101. 63
Discorso di Ronald Reagan, 1981
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 49
Un diffuso aumento dell’incertezza ed enormi difficoltà nella pianificazione
provocarono una frenata nella produzione e nel riformismo delle politiche sociali,
arrestando il processo di costruzione del welfare state.
L’inflazione aumentò a più riprese per la situazione delicata nell’area medio-orientale,
tra cui la rivoluzione iraniana del 1979, a ritmi tali che i Paesi occidentali vararono
nuovamente politiche di contenimento della domanda e tagli alla spesa pubblica che dal
dopoguerra ai primi anni Settanta era cresciuta sempre di più.
Con l’ascesa di Margaret Thatcher in Gran Bretagna e di Ronald Reagan negli Stati
Uniti, l’agenda politica internazionale cambiò profondamente a favore di una
liberalizzazione generalizzata del mercato a scapito del controllo statale.
Le nuove teorie conservatrici prendevano spunto dall’idea che l’interventismo dello
stato nel dopoguerra, sia stata la causa della crisi.
In Gran Bretagna, il primo ministro inglese Margaret Thatcher ridimensionò il ruolo dei
sindacati, privatizzò imprese un tempo pubbliche, liberalizzò il mercato degli affitti
diminuendo così la spesa pubblica in campo abitativo. In Germania il governo rispose
all’alto tasso di disoccupazione attraverso misure di austerità e tagli alla spesa sociale
gravando sui lavoratori, pensionati e disoccupati meno abbienti.
In Italia invece furono creati, sempre per la disoccupazione, i contratti di solidarietà
mediante i quali fu possibile trasferire personale di aziende in crisi in altri settori e
furono permessi particolari contratti in modo da facilitare l’assunzione dei giovani. Il
governo dovette far fronte all’aumento della spesa pubblica data dalla riforma del
sistema sanitario nazionale che, paradossalmente, di tipo universalistico si
contrapponeva al sistema occupazionale previdenziale. Inoltre, se il decentramento di
erogazione dei servizi alle Regioni favoriva l’espansione dello stesso con un
conseguente aumento di spesa sociale, a livello centrale prevaleva invece una tendenza
al contenimento dei costi. Queste contraddizioni ancora oggi gravano sulla struttura del
welfare italiano, a cui si aggiungono i ritardi strutturali del passato, lasciando che in
situazioni di emergenza tali limiti si rendono ancor più visibili e le cui soluzioni sono
ancora lontane per il carattere poco lungimirante di una politica interna autoreferenziale
e che non ha del tutto abbandonato il suo vizio clientelare.
La caduta del muro di Berlino del 1989 fece da spartiacque dato che questo evento
segnò la fine della competizione del socialismo reale con il suo avversario rappresentato
dal capitalismo del mercato globale.
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 50
Gli anni Novanta si sono contraddistinti come gli anni della ricerca di un nuovo
approccio alle politiche sociali capaci di tener conto dei mutati scenari economici. In
tutti i paesi avanzati le esigenze di contenimento dei costi, di fronte ad un’economia non
più florida e all’incertezza dei mercati internazionali, hanno imposto la ricerca di un
equilibrio tra qualità e quantità delle prestazioni da erogare.
Le dinamiche demografiche e l’eccesso di spesa pubblica resero necessario un
progressivo innalzamento dell’età pensionabile, e le dinamiche di mercato introdussero
il concetto di flessibilità.
Già a partire dagli anni Novanta il welfare state ha dovuto fare fronte alla
globalizzazione, che ancora oggi caratterizza il mercato, la produzione e la politica
internazionale. Inoltre il progressivo invecchiamento della popolazione ha messo a
rischio oltre al sistema della previdenza anche quello della spesa pubblica, come
spiegano in un editoriale del Corriere della Sera del 12 Settembre 2012 gli economisti
Alberto Alesina e Francesco Giavazzi:
L’allungamento della vita ha anche prodotto un aumento delle spese per la salute. Un
anziano oltre i 75 anni costa al sistema sanitario ordini di grandezza superiori rispetto a
persone di mezza età. Risultato, la nostra spesa sanitaria oggi sfiora il 10 per cento del Pil.
Insieme, sanità e pensioni costano il 27 per cento, 10 punti più di quanto costavano quando
il nostro Stato sociale italiano fu concepito. […] È questo uno dei motivi per cui abbiamo
smesso di crescere. Avevamo uno Stato calibrato per una popolazione relativamente
giovane; poi la vita si è allungata, le spese sono salite, ma lo Stato è rimasto
sostanzialmente lo stesso, richiedendo una pressione fiscale di 15 punti più elevata.64
Un altro elemento in comune ai vari progetti di riforma dello Stato Sociale è stato quello
di ritardare, attraverso incentivi di vario tipo, l’uscita dal mercato dei soggetti in età
pensionabile per arginare il costo elevato delle pensioni erogate.
All’inizio degli anni 2000 sono stati introdotti provvedimenti che miravano ad
affiancare schemi pensionistici integrativi di natura privata a quelli tradizionali statali.
Queste misure di razionalizzazione e di messa in sicurezza dei conti previdenziali hanno
subito una brusca accelerazione a seguito dell’impatto che hanno avuto i mutui
subprime sulle economie europee, nella crisi economica-finanziaria iniziata negli USA
nel 2006.
64
http://www.corriere.it/editoriali/12_settembre_23/stato-sociale-alesina-giavazzi_0834cb6e-
054b-11e2-b23b-e7550ace117d.shtml
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 51
CONCLUSIONI: IL TRAMONTO DEL WELFARE STATE?
Quello che ci preoccupa è la rotta e lo
scopo finale. Quello che ci preoccupa è
quello che ci definisce, il modo di azione.
Quello che ci preoccupa è che il mondo che
partorirà la nostra rabbia non assomigli
quello che oggi subiamo. Quello che ci
preoccupa è che il nuovo mondo non sia un
clone del mondo attuale o una mutazione
transgenica o una fotocopia di quello che
oggi ci fa orrore e che ripudiamo. Quello
che ci preoccupa è che in quel mondo non
ci sia né democrazia, né giustizia, né
libertà.65
Entrato in crisi negli anni Settanta e rimesso in discussione nel decennio successivo, lo
Stato Sociale sta vivendo tutt’oggi un processo di ristrutturazione.
Come abbiamo visto nei precedenti capitoli, una delle caratteristiche principali dello
Stato del benessere è di aver realizzato una sintesi stabile tra capitalismo e democrazia:
due elementi che apparirono (e a volte appaiono ancora a molti conservatori e
progressisti radicali) inconciliabili sia nella concezione liberale sia in quella marxista.
Dato che questi due principi si sono retti attraverso il paradigma della crescita
economica, la messa in discussione della medesima, conseguente alle numerose crisi
che abbiamo conosciuto dagli anni Settanta in poi, ha determinato il malessere dello
Stato sociale odierno.
Se per un lungo periodo l’espansione del prelievo fiscale e della spesa pubblica sono
stati un supporto e non un freno della crescita economica, ora non solo lo Stato ha perso
la fiducia dei cittadini ma deve affrontare sempre più le contraddizioni odierne del
mercato, della politica e del sistema internazionale, per non parlare delle inquietudini
del futuro che vivono le giovani generazioni.
65
MARCOS SUBCOMANDANTE INSORTO, La saison de la digne rage, Climats,
Paris, 2009, pp. 242-244
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 52
Tabella 2: Andamento della spesa pubblica in alcuni paesi OCSE in
percentuale del PIL nel 1950, 1965 e 1975 66
Paese 1950 1965 1975
Austria 25,0% 33,8% 40,3%
Canada 22,1% 29,3% 41,2%
Danimarca 19,3% 30,1% 47,6%
Finlandia 25,8% 31,5% 37,2%
Francia 28,3% 36,2% 42,4%
Germania occidentale 30,2% 35,0% 45,6%
Italia 23,0% 33,4% 43,1%
Norvegia 24,2% 36,4% 46,5%
Paesi Bassi 27,1% 40,9% 54,3%
Regno Unito 34,2% 35,1% 46,1%
Stati Uniti 22,3% 28,8% 36,2%
Svezia 26,5% 35,5% 51,0%
Il segreto quindi del welfare state stava in questo: con un solo strumento (la spesa
pubblica) si conseguivano due obiettivi molto importanti e cioè la promozione dello
sviluppo economico e la redistribuzione del reddito. Entrambi permettevano prosperità e
consenso sociale.
Questo nesso è stato progressivamente indebolito e opera ora in senso vizioso. Lo Stato
appare ai cittadini, come anche al mondo finanziario, come il responsabile
dell’inflazione e del disordine economico, facendo in modo che si siano gradualmente
ridotti i vantaggi e aumentati i costi della redistribuzione e dei servizi pubblici. Lo Stato,
“colpevole” dell’aumento di inflazione, secondo i neoliberisti e gran parte dell’opinione
pubblica, appare incapace di gestire la situazione contemporanea.
Ma non esiste solo l’inflazione economica, come abbiamo visto il malessere dei giorni
nostri non è solo di tipo economico ma riguarda anche la politica. L’inflazione politica,
termine coniato da Ruffolo nel suo libro La qualità sociale, afferma:
Nel mercato politico, la domanda è costituita dalle aspettative della gente, e si esprime nei
voti, che i partiti e i gruppi sociali organizzati traducono, attraverso le istituzioni dello
Stato, in diritti: diritti di natura economica (e in tal caso il mercato politico interferisce con
il mercato economico) e diritti di natura politica. La competizione oligopolistica per i diritti
66
OECD, National Accounts of OECD Countries, in F. CONTI, G. Silei, Breve storia,
cit., p.172
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 53
genera un’inflazione politica: una svalutazione dei diritti rispetto alle aspettative, dando
luogo così a una condizione generale e cronica di disagio, di conflittualità sociale latente,
che si traduce in ingovernabilità politica.67
Unendo il problema della crescita dell’inflazione economica, l’incremento
dell’inflazione politica (a cui si collega la disaffezione e l’indifferenza da parte dei
cittadini alla politica in generale e alla sua traduzione concreta, cioè i partiti politici) con
l’idea di uno Stato invadente, estraneo e a volte persino ostile, si possono capire le cause
della crisi dello Stato Sociale contemporaneo.
L’ultimo baluardo dello Stato del benessere, cioè la promessa della crescita economica è
ormai sfumata e sembra destinata a scomparire, lasciando spazio al fallimento del
Welfare state con inevitabili conseguenze critiche. Siamo, infatti, di fronte ad
un’instabilità generata dalla globalizzazione dei mercati, al sopravvento conquistato dai
settori finanziari e dal marcato indebolimento delle politiche e dei ruoli istituzionali, il
peggioramento nella distribuzione del reddito e la traslazione dei rischi produttivi dalle
imprese ai lavoratori, il tendenziale trasferimento delle responsabilità socio-assicurative
dalla dimensione pubblica a quella individuale, il conseguente aumento sia della
precarietà nei rapporti di lavoro sia dell’incertezza delle assicurazioni statali. La
globalizzazione in generale, novità dell’ultimo decennio, dopo la caduta del muro di
Berlino, ha aperto un nuovo orizzonte e acceso nuovi contrasti. Stefano Agnoletto a
proposito della globalizzazione, nel suo pamphlet Nuovi paradigmi e nuove alleanze
nell’età della globalizzazione, scrive:
Uno degli effetti più evidenti della globalizzazione riguarda le conseguenze sui sistemi di
Welfare State nel Nord del mondo. Si assiste a un cambiamento strutturale di orizzonte
economico-culturale: significativi livelli di disoccupazione e di sperequazione economica e
sociale divengono variabili dipendenti rispetto alle esigenze del mercato globalizzato,
mentre nella fase cosiddetta keynesiana rappresentavano elementi inaccettabili in una
prospettiva di piena occupazione. Le scelte economiche degli stati si trovano così ad essere
valutate in una realtà nella quale i mercati finanziari tendono a sostituirsi ai cittadini nel
loro ruolo di controllori dell’attività di governo.68
67
G. RUFFOLO, La Qualità sociale, cit., p.112 68
S. AGNOLETTO, Nuovi paradigmi e nuove alleanze nell’età della globalizzazione,
in S. AGNOLETTO (a cura di), Pensare ed agire nell’età della globalizzazione,
Edizioni di Terrenuove, Milano, 2002, p.25
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 54
Questi aspetti rappresentano un’evoluzione economica, politica e sociale che sta
indubbiamente sfibrando il sistema complessivo fino alla crisi globale i cui effetti
ricadono sulle classi sociali in difficoltà.
Oltre a ciò, esistono certamente anche dei limiti oggettivi che non sono legati né al
mercato né alla politica, ma che il sistema dello Stato sociale deve affrontare. Si tratta,
ad esempio, della bilancia demografica dei Paesi industrializzati: dal grafico ottenuto
con i dati delle nascite e dei decessi in Italia si può notare come l’indice delle nascite sia
sceso al di sotto dei decessi. Combinando questo dato con il progressivo aumento
dell’età media69
, la diminuzione della fecondità degli ultimi decenni e l’incremento
della disoccupazione, in un’ottica di medio-lungo termine questi fattori influenzeranno
negativamente il sistema previdenziale dato lo squilibrio tra popolazione attiva e
passiva, l’estensione del periodo di morbilità e l’allungamento di tempi improduttivi.
Figura 8: Nascite e decessi in Italia anni 1862-2009 ai confini attuali (per 1.000
abitanti) 70
69
http://www.census.gov 70
www.seriestoriche.istat.it
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 55
Figura 9: Tasso di disoccupazione in Italia anni 1990 - 2013 (modificato in base alla
stagionalità)71
Nonostante queste prospettive, i governi dei Paesi occidentali stanno rispondendo a
queste problematicità con un approccio a breve termine e di austerity in modo da
contenere il più possibile la spesa pubblica. Chiara Saraceno a proposito di queste
soluzioni scrive:
Benché la crisi economica sia stata e sia soprattutto di natura finanziario-speculativa e avvia
le proprie origini al di fuori dei meccanismi e degli istituti del welfare state, si è arrivati
progressivamente ad indicare in questi medesimi meccanismi e più in generale nella spesa
pubblica, la causa della crisi mettendo in difficoltà ulteriori passi in avanti in questo
frangente. La crisi nata nel mercato e in particolare nel crescente peso dei processi
finanziari a scapito di quelli produttivi, viene rimandata al mercato stesso per la sua
soluzione; con buona pace dell’importante, ancorché faticosa costruzione di una
cittadinanza sociale che al di là delle importanti differenze nazionali era stata alla base dello
sviluppo del welfare state in Europa.72
In altre parole le soluzioni trovate dei governi mondiali per rispondere a questa crisi
sistemica non sono sufficienti. L’austerity, il salvataggio degli istituti di credito come i
tagli alla spesa pubblica stanno determinando l’aumento della recessione economica,
71
http://epp.eurostat.ec.europa.eu 72
C. SARACENO, Il Welfare, cit., p.9
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 56
rendendo ancora una volta le istituzioni dipendenti dalla struttura economica mondiale.
Un cambio di paradigma si rende quindi necessario perché come scrive Giulio Sapelli la
crisi non è solo di tipo politico, economico o dello Stato sociale ma anche di valori
prettamente umani:
La crisi del capitalismo sta più, forse, negli uomini che nel sistema, se questo è capace di
dotarsi di regole severe. […] tutto ciò ci deve indurre ad avere il coraggio di andare oltre,
ovvero ad affrontare l’applicazione specifica del più generale rapporto tra economia ed
etica. Tenendo presente che è anche urgente, nel mondo globalizzato, interpretare e
organizzare l’economia riconoscendone con grande onestà e durezza sia il valore sia i
limiti. Di per sé un mercato mondiale organizzato con equilibrio e una buona
regolamentazione può portare, oltre al benessere, allo sviluppo della cultura, della
democrazia, della solidarietà e della pace. Ci si deve aspettare invece effetti ben diversi da
un mercato selvaggio che, con il pretesto della competitività, prospera sfruttando a oltranza
l’uomo e l’ambiente.73
Una generale presa di coscienza comune e l’abbandono di politiche che non prendono in
considerazione il breve se non brevissimo tempo, favorirebbero l’efficacia di uno
sviluppo non più dettato dalla crescita economica fine a sé stessa e senza spirito critico
ma capace di convogliare anche un accrescimento culturale per non commettere gli
stessi errori. Già negli anni Settanta, all’inizio di questi numerosi malesseri che
colpiscono le società odierne, è fiorita una letteratura critica che metteva in guardia
dalle possibili cattive evoluzioni dell’economia di mercato globale:
In ogni mondo reale ci saranno, per l’individuo, casi in cui potrà dare libero sfogo alle sue
predilezioni personali, ed altri in cui si spererà che egli attinga alla sue risorse morali e
agisca in conformità con i valori etici fondamentali piuttosto che indulgere alle proprie
preferenze. Il problema iniziale, per l’individuo, sarà quello di apprendere come distinguere
prontamente fra questi due casi; quello successivo sarà di scoprire quale decisione prendere
là dove è stato appurato che non si può dare briglia sciolta all’interesse personale.
Uno dei peccati commessi dalla glorificazione della libertà economica è stato precisamente
quello di tendere a confondere gli individui su dove corra la linea di demarcazione fra
questi due casi.74
73
G. DE LUCIA LUMENO, Un capitalismo senza eroi, in G. SAPELLI, La crisi
economica mondiale, Bollati Boringhieri, Torino, 2008, pp. 63-64 74
W. S. VICKREY, The goals of Economic life, in E.S. PHELPS (a cura di), Economic
justice, Penguin Education, Harmondsworth, 1973, p. 60
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 57
L’Italia, come abbiamo potuto costatare dalle attente e minuziose analisi fornite da
Fulvio Conti e Gianni Silei, Guido Crainz e Giulio Sapelli, non ha avuto, insieme alla
rivoluzione dei consumi e della produzione, l’evoluzione culturale che hanno avuto ad
esempio gli altri Stati europei. Il ritardo accumulato dal nostro Paese mette in evidenza i
limiti della costruzione del welfare state, ingessato da una politica ferma all’inflazione
politica di cui parlava Giorgio Ruffolo. Nel Rapporto sullo Stato Sociale 2011 questo
disagio è restituito così:
L’Italia come altri paesi dell’area mediterranea dell’Europa mostrano particolari difficoltà
[di fronte a questa nuova crisi mondiale] che affondano le loro origini nell’inadeguatezza
del sistema di Welfare che si è venuto a creare, con la sua caratteristica corporativistica e
sulla deresponsabilizzazione delle istituzioni che tendono a scaricare i problemi tipicamente
collettivi sulle famiglie e sull’individuo.75
Per questo motivo, è necessario ricorrere a un rilancio e a una riqualificazione del
cosiddetto Modello sociale Europeo fondato sui sistemi di welfare pubblici: ciò
potrebbe giocare un significativo ruolo propulsivo per una nuova stagione di benessere
collettivo che prenda atto delle quattro componenti della sostenibilità e cioè
istituzionale, economica, sociale ed ambientale.
Una rinnovata fiducia nel capitale umano consentirebbe alle società contemporanee di
ricalibrare il loro approccio dell’investimento sociale. Un investimento reso necessario
dalle critiche condizioni in cui verte l’Unione Europea, affinché si ritorni a coniugare
equità con efficienza, democrazia con sviluppo sostenibile e uguaglianza con coesione
sociale. Tutte queste caratteristiche erano alla base di quello Stato del benessere di
matrice europea, che la politica ha forse perso di vista.
Se la consapevolezza delle circostanze dimostrate nei capitoli di questa prova finale
guiderà le scelte dei governi e avverrà un progressivo rinnovamento di una collettività
più coesa e cosciente, la qualità del futuro che attende le attuali giovani generazioni di
cittadini potrà trarne beneficio.
75
F. R. PIZZUTI (a cura di), Rapporto sullo Stato Sociale 2011, Edizioni Simone,
Napoli, 2011, p.38
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 58
Bibliografia
AGNOLETTO Stefano, Nuovi paradigmi e nuove alleanze nell’età della
globalizzazione, in AGNOLETTO Stefano (a cura di), Pensare ed agire nell’età
della globalizzazione, Edizioni di Terrenuove, Milano, 2002
BARCA Fabrizio, Memoria politica dopo 16 mesi di governo,
http://www.fabriziobarca.it/un-partito-nuovo-per-un-buon-governo-fabrizio-barca/
BAUMAN Zygmunt, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone,
Laterza, Roma, 2001
BENASAYAG Miguel e SCHMIT Gerard, Les Passion tristes: souffrance
psychique et crise sociale, La Découverte, Paris, 2003
BRUNI Luigino e ZAMAGNI Stefano, Economia Civile. Efficienza, equità,
felicità pubblica, Il Mulino, Bologna, 2004
CAVAZZA Stefano e SCARPELLINI Emanuela, Il secolo dei consumi, Carocci
Editore, Roma, 2006
CODELUPPI Vanni, Il potere del consumo, Bollati Boringhieri, Torino, 2003
CONTI Fulvio e SILEI Gianni, Breve storia dello Stato sociale, Carocci, Roma,
2005
CRAINZ Guido, Il Paese reale, Donzelli Editore, Roma, 2013
DE LUCIA LUMENO Giuseppe, Un capitalismo senza eroi, in SAPELLI
Giulio, La crisi economica mondiale, Bollati Boringhieri, Torino, 2008
DEVOTO Giacomo e OLI Giancarlo, Vocabolario della Lingua Italiana 2011,
Le Monnier – Mondadori, Milano, 2011
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 59
FERRERA Maurizio, Modelli di solidarietà. Politica e riforme sociali nelle
democrazie, Il Mulino, Bologna, 1993
FUMAGALLI Andrea e MEZZADRA Sandro (a cura di), Crisi dell’economia globale,
mercati finanziari, lotte sociali e nuovi scenari politici, Ombrecorte, Verona, 2009
GALBRAITH John Kenneth, Storia Economica, BUR, Milano, 1990
HIRSCH Fred, I limiti sociali allo sviluppo, Bompiani, Milano, 2001
JACKSON Tim, Prosperità senza crescita. Economia per il pianeta reale, Edizioni
Ambiente, Milano, 2011
KEYNES John Maynard, Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della
moneta, Utet, Torino, 1978
KRUGMAN Paul, Il ritorno dell’economia della depressione, stiamo andando verso
un nuovo ’29?, Garzanti, Milano, 1999
LATOUCHE Serge, COCHET Yves, DUPUY Jean-Pierre e GEORGE Susan, Dove Va
il Mondo, Bollati Boringhieri, Torino, 2013
LOCKE John, Due trattati sul governo 1690, cit. in GILA Paolo, Capitalesimo, Bollati
Boringhieri, Torino, 2013
LORENZ Konrad, Gli otto peccati capitali della nostra civiltà, Adelphi, Milano, 1974
MAGATTI Mauro, La Grande Contrazione, Feltrinelli Editore, Milano, 2012
MARCOS SUBCOMANDANTE INSORTO, La saison de la digne rage, Climats,
Paris, 2009
MAZZETTE Antonietta e SGROI Emanuele, La metropoli consumata, Franco Angeli,
Milano, 2007
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 60
MONTANARI Franco, GI: Vocabolario della Lingua Greca, Loescher, Torino, 2004
MORRIS Charles R., Crack. Come siamo arrivati al collasso del mercato e cosa ci
riserva il futuro, Elliot, Roma, 2008
PIZZUTI Felice Roberto (a cura di), Rapporto sullo Stato Sociale 2011, Edizioni
Simone, Napoli, 2011
POLANYI Karl, La Grande Trasformazione, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1974
PROCACCI Giuliano, Storia del XX secolo, Milano, Mondadori Editore, 2000
PULCINI Elena, L’individuo senza passioni, Bollati Boringhieri, Torino, 2001
REVELLI Marco, Finale di partito, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2013
RUFFOLO Giorgio, La qualità sociale, Laterza, Roma, 1990
SALVADORI Massimo, Le inquietudini dell'uomo onnipotente, Laterza, Roma, 2003
SAPELLI Giulio, Modernizzazione senza sviluppo: il capitalismo secondo Pasolini,
Bruno Mondadori, Milano, 2005
SARACENO Chiara, Il Welfare: modelli e dilemmi della cittadinanza sociale, Il
Mulino, Bologna, 2013
SCALFARI Eugenio, Comincia il gioco dei quattro cantoni, in “la Repubblica”, 16
gennaio 1994
SERRES Michel, Tempo di Crisi, Bollati Boringhieri, Torino, 2010
VICKREY William Spencer, The goals of Economic life, in PHELPS Edmund Strother
(a cura di), Economic justice, Penguin Education, Harmondsworth, 1973
VIOLA Paolo, Il Novecento, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2000
Ascesa e Declino dello Stato Sociale - Andrea Sem Castelli 61
Sitografia
http://www.cattaneo.org/it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://tonto.eia.doe.gov/
http://data.bls.gov/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://elezionistorico.interno.it/
http://www.ohchr.org/
http://www.corriere.it/
http://www.attac.it/
http://www.census.gov
http://www.istat.it