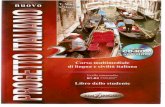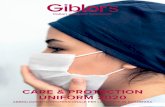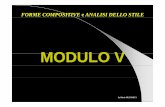Volti della campagna. Esperienza e scrittura dello spazio rurale in Tozzi
La responsabilità professionale dello psichiatra
Transcript of La responsabilità professionale dello psichiatra
La responsabilità professionale dellopsichiatra.
1.Alcune considerazioni introduttive: la terminologia delpenalista.
In base all’ordinamento italiano, la sussistenza diuna responsabilità penale in capo ad un individuopresuppone la realizzazione, da parte di costui:
1. di un fatto (consistente in un’azione od inun’omissione) corrispondente ad unafattispecie tipica, ossia ad una figura direato, prevista dalla legge penale, composta oda una semplice condotta o da una condotta edun evento, legati da un nesso causale (fattotipico);
2. di un fatto che oltre ad essere tipico, ossiain contrasto con l’ordinamento penale, siastato commesso in assenza di cause digiustificazione (fatto tipico e antigiuridico=contrarionon solo alla norma penale ma all’intero ordinamento.
3. di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole.La colpevolezza, necessaria alla sussistenza delreato ai sensi dell’art. 27, comma 1 Cost.(“La responsabilità penale è personale”, ossiacolpevole, secondo l’interpretazione costante)costituisce una nozione complessa. Essaconsiste in un giudizio di rimproverabilitàrivolto all’agente per il fatto tipico edantigiuridico realizzato, e richiede lapresenza, in capo al soggetto attivo,dell’imputabilità (ovvero, della capacità diintendere e volere), del dolo, della colpa odella preterintenzione (su cui v.
1
successivamente) e dell’assenza di cause diesclusione della colpevolezza (scusanti,errore sul fatto costituente reato e, inseguito alla sentenza C. Cost. n. 364/88,errore od ignoranza inevitabile della normapenale che prevede il fatto come reato).
Concentrando la nostra attenzione sui soli delitti,rileviamo, ex art. 42, comma 2, c.p., che “nessuno puòessere punito per un fatto previsto dalla legge comedelitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi didelitto preterintenzionale o colposo espressamenteprevisti dalla legge”. Ne discende che i delitti sono diregola puniti a titolo (soggettivo) di dolo, mentre idelitti preterintenzionali o colposi rappresentanoun’eccezione, che, in quanto tale, può essere sanzionataa condizione di una previsione espressa contenuta inun’apposita fattispecie legale.
La definizione degli elementi costituitivi del dolo edella colpa (il delitto preterintenzionale conta solo dueipotesi: l’omicidio preterintenzionale, che ex art. 584c.p., si verifica ove “chiunque, con atti diretti acommettere uno dei delitti preveduti dall’art. 581 –percosse- e dall’art. 582 –lesioni-, cagiona la morte diun uomo”, e l’aborto preterintenzionale, previstodall’art. 17, comma 2, l. n. 194/78, secondo cui “Lastessa pena” -la reclusione da tre mesi o due anni- “siapplica a chiunque provochi l’interruzione dellagravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alladonna”) è prevista dall’ 43 c.p., che al comma 1 cosìrecita: “il delitto è doloso, o secondo l’intenzione,quando l’evento dannoso o pericoloso da cui la legge fadipendere l’esistenza del reato, è dall’agente previsto evoluto come conseguenza della sua azione od omissione”.Tralasciando le oramai superate dispute dottrinali, sortein relazione all’oggetto del dolo (apparentementeconsistente nell’evento naturalistico; secondo laconcezione realistica dell’illecito penale, rappresentato
2
dall’evento in senso giuridico; ai sensidell’impostazione ora prevalente, esso è costituito dalfatto corrispondente alla fattispecie tipica, con leeccezioni previste al principio “ignorantia legis non excusat”indicate dalla già citata sentenza C. Cost. 364/88), perquanto concerne gli elementi costitutivi del più graveelemento soggettivo, esse richiedono la rappresentazionedi tutti gli elementi del fatto tipico (e non di quellidella corrispondente norma penale, a meno che, ex sent.C. Cost. n. 364/88, l’ignoranza/errore su di essi fosseinevitabile e quindi scusabile) e la loro volizione. Aseconda dell’intensità di quest’ultimo (rilevante ai finidella commisurazione della pena, ai sensi dell’art. 133,comma 2, n. 3), il dolo si distingue in intenzionale (nelcaso in cui il soggetto si rappresenti l’insieme di tuttigli elementi costitutivi del fatto ed agisca allo scopoprecipuo di realizzarli), diretto (il soggetto sirappresenta l’insieme degli elementi costitutivi delfatto e si rende conto che la sua condotta li realizzerà,incurante delle conseguenze accessorie necessariamente oassai probabilmente ad esso collegate – ai finiesplicativi,celebre è il caso del sig. Thomas di Bremache, nel 1875, per intascare il premiodell’assicurazione, suo scopo principale, fece esplodereun battello di sua proprietà, pur sapendo che tale eventoavrebbe quasi certamente provocato la morte dell’interoequipaggio -) o eventuale: figura, quest’ultima, assaiproblematica, al confine con la colpa cosciente. Nel doloeventuale il soggetto si rappresenta gli elementicostitutivi dell’intero fatto, ma non mira necessariamente allaloro realizzazione: l’elemento della volizione, criterioindispensabile ai fini della distinzione tra dolo ecolpa, è qui sostituito dall’accettazione del rischio dellaverificazione dell’evento, che egli prevede come possibile oprobabile (sul punto, v. il superato ma acceso dibattitodottrinale); nonostante tale previsione, il soggetto sidetermina ad agire, anche a costo di provocare il fatto
3
criminoso. Nella colpa cosciente o con previsione (per la qualela legge , ex art. 61, comma 2, n. 3, c.p. prevede unacircostanza aggravante comune), al contrario, il soggettoagente, pur rappresentandosi la possibilità/probabilitàdi verificazione del fatto, agisce con la certezza cheesso non si realizzerà.
Ex art. 43, comma 3, c.p., “il delitto è colposo, ocontro l’intenzione quando l’evento” (in ordine alladisputa del significato di tale nozione v. supra), “anchese previsto, non è voluto” (v., supra, la distinzione tra doloeventuale e colpa cosciente), “e si verifica pernegligenza, imprudenza o imperizia, o per l’inosservanzadi leggi, regolamenti, ordini o discipline. Il fattotipico colposo è dunque caratterizzato da una struttura“normativa”, sostanziandosi nell’inosservanza di regole dicondotta scritte (leggi, regolamenti, ordini, discipline:colpa specifica) o non scritte (negligenza, imprudenza oimperizia: colpa generica), elaborate in base al doppiocriterio della prevedibilità-evitabilità dell’eventolesivo. In altre parole, le regole in questioneindividuano condotte la cui adozione rende evitabilel’evento lesivo, e la cui violazione rende prevedibile laverificazione dello stesso.
Il giudizio di prevedibilità/evitabilità dell’eventoviene effettuato ex ante alla stregua del parametro oggettivoossia dall’agente modello che svolge la stessa professione,lo stesso mestiere, lo stesso ufficio, la stessaprofessione dell’agente reale. “Così” [MARINUCCI, La colpaper inosservanza di leggi, Milano, 1965, 194] “chi disponeregole sul tetto – anche se si tratta del padrone di casa– sarà giudicato col metro dell’operaio specializzato,esperto ed accorto, chi si pone alla guidadell’autoveicolo – anche se non è convenientementeaddestrato e non è in possesso della necessariaabilitazione – dovrà comportarsi come un espertoautomobilista: quel che conta, invero, è il fatto che una
4
persona abbia agito come ‘membro’ di un determinatogruppo sociale”.
In sede di colpevolezza, poi, al giudizio oggettivoconcernente l’inosservanza dei doveri precauzionali,effettuato alla stregua del parametro dell’homo eiusdemprofessionis ac condicionis (c.d. “misura oggettiva”), siaggiungerà la valutazione relativa all’attitudine del soggettoche ha concretamente agito ad uniformare il propriocomportamento alla regola di condotta violata. Tale accertamentodovrebbe tenere conto del livello individuale dicapacità, conoscenza ed esperienza del singolo agente(c.d. “misura soggettiva”). Il problema nasce però almomento di stabilire fino a che punto possa giungerel’esigenza di personalizzazione del giudizio dicolpevolezza colposa, rectius di quali caratteristicheindividuali dell’agente concreto sia possibile tenerconto al fine di escluderne la responsabilità, posto chegià lo standard oggettivo di diligenza etc. è ritagliato sudi un insieme di qualità personali, di cui l’agente sipresume dotato in quanto appartenente ad un determinatogruppo sociale. È infatti pacifico che se si pretendessedi tener conto di tutte le caratteristiche del soggetto,finiremmo col escludere sempre la responsabilità colposa,posto che le attitudini individuali dell’autorerenderebbero da lui inesigibile un comportamento diversoda quello effettivamente tenuto. Occorre dunque stabilirequali delle caratteristiche dell’agente concreto (ilpunctum dolens è rappresentato, nello specifico, dallecapacità intellettive) possano o meno rientrare nelladeterminazione della “misura soggettiva”.
Tornando al problema della “misura oggettiva” dellacolpa, si rileva come, non di rado, all’interno dellostessa categoria sociale/professionale di appartenenza,sia enucleabile una pluralità di agenti modello. Classico, atal proposito, è il caso rappresentato dalla professionemedica. In tale ipotesi, la misura della periziaoggettivamente richiesta nell’espletamento dell’attività
5
sanitaria è graduabile a seconda che il medico appartengaalla cerchia dei cattedratici, degli specialisti o deimedici generici. Sempre in tema di attività sanitaria, lagiurisprudenza tendeva a differenziare i presuppostidella responsabilità colposa a seconda della natura dellaregola precauzionale disattesa. Più precisamente, mentresi riteneva sufficiente a fondare la colpa medica unaminima violazione del dovere di diligenza od imprudenza,nel caso dell’imperizia la responsabilità venivaaffermata soltanto ove si trattasse di una manchevolezzagrave, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2236c.c., secondo il quale “il prestatore d’opera nonrisponde dei danni, se non nel caso di dolo o colpagrave” [Distinzione avallata dalla C. Cost., sent. n.166/73, seguita da Cass., sent. 10 aprile 1979]. Lamaggiore comprensione e “larghezza” manifestata nellavalutazione dell’imperizia si spiegava considerate leobiettive difficoltà da affrontarsi nell’ambitodell’attività medica (diagnosi complesse, interventioperatori rischiosi etc.) e l’esigenza di non inibirnetroppo l’operato gravandolo di eccessive cautele.
Senonché, anche ammettendo che si tratta di esigenzemeritevoli di considerazione, occorre per altro versoevitare il rischio che un pregiudiziale e aprioritarioabbassamento del grado di perizia esigibile dal medicocomporti una eccessiva indulgenza, con conseguentedisparità di trattamento rispetto ad altre categorieprofessionali. Si comprende così per quale motivo, negliultimi tempi, si sia andato sviluppandosi un diversoorientamento giurisprudenziale che, negando rilevanzaall’art. 2236 c.c. in sede di valutazione della colpapenale, sostiene che anche l’imperizia medica vadagiudicata in base agli stessi canoni applicabili allanegligenza ed all’imprudenza [Cass., sent. 18 dicembre1980].
Come si è affermato all’inizio del paragrafo, ove sitratti di un reato di evento (in campo medico, le
6
fattispecie che vengono in esame sono quelle degli artt.589 – omicidio colposo – e 590 – lesioni personalicolpose - ) la responsabilità sorge in capo al soggetto acondizione che tra la condotta e l’evento sussista unnesso di causalità. La condotta del medico assume per lopiù le vesti di un comportamento omissivo, con laconseguenza che la norma ad esso applicabile sarà quellaprevista dall’art. 40, comma 2 c.p.: “Non impedirel’evento che sia aveva l’obbligo giuridico di impedireequivale a cagionarlo”.
La disposizione dell’art. 40 cpv. c.p. dà adito a tredistinti ordini di problemi. Il primo riguarda la naturadella causalità omissiva, il secondo concerne il grado dicertezza esigibile in sede di accertamento del nessocausale ed il terzo sorge in ordine all’individuazione deisoggetti gravati dall’obbligo giuridico impeditivo.
1. In relazione alla prima delle due questioni vainnanzitutto precisato che nei reati omissivi d’evento(anche detti omissivi impropri, a differenza dei reatiomissivi propri, fattispecie di mera condotta, ocommissivi mediante omissione) non è possibileriscontrare un rapporto causale simile a quellosussistente nei reati commissivi. E non potrebbe esserediversamente: mentre nei reati commissivi si tratta distabilire un nesso di derivazione tra dati reali delmondo esterno (l’azione come dispiegamento di energiacausale ed il risultato dannoso), nelle fattispecieomissive il problema è verificare se ed in che modol’eventuale compimento dell’azione dovuta avrebbe incisosul corso degli accadimenti, in particolare evitando ilverificarsi dell’evento dannoso. Nei reati omissiviimpropri, l’accertamento del nesso causale presupponedunque un giudizio ipotetico o prognostico: il giudicesuppone come mentalmente verificata l’azione doverosaomessa e si chiede se, in sua presenza, l’evento lesivosarebbe venuto meno, utilizzando, quale criterio digiudizi, il modello della sussunzione sotto leggi causali. Così, per
7
accertare il nesso di condizionamento tra l’omissione delmedico del pronto soccorso che non ha praticatol’iniezione antitetanica e la morte di un feritoprovocata da un’infezione da tetano, occorre primaverificare l’esistenza di una legge scientifica cheasserisca che l’inoculazione del siero, a certe dosi,rende generalmente inattivo il focolaio infettivo.
Dopo aver individuato la “legge scientifica dicopertura”, in base alla quale è consentito affermare cheal verificarsi di determinati antecedenti, determinatieffetti vengono meno, si potrà comunque usare, come “testdi controllo”, la formula della condicio sine qua non, laquale, riferita all’illecito omissivo improprio, andràcosì articolata: l’omissione è causa dell’evento qualoranon possa essere mentalmente sostituita dall’azionedoverosa senza che l’evento venga meno. Nell’esempioproposto, l’omissione è “causale” se, sostituendomentalmente l’azione doverosa omessa con quella doverosa(l‘iniezione antitetanica), la morte del paziente causatadal tetano non si sarebbe verificata. Il nesso causaletra omissione ed evento viene qualificato col termine dirapporto di causalità ipotetica o normativa, per sottolineare che,in questo caso, non si è di fronte ad un nesso causalevero e proprio, bensì ad un suo equivalente, costruito aifini dell’imputazione al soggetto giuridicamenteobbligato ad impedire l’evento (c.d. garante).
2. a) Il secondo puntum dolens concerne il grado di certezzaraggiungibile in sede di accertamento della causalità omissiva. Atale proposito, parte della dottrina sottolinea come,trattandosi di un giudizio ipotetico, non si puòpretendere da esso lo stesso rigore richiestonell’accertamento del nesso di causalità attiva. Sarebbepertanto sufficiente, a tale scopo, in sede diapplicazione della formula della condicio sine qua non, chel’azione doverosa, ove compiuta, valga ad impedirel’evento con una probabilità vicina alla certezza. Una simileimpostazione, pur evidenziando che dai giudizi
8
prognostici esula ogni certezza prognostica.L’accertamento della causalità omissiva non dispensacomunque il giudice dal ricorso a criteri attendibili.D’altra parte, possono prospettarsi casi diresponsabilità omissiva in cui il giudizio prognosticosull’attitudine dell’azione doverosa ad impedire unevento non si accontenta di una “probabilità vicina allacertezza”: ad es., se una baby sitter lascia l’infante alei affidato a giocare da solo nei pressi di uno stagnodi un parco, ed il piccolo vi cade dentro morendoannegato, l’esercizio della sorveglianza, giuridicamentedoverosa ex art. 40 cpv. c.p. avrebbe senza alcun dubbioimpedito l’evento.
D’altra parte, la stessa tesi che riconduce laspiegazione relativa all’esistenza del nesso causale neireati commissivi alla sussistenza di leggi non solouniversali (rarissime) ma anche alle più frequenti leggistatistiche, fondate su diversi livelli probabilistici (enon assoluti) di verificazione dell’evento in conseguenzadi una determinata condotta (attiva), finisce perridimensionare grandemente la differenza, in tema dicertezza dell’accertamento, della causalità reale e diquella omissiva.
2. b) L’evoluzione registratasi sul terreno dellacausalità omissiva ha profondamente influenzato lagiurisprudenza, soprattutto in particolari settori, incui si assiste all’emergere di nuovi orientamentiall’interno di un quadro complessivo ancora incerto.
Il settore in cui tali sommovimenti appaiono maggioriè da quello della responsabilità medica. Se da un latoquesto è un campo nel quale non si possono pretenderecriteri di giudizio assolutamente certi, dall’altro latole aspettative di tutela dei beni primari in giocoappaiono estremamente elevate.
Ne consegue che la giurisprudenza a talvoltaaffermato la sussistenza di un nesso di causalitàomissiva anche nei casi in cui un intervento sanitario
9
corretto avrebbe soltanto aumentato le chances, di per sénon elevate di successo del trattamento dovuto. Aconferma di come, nella prassi applicativa, sia lapeculiarietà della materie trattata ad influenzare lalogica dell’accertamento causale, secondo una prospettivache confonde verifiche empiriche e giudizi di valore. Ilsettore dell’attività medico-chirurgica rientra in uno diquesti ambiti: in molti casi ad essi riconducibili,l’autorità giurisdizionale ha evitato di affrontare ilproblema della sussistenza del nesso causale, ritenendoloimplicito nella presenza della posizione di garanzia-obbligo di impedire l’evento- in capo al medico. In unacriticatissima sentenza, la mera esistenza dellaposizione di garanzia gravante sul sanitario è stataritenuta sufficiente per affermare, in via automatica, ilnesso causale tra omissione evento [Proprio in relazionealla morte di un malato mentale, Cass. 5 maggio 1988,pronuncia per fortuna isolata].
Nella maggior parte dei casi, tuttavia,l’accertamento del nesso causale non è apoditticamenteaffermato quale effetto dell’assunzione della posizionedi garanzia; tuttavia esso è ritenuto presente anchequando, in base a criteri statistico-probabilistici, leprobabilità di salvezza del paziente, ove il trattamentoomesso fosse stato effettuato, risultino medio-basse,assestabili persino sulla mera probabilità del 30% [Cass.12 luglio 1992]. Nuovamente, la ratio di un simile rigoreviene giustificata in base all’importanza dei valori dasalvaguardare, in primis la vita umana, la cui tutelaimplicherebbe il riconoscimento della causalità omissivaanche in presenza di scarse possibilità (è da notare comequest’ultima nozione, evocatrice di livelli più bassi diverificazione dell’evento, abbia sostituito il concettomeno incerto di probabilità) di successo dell’interventosanitario indebitamente omesso [Cass. 12 luglio 1991].
In altre ipotesi, più numerose, la giurisprudenza,pur rimanendo apparenza ancorata a leggi statistico-
10
probabilistiche, perviene artatamente ad un giudizio diresponsabilità a fronte dell’ “aumento del rischio”, o,peggio, della “mancata diminuzione del rischio” letale daparte del sanitario omittente. Il rapporto causale traomissione del medico ed evento letale che colpisce ilpaziente viene, in sostanza, affermato in base ad un merogiudizio prognostico, formulato ex ante, con buona paceregole basilari che disciplinano l’accertamento del nessodi causalità, in primis la necessità (a differenza di quantoavviene per il tentativo, in cui l’evento, par definition,non si verifica, proprio perché il delitto non perviene aconsumazione) della formulazione di un giudizio ex post [v.Cass., 19 aprile 1983].
La dimostrazione che la giurisprudenza, sul punto,appare ancora lontana da un definitivo assestamento, siveda Cass., 28 settembre 2000, che afferma l’esigenza diaffermare il nesso di causalità omissiva nei soli casi incui il corretto intervento del medico avrebbe impedito“con una probabilità vicina alla certezza” il verificarsidell’evento. La tendenza a ripudiare, almeno a livello diaffermazione di principio, il criteriodell’aumento/mancata diminuzione del rischio, ed arecuperare un livello di maggior rigore in sededell’accertamento della causalità in sensocondizionalistico, si è manifestata in alcune sentenzedel 2000 in maniera quasi “estremistica”, arrivando arichiedere, ai fini del riconoscimento del nesso causale,coefficienti vicini a 100, in riferimento sia allaprobabilità statistica sia a quella logica. Tuttavia,l’espressione sinora più meditata del sopracitatoorientamento è rappresentata dalla sentenza dellaCassazione Sez. Unite del luglio 2002, relativa al caso“Franzese”, che prospetta un equilibrato bilanciamentotra probabilità statistica e probabilità logica,ritenendo decisivo non tanto il maggiore o minorecoefficiente di idoneità dell’azione doverosa omessa adimpedire l’evento lesivo, in base a quanto affermato
11
dalla legge probabilistica in questione, quanto laprobabilità di escludere con pratica certezza l’influenzanella linea causale di fattori condizionanti diversidalla condotta dell’imputato.
3. Veniamo infine all’ultima questione, avvicinandocial tema più specificatamente oggetto del dibattito,ovvero al contenuto dell’obbligo di impedire l’eventolesivo (commesso dal paziente a danno di sé od altri)dicui è titolare, specificatamente, il medico psichiatra.In termini succinti, ci si chiede se lo psichiatra possadirsi gravato di un potere-dovere di controllodisciplinare nei confronti dei pazienti soggetti alla suaosservazione, e, nel caso di risposta affermativa, se siaipotizzabile che l’imposizione al medico di un’attivitàdi controllo finisca per ostacolare il correttosvolgimento di quella più propriamente terapeutica.
A differenza del mero “controllo sociale”, terminecon cui si indica la funzione di mediazione tra spintesociali contrapposte e di mantenimento di un adeguatolivello di omeostasi sociale, che è di fatto presente inogni istituzione, qualunque sia il suo scopo primario, il“controllo sociale disciplinare” costituisce il fineessenziale delle c.d. “istituzioni totali”, per usare untermine caro a Foucault, che esse esercitano con modalitàche possono giungere, ove necessario, alla costrizionefisica. In ogni società tale compito è svolto dal sistemapenal-penitenziario, che ne delega abitualmente quote asistemi ausiliari (ad es., quello di polizia).
In Italia, fino all’emanazione della l. n. 180 del1978, l’intervento nei confronti del sofferente psichicoera regolato dalla l. n. 36 del 1904, e dal regolamentoemanato con r.d. 16 agosto 1909 n. 615. I trattifondamentali della legge (confermati dai suoi riflessipenalistico-amministrativi di cui agli artt. 714-717 c.p.ed all’art. 153 t.u.l.p.s.) delineavano una visione dellamalattia mentale concepita non tanto quale una forma disofferenza personale e soggettiva, quanto, al contrario,
12
come un problema di ordine pubblico, da fronteggiarsi construmenti di polizia. L’infermo di mente rappresentava,in primo luogo, un soggetto “pericoloso a sé ed aglialtri”, insostenibile fonte di “pubblico scandalo”, edunque meritevole di un’unica modalità di trattamento,coercitivo ed intramurario. Il ricovero ospedaliero permotivi psichiatrici, quale effetto di una richiestavolontaria, non era previsto, a conferma dellaprevalenza, sull’interesse alla cura del paziente stesso,del più rilevante interesse facente capo al corposociale. L’accento non cadeva pertanto sul dirittodell’infermo ad essere curato, con conseguenteattenuazione della proprie difficoltà, quanto, piuttosto,sulla necessità di tutelare il corpo sociale daglieventuali comportamenti lesivi e/o aggressivi che ilsofferente psichico avrebbe potuto, anche soloeventualmente, porre in essere.
Per contro, la normativa attualmente in vigore è orarappresentata dalla l. n. 180/78 e da alcune parti dellal. 833/78. Il sistema che emerge dal quadro di talidisposizioni si fonda su principi antitetici a quellisottesi alla legislazione previgente. Il sofferentepsichico è riconosciuto come titolare dal diritto allapropria cura, con conseguente volontarietà deitrattamenti sanitari cui venga sottoposto. L’adozione diun Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) è previstocome extrema ratio, a fronte della comprovataimpraticabilità delle altre soluzioni. Dispongonoespressamente gli artt. 1, comma 5 l. n. 180/78 e 33,comma 5, l. n. 833/78 che i TSO “devono essereaccompagnati da iniziative rivolte ad assicurare ilconsenso e la partecipazione di chi vi è obbligato”. Eancor più restrittive sono le condizioni che permettonodi applicare il TSO per malattia mentale in situazioni didegenza ospedaliera. Insomma, la legislazione del 1978, adifferenza dalla normativa precedentemente in vigore,privilegia un intervento improntato alla tutela della
13
salute mentale. Un’ulteriore conferma di tale ratio, voltaad eliminare la costante equivalenza tra disturbopsichico e fonte di pericolo per l’ordine pubblico èrappresentata dall’abrogazione, successiva all’entrata invigore delle leggi del 1978, delle disposizioni delcodice penale espressamente finalizzate al controllo dipolizia dell’infermo di mente, vale a dire degli artt.714-717 c.p.
Alla luce nella normativa del 1978, il contenutodell’obbligo di garanzia gravante sul medico psichiatraappare profondamente mutato. Le indicazioni legislativeprivilegiano chiaramente il diritto alla curadell’infermo di mente, facendo sorgere in capoall’operatore sanitario il corrispondente obbligo diadottare iniziative affinché il paziente acquisisca unacrescente capacità di autodeterminazione ed unacorrispondente responsabilizzazione. È questo l’aspettoche rappresenta, in misura maggiore, la “novità” delledisposizioni in questione. Esperienze consolidate edampiamente dibattute hanno chiarito come le soluzionivolte ad assicurare una sistematica “protezione”, una“tutela ad oltranza” del paziente psichiatrico producanoin lui una regressione psichica, un peggioramento deldisturbo, ed abbiano pertanto un valore decisamente anti-terapeutico, al pari delle ideologie e delle prassi disistematica deresponsabilizzazione del soggetto edell’attribuzione di comportamenti socialmenteinaccettabili (se non, addirittura, penalmente rilevanti)non al paziente in quanto persona, ma alla sua malattia.Ne discende che provvedimenti coercitivi (il ricoveroospedaliero forzoso, ovvero, anche in assenza diricovero, l’adozione di trattamenti sanitari di generesostanzialmente inibitivi), se, da un lato, impedisconol’eventuale azione contra ius del paziente, dall’altro,conseguono tale risultato al prezzo di una sua ulterioreregressione psichica, e quindi di un futuro e maggiore
14
rischio di condotte, da parte sua, proprio del tipo diquelle che si voleva evitare.
Non vi è dubbio, tuttavia, che in una situazione incui il paziente stia ponendo in essere una condotta“pericolosa a sé ed agli altri” (per riprendere lalocuzione contenuta nella legge del 1904), e quindi, conogni probabilità, dotata di rilevanza penale, è compitodello psichiatra porre in essere modalitàdissuasivo/impedienti, sempre nei limiti della suacapacità di agire. Ma si può d’altronde affermare che unintervento di tal genere gravi, se non come doveregiuridico, quanto meno come dovere etico e di solidarietàsociale, su ogni cittadino, di fronte ad comportamentisocialmente inaccettabili posti in essere da chiunque,ancorché non affetto da turbe psichiche.
Il problema tocca qui due aspetti, necessariamentecollegati. Il primo concerne la questione se competa allopsichiatra un dovere specifico e particolare, diverso daquello che genericamente incombe su quisque e populo neiconfronti altrui, di impedire comportamenti antigiuridicidel malato mentale. Il secondo aspetto coinvolge unaquestione più pratica, ossia se l’obbligo impeditivodello psichiatra debba essere osservato non solo nellaconcreta immediatezza e fattualità del comportamentolesivo od autolesivo del paziente, ma anche nel caso incui vi sia la “possibilità”/ “probabilità” che talecondotta si realizzi nel futuro.
4. Siamo così tornati al punto di partenza dellanostra analisi, in particolare ai problemi chesoggiacciono alle nozioni di prevedibilità/evitabilitàdell’evento (le regole utilizzate della migliorscienza/esperienza per la formazione delle regolecautelari la cui inosservanza dà luogo allaresponsabilità colposa) e, soprattutto, alla questioneconcernente i criteri di accertamento della causalitàomissiva.
15
4. a) In molti campi clinici la colpa medica è stataaffermata non più in base all’opinione soggettiva delsingolo esperto, bensì in base a quella ampia più ampia èsolida dell’intera comunità degli esperti, ricavando i igiudizi dal dalla bibliografia scientifica piùaccreditata e dalle guidelines espresse dalle comunitàscientifiche degli specialisti, quest’ultime, a lorovolta basate sui risultati di grandi studi diepidemiologia clinica (la c.d. E.B.M., Epivedence BasedMedicine = medicina basata su prove di efficacia). Ilrisultato ottenuto è stato senz’altro positivo negliambiti clinici ove le procedure sono abbastanzastandardizzate, come ad esempio nel campo dell’anestesiae della rianimazione, ma ha sollevato una serie di altriproblemi là dove il trattamento sanitario debba o possadiscostarsi dalle linee guida per vari ragioni, tra cuila volontà del paziente, la particolarità dellasituazione od anche per la formazione culturale epratica del medico stesso, in condizioni cliniche in cuivari aspetti sono consentiti in assenza di uno cheprevalga nettamente sull‘altro in relazione alleaspettative di successo in base agli studi epidemiologicial momento disponibili.
La psichiatria rientra certamente in uno di questicampi, e nonostante un notevole sforzo clinico-scientifico volto ad una standardizzazione dei criteridiagnostici ed un avvicinamento delle diverse scuolenelle impostazioni terapeutiche di base, si è ancoramolto lontani da questo obiettivo, e numerosi scontri sirilevano tra correnti di pensiero relative a cometrattare i singoli casi e sulle cautele e le eventualimisure di contenzione da adottare di fronte ad un rischiodi suicidio od etero-aggressività. Quest’ultimo aspetto,tipico della psichiatria, rappresenta una delle questionipiù delicate che sorgono in ordine alla presenza didoveri e diritti tra loro apparentemente antitetici:l’obbligo di curare il paziente nel miglior modo
16
possibile (punto sul quale manca un accordo inpsichiatria), e il diritto, costituzionalmente garantito,del paziente, di accettare liberamente il trattamentoproposto, dopo aver ottenuto un’adeguata informazionerelativa alle alternative eventualmente praticabili.
La questione si è ulteriormente complicata a frontedella previsione, sia da parte della normativa italianaquanto da parte di quella tedesca, francese e di moltialtri paesi occidentali, di un dovere, sussistente incapo allo psichiatra, non finalizzato soltanto ad uncorretto adempimento della prestazione professionalesotto il profilo tecnico, ma anche, in aggiunta, di undovere generale di protezione del paziente, avente peroggetto l’intera sfera giuridica della sua persona equindi, tra i suoi diritti ed interessi, in primis dellasua integrità fisica. Simili concetti, applicati apazienti psichiatrici con rischio di auto/etero-aggressività creano il problema di fino a che punto ilmedico possa e debba spingersi nell’adozione di misurelimitative della libertà del paziente senza chequest’ultime vengano serenamente discusse e concordatecon quest’ultimo, a fronte di un suo difetto dicomprendere la situazione e di assumere decisioniconsapevoli proprio a causa del disturbo mentale in atto.
È evidente che un’interpretazione lata del dovere diprotezione comporterebbe il rischio di un eccesso disorveglianza nei confronti del paziente, e l’attivazione,nei suoi confronti, di un ipertrofico apparato sanitariocon una pesante impronta interventista. Il checomporterebbe un’inaccettabile limitazione della libertàe dell’autonomia del malato, in palese contrasto con imoderni indirizzi di trattamento psichiatrico. Se,infatti, il medico, soprattutto in ambito pubblico,dovesse essere chiamato a rispondere di un mancatotrattamento (ad es., di tipo farmacologico), in tutti icasi in cui era a ritenersi a priori che fosse meramentepossibile il compimento, da parte del paziente di azioni
17
dannose “a sé od ad altri” (cfr. l. n. 36/1904), nederiverebbero, per ovvie ragioni di prudenza (volte adevitare ogni attribuzione di responsabilità, civile openale), una valanga di interventi aventi come unicoscopo l’autotutela del sanitario, con buona pace delleesigenze di salute del malato, che, come si è detto inprecedenza, andrebbe incolpevolmente incontro adun’inevitabile regressione psichica. D’altra parte taleindirizzo, volto a gravare il medico di un dovereconfinante con un obbligo di controllo di stampo“custodialistico”, finirebbe per riproporre, sottomentite spoglie, la funzione dello psichiatra-guardianodei malati in funzione di difesa sociale, che avevacaratterizzato la posizione dell’operatore della salutementale sotto il vigore della l. n. 36 del 1904, ormairipudiata non solo in ambito scientifico e clinico, ma,in primis, sotto il profilo normativo.
4.b) Per quanto concerne il secondo quesito, relativoall’accertamento del nesso causale, inteso come“probabilità”, o la “possibilità”, che l’evento auto odetero-aggressivo sia realizzato da parte del paziente inassenza del doveroso intervento del medico, occorre tenerconto del fatto che nella pratica psichiatrica non èaffatto infrequente che una persona con un disturbopsichico manifesti propositi minacciosi nei confronti diun’altra. Addirittura, questo atteggiamento minatorio nonè appannaggio esclusivo dei soggetti psichicamentedisturbati: ogni persona, anche se immune daproblematiche di tal genere, necessita, quale via disfogo delle tensioni aggressive, di esprimere, medianteun comportamento fattualmente innocuo e socialmenteaccettabile, minacce che sono in genere consapevolmentedestinate a rimanere a livello di formulazione verbale.Ma anche quando tali minacce provengano da un soggettopsichicamente disturbato, non è esigibile, da parte dellopsichiatra, l’adozione di comportamenti maggiormenteimpeditivi. Innanzitutto, perché si correrebbe il rischio
18
di disporre complessi ed onerosi provvedimenti perfronteggiare manifestazioni puramente verbali destinatepoi a rivelarsi come “falsi allarmi”. In secondo luogo,perché questi stessi provvedimenti, che l’opinionepubblica - e la maggior parte dei giudici – ritiene ingrado di evitare, in tali circostanze, condotte lesive dibeni giuridici tutelati, risultano tutt’altro checostantemente efficaci. Questi provvedimenti sisostanziano, secondo la communis opinio, nel ricoverocoattivo e nel ricorso ad un trattamento farmacologico,ovvero nel suo incremento, ove questo sia già in atto.Tuttavia, l’esperienza dimostra come l’uso di sistemi dicontrollo, anche dei più sofisticati, non si sia maidimostrata sufficiente ad impedire del tutto icomportamenti auto od etero-aggressivi da parte di chi èristretto.
5. Ma il vero problema che si pone allo psichiatra,al di là di quelli sopra delineati, in presenza dellaprobabilità/possibilità che il paziente commetta fattipenalmente rilevanti, riguarda il conflitto tra un suopossibile comportamento repressivo, adottato in funzionepreventiva/impeditiva di tali fatti, da un lato, ed ilcomportamento propriamente terapeutico, dall’altro. Sulsignificato attribuibile alla nozione di “terapeutico” leposizioni non sempre coincidono; ma l’elemento comunealle diverse letture del termine è quello che riconosceun simile valore ad ogni atto diretto ad attenuare lasofferenza dell’individuo affetto da un disturbopsichico. E, come si è detto in precedenza, lasovrapposizione di un atteggiamento eterodirettivo, adopera dello psichiatra, alle istanze diautodeterminazione del paziente, sebbene ispirata daapprezzabili fini di tutela di beni giuridici penalmenterilevanti, assume un preciso valore antiterapeutico.
Lo psichiatra appare così preso tra due fuochi: da unlato, la pressione sociale pretende l’adozione di unsistematico atteggiamento preventivo o repressivo, di un
19
vero e proprio controllo disciplinare, nei confronti dicondotte realizzabili dal sofferente psichico,potenzialmente lesive nei confronti di interessigiuridicamente tutelati; dall’altro lato, la stessadisciplina normativa, impone allo psichiatra losvolgimento di una funzione terapeutica, che configura ilTSO come soluzione estrema, ed il TSO in condizioni didegenza ospedaliera come provvedimento del tuttoeccezionale e che prevede, quand’anche esso siaapplicato, l’adozione di “iniziative rivolte adassicurare il consenso e la partecipazione da parte dichi vi è obbligato” e che impone alla struttura sanitariapubblica di attivarsi “per ridurre il ricorso ai suddettiTSO” (art. 35, comma 5, l. n. 833/78). Il medico risultapertanto destinatario di un doppio ed antiteticomessaggio: da una parte una richiesta di prevenzione, dicura e di riabilitazione dei disturbi psichici, daattuarsi mediante il minor ricorso possibile aitrattamenti coattivi, specialmente intramurari;dall’altra un obbligo di impedire che la personaaffidatagli ponga in essere comportamenti auto odeteroaggressivi.
2. La giurisprudenza in tema di responsabilità dellopsichiatra per le azioni violente compiute dal paziente.
Tra le pronunce giurisprudenziali in materia, siricorda la sentenza del tribunale di Cagliari del 21novembre 1989, che riassume compiutamente leproblematiche maggiormente ricorrenti in questi casi. Sitratta di un procedimento penale per omicidio colposoinstaurato nei confronti di un medico psichiatra cheaveva disposto il ricovero, in una casa di cura privata,di un paziente affetto da sindrome neurodepressiva. Ilpaziente, collocato in una stanza del secondo piano lecui finestre erano prive di protezioni, si era suicidato
20
buttandosi da una di esse. Il medico era stato condannatoa titolo di omicidio colposo, per non aver adempiuto, acausa di negligenza ed imprudenza, il dovere di custodianei confronti del malato. La corte di appello, consentenza 9 aprile 191, aveva tuttavia riformato ladecisione di primo grado ed aveva assolto l’imputato, nonriscontrando nei suoi confronti una colpa grave a frontedelle difficoltà di trattamento del malato e della nonprevedibilità del suo comportamento ed interpretando ilcontenuto del dovere di custodia nei confronti delpaziente, non più considerato, come nel periodomanicomiale, un soggetto da “custodire”, bensì visto comeuna persona ancora libera e autonoma, ancorché bisognosadi assistenza, su cui non era lecito applicare sistemi dicontenzione o ricoveramento coatto al fine di conseguireuna riduzione del danno derivante dall’eventosuicidiario.
Notevole rilievo presenta anche la sentenza dellaCorte di Cassazione, Sez. IV, 1 luglio 1987, che annullauna pronuncia di condanna a titolo di omicidio colposodella Corte di Appello di Perugia nei confronti di unmedico psichiatra che aveva omesso di disporre un TSO diun soggetto affetto da schizofrenia che avevasuccessivamente ucciso la propria madre. I genitori delmalato, nei giorni precedenti al fattosi erano rivolti alservizio locale di igiene mentale per ottenere ilricovero coatto del figlio, fortemente disturbato. Ilfiglio però rifiutava di farsi visitare dallo psichiatradel servizio pubblico; quest’ultimo consigliava aigenitori di temporeggiare, sperando in una spontaneaattenuazione del fenomeno patologico che consentisse almedico un approccio terapeutico accettato dal paziente.L’omicidio della madre ed il grave ferimento del padreerano avvenuti due giorni dopo. In primo grado, l’autoremateriale del fatto era stato prosciolto dall’imputazionedi omicidio colposo per vizio totale di mente, ed ilmedico, dall’imputazione di concorso in omicidio colposo
21
per insussistenza del fatto (il non aver disposto il TSOnon costituisce violazione di una regola di prudenza ediligenza). La Corte d’Appello aveva invece ritenutosussistente, in capo allo psichiatra, una responsabilitàpenale a titolo di omicidio colposo e lo aveva condannatoa 6 mesi di reclusione. Fu quest’ultima sentenza a subirel’annullamento da parte della Cassazione, che ritenne perlo psichiatra insussistente l’obbligo giuridico diproporre un TSO, essendo la scelta di disporre taletrattamento ampiamente discrezionale, rappresentandoquesto “l’ultima ratio” tra le ipotesi di trattamentosanitario applicabili al paziente ex l. 180 e 833 del1978. Tuttavia, la decisione della Cassazione presta ilfianco ad una obiezione. Vero è, come ha rilevato laSuprema Corte, che si era di fronte, in quest’ipotesi, aduna situazione-limite, estremamente complessa, in cui ilsanitario appariva preso tra due fuochi: da un lato, lacomplessità di una valutazione circa l’opportunità“terapeutica” di un ricovero coattivo; dall’altro,un’analoga difficoltà di formulare il giudizio relativoall’efficacia di un trattamento alternativo: ove ilpaziente rifiutasse l’anamnesi medica, in base a qualipresupposti imporre una cura farmacologica volta abloccarne l’aggressività? Le affermazioni effettuatedalla Corte di Appello di Perugia, cadute di fronte aglistrali della Cassazione, tradiscono una visione“eticizzante” del diritto penale: “In una situazione diquesto genere tutto si può fare meno che rimanere inertiad attendere gli eventi”. Ma questo è, in realtà, il veropunctum dolens del problema, esente dalle venaturemoralistiche che caratterizzano le affermazioni dellaCorte di Appello. Se un comportamento penalmenterilevante è stato realizzato, da parte del medico che hadilazionato, senza neppur procedere ad una visita, ilricovero, esso potrebbe ricondursi non tanto alla colpa,ed al concorso in omicidio o lesioni, quanto al dolo,assumendole vesti della fattispecie di cui all’art. 328
22
c.p., omissione di atti di ufficio. Qui si concentra ildisvalore sanzionabile della condotta dello psichiatra:nel fatto di aver negato il TSO in assenza di unavalutazione medica in grado di fornire i presupposti perla (ampiamente discrezionale) decisione.
Il tribunale di Perugia si è successivamente resoprotagonista di un’altra vicenda che, per certi versi,ricorda la precedente, salvo per alcuni e più drammaticiparticolari. Come nell’ipotesi sopra esaminata, lamalattia mentale di un figlio sfocia nel matricidio: ma,a differenza di quanto accade nella prima ipotesi, in cuiil solo autore materiale dell’uccisione della madre e delferimento del padre presentava disturbi mentali, inquesto secondo caso tutti e quattro i componenti del medesimonucleo familiare risultavano “affetti da turbe psichichetali da renderli incapaci di provvedere a se stessi”[così Tribunale di Perugia, 20 ottobre 1986, in Foro it.,II, 1988, 108]. Al medico responsabile del Centro diigiene mentale, il Tribunale rimprovera di aver omessoalcun genere di intervento, pur essendo consapevole dellostato di incapacità, provocato dal disturbo psichico, incui versavano i componenti della famiglia. Tuttavia, daifatti riportati in sentenza emerge he il Cim si eraoccupato della madre, ritenuta affetta da sindromeparanoidea, ma il trattamento cui la donna si era sottoposta era stato interrotto a causa dell’opposizione deglialtri familiari, ostili fino al punto da creare unasituazione di “estremo rischio di natura implosiva”. Glioperatori sanitari avevano pertanto, delle turbe mentalidi cui il marito ed i figli erano affetti, una conoscenzameramente ufficiosa, non avendo mai preso in cura alcunodi essi, né avendo ricevuto alcuna richiesta in talsenso.
I problemi che nascono caso in esame appaiono dunquedi duplice natura. Da un lato, la questione investenuovamente l’individuazione dei presupposti che rendonoobbligatorio il trattamento; dall’altro, la
23
riconducibilità o meno della sua mancata adozione ad una(quale?) fattispecie penale.
Sotto il primo profilo, l’obbligo di interventocurativo scatta in capo al medico psichiatraogniqualvolta il malato stesso lo richieda; al di fuoridi quest’ipotesi, ossia qualora il soggetto affetto daturbe mentali rifiuti le cure, il potere/dovere diapplicarvi un TSO sorge dove sia il sindaco, con un suoprovvedimento autoritativo, a disporlo, ovvero dietroun’esplicita richiesta di un familiare o di un altrosoggetto interessato. Ciò premesso, si ricordi che laratio della riforma del 1978 configura il ricorso al TSOcome l’ultima ratio trattamentale, e ne subordinal’applicazione al rispetto del principio diautodeterminazione del paziente; d’altra parte sarebbeper lo meno grottesco immaginare, a carico dei medici deiservizi di salute mentale, un obbligo di “rastrellare” lecittà alla ricerca di soggetti mentalmente disturbati“pericolosi a sé ed agli altri” da internare. Ledifficoltà nascono in quei casi-limite, simili a quellodi specie, in cui l’operatore sanitario, senza esserestato espressamente interpellato, viene in qualche modo aconoscenza di una situazione di “estremo rischio dinatura implosiva”. Avrà egli il dovere di attivarsi, perevitare l’esplosione (rectius, implosione) di folliaomicida, o, in alternativa, di richiedere lacollaborazione della forza pubblica, istituzionalmentedeputata all’adozione di provvedimenti fisicamentecoercitivi? La risposta ad un simile interrogativo ècondizionata dall’interpretazione relativa al ruolo (e,di conseguenza, alle facoltà ed agli obblighi) chel’attuale normativa attribuisce allo psichiatra. Inproposito, l’unico riferimento normativo è quello di cuiall’art. 35, commi 5 e 7, l. 833/78, che impone alsanitario il dovere di comunicare al sindaco lasopravvenuta impossibilità di proseguire il TSO, doverela cui violazione può dar luogo, ove ne ricorrano tutti i
24
presupposti, all’applicazione dell’art. 328 c.p. neiconfronti del medico inadempiente. La legge richiedesolamente che il sindaco, a sua volta, dia notizia ditale comunicazione al giudice tutelare, senza esigereespressamente, da parte dell’autorità amministrativa,l’emanazione di provvedimenti finalizzati allaprosecuzione, anche coattiva, del trattamento.
Il secondo problema concerne l’applicabilità o meno,a carico del medico responsabile del Cim, dell’art. 591c.p., che dispone: “Chiunque abbandona una persona minoredegli anni quattordici, ovvero una persona incapace, permalattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa,di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere lacura, è punito dalla reclusione dai sei mesi ai cinqueanni” [corsivi nostri]. Aggiunge il terzo comma: “la penaè della reclusione da uno a sei anni se se dal fattoderiva una lesione personale (582), ed è da tre ad ottoanni se ne deriva la morte”. Alla base dellaresponsabilità dell’autore, afferma parte della dottrina,si configurebbe, in sostanza, una posizione di garanzia(rectius: di protezione), che, a differenza dell’istitutoelaborato in relazione dell’art. 40 cpv. c.p., e la cuiapplicazione altri Autori limitano ai reati omissivid’evento (tali nella loro forma pura, e non aggravata:l’art. 591 c.p. prevede l’evento consistente nellelesioni o nella morte soltanto quali ipotesi aggravanti),sorgerebbe non in capo a soggetti determinati, magraverebbe su chiunque. E, a fortiori, tra i soggetti attividi tale illecito, può ben collocarsi il medico, in quantotitolare di doveri terapeutici. Le difficoltà nascono almomento di individuare la fonte dell’obbligo diprotezione. Gli obblighi di garanzia ex art. 40, comma 2c.p., devono possedere una fonte giuridica, tra cui ladottrina annovera pacificamente un “contrattoterapeutico” (anche atecnicamente inteso): il chepresuppone che tra medico e paziente tale vicolo
25
giuridico sia ancora attuale, al pari del rapporto diconcreto affidamento che lega il secondo al primo.
A tale proposito si rendono necessarie dueprecisazioni. I “classici” soggetti passivi indicatinell’art. 591 c.p. sono rappresentati da un minore dianni quattordici (incapace di intendere e di volere pardefinition) e da un soggetto incapace per vecchiaia (siaccenna, tra le righe, ad i disturbi mentali che possonoinsorgere in questa fase della vita, quali la demenzasenile, l’alzheimer – solo per citare qualche esempionoto a quisque e populo –scemando grandemente od azzerandotali facoltà)
Per contro, qualora tale vincolo giuridico-fattualesia venuto meno (come nel caso de quo, in cui la signoraaveva inizialmente scelto di affidarsi alle cure dal Cim,per poi interrompere, sempre volontariamente –prescindendo dalle motivazioni sottese a tale più o meno“libera” decisione –, il trattamento curativo), il medicorisulta sollevato dalla posizione di garanzia neiconfronti della (ex) paziente, né il suo comportamentopuò configurare “l’abbandono” di cui all’art. 591 c.p.Secondo un’autorevole dottrina, lo psichiatra nonrisulterebbe immune dal rimprovero penale, essendo inogni caso configurabile, nei suoi confronti, lafattispecie prevista dall’art. 328 c.p., omissione d’attid’ufficio.
Più recente è la pronuncia della Corte diCassazione, Sez. IV, 12 gennaio-12 aprile 2005 n. 13241,che tratta il caso di un paziente sotto TSO, affetto daun riacutizzarsi di una grave forma depressiva, che avevagià in precedenza tentato il suicidio e manifestavaintenzioni suicidiarie attuali, il quale, nella notte, siera impiccato in bagno con un lenzuolo tagliato astrisce. Dall’accusa di omicidio colposo per omissionem, ilprimario del reparto ed il medico di guardia furono inprimo grado assolti, ed in appello condannati per non
26
aver fornito al personale infermieristico e sanitarioidonee e dettagliate istruzioni circa la necessità di unastretta sorveglianza di quel determinato paziente, stanteil rischio di un suo suicidio. Più precisamente, affermala Corte, “indiscutibilmente, essendo il pazientesoggetto a trattamento sanitario obbligatorio, esiste laposizione di garanzia a carico dei medici dellastruttura, in quanto l’art. 34, comma 4, della Legge883/78 stabilisce le condizioni in presenza delle quali èconsentito il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale;che costituisce extrema ratio, privilegiandosi il trattamento volontario;disponendosi tale trattamento da parte della competenteautorità amministrativa, si può prevedere che le curevengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistanoalterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici che nonvengano accettati dall’infermo e non vi siano le condizioni e le circostanzeche consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarieextraospedaliere (art. 34, comma 4, L. 833/78). In quali casi,dunque, si deroga al volontarismo che ha ispirato lalegge 180/78 in ordine alla libertà di cure, è consentitala limitazione della libertà personale a tutela delpaziente stesso (e in via riflessa anche di terzi), etale tutela, a fronte di una situazione di gravitàestrema e di mancata collaborazione del soggetto che nonaderisca ad un trattamento volontario, non può che noneffettuarsi che attraverso la custodia del soggetto, e se del caso anchedella contenzione. In sostanza, se un soggetto, in stato di gravealterazione psichica, accetta di sottoporsi ad un trattamento volontario, nonè suscettibile di coercizione, né conseguentemente può sorgere un obbligo dicustodia nei confronti di un soggetto al quale nulla può essere imposto[corsivi nostri].
L’impostazione della Cassazione, così rispettosa delvolontarismo che ispira la riforma del ’78, e delprincipio del TSO come ultima ratio tra i trattamentiadottabili nei confronti del sofferente psichico, non hamancato tuttavia di suscitare alcune critiche. Partedella dottrina ritiene infatti che il dovere di cura del
27
paziente ed i doveri di protezione che ne derivanopermettano l’adozione di provvedimenti limitativi dellalibertà personale ove sia necessario prevenirne azioniviolente danno a proprio od altrui, a prescindere dalnomen iuris attribuito al trattamento cui egli (si) èassoggettato (quindi anche al di fuori del range entro ilquale il TSO è consentito). Questa soluzione discende dadue ordini di considerazioni. In primo luogo, a frontedell’esistenza di zone di confine fra i due regimi (ilvolontario e l’obbligatorio) i cui limiti non sononettamente definiti (di fatto, il TSO non è sempreadottato nei confronti di tutti i soggetti che sitrovano nelle condizioni che consentano di ricorrervi).Ed inoltre, l’applicazione della norma di parte generaledi cui all’art. 54 c.p., disciplinante l’esimente dello“Stato di necessità”, potrebbe di per sé sola fondarel’esistenza di un obbligo di garanzia, penalmenterilevante, in capo ai medici psichiatri/operatori dellasalute psichica (i c.d. “garanti”) che imponga/consental’adozione di uno speciale regime di custodia esorveglianza nei confronti di soggetti altri, rispetto aquelli individuati dall’art. 34, comma 4, l. 833 del1978, ma comunque incapaci di badare a se stessi per unostato contingente di grave turba mentale.
28