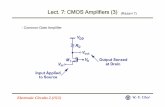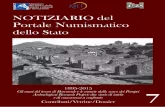analisis kelengkapan resep pasien anak usia 0-7 tahun di ...
"Il caso inglese", in Crisi e tramonto dello Stato moderno, a cura di Laura Barletta e Giuseppe...
Transcript of "Il caso inglese", in Crisi e tramonto dello Stato moderno, a cura di Laura Barletta e Giuseppe...
CRISI E TRAMONTODELLO STATO MODERNO
a cura di
LAURA BARLETTA
GIUSEPPE GALASSO
Università degli Studidella Repubblica di San MarinoSCUOLA SUPERIORE DI STUDI STORICI
San Marino, Antico Monastero Santa Chiara28-30 ottobre 2010
DSS
nntico Monastero Santa Chiara00010
Lorena Barale e Andrea Volonnino hanno collaborato al lavoro redazionaleper la preparazione di questo volume
Scuola Superiore di Studi StoriciUniversità degli Studi della Repubblica di San MarinoContrada Omerelli, 20 - 47890 Repubblica di San Marino
[email protected] - www.unirsm.sm/dss
ISBN 978-88-907837-7-7
Tutti i diritti riservati
241
IL CASO INGLESE
GUIDO ABBATTISTA
Due quesiti molto impegnativi si trovano al centro del tema che verrà affrontato nelle pagine seguenti.
Il primo riguarda l’esistenza o meno nell’Europa moderna di un mo-dello unico e generalizzabile di “Stato di antico regime” nel quale possa essere fatta rientrare anche l’Inghilterra del ‘700 e, di conseguenza, se sia possibile per quest’ultima individuare elementi di “crisi” e “tramonto” riconducibili a un fenomeno più generalmente europeo piuttosto che a specificità insulari riscontrabili anche nelle forme e negli assetti dello Stato. D’altra parte, a rigore non si dovrebbe parlare di un caso “inglese”, a proposito di crisi degli Stati europei di antico regime. La ragione è molto semplice. Ciò che può restituire il senso e le proporzioni di una fase tardo-settecentesca di crisi nella storia dello Stato monarchico-par-lamentare della Gran Bretagna è la sua dimensione non semplicemente inglese, ma, appunto, “britannica”, “imperiale” (o “neo-imperiale”, dato che la storiografia “imperiale” propriamente detta ha un lungo pedigree risalente alla seconda metà dell’Ottocento), o anche, come la storiografia più recente preferisce dire, “arcipelagica” e “atlantica”.
Rispondere a queste due domande è molto impegnativo, perché si-gnifica fare i conti con la “exploding galaxy”1 della storiografia anglofona che da un lato continua a muoversi nel solco delle “master-narratives”, le grandi sintesi consolidate (spesso incorporate in grandi iniziative edi-toriali2) dovute ai nomi di George M. Trevelyan, Basil Williams, John
1 P. J. CORFIELD, British History: the Exploding Galaxy, «Journal for Eighteenth-Century Studies», 34, 4, 2011, pp. 517-526.
2 I volumi d’anteguerra di Trevelyan, i due volumi di Williams e Watson per la Oxford History of England (Clarendon Press, Oxford 1939 e 1960), quello di Langford per la New Oxford History of England (Clarendon Press, Oxford 1989), la serie della Pelican History of England coi volumetti di Jack Plumb e di David Thomson sul Settecento e Ottocento (Hunt Barnard Printing, Aylesbury 1950), alla Penguin Social History of Britain: English Society in the Eighteenth Century di Roy Porter (1982), le serie di Cambridge University Press, per esempio la Cambridge Economic History of
Guido Abbattista
242
Steven Watson o le interpretazioni influenti come quelle di Lewis Na-mier e Herbert Butterfield (che, senza scrivere alcuna sintesi, hanno però lasciato una traccia profonda e duratura sull’interpretazione dell’Inghil-terra settecentesca), e dall’altro ha conosciuto negli anni potenti spinte di rinnovamento grazie ai lavori di storici come E. P. Thompson, Eric Hobsbawm, John R. Plumb, John Kenyon, Roy Porter, Paul Langford, Frank O’Gorman, John Brewer, Linda Colley, J. C. D. Clark (un elenco certamente difettoso). In un panorama per nulla fissato una volta per tutte si continuano a ripensare e re-interpretare originalmente i più si-gnificativi passaggi-chiave della storia nazionale tra fine Seicento e inizio Ottocento – la “rivoluzione gloriosa”, la “rivoluzione industriale”, la “ri-forma parlamentare”, la “rivoluzione commerciale e dei consumi”: temi sui quali, soprattutto sullo scorcio del XX secolo, si è registrata notevole vivacità e capacità di rimettere in discussione interpretazioni, paradigmi, periodizzazioni. L’interpretazione del Settecento britannico, insomma, è un terreno controverso e il pendolo interpretativo non smette di oscil-lare. Le categorie utilizzate per la sua lettura – età augustea, stabilità politica, consenso, “deference”, oligarchia, “patronage”, corruzione (“old corruption”), partito politico, indifferenza religiosa, secolarizzazione, “politeness”, modernizzazione, capitalismo, industrializzazione, “making of the working class”, nazionalità e nazionalismo – e le periodizzazioni proposte – essenzialmente le visioni di un “corto” (1715-1783) e di un “lungo” Settecento (1688-1815 o 1832) – sono materia di una discussio-ne che non sembra dare segni di stanchezza. Purtuttavia, come si vedrà, sul finire degli anni 2000 ci troviamo di fronte a quella che non sarebbe esagerato, per la Gran Bretagna del Settecento, definire una interpreta-zione condivisa e dominante, un vero e proprio paradigma ruotante con varietà di accenti sull’idea dell’ “eccezionalità” o “unicità” del caso britan-nico nel contesto europeo, pur con qualche non trascurabile correzione o addirittura eccezione.
A questo riguardo forse è utile assumere un punto di partenza ester-
Modern Britain (il primo volume, curato da Roderick Floud e Paul Johnson sull’industrializzazione, 1760-1800, apparso nel 2004) e la Cambridge Social History of Britain (i tre volumi curati da F. M. L. Thompson sul periodo 1750-1950 sono del 1990), ma anche le parti dedicate al mondo bri-tannico nella New Cambridge Modern History (i volumi dal 6 al 9, che coprono il Settecento, sono usciti tra il 1965, i due sul periodo più tardo, e il 1996, quando è uscito a cura di J. O. Lindsay il vol. 7 dedicato espressamente all’Old Regime 1713-1763).
Il caso inglese
243
no al dibattito anglofono e non del tutto convenzionale, interrogandoci su quanto ancora valido sia ciò che di crisi dell’antico regime in Inghil-terra scrisse Franco Venturi nei voll. III e IV (1979 e 1984) di Settecento riformatore e se quelle pagine non abbiano per caso già detto l’essenziale in materia. Anticipiamo subito che la risposta dovrebbe essere almeno parzialmente negativa3.
Le pagine venturiane hanno illustrato con grande efficacia come i problemi di stabilità politica in Inghilterra furono percepiti in Italia tra fine anni ‘70 e primi anni ’80 del Settecento e come l’opinione pubblica della penisola potesse dare una lettura “continentale” delle agitazioni nel mondo britannico: tutti elementi che Venturi utilizzava per dare corpo a un’idea di crisi generale dei sistemi politico-sociali di antico regime. Rilette a distanza di un trentennio, quelle pagine colpiscono per alcuni elementi di indiscutibile modernità. Tanto la prima crisi dell’antico regi-me, tra gli anni ‘60 e ‘70, quanto la crisi “definitiva”, che Venturi vedeva innescata dall’indipendenza americana a metà anni ‘70, venivano colte, individuate, localizzate «nelle forme più inattese e sorprendenti, ai mar-gini degli Stati e degli imperi tradizionali». Venturi sapeva cioè guardare sia alle periferie dei grandi Stati continentali nel cuore dell’Europa sia alle loro propaggini imperiali e coloniali, fornendo un’indicazione che certamente lui stesso non sviluppò né forse avrebbe avuto intenzione o interesse a sviluppare oltre certi limiti, ma che si sarebbe rivelata gravida di conseguenze storiografiche: l’indicazione, cioè, della necessità di rein-tegrare la dimensione e l’esperienza imperial-coloniale nella narrazione della storia dei maggiori Stati europei, delle loro dinamiche, della loro evoluzione e trasformazione dal tardo Settecento in avanti. Solo a questa condizione, infatti, come vedremo, acquista un senso preciso fare riferi-mento a una “crisi dell’antico regime” nel mondo britannico.
Eppure ci sono alcuni aspetti generali dell’idea venturiana di “crisi dell’antico regime” che difficilmente possono applicarsi al caso inglese: il ruolo degli intellettuali e la tempistica delle riforme. Ciò che sta al centro dell’interpretazione di Venturi della crisi è il rapporto tra la storia politica, gli aspetti politico-finanziari e il pensiero e il ruolo politico degli intellettuali, o il ruolo riformatore degli intellettuali dove esso poté trova-
3 F. VENTURI, Settecento riformatore, vol. 3, La prima crisi dell’antico regime (1768-1776), Einaudi, Tori-no 1979, pp. 381-443, e vol. 4, t. I, La caduta dell’Antico Regime. I grandi Stati dell’Occidente, Einaudi, Torino 1984, pp. 146-202.
Guido Abbattista
244
re spazio di azione. Una simile prospettiva applicata al mondo britannico porta poco lontano. I motivi, gli aspetti, il significato della crisi vanno cercati altrove che nel ruolo o nell’elaborazione teorica e ideologica de-gli intellettuali. La politica nel mondo britannico rivelò altresì elementi di sterilità, di incapacità a fronteggiare sviluppi inediti, ma la risposta fu soprattutto politica, cioè di movimenti politici, di una cultura politica diffusa (radicalismo, movimento per la riforma del suffragio, in seguito movimenti per la libertà economica), che poté sostanzialmente trovare sbocco nelle forme e nelle istituzioni della monarchia parlamentare, cer-tamente mettendone in evidenza limiti e rigidità, ma non provocandone un significativo indebolimento, e men che meno la disintegrazione. La stagione di riforme che ne derivò, inoltre, – e che indubbiamente anche la Gran Bretagna conobbe – avvenne dopo e non prima il periodo delle guerre rivoluzionarie e napoleoniche, presentando una sfasatura rispetto alle scansioni della storia continentale che rimandano a una profonda di-versità delle dinamiche economico-sociali interne e dei soggetti politici.
Il quadro cambia significativamente solo se allarghiamo l’osservazio-ne a una prospettiva “imperiale”, che includa cioè il mondo coloniale nord-americano e l’Irlanda: solo in questi contesti troviamo situazioni in cui le istituzioni monarchico-imperiali si rivelarono completamente incapaci di risolvere situazioni di crisi acuta, nel primo caso subendo una guerra civile, una sconfitta militare e la frattura del “primo impero coloniale”; nel secondo adottando soluzioni di carattere non duraturo e incapaci di eliminare alla radice le ragioni dei conflitti civili, economici e religiosi. Nel caso britannico, insomma, se di “decline and fall of the old regime” si può parlare, ciò è possibile solo entro le particolari coordinate di uno Stato imperiale non paragonabile al resto della situazione euro-pea e che quella crisi subì acutamente solo nelle sue dimensioni specifi-camente imperiali, ma con una singolare capacità di ricompattamento al centro, con l’avvio di una fase di riforme capaci di assorbire spinte indub-biamente dal potenziale disgregante, e, al tempo stesso, con un ampio sforzo di riconversione-ricostruzione imperiale nell’emisfero asiatico tale da consentire al paese di emergere alla fine degli anni ’30 dell’Ottocento con un indiscusso primato economico e politico mondiale.
A suo tempo, in particolare dopo l’apparizione della traduzione ame-
Il caso inglese
245
ricana dei citati volumi di Settecento riformatore4 ad opera di R. Burr Litch-field, da parte anglo-americana furono mosse riserve e critiche piuttosto estese all’idea stessa di «crisi generale dell’antico regime»5. D’altra parte, non era, quella di Venturi, una maniera scontata di porre il problema delle forme e modi della crisi di uno Stato come quello britannico tar-do-settecentesco. Non lo era perché, a ben vedere, nonostante i primi appelli (1975) di John Pocock, a Venturi ben noti6, ancora doveva ini-ziare e dare i suoi frutti maturi la stagione della “new British history”, caratterizzata dal ripensamento e dalla riscrittura della storia britannica su scala non insulare e neppure solo europea o imperiale, ma semmai neo-imperiale, arcipelagica e atlantica. E perché, comunque, la più con-solidata tradizione storiografica inglese e britannica non forniva chiavi di lettura della storia politica dell’ultimo quarto di secolo compatibili o del tutto coincidenti con il modo con cui Venturi trattava il problema. Sicché non si va lontano dal vero a dire che quella di Venturi fu una intu-izione storiografica, che da un lato si rivelava perfino in anticipo rispetto agli sviluppi storiografici dalla metà degli anni ‘80 in poi, e, dall’altro, si dimostrava anche recettiva rispetto alla proposta interpretativa dello storico americano Robert R. Palmer nel suo The Age of the Democratic Revolutions (1959 e 1964)7, opera che godette di una stagione di cele-brità e di consenso, per poi perdere di centralità e di mordente. Perché, cosa sosteneva quella storiografia tradizionale, espressione con la quale possiamo riferirci a due correnti totalmente opposte della storiografia britannica del ‘900, ossia la corrente mainstream del whiggismo storio-grafico simboleggiato da George M. Trevelyan, e quella revisionista e dissacrante riconducibile a Namier?
4 The End of the Old Regime in Europe, vol. 1, The First Crisis, Princeton University Press, Princeton 1989 e vol. 2, The End of the Old Regime in Europe, 1776-1789, Part I: The Great States of the West, Princeton University Press, Princeton 1991.
5 L. A. TILLY, Review of Settecento riformatore by Franco Venturi, «The American Historical Review», 86, 2, 1981, pp. 419-420; J. BLACK, Refractions in an Italian eye, «Times Higher Education Supple-ment», 960, 29 March 1991, ID., Ancien Regime and Enlightenment. Some recent writings on 17th and 18th century Europe, «European History Quarterly», 22, 1992, pp. 247-55, R. BURR LITCHFIELD, Franco Venturi’s ‘crisis’ of the Old Regime, «Journal of Modern Italian Studies», 10, 2, 2005, pp. 234-244; J. ROBERTSON, Franco Venturi’s Enlightenment, «Past & Present», 137, 1992, pp. 183-206.
6 F. VENTURI, Settecento riformatore: III. La prima crisi dell’Antico regime (1768-1776), Einaudi, Torino 1979, p. 381.
7 R. R. PALMER, The Age of the Democratic Revolutions. A Political History of Europe and America, 1760-1800, vol. 1. The Challenge, Princeton University Press, Princeton 1959, e vol. 2: The Struggle, Princeton University Press, Princeton 1964.
Guido Abbattista
246
Trevelyan, per quanto di più articolato e di più decisamente whig possa aver scritto nei suoi lavori storici ante-I guerra mondiale, dagli anni ‘20, cioè dalla grande sintesi sulla Gran Bretagna del XIX secolo, era divenuto un convinto assertore dell’eccezionalismo inglese, “celebrant of English exceptionalism” lo ha definito David Cannadine8. Né in questo era certo uno storico isolato in Europa, se si pensa a quanto sostenuto da Elie Halévy nell’Angleterre en 1815, primo volume della sua Histoire du peuple anglais au XIXe siècle (1919-1932, 6 voll.), ossia che l’Inghilterra al principio dell’800 presentava uno scenario unico ed eccezionale ri-spetto al resto d’Europa in quanto paese già modernizzato all’insegna della libertà politica e civile. Un punto di vista che ha avuto largo seguito anche presso una storiografia comparatista non inglese, come nel caso di François Crouzet9.
In cosa consisteva questo eccezionalismo? Nel fatto che l’Inghilterra, il suo popolo, la sua cultura, col suo spiccato “genio per la politica”, le sue classi dirigenti appartenenti a entrambi i maggiori partiti, avevano saputo assicurare al paese un ordinato svolgimento negli anni tormentosi tra la vigilia della rivoluzione francese, le guerre napoleoniche e l’evento che di quello sviluppo aveva rappresentato l’apoteosi, seppur temporanea: il “Great Reform Act” del 1832. La Gran Bretagna era diversa da tutti gli altri Stati europei tra Settecento e Ottocento per aver sempre saputo co-niugare “liberty and order”. Per parafrasare il citato Crouzet, è, sì, esistito un English ancien régime coi suoi abusi e i suoi conflitti, solo che le forze capaci di produrre equilibrio erano superiori a quelle tendenti a spinge-re verso una dissoluzione; c’era una evoluzione relativamente ordinata verso un modello di governo libero capace di garantire le libertà; non c’era conflitto tra nobiltà e borghesia su questioni riguardanti i privilegi nobiliari (scarsamente esistenti); non c’erano ordini sociali cristallizzati e la mobilità sociale era reale; non c’era una piccola nobiltà impoverita e arrogante; né una classe intellettuale declassata alla ricerca di rivalsa; non ci fu crisi agraria; le classi agricole non erano composte da coltivatori im-poveriti dal peso delle tasse, delle esazioni feudali e delle decime; la vita culturale non risentì dell’invadenza clericale e della censura; non ci fu crisi finanziaria come quella che fece detonare la rivoluzione in Francia.
8 D. CANNADINE, G. M. Trevelyan: a Life in History, HarperCollins Publishers, London 1992, p. 108.9 F. CROUZET, Britain Ascendant: Comparative Studies in Franco-British Economic History, Cambridge
University Press, Cambridge 1990 (ed. or. francese, 1985), p. 262 sgg.
Il caso inglese
247
Si potrebbe aggiungere che un quadro del genere è confermato dalle testimonianze dei viaggiatori stranieri nell’Inghilterra del secondo Sette-cento, le immagini trasmesse dai quali non sembrano certo essere quella di un paese in difficoltà o, peggio, in crisi o con gravi sintomi di crisi. Tali immagini contrastano significativamente, anzi, nell’inevitabile confronto coi paesi continentali di appartenenza di quei testimoni. Vincenzio Mar-tinelli, per esempio, a metà secolo evidenziava le peculiarità di un origi-nale sistema istituzionale misto capace di garantire la libertà, l’assenza di mali radicati come la venalità delle cariche o la feudalità e le giurisdizioni feudali, parlava di un paese giunto a condizioni di grande “felicità” grazie a condizioni di libertà politica e civile, manifestava il suo apprezzamen-to per la classe dirigente inglese costituita da una aristocrazia politica compatta, solida, impegnata – che tra l’altro aveva munificamente sot-toscritto la sua Istoria critica della vita civile – da una educazione pubblica alimentata da un’editoria fiorente e dalla libertà di circolazione dei libri e della stampa in generale. Non diversa era stata l’impressione di Alfieri, registrata nella Vita, in occasione del viaggio inglese compiuto nel 1768.
Si trattava certo di una visione ottimistica, legata anche ad un modo particolare di osservazione della realtà britannica che certamente non tutti condividevano, se è vero che altri osservatori davano in quegli stessi anni una rappresentazione assai più conflittuale e problematica delle condizioni interne della monarchia inglese. Henry Lloyd, per esempio, alla fine degli anni ‘60 offriva a Pietro Verri una raffigurazione allarmata dell’Inghilterra come di un paese sull’orlo della guerra civile, con la costi-tuzione sotto scacco e la classe parlamentare corrotta. Ma da qui, da una rappresentazione chiaramente influenzata dal clamore del caso Wilkes e dagli inizi della crisi con le colonie nordamericane, a parlare di una crisi sistemica dell’antico regime inglese ce ne correva. E infatti Alfieri, per esempio, notava con ammirazione la prosperità, l’attivismo, il “be-nessere universale”, il “moto perenne di denaro e d’industria” all’interno della capitale e delle province di quel “fortunato e libero paese”, grazie addirittura agli “effetti divini” della costituzione. E lo stesso Wilkes, du-rante la sua permanenza in Italia a metà anni ‘60, benché personalmente colpito da provvedimenti giudiziari emessi dalle autorità britanniche, di fronte alle condizioni delle città e della società italiane, non mancava di rimpiangere il suo paese d’origine. Le notazioni che emergevano occa-sionalmente sulle gazzette italiane potevano anche registrare una certa asprezza di conflitti in Inghilterra e talvolta presentare la situazione in
Guido Abbattista
248
termini drammatici (la libertà vacillante, il patriottismo estinto, il Parla-mento attaccato come strumento della tirannide di un pugno di politici, le diseguaglianze sempre più pesanti, il debito pubblico fuori controllo, le colonie vittime di crescente oppressione, la libertà a rischio di degene-rare in potere assoluto della monarchia), ma sarebbe un errore prendere le eco giunte nelle pagine delle gazzette italiane – peraltro spesso viziate da cattive traduzioni dall’inglese e da scarsa consuetudine col sistema politico e costituzionale britannico – come sintomi attendibili di una reale crisi sistemica.
È certamente vero che alla fine degli anni ‘60 le vicende di Wilkes e il movimento “Wilkes and Liberty” crearono in Inghilterra un clima di aspra contestazione, senza precedenti dopo la Gloriosa, diretto contro i fondamenti stessi della costituzione, specie il Parlamento. Si era cioè in piena nascita del movimento radicale e di richiesta di riforma della rappresentanza: qualcosa sicuramente di più profondo di quanto non fossero state precedenti crisi legate a proteste fiscali, come la “Excise crisis” nel 1733, o a rigurgiti proto-nazionalistici come le reazioni antiministeriali di segno antispagnolo del 1739, ma ancora tutto sommato ben lungi dal configurare una crisi sistemica radicata in un conflitto tra società e istituzioni. Anzi, l’esistenza stessa in seno all’agitazione radicale di movimenti in difesa della libertà di stampa, di forme di partecipazione politica allargata, di diretto coinvolgimento popolare in grandi questioni a carattere nazionale come il caso Wilkes, testimoniava in fondo, anche in presenza di turbamenti dell’ordine pubblico e di corrispondenti forme di repressione, delle condizioni di salute di una società non ingessata e non intimorita dalle nuove realtà politiche e capace di trovare internamente le risorse per correggere atti d’arbitrio o esempi di corruzione e degenerazione illiberale. Insomma, ciò che attestava come l’Inghilterra non si trovasse in una fase storica di declino istituzionale e sociale era non il fatto che fossero assenti quei rischi di involuzione illiberale da cui nessun governo libero è immune una volta per tutte, bensì il fatto che la società fosse internamente provvista dei mezzi per far loro fronte in nome della libertà e preservando le tutele della legge e che addirittura fosse capace di generare nuove forme di partecipazione capaci di far progredire quella libertà politica verso nuovi e più avanzati assetti.
La storiografia anglofona corrente descrive perciò la società inglese di fine ‘700 servendosi di espressioni e immagini come quelle di un “polite and commercial people”, della “opulence and glory” di un paese pieno
Il caso inglese
249
di fiducia in se stesso dopo le vittorie militari della guerra dei Sette Anni e nonostante la sconfitta americana (le cui conseguenze economiche e politico-strategiche furono minime, certamente inferiori a quelle “d’im-magine”), nel quale le indubbie preoccupazioni per il debito pubblico post-bellico e il peso fiscale erano ampiamente bilanciati dalla vitalità commerciale, dall’entusiasmo generato dai progressi tecnologici, dall’atti-vismo e dal compiacimento degli uomini d’affari, dal fervore associativo e di iniziative in campo scientifico e tecnologico e dalla sensazione che i primi progressi industriali fossero più portatori di benefici che di incon-venienti e degni di elogio più che di critiche. La “happy constitution” era ancora largamente venerata come capace di garantire la solidarietà tra il “propertied public” e il Parlamento, e il Parlamento stesso continuava ad essere sentito come sostanzialmente ricettivo della mentalità, della cultura e della sensibilità della “middle-class”10.
A questo proposito – sempre per cercare di capire quale significato e applicazione possa avere la categoria di antico regime nel caso britan-nico – va notato anche come in Inghilterra, nel linguaggio sia politico sia storiografico, non ci sia stata una adozione generale o scontata della categoria di “antico regime” per convogliare il senso di un cambiamento radicale rispetto a un passato avvertito come essenzialmente diverso. In ciò ha certamente influito la matrice francese dell’idea di antico regime con il suo carico di allusioni rivoluzionarie (anche se nelle Reflections di Edmund Burke si trovano frequentemente impiegate espressioni come “old establishments”, “system of old governments”, “old prejudices and habits”). La storiografia anglofona ha tardivamente applicato l’espressio-ne ancien régime all’Inghilterra sei-settecentesca, probabilmente perché l’espressione è stata sentita più pertinente alla situazione europeo-con-tinentale che a quella britannica, della quale si è preferito individuare altre scansioni e altre periodizzazioni, e affermare la peculiarità, se non l’ “eccezionalità” di condizioni.
Questo non significa affatto che il linguaggio politico e la tradizione storiografica, soprattutto quella whig, non abbiano fatto uso di espressio-ni rivolte a segnare le discontinuità tra il mondo ottocentesco da quello del secolo precedente. La politica e la storiografia whig, per esempio,
10 P. LANGFORD, A Polite and Commercial People, 1727-1783, New Oxford History of England, vol. 1, Clarendon Press, Oxford 1989.
Guido Abbattista
250
pur nel culto della continuità e della stabilità, hanno sempre espresso il senso di un processo di modernizzazione, di passaggio dal vecchio al nuovo che si sarebbe compiuto nell’economia, nella società, nelle for-me della politica, a cavallo tra Settecento e Ottocento: solo che ne ha evidenziato le modalità all’insegna della continuità istituzionale di fon-do, l’astensione dalle rotture violente, la capacità di auto-riforma della società e delle istituzioni. Già nel linguaggio giornalistico dell’epoca del “Reform Act” del 1832, per esempio, era abituale riferirsi all’ “old system” o all’ “unreformed parliament” (o “electorate”)11. E uno storico come Tre-velyan parla di “vecchio mondo”, “vecchia Inghilterra”, “vecchio sistema economico”, “vecchio sistema economico e sociale” e “vecchio modo di governo”, soprattutto per sottolineare la separazione tra il vecchio mon-do rurale e quello nuovo prodotto dalle trasformazioni industriali, tra il dominio dell’aristocrazia terriera e l’avvento delle classi medie urbane, tra l’oligarchia parlamentare e municipale del Settecento e il sistema post-riforma parlamentare: una discontinuità, quest’ultima, tra il mondo pre- e post-riforma parlamentare che prima che dalla storiografia è stata ben espressa dai termini più forti e polemici della politica, come “old Corruption”. Dunque, se guardiamo alla sostanza, l’idea di una società ancora largamente rurale, dominata da una grande aristocrazia terriera e da una oligarchia politica e confessionale, ossia influenzata dal conformi-smo religioso, che potremmo anche definire convenzionalmente antico regime, non è affatto estranea alla politica e alla storiografia britanniche, soprattutto quelle che hanno accreditato l’idea di un più o meno gra-duale tramonto di quel tipo di società a partire dalla data simbolica del 1832. Ciò che varia è piuttosto l’interpretazione di aspetti particolari: ossia, quali sono stati gli elementi che più hanno contrassegnato quell’an-tico regime: la religione e le istituzioni religiose, concezioni politiche tra-dizionali, filo dinastiche e filo monarchiche, una organizzazione sociale basata sulla deferenza? E che peso hanno avuto, invece, gli elementi altrettanto indubbi di modernizzazione economica, sociale, politica e culturale? E che grado di somiglianza hanno presentato quegli aspetti rispetto alla situazione dell’Europa continentale ? E di che genere di crisi possiamo parlare quando facciamo riferimento ad alcuni fondamentali snodi soprattutto nel secondo Settecento?
11 E. J. EVANS, The Great Reform Act of 1832 (Methuen, London 1983, 2nd ed. 1994).
Il caso inglese
251
Se diamo uno sguardo alle partizioni cronologiche oggi consolidate, troviamo che l’idea implicita o esplicita di un antico regime inglese o bri-tannico, della sua evoluzione interna e delle sue crisi successive si manife-sta in alcune fondamentali scansioni relative sia al lungo sia al medio pe-riodo. La prima scansione, oggi sostanzialmente accettata, è quella di un «long eighteenth century»12. In base a questa periodizzazione, il termine a quo è convenzionalmente identificato con il 1688: è con la “Gloriosa” che si fissano i parametri costituzionali e politici che reggeranno il paese per i successivi centocinquanta anni. Il secondo estremo cronologico è il 1832, o meglio la fase tra la fine degli anni ‘20 e i primi anni ‘30, quando cambiano alcuni dei punti fermi della vita istituzionale britannica di an-tico regime con riferimento agli assetti religiosi e parlamentari. Tra le va-rie ulteriori scansioni cronologiche che potremmo indicare, alcune sono rilevanti proprio in relazione all’identificazione dei ritmi di evoluzione sociale e politica dell’antico regime inglese (o britannico). Una vede nel 1760, o nel 1763, un punto di svolta, dato dal cambiamento di clima politico all’inizio del nuovo regno di Giorgio III, dai prodromi della crisi americana e da una ripresa di instabilità politica accompagnata da forte attività extraparlamentare. Una seconda scansione è data dal 1780-84, con lo slancio del movimento extraparlamentare per la riforma elettorale e la protesta irlandese fino all’indipendenza parlamentare dell’Irlanda, la sconfitta nella guerra americana, la caduta del governo North e l’instabi-lità politica cessata solo con l’avvento al potere di William Pitt il Giovane nel 1784. Una terza scansione è ovviamente data dal periodo 1793-1815, con la partecipazione alle guerre rivoluzionarie, la grande ripresa trasversale di sentimento patriottico e filo-monarchico e il temporaneo affievolimento della protesta radicale, che riprenderà dopo il 1815, a pace conclusa. Infine, naturalmente, gli anni 1815-1832, culminanti con il “Great Reform Act”. Se dunque di crisi dell’antico regime in Inghilterra si può parlare, essa deve essere vista e interpretata sullo sfondo di queste articolazioni temporali che rimandano a ritmi evolutivi profondamente
12 L’introduzione di questa espressione si deve a J. C. D. CLARK, English Society 1688-1832: Ideology, Social Structure and Political Practice During the Ancien Regime, Cambridge University Press, Cambridge 1984; per la sua entrata nell’uso corrente v. poi F. O’GORMAN, The Long Eighteenth Century: British Political and Social History, 1688-1832 (The Arnold History of Britain), London 1997 (repr. Hodder Arnold, London; Oxford University Press, New York 2007); v. anche P. BAINES, The Long Eighteenth Century, Arnold, London 2004.
Guido Abbattista
252
diversi da quelli dell’Europa continentale e ai quali hanno contribuito anche quei grandi mutamenti economico-sociali che in genere guardano al 1760 come al decennio di avvio delle grandi trasformazioni degli as-setti produttivi, ma anche delle forme della politica pubblica. Sicché non manca una visione complessiva e unitaria del periodo 1783-1846, dalla sconfitta nella guerra americana alla riforma delle Corn Laws, come un periodo di grande turbolenza interna, causata dalle conseguenze sociali dell’urbanizzazione e dell’industrializzazione, dalle difficoltà finanziarie legate alle guerre continentali, dal timore del contagio rivoluzionario: una turbolenza, però, che sarebbe stata positivamente riassorbita dalle vittorie militari e da una serie di iniziative riformiste in campo religioso, economico e politico che, dalla fine degli anni ’20 alla metà degli anni ’40, avrebbero prodotto una vera “crisis of the old order” ritardata rispet-to alla tempistica continentale13.
Può essere istruttivo tornare a Venturi. Venturi aveva correttamente individuato il principale sintomo della crisi del vecchio ordine nella crisi e nella rottura definitiva tra Gran Bretagna e mondo nordamericano. Del resto, se non ama l’espressione antico regime, dalle risonanze troppo autocritiche e contrarie a un’idea di continuità, la storiografia imperiale britannica ha parlato di “First British Empire” proprio per indicare quel sistema di assetti economici, legislativi e politico-istituzionali che entrò in crisi nel 1776. Non c’è dubbio in effetti che la prima, vera crisi dell’antico regime in Gran Bretagna fu la rivoluzione americana. Il suo antico regi-me era non tanto o non solo all’interno del paese, ma alla sua periferia, nelle colonie, anzi, per essere precisi, nei rapporti con quelle colonie, nel contrasto insanabile tra due società e due culture che si erano divaricate profondamente a causa di un complesso di regolamentazioni commer-ciali e di rapporti politici non certo statici né applicati con rigidità, ma sempre meno compatibili con la realtà di fatto. Madrepatria e colonie nordamericane avrebbero certo potuto continuare a convivere trasfor-mando quell’antico rapporto. Edmund Burke lo aveva invocato e così pure Adam Smith, in certo senso smentendo l’affermazione di Namier secondo cui solo nello spirito della fratellanza religiosa “dissenter” tran-satlantica si sarebbe potuta risolvere la crisi americana14. Soprattutto Bur-
13 B. HILTON, A Mad, Bad, and Dangerous People?: England 1783-1846 (New Oxford History of En-gland), Oxford University Press, New York 2006.
14 L. NAMIER, England in the Age of the American Revolution, Macmillan, London 1963, p. 39.
Il caso inglese
253
ke aveva invocato una riconfigurazione dell’impero nello stesso spirito con cui perorava riforme (moderate) all’interno del paese per garantire la continuità costituzionale. Fu invece conflitto e l’antico regime colonia-le fu perduto. E, a ben vedere, fu un conflitto dovuto paradossalmente a una particolare forma di riformismo politico-istituzionale ed economico: a quel tentativo, cioè, dello Stato monarchico-parlamentare britannico di dotarsi, per rispondere alle esigenze scaturite dall’esito della guerra dei Sette Anni, di un vero profilo imperiale fin lì solo blandamente realiz-zato. Fu dunque una crisi di crescita statale in direzione imperiale, fu la conseguenza dell’abbandono di una via pragmatica e accomodante di gestione delle relazioni con le colonie a favore di un sistema tendenzial-mente più centralizzato, burocratizzato e militarizzato. La Gran Bretagna perse le colonie per essersi voluta evolvere in direzione di una forma sta-tale imperiale di tipo più continentale, perdendo quelle specificità in ter-mini di adattamento empirico che, come Burke sottolineava, ne avevano a lungo garantito la sopravvivenza. Qui, nel campo imperiale, passava la “linea divisoria tra Vecchia e Nuova Inghilterra”, tra concezioni della li-bertà, idee, visioni dei diritti che, pur dalle radici comuni, si erano andate divaricando. Se in madrepatria la linea divisoria si ricompose, in campo imperiale si trasformò in un solco e in una rottura insanabile. Fu dunque crisi irreversibile dell’antico regime coloniale, ma non crisi irrimediabile del regime politico-sociale della madrepatria.
La guerra con le colonie americane ribelli fu sicuramente uno choc per la classe dirigente inglese che fu costretta a ripensare se stessa: fu una sconfitta militare che ne danneggiò l’immagine pubblica e ne mise seriamente in dubbio la competenza in quanto élite dirigente (d’altra par-te, si rammenti che quella americana fu l’unica sconfitta militare subita dall’Inghilterra nel ‘700 e l’unica che avrebbe subito anche nelle guerre successive, cosa che probabilmente spiega meglio di molte altre circo-stanze i motivi della stabilità politica e sociale del paese)15. La classe diri-gente inglese, l’élite aristocratica che la componeva subì tre fondamentali prove: la guerra americana, le guerre contro la Francia rivoluzionaria e, nel frattempo, l’attacco devastante del nascente radicalismo, con la sua propaganda delegittimante che prese di mira l’aristocrazia di gover-
15 L. COLLEY, Britons: Forging the Nation 1707-1837, Yale University Press, New Haven-London 1992, p. 148.
Guido Abbattista
254
no come vera e propria classe sociale parassita, raffigurandola come un patriziato degenerato, privo di patriottismo e di spirito civico. Eppure, quell’aristocrazia seppe riprendersi da tutte e tre le crisi, dalle quali uscì anzi rafforzata, ricostruita, consolidata nel suo prestigio, celebrata nel suo patriottismo dopo aver dimostrato la propria capacità di guidare militarmente il paese nella durissima prova delle guerre napoleoniche16.
Questo non significa che all’interno della Gran Bretagna nell’ultimo quarto del ‘700 e nei primi anni del secolo seguente non ci fossero sintomi di crisi anche gravi: solo che ebbero manifestazioni diverse, tem-pistiche diverse e soprattutto esiti molto diversi che ovunque in Europa. All’interno della Gran Bretagna, come la rivoluzione americana aveva dimostrato, ci fu certamente la crisi di una classe dirigente e ci fu soprat-tutto l’emergere di nuove forme e nuove energie politiche, cambiarono i modi e i linguaggi della partecipazione politica, cambiò l’opinione pub-blica, cambiarono gli stili, ma anche gli obiettivi della protesta politica, soprattutto per effetto di quella “popular politics” e di quel delinearsi del-le “two nations” che John Brewer, e prima George Rudé, Ian Christie e Bernard Labaree, Colin Bonwick e altri (sulla scia di Herbert Butterfield), analizzarono con finezza ormai 25 e più anni fa, alterando in modo importante il quadro scaturito dalle analisi dell’alta politica di Lewis Na-mier. Quali le conseguenze sostanziali sia della rivoluzione americana sia dei sommovimenti politici in madrepatria che, complessivamente con-siderati, costituiscono ciò che di più vicino ci sia a una “crisi dell’antico regime” in Gran Bretagna? In estrema sintesi possiamo dire: la messa in discussione delle gerarchie sociali e politiche. Ma l’elemento di massimo interesse non è tanto questa messa in discussione, quanto gli obiettivi che essa si prefisse e i risultati a cui portò. I quali, è inutile dirlo, non causarono quei sommovimenti rivoluzionari che scossero altri paesi e in-vece alimentarono un prolungato anche se conflittuale dialogo tra classi dirigenti e movimenti di protesta e di riforma che, dopo la parentesi delle guerre rivoluzionarie con il loro empito patriottico e conservatore, trovarono sbocco in una intensa e duratura stagione riformistica su cui torneremo oltre.
Quei molteplici aspetti di instabilità che si innescarono dopo il 1763 e soprattutto dopo il 1776-78, insomma, rivelarono sicuramente alcuni
16 Ivi, p. 147.
Il caso inglese
255
elementi di debolezza e alcuni difetti non secondari del sistema politi-co britannico, mutando l’atteggiamento che fino ad allora aveva fatto del “preservare” e non del “cambiare” l’esigenza politica primaria. Tra questi difetti certamente vi furono le discriminazioni civili, politiche ed economiche ai danni degli Irlandesi, sia protestanti sia cattolici, le in-congruenze del sistema rappresentativo facente centro sul parlamento di Westminster, la scarsa flessibilità di istituzioni ancorate a tradizioni e consuetudini poco o per nulla ricettive di nuove istanze di partecipazio-ne politica dal basso, la perdurante diseguaglianza di condizione civile e politica dei sudditi cattolici. Ma questo, come dicevamo, non dette luogo a una contestazione radicale del sistema istituzionale e delle relazioni sociali. Per quanto espressa anche con toni radicali, la protesta continuò perlopiù a riguardare il funzionamento più che la natura delle istituzioni – i rapporti tra corte e Parlamento, i partiti politici, l’equilibrio reale dei poteri, le forme e l’esercizio della rappresentanza –, a generare istanze di riforma più che aspettative di rigenerazione integrale che restarono appannaggio di minoranze e che non intaccarono la tenuta di una classe dirigente sostanzialmente aristocratica. Le sfide degli anni ‘70-’80 furo-no certamente all’origine dell’instabilità generale che afflisse l’impero atlantico, con la crisi e la guerra americana e il movimento irlandese dei Volunteers; comportarono la ripresa in madrepatria della protesta dei Dissenters, le critiche al sistema economico mercantilista, la nascita del movimento di protesta delle contee e di richiesta di riforma parlamenta-re nel Middlesex e nello Yorkshire, che da Butterfield17 in poi non è pos-sibile leggere riduttivamente come un episodio sulla strada della riforma parlamentare e che pare meglio comprensibile entro la prospettiva del “National revival”. Eppure, se indubbiamente di crisi si trattò, e sia pure crisi di antico regime, essa non poté scalfire il sostanziale lealismo delle classi medie urbane, il loro attaccamento alla costituzione e la loro volon-tà di distanziarsi dalle manifestazioni popolari più radicali o di disaffezio-ne e ribellismo americano e ancor più irlandese e dunque non assunsero mai il carattere di vere e proprie crisi sistemiche. La classe dirigente dimostrò una fondamentale capacità di ricompattamento dopo l’insta-bilità causata dalla sconfitta americana, con il riconquistato equilibrio al centro durato sostanzialmente un ventennio, dal 1784 al 1815; il movi-
17 H. BUTTERFIELD, George III, Lord North, and the people, 1779-80, Bell, London 1949.
Guido Abbattista
256
mento di protesta popolare extraparlamentare risvegliò una capacità di risposta con una cauta autoriforma di alcuni degli aspetti più critici del sistema istituzionale britannico attraverso la riforma economica e ammi-nistrativa, l’alleviamento delle restrizioni economiche sull’Irlanda, l’Ha-beas Corpus Bill (1781) e l’indipendenza parlamentare irlandese (1782), l’attenuazione delle discriminazioni anticattoliche, ma anche la serie di interventi di riforma del governo dell’India nell’arco di parecchi decenni (1773-1833): gli stessi tentativi ripetuti di riforma parlamentare proposti da Pitt il Giovane a metà degli anni ‘80, per quanto falliti, mostrarono un governo niente affatto privo di lungimiranza e di volontà di sottrarre al paese l’iniziativa riformista.
Naturalmente tutto questo non sarebbe bastato ad assicurare la tenu-ta del sistema politico britannico, se non ci fossero state circostanze di tipo occasionale, di tipo congiunturale e di tipo eccezionale: del primo genere furono, nell’estate 1780, i “Gordon’s riots”, in quella che Butter-field definì una “situazione quasi-rivoluzionaria” o anche la «nostra rivo-luzione francese, la rivoluzione a cui sfuggimmo»18, di cui non si può in alcun modo trascurare l’impatto come elemento di fortissimo richiamo all’ordine; del secondo tipo fu il boom economico iniziato nel 1784, pa-radossalmente legato proprio alla grande ripresa delle esportazioni verso l’America indipendente oltre che agli sviluppi in campo infrastrutturale e manifatturiero, e che non mancò di generare ottimismo nel paese; e del terzo tipo furono infine gli eventi rivoluzionari di Francia, soprattutto a partire dal 1793, quando l’Inghilterra, nonostante – o forse meglio: gra-zie anche alla – radicalizzazione delle posizioni ideologiche espresse da Richard Price, Thomas Paine e i “Friends of the People” che causarono la drammatica spaccatura in seno agli Whigs tra Fox e Burke, si compat-tò internamente intorno al governo Pitt, assumendo su di sé la difesa dell’ordine europeo. Come è stato detto, «la rivoluzione francese riuscì là dove la rivoluzione americana, le vicende Wilkes, le rivendicazioni dei dissenters erano riuscite solo in parte: nel creare in Inghilterra un partito dell’ordine»19.
18 BUTTERFIELD, George III, Lord North, and the people cit., p. VI.19 W. R. WARD, The beginnings of reform in Great Britain, imperial problems, politics and administration,
economic growth (Chapter XIX), in A. GOODWIN (ed.), New Cambridge Modern History, vol. 8, The American and French Revolutions, 1763–93, Cambridge the University Press, Cambridge 1965, p. 560.
Il caso inglese
257
Perché quei sommovimenti politici interni ebbero un esito gradual-mente riformatore che rafforzò le istituzioni del paese, senza che la situa-zione degenerasse in una crisi generale? Sostanzialmente per due motivi. Il primo è che la Gran Bretagna nell’ultimo quarto del secolo fu, nono-stante la sconfitta americana, un paese vincitore: lo era stato anni prima nel teatro coloniale (1756-1763), lo fu poi in India e in entrambi i casi la rivalità francese fu tolta di mezzo in via definitiva; e lo fu ancora di più contro la Francia rivoluzionaria e napoleonica. Fu un paese vittorioso, ma anche un paese intensamente percorso da sentimenti patriottici e filo monarchici attraverso cui si manifestò un potente richiamo all’ordine e alla difesa delle istituzioni. Il secondo motivo è che la Gran Bretagna fu un paese in forte crescita economica, demografica, agricola (crescita delle rendite fondiarie, consolidamento delle élites terriere) capace di ammortizzare il peso delle guerre coloniali contro la Francia e contro i ribelli americani, di assorbire senza traumi la perdita delle colonie norda-mericane che non produsse contraccolpi economici, di sostenere il peso dell’espansione in India e, infine, di assumere sulle sue spalle la resistenza terrestre e navale contro la Francia rivoluzionaria e napoleonica. In que-sto quadro, la struttura della società e della politica tennero solidamen-te, pur in un momento di grandi trasformazioni economiche e sociali, per motivi che affondano le proprie radici in una molteplicità di fattori delineatisi al passaggio tra ‘600 e ‘700, primo tra tutti il sorgere della struttura del debito pubblico gestito dalla banca centrale e, attraverso questo, il solido legame venutosi a creare tra classi possidenti, mercantili e finanziarie titolari del debito pubblico e istituzioni dello Stato.
C’è un altro paradosso da evidenziare. La Gran Bretagna a cavallo tra Settecento e Ottocento conobbe certamente una intensa e creativa sta-gione culturale: si pensi al revival dell’umanitarismo filantropico evange-lico, all’utilitarismo benthamiano, al “radicalismo filosofico”, all’economia politica, ma anche al pensiero scientifico e all’innovazione tecnologica. Ma a consentire alla Gran Bretagna il tipo di sviluppo che conobbe, ossia di passare relativamente indenne attraverso le crisi atlantiche ed europee e ad autoriformarsi parzialmente a inizio ‘800, non fu un movimento di segno modernizzatore e secolarizzatore apparentabile a ciò che erano stati i Lumi europei, francesi soprattutto – quanto meno nel loro signifi-cato più tradizionale di movimento antinobiliare, anti-ecclesiastico, anti-religioso e antimonarchico. Quello che avvenne in Gran Bretagna fu un processo di svecchiamento politico e di critica della tradizione che forti-
Guido Abbattista
258
ficò la società e le istituzioni e ricavò gradualmente nuovi spazi all’azione delle middle classes, anche se certamente a prezzo del mantenimento di antiche gerarchie e della creazione di nuove disuguaglianze, nate dallo stesso processo di sviluppo economico industriale.
Questo è il quadro che sembra risultare da un paradigma storiografi-co dominante che potremmo definire “neo-whig”, che è stato elaborato e rafforzato sulle due sponde dell’Atlantico nel corso degli anni ’70 e ’80 del Novecento da storici di una generazione più anziana come John R. Plumb e da altri più giovani come John P. Kenyon, Isaac Kramnick, John Brewer, Harry T. Dickinson, Roy Porter, e di cui il Companion to Eighte-enth-Century Britain curato da Harry Dickinson nel 200220 è la migliore, più recente sintesi. Fondamentali, tra le altre, nell’elaborazione di questo paradigma sono state tre opere, di cui John Brewer è stato autore o co-autore: The Birth of a Consumer Society: The Commercialization of Eigh-teenth Century England (Neil McKendrick, John Brewer, John H. Plumb, 1982), The Consumption of Culture 1600-1800: Image, Object, Text, (Ann Bermingham and John Brewer, 1995) e The Sinews of Power: War, Money and the English State, 1688-1783 (1988), alle quali va aggiunto l’impor-tante volume collettaneo, al quale lo stesso Brewer ha collaborato, An Imperial State at War: Britain from 1689-1815, a cura di Lawrence Stone (Routledge, London 1993). L’importanza soprattutto di questi ultimi due volumi, unitamente a studi sulla struttura delle finanze pubbliche e sullo sviluppo economico britannico come quelli di Patrick O’Brien21, con-siste nel fatto di proporre una interpretazione delle dinamiche statali britanniche tendente a far rientrare il caso inglese in una più generale evoluzione europea, ma senza rinunciare al tempo stesso a una visione più complessiva improntata all’idea di specificità o, se vogliamo, eccezio-nalità tutta britannica.
Se uno dei tratti fondamentali dell’eccezionalismo di matrice whig era dato dall’idea che quella britannica del Settecento fosse una società con poco Stato e proprio perciò capace di liberare le energie che l’avrebbero
20 H.T. DICKINSON (ed.), A Companion to Eighteenth Century Britain, Blackwell, Oxford 2002.21 P. K. O’BRIEN, The nature and historical evolution of an exceptional fi scal state and its possible signifi -
cance for the precocious commercialization and industrialization of the British economy from Cromwell to Nelson, «Economic History Review», 64, 2, 2011, pp. 408-446; ID., Fiscal Exceptionalism: Great Britain and its European Rivals. From Civil War to Triumph at Trafalgar and Waterloo, Department of Economic History London School of Economics, Working Papers n. 65/01, October 2001.
Il caso inglese
259
condotta all’industrializzazione, allo sviluppo moderno e, in ultima istan-za, alla modernizzazione politica, Brewer e altri studiosi, come Patrick O’Brien, hanno invece mostrato come i dati rivelino una dinamica di crescita della macchina statale deputata all’amministrazione del fisco e delle finanze pubbliche, delle forze armate soprattutto navali, della di-plomazia, delle regolamentazioni amministrative e commerciali in tutto e per tutto analoghe a quelle degli altri maggiori Stati europei. Se il paese si trovò impegnato nell’assunzione di un ruolo attivo sia in cam-po europeo sia, soprattutto, in campo colonial-imperiale e commerciale globale, ciò non poté avvenire che a prezzo di un massiccio sviluppo del “fiscal-military State”, degli uffici statali, della burocrazia, della pressione fiscale, dell’indebitamento pubblico – pur in una situazione di sostan-ziale solidità finanziaria e di pressione fiscale certamente crescente nel corso del secolo, ma comparativamente più snella e leggera che in altre parti d’Europa e soprattutto mai giunta sull’orlo di crisi di solvibilità. Una visione, questa, che è stata in seguito approfondita mediante l’analisi dell’espansione dello “spazio funzionale” dello Stato anche prima della Gloriosa rivoluzione: una analisi che significativamente ha insistito sul fatto che quell’espansione non avvenne comunque in termini di “potere” dello Stato, che l’autorità politica continuò ad essere materia di negoziato e quell’espansione stessa non poté fare a meno di forme di legittimazio-ne22.
Un libro influente come Britons (1992) di Linda Colley ha avvalora-to l’interpretazione riconducibile a Brewer, completandola sul lato della storia sociale e delle identità politiche e culturali e offrendo ulteriori elementi di comprensione dei motivi che permisero alla Gran Bretagna del secondo Settecento di mantenere una sostanziale stabilità di lungo periodo pur nell’instabilità di fine secolo. Ciò avvenne infatti innanzitut-to con la ricostruzione e il rafforzamento della classe dirigente, composta da una élite terriera parzialmente rinnovata da movimenti di proprietà capaci di variarne e rinsaldarne i legami interni grazie alla scala del fe-nomeno non limitata all’Inghilterra, ma all’intera area britannica. Nello stesso senso agirono l’aumento delle rendite fondiarie grazie all’aumen-to dei prezzi dei prodotti agricoli, la graduale fusione delle aristocrazie
22 M. BRADDICK, State Formation in Early Modern England c. 1550-1700, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
Guido Abbattista
260
periferiche – scozzese, gallese, anglo-irlandese, inglese – l’emergere di uno stile di vita e di una cultura aristocratiche relativamente omogenee, gradatamente distaccate dalle abitudini proprie della vita provinciale e sempre più vicine a un modello urbano, londinese, plasmato dalla so-cietà della capitale e dalla prossimità ai centri del potere: un processo che ricorda la romanizzazione delle aristocrazie provinciali nell’impe-ro di Augusto descritta da Ronald Syme e che è illustrato molto bene dall’apparizione di un peerage britannico catalogato in modo unitario dalle pubblicazioni specializzate, come lo Stockdale’s Peerage nel 1808 o il Collin’s Peerage del 1812. In tal senso certamente contribuirono anche la percezione e il riconoscimento degli elementi di comune interesse che i membri dell’aristocrazia condivisero nei confronti delle realtà esterne con le quali la Gran Bretagna si confrontò nel suo processo di espansio-ne e consolidamento imperiali, ma anche il sempre più uniforme model-lo di educazione patrizia attraverso le public schools e le università basato su ideali di patriotic duty, alimentati dalla storia dell’antichità classica e dalle immagini di grandezza imperiale di ascendenza romana, e da un’i-deologia di vigore e fortitudine maschile – un’immagine di mascolinità – coltivata al servizio della patria.
La nuova politica popolare, il radicalismo, la richiesta di riforma par-lamentare, l’agitazione irlandese, l’ideologia radicale di Thomas Paine e di Jeremy Bentham, i loro attacchi dissacratori alla classe dirigente e alle sacre istituzioni britanniche non produssero affatto una crisi generale di consenso e di tenuta delle istituzioni, pure gravemente danneggiate dalle vicende della monarchia e da quelle personali di Giorgio III fino al periodo della Reggenza. Il paese poté evolvere in modo sostanzialmente ordinato verso l’autoriforma in un quadro di continuità costituzionale. Ciò poté avvenire in sostanza grazie alla maturità dell’opinione pubblica, alla libertà del dibattito politico, alle forme tutto sommato aperte della politica, alla partecipazione della classe media in un quadro di stabilità economica e finanziaria reso possibile dall’assenza di insopportabili pri-vilegi fiscali, sociali o politici.
È stato ben chiarito – per tornare al tema del ruolo dello Stato poco sopra evocato – che se questo poté accadere fu anche grazie a una macchina statale che nel corso del Settecento si era perfezionata e rafforzata dal punto di vista del suo funzionamento come “fiscal-military state” mediante un sistema solido di finanza pubblica, un fisco centralizzato ed efficiente a cui tutti i sudditi contribuivano e
Il caso inglese
261
una integrazione e permeabilità del sistema statale da parte delle forze economiche: altrettanti elementi di compattezza che permisero alla Gran Bretagna settecentesca di diventare l’arbitro della bilancia europea, di acquisire il primo impero, di perderlo e di costruirsene un secondo.
Certo, tutto questo comportò, nel momento del massimo pericolo – agitazioni politiche, diffusione di semi di giacobinismo rivoluzionario, minacce di invasione, segnali di rivolta in Irlanda e di ammutinamento in madrepatria – limitazioni della libertà civile e politica ai danni dei simpatizzanti filo giacobini interni che suscitarono le critiche corrosive contro l’élite al potere da parte dei radicali “outdoor”. Ma al tempo stesso servì a rafforzare enormemente i valori attorno ai quali si strinsero non solo la monarchia parlamentare e la sua classe dirigente, ma anche la società nel suo complesso: valori di patriottismo, di solidarietà nazionale contro la minaccia esterne, di orgoglio militare e imperiale. E fu grazie a questo che il paese poté attraversare senza scosse troppo gravi il terri-bile periodo delle guerre napoleoniche e del blocco continentale, con il rinnovato impegno militare sul mare prima e sulla terraferma europea in seguito; e presentarsi dopo il 1815 nelle condizioni per realizzare la riforma di alcuni dei suoi perduranti elementi di antico regime: le misure di risanamento amministrativo, finanziario e fiscale seguite all’enorme pressione sul contribuente causata dalle guerre e note collettivamente come “economic reform”, l’abolizione della tratta degli schiavi e della schiavitù, effettuata per gradi nel 1807, 1833 e 1838, l’abolizione nel 1824 delle leggi proibitive delle associazioni di lavoratori (Combination Acts, or An Act to prevent Unlawful Combinations of Workmen, 1799-1800), le leggi per garantire ordine e sicurezza pubblica con l’istituzione di un ufficio metropolitano di polizia, la riforma delle Poor Laws nel 1834 e dei consigli municipali nel 1835, l’affrancamento dei Dissenters con l’abro-gazione dei cosiddetti Test e Corporation Acts nel 1828, l’emancipazione cattolica (la legge del 1829 giunse a coronamento di una serie di 5 precedenti atti di relief tra 1774 e 1828), l’alleggerimento delle politiche doganali e fiscali in senso liberista e l’apertura graduale nel 1813 del commercio indiano fino ad allora monopolizzato dalla East India Com-pany fino alla sua liberalizzazione completa nel 1833, quando la com-pagnia divenne una mera agency di governo per restarlo fino al 1858; e infine la riforma parlamentare del 1832, seguita allo storico ritorno al potere degli Whigs liberali di Grey (1830), dopo il lungo sostanziale predominio della parte tory da Pitt il Giovane a Canning, e con l’avvio di
Guido Abbattista
262
una fase storica in cui l’alternanza delle due parti politiche non impedì di arrivare all’abrogazione nel 1846 delle leggi protettive sul commercio del grano. Questo insieme di misure è generalmente identificato sia dalla storiografia whig più tradizionale sia da quella contemporanea neo-whig come il tramonto dell’ “old order” in Inghilterra o come “The Waning of ‘Old Corruption’”23: un obiettivo che dimostrò la capacità della classe dirigente inglese sia Tory sia Whig, rinnovata spiritualmente anche dal fervore evangelico dell’inizio del secolo, di far fronte alle sfide radicali e di perpetuare ancora a lungo l’egemonia sociale dell’aristocrazia terriera, il cui reale declino sarebbe iniziato solo nella tarda età vittoriana24. Esso segnò la vera conclusione del “long eighteenth century”.
Ciò che tuttavia va registrato è come, sulle caratteristiche complessive di quel periodo unitario tra il 1688 e il 1832, accanto all’interpretazione prevalente che vi scorge il predominio di tratti liberali, secolari, radi-cal-borghesi, modernistici e progressivi – l’Inghilterra avrebbe presen-tato qualità uniche come il costituzionalismo, il governo parlamentare, il governo della legge, la tolleranza religiosa e la libertà di parola – ne esista un’altra, meno fortunata, ma certo non improvvisata, secondo la quale, in opposizione molto netta e polemica con la cosiddetta vulgata riduzionista ed economicista marxista e whig o neo-whig, la storia della società e del sistema politico britannico sarebbe stata caratterizzata da tratti genuinamente e autenticamente definibili di antico regime in sen-so europeo-continentale, ossia confessionali, aristocratici, dinastici, ge-rarchici e tradizionalisti. Si tratta di una interpretazione che dalla metà degli anni ‘80 ha alimentato una vivace controversia, probabilmente per l’intonazione apertamente polemica del suo autore, e che è pertinente richiamare qui perché ha riguardato proprio l’interpretazione della na-tura dell’ “old order” britannico, delle sue specificità, della sua natura più o meno modernizzata, più o meno affrancata dalla tradizione. Si tratta della controversia che, in un momento di ampia ripresa degli studi sul Settecento britannico, è nata a seguito dell’apparizione dei lavori di quello storico prolifico, dallo stile apertamente iconoclasta e pertanto
23 P. HARLING, The Waning of ‘Old Corruption’. The Politics of Economical Reform in Britain, 1779-1846, Clarendon Press, Oxford 1996; e ID., Rethinking ‘Old Corruption’, «Past and Present», 147, 1995, pp. 127-158.
24 D. CANNADINE, The Decline and Fall of the British Aristocracy, Yale University Press, New Haven 1990.
Il caso inglese
263
estremamente discusso che è Jonathan C. D. Clark. Storico della politica, del pensiero e delle ideologie politiche, della
società e della religione nell’Inghilterra settecentesca, al quale si deve tra l’altro l’introduzione dell’espressione “long eighteenth century”, il suo la-voro ha influenzato profondamente il dibattito sulla natura della società inglese tra la Gloriosa e il primo “Reform Act”25, sostenendo, in dichiara-ta antitesi rispetto alle interpretazioni di segno “secolare” e “positivista”, la sostanziale omogeneità di carattere della società e delle istituzioni inglesi nel periodo indicato, sotto il segno di un tradizionalismo legato alla permanente presa del fattore religioso e confessionale. Non solo, l’interpretazione di Clark ha avuto come conseguenza (o forse come obiettivo principale) quella di ridimensionare l’idea dell’eccezionalismo britannico, sottolineando i tratti comuni che l’Inghilterra condivideva coi propri vicini europei proprio all’insegna di quegli istituti comuni noti come “antico regime”. Da questo punto di vista, sicuramente l’opera di Clark ha avvalorato l’immagine di una società di antico regime come essenzialmente riscontrabile in tutta Europa; e così facendo è andato ben oltre ciò che sarebbero stati disposti ad ammettere molti storici che, assai prima di lui, hanno richiamato il carattere gerarchico della società inglese hannoveriana, la natura aristocratica della sua leadership, il con-servatorismo dominante nelle istituzioni, i valori, i modi di pensiero e di comportamento26.
25 I suoi libri più signifi cativi sono The Dynamics of Change. The crisis of the 1750s and English party systems, Cambridge University Press, Cambridge 1982; il già citato English Society, 1688–1832: Ideology, Social Structure and Political Practice during the Ancien Regime, del 1984, riedito con sos-tanziali riscritture nel 2000, Revolution and Rebellion: State and Society in England in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, Cambridge University Press, Cambridge 1986; The Language of Liberty 1660–1832: Political Discourse and Social Dynamics in the Anglo-American World, Cambridge Uni-versity Press, Cambridge 1994. Per alcune delle prime, più importanti reazioni alle tesi di Clark, v. J. INNES, J. C. D. CLARK, Social History and England’s ‘Ancien Regime’, «Past and Present», 115, 1987, pp. 165-200; J. G. A. POCOCK, 1660 and All That: Whig-Hunting, Ideology and Historiography in the Work of Jonathan Clark, «Cambridge Review», 108, 2, 1987, pp. 125-128; J. BLACK, On Second Thoughts: England’s ‘Ancien Regime’?, «History Today», 38, 3, 1988, pp. 43-51; K. M. SHARPE, M. A. KISHLANSKY, H. T. DICKINSON, Symposium: Revolution and Revisionism, in «Parliamentary History», 7, 2, 1988, pp. 328-338; F. O’GORMAN, Review of English Society 1688-1832: Ideology, Social Structure and Political Practice During the Ancien Regime, «Reviews in History» (URL: http://www.history.ac.uk/reviews/review/41b Date accessed: 28 April, 2012).
26 Questo è certamente vero per Lewis Namier, ma più recentemente per storici come John Can-non, Aristocratic Century: The Peerage of Eighteenth-Century England, Cambridge University Press, Cambridge 1984; I. CHRISTIE, Stress and Stability in Late Eighteenth Century Britain, Clarendon Press, Oxford 1984, e J. A. W. GUNN, Beyond Liberty and Property: the Process of Self-Recognition in Eigh-teenth Century Political Thought, McGill-Queen’s University Press, Kingston and Montreal 1983.
Guido Abbattista
264
Tuttavia, il cuore della contesa non sembra essere tanto nel quesito se l’Inghilterra abbia conosciuto o meno nel Settecento un “old order” fatto di tradizionalismo sociale, economico, politico e religioso, quanto nel quesito se l’assetto sociale, economico, politico e religioso del paese sia stato dominato prevalentemente da questi aspetti tradizionali oppure da altri di diverso segno: sviluppo economico commerciale e industriale, crescita delle classi medie, dinamismo sociale, eterodossia religiosa, dis-senso politico e ideologico, vivacità dell’opinione e della comunicazione pubblica, insomma tutti quegli aspetti che si suole a torto o a ragione considerare indici di modernizzazione e che importanti filoni storiografi-ci negli anni ‘80-‘90 hanno contribuito a mettere in evidenza con lavori di grande interesse e persuasività. I ripetuti interventi di Clark, pur mossi dal giusto e condivisibile intento di ridare la dovuta considerazione agli elementi di tradizionalismo, sembrano però aver scelto un piano arti-ficioso e poco produttivo di discussione, facendo leva certamente per intento polemico su una serie di alternative dicotomiche che la storiogra-fia sociale, economica e politica ha cercato di evitare, a favore di quadri sfumati, complessi, variegati e non tracciati con le sole tinte del bianco e del nero. Il problema perciò non sembra poter essere correttamente in-teso ponendo la domanda se sia possibile definire l’Inghilterra un paese di antico regime: rispondendo positivamente e volendo estendere la vali-dità di tale risposta fino alle soglie delle riforme del 1829-1832, Clark ha finito con il non trovare egli stesso una convincente spiegazione alle tra-sformazioni intervenute in quegli anni, che egli presenta come un frutto relativamente repentino, difficile da comprendere senza tenere conto di processi di cambiamento in atto da lungo tempo. La domanda corretta sembra essere piuttosto come l’Inghilterra, dato il suo assetto istituziona-le e politico, poté armonizzare elementi di indubbio tradizionalismo con elementi di altrettanto indubbia modernizzazione, elementi favorevoli al mantenimento dell’ “old order” ed elementi che premevano per la sua trasformazione, limitando, tutto sommato, il precipitare di una crisi mag-giore di consenso e di compattezza alla pur dirompente crisi americana, e contenendo gli effetti delle altre pur gravi crisi imperiali (Irlanda, e in assai minor misura India) e domestiche (movimenti di protesta popolare extraparlamentare) assorbendoli finalmente entro i canali istituzionali.
Ebbene, se questi termini della domanda sono corretti, fino a che punto è utile alla risposta un concetto come quello di “crisi generale dell’antico regime”? Fino a che punto esso permette di risalire a fattori
Il caso inglese
265
e spiegazioni capaci di dar conto dell’evoluzione della Gran Bretagna a cavallo tra i due secoli e fino alla prima riforma parlamentare? Tenu-to conto dei molteplici elementi di specificità dell’assetto complessivo della Gran Bretagna, che pur senza essere trasformati in un profilo di “eccezionalismo” permettono di distanziare quel paese dagli standard eu-ropei prevalenti in ogni settore della vita associata, la sensazione è che la prospettiva della “crisi generale” sia incapace di spiegare perché un paese pervaso da profondi sintomi di disaffezione e di protesta contro l’establishment, un paese da poco uscito da una guerra civile in ambito imperiale capace di minare la credibilità della propria classe dirigente, nel giro di pochi anni sia stato in grado di ritrovare, al di là degli indub-bi elementi interni di conflittualità politica, partitica, religiosa e sociale, l’unità politica, il dinamismo economico, l’efficienza statale, lo spirito collettivo grazie ai quali ha potuto sostenere l’immane sforzo bellico del periodo 1793-1815 e riprendere, una volta ripristinata la pace europea di cui è tornato ad essere garante, come già un secolo prima, il passo lento ma sicuro dell’adattamento al mutamento storico. Gli storici, come Linda Colley, che hanno insistito sulla forza dello spirito nazionale e del patriottismo britannici tra Settecento e Ottocento, cominciando a trac-ciarne un più completo ritratto, e che, come John Brewer, hanno sottoli-neato l’esistenza di un potente ed efficiente apparato centrale dello Stato capace di mobilitare risorse in una combinazione di potere e libertà, hanno probabilmente individuato la strada per giungere alla risposta più persuasiva e l’hanno fatto tenendo ben presente la ineludibile dimen-sione imperiale, e non “little-England”, della Gran Bretagna tardo-sette-centesca, e chiamando in causa, di nuovo, un elemento di precocità, di distinzione, di originalità della configurazione sociale, politica e culturale della Gran Bretagna rispetto al resto dell’Europa.
Il nocciolo della questione torna ancora una volta ad essere quello della rappresentazione dell’Inghilterra, o meglio, della Gran Bretagna in termini di “eccezionalità” e “unicità” rispetto all’Europa continentale e, più precisamente, di “modernizzazione” o “modernità” precoce, specie con riferimento alle forme dell’economia, ai modi della vita sociale e culturale e anche alle libertà politiche e civili. Come già accennato, la visione “neo-whig” che propone tale rappresentazione, pur con sfuma-ture e distinguo, continua dagli anni ‘70 ad avere ampio seguito e la ritroviamo in influenti opere di sintesi e di alta divulgazione, come il già citato Companion to Eighteenth Century Britain curato nel 2002 da H.
Guido Abbattista
266
T. Dickinson oppure la sintesi di Paul Langford, The Eighteenth Century, 1688-1815 (Oxford University Press, Oxford 200227).
Va pur detto che la storiografia più recente ha fatto molto per de-in-sularizzare la Gran Bretagna soprattutto dal punto di vista di una sua affermata modernità precoce e per reagire a visioni “eccezionaliste” ten-denti a cogliere della società britannica esclusivamente o prevalente-mente gli elementi di modernità e di progresso secondo quella tipica visione teleologica definita “interpretazione whig della storia”. Non c’è dubbio che la società e le istituzioni britanniche settecentesche siano da caratterizzare come ancora largamente pre-moderne, specialmente se osservate non tanto dal centro della vita politica e istituzionale, ma dalla provincia: un paese largamente rurale, ruotante attorno alle comunità locali dominate dai notabili o dai magnati del posto, basato ancora su deferenza, status, gerarchia sociale, proprietà della terra, valori religiosi e confessionali istituzionalizzati, tradizionalismo politico, attaccamento dinastico, disciplina del patronage, “influenza” e “political bargaining”; con una economia ancora impacciata da sopravvivenze di altre epoche – gilde, corporazioni, monopoli, scarsità di capitali, basso ricorso al cre-dito, trasporti interni difficoltosi, politiche vincolistiche. Era inoltre uno Stato confessionale, che si ispirava a un’idea di uniformità e conformità religiose che sarebbero state molto dure a morire (l’esclusione dei dissen-ters da Oxford e Cambridge sarebbe stata eliminata del tutto solo nel 1878). Ma anche il governo centrale non presentava un quadro troppo più efficiente, con il carattere sostanzialmente oligarchico della cosid-detta unreformed House of Commons (513+45 membri rispettivamente per Inghilterra e Galles più la Scozia, divenuti 698 dopo l’Act of Union irlandese del 1801), con tutte le incongruenze di una rappresentanza di contee e borghi diseguale, bizzarra e dominata dall’influenza sociale e da pratiche corruttive, di ricatto e aperta compravendita di favori grazie ai mezzi a disposizione della Corte e dell’esecutivo per influenzare il legislativo. Molte di queste osservazioni servirono a fine Settecento per elaborare la visione della “Old corruption”: l’idea del governo centrale come consistente in una cricca di affaristi corrotti dediti esclusivamente alla distribuzione di privilegi di casta elaborata e trasmessa al secolo
27 Parte della serie Short Oxford History of the British Isles, questa agile ed effi cace sintesi è stata ristampata nel 2009.
Il caso inglese
267
seguente da critici radicali come Tom Paine, William Godwin, William Cobbett e dai vari Red e Black Books.
È altrettanto vero però che ancora sotto molti aspetti è possibile caratterizzare il paese in termini diversi e relativamente più avanzati rispetto al resto d’Europa, a cominciare dalla semplice circostanza, che si traduceva in una considerevole limitazione del potere della monarchia, secondo cui nessun governo inglese nel secolo XVIII poteva funzionare se privo di una maggioranza parlamentare e ogni politico o ministro basava il proprio potere sulla capacità di influenza parlamentare. Pur in una struttura sostanzialmente oligarchica, il potere centrale era giocoforza che fosse condiviso e limitato. Quanto all’economia e alla società, è comunque indubbio che tutto il Settecento fu un periodo di crescita, di dinamismo, di miglioramenti soprattutto per quanto riguarda il commercio estero e, in una fase più avanzata, la produzione manifatturiera e le infrastrutture. Il Settecento fu inoltre un periodo di crescita delle classi medie urbane, della loro cultura, del loro stile di vita, e di conseguenza della loro pressione per una maggiore partecipazione politica.
La crisi che innegabilmente vi fu a partire dal 1760 e ancor più dal 1775 interessò dunque un tipo di antico regime molto diverso da quello continentale: senza residui di privilegio feudale, privo di un ethos no-biliare separatista (se non di modi e comportamenti), con una Chiesa istituzionalizzata e funzionale al regime politico, socialmente più dina-mico e aperto al talento (almeno sopra la linea della proprietà), con forme ed espressioni più marcate e soprattutto più costanti e durature di vitalità, di partecipazione e di apertura politica, con un grado maggiore di compattezza istituzionale e nazionale attorno a valori fondamentali condivisi – orgoglio e fiducia in una realtà correntemente e consen-sualmente definita “costituzione” come garanzia di “liberty and order” –, con una magistratura indipendente con “tenure for life” e per buona condotta, senza forme di censura dell’opinione salvo che per fatti di rilevanza penale (minaccia all’ordine, calunnia, sedizione, blasfemia) e, anzi, con un grado elevato di integrazione tra alta cultura e istituzioni, con un grado maggiore di integrazione politica e anche giudiziaria tra centro e periferia in un sostanziale equilibrio tra autonomia locale ed esercizio del potere al centro. Tutto questo va unito a un quadro di crescita economica, di miglioramento complessivo delle condizioni delle classi medie – senza bisogno di appiattirsi sul paradigma del “rise of the
Guido Abbattista
268
middle classes” – di urbanizzazione, di progresso agricolo e industriale: nonostante tentativi revisionisti anche a questo proposito ancora non è stato possibile dissolvere l’idea di una “rivoluzione industriale” in atto dopo il 1760 e legittima figlia di un secolo intraprendente e innovatore. Nel suo insieme possiamo desumerne l’immagine di una “diversità” del mondo britannico sotto il profilo della natura libera delle istituzioni e della vivacità sociale ed economica: aspetti che, del resto, furono perfet-tamente percepiti e descritti praticamente da tutti i viaggiatori e visitatori contemporanei.
Una visione di questo genere è quanto emerge in modo estrema-mente ricco e articolato in un recente, ambizioso e voluminoso libro dello storico economico Joel Mokyr, che si segnala sia per l’impiego di categorie e concetti di portata sicuramente innovativa, sia per quanto è in grado di aggiungere alla discussione di cui ci stiamo occupando in questa sede28.
Non è possibile richiamare qui il complesso percorso di ricerca di Mokyr, che ne fa uno dei più prolifici e originali studiosi dei processi di trasformazione economica avvenuti soprattutto nell’area britannica a cavallo tra Settecento e Ottocento29. Né sarebbe possibile riassumere in poche righe un libro di quasi seicento pagine come The Enlightened Eco-nomy. Non si può però fare a meno di notare quali siano le implicazioni di quest’ultimo in termini di visione generale del processo di cambia-mento storico che interessò la Gran Bretagna nell’arco temporale 1700-1850, quello stesso cioè che al proprio interno racchiude quella che in altri contesti è stata definita “crisi dell’antico regime”. Tre elementi vanno sottolineati a questo proposito. Il primo è la natura di un’interpretazione che investe non solo i fatti economici, ma che riguarda l’insieme della so-cietà, della vita pubblica e delle istituzioni britanniche. Le trasformazioni di cui Mokyr parla non sono più riassumibili col tradizionale concetto di “rivoluzione industriale”, troppo centrato sui soli fenomeni dell’econo-mia, ma semmai con il più comprensivo concetto di “modernizzazione”
28 J. MOKYR, The Enlightened Economy. An Economic History of Britain 1700-1850, Yale University Press, New Haven 2010.
29 Ricordiamo solo, tra i suoi libri più signifi cativi, The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress, Oxford University Press, New York-London 1990 (tr. it. Il Mulino, Bologna 1995); The Gifts of Athena: Historical Origins of the Knowledge Economy, Princeton University Press, Princeton 2002 (tr. it. Il Mulino, Bologna 2004).
Il caso inglese
269
(o, se preferiamo, di superamento dell’antico regime). In luogo di questo concetto che resta comunque ambiguo e generico, però, Mokyr preferi-sce introdurre una espressione di fresco conio come quella di “enlighte-ned economy”, il cui intento è quello di porre l’enfasi sulle origini “cul-turali” e “sociali” delle trasformazioni economiche, ossia sul fatto che le trasformazioni innovative nella sfera economica non poterono derivare solo dai “duri” fatti economici, ma dovettero trarre forza da un comples-so di circostanze di ordine sociale e soprattutto culturale. Furono i saperi, la conoscenza, l’attitudine sperimentale e all’innovazione, un ambiente aperto e ricettivo verso la capacità di sperimentare e di innovare che, insieme a istituzioni capaci di assecondare e migliorare la vita, l’iniziativa, la capacità imprenditoriale dei membri della società, permisero di fare della Gran Bretagna un paese ricco e potente, senza eguali nel resto del mondo. Il concetto su cui (giustamente, a nostro avviso30) insiste a que-sto proposito Mokyr – in base al proprio assunto secondo cui “ciò che le persone credono e pensano ne influenza il comportamento economico” – è quello di “useful knowledge”, definito anche “il più grande e potente agente di cambiamento storico”. Questo concetto, che non ha a che fare tanto con le istituzioni e i processi educativi (che restarono sostanzial-mente estranei alla formazione di un tessuto culturale imprenditoriale) quanto con un atteggiamento culturale e comportamentale diffuso, gli consente di stabilire un nesso causale bidirezionale fra trasformazioni economico-sociali sostenute e durature e fatti culturali, in particolare quelli che Mokyr considera propri di una cultura illuministica, intesa in senso propriamente “encyclopédique”, ossia come tutto ciò che scatu-risce e insieme alimenta curiosità scientifica, innovazione tecnologica, culto del lavoro manuale e della tecnica, sociabilità culturale e scambio internazionale di saperi pratici protesi al miglioramento della condizione umana e capaci di alimentare nuovi profili di imprenditori sperimenta-tori: insomma, un Illuminismo industriale e una economia illuminata. Ebbene, una cultura illuministica così intesa fu capace di produrre una
30 Sull’importanza di un concetto analogo e del corrispondente atteggiamento intellettuale ravvisa-bile in un autore scozzese di fi ne Settecento, ma estendibile a una diffusa visione contemporanea della società e del ruolo dei suoi singoli membri, ci siamo soffermati a suo tempo in Commercio, colonie e impero alla vigilia della Rivoluzione americana, Olschki, Firenze 1989, pp. 13 sgg. e 420-427. Vale la pena sottolineare la straordinaria analogia tra l’interpretazione di Mokyr e la visione ela-borata da John Campbell nel 1774 dei progressi della Gran Bretagna come frutto degli «artifi cial expedients for facilitating the progress of national improvement».
Guido Abbattista
270
serie graduale di migliorie e positive influenze dalle quali emerse “il mondo illuminato del XIX secolo: non l’età dell’Illuminismo, ma un’età illuminata”. E se ciò poté avvenire fu grazie alle sempre più ampie con-dizioni sociali e istituzionali di libertà e tolleranza in ogni sfera della vita pubblica che, realizzatesi in Gran Bretagna lungo tutto l’arco di un secolo e mezzo, dissolsero lentamente le vestigia dell’antico regime senza farlo giungere mai sull’orlo di una crisi acuta e di uno stallo e agevolarono la trasformazione dell’innovazione in crescita economica e della crescita economica in sviluppo e progresso civile. Da questo punto di vista pare non esserci dubbio che, se si vuole trattare in termini comparativi di “crisi dell’antico regime”, quello della Gran Bretagna continua a presentarsi a tutti gli effetti, anche nella letteratura più recente, come un caso unico, sebbene il dibattito storiografico non mostri segni di stanchezza nel tene-re aperta la questione dell’eccezionalità britannica, per esempio sul tema cruciale del perdurare di politiche mercantilistiche, le si consideri tipico retaggio di un ordine antico duro a morire oppure il frutto di una com-mistione tra politica ed economia che nel mondo britannico assunse i tratti originali di una permanente negoziazione tra società e istituzioni31.
31 Cfr. per esempio P. GAUCI (ed.), Regulating the British Economy, 1660-1850, Ashgate Publishing Ltd, Farnham 2011.