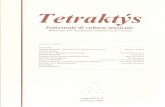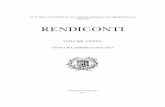La tradizione manoscritta dei trovatori genovesi, (2004) 2006
Postille alla «Tradizione manoscritta della Mulomedicina di Publio Vegezio Renato»
Transcript of Postille alla «Tradizione manoscritta della Mulomedicina di Publio Vegezio Renato»
SILENO RIVISTA DI STUDI CLASSICI
E CRISTIANI
FONDATA DA QUINTINO CATAUDELLA
ANNO XXIV· NUMERO 1 I 2
[ESTRATIO]
igg8
AGORÀ EDIZIONI
POSTILLE ALLA «TRADIZIONE MANOSCRITTA DELLA 'MULOMEDICINA' DI PUBLIO VEGEZIO RENATO»
VINCENZO ORTOLEVA
Dopo più di tre anni dalla pubblicazione del mio libro sulla tradizio-ne manoscritta dei Digesta artis mulomedicinalis e della De curis boum epi-toma di Vegezio1 si rende necessario aggiungere in questa sede alcuni dati supplementari, fomiti perlopiù dall'uscita nel 1997 degli indici complessivi dei sei volumi dell'Iter Italicum di P. O. Kristeller2• Tale oc-casione si presta inoltre a commentare alcune osservazioni espresse da M. D. Reeve in una sua recensione allo stesso libro3•
1. ADDENDA ALLA TRADIZIONE MANOSCRITTA.
1.1 I Digesta artis mulomedicinalis e la De curis boum epitoma.
Ai 19 testimoni elencati e descritti alle pp. 8-13 va aggiunto4:
1 V. Ortoleva, La tradizione marwscritta della uMulomedicina» di Publio Re-nato, Acireale, Editrice Sileno, 1996, pp. 21 i. Nel titolo di questo libro il termine Mulomedicina indicava complessivamente, secondo la communis opinio, due opere che in realtà debbono essere mantenute distinte: i Digesta artis mulomedicinalis (libri 1-3 della «Mulomedicina») e la De curis boum epitoma (libro 4). Ciò è stato da me di-mostrato nell'Appendice dello stesso libro (191-194). Da quel momento in avanti ho preferito pertanto attenermi esclusivamente a questa terminologia.
2 A cumulative index to volumes I-VI of Paul Oskar Kristeller's Iter Italicum, Leiden -New York - Kòln 1997·
3 «CR» 47, 1997• 317-320. •1 Prima di inoltrarci nei problemi riguardanti la tradizione di queste due opere sarà
bene fornire qualche cenno sui mss. e sulle loro famiglie (una trattazione particolareg-giata è rinvenibile in Ortoleva, op. cit., 7-59 e 187-189). A parte due mss. frammentari (S [VI sec.]; C [IX sec.]) che non contengono passi discussi in questa sede, i testimoni dei Digesta artis mulomedicinalis e della De curis boum epitoma sono i seguenti: L (a. 1537), W (sec. XVI), F (sec. XN), Ve (sec. XIII), A (sec. XV), B (sec. XV ex.), G (a. 1488), O (a. 1489), Q (sec. XV ex.), T (sec. XV ex.), Y (sec. XV ex.), H (XNsec., florilegio),M (sec. XV ex.), N (sec. XV ex.), P (sec. XN), U (a. 1441), V (sec. XV ex.), 7t (editio princeps, a. 1528). LW sono due copie umanistiche di mss. databili assai probabilmente in epoca alto-medievale; essi rappresentano il ramo potiordella tradizione. FVe costituiscono la famiglia E, caratterizzata dal ratto che la De curis boum epitomasi rinviene erroneamente posizionata
Vincenzo Ortoleva
J Jena, Thiiringer Universitats- und Landesbibliothek, G. B. f. 14, cartaceo, sec. XV, 280 x 205 rrim., I+66 ff., Il. 235•
La copertina è costituita da un foglio pergamenaceo una volta ap-partenente a un altro manoscritto. In alto a destra si legge: «Manca in questo codice la prefazione del 4 ° libro, la quale fu pubblicata nella Biblioteca Latina dal Fabricio, sopra un Codice dell'Abbazia di Gorbia, riscontrato dal Gudio. 7, Gennajo 1847».
Al f. 1, all'interno di un medaglione si legge: «In hoc codice contine-tur opus egregium Publii Vegetii Renati illustris uiri de infumitatibus boum et eorum :rnedicamentis exaratum fideliter et transumptum ex originali libro bibliothecae illustrissimi ac magnanimi ducis Vrbini pro Pierfrancisco Gonello huius artis mascaltiae peritissimo»6• Al f. 2 è ripro-dotto uno stemma recante l'immagine di due zufoli, con la scritta «CIVFFOLl». Ai ff. 2-2v si rinviene, senza alcun incipit, l'elenco dei capi-toli del terzo libro della «Mulomedicina» così com'è tràdito dai testimo-ni del gruppo ç ( 1. De morbis boum et primo de malleu, 2. Si uermes animal Jece-rit, etc.). A metà del f. 3v, dopo l'indice, si legge: «Expliciunt capitula, incipit prohemium libri tertii»; quindi segue (fino al f. 51) ciò che nel gruppo ç costituisce il terzo libro, ma che in realtà sono la De curis boum epitoma (il cosiddetto quarto libro della «Mulomedicina») e i capitoli 66-149 del secondo libro dei Digesta artis mulomedicinalis. Al f. 51 si legge: «Explicit liber tercius uegetii. Incipiunt capitula quarti libri»; seguono (ff. 51-5iv) i capitoli di ciò che in çè considerato il quarto libro (in realtà il terzo libro dei Digesta) e quindi il testo di tale libro (ff. 5iv-64v), non preceduto da alcun prologo, così come si rinviene in ç.
fra i capp. 64 e 65 del secondo libro dei Digesta. ABGOQ1Y rappresentano il ramo più tardo della tradizione (ç); in esso il De curis boum si trova fra i capp. 65 e 66 del secondo libro dei Digesta. HMNPUV (gruppo y) tramandano un testo abbreviato e modificato in molti punti (ma riportante le due opere secondo l'ordinamento corretto come LW). Inquadrabile nel gruppo y è anche R (XV sec.), che tramanda una traduzione italiana (eseguita da Giovanni Brancati) delle due opere vegeziane. L' editioprinceps (7t) è il risulta-to della contaminazione di due manoscritti: uno assai vicino adA, l'altro in qualche modo affine a LW. Le famiglie yfl; sono in buona misura imparentate tra loro, mentre LW devo-no essere collocati in un ramo a parte. Occorre infine precisare che alcuni manoscritti sono copie di altri a noi noti; essi, non rivestendo alcun interesse per la constitutio textus, non saranno citati in questo studio: si trattadi GO (copie di A) e di V (copia di N).
5 Il ms. si rinviene menzionato in P. O. Kristeller, Iter Italicum, 3, London -Leiden 1983, 411.
6 Si noti che a Urbino già prima del i482 era conservato un ms. della «Mulo-medicina» di Vegezio: llegetii Renati uiri illustris liber de Mulomedicina (cfr. M. Manitius, Handschriften antiker Autonm in mittelalterlichen Bibliothekskatawgen, Leipzig i935, 204).
Postille
Dalla struttura di tale manoscritto appare evidente che si tratti di un testimone appartenente al gruppo ç (il ramo più tardo della tradizione) mutilo dei primi due libri (cioè del primo libro e dei capitoli 1-65 del secondo libro dei Digesta). Con ogni probabilità tale mancanza era pro-pria anche dell'antigrafo diJ, dato che nel medaglione del f. 1 si dice che il testo era stato «exaratum fideliter et transumptum ex originali libro». L'assenza dei primi due libri (e dell' inscriptio dell'opera) e il fatto che il manoscritto iniziasse con il prologo della De curis boum epitoma aveva poi fatto scrivere nello stesso medaglione che «in hoc codice conti-netur opus egregium Publii Vegetii Renati illustris uiri de infirmitatibus boum et eorum medicamentis», sebbene a partire dal f. 15v si legga il testo dei Digesta artis muwmedicinalis.
Rimane da appurare in quale particolare àmbito del gruppo ç si collochi J. Si consideri a tal proposito la seguente tabella7:
LW y EAlt BQTY 1 2.71.1.2 testium dolor dolor dolor eA dolor dolor QT"'Y"' do lor
renum li doler renum BTP'YP'
ibid. qui his qui his qui his eA his li quibus BQY qui his T qui bus (qui his a con:J')
2.71.2.7 sa gis L : agis ragis ragis eA sagis ragis Q ragis w .M"'N"'PU li tangis Ba (asteriscum
sagis MP'Nfx carr. y sagis add.f) acarr.T
2.7t.2. testes fricando testes fricando testes fricando testes perun- testes perun-ICHl perungues L : perunges perunges E ges fricando ges fricando
testes fricando testes perun- QTY testes per uenas per- ges fricando perunges B unges W Ali
2·74·1.4 asphodulae L affodilli MP affodilli eA ascondilli ascondilli sphondoliae W affodili U aphodilli li BQTY
afrodili N"' asfodeli Nfx
2.76.1.11 pinguibus pinguibus pinguibus E pigribus pigribus pigris Ali BQTY pinguibus mg. T
2.nt.11 si uero sanguinem si uero sangui- si uero sangui- si uero sanguinem reiacto si uero sanguinem
7 Ho evitato di riportare il testo dell'ultima edizione dei Digesta e del De curis boum (P. Vegeti Renati Digestorum artis mulamedicinae libri, ed. E. Lommatzsch, Lipsiae 1903), per-ché per molti versi inaffidabile e fuorviante (cfr. Ortoleva, op. cit, 140-142). Le citazioni seguono tuttavia, per motivi di comodità, la suddivisione in capitoli, paragrafi e linee rin-venibile in tale edizione. Nei casi riprodotti in tabella le lezioni genuine (tranne che a 2.74.i.4, dove l'originale asplwdelinon è riportato da nessun testimone) si rinvengono
Vincenzo Ortoleva
reicit W: si uero nem (-ne NU) nem reiecto T (mg. uomat add. TI) uomat animai reicit L reiecto E ·si uero sangui- si uero sanguinem *** QY
nem uomat Alt (uomat in lacuna YI) si sanguinem uomat B
2.79.2.19 quam extensionem quod extensio quod extensio est quod extensio est quod extensio est est E.A quod extensiones
et li
2.79.11. si (cum W) si ex intesti- intestinum ex in intestino ex in intestino ex 13-14 intestinum norum ulcere ulcere uenerint ulcere uenerunt ulcere uenerunt
exulcerauerint uenerint E in intestinis ex (cum ex li) ulcere uenerunt Alt
2.129.9.8 infundis in infundis. uini in passi ss. III T in inpassi ss. III passi sext. tribus passi ss. III F (uini mTI) in W: infundis. in inpassi ss. III Q infundes in passi ss. Ili Ve uuae passae ss. passis sext. III L infundis in pas- III B uuae (in ms.
si sextariis 3 li add. Y2) passae uini passi ss. III A (ex passi) ss. Jll Y
All'interno di ç, J si distacca nettamente da A (il testimone più an-tico di tale ramo della tradizione) per concordare in errore con BQTY (2.74.I.4, 2.76.I.11, 2.79.1 I.13-14). Nell'àrnbito di quest'ulti-mo gruppo J appare porsi in posizione separata da B, che concorda con la seconda mano di Y in alcuni interventi congetturali (cfr. 2.71.2.7, 2.129.9.8). Non sono tuttavia assenti inJ punti che farebbe-ro pensare a qualche fenomeno di contaminazione all'interno di ç (dr. 2.77.I.11)8; significativo è inoltre l'accordo con Q a 2.129.9.8. In conclusione, con J ci troviamo di fronte a un testimone assai tardo, tramandante una fase del testo peraltro altrimenti ben nota. Di esso si può fare tranquillamente a meno ai fini della constitutio textus.
*** Nel corso della descrizione del codice M (Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana, lat. 45.18, sec. XV, ff. 100)9 mi era sfuggito un partico-lare che si rinviene ai ff. 73v-75'·. Al f. 73 finisce il testo della De curis boum epitoma in modo analogo a quanto accade negli altri testimoni
tràdite da LW; quando vi è un disaccordo fra i due mss. la lezione corretta è quella che precede i due punti.
8 J presenta inoltre delle correzioni operate da una seconda mano (soprattutto ai ff. 5v-1S e al f. 50) sulla base di una collazione verosimilmente con un altro esponente di ç.
9 Ortoleva, op. cit., io.
Postille
del ramo y della tradizione (di cui M fa parte): cap. 1 7 seguito da un capitolo sulla rabbia non rinvenibile in LWelJ't (Rabiosis equis et canibus da bibere rasuram de ylienua et sanantur M). In M si legge quindi «DEO GRACIAS» e, sotto, scritto dalla seconda mano (la stessa a cui si de-vono le numerose aggiunte marginali) «Prohibendum est ne equus possit se lingere in aliquo suo uulnere». Ai ff. 73v-75v, senza incipit né explicit, sono copiati (probabilmente sempre dalla seconda mano) i capp. 154-25 della De curis boum epitoma. Il f. 76 è bianco. Ai ff. 76v-1 oo si rinviene - come si è già detto - un anonimo trattato de re mili-tari tradotto dal greco in latino da Sofiano, preceduto da un'epistola introduttiva indirizzata a Lellio della Valle.
Il perché di questo addendum rinvenibile nei ff. 73v-75v di M (che d'ora in poi chiameremo K) ritengo debba essere spiegato con il fatto che nei manoscritti del gruppo y il De curis boum è mancante dei ca-pitoli 18-25; tale mancanza avrà spinto la seconda mano di Ma inte-grare il testo con l'ausilio di un manoscritto diverso da quello da cui era stato copiato il testo dei ff. 1-73• sebbene debba essere notato che Me K di fatto si sovrappongono per cur. boum 154-18. Ciò che è più rilevante indagare è tuttavia la fonte di K e di conseguenza la sua im-portanza per la constitutio textus dell'opera vegeziana.
Il testo di K, a differenza di quanto si rinvenga in Ly per le corrispon-denti porzioni di testo, non è suddiviso in capitoli titolati; in Knon si va inoltre mai a capo a fine periodo; una situazione analoga si rinviene in WelJ't. Unici fatti grafici degni di rilievo sono il leggero rientro a sinistra della prima parola di 15.4 ( Sz) e il fatto che la prima parola del cap. 18 (Machine) sia scritta quasi completamente sul marginç sinistro, proba-bilmente a seguito di una correzione.
Un'analisi comparativa di K con gli altri testimoni del De curis boum mette in evidenza una strettissima parentela tra K ed F, un mano-scritto che fa parte del gruppo E ma che deriva da un esemplare for-temente contaminato con un esponente di y10• Tale conclusione può essere dimostrata dalla seguente tabella, in cui alle lezioni della tradi-zione manoscritta vegeziana è stato giustapposto anche il corrispon-dente testo di Columella, fonte pressoché esclusiva del De curis boum. Quando uno o più rami della tradizione vegeziana concordano con il testo di Columella si può ragionevolmente ritenere che si tratti di le-zioni genuine11 •
1° Cfr. Ortoleva, op. cit., 2g-31. 11 Anche in questo caso le citazioni seguono la suddivisione in capitoli, paragra-
fi e linee dell'ed. di Lommatzsch (cit.). Tutte le citazioni del De re rustica di
i86 Vincenzo Ortoleva
K F Altri testimoni Columella12
154.21 cum aqua cum aqua aqua LWy : rum a qua aqua Vetlt
15.p2 lauanda lauando diluenda L dela- inlinenda branda W lauanda yVetlt
15 .. p auena auena auia WVeABTP'ì' : auia abia L aura T"' ama li auena NU auenarnMP
154.2-3 clauorum qui ceruicem clauorum qui clauorum qui clauorurn, qui minorem ceruicem minorem ceruicem infestant fere ceruicem
minor molestia est minor W clauorum quidem molestia est ceruicem infestant minor modestia est L clauorum qui ceruicem infestant minorem est Ve qui ceruicem infestant (-stat B) minor est ç quae ceruicem infestant minor est cura li om. y
15.5.5 caluiscant caluiscant caluescant W caluescant calliscant L caluiscant ç caluescunt li clauiscant Ve om. y
15.5.7 in opere madefacta in opere madefacta in opere madefacta in opere madefacta est est est WVeB: est
madefacta est in opere ATYll in opere defricata est L om. y
15.5.8 boues boues bouis ATYll : ·ues -WVeB bobis L"' bouis I)c om. y
15.5.9 siccati fuerint siccaù fuerint adsiccauerint LW : adsiccuerint exsiccaù fuerint Vetlt om. Y
i bi d. uinum (cc-no) et uino et oleo subinde oleo LW : subinde oleo oleum e.xinde oleo iterum
Columella sono invece tratte da L. luni Moderati Columellae Opera quae exstant, ree. V. Lundstrom, fase. 4 (Res rust. li. 6-7), Gotoburgi 1940.
12 Ecco qui di seguito le corrispondenze fra i passi citati del De curis boum e il De re rustica di Columella: cur. boum 154-5 - Colum. 6.14.6-7; cur. boum 16 - Colum. 6.15.1-2; cur. boum 17 - Colum. 6.15.2; cur. boum 24- Colum. 6.18.1-2.
Postille
16.1.11 uomere uomere uomere W : -mer uomere
16.I.13 imponilo et ungilo imponilo et ungitG inurito W: inurito imposuto L imponito et ungito B'IYll imposito et ungilo VeA instilla et ure y
16.1.14 optimum optimum optimeLW: optime -mum Eljt om. y
16.1.15 pertuderit pertunderit pertuderit LW : pertuderit perrussa fuerit y protunditur AVe pertunditur 'IYll
16.1.17 praecepi praecepi praecepi : praecepi dixi y dixerint L
ibid. aperte aperte spartea W : spania L spartea ex parte Ali om. y
16.2.18 crura cruras crus LWVey : om. Ali crus
IH-5 huhulina urina huhulina urina huhula urina W : huhula urina huhum Iaurinam L huhulina urina
17-7 inunguntur inunguntur eius unguntur : eius unguntur superpone y
i bi d. tamen tamen minus tamen minus tamen claudicahunt claudicahunt claudicahunt LVe : claudicahunt
et daudicahunt W minus tamen daudicant om. y
17.8 disiuncti disiuncti disiunctis disiunctis -ti Lom. y
ibid. Iauenttir pedes Iauentur pedes pedes Iauentur Iauentur pedes
24.1.17 praedudit praedudit praeclusit transitum cihis transitum citius transitum ciuis transitum cihis W ·praecludit
induditur (-detur pc) aut si cum cihis L praedudit transitum ceruicis Ve om.
24.1.3 recedit recedit decidet L : decedet decidit W recedit om. y
24.2.3 cimicum cimicum cimicisLWVe: cimicis cimini
ibid. si super super super om. y -24.24 et uhi sanguisuga uhi sanguisugam uhi sanguis -
188 Vincenzo Ortoleva
fuerit afflauerit afflauerit (spatium album sequitur) W ubi sanguisugam afflauerint L ubi sanguisucam (-ca Ve -gam !t) afflauerit Vel}t om. y
i bi d. euellet eam euellet uellit W reuellit L -euellet Vel}t om. y
24.2.5 qui sisit qui quodsi LW!}t: si tamen qui Ve am. y
24.2.6 effuso effuso infuso LW!}t : infuso infusum Ve om. y
Come si può notare da tali raffronti, F e K concordano quasi co-stantemente. Si vedano in particolare i casi in cui entrambi i testi-moni riportano corruttele non riscontrabili altrove (o comunque non al di fuori di y): 15.41, 15+2-3, 15.5.9, 16.i.17 bis, 16.2.18, 17.7, 24.2.3, 24,.2.6. I casi di discordanza tra F e K sembrano vice-versa tutti imputabili a tentativi da parte del copista di K di inter-pretare o sanare ciò che in F è poco chiaro o manifestamente cor-rotto: si noti quanto avviene a 15.4.22, 15.5.9 bis, 16.i.15, 16.2.18, 24.i.17, 24.2.3 bis, 24.2.4, 24.2.5. Tutto ciò sembra far concludere che K sia stato copiato direttamente da F - manoscritto conservato fra l'altro, al pari di M, presso la Biblioteca Medicea Laurenziana a Firenze (lat. 45.19, sec. XIV) - e che la sua importanza ai fini della constitutio textus sia praticamente nulla.
Esiste tuttavia un altro aspetto nel testo del De curis boum tràdito da K che merita di essere indagato. Come si è potuto notare dalla tabel-la sopra riportata, i casi di concordanza fra F e K non vanno oltre cur. boum 2+2. Nell'ultimo capitolo del trattato (cur. boum 25) il testo trà-dito da K diverge infatti sensibilmente da tutti i restanti testimoni a nostra disposizione (F compreso). Ecco riportato qui di seguito il testo in questione così come lo si legge in K, nel resto della tradizio-ne e nel corrispondente passo di Columella (6.19.1-3) 13:
K Machinae quoque describenda est fabrica, qua clausa cuiusuis generis iumenta bouesque curantur, ut et tutus ad pecudes medentibus sit ac-cessus: nec in ipsa curatione quadrupes reluctando remedia respuat aut
13 Anche in questo caso si è preferito non riportare il testo stabilito da Lommatzsch (ed. cit.); il testo riprodotto sotto la dicitura «Altri testimoni» è stato da me stabilito e corredato di apparato critico.
Postille i8g
membra conuexet. Roboreis axibus compingitur solum quod in longitu-dinem nouem pedes debet habere, et in làtitudinem pars prior pedes duos semis pars posterior pedes quatuor quae ad posteriora animalium pertinent hi quatuor pedes texuntur transuectis temonibus ita ut uelut in caueam inductum animai non possit exire ab ea posteriori parte ubi pau-lum latior est. A priore autem parte machinam strictiorem compingi oportet cui transuersus tigillum ad modum iugi cof)stituendum est: ad quod equorum capita uel boum comua religentur: nam reliquum corpus ad temones loris uel funibus alligetur: ut immotum praestetur medentis arbitrio. Haec machina ad omnium maiorum animalium medelam solet esse communis.
Altri testimoni Machinae quoque describenda est fabrica, qua conclusa cuiusuis generis iumenta bouesque curantur, ut et tutus ad pecudem medenti accessus sit nec luctando quadrupes aut membra conuexet aut remedia respuat. Roboreis assibus constringetur solum, quod in longitudinem nouem pedes debet habere, in latitudinem pars prior duos semis pedes; pars uero quae ad posteriora animalium pertinet quatuor pedes. 2 Huius la-tera de tigillis texuntur ita ut uelut in caueam inductum animai non pos-sit exire, sed a parte posteriore paulo latiorem, a priore constrictiorem machinam compingi oportet. 3 Cui transuersum tigillum ad modum iugi configendum est, ad quod equorum capita uel boum comua religentur. Nam reliquum corpus ad temones loris uel funibus alligetur ut immotum praestetur ad medentis arbitrium. Quae machina omnium maiorum ani-malium medelis solet esse communis.
deest in SCy Il 1 machinae LWeç : -na 7t Il qua Leç : quo W Il conclusa LWVeljt: cum elusa F Il et tutus ad eljt: tutus ad W tusam L Il pecudem LVeljt : pecudes W pedem F Il medenti Lomm. : -di LWe -dum ART7t re-medium Y Il nec Leljt : ac W Il luctando WE7t : -dum L lutando ç Il qua-drupes eljt : -pedes LW Il conuexet LWE7t : connexet ç Il aut LWe : ac si ç ac sic 7t Il respuat Lomm. : -puet LWe despuet ljt Il roboreis LW : -reas eljt Il assibus LJc : assebus Lac axissibus W asses Veljt axis F Il constringitur W : -getur L -gantur Ve -gi FBTY -gis A1t Il solum quod LWF : solium quod VeATY7t solumque B Il longitudinem LWFç : -ne Ve7t Il in latitudinem Lomm. : et in I- L in altitudinem WVeATY7t inualitudinem F om. B Il prior Lomm. : posterior LWeljt Il duos WBE7t : duo L duae ç Il semis pedes LW : semipedes eç simipedem 7t Il pars uero LW7t : pars uero pedis Veç par sub-pedis F Il ad posteriora Lomm. : ad priora LWeljt Il pertinet Leljt : -nent w.
2 huius latera de tigillis om. eljt Il tigillis W : te- L Il ut om. L Il uelut LWY mg. T: uelum eAR7t Il caueam W: -uea L caucam Ve caudam Fljt Il inductum We : intactum L ductum ART7t deductum Y Il animai LW : om. eljt Il possit LJcWeljt: -set Lac Il posteriore L: -ri Weljt Il paulo LW: -lulum
Vincenzo Ortoleva
E/jt li latiorem We/jt : -re L li constrictiorem L : strictiorem We/jt li com-pingi L1t : -pungi El; -poni W.
3 transuersum WETY1t : trabersum L tranuersum B Il tigillum LWEBTP<YP< : tri- AT0cY0"lt li configendum LVe : confringendum W confri-gendum F confirmandum /jt li ad quod equorum We/jt: ad quorum L Il religentur LJcWe : religantur /jt ligentur Lac li ad temones LWTP"TC : ad ti-mones VeATacy ad timonem B atimones F li loris 'f2 s. l. : socis ET soccis B socios AY soc os (sic) 1t fictos L om. W Il alligetur E/jt: -gatur LW li im-motum LW : immatum E inuiatum T imustum Y uinctum B mg. Y iu-mentum mg. T iuuamentum A1t li ad LWVe/jt: ac F Il arbitrium LWBTY1t : -trio Ve -tri;;t A -tri F Il omnium eç : ad omnium 1t ouium W om. L li maio-rum LE/jt : -rem W li medelis L : medetis W medela eç medelam 1t Il com-munis LE/jt : comu- W.
Colum. 6.19.1-3 Sed et machina fabricanda est, qua clausa iumenta bouesque curentur, ut et propior accessus ad pecudem medentibus sit nec in ipsa curatione quadripes reluctando remedia respuat. Est autem talis machinae forma: roboreis axibus conpingitur solum, quod habet in longitudinem pedes nouem et in latitudinem pars prior dipundium semissem, pars posterior quattuor pedes. Huic solo septenum pedum stipites recti ab utroque la-tere quaterni adplicantur. Ii autem in ipsis quattuor angulis adfixi sunt, omnesque transuersis sex temonibus quasi uacerrae inter se ligantur, ita ut a posteriore parte, quae latior est, uelut in caueam quadripes possit in-duci nec exire alia parte prohibentibus aduersis axiculis. Primis autem duobus statuminibus inponitur firmum iugum, ad quod iumenta capi-. strantur uel boum cornua religantur, uhi potest etiam numella fabricari, ut inserto capite descendentibus per foramina regulis ceruix catenetur. Ceterum corpus laqueatum et distentum temonibus obligatur inmotum-que medentis arbitrio est expositum. Haec ipsa machina communis erit omnium maiorum quadripedum.
Non è facile fornire una spiegazione dei motivi per cui K si com-porti riguardo al cap. 25 tanto diversamente da quanto aveva fatto registrare in precedenza. Alcune varianti potrebbero derivare dalla collazione del testo leggibile in F direttamente con quello di Colu-mella14 ( clausa; ad pecudes medentibus sit accessus, in ipsa curatione, ecc.). Altre differenze tra F e K incontrano però maggiori difficoltà
M La seconda mano di M, alla quale si deve assai probabilmente la copiatura di K, era a conoscenza che il De curis boum di Vegezio ha come fonte principale il sesto libro del De re rustica di Columella. Riferimenti a Columella si rinvengono infatti ai margini dei ff. 69 («Columella eidem»), 70 («hebetes ex colum.»), 71 («colum.») e 73 ( «columela auiam appellat»).
Postille
a essere interpretate secondo tale criterio. Si veda ad esempio al pa-ragrafo 2 la presenza di animal, che si riscontra solo in LW, mentre in Bç1t è omesso e in Columella si legge quadripes. Si consideri inol-tre la lezione loris, che nei restanti testimoni è tràdita solo dalla se-conda mano di T e che non è ricavabile da Columella. Per contro, il modo in cui in K si rinviene il testo da roboreis a texuntur non è perfettamente perspicuo: quae ad posteriora animalium pertinent hi quatuor pedes texuntur sembra quasi un tentativo poco riuscito di col-mare la lacuna presente in eç (e quindi anche in F), dove si legge più o meno: pars uero Pttdis quae ad priora animalium pertinet quatuor pedes texuntur. .. Mentre appare più corretto ciò che si può ricavare dalla collazione di LW: ... pars uero quae ad posteriora animalium perti-net quatuor pedes. Huius latera de tigi,ZZis texuntur... In conclusione, propenderei per ritenere la diversa redazione di cur. boum 25 in K il risultato di un'attività congetturale corredata dell'ausilio del testo di Columella; tale attività ha avuto l'effetto di cogliere nel segno in almeno un caso (anima[) e di giungere a esiti poco felici in altri. Non mi sembra del resto proponibile ipotizzare - in base a un passo così limitato e di cui disponiamo della congiunta testimo-nianza di LW - l'esistenza di una redazione così diversa (e in vari punti assai più fedele alla fonte utilizzata da Vegezio) non altri-menti attestata.
1. 2 La «Medela equorum» di Teoderico da Cervia.
Ai g manoscritti elencati alle pp. 87-88 del mio libro va aggiunto:
1) Torino, Bibl. Nazionale, 791 (E-VI-4), (XIV sec.) 15•
1.3 n primo volgarizzamento anonimo (t).
Ai 22 manoscritti elencati alle pp. 144-146 vanno aggiunti:
1) Paris, Bibl. Nationale, ital. 452 (sec. XVI); 2) Paris, Bibl. Nationale, ital. 456 (sec. XVI) 16;
3) Pisa, Bibl. Arcivescovile Card. Pietro Maffi, s. n. (sec. XV) 17;
15 Inoltre, al nr. 6 (op. cit., 87) in luogo di «Padova» si legga «Pavia». 16 Su questi due codd. parigini cfr. G. Mazzatinti, Inventario dei manoscritti italia-
ni delle biblioteche di Francia, i, Roma 1896, 95. 17 Cfr. Kristeller, op. cit., 6, London - Leiden 1996, 141; si veda anche N.
Caturegli, Codici e manoscritti della Biblioteca Arcivescovile «Cardinale P. Maffi», Pisa, «Bollettino Storico Pisano» 31-32, 1962-63 (1965), 222-223, nr. 3.
192 Vincenzo Ortoleva
4) Roma, Biblioteca Nazionale, V. E. 12 (sec. XV) 1B;
5) Siena, Biblioteca Comunale, I.VII.9 (sec. XV); 6) Siena, Biblioteca Comunale, L.VI.13 (sec. XV); 7) Siena, Biblioteca Comunale, L.VI.14 (sec. XV); 8) Siena, Biblioteca Comunale, L.VII.13 (a. 1485) 19•
2. UNA RISPOSTA A M. D. REEVE
In «CR» 4 7, 1997, 3 17-320 è apparsa - come si è già accennato - la recensione di M. D. Reeve al mio libro su Vegezio20. Benché Reeve non abbia potuto non ammettere che «0. has worked with impressive thoroughness» e che il mio libro occupa «a distinguished place in recent work on textual traditions»21 , egli perviene a conclusioni assai discutibili che necessitano di essere analizzate singolarmente in questa sede22.
- «O. [ ... ] argues from agreements instead of shared innova-tions»23. Reeve adduce come presunta prova della sua affermazione alcune mie considerazioni preliminari sulla struttura dell'opera ve-geziana nelle varie famiglie di manoscritti. Come ho più volte fatto notare, in LWy la De curis boum epitoma (il quarto libro della Mulo-medicina nell'edizione di Lommatzsch) si rinviene dopo il terzo (e ultimo) libro dei Digesta artis mulomedicinalis', in E il De curis boum si trova invece inserito tra i paragrafi 64 e 65 del secondo libro dei Digesta; in IJt il De curis boum si trova tra i paragrafi 65 e 66 sempre del secondo libro dei Digesta. Questa osservazione (posta subito
18 Per i quattro mss. senesi (della cui esistenza sono stato gentilmente informato dal Dr. Marcello Aprile) cfr. L. Ilari, La biblioteca pubblica di Siena dispostq secondo le ma-terie, 7, Siena 1848, 13. Il cod. L.VI.14 sembrerebbe essere mutilo dei primi due libri.
19 Una sommaria descrizione si trova nel catalogo a schede della biblioteca: si tratta di un cod. cartaceo, di 202 x 135 mm., costituito da 134 ff. La traduzione della Muùnnedicina si rinviene ai ff. 1-129 ed è suddivisa in 5 libri.
20 Oltre a quella di Reeve il mio libro è stato oggetto di varie altre recensioni, tutte positive: I. Mazzini, «BollStudLatn 26, i996, 641-642; P. Rosa, «Eikasm6s» 7, 1996, 393-397; G. Polara, «Orpheus» n. s. 18, i997, 249-252; M. Conde, «Emeritan 45, 1997, 124-125; L. Bodson, «SAM Reviewn 24, 1997, 213; D. Gourevitch, «ACn 67, 1998, 439-440. Il mio libro ha inoltre stimolato uno studio particolare da parte di I. Mastrorosa (La tradizione manoscritta dell'opera veterinaria di Vi?gezio: note in mar-gine ad uno studio recente, «GIFn 49, 1997, 97-106).
21 Ree. ciL, 318. 22 Tralascio di norma di riportare in questa sede le osservazioni di minore im-
portanza e soprattutto quelle in cui si muovono critiche non suffragate da esempi o, peggio, non accompagnate da proposte alternative.
23 Ree. ciL, 318.
Postille 1 93
dopo la riproduzione degli stemmata - quasi del tutto erronei - di Lommatzsch24 e di Robles G6mez25) mi consentì di parlare in via preliminare di «tre blocchi ben definiti, di cui due molto vicini fra loro»26• Tali mie osservazioni non riguardavano ancora la delinea-zione di uno stemma, non essendo stato fatto alcun esame all'inter-no del testo fino a quel momento, ma avevano il solo scopo di fare chiarezza all'inizio della trattazione27• Come dire: esistono tre bloc-chi ben definiti di testimoni; vediamo ora in che rapporto stanno fra loro. Naturalmente anche in questa fase - che potremmo defi-nire esplorativa - non si è tuttavia lavorato su ciò che è sicuramen-te genuino ma su ciò che sicuramente non lo è: la struttura errata dieeç.
- «and as O. argues that the arder in ç was a deliberate adjustment to the arder in e, he still needed to prove ç independent of e»28• Mi sembra di aver dimostrato assai ampiamente (cfr. pp. 16-19, 29-31; si veda pure tutto il cap. 6) che ç costituisce nient'altro che un ramo più tardo della tradizione dipendente dallo stesso subarche-tipo dal quale deriva e (p nello stemma di p. 189).
- «his reasons for continuing to associate LW are invalid»29• Questa è l'affermazione che più di ogni altra dimostra quanto Reeve possa essere vittima delle teorie di critica testuale formulate da Paul Maas. La sua acritica osservanza della dottrina degli errori congiuntivi e del-l'unicità dell'archetipo ha come inevitabile conseguenza quella di scartare l'ipotesi che anche solo il buon senso reputerebbe la più pro-babile. Ho ripetuto più volte che yeç sono accomunati da significativi errori comuni. Nessun errore che possa veramente essere definito congiuntivo è stato invece finora rinvenuto in LW. Da un raffronto con il testo delle principali fonti utilizzate da Vegezio (Pelagonio, Mulomedicina Chironis e Columella) si può tuttavia tranquillamente affermare che il testo tràdito da LW (e, per quel che si può vedere, da SC 1t' Y ') è di molto più corretto rispetto a quello leggibile in yeç. Ciò però non significa che esso sia esente da errori ma solamente che
24 Ed. cit., XXVI. 25 J. M. Robles G6mez, Aportaciones criticas a una edici6n de la Mulomedicina de
gecio, «Emerita» 54, 1986, 303-316 (cfr. in particolare p. 316). 26 Ortoleva, op. cit., 15. 27 Ed è prova di ciò che nel mio stemma di p. 189 LW (e altri testimoni minori)
sono fatti discendere da a', yEI; da a". 28 Ree. cit., 318. 29 Ree. cit., 318.
1 94 Vincenzo Ortoleva
nella maggior parte dei casi non è possibile riconoscerli. Reeve di questo non tiene conto; egli non si accorge cioè che gli errori con-giuntivi assai difficilmente possono essere scorti agli stadi alti della tradizione30• Di qui la sua convinzione che Le W debbano essere sepa-rati. Ma se si tengono separati L, W e yeç ciò significa, secondo la logi-ca di Maas- e di Reeve -, che tali tre testimoni (o gruppi di testimoni) dovrebbero derivare da un unico archetipo altomedievale seguendo uno stemma tripartito. Se però ciò è probabilmente possibile in linea teorica non sarà mai praticamente dimostrabile, perché gli errori comuni a LWye' possono sempre essere fatti risalire a uno stadio della tradizione tardoantica piuttosto che a un archetipo dell'VIII-IX seco-lo. Il problema va invece risolto andando verso altre direzioni, che esulano dalla logica degli errori congiuntivi propriamente detti. In primo luogo bisogna definitivamente rinunciare a postulare che tutta la tradizione superstite delle due opere di veterinaria di Vegezio possa derivare da un unico archetipo altomedievale. Che gli archetipi fossero almeno due è testimoniato già dall'origine stessa dei manoscritti in nostro possesso31 : tutti i codici inquadrabili nei gruppi yeç sono di origi-ne italiana; SCL e n' (nulla di preciso si può dire per W) sono invece di chiara provenienza continentale. Se inoltre non è possibile rinvenire evidenti errori congiuntivi all'interno di quest'ultimo gruppo esistono tuttavia due palesi affinità strutturali che dovevano essere esclusive del-l'archetipo da cui LW - seppur indirettamente32 - discendono: 1) as-senza di incipit all'inizio dei Digesta; 2) indici dei tre libri dei Digesta posti all'inizio dell'opera e non prima di ogni libro come in 8' l\1PU (que-st'ultima era probabilmente caratteristica peculiare anche di n').
- «he associates Borgognoni's excerpts with LW and specifically with W (p. 99), but he nowhere discusses Prol. 9, where Borgognoni
3° Cfr. E. Flores, Elementi critici di critica del testo ed epistemologia, Napoli 1998, 76: «Più si risale nel tempo e minore è il numero degli errori congiuntivi che si rin-vengono per ricostruire un archetipo di datazione alta, fino al limite zero che indi-ca soltanto che, pur essendoci nel testo delle corruzioni, non riusciamo a vederle, per cui la corruzione annidata è uguale al testo genuino».
31 I due archetipi sono designati con le sigle a.' e a." nello stemma di p. 189 del mio libro. Sull'assoluta inverosimiglianza che la quasi totalità degli autori greci e latini discen-da da archetipi unici «salvatisi miracolosamente» cfr. ancora Flores, op. cit., 55 e 88-89.
32 Cfr. Ortoleva, op. cit., 27: « ... L e W devono appartenere alla stessa fumiglia, pur presentando ambedue un buon numero di errori singolari che non permetto-no di ipotizzare una stretta parentela dei due manoscritti. D'altra parte, LW in al-cuni punti significativi si distaccano tanto nettamente da yel; [ ... ] da non poter es-sere fatti discendere dallo stesso subarchetipo da cui yel; derivano».
Postille 1 95
shares peritia with yi;ç against the more rhythmical sapientia of LW (p. 92), and in another chapter one encounters innovations that Borgognoni shares with eç, namely 1.1.2 [stupentibus ... fiaccidis], i.i.4 consuetudini [pmtinae] (p. 109)»33• Qui Reeve si sofferma sugli excerpta dei Digesta fatti confluire da Teoderico Borgognoni ( 1205-1298) nella sua opera denominata Medela equorum. Gli esempi cita-ti da Reeve sono ben poca cosa in rapporto ai numerosi passi si-gnificativi riportati nel cap. 4 del mio libro (pp. 91-99). Fonda-mentale è inoltre quanto si rinviene in Teoderico e in W a dig. 2.89.2 (cfr. pp. la netta differenziazione del testo di Teoderico (e insieme la sua indubitabile superiorità) rispetto a quanto è riportato in yi;ç è tale da escludere una discendenza di-retta di questi testimoni da un subarchetipo in comune. I casi ri-portati da Reeve circa presunte concordanze in errori congiuntivi fra Teoderico ed eç sono del resto facilmente spiegabili in vari modi. Possono infatti essersi verificati in maniera indipendente guasti interni alla tradizione di Teoderico (semplici omissioni e ba-nali salti 'da uguale a uguale') o possono essere avvenute contami-
33 Ree. cit., 318. In realtà in Theod. med. eq. i.16 si legge pristirtae consuetudini. 3-t A dig. 2.58.2.19-21 la tradizione diretta presenta il seguente testo: Item subtritis pedibus prodest picis liquidae selibram, aceti heminam, salis seli-
bram, hederae folia quantum sufficit pariter contundis, et laboranti cotidie pedes perunges.
deest in SCL Il picis liquidae selibram ego : picis liquidae selib. 1t picis liquidam selibram W picis liquidae lib. s. y picem (pridem picem F) liquidam lib. s. E picem liquidam selib. Il aceti heminam, salis selibram W : aceti hem., salis lib. 1t om. Il hederae folia WF : foliorum hederae y hederae foliis VeYt; Il contundis y$ : contendere W Il perunges y$ : perungere W.
La fonte del passo è Pelagon. 264 (E= Einsiedeln, Stiftsbib!iot:hek, 304 (514); R = Firenze, Bibl. Riccardiana, 1179):
Item. Medicamen ad pedes subtritos. Picis liquidae selib., aluminis selib., aceti selib., salis selib., hederae folia quod sufficit: contundito omnia simul et equo la-boranti cotidie pedes perungito.
medicamen E : medicamine R Il aluminis R : inluminis E Il aceti selib., salis selib. ego: acetis elibram salis selibram E om. R Il cotidie pedes R: p- e- E Il perun-gito R : perunguetur E.
Ecco cosa si legge in Theod. med. eq. 3.1 o: Item subtritis pedibus prodest: picis liquidae lib. s., aluminis lib., aceti heminam,
salis lib. s., foliorum hederae quantum supradicta pariter contunde et equo labo-ranti cotidie pedes inunge.
Teoderico riporta dunque in questo caso una porzione di testo del tutto assente in e solo parzialmente in Wn.
Vincenzo Ortoleva
nazioni di essa con esponenti di El; (un caso inverso, esponenti di ç contaminati con Teoderico, è del resto attestato in TY) 35•
- «After giving the epitome y a subordinate place in the stemma, he had no need to discuss at length whether Vegetius himself could have produced it»36• La trattazione di y nel primo capitolo (pp. 27-29) serve solo a inquadrare tale famiglia nello stemma, ma le pro-blematiche offerte da questo gruppo di codici erano così vaste da necessitare un capitolo a parte (il secondo appunto). In particola-re, il paragrafo riguardante l'eventualità che y potesse derivare di-rettamente d,alla volontà di Vegezio (pp. 40-44) non sarebbe mai potuto essere inserito nel primo capitolo. Sull'opportunità o meno di trattare tale questione - prima o poi qualcuno l'avrebbe solleva-ta - non mi sembra possano esistere dubbi.
- «As far the family of y, four of the five conclusions that he draws from an oddly incomplete presentation of the evidence [ ... ] seem unjustified; more precisely, I cannot see why M should not de-rive from P, and it would be easier to uphold the independence of U than N, where inhorrescit at 2.112.1.7-9 is surely not the truth (n. 39) but an implausible correction or further corruption of the non-existent word offered by PMU, mordescit>>37• Da tali affermazioni si può solo notare come Reeve abbia le idee assai poco chiare sia sui rapporti interni alla cosiddetta «tradizione epitomata» (y) che sui rapporti di essa con gli altri rami della tradizione. Stupirsi che in una tabella comparativa finalizzata a considerare le varianti interne al gruppo y si siano riportate le lezioni di El; solo nei casi in cui il testo di LW non era disponibile dimostra infatti che lo studioso inglese non è riuscito a capire che El; presentano uno stadio del testo in-feriore sia a LW che a y. Quando pertanto si dispone delle lezioni di LW (cioè quando in tali testimoni non si rinvengono lacune), la cita-
35 Ecco cosa si rinviene in dig. i.56.26 dopo ... quae omnia confusa oportet apponi solo in TY THEOD. ( med. eq. i.15 p. 44 Dolz):
Extenuatus (extr-Tfx:) equus citissime impinguatur si per quattuor (s. Y) dies her-bam ad rorem posita pro uelle sibi detur. Postea minuatur annonamque (auenamque THEOD.) competenter praebebis et diebus singulis (et s- T) sulphur cum sale propina. Dicunt quidam quod (om. THEOD.) si cum cepe murium faciem (f.. iterauitY) et caput eius (equi THEOD.) fricaueris (-camus Y -cabis THEOD.) impinguatur (-bitur THEOD.).
Non escluderei inoltre che Teoderico abbia lavorato sulla base di due mss. (uno affine a LW e l'altro a e) o, forse più verosimilmente, di un unico ms. con varianti.
36 Ree. cit., 318. 3; Ree. cit., 318-319.
Postille 197
zione del testo di et; è del tutto superflua; in tali famiglie di testi-moni possiamo infatti rinvenire: 1) lezioni genuine che concorda-no con LW (del tutto inutili ai nostri fini); 2) varianti erronee pro-prie di et; (anch'esse del tutto inutili in questa sede); 3) errori co-muni a y (che. possono solo ribadire la presenza di un subarchetipo in comune a yel;, ma che risultano assolutamente ininfluenti per in-dagare i rapporti interni a y).
Inoltre, è veramente singolare che Reeve ritenga di riconoscere l'indipendenza di U rispetto a MNPV. Voglio solo pensare che tale presa di posizione derivi,più da distrazione che da un reale convin-cimento. Mi era infatti sembrato di essere stato abbastanza chiaro quàndo a ·P,· 46 scrivevo:
Un elemento che può essere utile a una prima divisione in due classi dei manòscritti .della cosiddetta recensio 'epitomata' è il diverso modo in cui
. sono posizionati gli indici dei capitoli. Un sommario posto prima di tutta l'opera si· rinviene in NRV ... ; MPU presentano [ ... ] una distribuzione degli indici del tutto particolare ...
' . . . .. Si vedano poi i casi di divergenza testuale, con concordanza in errore di MPU, a i.i7.4,.18 (nullo plurimi medicinae auctoms MPU plurimi mu-l.omedicinae auctores LW NV); i.39.2.21 (imperitia uetus arriorum MPU imperitia ueterinariorum NV ueterinariorum imperitia et;7t deest in LW) ; 2.2.17-8 (mense uitatur HMPU; mens hebetatur NV et;7t deest in LW); ecc. Anche la presunta derivazione di M da P non offre realistiche possibilità di essere dimostrata. I due manoscritti, pur legati fra loro da uno stretto rapporto di parentela38, presentano varie divergenze che possono difficilmente essere spiegate postulando una discenden-za di M da P; si veda ad esempio quanto avviene a i.17.7-8, i.26+g-10 (p. 47); 2.5.34 (p. 48); 2.67.6.8-g (p. 49). Per quanto riguarda in-fine la lezione inhorrescit a 2.112.i.7-g, essa non può essere considera-ta una correzione isolata di N perché trova il conforto di R (trema). Tale lezione doveva pertanto essere perlomeno presente nel subar-chetipo da cui dipendono questi due manoscritti.
- «What are the medieval libraries in whose catalogues the Mulomedicina appears many times (p. 8 n. 5)? Before the fourteenth century I can find only Reichenau»39• In realtà nella n. 5 di p. 8 avevo scritto:
38 Essi sono infatti fatti discendere dal medesimo antigrafo (K) nei miei stemma-ta (cfr. Ortoleva, op. cit., 58 e iSg).
39 Ree. cit., 319.
Vincenzo Ortoleva
La Mulomedicina di Vegezio ricorre inoltre più volte nei cataloghi delle biblioteche medievali; cfr. G. Bècker, Catalogi bibliothecarum antiqui, Bonnae i885, g (nr. i63), 75 (nr. 56) e M. Manitius, Handschriften an-tiker Autoren in mittelalterlichen Bibliothekskatalogen, Leipzig ig35, 201-204.
L'espressione «più volte» non corrisponde perfettamente all'inglese «many times»; inoltre, l'aggettivo «medievali» non implica affatto il termine temporale del XIV secolo, come sembra ritenere Reeve40•
- Why did Gudius, who had seen only L, say that the exemplar Corbiensis monasterii was written litteris uncialibus (p. i25)? Most of Lommatzsch's evidence (pp. x-xi) proves nothing of the kind, but he does mentimi that the scribe of L (or was it an earlier scribe?) reproduced the script of two words that he could not fathom»41 •
Ancora una volta Reeve è perlomeno impreciso nella descrizione dei fatti perché a p. I 2 5 non si riproducono le parole di Marquar-dus Gudius ma una notizia diJ. A Fabricius, che era entrato in pos-sesso della copia dell 'editio princeps munita di varianti marginali ap-partenuta a Gudius. Un'ulteriore interessante notizia circa la colla-zione di Gudius si rinviene nell'edizione di J. M. Gesner, a cui Fabricius aveva prestato la copia dell' editio princeps già appartenuta a Gudius. Gesner infatti afferma42:
Adscripsit enim, quisquis primus fuit collationis illius auctor: Contuli cum exemplari descripto ex MS. codice Corbeiensis mona,sterii, tunc temporis Coloniae apud S. Pantaleonis deposito. Item illud, Codex Corbeiensis optimae notae admo-dum antiquus, literis uncialibus exaratus, lacerus tamen et inde (forte hic inde) lacunis deformatus. Quoties deficiat Corbeiensis codex, ex nostris notulis potest intelligi.
Si noti che la frase «ex MS. codice Corbeiensis monasterii, tunc tem-poris Coloniae apud S. Pantaleonis deposito» riprende quasi alla let-tera quanto si legge al f. 7iv di L: «Coloniae. Anno i537. g. Octobris ex exemplari Corbiensis Monasterii, tunc temporis S. Pantale. deposi-to». È difficile fare ipotesi circa i motivi che indussero Gudius - o chiunque sia stato l'autore della collazione - a fornire ragguagli circa il tipo di scrittura del codex Cvrbeiensis. Forse si trattava di pure illazio-ni; forse lo scrivente aveva effettivamente visto tale manoscritto o gli era stato descritto da qualche dotto amico. Di più non si può dire.
·to Per Reichenau si veda anche A. Holder, Die Reichenauer Handschriften, 3, Leip-zig 1918 (Wiesbaden 19732), 84 (nr. 163).
11 Ree. cit., 319. ·12 Cfr. Ortoleva, op. cit., 137.
Postille 199
- «Was the epitome y, attested by at least three Neapolitan witnesses, not made in the medicai school at Salerno?»43 • In questo caso Reeve avanza un'ipotesi non solo non dimostrabile, ma anche assai azzarda-ta. I testimoni «napoletani» sarebbero NP ed R, il manoscritto che tramanda la traduzione italiana di Giovanni Brancati. Si faccia tutta-via attenzione al fatto che se Ne R (fra l'altro strettamente imparenta-ti fra loro) sono prodotti eseguiti espressamente per le esigenze della Biblioteca aragonese nella seconda metà del XV secolo, P (sec. XIV) appare verosimilmente essere stato copiato anteriormente alla costi-tuzione di tale biblioteca, sebbene poi fu per un certo tempo da essa posseduto. Si noti inoltre' che nemmeno H (sec. XIV), oltre a MU (ambedue databili al XV sec.), sembra essere di ambiente napoleta-no. Al contrario Q (sec. XV) che fa parte di ç e non di y, reca anch'es-so lo stemma aragonese. È assai singolare che Reeve possa tanto inge-nuamente pensare che sia sufficiente che dei codici siano passati da Napoli per ipotizzare un'origine napoletana del testo da loro tra-smesso! Il fatto che almeno quattro manoscritti siano stati posseduti dalla Biblioteca aragonese dimostra solo l'interesse (probabilmente pratico) della corte napoletana per i trattati di mascalcia. Ho infine dimostrato come il testo di y si sia formato in età non molto posteriore a quella di Vegezio stesso (pp. 44-45), ben prima quindi dell'istituzio-ne della cosiddetta scuola salernitana.
- «Several phrases are peculiar to ç, but only when O. reaches the translations does he declare them in a footnote to be interpo-lations (p. 152 n. 39)»44• Questo dato non aggiunge né toglie nien-te all'economia dei rapporti tra ç e gli altri testimoni. La lunghezza e la frequenza (entrambe assai limitate) di tali 'interpolazioni' non costituiscono del resto il carattere maggiormente identificativo di ç. Inoltre, era necessario prima fissare bene i rapporti tra i codici per procedere poi a giudicare la genuinità o meno delle porzioni di testo riscontrabili solo in ç.
- «From the same chapter one learns in passing that F has variants (p. 156), a fact ignored both in the description (p. g) and in the discussion (pp. 30-1) »45 • In effetti, F presenta solo assai di rado qualche variante marginale, uno di questi rari casi è quello di cui si tratta a p. 156. Molto probabilmente Reeve fa ancora confusione;
43 Ree. cit., 319. 44 Ree. cit., 319. •15 Ree. cit., 319.
200 Vincenzo Ortoleva
in questo caso fra varianti marginali (esterne quindi al testo e per-lopiù trascritte da un'altra mano) e la profonda contaminazione tra E e y presente all'interno del testo tràdito da F. Di ciò si tratta a lungo nel primo capitolo (pp. 30-31).
Alla fine della recensione Reeve si sofferma sulla constitutio textus di tre luoghi dell'opera vegeziana. La discussione è introdotta dalla domanda (retorica?): «Finally, has O. heard of clausulae?»46• Ci si aspetterebbe dunque che l'analisi testuale di Reeve fosse tutta, o al-meno in parte, incentrata su lezioni facenti parte di clausole metri-che a fine perioçlo. Sorprendentemente in ciò che segue non si rin-viene nulla di tu;tto questo. A parte, inoltre, le affermazioni tanto gratuite quanto fuori luogo sulle clausole, due dei tre interventi te-stuali avanzati da Reeve risultano discutibili, per non dire un po' goffi. Esaminiamoli in dettaglio.
*** Dig. pro!. 5 Additur etiam quod studio lucri quaedam ita sunt compositae potiones ut pretium enorme contineant et curae taxatio aestimationem animalis prope uideatur aequare ut plerumque aut parei homines aut certe prudentes ani-malia sua casibus dedant aut damnosam curationem dissimulent
Questo il testo stabilito da Lommatzsch. Reeve fa pure seguire una sua «interpretazione» dell'apparato dell'edizione teubneriana, di fat-to erronea, perché attribuisce lezioni all' editio princeps senza alcuna base47• In realtà le varianti che i testimoni presentano per questo passo sono le seguenti4B:
deest in SCWH Il additur LeATY"°\"lt : al. adde- mg. L adduntur BYPc Il guod LeTYy1t THEOD. s. l. A : qui A quaedam B Il studio LEByx THEOD. : de s- ATY Il lucri om. A Il sunt LeABTPcYP"\'1t THEOD. : sint Tacyac Il aesti-mationem animalis Ly THEOD. : a- ae- APéfY1t a- extimationem eAacB Il prope om. y Il ut yeçn: THEOD. : ac L Il parei Vex THEOD. : pauei LFç peri-
-m Ree. cit, 320.
•17 Ecco cosa effettivamente si legge nell'ed. di Lommatzsch (ad Zoe.): «4 dent AF dederint M I et annos a curatione d. L et a damnosa c. d. AFP I His et] Si is A his F»; Reeve invece «interpreta» in tal modo: «aut damnosam curationem ed. pr.: et annosa curatione L: et a damnosa curatione yeç (PFA)».
48 Da questa e dalle successive collazioni, oltre a GOV (apografi di mss. in no-stro possesso [cfr. supra n. 4]) si è fatto a meno anche di Q, ms. assai vicino a BTY che può essere tranquillamente trascurato per la constitutio textus.
Postille 201
ti y Il casibus LEYy s. l. A : canibus ABT1t codd. THEOD. uariant Il dedant L1t : dent cl;; dederint y Il aut damnosam curationèm Samb. : et damnosa cura-tione y et damnosam curationem NPc (et V) et annos acuratione L et a damnosa curatione cl;; aut (ut THEOD.) a damnosa curatione 1t THEOD. per la damnosa curazione R
Nonostante tutto Reeve afferma categoricamente: «but in any event Vegetius must have written et a damnosa curatitme dissimulent. Tue Thesaurus gives an example of dissimulare ab from Tertullian and many from the fourth century (V i483.72-1484.2)». In realtà, qui dissimul.o si riferisce direttamente ad animalia sua e la lezione genuina è et dam-nosa curatione di y ( cfr. anche et annos acuratione di L), cioè un sempli-ce ablativo di causa Per dissimul.o usato transitivamente cfr. Th[L s. v., i4844-54; si veda in particolare lo stesso Veg. mil. i.28.7: cura exercitii militaris primo neglegentius agi, postea dissimulari . . . cognoscitur. Si dovrà pertanto tradurre: « ... tanto che il più delle volte le persone parsimo-niose o in ogni caso avvedute abbandonano alla loro sorte i propri animali e li trascurano a causa della dispendiosità della cura». La rico-struzione di Reeve prevede invece che et a damnosa curatione sia diret-tamente collegato a dissimulent, cioè: « ... e trascurino una cura rovino-sa». A parte il fatto che nei due luoghi dei Digesta in cui si rinviene il sostantivo dissimulatio esso assume il particolare senso di «Comporta-mento negligente» nell'àmbito del governo degli animali e non di «Omissione» di una particolare azione (ad esempio di una determina-ta cura) 49, la proposta di Reeve ha il fondamentale difetto di non te-nere in alcun conto la gerarchia stemmatica dei testimoni (un fatto davvero spiacevole per un convinto seguace della teoria maasiana!), dal momento che la lezione da lui appoggiata è quella tràdita dai ma-noscritti più tardi (El;).
*** Prol. 6 His et talibus rationibus inritatus, cum ab initio aetatis alendorum equo-rum studio flagrarem, hanc operam non inuitus arripui ut conductis in unum Latinis dumtaxat auctoribus uniuersis, adhibitis etiam mulo-medicis et medicis non omissis (nam mulomedicinae doctrina ab arte medicinae non adeo multis discrepat sed in plerisque consentit), in
49 Cfr. dig. 3.prol.1 (Solemnis excusatio negligentium est dispendia ex dissimulatione ue-nientia deo imputare uel casibus) e 3.prol.3 (malo enim nihil inexpertum relinqui, quam, si quid calamitatis euenerit, auaritiae uel dissimulationibus imputan).
202 Vincenzo Ortokva
quantum mediocritas ingenii patitur piene ac breuiter omnia epitoma di-gererem causasque et signa morborum omnium declararem.
deest in SCWH Il his et L"flt THEOD. : si is A his eBTY Il inritatus L: inui-tatus yeç1t inuitati THEOD. Il cum - flagrarem om. THEOD. Il aetatis alen-dorum LAB'\"lt THEOD. : a- ae- eTY (con: Y2) Il non inuitus LB'\"lt: inuitus EATY libenter THEOD. (non s. l. A2Y2) Il uniuersis om. THEOD. Il mulome-dicis LEBYy1t THEOD. : mulo medicinis ATPc medicinis Tac Il multis L : in m- yaç,t THEOD. Il in plerisque Lye THEOD. : in multis plurimisque ç,t Il piene ac breuiter omnia LVeç,t THEOD. : piene ac leuiter omnia F haec omnia breuiter y Il epitoma L : -me 1t -mata TY epicomata VeAB THEOD. enucleata y enucleata epitomata F Il digererem Lomm. : digerere L con-gererem 1t dirigerem eç THEOD. dictam MP dietam N dictas mg. M dicam U la dieta R Il causasque LEATY1t THEOD. : -samque B causas y Il declara-rem Fç,t THEOD. : -clarare LVe -clarem MNP -claram ex con: U Il post de-clarare lacuna signo +notata in L, nullam lacunam praebent yeç,t THEOD.
Questa volta il testo citato è stato da me costituito e corredato di apparato critico50• A proposito di questo passo Reeve afferma: «O. himself favours the reading of L (p. 194 n.13), but it is hard to construe and does not give the faultless rhythm of epitomata». Al contrario di quanto possa pensarne Reeve la lezione epitoma ha più di una ragione per essere sostenuta: 1) epitoma trova l'appoggio dei due migliori testimoni di questo passo, L1t; 2) la variante epitomata (o epicomata) di eç THEOD. è una chiara corruzione di epitoma; 3) la lezione enucleata di y è una palese innovazione inserita nel testo per rimpiazzare un vocabolo di difficile interpretazione come epitoma o epitomata51 • Si faccia inoltre attenzione al fatto che I' editio princeps (1t) si basa sulla contaminazione di due manoscritti, uno assai simile ad A (gruppo ç), l'altro assimilabile a LW. Se pertanto in 1t non si legge epitomata o epicomata come in ç ciò significa che quanto tràdito da 1t (epitome) o è una congettura dell'editore o è la lezione dell'altro manoscritto a sua disposizione, cioè quello assimilabile a LW52• Il fatto che epitome sia il risultato di un intervento editoriale su epito-
50 Reeve riporta invece il testo di Lommatzsch seguito da un apparato approssi-mativo dove non si dà ragione di quanto si rinviene in F: «enucleata y: epitoma L: deest epitomata (vel epicomata) Theod., eç: epitome ed. pr. ... Quel che è peggio è che Reeve attribuisce a me tale apparato ( «This time I cite O.'s apparatus [p. 193]»).
51 Reeve ritiene che «the reading of y carne from either the preface to Book 4 or Epit. U?8.1». In realtà il participio enucleatus oltre che in miL i.28.1 e in cur. boum pr. 2 si rinviene anche in dig. i.64.2.
52 Cfr. Ortoleva, op. cit., 103-119.
Postille 203
mata o epicomata mi pare senz'altro da scartare, non foss'altro per-ché epitome rappresenta qui un classico caso di lectio difficilior. Molto più probabilmente Faber leggeva nel suo codice recenziore epico-mata, proprio come in A, e non avendone inteso il senso (forse non avendo neppure capito che si trattava di una corruzione di epitoma-ta) avrà preferito accogliere la lezione presente nel suo codice più antico, che forse doveva essere epitoma proprio come in Le che egli normalizzò in epitome.
In ogni caso l'accordo tra L e 1t lascia pochi dubbi sulla scelta della lezione genuina. Ancora,una volta Reeve, invece, accoglie una lezione tràdita dai manoscritti rinvenibili negli stadi più bassi dello stemma, per rigettare quella attestata nei testimoni più vicini all'originale. Vera-mente uno strano modo di procedere! Tanto più che l'ablativo epitoma non è per niente difficile da costruire, o almeno non lo dovrebbe essere per un filologo nei nostri tempi. Per digero con l'ablativo si vedano inol-tre Hier. epist. 52.11 ( ut tibi breui uolumine digeram praecepta uiuendz); Ps. Aug. quaest. test. app. 3 (facta et dieta ... quattuor uoluminibus digesta); Cod. Iust. i.17.2.1 (constitutiones XIIlibris digesta); Sidon. epist. g.9.10 (legimus opus ... digestum titulis exemplisque congestum). Il passo in questione va dunque così tradotto: « ••• ho intrapreso volentieri quest'opera, per ordinare, dopo aver raccolto insieme perlomeno tutti gli autori latini, [ ... ]ogni cosa in un'epitome in maniera completa e concisa e per spie-gare le cause e i sintomi di tutte le malattie».
*** Il terzo contributo testuale di Reeve ha per oggetto il prologo della De curis boum epitoma. Egli afferma: «When O. discusses the opening of Book 4 (p. 191), he cites the text from Lommatzsch, whose ap-paratus I add»53• Il testo stabilito da Lommatzsch è il seguente:
Cur. boum prol. i
Mulomedicinae me commentarios ordinante ciuium atque amicorum fre-quens querela accepti operis continuationem suspendit, deflentium aegri-tudines mortesque damnosissimas boum, cum magnopere peterent publi-candum, si quid pro salute tam commodorum animalium scriptum reperi-retur in libris.
53 Anche in questo caso la riproduzione dell'apparato di Lommatzsch è assai manchevole, confusa e arbitraria. In Lommatzsch (ad ÙJc.) si legge: «12 commentariis (ex-dariis) ordinatione A mulom. commentarla ordinanti P li 13 incepti Gesn. I conti-nuatione P»; Reeve riporta invece il tutto in questo modo: «Ordinante ed. pr.: ordinan-ti P. ordinatione A incepti Gesner continuationem A, ed. pr.: continuation [sic] P..
Vincenzo Ortoleva
Dalla collazione dei testimoni a nostra disposizione si ricava il se-guente apparato:
deest in SCI.H Il mulomedicinae y$ : molo- W Il me om. y Il commentarios WVe11:: commentarla Fy commentatoris ç Il ordinante 7t: -tem Ve -nanti y-nate F -nantur W -natione ç Il accepti operis ycljt : ceperis (post ce finis lineae) W incepti operis Gesner Il continuationem yn: : continuatione Wet; Il deflentium y$ : -flectium W Il -que Wyn: : om. et; Il damnosissimas WFBy : clamosissimas VeA1Y7t Il magnopere 7t: magno opere Wet;y Il peterent publicandum ABT7t: peteret pu- Y peterint (ex con:) pu- W quae peterent F supplicantium y Il quid y$: quid tamen W Il salute WVeçyn:: saluta F e s. l. ad. F 11 tam commo-dorum animalium Ft;c : comodorum animalium Ve animalium W eorum y Il scriptum reperiretur in libris W$: in libris scriptum reperitury.
Reeve così si esprime a proposito di questo passo: «Much as in Prol. 5, read Mulomedicinae me commentarios ordinantem ciuium atque amico-rum frequens querela a coepti operis continuatione suspendif>>. Ma perché «much as in ProL' 5»? quali sono le analogie che legano i due passi? Io francamente non le vedo. Tanto più che se la proposta di Reeve è da considerarsi completamente errata nel primo caso, deve essere in-vece accettata nel secondo, sebbene essa possa essere considerata una congettura originale solo in parte, dal momento che ordinantem è attestato da Ve e continuatione da Wel;. Viene cioè messo in luce an-cora una volta un metodo assai discutibile consistente nell'avanzare proposte testuali senza prima aver collazionato tutti i testimoni.
*** Reeve concludeva la sua recensione avvalendosi dei tre passi citati per dimostrare che i motivi per cui l'opera di Vegezio aveva biso-gno di una nuova edizione critica erano assai più numerosi di quel-li forniti nel mio libro, finendo poi per avanzare anche dei dubbi sulle mie capacità ecdotiche54• Tutto ciò rappresenta qualcosa di difficilmente comprensibile. L'unica cosa che invece si capisce dav-vero è quanto il comportamento di Reeve sia stato scorretto. Per mettere in luce le sue (presunte) doti di editore di testi classici, ha fatto credere ai suoi lettori, distorcendo palesemente la realtà, che nel primo e nel terzo passo da lui commentati io avessi in qualche modo avallato le scelte testuali di Lommatzsch. In verità, in nessuna parte del mio libro mi sono soffermato su dig. prol. 5; ho invece cita-
54 Ree. cit., 320.
Postille
to (a p. ig1) cur. boum prol. I secondo l'edizione di Lommatzsch solo per comodità, in occasione della trattazione delle modalità di com-posizione della De curis boum epitoma.
Un libro sulla tradizione manoscritta di un testo antico è del resto un luogo dove solo assai di rado è concesso di inoltrarsi in questioni di constitutio textus. Se avessi voluto trattare di tali problematiche non avrei avuto che l'imbarazzo della scelta e certamente non mi sarei li-mitato a tre soli esempi, ma avrei potuto scrivere un altro libro. Cosa che sarebbe risultata del tutto superflua dal momento che da alcuni anni mi sto occupando della pubblicazione di un'edizione commen-tata dei due trattati vegeziani. Quanto poi alle mie capacità ecdotiche, su ciò giudicheranno i critici dopo che tale edizione sarà uscita. Sulle capacità di Reeve di intendere il testo di Vegezio ciascuno può invece giudicare già sulla base di quanto qui riportato55•
SVMMARIVM: In huius scripti parte priore quae l.eguntur in libro meo «La tradizio-ne manoscritta della 'Mulomedicina' di Publio Thgezio Renato» inscripto augentur atque renouantur. In altera uero parte argumenta Michaelis D. Reeve confutantur, qui cum libri mei censuram fecisset («CR» 47, r997, 3r7-320) sicut demon-stratur - in errore uersatus est.
55 A mo' di appendice desidero inoltre segnalare che la ·recensione di Reeve non è neppure esente da refusi, errori di distrazione e imprecisioni, cosa per lo meno disdice-vole in uno scritto che si propone di mettere in evidenza gli errori altrui. Ecco i casi più rilevanti: a p. 318 (rr. 5-'7) Reeve, nel trattare dei testimoni già noti a Lommatzsch (ed. ciL), riporta che I' editio princeps era da quest'ultimo considerata «as a relative ofF con-taminated from a relative ofL»; in realtà Lommatzsch si esprime così a tale proposito (ed. ciL, XXI): «Huc liceat pauca adiungere de codice unde editio princeps fluxerit: codex iste capitula omnia operi anteposita habebat; ut cod. L; sed ordo librorum est is quem praebet classis codicisA (G) [ ... ] Vìdes igitur ethunc codicem editionis principis esse conflatum ex duabus classibus statutis ... »; a p. 31 g (r. 38) in luogo di «eruditissimiS>• si legga «amicissimiS>•; nella stessa p. (r. 49) in luogo di «2.5.3-4» si legga «2.5.34»; a p. 320 (r. 24) in luogo di «Continuation» si legga «continuatione».