R. Marchionni, La tradizione non solo manoscritta del ‘carmen epigraphicum’: Patris opus...
Transcript of R. Marchionni, La tradizione non solo manoscritta del ‘carmen epigraphicum’: Patris opus...
ATTI DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA ROMANA DI ARCHEOLOGIA(SERIE III)
RENDICONTI
VOLUME LXXXV
ANNO ACCADEMICO 2012-2013
TIPOGRAFIA VATICANA
2013
ATTI DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA ROMANA DI ARCHEOLOGIA(SERIE III)
RENDICONTI
VOLUME LXXXIV
ANNO ACCADEMICO 2011-2012
TIPOGRAFIA VATICANA
2012
COMITATO DI REDAZIONE
Marco Buonocore, Elisa Lissi Caronna, Letizia Pani Ermini, Paolo Liverani,Federico Guidobaldi, Maria Pia Muzzioli, Gian Luca Gregori, Maria LetiziaLazzarini, Margherita Bonanno Aravantinos.
Curatore delle stampe: Giuseppina Pisani Sartorio
Le comunicazioni scientifiche sono sottoposte a peer-review.
ISSN 1019-9500© Città del Vaticano 2013 - Pontificia Accademia Romana di ArcheologiaVia della Conciliazione, 5 - 00193 - Roma - tel. 06 [email protected] - www.pont-ara.org
I N D I C E
Elenco degli Accademici V
Consiglio Accademico XIII
Verbali delle adunanze pubbliche XV
COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE
G. De Tommaso, Alla ricerca di Alessandria: vetri dipinti 3
o. DiliberTo, Celio Calcagnini: umanista del Sedicesimo secolo e giurista ‘dimenticato’ 13
m. Gras, H. DuDay, La necropoli meridionale di Megara Hyblaea Storiografia, archeologia, antropologia biologica 27
a. GuiDi, Dai rituali ctonii alla religione di stato: evoluzione delle manifestazioni del culto nell’Italia centrale protostorica 63
s. orlanDi, C. ConTi, Sui travertini del Colosseo tra restauro ed epigrafia 71
a. esCH, Spolia minora Il reimpiego dell’antico lungo le strade romane nell’Italia centrale 89
J. remesal roDríGuez, El Monte Testaccio: de vertedero a archivo 111
m. PiranomonTe, Nuovi ritrovamenti sulla via Flaminia 129
m. aoyaGi, C. anGelelli, La c d Villa di Augusto a Somma Vesuviana (NA) Nuove ipotesi di lettura sulla base delle più recenti ricerche archeologiche 171
P. zanDer, La necropoli di San Pietro in Vaticano alla luce degli ultimi restauri 203
e. CeCCaroni, F. GalaDini, C. evers, n. massar, C. leTTa, Recenti scoperte archeologiche nella città romana di Alba Fucens
i. e. CeCCaroni, Alba Fucens: gli interventi della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo nell’isolato di via del Miliarioe nel piazzale del santuario di Ercole 245
ii. F. GalaDini, Il piano della civita pre-Alba Fucens Indicazioni da sondaggi geognostici nel settore meridionale dell’area archeologica 279
iii. C. evers, n. massar, Découvertes archéologiques récentes à Alba Fucens La zone sud-occidentale du forum 295
iv. C. leTTa, Prime osservazioni sui Fasti Albenses 315
l. ambrosini, Le divinità dei pocola deorum: un nuovo pocolomdi Voluptas del Volcani group 337
m. massaro, L’impaginazione delle iscrizioni latine metriche e affettive 365
F. PaoluCCi, La statua di Elena seduta della Galleria degli Uffizi alla luce dei recenti restauri 415
e. rosCini, Varia epigraphica da Carsulae (Umbria) 433
r. marCHionni, La tradizione non solo manoscritta del‘carmen epigraphicum’: Patris opus munusque suum (CIL VI 1163) I segreti dell’obelisco lateranense 455
COMMEMORAZIONI
H. PaTTerson, CHr. smiTH, David Whitehouse (1941-2013) 475
LA TRADIZIONE NON SOLO MANOSCRITTA DEL CARMEN EPIGRAPHICUM
PATRIS OPUS MUNUSQUE SUUM (CIL VI 1163). I SEGRETI DELL’OBELISCO LATERANENSE1*
DI
ROBERTA MARCHIONNI **
______
Durante la sua permanenza nel Circo Massimo, l’obelisco oggi detto Lateranense si fregiava di una base, a sua volta arricchita da un carme di 24 versi. Di essa non restano oggi che pochi frammenti, ma lo zelo di alcuni uomini del passato ci ha assicurato non solo la tradizione manoscritta del carmen, ma anche un testimone inconsueto, un oggetto che mirava a riprodurre, conservare e tramandare base e testo epigrafico nel suo insieme, la base vaticana.Parole chiave: obelisco lateranense, carmen epigraphicum CIL VI 1163, tradizione manoscritta, tradizione archeologica, ricezione.
Während seines Aufenthaltes im Circus Maximus schmückte den heute so genannten lateranensi-schen Obelisk eine Basis, die ihrerseits ein 24 V. langes carmen trug. Von der Basis sind uns nur wenige Fragmente erhalten, aber der Eifer einiger Männer der Vergangenheit hat uns nicht nur die handschriftliche Überlieferung des carmen gesichert, sondern auch einen ungewöhnlichen Zeugen, der das Denkmal und den epigraphischen Text als Ganzes reproduzieren, behalten und überliefern sollte, die kleine Basis Vaticana. Schlüsselwörter: Lateranensischer Obelisk, Carmen Epigraphicum CIL VI 1163, Hand-schriftliche Überlieferung, Archäologische Überlieferung, Rezeption.
1* Nota presentata dal socio effettivo Marco Buonocore. [email protected]
** Ringrazio innanzitutto Marco Buonocore per il preziosissimo aiuto prestatomi du-rante tutte le fasi di questa ricerca. Sono poi grata all’amica Christina Savino, che ha letto con cura l’articolo, migliorandolo in più parti. Un grazie particolare, infine, a mia sorella Tiziana Marchionni, con l’aiuto della quale ho potuto individuare e fotografare i frammenti della base di Costanzo, inseriti nel corpo dell’obelisco.
REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. - VOL. LXXXV456
Il più imponente tra gli obelischi, che gli imperatori romani strapparono all’Egitto per trasportarli in Italia,1 si staglia oggi con i suoi m 32,18 contro il cielo di Roma, al centro della piazza di fronte alla Basilica di San Giovanni in Laterano, davanti agli occhi dei tantissimi cittadini romani e dei turisti, che in massa si trovano a passare ogni giorno in questa zona trafficatissima della città.
Non pochi sono anche gli studiosi, provenienti dalle tante discipline dell’an-tichistica, e non solo, ad aver rivolto le loro attenzioni al monumento.
Ciononostante l’obelisco, protagonista di una storia che si estende per secoli, anzi, per millenni, e di cui è anche testimone principale, è riuscito fino ad oggi a tenere per sé più di un segreto.
Del suo movimentato passato darò qui solo brevi cenni: 2 eretto a Tebe, presso il tempio di Amon nel XV secolo a.C. sotto Thutmose IV, 3 vi rimase circa 1700 anni, fino al momento cioè in cui la sua maestà gli attirò l’attenzione prima di Augusto, che sognava di trasferirlo a Roma, poi di Costantino, che riuscì ad imbarcarlo fino ad Alessandria, infine di Costanzo II, che riuscì nell’impresa di trasportarlo a Roma e di farlo erigere, nell’anno 357, nel Circo Massimo.4
L’operazione di trasporto di questo gigante non lasciò indifferenti i con-temporanei: Ammiano Marcellino, nelle sue Res gestae (17, 4), ce ne offre un particolareggiato resoconto. Ma anche nel carmen inciso sulla base che Costanzo II fece porre sotto l’obelisco a Roma, oggi noto come CIL VI 1163 (= CLE 279),5 opera di un autore a noi sconosciuto, trovò posto, adeguatamente inse-rita nel contesto generale di lode di Costanzo, la narrazione delle difficoltà del trasporto e dell’erezione dell’obelisco.6
1 Sul tema si veda C. D‘OnOfriO, Gli obelischi di Roma, Roma 1992.2 Per informazioni più dettagliate rimando alla sterminata bibliografia sull‘obelisco (di
seguito una scelta di titoli): O. Marucchi, Gli obelischi egiziani di Roma illustrati con traduzione dei testi geroglifici, Roma 1898; H. Kastl, Der Lateranensische Obelisk in Rom, Schicksal eines antiken Baudenkmals, München 1964; E. iversen, Obelisks in exile, vol. I, Copenhagen 1968, pp. 55-64; L. habachi, The Obelisks of Egypt, Sky-scrapers of the past, London 1978; D‘OnOfriO, Gli obelischi cit. (nota 1); P. liverani, Costanzo II e l‘obelisco del Circo Massimo a Roma, in A. Gassze, F. servajean, C. thiers (a cura di), Et in Aegypto et ad Aegyptum: recueil d‘études dédiées à Jean-Claude Grenier, Montpellier 2012, pp. 471-487.
3 Marucchi, Gli obelischi egiziani cit. (nota 2), p. 46, data l‘erezione dell‘obelisco in maniera ancora più precisa, tra il 1443 ed il 1435 a. C.
4 Accanto all‘obelisco di Augusto. Sulla presenza dei due obelischi nel circo si veda liverani, Costanzo II cit. (nota 2), p. 483.
5 CIL XVIII/1, 42 è la numerazione provvisoria del carmen nel volume di benGt e. thOMassOn, Carmina Epigraphica Urbis Romae, a cui ho collaborato durante la mia perma-nenza al Corpus Inscriptionum Latinarum, curando tra l‘altro la scheda relativa a questa iscri-zione, e la cui uscita dovrebbe essere prossima.
6 Sulle significative differenze tra il testo di Ammiano e quello di CIL VI 1163 ragionò già Michele Mercati nel suo De gli obelischi di Roma, Roma 1589 (in particolare a p. 301). Si vedano inoltre G. Kelly, The New Rome and the Old: Ammianus Marcellinus‘ Silence on Con-
R. MARCHIONNI - LA TRADIZIONE NON SOLO MANOSCRITTA DEL CARMEN 457
Difficile dire quanti anni l’obelisco trascorse in questa sua nuova sede: secondo un‘ipotesi del Mercati 7 furono gli ostrogoti di Totila ad abbatterlo, dunque intorno al 544-550; più cauto Iversen, che riporta alcune delle ipotesi più accreditate per concludere «the fact remains that we just do not known».8
Certo è invece che esso giacque per secoli sepolto sul fondo del Circo Massimo, quest‘ultimo ridotto nel frattempo ad un‘immensa palude. Bisognerà attendere il 1587 perché l’obelisco venga risvegliato dal suo sonno centenario. Fra gli attori di questo recupero, spiccano due personaggi di rilievo del mon-do culturale dell’epoca, entrambi influenti consiglieri e persone di fiducia del papa Sisto V (1520-1590): Michele Mercati (1541-1593) e Domenico Fontana (1543-1607).9 Il primo è esperto di medicina, di botanica, delle varie scienze umanistiche, dunque filosofo, archeologo, filologo, incarna insomma l’ideale dello studioso umanista. Fontana è l’architetto di Sisto V, come tale sovrintende a non pochi incarichi volti a potenziare l’impatto del potere papale. È dunque predestinato per l’impresa di riportare alla luce, restaurare ed erigere nuovamente il monumento in una nuova sede, secondo i piani e gli intenti del pontefice.10
Al disseppellimento il corpo dell’obelisco è rotto in tre pezzi, ma la base è frantumata in talmente tanti frammenti, che il suo restauro appare impresa impossibile. Sisto V, del resto, ha in programma per l’obelisco non solo un nuovo trasloco, ma anche una nuova base ed una nuova iscrizione, quelle che possiamo ammirare ancora oggi al di sotto dell’obelisco nella piazza di S. Giovanni in Laterano.11 Mercati però non si rassegna alla perdita definitiva dei versi tardoantichi: ricomporrà il puzzle dei frammenti giusto per poterne approntare una trascrizione,12 dopodiché li abbandonerà al proprio destino.13
stantinople, in Classical Quarterly 52, 2 (2003), pp. 588-607. Ulteriore bibliografia sulla visita di Costanzo a Roma nel 357, durante la quale venne eretto l‘obelisco, e sulla versione di Ammiano Marcellino ci offre liverani, Costanzo II cit. (nota 2), p. 471, nota 1.
7 Mercati, De gli obelischi cit. (nota 6), p. 336.8 iversen, Obelisks in exile cit. (nota 2), p. 59.9 Per entrambi si veda il Dizionario Biografico degli Italiani, s. v., con ampia bibliografia.
10 iversen, Obelisks in exile cit. (nota 2), p. 61 ss.11 Per il testo, anch‘esso un riassunto della storia dell‘obelisco arricchito delle ultime
vicende, vd. e.g. iversen, Obelisks in exile cit. (nota 2), p. 63 s.12 La trascrizione del Mercati si trova alle pp. 291-292 del suo già citato De gli obelischi
cit. (nota 6). A p. 288 si trova la descrizione della base di Costanzo «alta tredici palmi, e un quarto, larga palmi sedici. Fu fatta di sei pezzi di granito rosso...».
13 A.F. GOri, Thesaurus veterum diptychorum consularium et ecclesiasticorum, Florentiae 1759 (opus posthumum), p. 73 s., lamenta il fatto che ai tempi suoi i frammenti della base giaces-sero ancora in un angolo della piazza, ignorati, mentre si sarebbe potuto ricomporli «ut Mercatus fecit» ed aggiunge: «qui de … antiquae eruditioni adversis fatis conquesti sunt, tantam debacchasse barbariem summopere dolemus».
REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. - VOL. LXXXV458
i fraMMenti superstiti
Di questi frammenti sono quattro ad esser giunti fino a noi. Il più famoso 14 è il cosiddetto frammento a, conservato oggi al Museo Nazionale di Napoli, pubblicato da Camodeca: 15
[- - - ]ANGEBAT CVRA VEH[- - -]
Gli altri frammenti superstiti hanno avuto un destino ben più curioso. Già Fontana, nell’opera dedicata alle sue imprese di architetto pontificio,16 racconta di aver usato alcuni frammenti della base per restaurare il corpo dell’obelisco stesso. Due di questi, siglati b e c, vennero individuati da Georg Zoega,17 studioso danese fra gli iniziatori dell’archeologia, e poi recepiti da parte degli studiosi che si sono occupati dell’obelisco.18 Seguendo le indicazioni di Zoega, ho potuto individuare entrambi i frammenti e fotografarli (figg. 1 e 2): 19
Sulla base delle riproduzioni mi è stato possibile leggere alcune lettere in più rispetto a quelle tramandateci da Zoega 20 (ed alcune di meno):
14 Per alcuni l‘unico, vd. e. g. E. cOurtney, Musa Lapidaria, A Selection of Latin Verse Inscriptions, Atlanta 1995, p. 251.
15 Catalogo delle iscrizioni latine del Museo Nazionale di Napoli, Napoli 2000, n. 27, p. 70 (foto a p. 275). Rinvio a questo testo anche per la descrizione del frammento.
16 Della trasportatione dell‘obelisco Vaticano et delle fabriche di nostro signore Papa Sisto V fatte dal Cavalier Domenico Fontana architetto di Sua Santità, Roma 1590, pp. 70v-74v.
17 De origine et usu obeliscorum, Romae 1797, pp. 52-53, nota 4.18 Da Henzen nella sua scheda per il CIL VI 1163, da Marucchi ed Iversen, ad esempio.19 Fino ad ora solo iversen, Obelisks in exile cit. (nota 2), foto 27, offriva un‘immagine del frammento c.
Le figg. 1-3 sono state ruotate di 90°; le fig. 1 e la 2 a sinistra, la fig. 3 a destra per permettere una visione più agevole delle lettere latine.
20 Che peraltro ha compiuto un‘impresa non indifferente leggendo lettere del frammento b ad un‘altezza di più di circa 35 metri (con la base di Sisto V, l‘obelisco raggiunge oggi i 47 metri).
Zoega
framm. b (fig. 1)
STVDIVMQDNONCREAS CONSVR
framm. c (fig. 2)LOCANDIRETVLLVSREINAVRA
La mia lettura
framm. b
[- - -]TESTVDIVMQDNONCREAS CONSVR
framm. c LO[-]ANDIETVLLVSEREINAVRA
R. MARCHIONNI - LA TRADIZIONE NON SOLO MANOSCRITTA DEL CARMEN 459
Fig. 1 - Lato occidentale, in alto
Fig. 2 - Lato orientale, in basso
REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. - VOL. LXXXV460
Iversen 21 parla di tre frammenti inseriti nell’obelisco, pur citando solo i due di Zoega: in effetti, un‘attenta analisi delle nuove riproduzioni, mi ha portato ad individuare alcune lettere, vicinissime al frammento c:
[- - -] †† [- - -]RE
la traDiziOne ManOscritta – le trascriziOni rinasciMentali
Con la dispersione e distruzione della maggior parte dei frammenti termina l’esistenza, per così dire, fisica di CIL VI 1163. È quindi giunto il momento di incamminarsi nella storia della tradizione di questa iscrizione, tradizione manoscritta, in primo luogo. Come ho anticipato sopra, Mercati approntò una trascrizione del carmen latino iscritto nella base, che riporto di seguito:
Patris opus munusqu[e suum] tibi Roma dicavitAugustus [toto Constan]tius orbe recepto et quod nulla tulit tellus nec viderat aetascondidit ut claris exa[equ]et dona triumfis
5 hoc decus ornatum genitor cognominis urbis esse volens caesa Thebis de rupe revellit.
sed gravior divum tangebat cura vehendi quod nullo ingenio nisuque manuque moveri caucaseam molem discurrens fama monebat.
21 iversen, Obelisks in exile cit. (nota 2), p. 58 e ibid., nota 1.
Fig. 3 - Lato orientale, a sinistra del frammento c
R. MARCHIONNI - LA TRADIZIONE NON SOLO MANOSCRITTA DEL CARMEN 461
10 at dominus mundi Constantius omnia fretus cedere virtuti terris incedere iussit haut partem exiguam montis pontoq(ue) tumenti credidit et placido [vexerunt aequora flu]ctu litus ad Hesperium [Tiberi] mirante carinam.
15 interea Romam ta[po]ro vastante tyranno Augusti iacuit donum studiumque locandi non fastu spreti sed quod non crederet ullus tantae molis opus superas consurgere in auras
nunc veluti rursus ruf[is] avulsa metallis 20 emicuit pulsatque polos haec gloria dudum
auctori servata suo cu[m c]aede tyranni redditur atque aditu Ro[mae vi]rtute reperto victor ovans urbiq[ue locat sublim]e tropaeumprincipis et munus cond[ignis us]que triumfis.22
Nella trascrizione si possono facilmente identificare tre dei frammenti su-perstiti: il frammento a costituiva dunque la fine del v. 7, i frammenti b e c, uniti, appartengono alla parte finale dei versi 16-18 (con perdita di alcune lettere centrali). Attribuire il frammento d ad un verso è più difficile: troppo insicura la lettura delle poche lettere visibili.23
Oltre al Mercati, e da lui non del tutto indipendenti, trascrissero il testo del carmen Fontana stesso 24 ed il letterato Giuseppe Castiglione.25 Le tre trascrizioni
22 Per la traduzione italiana rinvio nuovamente al già citato articolo di Liverani (vd. nota 2). Egli propone (p. 472) «una nuova traduzione, che potrà apparire poco fluida, ma che cerca di rispecchiare per quanto possibile fedelmente quelle scelte del testo che ritengo pertinenti dal punto di vista dell‘analisi storica».
23 Se veramente, come credo, le lettere di v. 1 del frammento sono R ed E, potrebbe trattarsi dei vv. 9 e 10.
24 Della trasportatione cit. (nota 16), p. 73r.25 Iosephi Castalionis Iurisconsulti Variae lectiones et opuscula, Romae 1594, pp. 44-47. Ca-
stiglione è spesso dimenticato in questo contesto e viene piuttosto ricordato per la sua “Vita di Fulvio Orsini” (Fulvii Ursini Vita a Josepho Castalione scripta, Romae 1657). Se non fosse che entrambe le trascrizioni sono uscite dopo il De gli obelischi…, si potrebbe pensare che a loro si rivolga il Mercati con queste parole (p. 290): «con grandissima difficultà, et fatica, possetti io metter insieme gli detti versi dell‘inscrittione, per mostrarli all‘hora a sua Santità, i quali quantunque siano di poi stati stampati due volte in Roma, nondimeno per che questo luogo gli richiedè, et perchè quelli che gli hanno fatto stampare, me gli hanno cavati dalle mani avanti che io gli haveßi bene acconci, et vi hanno anco commeßo dentro alcuni errori, mi sono per cio risoluto di porli qui di nuovo per ordine come stavano».
REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. - VOL. LXXXV462
del testo conservato (ai loro tempi) sono identiche (eccezion fatta per la variante monebat/moneret in v. 9 ex.), mentre alcune delle integrazioni si differenziano:
Mercati v. 9 monebat
v. 13 credidit et placido [vexerunt aequora flu]ctu litus ad Hesperium [Tiberi] mirante carinam interea Romam ta[po]ro vastante tyranno Augusti iacuit donum ...
Fontana v. 9 moneret
v. 13 credidit et placido vectu est velocius euro littus ad Hesperium populo mirante carimam (sic!) interea Romam taporo vastante tyranno Augusti iacuit donum ...
Castiglionev. 9 moneret
v. 13 credidit et placido vecta est velocius euro litus ad Hesperium populo mirante carinam interea Romam taetro vastante tyranno Augusti iacuit donum ...26
Le scelte fatte per integrare il testo lacunoso contrappongono dunque Mercati da un lato, a Fontana e Castiglione dall’altro.27 Nella trascrizione di Castiglione, infatti, l’unica divergenza notevole è data dal supplemento ta[et]ro
26 Non entrerò in questa sede nella questione della restituzione del testo di CIL VI 1163, eccezion fatta per il taporo di v. 15, di cui si parlerà in seguito.
27 Ulteriori differenze avvicinano piuttosto Mercati e Castiglione, ma qui bisognerà te-ner conto di una certa disattenzione del Fontana riguardo all‘ortografia dei frammenti (per non parlare di errori veri e propri come il vectu al v. 13 e carimam al v. 14): v. 4 triumfis Mer-cati e Castiglione, triumphis Fontana; v. 6 Thebis Mercati e Castiglione, Thaebis Fontana; v. 12 haut Mercati e Castiglione, haud Fontana; v. 14 in litus Mercati e Castiglione, littus Fontana; v. 24 triumfis Mercati e Castiglione, triumphis Fontana. Castiglione si distingue per l‘uso co-stante dell‘abbreviazione q(ue); segnalo solo per dovere di cronaca il suo erroneo Cacuaseam di v. 9. Sia Fontana, sia Castiglione non segnalano le integrazioni. Solo nel commento, Ca-stiglione discute l‘integrazione ta[po]ro, ed è dunque costretto ad evidenziarla in quanto tale.
R. MARCHIONNI - LA TRADIZIONE NON SOLO MANOSCRITTA DEL CARMEN 463
al posto di ta[po ]ro, a v. 15, ed essa è puntualmente giustificata dal Castiglione stesso, che la accredita al collega Fulvio Orsini, poco propenso ad accogliere la stravagante congettura, benché formulata «a viro non indocto».28 Ma su questo avrò modo di tornare.
la traDiziOne archeOlOGica: la base vaticana
Un quarto testimone si aggiunge a quelli appena menzionati. Si tratta della base vaticana, il curioso oggetto qui rappresentato 29 (figg. 4-8):
28 Iosephi Castalionis cit. (nota 25), p. 45 s. 29 Ringrazio Marco Buonocore per avermi messo a disposizione le foto della base
vaticana dall‘archivio della Biblioteca Apostolica Vaticana.
Fig. 4
Fig. 5
_
R. MARCHIONNI - LA TRADIZIONE NON SOLO MANOSCRITTA DEL CARMEN 465
La base vaticana è conservata ai Musei Vaticani, e reca il numero di inventario 66535. Secondo la scheda che l’accompagna, si tratta di una «Arula settecentesca, ... nucleo di peperino, montata tra due lastre di marmo rosso». L’oggetto misura (in cm) 14 x 16,5 x 16,2, l’iscrizione stessa occupa cm 6 x 15 x 15. Il titulus pictus riportato sui quattro lati non è altri che il nostro carme CIL VI 1163.
La vicenda della base vaticana è tutt‘altro che limpida. I primi a parlarne sono due studiosi del XVIII secolo: si tratta di Antonio Francesco Gori 30 e del già menzionato Zoega. Entrambi sono prodighi di particolari sul conto della base, entrambi sono sicuri di trovarsi in presenza di un antico manu-fatto. Zoega, che cita in Gori la sua fonte,31 riporta la datazione di Gaetano Marini al sec. V o VI. Gori era invece andato ben oltre ed aveva identifi-cato la base con il modello utilizzato per la base di Costanzo, ovvero con il suo ‚archetipo‘. Essa sarebbe venuta alla luce nel 1730 a Castel Gandolfo e Francesco Vettori l’avrebbe posta nel Museo Vettori, la cui collezione sarebbe poi passata al Museo Cristiano.32 Gori aggiunge ancora un dato interessante sull’iscrizione: «versuum lectio exscripta est ex archetypo marmore ab eo-dem Mercato...».33 Mercati avrebbe dunque impiegato lezioni dell’iscrizione trasmesse dalla base per integrare le lacune della propria trascrizione.
Per verificare questa affermazione, andiamo a vedere il testo del titulus pictus della base vaticana: le lettere sottolineate sono quelle che leggeva Zoega e che, almeno in base al mio confronto fatto su riproduzioni fotografiche, non sono più visibili:
[.]A[.]RIS opus mun[- - -]Augustus toto Co[- - -]et quod nulla tulit [- - -][- - -]didit ut claris exaequet dona trium[- - -]
5 [- - -] decus ornatum genitor cognominis urb[- - -][- - -] volens caesa Thebis de rupe revell[- - -]
[- - -] gravior divu(m) taṇ[- - -]t cur[- - -]
30 GOri, Thesaurus veterum cit. (nota 13), p. 69 s.: «Constat basis haec quadrata, adeo-que anno 1730 reperta est apud Castrum Gandulphi... Nemo est qui non videat, quanto in pretio habendum sit archetypum hoc monumentum, exemplum basis nempe Obelisci».
31 zOeGa, De origine et usu cit. (nota 17), p. 54, nota 1.32 Di cui Vettori fu sin dalla fondazione, nel 1757, prefetto e curatore. Al proposito si
veda C. leGa, La nascita dei Musei Vaticani: le antichità cristiane e il Museo di Benedetto XIV, in Bollettino dei Monumenti Musei e Gallerie Pontificie, 28, 2010, pp. 95-184. A p. 115 s. viene ricordata «la cospicua collezione di oggetti cristiani donata personalmente al Pontefice nel 1756 da Francesco Vettori, che contava 6500 impronte gemmarie e 400 reperti, costituiti da vetri dorati, gemme, cammei, intagli su cristallo e vari altri manufatti».
33 GOri, Thesaurus veterum cit. (nota 13), p. 73.
›
REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. - VOL. LXXXV466
quod nullo ingenio nisuq(ue) manuq(ue) move[- - -] Caucaseam molem discurrens fama monebat
10 [- - -] dominus mu(n)di Constantius omnia fretus [-]edere virtuti terris incedere iussit [-]aut partem exiguam montis ponto(que) tum[- - -]
[- - -]†cta est velocius [- - -][- - -]pulo mirante carinam
15 interea Roma(m) taporo vastante tyranno [-]ugusti iacuit donum studiumq(ue) locandi [-]on fastu spreti sed quod no(n) crederet ullus [-]antae molis opus superas consurgere in aur[- - -]
[- - -] av[- - -]20 [- - -]que polos haec gloria dudum
auctori servata suo cum caede tyranni redditur atque [- - -]tu Romae virtute re[- - -] victor ovans urbiquae locat sublime tropae[- - -]principis et munus condignis usq(ue) triumphis.
Mentre dunque al v. 9 ritroviamo monebat, come lesse il Mercati (con-tro il moneret di Fontana e Castiglione), per il resto vengono confermate le integrazioni di Fontana e Castiglione:
[- - -]†cta est velocius [- - -][- - -]pulo mirante carinam
15 intêrea Roma(m) taporo vastante tyranno
Non convince dunque che Mercati abbia avuto accesso al presunto «ar-chetipo», respingendone sostanzialmente il dettato.
Va inoltre notato che Mercati non menziona alcun archetipo, ed anzi si attarda a dare precise spiegazioni di quella che egli stesso tratta come una propria congettura, ovvero il curioso taporo di v. 15: «...perciochè qui si fa mentione di Magnentio, il quale si nomina Taporo Tyranno, acciochè con mag-gior odio si rappresenti la sua memoria, havendo egli con gli suoi congiurati ... ammazzato Constante fratello di Constantio appresso Helena Castello delli Tapori, i quali sono popoli della Cantabria vicini alli monti Pirenei, dove ai nostri tempi da helena è rimasto il nome alla città di Elna nella Biscaia...».
Mente Mercati, tacendo l’archetipo, per esaltare le proprie doti filologi-che? O veramente non lo conobbe e giunse, ope ingenii, a restaurare la vera lezione al v. 15?
›
R. MARCHIONNI - LA TRADIZIONE NON SOLO MANOSCRITTA DEL CARMEN 467
Apriamo un nuovo cantiere, ed osserviamo l’aggettivo taporus più da vicino. Esso è attestato, in ambito letterario, una sola volta in Plinio, mentre conta 25 attestazioni fra le iscrizioni. Nel passo di Plinio, nat. 4, 118, che conserva un elenco di popolazioni della Lusitania, Tapori è denominazione alternativa per Turduli, insieme a quella di Bardili.34
Le iscrizioni che attestano l’aggettivo - ma spesso solo come integra-zione -, provengono tutte dalla Lusitania, tranne due, che provengono da zone al confine con la Lusitania stessa. Come annota A. Stylow,35 l’aggettivo viene impiegato o per indicare l’origo (cfr. ad es. CIL II 519-521) o quale cognome derivato dall’etnonimo (come per es. in CIL II 881).
Questa breve rassegna delle occorrenze di taporus, ci porta a due conclusioni: l’aggettivo non solo non viene mai usato con riferimento a Magnenzio, ma esso non ha nemmeno nulla a che vedere con la locali-tà Helena (oggi Elne, nei Pirenei), bensì designa un popolo stanziato su un‘area geografica, il cui centro va oggi identificato con la zona presso Capinha, Fundao e Castelo Branco.
Al verso 15 non va dunque integrato taporo, ma il più banale eppur giusto taetro di Orsini,36 come fece saggiamente il Castiglione, seguito in questo da Henzen e Bücheler.37
Ma è innegabile che l’azzardato taporo ebbe grande successo nella storia della tradizione di questo carmen: accolta senza riserve da Fontana, che pure, come abbiamo visto, non assume indiscriminatamente tutte le integrazioni del Mercati, conosciuta e rispettosamente accantonata dal Castiglione, che non esita a far il nome del grande Orsini a garanzia della sua scelta, ripresa dalla base vaticana, ribadita da Gori (ma lasciata senza commento da Zoega), essa si affaccia ancor oggi in alcune edizioni moderne di CIL VI 1163.38
34 Stipendiariorum quos nominare non pigeat…Augustobrigenses, Aeminienses, Aranditani…, Mirobrigenses qui Celtici cognominantur, Medubrigenses qui Plumbari, Ocelenses, Turduli qui Bardili et Tapori. Lusitaniam cum Asturia et Gallaecia patere longitudine DXL ...
35 Beiträge zur lateinischen Epigraphik im Norden der provinz Còrdoba, 1986, p. 244. Si veda anche M. navarrO caballerO, Grupo, cultura y territorio: referencias onomásticas „identitarias“ de los celtíberos y de los restantes pueblos del norte de la Citerior, in S. lefebvre - A. caballOs, Roma generadora de identidades: la experiencia hispana, Madrid 2011, pp. 107-140 (a p. 132 la mappa con le località, dove sono attestati i Tapori).
36 Un‘immagine, quella del taeter tyrannus, già cara a Cicerone (Phil. 13, 18 tam taeter, tam crudelis tyrannus eqs.; rep. 2, 48 tyrannus, quo neque taetrius neque foedius eqs.).
37 Bücheler, more suo, non si risparmiò, commentando la lezione taporo: „ceteri incredibiliter“.38 Ritroviamo taporo nel testo di CIL VI 1163 reso da Kastl, Der Lateranensische cit.
(nota 2), p. 10, con tanto di spiegazione nella nota 42, a p. 29: «das Volk nannte Magnentius Taporo. Wir wissen nicht, was dieser Spitzname bedeutet».
REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. - VOL. LXXXV468
Non sarà dunque ozioso suggerire un possibile scenario per la genesi di questa congettura del Mercati. Egli, come personaggio di spicco dell’ambiente culturale romano, intratteneva contatti con letterati ed intellettuali dell’epoca: tra questi figura l’umanista portoghese Achille Stazio.39 La presenza di un com-ponimento poetico40 di quest‘ultimo all’inizio dell’opera del Mercati «Instruttione sopra la peste», stampata a Roma nel 1576, è prova della loro familiarità.41 Stazio, che si era trasferito a Roma nel 1560, si era dedicato fin da giovanissimo allo studio dell’epigrafia.42 Come ci racconta Alejandra Guzmán Almagro43 «some old notes written by the young Estaço exist in which he writes down Latin words, possibly extracted from epigraphy and Portuguese toponymy...».
Queste notitzie mi suggeriscono l’ipotesi che il toponimo portoghese taporus fosse noto al Mercati per via della sua frequentazione col lusitano epigrafista Stazio e che, posto di fronte ad una lacuna nel testo del carmen, sia riandato col pensiero ad un‘antica, dotta discussione con il suo amico, scomparso ormai da sei anni, che a tali toponimi si era appassionato fin dalla gioventù.
La base vaticana, dal canto suo, ben lungi dall’essere l’archetipo del carme, andrà piuttosto classificata come un suo testimone contaminato, portatore cioè di lezioni caratteristiche di ambo i suoi modelli - Mercati da un lato, Fontana e Castiglione dall’altro. Per la datazione della base va visto il 1759, l’anno della pubblicazione del lavoro di Gori, come terminus ante quem, mentre il 1589, anno della pubblicazione della trascrizione del Mercati (con la congettura taporo), va considerato come terminus post quem. Quando, nell’arco di questi duecento anni circa, si diede l’incarico di costruire il manufatto, ed a quale scopo?
39 Per questo personaggio, autore dell‘Orthographia alphabetica collecta ex antiquis lapi-dibus, numismatibus et aliis monumentis, mai stampata, ma che ci è conservata completa nel codice B 104 della Biblioteca Vallicelliana a Roma, rimando al recente contributo di A. GuzMán alMaGrO, A Portuguese Contribution to 16th Century Roman Antiquaranism: The Case of Aquile Estaço (1524-1581) and Roman Epigraphy, in M. berbara, K.A.E. enenKel (a cura di), Portuguese Humanism and the Republic of Letters, Leiden - Boston 2012, pp. 353-372. In par-ticolare nella nota 2 di p. 353 si trova una raccolta di contributi relativi alla biografia dello Stazio. Vd. anche la bibliografia alla fine del contributo.
40 In dodici versi, inc. Sollers naturam extantem.41 È assai probabile che l‘amicizia, o almeno la frequentazione tra i due, sia nata
all‘interno della cerchia di Filippo Neri, a cui Stazio in punto di morte (1581) donò la sua ricca raccolta di volumi, e che può a tutti i titoli per questo esser considerato il fondatore della Biblioteca Vallicelliana. In generale, vd. G. finOcchiarO, Vallicelliana segreta e pubblica: Fabiano Giustiniani e l‘origine di una biblioteca universale, Firenze 2011.
42 Ebbe per maestro anche André de Resende, considerato «the first author of antiqua-rian treatises in Portugal». V. GuzMán alMaGrO, A Portuguese cit. (nota 40), p. 354 s..
43 GuzMán alMaGrO, A Portuguese cit. (nota 40), p. 355.
R. MARCHIONNI - LA TRADIZIONE NON SOLO MANOSCRITTA DEL CARMEN 469
Una testimonianza, quella di Antonio Nibby, 44 sembrerebbe farci fare un passo avanti in questa ricerca: «Angelo Rocca ... fece collocare nella Biblioteca Vaticana un modello di questo piedistallo medesimo prima che fosse distrutto, e dove anche oggi si vede».
L’ipotesi che sia stato proprio il Rocca, fondatore della Biblioteca An-gelica nel 1604 e quindi quasi contemporaneo dei personaggi di cui si è finora parlato, a commissionare il manufatto, è suggestiva. Ma non se ne trova alcun riscontro, nemmeno nell’opera del Rocca stesso, la Bibliotheca Apostolica Vaticana, stampata a Roma nel 1591, che pure alle pp. 17-20 e 275-278 si dedica al testo della base di Costanzo.
Fino al momento in cui queste affermazioni di Nibby non verranno confermate, bisogna dunque continuare a cercare. Secondo il Nibby, il mo-dellino della base sarebbe stato concepito indipendentemente dall’obelisco. Ma Gori 45 non dubitava del fatto che il modellino comprendesse un tempo anche l’obelisco e, tra le varie ipotesi, immagina come un nobile romano se lo sia portato, ormai diviso dalla sua base, nella sua tenuta di campagna, per goderselo da solo e a pieno agio.
Del resto, modellini di obelischi sono noti e tra questi i più degni di interesse sono senz‘altro quelli che appartennero al famoso Athanasius Kir-cher, che se ne serviva per le sue lezioni di egittologia presso il Collegio Romano; alcuni di questi, uno sprovvisto di base, sono conservati oggi nel Liceo-Ginnasio Ennio Quirino Visconti, istituto erede degli spazi del Collegio.46
Nell’attesa che a queste speculazioni venga dato riscontro scientifico, dobbiamo accettare che sia la data esatta della fabbricazione del manufatto sia il nome del committente restino ignoti.47
44 Roma nell‘anno MDCCCXXXVIII, parte II, Roma 1839, p. 259. Tra l‘altro anche il Nibby accetta taporo senza battere ciglio e non si attarda nemmeno a darne una spiegazione.
45 GOri, Thesaurus veterum cit. (nota 13), p. 74.46 Kircher, nei suoi numerosi scritti di egittologia, si occupò anche dell‘Obelisco Late-
ranense, ad es. nell‘Oedipus Aegyptiacus, Romae 1654, III, dove, tra le pp. 160 e 161, si può ammirare una splendida illustrazione del monumento. Fotografie dei modellini di obelisco si trovano nel volume di O. hein, r. MaDer, I modelli degli obelischi di Atanasio Kircher S.J. nel Collegio Romano, Köln - Wien 1991, pp. 29-32.
47 Anche se va preso sul serio il ruolo avuto dal Vettori e sottolineato dal Gori (vd. supra). Una direzione che potrebbe prender la ricerca mi sembra suggerita ancora da leGa, La nascita cit. (nota 33), p. 116, nota 60, che riporto quasi per intero: «Un inventario parziale (già ritenuto perduto) delle opere del Museo Vettori, passate nel Museo Cristiano, si con-serva in duplice copia in Biblioteca Apostolica Vaticana, Arch. Bibl. 11, ff. 469r-481r; Arch. Bibl. 51, ff. 42r-60v: è firmato in entrambe le copie dal Vettori e comprende … un totale di 326 oggetti(303 + 23 aggiunti), ma in calce al documento si annota: Sunt quoque plura ex ebore vetusta monimenta, quae cum Sacra non sint, licet variis temporibus e sacris Coemeteriis prodierint,
REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. - VOL. LXXXV470
Ma val la pena di ragionare sullo scopo che portò alla sua fattura: opus imperfectum, modello dunque della sola base, oppure di tutto l’obelisco, da cui il corpo stesso andò chissà quando perduto, commissionato come og-getto di collezione o di studio, certo è che esso è stato concepito e creato per conservare e trasmettere la base antica ed il suo testo, nella loro unità.
Costruito in un tempo in cui la base di Sisto campeggiava in mezzo ad una delle più importanti piazze di Roma, non riprodusse questa ed il suo testo, ma base e testo antichi, destinati altrimenti a sparire, almeno in questa forma. Una trasmissione per così dire tridimensionale e dunque alternativa a quella che ha impegnato i più famosi collezionisti e divulgatori di iscrizioni per via manoscritta.
L’importanza dell’unità di testo e monumento rispecchia una visione piuttosto moderna, oggi definitivamente riconosciuta come l’unica possibile ed efficace nello studio dell’epigrafia da parte di tutti i progetti intenti all’e-dizione di iscrizioni antiche. In prima linea, con la pubblicazione di foto, calchi e testimoni manoscritti, ma anche con la descrizione minuziosa del monumento che reca l’iscrizione, troviamo il Corpus Inscriptionum Latinarum.
l’ultiMO seGretO Dell’ObeliscO lateranense
La storia dell’obelisco lateranense illustra in maniera esemplare e sotto diversi punti di vista il fenomeno della ricezione: per due volte viene recepito in contesti e culture nuove, deve per così dire integrarsi, aggiungere nuove identità a quella (o a quelle) già esistenti. In questo lo aiutano le basi con le loro iscrizioni, dedicata a Costanzo II quella del IV sec., a Sisto V quella del XVI sec. Ancor oggi l’obelisco conserva le tracce delle sue diverse identità: ben saldo sulla base seicentesca, fa intravvedere, tra i geroglifici, le lettere latine dei frammenti usati dal Fontana per il restauro. Costante resta il suo ruolo di emblema del potere, di quello di Thutmose IV prima, di Costanzo II poi ed infine di quello papale. Costante anche il suo essere uno strumento di propaganda e di comunicazione del potere con il popolo: senza voler entrar nel merito, sarà interessante osservare che mentre Costanzo e Sisto V mantennero la comunicazione quasi ad altezza d‘occhi con il passante, già gli Egiziani, i cui geroglifici giungono fino alla punta del monumento, sembrano aver pensato, tra i loro lettori, anche agli dei.
heic non describuntur. Nell‘inventario del Museo Cristiano del 1762 … risultano inoltre cata-logati come provenienti dalla collezione Vettori diversi altri manufatti di materiale vario, che tuttavia non sono compresi in questo inventario del Museo Vettori».
R. MARCHIONNI - LA TRADIZIONE NON SOLO MANOSCRITTA DEL CARMEN 471
Domenico Fontana, architetto del papa nel XVI sec., potrebbe aver covato la stessa ambizione: diversamente è difficile comprendere come mai egli, non pago della famosa firma scritta sulla base (fig. 9), pose una seconda iscrizione, a mio avviso sinora ignota e non visibile ad occhio nudo, che si trova sulla punta dell’obelisco, ed in cui leggiamo (figg. 10-11):
Iovanes Fontanna[- - -]p. m. erecto iam alter(o) ad limina petri et alium ad s(anctae) m(ariae)
m(aioris) pendicesDominicus Fontanna adiutore Carolo Maderno ex sorore nep(ote)
erexer(unt) an(no) MDLXXXVII
Giovanni Fontana[- - -] p(ontefice) m(assimo). Eretto già un obelisco alle soglie di Pietro ed un
altro alle pendici di S. Maria Maggiore, Domenico Fontana con l’aiuto di Carlo Maderno, nipote da parte di sorella, hanno eretto (l’obelisco) nell’an- no 1587.
Fig. 9






























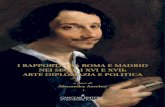




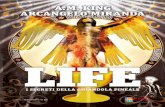

![Terrorism, A Female Malady [on Segreti segreti and Diavolo in corpo]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63156614c32ab5e46f0d49c2/terrorism-a-female-malady-on-segreti-segreti-and-diavolo-in-corpo.jpg)

