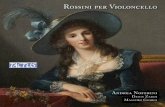PER UNA TIPOLOGIA DELLA CERAMICA PREISTORICA:NOTE METODOLOGICHE PER LO STUDIO DELLE PRODUZIONI DEL...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of PER UNA TIPOLOGIA DELLA CERAMICA PREISTORICA:NOTE METODOLOGICHE PER LO STUDIO DELLE PRODUZIONI DEL...
COMITATO DI REDAZIONEG. Bartoli – R. Belcari – P. Cavicchi – F. Fedeli – A. Galiberti – L. GiannoniP. Gorini – C. Murolo – M. RicciC.P. 109 – 57025 Piombino LIDir. resp. I. TognariniReg. Trib. di Firenze n. 3045 del 5.7.1982
Gli autori sono responsabili delle opinioni espresse nei singoli contributi.
CONSULENTI SCIENTIFICIS. Bruni – G. Ciampoltrini – G. De Tommaso – L. Donati – R. Grifoni CremonesiM. Massa – A. Romualdi
RASSEGNA DI ARCHEOLOGIA è pubblicata annualmente in due fascicoli a cura dell’Associazione Archeologica Piombinese, con il contributo della Provincia di Livorno e del Comune di Piombino.
EDIZIONE E DISTRIBUZIONEEdizioni All’Insegna del Giglio s.a.s. – Via della Fangosa, 38 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)E-mail [email protected]/[email protected] Tel. +39.055.8450216 Fax +39.055.8453188
ABBONAMENTI2 fascicoli semestrali: Italia € 34,00; Estero € 36,001 fascicolo: Italia € 18,00; Estero € 19,00Per gli invii all’estero saranno addebitate le spese di spedizione.
In copertina: scodella del Bronzo Finale da L. ARCANGELI-E. PELLEGRINI-G. POGGESI, in L’insediamento sommerso di Punta degli Stretti, in Atti della XXXIV Riun.Sc. IIPP, Firenze 2001.
ISSN 1721-629XISBN 978-88-7814-528-3 © 2011 All’Insegna del Giglio s.a.s.
Edizioni All’Insegna del Giglio s.a.s via della Fangosa, 38; 50032 Borgo S. Lorenzo (FI) tel. +39 055 8450 216; fax +39 055 8453 188 e-mail [email protected]; [email protected] sito web www.edigiglio.it
Stampato a Firenze nel dicembre 2011 Tipografia Il Bandino
SOMMARIO
Palma di Cesnola A. Le industrie di Grotta Paglicci (Rignano Garganico – FG): strati 9-8 (scavi A. Palma di Cesnola 1973-1975)
Pag. 11
Galiberti A. Nuova proposta di scheda per lo studio degli utensili litici da miniera per l’estrazione della selce
» 55
De Angelis M.C. Materiali dell’età del Bronzo dalla Grotta dei Cocci di Narni (TR)
» 73
Poesini S., Agresti A. Per una tipologia della ceramica preistorica: note metodologiche per lo studio delle produzioni del Bronzo finale e del primo Ferro
» 83
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE
AA – Archäologischer Anzeiger, Berlin.AEA – Archivo Español de Arqueologìa, Madrid.AION Arch. St. Ant. – Annali del Dipartimento di Studi del Mondo Classico e del Mediterra-
neo Antico. Istituto Orientale di Napoli, sez. Archeologia e Storia Antica, Napoli.
A.I.R.R.S. – Acta Instituti Romani Regni Sueciae, Stockholm.AJA – American Journal of Archaeology, Baltimore.AM – Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Atenische
Abteilung, Athen.Ant. Afr. – Antiquités Africaines.Arch. Antr. Etn. – Archivio per l’Antropologia e l’Etnologia, Firenze.Arch. Class. – Archeologia Classica, Roma.Atti Acc. Naz. Lincei – Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Roma.Atti Acc. Pont. – Atti dell’Accademia Pontificia Romana di Archeologia, Roma.Atti e Mem. Acc. Agric. SS.LL. Verona – Atti e Memorie dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di
Verona, Verona.Atti Riun. Sc. I.I.P.P. – Atti delle Riunioni Scientifiche dell’Istituto Italiano di Preistoria e
Protostoria.Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Mem. – Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie, Serie A, Pisa.B.A. – Bollettino d’Arte, Roma.BAR – British Archaeological Reports, Oxford.BCH – Bulletin de Correspondance Hellénique, Athènes-Paris.B.E.F.A.R. – Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome, Paris.BdI – Bollettino dell’Istituto di Corrispondenza Archeologica, Roma.Boll. Mus. Civ. St. Nat. Verona – Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Verona.B.P.I. – Bollettino di Paletnologia Italiana, Roma.BSA – Annual of the British School at Athens, London.Bull. Com. – Bollettino della Commissione Archeologica Comunale, Roma.Bull. Soc. Geol. It. – Bollettino della Società Geologica Italiana.CAS – Cahier d’Archéologie Subaquatique, Gap.C.I.E. – Corpus Inscriptionum Etruscarum, Leipzig, Firenze.C.I.I. – Corpus Inscriptionum Italicarum (a cura di A. Fabretti), Torino.C.I.L. – Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlino.C.N.I. – Corpus Nummorum Italicorum, 1910-1943.DdA – Dialoghi d’Archeologia, Roma.JRS – Journal of Roman Studies, London.Lavori Soc. Ital. Biogeogr. – Lavori della Società Italiana di Biogeografia.MAAR – Memoirs of the American Academy in Rome, Roma.MAL – Monumenti Antichi dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Roma.MEFR – Mélanges d’Archéologie et d’Histoire de l’École Française de Rome,
Paris.MEFRA – Mélanges de l’École Française de Rome, Antiquité, Roma.Mem. Acc. Naz. Lincei – Memorie dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Roma.Mem. Mus. Civ. St. Nat. Verona – Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Verona.Not. Sc. – Notizie degli Scavi di Antichità, Roma.Par. Pass. – La Parola del Passato, Napoli.P.B.S.R. – Papers of the British School at Rome, London.Proc. Prehist. Soc. – Proceedings of the Prehistoric Society, Cambridge.RA – Revue Archéologique, Paris.RCRFA – Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta.RE – Real-Enzyklopädie der classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart.REA – Revue des Études Anciennes, Bordeaux.
REE – Rivista di Epigrafia Etrusca (in Studi Etruschi), Firenze.RIC – Roman Imperial Coinage, London.RM – Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische
Abteilung, Rom.Rend.Acc.Arch.Lett.BB.AA. Napoli – Rendiconti dell’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli,
Napoli.Rend. Ist. Lomb. Acc. SS.LL. – Rendiconti dell’Istituto Lombardo Accademia Scienze e Lettere.Rend. Ist. March. SS.LL. ed Arti – Rendiconti dell’Istituto Marchigiano di Scienze, Lettere ed Arti, Ancona.Riv. Antr. – Rivista di Antropologia.RSL – Rivista di Studi Liguri, Bordighera.RSP – Rivista di Scienze Preistoriche, Firenze.SCO – Studi Classici e Orientali, Pisa.St. Etr. – Studi Etruschi, Firenze.Wiad. Arch. – Wiadomos’ci Archeologiczne, Warsava.
Rassegna di Archeologia 23A/2007-2008
Stefania Poesini* – Alberto Agresti**
PER UNA TIPOLOGIA DELLA CERAMICA PREISTORICA: NOTE METODOLOGICHE PER LO STUDIO DELLE PRODUZIONI
DEL BRONZO FINALE E DEL PRIMO FERRO
Il presente studio si inserisce nel filone di ricerca metodologica volto alla definizione di parametri utili per la creazione di una griglia di classificazione delle produzioni ceramiche, sia a livello formale sia di attributi secondari1.
L’analisi dei materiali archeologici si basa principal-mente sulla loro descrizione e classificazione, con un duplice intento: la datazione dei complessi in studio attraverso la creazione di cronologie relative e la rico-struzione dei molteplici aspetti della cultura materiale, dalle tecniche di produzione agli stili, sino alle possibili implicazioni socioculturali2. Descrivere è sempre il pri-mo passo verso la comprensione, in quanto permette di cogliere le affinità e le differenze dei fenomeni oggetto di studio, mettendone in luce i rapporti più intimi. La descrizione può servire anche a scopi classificatori, qua-lora permetta di trovare le relazioni all’interno di una moltitudine apparentemente caotica di manufatti3. Ne deriva una conoscenza empirica dell’oggetto in studio che non deve però essere fine a sé stessa, ma costituire il primo passo di una ricerca su base razionale4.
TRA CLASSIFICAZIONE E TIPOLOGIA: QUESTIONI DI METODO
Ogni qualvolta ci avviciniamo allo studio dei materiali, è normale imbattersi in differenti metodi
di classificazione. In campo archeologico il dibattito scientifico sui vari modelli impiegati e sulla loro utilità divide ed unisce scuole di pensiero diverse. Classificare significa dividere una qualsiasi realtà osservabile in categorie discrete5, e nel nostro caso ordinare e suddividere i reperti secondo un procedi-mento di tipo cladistico (a frazionamento crescente) che porti all’identificazione di entità minime omo-genee e non ulteriormente divisibili6. Si tratta di un modo per analizzare sistemi politetici multiformi, creando sulla base di dati empirici delle griglie astrat-te di riferimento che permettano di individuare i rapporti interni ai materiali. Questi vengono divisi in classi distinte, caratterizzate ciascuna dalla ricorrenza di specifiche caratteristiche tecnologiche, formali e tipometriche. Per la comprensione, l’organizzazione del nostro pensiero si affida al principio di similarità tra le cose, attraverso il quale riesce a cogliere il reale scomponendolo in categorie distinte7. Inoltre, per essere efficace, una classificazione deve avere solide basi epistemologiche ed utilizzare criteri chiari ed univoci, che possano anche essere verificabili su base statistica8. Il primo problema connesso con un’operazione di questo genere è stabilire i principi su cui basare le definizioni di analogie e differenze, dato che le proprietà fisiche di un oggetto possono essere molteplici. La maggior parte delle moderne classificazioni archeologiche si ispira direttamente o indirettamente ai criteri tassonomici delle scienze9,
* Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti – Sezione di Preistoria ([email protected]).** Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Medioevo, Rinascimento e Linguistica, sez. Paletnologia.1 SARTI, 1989; SARTI, 1993; SARTI, 2005; VOLANTE, 2001.2 CAZZELLA, 1999, pp. 13-20; SARTI, 2005, p. 573; PERONI, 1998.3 MALINA VAŠÍČEK, 1997, pp. 91-92.4 LAPLACE, 1975, p. 92.5 PALOMBINI, 2001, p. 127.6 VIDALE, 2007, p. 88.7 Noi riconosciamo le cose solo se rispondono ai principi aristotelici di unità, uniformità ed universalità: per questo confrontare gli oggetti
sulla base del loro aspetto permette di coglierne i legami più profondi: MALINA VAŠÍČEK, 1997, pp. 148-149; SARTI, 1989, p. 130.8 CLARKE, 1998, pp. 161-188; PERONI, 1994, p. 25; VIDALE, 2007, p. 88.9 RICE, 1987, pp. 282 e ss.; VIDALE, 2007, pp. 96-97.
STEFANIA POESINI – ALBERTO AGRESTI84
la cui rigidità è stata attenuata attingendo anche a modelli concettuali di tipo filosofico10. Ciò è stato dettato dalla natura stessa dei manufatti, in quanto, essendo un prodotto culturale, conservano in sé quell’alta variabilità propria dei processi umani che li hanno creati, difficilmente comprimibile entro rigide categorie. Ogni procedimento classificatorio comporta la definizione di criteri univoci con cui poter selezionare i descrittori per mezzo dei quali individuare le diverse classi. La maggior parte degli studi si basa solitamente su tipologie canonizzate di tipo intuitivo, dove si uniscono assieme aspetti formali e culturali. I sistemi classificatori impiegati nella ricerca archeologica possono essere diversi, a secondo dei fini che ci si pongono, ma gli obiettivi principali rimangono sempre gli stessi: ricostruire il quadro culturale di riferimento e, soprattutto, realiz-zare delle serie tipologiche che permettano di definire la cronologia relativa di un sito ed il suo rapporto con quella assoluta di un territorio11. Le principali tendenze nello studio delle produzioni artigianali archeologiche si possono ridurre sostanzialmente a due: uno classificatorio propriamente detto ed uno tipologico. Il primo è volto all’identificazione di categorie definite da criteri morfologici (formali) e dimensionali (tipometrici), funzionali a cogliere l’omogeneità formale e le anomalie stilistiche di una produzione artigianale. Il secondo è invece finalizzato essenzialmente ad individuare su basi intuitive le unità significative minime (i tipi secondo l’accezione tradizionale) di un dato contesto cultu-rale. Tale distinzione riflette quella ben più ampia indicata in ambito angloamericano rispettivamente con i termini etic (etico) ed emic (emico)12. Questi due sistemi operativi, apparentemente contrapposti, nella realtà della ricerca sono tra loro complementari,
in quanto, pur procedendo su piani distinti, tendono a convergere nel momento in cui ci si appresta alla comprensione dei fenomeni13.
Qualunque sia il criterio di analisi, è necessa-rio comunque fare molta attenzione nella scelta degli attributi, in quanto tale operazione impli-ca un principio discriminatorio che deve essere supportato da un valido statuto epistemologico14. Parte fondamentale della classificazione è volta ad individuare tipi e tipologie, concetti basilari della ri-cerca archeologica. Il termine tipologia infatti, può essere usato per indicare il processo classificatorio, gli esiti dello stesso processo ed il tipo stesso, inteso come forma specifica all’interno di una categoria di manufatti. Già G. Laplace ne aveva osservato la natura plurima, riconoscendole due significati: da una parte quello di scienza dell’elaborazione dei tipi, che aiuta nell’analisi di una realtà complessa e nella classificazione (sistematica o tassonomica), dall’altra quello di sistema o lista di tipi15. Questa ambiguità certo non ha facilitato la comunica-zione nel dibattito scientifico, né si è cercato di adottare un linguaggio comune ed ampiamente condiviso16.
Studi recenti hanno cercato di mettere in eviden-za i limiti dei metodi classificatori tradizionali su base intuitiva: riconoscendone l’insufficienza, vi è chi suggerisce di operare con molteplici sistemi classifi-catori, i cui dati, una volta fatti interagire, possono fornire un quadro più completo e verosimile della realtà archeologica indagata17. I sistemi tipologici di analisi devono essere considerati come semplici mezzi, attraverso i quali perseguire degli obiettivi chiari e predefiniti18: non attribuendo loro ulteriori valori concettuali, si avranno anche meno problemi a modificarli qualora si rivelino inadeguati19.
10 Si pensi alle categorie aristoteliche di Peroni, al metodo dialettico di Laplace o agli apporti delle teorie marxiste, processuali (Binford, Clarke), post processuali (Renfiew, Baham, Hodder) e neostrutturaliste: PERONI, 1994, p. X; MALINA VAŠÍČEK, 1997, pp. 78-115; LAPLACE, 1975, pp. 94-97; RANDSBORG, 2000, pp. 171-188; CUOZZO, 2000, pp. 323-360.
11 BIETTI SESTIERI, 2000, p. 61.12 BIETTI SESTIERI, 1999, pp. 21-25; CAZZELLA, 1999; COCCHI GENICK, 2006, pp. 561-562; GUIDI, 1994, p. 53; PALOM-
BINI, 2001, pp. 127-128; PERONI, 1998, pp. 11-14.13 CAZZELLA, 1999, p. 18; SARTI, 2005, p. 573, nota 13.14 PALOMBINI, 2001, p. 129.15 LAPLACE, 1975, p. 92; VIDALE, 2007, p. 91.16 Una delle proposte più recenti, per superare le ambiguità, vorrebbe limitare l’uso del termine tipologia ad identificare la sola lista
dei tipi, dato che per indicare il metodo di definizione e le singole fogge esistono termini appositi più precisi. In tal modo si scinderebbe il processo classificatorio dal rapporto diretto con le liste tipologiche, limitandone il valore a supporto terminologico: PALOMBINI, 2001, pp. 137-139; VIDALE, 2007, p. 91.
17 VIDALE, 2007, p. 96.18 PALOMBINI, 2001, pp. 137-138.19 LAPLACE, 1966, p. 11; PALOMBINI, 2001, pp. 138-139.
NOTE METODOLOGICHE PER LO STUDIO DELLE PRODUZIONI DEL BRONZO FINALE E DEL PRIMO FERRO 85
Nell’analisi tipologica dei materiali ceramici pro-venienti da alcuni contesti protostorici toscani del Bronzo finale – Punta degli Stretti (Orbetello, GR); Cilea (Sesto Fiorentino, FI) – e della prima età del Ferro – Madonna del Piano 4c (Sesto Fiorentino, FI) – si è deciso di ricorrere al metodo gerarchico morfotipometrico sviluppato da L. Sarti e dal suo gruppo di ricerca a partire dalla tipologia analitica di G. Laplace20. Attraverso parametri predefiniti su base empirica, basandosi sui dati tipometrici e morfotecnologici degli oggetti21 e sulla ricorrenza delle loro caratteristiche all’interno dell’industria, è possibile definire classi formali e dimensionali. Questi dati inoltre, per mezzo di semplici calcoli statistici consentono di individuare i modelli a cui gli oggetti fanno riferimento, le cui caratteristiche possono essere dettate da necessità funzionali oppure essere frutto di motivi semplicemente “culturali”22. La tipologia analitica si sforza inoltre di elaborare una terminologia valida per tutte le industrie, a prescin-dere dal contesto cronologico, culturale e regionale, permettendo così di cogliere l’esistenza di fenomeni di convergenza morfotecnologica e strutturale, dif-ficilmente accessibili ad un sistema di analisi solo di tipo empirico o funzionale23. Il metodo analitico laplaciano rielaborato da L. Sarti può essere in parte collocato tra i sistemi classificatori descrittivi (etici), in quanto propone una classificazione non spontanea ma cladistica su base analitica24. Tuttavia, si presenta anche come strumento per la lettura storica dei complessi industriali, rivelando di avere i caratteri di una vera e propria tipologia25. La sua maggiore peculiarità risiede soprattutto nel rifiuto di criteri essenzialmente funzionali e descrittivi, in favore di un’analisi gerarchica degli attributi26. A prescindere dal rigore formale, ha mantenuto la sua natura ori-ginale di strumento di ricerca, mostrandosi capace di essere costantemente ampliato ed aggiornato attra-
verso un rapporto dialettico con i materiali di volta in volta analizzati, rientrando così pienamente tra i metodi innovativi e non rigidamente normativi27.
LE TERMINOLOGIE IN USO PER LA CERAMICA PROTOSTORICA
I reperti ceramici, data la loro molteplicità di forme e di funzioni, rappresentano un prodotto culturale manipolabile ed apparentemente di facile interpreta-zione, capace di fornire immediati risultati conoscitivi. Anche se frammentari conservano le tracce dei pro-cessi tecnologici e culturali delle comunità di cui sono espressione: per questo vengono considerati come veri e propri fossili guida per la datazione dei complessi archeologici. A questo aspetto se ne aggiungono inoltre altri due: la comprensione dei fenomeni legati alla loro produzione e circolazione, e l’individuazione degli aspetti socioculturali connessi con il loro utiliz-zo (dalle pratiche alimentari a quelle rituali)28. Una delle difficoltà maggiori che si presenta allo studioso di reperti ceramici, è l’alta variabilità delle forme vascolari che ha portato, nella tipologia intuitiva di tipo tradizionale, alla proliferazione di termini diversi, dal valore spesso regionale, usati come sinonimi per indicare gli stessi tipi di oggetti, con il risultato di non essere sempre chiari ed univoci (Fig. 1).
Si tratta, tuttavia, di una terminologia ormai codificata dall’uso e sostanzialmente non modifica-bile, della quale non può fare a meno chiunque si accinga alla definizione dei confronti tipologici. Per i materiali italiani del Bronzo Finale e della prima Età del Ferro esiste una tradizione di studi consoli-data che fa principalmente riferimento al dizionario terminologico dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione29 ed alle liste terminologiche elaborate da R. Peroni e dalla sua scuola30.
20 LAPLACE, 1975, p. 92; SARTI, 1989; SARTI, 2005.21 LAPLACE, 1975, pp. 96-97.22 Se si può così dire, attraverso un procedimento etico permette di giungere a considerazioni d tipo emico: SARTI, 2005.23 VOLANTE, 2001, p. 78.24 Si basa cioè su dati tipometrici e morfotecnologici, dove però l’analisi procede secondo un principio gerarchico: LAPLACE, 1968;
LAPLACE, 1975.25 SARTI, 1989, p. 131.26 SARTI, 1989, p. 130.27 VIDALE, 2007, p. 96.28 Orton le definisce come le big three: dating evidence, distributional evidence, evidence for function and/or status: CIACCI, 2007, pp.
156-157; ORTON et ALII, 1993, pp. 23-24.29 PARISE BADONI, 1980; PARISE BADONI, 2000.30 PERONI, 1967; PERONI, 1994; PERONI, 1998, pp. 10-27. Si vedano a riguardo anche le pubblicazioni della collana da lui diretta,
Grandi contesti e problemi della protostoria italiana.
STEFANIA POESINI – ALBERTO AGRESTI86
Fig. 1 – Tabella sinottica della terminologia corrente impiegata per le principali forme vascolari del Bronzo finale-primo Ferro italiano.
SARTI, 2005PARISE
BADONI, 1980, 2000
PERONI, 1994 CARDARELLI et ALII, 1999
CÀSSOLA et ALII, 1999
BELARDELLI et ALII, 1999
NEGRONI CATACCHIO et ALII, 1999
BENTINI et ALII, 1999
BONGHI JOVINO, 2001
D’AGOSTINO-GASTALDI, 1988; GASTALDI, 1998
Forme molto basse teglia piatto per focacce teglia teglia teglia
Forme basse
piattello piatto piattello piatto piatto/ciotola piattellopiattello su piede coppa-piattello piattello su piede
scodella
scodella scodella scodella scodellaciotola• ad orlo rientrante• troncoconica
scodella• a labbro rivolto all’esterno• a labbro rientrante• di copertura
scodella/ciotola/coppa
scodella/scodellone
scodella/coppa su piede coppa (su piede)
coppa coppa (= kotyle) tazza
Forme medie
ciotola ciotola ciotola ciotolaciotola• carenata• a profilo ad S
scodella a labbro rivolto all’esterno coppa/tazza
tazza tazza bassa tazza tazza tazza ciotola attingitoio tazza oriolo tazza/attingitoiotazza-attingitoioanforetta tazza biansata anforetta tazza biansata anforetta anfora
Forme medie/profonde
boccale boccale boccale boccale boccale boccale boccale/orciolo boccale
brocca/brocchetta brocca brocca brocca brocca brocca/brocchetta
bicchiere/olletta bicchiere bicchiere vaso
• ad olla• globulare• cilindrico
bicchiere olla ovoide/olla globulare bicchiere
Forme profonde
ollaolla olla olla olla olla/olletta
olla ovoide/olla ovoide-cilindrica/olla ovoide-globulare/orciolo
olla/olletta monoansata
urna/vaso a collo vaso a collo vaso a collo vaso a collo distinto vaso lenticolare vaso a collo distinto olla globulare
vaso biconicovaso biconico
urna/vaso a collo troncoconico e corpo biconico vaso
biconicoossuario biconico vaso biconico vaso biconico biconico olla biconica
urna/vaso biconico
brocca orciolo orciolo orciolo
anfora anfora anfora vaso ad anfora anfora/anforetta anfora
dolio dolio dolio dolio dolio dolio olla doliaria dolio/ziro
Fig. 2 – Schema tipologico dell’analisi gerarchica dei contenitori 34.
Tipo formale primario tipo formale secondario
Serie formale Classe formale Gruppo formale Variantecaratteri formali principali caratteri formali secondari
forma bassa (scodella) semplice a calotta ad orlo non distinto con ansa orizzontale a bastoncello; decorazione a punzone sull’orlo31
forma media (tazza) composta con vasca a calotta e parete troncoconica
breve parete troncoconica ad orlo non distinto, alta carena32
forma profonda (vaso) semplice cilindrico a parete convessa ad orlo non distinto con decorazione plastica a cordone
liscio orizzontale33
forma profonda (vaso) composta biconicoad orlo distinto a tesa, collo convesso, spalla arrotondata e ventre troncoconico a pareti rettilinee
ansa orizzontale a bastoncello a sezione circolare
31 SARTI, 1997, p. 222.32 SARTI, 1997, p. 148.33 SARTI, 1997, p. 237.34 GRIFONI CREMONESI et ALII, 1999, p. 63; SARTI, 1989; SARTI, 2005, p. 573; VIGLIARDI, 1999, p. 179.
NOTE METODOLOGICHE PER LO STUDIO DELLE PRODUZIONI DEL BRONZO FINALE E DEL PRIMO FERRO 87
Fig. 3 – Tese molto ampie (nn. 1-4); ampie (nn. 5, 7); strette (nn. 6-7). Da Madonna del Piano 4c (Sesto Fiorentino, FI) (nn. 1-3, 5, 7, 9-10) e dal sepolcreto Benacci Caprara di Bologna (nn. 4, 6, 8, da TOVOLI, 1989).
STEFANIA POESINI – ALBERTO AGRESTI88
Fig. 4 – Forme basse (scodelle) ad orlo non distinto introflesso: A) Bronzo finale: nn. 1-3 da Cilea (Sesto Fiorentino, FI); nn. 4-6 da Punta degli Stretti (Orbetello, GR); B) Prima età del Ferro: nn. 7-8 da Madonna del Piano 4c (Sesto Fiorentino, FI).
35 SARTI, 2005.36 SARTI, 1989, p. 133; SARTI, 2005, p. 568.
Il metodo elaborato da L. Sarti permette di sem-plificare lo studio delle forme, agevolando l’indivi-duazione di macrocategorie morfologiche (Fig. 2).
I tipi formali primari, vengono definiti dalla som-ma degli attributi strutturali (serie, classe e gruppo) e costituiscono il modello archetipico metastorico35. L’oggetto concreto corrisponde invece al tipo formale secondario (o variante), identificato da quei caratteri secondari distintivi di una data facies culturale, che
variano ma non mutano il tema morfologico origi-nale36. I caratteri che concorrono a definire le varianti sono a loro volta divisibili in primari e secondari: i primi sono determinati dalla morfologia dei singoli elementi strutturali (orlo, corpo, base) e possono tal-volta intervenire nella definizione del tipo formale, i secondi da quelli accessori (anse, prese, decorazione) e non alterano in alcun modo la definizione del tipo formale, ma semplicemente lo caratterizzano.
A
B
NOTE METODOLOGICHE PER LO STUDIO DELLE PRODUZIONI DEL BRONZO FINALE E DEL PRIMO FERRO 89
Fig. 5 – Forme basse (scodelle) ad orlo non distinto introflesso tendente a distinto: nn. 1-2 da Cilea (Sesto Fiorentino, FI); nn. 3-6 da Punta degli Stretti (Orbetello, GR).
GLI ORLI DELLE FORME BASSE. ANNOTAZIONI MORFOTIPOMETRICHE
Sulla base di queste considerazioni, abbiamo ritenuto opportuno introdurre alcuni parametri aggiuntivi, sia tipometrici che morfologici, che si adattassero in modo più appropriato a contesti protostorici. Questa necessità si è presentata in occa-sione dello studio di industrie ceramiche provenienti dall’area di Sesto Fiorentino (FI) e risalenti all’età del Bronzo recente/finale ed al primo Ferro con elementi
di analisi dedotti dallo studio di Punta degli Stretti (Orbetello-GR) come contesto di passaggio tra Bronzo finale e primo Ferro37. Presentiamo in questa sede alcune considerazioni di carattere morfotipo-metrico relative agli orli delle forme basse.
L’orlo è definibile come la porzione superiore di un contenitore prossima all’imboccatura, la cui parte terminale è indicata con il termine di bordo. Una volta assodata la differenza tra gli orli distinti e non distinti38 e riconosciutane la diversa tipologia in base alla morfologia che li caratterizza39, si prende in con-
37 Lo studio del materiale è inserito all’interno del dottorato in Archeologia Preistorica presso l’Università degli Studi di Siena e di una tesi di laurea in Archeologia Preistorica presso l’Università degli Studi di Firenze.
38 L’orlo non è distinto se il suo profilo è in continuità con quello della parete sottostante e viceversa.39 Orli diritti, introflessi, estroflessi, a colletto, a tesa.
STEFANIA POESINI – ALBERTO AGRESTI90
Fig. 6 – Forme basse (scodelle) ad orlo distinto introflesso stretto: A) Bronzo finale: nn. 1-2 da Sorgenti della Nova (CRE-MONESI, 2006; BELARDELLI et ALII, 1999); nn. 3, 6 da Cilea (Sesto Fiorentino, FI); n. 7 da viale XI Agosto (Sesto Fiorentino, FI); nn. 4-5 da Punta degli Stretti (Orbetello, GR); B) Età del Ferro: nn. 8-10 da Madonna del Piano 4c (Sesto Fiorentino, FI).
A
B
NOTE METODOLOGICHE PER LO STUDIO DELLE PRODUZIONI DEL BRONZO FINALE E DEL PRIMO FERRO 91
Fig. 7 – Forme basse (scodelle) ad orlo distinto introflesso ampio: n. 1 da Sorgenti della Nova (CARDOSA-PASSONI, 2003); nn. 2-4 da Punta degli Stretti (Orbetello, GR).
siderazione il criterio tipometrico definibile come ampiezza40, ovvero la distanza che separa il bordo dal punto della parete in cui inizia la modifica.
L’attenzione a questo parametro, applicato alle industrie protostoriche analizzate, ha portato ad introdurre fra le tese, accanto a quelle ampie e strette, il tipo a tesa molto ampia, nel caso in cui la misura dell’orlo sia maggiore a mm 30:– tese strette: ampiezza < 20– tese ampie: 20 ≤ ampiezza ≤ 30– tese molto ampie: ampiezza > 30.
Questo parametro è risultato particolarmente significativo per la classificazione dell’industria vil-lanoviana di Madonna del Piano, in cui ricorrente è il campione delle forme basse (piatti e piattelli) con tesa ampia e molto ampia, spesso decorata, mentre non particolarmente significativa è la presenza delle tese strette, perlopiù frammentarie. Analoga carat-teristica si ritrova in contesti bolognesi coevi della seconda metà di VIII secolo a.C. e continua in età orientalizzante anche in area fiorentina41 (Fig. 3).
Tra gli orli distinti, particolare attenzione merita-no anche gli orli introflessi, che presentano un’ampia varietà tipologica a partire dal Bronzo finale (si tratta
delle cosiddette scodelle ad orlo rientrante). Nei casi analizzati, si è notato che esistono sia vari gradi di discontinuità angolare tra l’orlo e la parete, sia variazioni importanti nello sviluppo dell’ampiezza dell’orlo verso l’interno fino ad arrivare al limite con le forme composte.
Nell’analisi degli orli introflessi distinti è apparso utile, ai fini della definizione crono-culturale delle industrie, definirne l’ampiezza su base tipometrica, al pari di quanto è stato condotto per le tese.
La prima essenziale precisazione è che gli orli introflessi possono essere sia non distinti che distinti: nelle industrie analizzate sono presenti entrambi i tipi, cosicché il metodo di valutazione possa risul-tare chiaro ed efficace. Tuttavia, vista la presenza di forme non intere, se pur ipotizzabili, per maggior attendibilità si è fatto ricorso a forme complete, pertinenti a complessi coevi, con le quali ci siamo poi confrontati, una volta individuati i parametri tipometrici di riferimento.
Gli orli introflessi non distinti si sviluppano in continuità con la parete, senza tuttavia presentare alcuna discontinuità angolare, e possono essere di-stinti da essa solo per un leggero andamento verso l’interno (Fig. 4).
40 Si considerino le annotazioni metodologiche apportate a proposito da N. Volante in VOLANTE, 2003, pp. 378-381.41 POGGESI, 1999; ZANNONI, 2000, pp. 224-226.
STEFANIA POESINI – ALBERTO AGRESTI92
Fig. 8 – Forme basse (scodelle) ad orlo distinto introflesso molto ampio, al limite con le composte: n. 1 da BELARDELLI et ALII, 1999; nn. 2-4 da Sorgenti della Nova (nn. 2-3 da MASSARI, 2003; n. 4 da CARDOSA-PASSONI, 2003); n. 5 da Cilea (Sesto Fiorentino, FI), n. 6 da Punta degli Stretti (Orbetello, GR).
Un altro gruppo presente nelle industrie proto-storiche analizzate è rappresentato dagli orli intro-flessi non distinti con una tendenza alla distinzione della parete, apprezzabile per lo più nel profilo interno (Fig. 5).
Per quanto riguarda gli introflessi distinti, ovvero nel caso in cui l’orlo presenti una netta separazio-ne dalla parete, si propongono dei parametri di riferimento per una loro classificazione, basati sul rapporto tra ampiezza dell’orlo e della parete, così da distinguere gli orli in stretti (Fig. 6), ampi (Fig. 7) e molto ampi (Fig. 8):– introflessi stretti: ampiezza orlo ≤ ¼ della parete– introflessi ampi: > ¼ ampiezza orlo < ⅓ della parete– introflessi molto ampi: > = ⅓ ampiezza orlo < ½ della parete.
Il valore molto ampio si può considerare al limite con la definizione delle classi composte: nel qual caso, appena al di sopra del valore stabilito, non
avremmo più un introflesso ma una forma composta ad orlo non distinto.
L’analisi morfotipometrica condotta sulle indu-strie ceramiche di Sesto Fiorentino si è dimostrata utile per cogliere gli aspetti di evoluzione interna delle forme vascolari permettendo di cogliere ele-menti di continuità e di discontinuità tra periodi cronologici differenti e meglio definire la variabilità interna alle singole produzioni. All’interno delle produzioni di Bronzo finale analizzate, infatti, è stato possibile notare come nelle forme basse il gusto per lo sviluppo delle tese, che compare in ambito medio tirrenico a partire dal Bronzo finale, diviene distintivo nella prima età del Ferro, con un’ampiezza sempre più marcata. Mentre per quanto riguarda lo sviluppo degli orli introflessi distinti delle forme basse (scodelle ad orlo rientrante) è stato possibile apprezzare come questo aspetto, ricorrente nelle produzioni di Bronzo finale, si venga man mano a perdere nella prima età del Ferro, dove è limitato, almeno nell’industria esaminata, ai soli orli stretti.
Fig. 9 – Tavola sinottica della terminologia corrente impiegata per le forme vascolari del BF-I Ferro italiano. Non sono state considerate le forme strettamente regionali, quelle rare e particolari o d’importazione. Nella tipologia SARTI, 2005 il riferimento alle forme semplici o composte è pertinente alla parte contenente del vaso poiché alcuni elementi morfologici come il piede, costituiscono attributo secondario di una forma (segue).
SARTI, 2005PARISE
BADONI, 1980, 2000
PERONI, 1994 CARDARELLI et ALII, 1999
CÀSSOLA et ALII, 1999
BELARDELLI et ALII, 1999
NEGRONI CATACCHIO et ALII, 1999
BENTINI et ALII, 1999
BONGHI JOVINO, 2001
D’AGOSTINO-GASTALDI, 1988; GASTALDI, 1998
forme molto basse
teglia piatto per focacce
teglia teglia teglia
forme basse semplici
e su piede
piattello piatto piattello piatto piatto/ciotola piattello
piattello su piede
coppa-piattello piattello su piede
scodella scodella scodella scodella scodella ciotolaad orlo
rientrante
troncoconica
Scodella a labbro
rientrante
di copertura
a labbro rivolto all’esterno
scodella
ciotola
scodella/scodelline a labbro rientrante
ovoide
SARTI, 2005PARISE
BADONI, 1980, 2000
PERONI, 1994 CARDARELLI et ALII, 1999
CÀSSOLA et ALII, 1999
BELARDELLI et ALII, 1999
NEGRONI CATACCHIO et ALII, 1999
BENTINI et ALII, 1999
BONGHI JOVINO, 2001
D’AGOSTINO-GASTALDI, 1988; GASTALDI, 1998
forme basse semplici
e su piede
scodella scodella/coppa su piede
coppa (su piede) con spalla distinta
carenata
composte su piede
coppa coppa (= kotyle) Coppa
forme medie semplici
composte
ciotola ciotola ciotola ciotola ciotolaa profilo ad S
carenata
scodella a labbro rivolto
all’esterno
coppa/tazza
Tazza tazza bassa tazza tazza tazza ciotola attingitoio
tazza tazza tazza/attingitoio
tazza-attingitoio
Anforetta tazza biansata anforetta tazza biansata anforetta anfora
SARTI, 2005PARISE
BADONI, 1980, 2000
PERONI, 1994 CARDARELLI et ALII, 1999
CÀSSOLA et ALII, 1999
BELARDELLI et ALII, 1999
NEGRONI CATACCHIO et ALII, 1999
BENTINI et ALII, 1999
BONGHI JOVINO, 2001
D’AGOSTINO-GASTALDI, 1988; GASTALDI, 1998
forme medie/profonde semplici
composte
semplici
boccale boccale boccale boccale boccale boccale boccale/orciolo boccale
brocca/brocchetta
brocca brocca brocca brocca brocca/brocchetta
bicchiere/olletta bicchiere bicchiere vaso ad olla globulare
cilindrico
bicchiere olla ovoide/ globulare
bicchiere
olla olla olla olla olla olla/olletta olla ovoide/olla ovoide-
cilindrica/olla ovoide-
globulare/orciolo
olla/olletta monoansata
SARTI, 2005PARISE
BADONI, 1980, 2000
PERONI, 1994 CARDARELLI et ALII, 1999
CÀSSOLA et ALII, 1999
BELARDELLI et ALII, 1999
NEGRONI CATACCHIO et ALII, 1999
BENTINI et ALII, 1999
BONGHI JOVINO, 2001
D’AGOSTINO-GASTALDI, 1988; GASTALDI, 1998
forme profonde composte
urna/vaso a collo
vaso a collo vaso a collo vaso a collo distinto
vaso lenticolare vaso a collo distinto
olla globulare vaso biconico
vaso biconico urna/vaso a collo
troncoconico e corpo biconico
vaso biconico ossuario biconico
vaso biconico vaso biconico biconico olla biconica
urna/vaso biconico
brocca orciolo orciolo orciolo
NOTE METODOLOGICHE PER LO STUDIO DELLE PRODUZIONI DEL BRONZO FINALE E DEL PRIMO FERRO 95
SARTI, 2005PARISE
BADONI, 1980, 2000
PERONI, 1994 CARDARELLI et ALII, 1999
CÀSSOLA et ALII, 1999
BELARDELLI et ALII, 1999
NEGRONI CATACCHIO et ALII, 1999
BENTINI et ALII, 1999
BONGHI JOVINO, 2001
D’AGOSTINO-GASTALDI, 1988; GASTALDI, 1998
forme profonde composte
semplici
anfora anfora anfora vaso ad anfora anfora/anforetta
anfora
dolio dolio dolio dolio dolio dolio olla doliaria dolio/ziro
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
AA.VV. (2007) – Appunti sulla ceramica in archeologia, Firenze.
BIETTI SESTIERI A.M. (1999) – Classificazione, tipologia e terminologia in pratica, in COCCHI GENICK, 1999, vol. I, pp. 21-30.
BIETTI SESTIERI A.M. (2000) – Classificazione e tipologia, in FRANCOVICH, MANACORDA, 2000, pp. 61-65.
BONGHI JOVINO M. (2001) (a cura di) – Tarquinia. Scavi sistematici nell’abitato. Campagne 1982-1988 / I materiali, Roma.
BELARDELLI et ALII (1999) – Il Bronzo finale e la prima età del Ferro nell’Italia centrale, in COCCHI GENICK, 1999, vol. II, pp. 403-428.
BENTINI et ALII (1999) – Il vasellame ceramico dell’età del Ferro in Emilia e in Romagna, in COCCHI GENICK, 1999, vol. II, pp. 335-349.
CARDARELLI A., DAMIANI I., DI GENNARO F., IAIA C., PACCIARELLI M. (1999) – Forme del vasellame ceramico in Italia peninsulare dal Bronzo medio al princi-pio del’età del Ferro: criteri e proposte di nomenclatura, in COCCHI GENICK, 1999, vol. II, pp. 281-307.
CARDOSA M., PASSONI A. (2003) – La capanna del settore Ve, Milano.
CASSOLA GUIDA P. et ALII (1999) – Le età del Bronzo e del Ferro in Italia nordorientale, in COCCHI GENICK, 1999, vol. II, pp. 309-321.
CAZZELLA A. (1999) – Terminologia e tipologia: deno-minare che cosa?, in COCCHI GENICK, 1999, vol. I, pp. 13-20.
CIACCI A. (2007) – Appunti sulla ceramica di età preromana, in AA.VV., 2007, pp. 155-185.
CLARKE D. L. (1998) – Archeologia analitica, Milano.COCCHI GENICK D. (1999) (a cura di) – Criteri di no-
menclatura e di terminologia inerente alla definizione delle forme vascolari del Neolitico/Eneolitico e del Bronzo/Ferro, Atti del congr. Lido di Camaiore, voll. I-II, Firenze.
COCCHI GENICK D. (2006) – Considerazioni sull’iden-tificazione dei modelli nella produzione artigianale, RSP, LVI, pp. 551-594.
CREMONESI C. (2006) – La grotta 7 del settore IV: un luogo di culto nell’abitato, Milano.
CUOZZO M. (2000) – Orizzonti teorici ed interpretativi tra percorsi di matrice francese, archeologia post-processuale e ten-denze italiane: considerazioni e indirizzi di ricerca per lo studio delle necropoli, in TERRENATO, 2000, pp. 323-360.
Fig. 9 (pagina a fronte e sopra) – Tavola sinottica della terminologia corrente impiegata per le forme vascolari del BF-I Ferro italiano. Non sono state considerate le forme strettamente regionali, quelle rare e particolari o d’importazione. Nella tipologia SARTI, 2005 il riferimento alle forme semplici o composte è pertinente alla parte contenente del vaso poiché alcuni elementi morfologici come il piede, costituiscono attributo secondario di una forma.
STEFANIA POESINI – ALBERTO AGRESTI96
D’AGOSTINO B., GASTALDI P. (1988) (a cura di) – Pon-tecagnano. II La necropoli del Picentino .1. Le tombe della Prima Età del Ferro, Napoli.
FRANCOVICH R., MANACORDA D. (2000) (a cura di) – Dizionario di archeologia, Bari.
GASTALDI P. (1998) – Pontecagnano. II.4. La necropoli del Paglierone, Napoli.
GRIFONI CREMONESI R. et ALII (1999) – Facies neoliti-che dell’Italia centrale e del versante adriatico meridionale, in COCCHI GENICK, 1999, vol. I, pp. 63-65.
GUIDI A. (1994) – I metodi della ricerca archeologica, Bari.LAPLACE G. (1966) – Recherches sur l’origine et l’evolution
des complexes leptolitiques, Paris.LAPLACE G. (1968) – Recherche de typologie analitique,
Origini, II, pp. 1-64.LAPLACE G. (1975) – La typologie analytique et structurale:
base rationelle d’étude des industries lithiques et osseues, in Banques de donnés archéologiques, Colloques Nationaux de la Recherce Scientifique, 932 (Marseille, 12-14 juin 1972), pp. 92-143.
MALINA VAŠÍČEK Z. (1997) – Archeologia. Storia, pro-blemi, metodi, Milano.
MARTINI F., SARTI L. (2000) (a cura di) – Insediamenti ed artigianati dell’età del Bronzo in area fiorentina. Le ricerche archeologiche nei cantieri CONSIAG (1982-1992), Firenze.
MASSARI A. (2003) – Le capanne del settore I, Milano.NEGRONI CATACCHIO N., CARDOSA M., DOMA-
NICO L. (1999) – Il Bronzo finale nelle valli del Fiora e dell’Albegna, in COCCHI GENICK, 1999, vol. II, pp. 429-439.
ORTON C., TYERS P., VINCE A. (1993) – Pottery in archaeology, Cambridge.
PALOMBINI A. (2001) – Miti e pregiudizi nell’uso dei sistemi di classificazione in archeologia, Rassegna di Archeologia, 18A, pp. 127-144.
PARISE BADONI F. (1980) (a cura di) – Dizionari termi-nologici. Materiali dell’età del Bronzo finale e della prima età del Ferro, Firenze.
PARISE BADONI F. (2000) (a cura di) – Ceramiche d’im-pasto di età orientalizzante in Italia. Dizionario termino-logico, Roma.
PERONI R. (1967) – Tipologia ed analisi stilistica nei materiali della preistoria: breve messa a punto, DA, 1, 2, pp. 155-158.
PERONI R. (1994) – Introduzione alla protostoria italiana, Bari.
PERONI R. (1998) – Classificazione tipologica, seriazione cronologica, distribuzione geografica, Aquileia Nostra, LXIX, pp. 10-27.
POGGESI G. (1999) (a cura di) – Il guerriero di Prato Rosello, Firenze.
RICE P. M. (1987) – Pottery Analysis. A Sourcebook, Chicago.RANDSBORG K. (2000) – L’archeologia e la realtà materiale
creata dall’uomo, in TERRENATO, 1999, pp. 171-188.SARTI L. (1989) – Per una tipologia della ceramica preistorica:
appunti sullo studio morfologico dei manufatti, Rassegna di Archeologia, 8, pp. 129-145.
SARTI L. (1993) – Per una tipologia della ceramica prei-storica: considerazioni sulla struttura morfologica e sulla nomenclatura delle anse, Rassegna di Archeologia, 11, pp. 143-148.
SARTI L. (1997) (a cura di) – Querciola. Insediamento cam-paniforme a Sesto Fiorentino, Firenze.
SARTI L. (2005) – Per una tipologia della ceramica preisto-rica: aggiornamenti e considerazioni su una metodologia analitica, in Askategi. Miscellanea in memoria di George Laplace, RSP, Supplemento 1, pp. 567-576.
TERRENATO N. (2000) (a cura di) – Archeologia teorica. X Ciclo di Lezioni sulla ricerca applicata in Archeologia (Certosa di Pontignano 1999), Firenze.
TOVOLI S. (1989) – Il sepolcreto villanoviano Benacci Caprara, Bologna.
VIDALE M. (2007) – Ceramica e archeologia, Roma.VIGLIARDI A. (1999) – L’Eneolitico nell’Italia centrale
tirrenica, in COCCHI GENICK, 1999, vol. I, pp. 179-187.
VOLANTE N. (2001) – Per una tipologia della ceramica preistorica: gli elementi di presa, Rassegna di Archeologia, 18A, pp. 77-90.
VOLANTE N. (2003) – Neto-Via Verga (Sesto Fiorentino): la produzione vascolare dell’area 1, RSP, LIII, pp. 375-504.
ZANNONI M. (2000) – Madonna del Piano 2, in MAR-TINI-SARTI, 2000, pp. 218-231.
RIASSUNTO
L’analisi con il metodo gerarchico laplaciano delle industrie ceramiche provenienti da alcuni complessi toscani del Bronzo finale e della prima età del Ferro – Sesto Fiorentino (FI) e Punta degli Stretti (GR) – ha portato a confrontarsi con la terminologia corrente, ormai codificata dall’uso, della quale si riporta una sintesi aggiornata agli studi più recenti, rapportandola con la tipologia Sarti. Inoltre lo studio di queste industrie ha portato a sviluppare alcuni parametri morfotipometrici specifici per i complessi protostorici. Si propongono in questa sede alcune annotazioni morfotipometriche per l’analisi degli orli a tesa e rientranti distinti, pertinenti a forme basse (piatti, piattelli e scodelle ad orlo rientrante della tipologia tradizionale).
SUMMARY
The analisy of some pottery industries of Final Bronze age and First Iron Age in Tuscany area – Sesto Fiorentino (FI) e Punta degli Stretti (GR) – have been made with Laplace’s method compared with recent studies; we propose a summary of terminologies applicated at the study of pottery analysis com-pared with Sarti’s tipology. We propose additional elements in morphotipometric study of pottery-rims.