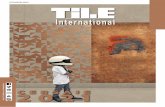Longhi, in Pasolini a casa Testori
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Longhi, in Pasolini a casa Testori
Ritrarre Roberto Longhi “Si capisce solo dopo chi è stato il vero ma-estro: quindi il senso di questa parola ha la sua sede nella memoria come ricostruzione intellettuale anche se non sempre razionale di una realtà comunque vissuta” (Pasolini 1970, p. 2593).E ad accendere le intermittenze, del cuore e della memoria, non deve aver contato meno il fatto che a curare l’antologia di Longhi fosse stato un altro dei pochi punti fermi dell’intero percorso pasoliniano: “Gianfran-co Contini – devo dire che è attraverso di lui che Longhi mi si è rivelato il mio vero mae-stro?” (Pasolini 1974b, p. 1978).La scelta di rovesciare la fotografia per otte-nere l’immagine da cui avviare la serie deve forse essere interpretata come una scelta pu-ramente espressiva; eppure vale la pena di rievocare, come è stato fatto (camPus 2010), lo scritto dedicato proprio nel 1974 al Ca-ravaggio, dove Pasolini ricorda che, secon-do l’insegnamento di Roberto Longhi, una delle grandi invenzioni del pittore è quel “diaframma (anch’esso luminoso, ma di una luminosità artificiale [...]) che traspone le cose dipinte dal Caravaggio in un universo separato, in un certo senso morto, almeno rispetto alla vita e al realismo con cui quelle cose erano state percepite e dipinte”. Dia-framma che “è stato stupendamente spiega-to da Roberto Longhi con la supposizione che il Caravaggio dipingesse guardando le sue figure riflesse in uno specchio. Tali figure erano perciò quelle che il Caravaggio aveva realisticamente scelto [...]: eppure... eppure dentro lo specchio tutto pare come sospeso come a un eccesso di verità, a un eccesso di evidenza, che lo fa sembrare morto” (Paso-lini 1974a, pp. 2672-2673).I ritratti di Longhi del 1974 sono realizzati in novembre a Chia, nella torre medievale scoperta da Pasolini durante le riprese del Vangelo e acquistata nel 1970, un luogo “nel paesaggio più bello del mondo, dove l’Ario-sto / sarebbe impazzito di gioia nel vedersi ricreato con tanta / innocenza di querce, colli, acque e botri”, sognato più volte come
“In una nazione civile questo dovrebbe es-sere l’avvenimento culturale dell’anno.” Così Pasolini accoglie nel gennaio 1974, con sin-cero entusiasmo, l’uscita, nell’ottobre 1973, dell’antologia di scritti di Roberto Longhi (Da Cimabue a Morandi) curata da Gian-franco Contini per “i Meridiani” Mondadori (Pasolini 1974b, p. 1978). Pochi mesi dopo Pasolini, che dal 1971 al 1973 sembra non aver dipinto o disegnato alcunché, torna alla sua antica passione. Nel citato articolo del dicembre 1974 (cfr. qui a p. 78) dichiarerà di aver “ricominciato” a di-pingere il 19 marzo 1974, descrivendo una tecnica (“ho preso un barattolo di colla, ho disegnato e dipinto, insieme, rovesciando direttamente il liquido sul foglio”: listri 1974) che si attaglia alla perfezione ad al-meno tre splendidi profili, siglati appunto 1974, dell’amico poeta Andrea Zanzotto (Pier Paolo Pasolini 1978, n. 156; P. P. Pa-solini 1995, p. 49; Organizzar 2011, p. 69). Entro la fine dell’anno realizza anche i primi ritratti di Roberto Longhi, ripresi proprio dalla fotografia che compare sul cofanet-to dell’antologia continiana; fotografia che Pasolini ha “curiosamente” ribaltato, come sottolinea già lo stesso Contini dando notizia di questa serie “massiccia” di disegni, “non già detratti postumamente dalla memoria, ma dalla bella immagine che avvolge la mia antologia (niente può toccarmi tanto quan-to essere stato strumentalmente coinvolto in questa mediazione) – un’immagine però rovesciata, un’immagine curiosamente allo specchio, quasi assimilata alla direzione ob-bligata dell’ego” (contini 1980, p. 395).Certo l’uscita del “Meridiano” (longhi 1973) offre a Pasolini una nuova occasione per meditare un omaggio al suo unico ma-estro riconosciuto. Un omaggio tardivo, ma chiarito nel suo ritardo dalle stesse parole con cui il poeta riflette sulla figura di Longhi, nell’articolo qui riportato alle pp. 115-116:
Stefano Bruzzese
126
rifugio dove ritirarsi a comporre musica (ne Il poeta delle ceneri), o dipingere (galluzzi 1994, p. 169): il luogo dove scrive Petrolio. Si conoscono cinque fogli datati 1974. I quat-tro qui esposti (figg. 32-35) e un ultimo (fig. XXViii, qui a p. 185), già di Attilio Bertolucci e pubblicato per la prima e unica volta in un articolo su “la Repubblica” nel 1990 (berto-lucci 1990), che dovrebbe essere ancora in pro-prietà degli eredi. Pur in modo di-verso, questi dise-gni mantengono tutti uno stretto rapporto con la foto di partenza, soprattutto l’e-semplare già Ber-tolucci, forse il più ricercato nel tentativo di far aderire le sfuma-ture alle ombre dell’originale. E lo sforzo di ade-guarsi al modello di partenza è ben evidente in un al-tro disegno (fig. 32), il quale da vicino mostra la traccia di diver-si pentimenti nel naso e nella mano. La scelta dei ma-teriali è abbastan-za omogenea: il profilo, a matita o pastello, è evidenziato da una linea ondulata il più possibile continua, delineata a pastello con tracce di acquerellatura.Il secondo nucleo di ritratti, il più consisten-te (ne rimangono almeno nove esposti in mostra, figg. 36-44 e altri tre di ubicazione sconosciuta, figg. XXiX-XXXi), risale all’ot-tobre 1975. Pasolini è ancora nella torre di
Chia e questa volta vuole farsi fotografare da Dino Pedriali. Disegna e dipinge stando in ginocchio. Non ha più con sé la fotografia di Longhi, ma riparte dai ritratti del 1974, disposti a raggera sul pavimento. La scatolet-ta di plastica dove tiene i colori non è molto fornita: matite colorate, pezzetti di carbonci-no, pochi pastelli e boccette di china.
Il profilo di Lon-ghi non è mai né icastico, né iconico: è la sua grande ironia, più volte decan-tata da Pasolini, a emergere. La fisionomia del maestro è resti-tuita ogni volta, nonostante le deformazioni , con viva im-mediatezza da un segno deci-so e armonico: un esercizio di puro istrionismo tecnico in cui a ogni ripresa il modello è bru-ciato da un’esi-genza espressiva che esaurisce il suo significato nell’atto stesso della pittura, nel gesto creativo, che acquista l’a-
spetto di una vera performance, al pari dei ri-tratti della Callas del 1970 (figg. 31, XX-XXVi). Lo confermano le foto di Pedriali, molto co-struite e pensate proprio come testimonian-za e parte integrante dell’opera d’arte. Non a caso lo stesso autore delle foto ricorda che Pasolini, dopo aver finito i ritratti, gli disse che, se voleva, poteva anche prenderseli: or-mai avevano svolto la loro funzione.
127