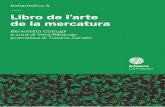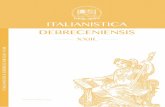I giocatori siciliani 1500 – 1975, Milano, aprile 2011, i libri di Scacchitalia, 500 pp.
Lingua e contesto nella comunicazione mediata dal computer, 21 aprile 2008, Varsavia (Dipartimento...
Transcript of Lingua e contesto nella comunicazione mediata dal computer, 21 aprile 2008, Varsavia (Dipartimento...
1Carla Bazzanella
(Torino, Italia)
Lingua e contesto nellacomunicazione mediata dal computer
Varsavia 23-4-2008
2
1. Lingua in interazione 2. La comunicazione mediata dal
computer (CMC)2.0 definizione e sviluppi2.1 tratti contestuali della CMC2.2 aspetti linguistici della CMC
indiceindice
3
1. Lingua in interazione1. Lingua in interazione“[…] ogni atto linguistico individuale presuppone uno scambio” (Jakobson 1953, ripubblicato in Jakobson 1963/1966, 11) “[…] nel momento in cui la nozione di soggettività è riformulata nei termini di intersoggettività, la lingua, più che un mezzo di azione, è considerata un mezzo di interazione tra gli individui che, in un qualsiasi processo comunicativo, si trovano avviluppati in una rete di influenze vicendevoli: parlare è scambiare, e cambiare scambiando” (Kerbrat-Orecchioni 2001, 2)
4
co-produzioneco-produzione
La conversazione è frutto di una collaborazione, tanto da essere considerata metaforicamente come un tessuto, in cui i contributi di parlante di turno ed interlocutore/i si intrecciano tra di loro, fin quasi a confondersi, e comunque a costituire un unico prodotto..
5
lo sviluppo conversazionalelo sviluppo conversazionale
• sequenzialità
• interattività
• dinamicità
6
sequenzialitàsequenzialità
• La sequenzialità, tipica del parlato a livello strutturale, è stata messa in luce recentemente soprattutto dall’Analisi della Conversazione, che ne ha evidenziato alcune caratteristiche come le sequenze complementari,
• ma era già stata anticipata, in sostanza, dalla Linguistica testuale.
7
interattivitàinterattività
• L’interattività, caratteristica della situazione canonica faccia-a-faccia (cfr. Lyons 1977), è un tratto centrale del dialogo in generale (cfr. Dascal 1985, Bazzanella 2002), in cui può rivestire gradi diversi: la compresenza di parlante ed interlocutore/i nella stessa situazione enunciativa comportano la possibilità di feed-back immediato (anche con interruzioni) e di maggiore coinvolgimento emotivo rispetto ad altre interazioni in assenza di condivisione.
8
dinamicitàdinamicità
• La dinamicità della lingua deve essere considerata– non solo in relazione alla situazione comunicativa, ed al dialogo in generale (cfr. Markovà, Foppa 1990)
– ma anche rispetto alla cosiddetta grammatica emergente, intesa come un processo continuo di strutturazione e di risistematizzazione (cfr. Hopper 1987, Bybee, Hopper 2001).
9
grammatica emergentegrammatica emergente
Emergenza come sviluppo graduale di strutture e procedure cognitive, instabili e stocastiche, che si formano nell’interazione discorsiva, caratterizzata da elementi soggettivi, dalla negoziazione, dalle costrizioni cognitive (come la memoria ed il processo di comprensione in atto), e regolata dall’auto-organizzazione, come nei sistemi complessi in genere (cfr. Bazzanella 2008).
10
2. La CMC2. La CMC 2.0 definizione e sviluppi 2.0 definizione e sviluppi
Insieme di varie forme miste di comunicazione che utilizzano il computer come mezzo di comunicazione e che coinvolgono persone situate in diversi contesti, impegnate in interazioni con varietà di scopi.
11
come nasce la CMC?come nasce la CMC?• Negli anni ‘50 i primi esperimenti di comunicazione tra due elaboratori avvennero tramite normale linea telefonica
• Negli anni ‘60, con il progetto ARPANET, vennero installate le prime reti telematiche per consentire la connessione dei terminali remoti all’elaboratore centrale, così da evitare agli operatori di recarsi presso il centro di calcolo. In quelle fasi la comunicazione era necessariamente sincrona, in quanto metteva in contatto fra loro solo utenti che operavano, nello stesso istante, sul medesimo elaboratore.
12
sviluppi della CMCsviluppi della CMCBen presto si sentì l’esigenza di consentire la comunicazione anche in caso di connessione non contemporanea, iniziando le prime applicazioni di comunicazione asincrona. In tempi recenti la diffusione dei personal computer e l’esponenziale sviluppo della rete Internet hanno trasformato la CMC da fenomeno circoscritto a pochi utenti in un fenomeno di massa che coinvolge un’ampia percentuale della popolazione mondiale.
13
2.1 Tratti contestuali 2.1 Tratti contestuali della CMCdella CMC
2.1.1. setting
2.1.2 interattanti2.1.3 tipo e scopo dell’interazione
15
tempotempo• interazioni (parzialmente) sincrone:
– Internet Relay Chat (IRC)– Computer conferencing (CC)
• interazioni asincrone (o: differite) :– Electronic mail (e-mail)– Mailing list– Newsgroups /Usenet groups– Blogs
16
una nuova temporalitàuna nuova temporalità
• “Teenagers […] have massively appropriated and diffused the distinctive feature of digital revolution in everyday communication: […] a new temporality of writing.” (Caron e Caronia 2007, relativamente agli SMS)
• Writing looses one of its traditionally constitutive features: the temporal gap between the emission and the reception of the message.”(ib.)
17
SMS –SMS –dialogo quasi-sincronodialogo quasi-sincrono (da (da Pistolesi 2004)Pistolesi 2004)
A. Ciao Rinko, sei ancora a passeggio? (21:10)B. no, a casa, ma credi! sto sudando 7 mutandeA. Io sono con il ventilatore a manetta puntato addosso! (21:21)B. Io non ce l’ho! azz ora vado al cine a godermi l’aria condizA. A vedere cosa? (21:27)B. non importa, cmq The gift. Guardi quark speciale stronzi?A. stò facendo zapping (21:32)B. non c’e’ un c. in TV: e’ una congiura. esco xché sto bollendo! almeno la notte dormi?A. No fa troppo caldo, e tu? (21:39)B. Fino alle 3 niente! voleva venire Paolino ma l’ho bloccato fino a giov, arriva il frescoA. Speriamo! qui da domani sera dovrebbe cambiare (21:47)B. si prevedono temporali distruttivi! Mai una cosa norm. esco è tardi! buonanotte:-DA. ciao e buon divertimento (21:52)B. Merci! ci messaggiamo domani: ora hai preso il vizioA. OK ma anche tu non scherzi! (21:57)B. notteA. un bacio (21:58)
18
spaziospazio tratto comune nella CMC: la distanza spaziale tra gli interlocutori, che coinvolge
un uso diverso dei deittici spaziali (es. qui, lì, vicino, lontano) e può portare a fraintendimenti, ad es. nella chat:
“The lack of extra-linguistic and prosodic cues (only partly replaced by transcription conventions, smileys, etc.), together with the rapidity of the ‘scrolling’, sometimes impedes a correct understanding of the pragmatic aspects (illocutionary force, implicatures, indirect speech acts, etc.), and in general of interpretation.” (Bazzanella e Baracco 2003, 128)
19
mezzo di trasmissionemezzo di trasmissione• Il mezzo di trasmissione è la tastiera, ma ciò non vincola le caratteristiche linguistiche, data la presenza di tratti misti e l’intreccio di polarità (v. 2.2.0).
• Per quanto riguarda il codice usato, lingua standard, dialetto ed altre lingue nazionali tendono a mescolarsi (v. 2.2.2).
• Caratteristica centrale della CMC è la multimodalità:
20
multimodalitàmultimodalità• La multimodalità è una caratteristica centrale della CMC, in particolare nelle forme più recenti, che sviluppano e diffondono tecnologie sempre più raffinate, in particolare rispetto all’audio-visivo.
• «Il punto è che a nessuno dei media contemporanei corrisponde una sola forma di comunicazione, ma tutti, vecchi e nuovi, ne permettono una molteplicità, con regole anche molto diverse» (Cosenza 2004, 10).
21
dimensioni testualidimensioni testuali• La varietà delle forme possibili incide anche sulle dimensioni testuali (cfr. Bazzanella i.c.s.a), in particolare su:
•la lunghezza dell’interazione relativamente sia al genere (v. e-maill v. sms), sia all’interazione specifica
•l’ampio uso di brachilogie, in cui rientrano ad es. acrostici (tvtb per ti voglio troppo bene), simboli matematici come 1,x,6, ecc.
22
motivazioni e problemi delle motivazioni e problemi delle brachilogiebrachilogie• L’uso di brachilogie, oltre che dall’economia, è motivato anche da:–sottolineare la ‘segretezza’ della lingua
–mantenere il ritmo interattivo della conversazione orale.
• Le abbreviazioni possono però comportare anche difficoltà di comprensione (cfr. Bazzanella, Damiano 1997, Dascal 1999), come nell’esempio seguente tratto dal corpus di Allora n.p.:
23
un esempio di difficoltà di un esempio di difficoltà di comprensionecomprensione
• <^somma^> ciao!?......ci 6? • <e-mage> sì! Dove, xò?• <^somma^> mo, tu? anni? • <e-mage> cosa vuol dire mo?• <^somma^> modena• <e-mage> ah, ma io pensavo ai chan, dove 6 tu?
• <^somma^> cosa sono i chan? • <^somma^> ei ci 6 ancora?
25
numero degli interattantinumero degli interattanti Il numero degli interattanti può variare da • due (come avviene ad es. in molti scambi di posta elettronica)
• ad un numero molto alto, secondo diverse modalità:• da uno a molti (come in alcuni casi della posta elettronica, ad es. dalla direzione a tutto il personale)
• da molti a molti (come in IRC, e newsgroups),• da molti a uno (caso più raro).
A volte non è calcolabile, ad es. quelli che visitano i blogs senza lasciare commenti (alcuni registrano automaticamente il numero dei visitatori/trici).
26
due aspetti dell’identità due aspetti dell’identità
• la possibilità di identificazione
• la costruzione dell’identità nella CMC
27
possibilità di possibilità di identificazioneidentificazione
– l’identità individuale può o meno essere individuata, a seconda delle differenti forme (ad es. in IRC può essere 'mascherata'), e dei possibili indici visivi (come nelle computer conferencing)
– tratti sociolinguistici generici possono essere inferiti, ad es. sulla base del linguaggio giovanile (cf. Pistolesi 2005), o di usi/inflessioni dialettali.
28
costruzione dell’identità costruzione dell’identità nella CMCnella CMC
– l’identità nella CMC viene spesso costruita e definita localmente nell’uso dei media stessi (come nella chat)
– la frequente possibilità di anonimato nell’interazione rende possibile “giocare con l’identità”, ad es. con nicknames.
29
common groundcommon ground degli degli interattantiinterattantiSi parla di common ground (cfr. Clark 1996, Fetzer 2004), o di conoscenze/credenze condivise, quando determinate conoscenze/ credenze vengono date per scontate nel corso di una interazione (ad es. la città cui ci si riferisce con «la capitale della Polonia»), in quanto conosciute sia dal parlante che dagli interlocutori.
30
common groundcommon ground condiviso o no? condiviso o no? <GIO1> wolfo di dove sei??<wolfo> to<GIO1> lavori a to??<wolfo> si<GIO1> ok<wolfo> sono vicino alle gru<spoky99> ?<spoky99> !<GIO1> ho capito..<spoky99> miiiii ma e' pericoloso!! metti che ti cada un tubo in testa!!
<wolfo> spoky99 ??????????????????????<spoky99> ste gru alzeranno pure qualcosa?? (da Allora, n.p.)
31
2.1.3 tipo e scopo 2.1.3 tipo e scopo dell’interazionedell’interazione
scopi generali nella CMCscopi generali nella CMCSi passa dai protocolli di trasferimento di informazioni alla interazione sociale persona-persona:– lo scopo ’fàtico' (l’essere connessi) sembra prevalere sullo scopo 'proposizionale’ (scambiare informazioni) in alcune forme di CMC (es. IRC).
– il tratto 'ludico' sembra giocare un ruolo cruciale nell’uso della comunicazione on-line.
32
scopi specifici scopi specifici dell’interazionedell’interazioneSi devono considerare sia il genere di CMC che si sta analizzando (ad es. e-mail vs. IRC) che l’interazione specifica in esame, in quanto possono variare in modo significativo. In altre parole, interazioni differenti all’interno dello stesso genere di CMC non condividono necessariamente un unico scopo interattivo.
33
tipo di interazione tipo di interazione – formato conversazionale di – formato conversazionale di produzioneproduzioneSistema a triplette negli sms:
A. SE VUOI ANDIAMO AL BESTIAL A PRANZO. FAMMI SAPERE. J.
B. Non pranzo da mesi, ormai: grazie ugualmente. Ci vediamo
A. OKAPPA(tratto da Cosenza 2002, 198-199)
34
scopo dell’interazione - es. scopo dell’interazione - es. SMSSMS Un SMS può rispondere, ad es., ad una funzione di informazione, talvolta caratterizzata dall’urgenza:
• “arrivo tra 2 min”ma anche esprimere semplicemente il desiderio di contatto:
• “un bacio”, “buona notte”, “ti penso”.
35
2.2 Aspetti linguistici della 2.2 Aspetti linguistici della CMCCMC2.2.0 tratti misti2.2.0 tratti mistiLa CMC è stata definita
written speech da Carlini 1999, écriturorale da Caron, Caronia 2005, in quanto caratterizzata da tratti prototipici sia del parlato che dello scritto, in modo misto, favorito anche dalle nuove tecnologie audiovisive.
36
2.2.1 intrecci di polarità2.2.1 intrecci di polarità• Ciò che colpisce particolarmente in questa nuova forma di comunicazione (a parte la diffusione) è l’intreccio multiplo di polarità, il ritrovare cioè nello stesso mezzo tratti contrapposti normalmente distinti:
• parlato e scritto• sintesi e ridondanza• creatività e stereotipia• semplificazione e ricercatezza
37
parlato e scrittoparlato e scritto• In generale, «[...] le differenze tra l’italiano scritto e l’italiano parlato concernono la maggiore o minore frequenza di certi tratti piuttosto che l’esistenza di ‘regole’ davvero diverse» (D’Achille 2003, 166).
• Nella CMC molte caratteristiche linguistiche riflettono quelle del parlato:– l’immediatezza, – la scarsa pianificazione, – l’uso limitato della cancellazione (anche se i mezzi tecnici consentono correzioni, la rapidità di esecuzione limita di fatto la possibilità).
38
stile colloquiale, ironia e stile colloquiale, ironia e giocogioco• Caratteristica comune nella CNC è lo stile colloquiale, correlabile anche all’utenza giovanile, e riscontrabile nel ricorso frequente all’ironia ed al gioco:
Che fai Miky (Mouse)? ... mi tieni il muso? (tratto da Baracco 2002)
• grazie anche all’utilizzo di particolari segni grafici (cfr. Schulze 1999):
:-| o---- (la cravatta è d'obbligo). (ib.)
39
sintesi e ridondanzasintesi e ridondanza
Quella che appare la ‘stranezza’ della ridondanza, date le particolari restrizioni contestuali (v. ad es. lo spazio negli SMS) è motivata da altre funzioni che non la semplice informatività e l’esigenza di economicità; in particolare sembra incidere la polifunzionalità ed in particolare lo scopo ludico (cfr. Pistolesi 2004 e i.c.s., Bazzanella i.c.s. a).
40
creatività e spontaneitàcreatività e spontaneità
• Ad una diffusa stereotipia (pensiamo alle abbreviazioni, sia negli SMS che nelle chat, ed allo stesso uso degli smileys) corrisponde una frequente, inattesa, creatività.
• Caron, Caronia (2007,190) parlano di “lavoro metalinguistico” che in particolare i giovani, grandi fruitori dei nuovi mezzi di comunicazione, producono nell’uso degli SMS.
41
semplificazione e semplificazione e ricercatezzaricercatezzaUn’altra alternanza frequente è quella tra semplificazione (spesso dettata dall’esigenza di rapidità e di spazio) e ricercatezza (per cui ritroviamo ad esempio messaggi in rima, che richiedono necessariamente tempo e concentrazione, cfr. Cosenza 2002, 144). In altre parole si mescolano economia e sovrabbondanza, in un intreccio di funzioni diverse, tra pura informazione e puro divertimento (inteso sia come gioco che come modo per passare il tempo).
42 2.2.3 uso di codici linguistici
diversi• Anche la lingua usata si mescola e varia tra lingua standard, dialetto e altre lingue nazionali, presentando commutazioni di codice molto più frequenti che nel parlato quotidiano:
• per quanto riguarda la lingua standard, in genere prevale “[…] la tendenza al registro unico, modellato sul parlato informale, che viene applicato ad ogni tipo di testo, con un sensibile appiattimento delle scelte lessicali e sintattiche.” (Pistolesi 2004, 250).
43
uso del dialetto proprio o uso del dialetto proprio o altruialtrui • Per quanto riguarda il dialetto, può essere usato il proprio:
Ciò stèa, vignerissito a çena co mi, stassèra? (es. veneto, tratto da Ursini 2004, 332)
• ma anche un dialetto o un italiano regionale altrui, utilizzando espressioni isolate:
Famme sapè! (es. romano; ib.)con frequenti commutazioni di codice.
44
2.2.3 uso di altre lingue nazionali• Possono intrecciarsi nell’uso anche diverse lingue nazionali: tipicamente l’inglese, ma anche spagnolo, francese, tedesco, spesso in un’ironica “affabulazione”:
“[…] Always two there are: a master and an apprentice. No so ben come che se scrive, ma xe cusì […]. Fame savuar; Ich bin bunn bang from zu art ort urt urt uqtt! Gutarbaiten!; I have interest for una solla (très chère une, la ùnica querida).” Ursini (2004, 333).
• Per la compresenza inglese/polacco, cfr. Jamrozik i.c.s.
45
2.2.3 multimodalità e 2.2.3 multimodalità e situazione ‘emergente’situazione ‘emergente’La multimodalità comporta anche una contaminazione di generi ed un nuovo panorama generale dei vari mezzi di comunicazione. La continua espansione e diversificazione dei mezzi tecnologici permette forme, come i weblogs, caratterizzate da: – inedita unione di parole e immagini – forme particolari di interattività (v. commenti)
– sfruttamenti non solo pubblicitari, ma anche politici (v. blog di Beppe Grillo).
47
In conclusione,In conclusione,
Tantissime variabili entrano in gioco Tantissime variabili entrano in gioco in uno sviluppo conversazionale in uno sviluppo conversazionale specifico: dall’intreccio specifico: dall’intreccio ‘attualizzato’ di tutti i tratti, dai ‘attualizzato’ di tutti i tratti, dai vincoli sociali e fisici della vincoli sociali e fisici della situazione comunicativa, dalla situazione comunicativa, dalla configurazione complessivaconfigurazione complessiva si costruisce si costruisce ogni interazione specifica, in un ogni interazione specifica, in un equilibrio di variazioni e di costanti equilibrio di variazioni e di costanti che fanno di ogni scambio verbale che fanno di ogni scambio verbale un’occasione unica, ma simile ad un’occasione unica, ma simile ad altre.altre.