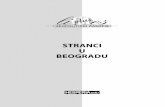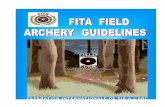Limes - Crimea. Europa contro Russia. La prima volta
-
Upload
unitelmasapienza -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Limes - Crimea. Europa contro Russia. La prima volta
0
210
26
4
0
Limes al Festival del Giornalismo
Quasi tutti vogliono l’Aiib Italia-Mediterraneo Siria etno-religiosa
Europa contro Russiain Crimea, la primavolta
13/04/2015
Un secolo e mezzo fa si combattevano per la prima
volta dopo Napoleone (e per l’ultima prima della
Grande Guerra) le principali potenze europee e
l’impero zarista.di Antonello Battaglia
ITALIA, RUSSIA, RUSSIA E CSI
La Crisi d’Oriente del 1853-1856 fu il primo conflittocontinentale successivo alle guerre napoleoniche e –eccettuando la Seconda Guerra d’Indipendenza (1859), la
Cerca...
AfricaAmerica LatinaAsia-PacificoEuropaItaliaMedio OrienteRussia e CsiUsa e Canada
Comegoverna loStatoIslamicoI traffici tra ijihadisti e noiCosa (non)fare in Libia
In edicola, libreria, ebook,iPad
Accedi
Accedi
OGGI SU LIMES
[Carta di Laura Canali]
AREEGEOPOLITICHE
CHI HA PAURADEL CALIFFO
HOME CHI SIAMO
NUMERO DEL MESE ARGOMENTI
RUBRICHE CARTE VIDEO EVENTI
ABBONAMENTI ARRETRATI EBOOK
IPAD
guerra austro-prussiana (1866) e quella franco-prussiana(1870), tutte circoscritte – fu l’ultimo scontro generalizzatoprima della Grande Guerra. Tutti gli Stati europei, direttamenteo indirettamente, vi furono implicati a titolo diverso. Fu un momento storico di grande importanza perl’Europa, destinato a mutare definitivamente gli equilibricontinentali sancendo una cesura tra “l’Occidente” e la Russiache a seguito della sconfitta militare si sarebbe isolata in unraccoglimento ventennale. A partire da Pietro il Grande, l’obiettivo della politicainternazionale russa era assicurarsi il controllo del MarBaltico per accedere all’Atlantico e soprattutto entrare nelMediterraneo. L’Impero di fatto era privo di uno sbocco suimari caldi; gli unici porti a disposizione erano Arcangelo,Odessa e San Pietroburgo ghiacciati per buona partedell’anno, praticamente inservibili e strategicamente irrilevanti.Allora come adesso, il porto di maggior importanza per la flottarussa si trovava in Crimea, a Sebastopoli. La potenzialefunzione strategica era tuttavia vanificata dagli Stretti delBosforo e dei Dardanelli – dominio ottomano – chesorvegliavano e gestivano il passaggio tra Mar Nero eMediterraneo orientale. Il controllo turco di quell’area non consentiva alla Russiadi inserirsi nei traffici commerciali più importanti dell’epoca esoprattutto ne neutralizzava la flotta, confinandola al Mar Nerosettentrionale. Le manovre zariste miravano dunque aindebolire il già “grande malato d’Europa”, inserire SanPietroburgo nelle dinamiche mediterranee ed espanderel’influenza in area balcanica in linea con i principi slavofili epanslavisti. Nel 1832 l’esercito ottomano fu duramente messo allaprova dalla rivolta del khedivè Mehmet Ali che minacciava lasecessione egiziana, dilagava in Siria e invadeva i territorianatolici. Il sultano Mahmud II chiese l’aiuto delle potenzestraniere e lo zar colse immediatamente l’appello inviando uncontingente che si rivelò provvidenziale. Nicola I desideravadare man forte con l’idea di farsi pagare a caro prezzo l’aiutoofferto. Il 20 febbraio 1833 una squadra navale giunse aCostantinopoli e alcune settimane dopo diecimila soldati russisbarcarono sulla riva asiatica del Bosforo. Era la prima voltache lo zar giungeva al cuore della Porta. Nicola si intromettevanella politica interna ottomana e imponeva come contropartitaper l’appoggio militare l’apertura esclusiva degli stretti alle navida guerra russe (Trattato di Hünkâr İskelesi, 1833). Lestrategia diplomatica zarista preoccupava Francia e Inghilterra.La monarchia orleanista voleva riabilitare l’immagine francesedopo la débâcle napoleonica e mirava al controllo del
Trovaci su Facebook
Limes, rivistaitaliana digeopolitica
Limes, rivista italiana digeopolitica piace a 130.278persone.
Mi piace
Chi ha paura del califfoCome governa lo Stato IslamicoI traffici tra i jihadisti e noiCosa (non) fare in LibiaIn edicola, libreria, ebook, iPad
Numero del mese
Mediterraneo. La possibilità che le navi da guerra russe potesseropassare indisturbate gli Stretti era inquietante. Discorsosimile per la Gran Bretagna, la cui leadership economico-commerciale si basava sull’antica e redditizia via delle Indieche aveva proprio nel Mediterraneo orientale e in Egitto unosnodo di fondamentale importanza. L’inserimento russo inquesta rotta, parallelamente all’estensione in Persia, avrebbecompromesso il primato di Londra, permettendo l’ascesadell’Impero zarista. Stante la grave minaccia, Francia eInghilterra spinsero il sultano Abdul Mejid, successore diMahmud II, a ridefinire gli accordi sugli Stretti. Il 13 luglio 1841fu siglata la Convenzione di Londra che impediva in caso diconflitto il passaggio di navi da guerra attraverso Bosforo eDardanelli. Il provvedimento danneggiava volutamente laRussia, la cui flotta tornava a essere isolata nel defilato MarNero. La condotta altalenante del sultano infastidì Nicola I, cheiniziò a prendere in considerazione l’ipotesi di una guerra cheavrebbe permesso al suo impero di estendersi fino aCostantinopoli. Lo zar doveva trovare soltanto il pretesto perdichiararla. In questo contesto maturò la crisi dei luoghi santi che,seppur lontana nel tempo e nello spazio, costituì il casus bellidel conflitto di Crimea. Venne alla ribalta la questione dellagestione dei più importanti siti di culto: secondo gli antichiprivilegi confermati alla fine del XV secolo a Francesco I diValois, era la Francia ad avere il diritto di protezione di luoghi efedeli cristiani. Le capitolazioni erano state rinnovate nel 1740e ulteriormente confermate nel trattato di Küçük Kaynarca del1774. Alla fine del XVIII secolo la Rivoluzione Francese avevatravolto la monarchia borbonica e la Francia, de facto, nonaveva più esercitato le sue prerogative sui luoghi santi.Contestualmente era aumentata l’influenza ortodossa e conessa quella dell’Impero russo. Stante l’incremento del flusso dipellegrini di fede greca, lo zar aveva rivendicato per sé iprivilegi soprattutto alla luce dell’escalation di risse tra monacicattolici e ortodossi per l’amministrazione dei luoghi di culto. All’inizio degli anni ‘50 dell’Ottocento, la politica esterafrancese divenne più aggressiva. Il presidente dellaRepubblica Carlo Luigi Napoleone Bonaparte (il nipote diNapoleone) voleva fare dell’Hexagone una grande potenzamondiale e sul solco di questo nuovo corso di grandeurdenunciò la violazione dei privilegi da parte russa. Acomplicare ulteriormente la situazione, l’incerta politica delsultano che alternativamente rassicurava sia i diplomaticifrancesi sia quelli russi. Il negoziatore transalpino La Vallettefu ricevuto da Abdul Mejid l’8 febbraio 1852 e ottenne le chiavidella Chiesa di Betlemme e il diritto di officiare nella tomba
della Vergine. Al ritorno a Parigi la missione fu accolta datripudio, mentre il legato dello zar, Titov, otteneva dal sultanola revoca di quanto appena concesso ai francesi. Nella Ville Lumière l’indignazione fu grande. «Chi vuolservire due padroni raramente evita noie e accuse daambedue» commentava arguta «La Civiltà Cattolica». Allanota ufficiale di protesta, il sultano rispose scusandosi eriaccordando i privilegi. Era questo il pretesto di cui avevabisogno lo zar, un’impasse internazionale che incrinasse irapporti con la Sublime Porta giustificando un’eventualeguerra. Nicola inviò il generale Alexander SergeyevichMenshikov a Costantinopoli. Il 29 febbraio 1853 l’ufficialegiunse nella capitale ottomana saltando di proposito la visita diprotocollo al ministro degli Esteri turco Fuad Effendi,notoriamente anti-russo. Il generale si presentò al cospetto delsultano in semplici abiti borghesi boicottando il cerimonialedella diplomazia internazionale. La visita della delegazionerussa era volutamente provocatoria. Menshikov presentò alsultano le richieste dello zar: esclusività dei privilegi sui luoghisanti; sovranità su tutti i sudditi ottomani di fede ortodossa;placet sull’elezione del patriarca di Costantinopoli. Si trattavadi condizioni volutamente inaccettabili. Se il sultano avesseaderito completamente alle richieste russe, avrebbe ceduto ipropri diritti sovrani sui tre quarti della Turchia europeacompromettendo l’esistenza stessa dell’Impero ottomano.Abdul Mejid fu spiazzato dalla risolutezza russa e, coscientedella netta inferiorità militare ottomana, cercò di stemperare latensione sostituendo Fuad Effendi con il filo-russo RifaatPasha. La mossa ebbe l’effetto opposto: palesò i timori ottomaniconfermando il servilismo nei confronti della Russia. Lacondotta era eccessivamente accomodante. Il 5 giugno 1853Nicola I, nella sua spregiudicatezza diplomatica, ordinò aBalabine, primo segretario della legazione russa, diconsegnare l’ultimatum. Se le pretese non fossero stateaccolte, l’esercito avrebbe invaso i principati ottomani diMoldavia e Valacchia. All’arrendevolezza del sultano,consapevole di non poter accettare il diktat russo e allo stessotempo di non riuscire a contrastarlo militarmente, fece dacontraltare l’immediata attività diplomatica di Inghilterra eFrancia. L’Impero ottomano aveva un’importanza strategicafondamentale. Nonostante l’inarrestabile decadenza eratenuto in vita perché copriva un territorio etnicamentevariegato che fungeva da cerniera tra Occidente e Oriente eda baluardo difensivo per l’Europa. Un suo eventuale crolloavrebbe permesso alla Russia di espandersi minacciosamenteverso ovest affermandosi come indiscussa potenza. Per
Londra era indispensabile mantenere lo status quo e difendereCostantinopoli; per Parigi era l’occasione di cimentarsi in unconflitto e rilanciarsi come protagonista dello scacchiereinternazionale. L’eventuale appoggio militare anglo-franceserassicurò Abdul Mejid rinvigorendo i toni della diplomaziaottomana. Dalla condotta arrendevole si passò al netto rifiutodell’ultimatum e alla chiamata alle armi per lo Jihad. Adarroventare la situazione, la morte del patriarca diCostantinopoli. Il sinodo bizantino si riunì ed elesse ilsuccessore: il sultano, violando le richieste russe, impose lesue prerogative e riconobbe per primo il nuovo patriarca. Nelleconvulse trattative che precedevano la deflagrazione delconflitto, Nicola I cercò di ovviare all’alleanza tra inglesi,francesi e turchi chiedendo l’appoggio dell’Impero austriaco.Vienna aveva per lo zar un’importanza strategicafondamentale il cui sostegno avrebbe permesso diridimensionare la coalizione filo-turca rilanciando le possibilitàdi vittoria russe. D’altronde l’Impero asburgico era debitore dello zar perchénella stagione rivoluzionaria del 1848-‘49 aveva perso ilcontrollo di Buda e Pest. Nonostante lo sforzo bellico,Francesco Giuseppe non era riuscito ad avere ragione dellaresistenza magiara ed era stato costretto a fare appello allaSanta Alleanza e richiedere l’intervento russo. Nicola I nonaveva esitato a correre in aiuto e, dopo un sanguinosoassedio, aveva riconsegnato le città all’imperatore. Aldivampare della Prima Crisi d’Oriente e alla vigiliadell’imminente guerra, lo zar poteva contare sullariconoscenza asburgica e sulla consolidata alleanza. Laposizione dell’Impero austriaco non era tuttavia semplice:Francesco Giuseppe, pur apprezzando il sacrificio russo, nonaveva gradito il paternalismo di Nicola I e la sua paleseattitudine a considerare Vienna una potenza subordinata. A ciò si aggiungeva la tendenza russa a espandersi versoi Balcani, regione considerata dagli austriaci propria sfera diinfluenza. La paventata caduta ottomana avrebbe senzadubbio favorito la penetrazione zarista in quest’area. I calcoli diNicola I sull’Austria erano dunque errati: Francesco Giuseppenon gli era ostile, ma certamente non sarebbe stato un suoalleato. l’Impero austriaco declinò dunque la proposta russaspiazzando lo sdegnato Nicola. A influenzare la scelta diFrancesco Giuseppe era stata anche la posizione del papa.Pio IX infatti si scagliava contro lo zar per la sua accanitarivalità nei confronti dei cattolici. La questione dei luoghi santiaveva irritato il pontefice che in una eventuale vittoria russavedeva il ridimensionamento dell’occidente, del cattolicesimo eil trionfo della Chiesa ortodossa. «La Civiltà Cattolica» lochiamava “l’autocrate” e Pio IX non nascondeva la suaapprovazione nei confronti di una lega anti-russa in grado di
neutralizzare la minaccia. Guerra a una potenza ortodossa,ma paradossalmente alleanza con una islamica. La fedemaomettana, a detta del papa, non costituiva più una minacciama un’opportunità di alleanza e d’intesa. Pio IX tuttavia, purcaldeggiando la guerra alla Russia, faceva consegnare unanota a Vienna in cui richiedeva che l’Impero austriacorimanesse neutrale. L’Occidente avrebbe marciato ma non gliAsburgo. Questa esortazione era dettata dal timore che uninvio delle truppe viennesi a est avrebbe sguarnito il fronteitaliano permettendo al Regno di Sardegna e ai volontari diintraprendere una nuova campagna militare ai danni delLombardo-Veneto. La Penisola si sarebbe sollevata e con essa lospauracchio repubblicano che nel ‘49 aveva spadroneggiatosull’Urbe. Stante la neutralità austriaca, francesi e inglesiproposero a Vienna di entrare nella coalizione filo-turca. LaHofburg declinò l’invito. Di contro gli anglo-francesi si rivolseroal Regno di Sardegna per un duplice motivo: dare uno schiaffodiplomatico agli austriaci, di cui il Piemonte era nemico, e allostesso tempo dimostrare che la frontiera italiana sarebberimasta inviolata grazie alla partenza del contingente sabaudo.Nell’aprile del 1854 i delegati di Parigi e Londra si recarono aTorino dove furono ben accolti da Cavour. Il primo ministro sabaudo non voleva perdere l’occasionedi uscire dall’isolamento diplomatico e permettere alPiemonte di entrare nell’empireo delle grandi potenzecontinentali. Si disse disposto a intavolare una trattativa eimpegnare l’esercito nella campagna militare. Molti esponentipolitici sabaudi non erano d’accordo con la condottaprecipitosa cavouriana. Le principali critiche riguardavanol’esoso sborso finanziario; l’alleanza del liberale Piemonte conl’autoritario Secondo Impero di Napoleone III; lapartecipazione a una guerra senza tornaconti economici e percause completamente estranee. Nonostante le accaniteresistenze, ma con il tacito accordo del re, Cavour decise diprocedere autonomamente e conchiudere l’accordo dialleanza mettendo il parlamento davanti il fatto compiuto. Ilministro degli Esteri Vittorio Dabormida si dimise perprotestare contro una decisione che riteneva dittatoriale. IlRegno di Sardegna entrava in una guerra piena di incognite,priva di garanzie e soprattutto senza disposizioni precise perl’esercito. Alfonso La Marmora fu nominato comandante incapo e poco prima di imbarcarsi salutò Cavour chiedendoistruzioni. Lo statista sabaudo replicò: «Ingegnati!». Non importavano gli ordini o le battaglie cui prendereparte: per Cavour l’obiettivo era stato già raggiunto e ilPiemonte era entrato nell’alleanza con le blasonate Francia eInghilterra. Nel contempo, il 27 febbraio le potenze occidentali
avevano invitato lo zar ad abbandonare i principatirecentemente occupati. Dinanzi all’ostinatezza di Nicola I cheordinava l’avanzata in Dobrugia, Francia e Inghilterradichiararono guerra. Il teatro del conflitto divenne fin da subito la Crimea. Parigie Londra erano coscienti dell’importanza strategica dellaregione e decisero di giocare d’anticipo bloccando la flottarussa a Sebastopoli. Napoleone III commentava: «Semmaidecideste di prendere la Crimea, sappiate l’originedell’iniziativa non è vostra ma mia che già da tempo horiconosciuto la sua importanza dal punto di vista strategico. Lasua conquista è l’unico mezzo per portare un decisivo colpoalla Russia». Il 22 aprile 1854, cinque fregate inglesi e trefrancesi bombardarono Odessa. L’assedio della piazzaforteconsentiva di neutralizzare le azioni marittime russe relegandol’avanzata zarista alla mera guerra terrestre senza lapossibilità di bloccare gli Stretti o bombardare Costantinopoli. Il17 ottobre 1854 iniziava l’assedio di Sebastopoli. Le forzealleate non riuscirono ad accerchiare la roccaforte e silimitarono ad attaccare da sud respingendo, con grossedifficoltà, le sortite russe. L’8 settembre 1855, 60 mila francesiagli ordini di Mac-Mahon espugnarono la posizione fortificatadi Malakoff infliggendo dure perdite al nemico. I russiabbandonarono le fortificazioni e si ritirarono. Il 9 settembreterminava l’assedio costato 4 mila morti allo zar e 16 mila allacoalizione tra vittime, feriti e prigionieri. In tutta la guerra laRussia patì 102 mila perdite, la coalizione 128.400 circa, tracui 2050 piemontesi. Finiva la logorante Guerra di Crimea. Gerusalemme e i suoi luoghi santi, casus belli, erano statipresto dimenticati e l’astio dell’Europa occidentale neiconfronti del minaccioso espansionismo russo era deflagratoin tutta il suo vigore. Lo status quo era stato salvaguardato econ esso gli interessi di Londra che avrebbe voluto continuarea oltranza il conflitto per annichilire definitivamente il nemico.La via delle Indie era stata preservata e la leadershipbritannica garantita. Anche Parigi poteva dirsi soddisfatta.Napoleone III aveva profuso ingenti risorse e aveva persomolti uomini. Il Secondo Impero era riuscito ad affiancarel’Inghilterra e consacrarsi come arbitro delle controversieinternazionali. Gli Stretti rimanevano ottomani e restavanochiusi alle navi da guerra.Pio IX era appagato: l’ortodossia erastata ridimensionata e “l’autocrate” era stato sconfitto. Lasupremazia spirituale di Roma e il primato del papa erano statimantenuti. Allo stesso tempo non erano scoppiati disordininella Penisola e la minaccia mazziniana era stata esorcizzata. Anche Cavour esprimeva soddisfazione: il Piemonte erauscito dall’isolamento internazionale e si era seduto altavolo delle grandi potenze. Il Congresso di Parigi ospitò
anche la delegazione sabauda e Cavour prese parteall’importante summit perorando la causa piemontese. Primadella chiusura, i diplomatici anglo-francesi gli concessero lapossibilità di presentare l’annosa questione italiana. IlCongresso terminò senza alcuna decisione in merito e Cavourtornò a Torino scoraggiato. Al contrario delle sue impressioni,fu accolto da una folla festante perché per la prima volta lecancellerie europee erano state messe davanti al problemaitaliano e ne avevano preso coscienza. L’Austria era rimastaimpacciata nel suo cul de sac. Non era intervenuta a fiancodello zar decretando la fine della decennale Santa Alleanzama allo stesso tempo, pur appoggiando la causa anglo-francese, aveva evitato di impegnarsi militarmente. Il suoprestigio ne avrebbe risentito negli anni a venire. Sarebbestata sconfitta nella Seconda Guerra d’Indipendenza (1859)dall’asse franco-sabaudo e avrebbe perso l’influenza sullaConfederazione Germanica a seguito della grave sconfittamilitare nella guerra austro-prussiana del ‘66. Estromissionedalla penisola italiana e perdita della preponderanza in areagermanica: i due pilastri del grande impero asburgicosarebbero venuti meno e con essi l’influenza austriaca. Dopo la guerra di Crimea, il nuovo concerto europeo sibasava sull’asse anglo-francese, ma la crescente potenzaprussiana avrebbe sovvertito questo equilibro a partire dallametà degli anni Sessanta. L’Impero ottomano, seppure in crisi,aveva vinto la guerra. Francia e Inghilterra lo avevano protettoper salvaguardare i propri interessi. Non avrebbe risolto i graviproblemi e la sua decadenza si sarebbe protratta fino allaGrande Guerra. La Russia aveva perso il confronto diretto conle potenze europee e l’opportunità di assumere il controllodell’Europa orientale e raggiungere gli agognati Stretti. SanPietroburgo, da protagonista al Congresso di Vienna, si ritrovòostracizzata dal centro nevralgico di potere continentale etagliata fuori dal nuovo concerto europeo. La Crimea, alloracome oggi, aveva un’importanza strategica fondamentaleperché unico porto servibile da impiegare a servizio dellaflotta. L’intento punitivo delle potenze occidentali fu chiaro etrapelò dagli atti della Conferenza di Pace allorché fu impostoil divieto di mantenimento di flotte militari nel Mar Nero. Questadecisione penalizzava più lo zar che il sultano. La fragilità della Russia, prima ancora che militare, eraeconomica e organizzativa. Era il paese più vasto epopoloso del mondo, ma era arretrato in ogni settore.L’economia era esclusivamente agricola, il 90% dellapopolazione era rurale, la produzione era notevole grazie alleestese aree coltivabili ma era relativamente scarsa secomparata allo sfruttamento intensivo del suolo praticato inFrancia, Inghilterra e Paesi Bassi. Tecniche, tecnologie erapporti sociali di tipo feudale erano all’origine della grave crisi,
concretizzatasi nella disfatta militare. Per i detrattori dello zar,il fallimento della difesa di Sebastopoli era stato causatodall’inesistenza di adeguate vie di comunicazione e dallascarsità di linee ferrate. Il carente approvvigionamento diuomini, munizioni e vettovagliamento non aveva consentitoalla roccaforte di resistere all’assedio della coalizione nemica.Il successore di Nicola I fu Alessandro II. Il nuovo zar avviò un’intensa stagione di riforme conl’obiettivo di modernizzare il paese. Nel 1861 firmò lacontroversa legge sull’abolizione della servitù della gleba,riformò l’amministrazione fiscale, l’università, l’esercito,l’amministrazione locale e promulgò la riforma dell’ordinegiudiziario. In politica estera la Russia di fatto uscì dalle dinamicheeuropee per circa un ventennio, spostando il suo baricentroin Asia, in particolare sul Caucaso. Da potenza pulsanteeuropea, l’Impero era adesso “esiliato” a est. Lo spauracchiorusso al momento era stato sconfitto e allontanato dall’Europa. Per approfondire: 2014-1914 l’eredità dei grandi imperi
ITALIA, RUSSIA, RUSSIA E CSI
ARTICOLI CORRELATI
Il MarNeroUnacartastoricatrattada
Dopo Parigi, che guerra fa.
La
lettera di Putinsull’UcrainaIl presidente russo hainviato una missiva al suoomologo Poroshenko. Ilrifiuto di Kiev di accettare lesue richieste lo spinge adalzare la posta nel Sud-estucraino, consapevole che laresa dei conti con gli Usadeve ancora arrivare.L’ultima partita dello zarPutin di Lucio Caracciolo
0 commenti
Login
Scrivi un commento
L A R I V I S T A
Numero del meseArretratiAbbonamentiHeartland (Limes ininglese)
L I M E S
Chi siamoTirocinioCollaboraContatti
L I M E S O N L I N E
I nostri argomentiRubricheCarteVideo
A R E EG E O P O L I T I C H E
AfricaAmerica LatinaAsia-PacificoEuropaItaliaMedio OrienteRussia e CsiUsa e Canada
S O C I A L
FacebookTwitterLinkedinGoogle+RSS
S I T I A M I C I
EconomonitorTv SvizzeraRassegna EstLa guerra dei droniThe Post Internazionale
Copyright © 1999-2015 Elemedia S.p.A.Tutti i diritti riservati
Gruppo Editoriale L’Espresso Spa —P.Iva 05703731009
La
Transnistria, un’escasulla nuova cortina diferroIl confronto tra Russia,Ucraina e Occidentepotrebbe trovare uno deisuoi epicentri lungo il fiumeDnestr.La Russia in guerra, ilnuovo numero di Limes
L’Italia torna nel Cornod’AfricaIl viceministro degli EsteriLapo Pistelli ha visitatoSomalia, Gibuti, Eritrea,Sudan ed Etiopia.L’obiettivo: rafforzare lacooperazione e scrollarsi didosso la retorica delcolonialismo. Bene, purchél’interesse di Roma per laregione non sia episodico.Quando la Libia era Italia