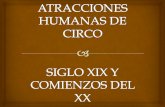Il ruolo politico delle fazioni del Circo a Costantinopoli: Giovanni Antiocheno e la rivolta contro...
Transcript of Il ruolo politico delle fazioni del Circo a Costantinopoli: Giovanni Antiocheno e la rivolta contro...
a cura di GIUSEPPE ZECCHINI
‘Partiti’ e fazioninell’esperienzapolitica romanaST
OR
IA |
RIC
ER
CH
E
PP Zecchini.qxd 26-10-2009 12:49 Pagina 3
www.vitaepensiero.it
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limitidel 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previstodall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico ocommerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essereeffettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso diPorta Romana n. 108, 20122 Milano, e-mail: [email protected] e sito webwww.aidro.org
© 2009 Vita e Pensiero - Largo A. Gemelli, 1 - 20123 MilanoISBN 978-88-343-1840-9
La pubblicazione di questo volume ha ricevuto il contributofinanziario dell’Università Cattolica sulla base di una valutazionedei risultati della ricerca in essa espressa.
PP Zecchini.qxd 26-10-2009 12:49 Pagina 4
INDICE
Introduzione VII
TIM J. CORNELLPolitical conflict in archaic Rome and the republican historians 3
GINO BANDELLIFilippo Càssola e «I gruppi politici romani nel III secolo a.C.» 31
GIOVANNI BRIZZIGli schieramenti politici a Cartagine nell’età delle guerre puniche 49
LUCIO TROIANI‘Partiti’ e religione nel mondo ebraico di epoca greco-romana. Alcune riflessioni 75
MARIA TERESA SCHETTINOI partiti politici nell’età postsillana 87
GIUSEPPE ZECCHINII partiti politici nella crisi della repubblica 105
ALESSANDRO GALIMBERTIFazioni politiche e principesse imperiali (I-II sec. d.C.) 121
WERNER ECKConsules, consules iterum und consules tertium - Prosopographie und Politik 155
MILENA RAIMONDII ‘partiti’ dei Papi nel IV secolo 183
UMBERTO ROBERTOIl ruolo politico delle fazioni del circo a Costantinopoli: Giovanni Antiocheno e la rivolta contro Foca (ottobre 610) 213
01_indice.qxp 26-10-2009 12:50 Pagina V
UMBERTO ROBERTO
Il ruolo politico delle fazioni del circo a Costantinopoli: Giovanni Antiocheno e la rivolta contro Foca (ottobre 610)
1. L’attività delle fazioni del circo, divise nei due gruppi dei Verdie degli Azzurri, caratterizza la vita urbana delle maggiori città del-l’impero romano tra V e VII secolo. Queste associazioni provve-devano all’organizzazione degli spettacoli e dei divertimenti perconto dell’imperatore e delle autorità del governo centrale; allostesso tempo, assunsero un ruolo di grande rilievo, come vocedelle masse popolari (������ nelle città tardoantiche. L’originedelle fazioni è da ricercare nell’unione di diverse associazioni cheanimano la città antica: così, ad es., le organizzazioni dei giovanio i gruppi professionali legati al mondo dello spettacolo; impor-tante appare anche il legame di solidarietà tra fazioni e corpora-zioni professionali. Ma non si deve pensare a compagini chiuse eben definibili: gli studi degli ultimi decenni hanno dimostratoche è impossibile assegnare alle fazioni tardoantiche un’omoge-nea identità sociale, religiosa o culturale. Si tratta al contrario dicomunità aperte, che attraggono esponenti di diverse fasce socia-li, di diversa fede e posizione economica. Il solo criterio necessa-rio è l’appartenenza al corpo civico della città, appunto al �����nel suo significato politico1.
In età imperiale, lo sviluppo delle occasioni ludiche nelle gran-di città dell’impero favorì la crescita delle associazioni circensi.Fin dall’età repubblicana esistevano quattro fazioni: Verdi e
1 Sulla composizione delle fazioni tardoantiche cfr. AL. CAMERON, Circus Factions. Bluesand Greens at Rome and Byzantium, Oxford 1976, pp. 24-44; C.M. ROUECHÉ, Performersand Partisans at Aphrodisias, London 1993, pp. 135-140, con particolare riferimento alrapporto di continuità tra fazioni e altre associazioni di età imperiale; C. ZUCKERMAN,Le cirque, l’argent et le peuple. A propos d’une inscription du bas-empire, REB, 58 (2000), pp.69-96, in part. pp. 93-94 per la solidarietà tra associazioni professionali e fazioni, e piùin generale per il rapporto tra fazioni e �����. Si vd. pure W. LIEBESCHUETZ, TheDecline and Fall of the Roman City, Oxford 2001, pp. 213-218: lo studioso individua nellaxenofobia un carattere condiviso dalle fazioni tardoantiche.
12_Roberto.qxp 26-10-2009 12:58 Pagina 213
Azzurri, Rossi e Bianchi. In età tardoantica, le fazioni presentinelle maggiori città dell’impero sembrano ridursi a due soli grup-pi: gli Azzurri e i Verdi. In realtà, Rossi e Bianchi non scomparve-ro del tutto dall’ambito ludico: l’imperatore Anastasio, ad esem-pio, era un tifoso dei Rossi; ma è un fatto che la loro posizionedivenne fortemente subalterna rispetto ai due gruppi principali.Comunque, uscendo dal contesto occasionale delle competizionisportive, i due gruppi ricordati dalle fonti sono gli Azzurri e iVerdi2. La struttura delle fazioni prevedeva una forma di arruola-mento ufficiale dei membri, registrati in elenchi (cfr. Theophyl.Sym. VIII 7, 10-11), e la presenza di una gerarchia interna concapi riconosciuti anche dalle autorità imperiali. Ma la loro forzaeffettiva superava la consistenza numerica dei membri ufficial-mente arruolati. Infatti, oltre agli iscritti negli elenchi, v’era unvasto numero di individui coinvolti in diverso modo nell’attivitàdelle fazioni3.
L’aspetto più importante della storia delle fazioni in età tar-doantica è il loro ruolo politico. Sulle forme e il significato di taleruolo si è sviluppato nella seconda metà del XX secolo un inten-so dibattito storiografico, propiziato da due monografie di AlanCameron: Porphyrius the Charioteer (1973) e Circus Factions. Bluesand Greens at Rome and Byzantium (1976). Nello stile di Cameron,queste opere presentano ricchezza di dottrina, analisi diretta
UMBERTO ROBERTO214
2 Sulla questione cfr. CAMERON, Circus Factions, pp. 45-73.3 Cfr. in generale ROUECHÉ, Performers and Partisans, pp. 147-156: accanto al demarco,capo della fazione, esiste un gruppo ristretto di ‘dirigenti’ che vengono convocati perprendere decisioni. Cfr., ad es., Teofane p. 289 (citato d’ora in avanti nell’edizione acura di C. de Boor) e Teofilatto Simocatta VIII 9 (sempre nell’edizione de Boor) sullarichiesta di aiuto ai Verdi da parte di Germano, che voleva diventare imperatoreprima dell’entrata in città di Foca nel 602. Germano interpellò il demarco Sergio;questi riunì i dignitari del gruppo, ed insieme diedero risposta negativa. Altrove, lostesso Teofane p. 295 riferisce delle richieste di Germano al demarca dei Verdi nel603. Per avere il loro appoggio Germano si rivelò disposto a versare ai Verdi moltodenaro. Il demarco convocò i dignitari, ma: � � �� ���� ��� ����� �� ����������������� Un ruolo importante di comando nelle fazioni sembrano svolgere, in talunecircostanze, gli aurighi e i campioni del circo: cfr. Giovanni Malala XVI 6 Thurn perl’auriga Porphyrius Calliopas, capo di una rivolta anti-giudaica ad Antiochia nel 507(si vd. al riguardo anche AL. CAMERON, Porphyrius the Charioteer, Oxford 1973); ancheGiovanni di Antiochia, fr. 321 Roberto, ricorda un Calliopas Trimolaimes che guidai Verdi nello scontro contro gli uomini di Foca. Sulla capacità delle fazioni di crearevincoli di solidarietà con larghe parti della popolazione urbana cfr. ROUECHÉ,Performers and Partisans, pp. 151-152.
12_Roberto.qxp 26-10-2009 12:58 Pagina 214
delle fonti, ma pure un taglio drastico nelle conclusioni. An-dando contro la communis opinio – che, a partire dagli studi di G.Manojlovic, non dubitava dell’importanza politica delle fazioni –,Cameron non crede che le fazioni del circo avessero un ruolo aldi fuori dello spazio ludico. Manojlovic considerava Azzurri eVerdi come partiti politici in armi. Secondo Cameron (cheriprende ipotesi già presenti in A. Rambaud nel 1870), in età tar-doantica fu concessa alle fazioni una parte “scenica” nelle ceri-monie imperiali; a partire dal V secolo, le fazioni agiscono purecome claques professionali pagate dallo Stato; ma è da escludere,salvo rarissime e sporadiche eccezioni, che svolgessero una con-creta attività politica nella vita della capitale e delle grandi cittàdell’Oriente romano. L’idea di un potere delle fazioni che puòarrivare ad opporsi a quello imperiale sarebbe un fraintendimen-to dei moderni, causato da una cattiva interpretazione delle fonti.La violenza e le rivolte da loro provocate sarebbero invece da spie-gare non come forme di lotta politica, bensì come manifestazio-ne di teppismo e vandalismo urbano, condotti da bande legate almondo della competizione sportiva e in parte formate da crimi-nali e balordi4.
Molti studi, anche recenti, hanno evidenziato l’eccessiva sem-plificazione del giudizio di Cameron5. Lo studioso dimostra con-vincentemente che le fazioni non sono partiti politici o religiosi.E tuttavia, la completa “depoliticizzazione” del ruolo delle fazioninon spiega le ragioni profonde delle esplosioni di violenza checaratterizzano l’attività di queste associazioni. D’altra parte, la tesidi Cameron appare piuttosto fragile di fronte ad eventi come larivolta Nika del 532, oppure l’azione di Verdi e Azzurri nel perio-
IL RUOLO POLITICO DELLE FAZIONI DEL CIRCO A COSTANTINOPOLI 215
4 Sul ruolo di associazioni sportive vd. già A. RAMBAUD, De Byzantino hippodromo et cir-censibus factionibus, Paris 1870. Per l’analisi delle fazioni come partiti politici cfr. inve-ce G. MANOJLOVIC, Carigradski Narod, «Nastvani Vjesnik», 12 (1904), pp. 1-91, poi tra-dotto in francese da H. GRÉGOIRE, Le peuple de Constantinople, «Byzantion», 11 (1936),pp. 617-716. Insiste pure sulle componenti sociali e religiose delle fazioni lo studio diJ. JARRY, Hérésies et factions dans l’Empire byzantin du IVe au VIIe siècle, Le Caire 1968.5 Per il dibattito sulla tesi Cameron cfr. già J. GASCOU, Les institutions de l’Hippodromeen Égypte byzantine, BIFAO, 76 (1976), pp. 185-212, in part. p. 189; più recentementecfr. W. LIEBESCHUETZ, The Circus Factions, in Convegno per Santo Mazzarino (9-11 maggio1991), Roma 1998, pp. 163-185; M. WHITBY, The Violence of the circus factions, in K.HOPWOOD (ed.), Organised Crime in Antiquity, Swansea 1998, pp. 229-253; G.VESPIGNANI, Il circo di Costantinopoli nuova Roma, Spoleto 2001, pp. 17-34.
12_Roberto.qxp 26-10-2009 12:58 Pagina 215
do tra la caduta di Maurizio, l’ascesa di Foca e la sua fine(602/609-610). Il ruolo politico delle fazioni in questi eventi èindubbio; ed infatti già Cameron li considerava «special cases»rispetto alla sua teoria6.
Il dibattito innescato da Cameron ha avuto il merito di favori-re un diverso metodo di approccio al problema. In primo luogosi è tentato di spiegare le ragioni della violenza. L’attenzione diuna parte degli studiosi si è spostata sul significato sociale dellaviolenza delle fazioni, che è stata ricollegata al problema dellapovertà urbana. Sotto questo aspetto, gli studi di E. Patlageanhanno rappresentato un importante punto di partenza. La stu-diosa ha interpretato l’attività violenta delle fazioni come espres-sione del disagio sociale dei ceti più poveri nelle grandi città del-l’impero. Le forme di protesta poste in atto dalle fazioni sarebbe-ro ricollegabili ad un brigandage urbain ampiamente diffuso nellecittà d’Oriente, tra masse impoverite e senza speranza7.
Ma è la capacità delle fazioni di dare voce alle masse urbaneche spiega la loro importanza nel tessuto urbano dell’Orienteromano. Questo fattore è stato evidenziato dagli studi di C.Roueché8. Da questo punto di vista, le fazioni svolgono un ruolopolitico nella vita delle città tardoantiche, dal momento che “darevoce” significa anche controllare e indirizzare le espressioni diplauso, malcontento e protesta delle masse. Inoltre, questa attivi-tà avviene in contesti, formule e spazi che sono altamente politi-cizzati9. A favorire l’ascesa politica delle fazioni circensi fu la sem-plificazione dei “divertimenti” a partire dal III secolo. Nella mag-
UMBERTO ROBERTO216
6 CAMERON, Circus Factions, pp. 280-281. Per la rivolta Nika cfr. infra n. 15. Per altreoccasioni di rivolta delle fazioni che mostrano spiccato valore politico cfr.LIEBESCHUETZ, The Circus Factions, pp. 180-181.7 Per questa linea interpretativa cfr. E. PATLAGEAN, Pauvreté économique et pauvreté socia-le à Byzance 4e-7e siècles, Paris-La Haye 1977, pp. 203-231, in partic. p. 225; G. DAGRON,Le peuple de Constantinople et la division en Verts et Blues, MEFRM, 108 (1996), pp. 369-372. Per un documento di grande interesse sulle fazioni come espressione del disagiosociale, al di là di ogni appartenenza a partiti politici, culto, ceto sociale, cfr. DoctrinaJacobi nuper baptizati, éd. par V. DÉROCHE - G. DAGRON, T&M, 11 (1991), pp. 17-273; iltesto ricorda l’esperienza di un membro delle fazioni, di religione ebraica, all’iniziodel VII secolo. Si vd. pure VESPIGNANI, Il circo, pp. 34-42.8 C.M. ROUECHÉ, Acclamations in the Later Roman Empire: new evidence from Aphrodisias,JRS, 74 (1984), pp. 181-199; EAD., Performers and Partisans.9 LIEBESCHUETZ, The Circus Factions, pp. 169-172, con l’analisi di Giovanni Malala VII 6Thurn, un passo che fa risalire il ruolo politico delle fazioni alle origini di Roma.
12_Roberto.qxp 26-10-2009 12:58 Pagina 216
gior parte delle città, lo spettacolo nell’ippodromo conquistò unasorta di monopolio sugli eventi ludici che scandivano la vita urba-na. Poiché gli spettacoli erano sponsorizzati dalle autorità, l’ip-podromo si confermò come uno dei luoghi dove si realizzava ilcontatto tra comunità urbana e potere pubblico: l’imperatore aCostantinopoli, i governatori e le élites locali in provincia10. Inquesto contesto, le fazioni assunsero un’importanza enorme apartire dal V secolo: ad esse spettava tanto l’organizzazione deglispettacoli, quanto un ruolo di mediazione tra i ceti medio-bassidelle città e le autorità. In breve tempo, le fazioni vennero perce-pite come voce organizzata e riconosciuta delle esigenze dellemasse urbane11. Il loro compito era guidare l’espressione del con-senso o del risentimento della folla nei confronti delle autorità.Questa attività si realizzava attraverso la gestione delle “acclama-zioni rituali” alla presenza dell’imperatore o del suo rappresen-tante, il governatore. Quando con i loro cori spingevano le masseall’acclamazione, oppure quando protestavano, fomentando larivolta popolare, le fazioni esprimevano sempre un messaggio dinatura politica, che puntava diritto alle autorità. E la protesta – oin alternativa il plauso – era quasi sempre legata al nome di unao più persone: governatori, funzionari, ministri o l’imperatorestesso12.
IL RUOLO POLITICO DELLE FAZIONI DEL CIRCO A COSTANTINOPOLI 217
10 Cfr. al riguardo W. LIEBESCHUETZ, Administration and politics in the cities of the 5th and6th centuries with special reference to the circus factions, in C. LEPELLEY (éd.), La fin de la citéantique et le début de la cité médiévale, Actes du Colloque tenu à l’Université de Paris X-Nanterre, 1-3 avril 1993, Bari 1994, pp. 161-182, in partic. pp. 179-180. Cfr. WHITBY,The Violence, p. 236: l’imperatore dava molta importanza alla voce del popolo, espres-sa nell’ippodromo; in questo luogo, insieme agli spazi delle cerimonie religiose, eglisi mostrava con più frequenza al suo popolo. Sull’ippodromo come spazio politicocfr. pure: C. HEUCKE, Circus und Hippodrom als politischer Raum, Hildesheim 1994, pp.265-310; VESPIGNANI, Il circo, pp. 81-88.11 Si tratta di un valore simbolico da tutti riconosciuto, al punto tale che già Costantinoordinò di registrare le acclamazioni dei provinciali e di inviarle nella capitale perchéfossero esaminate: cfr. CTh I 16, 6 del 331 (= CJ I 40, 3). Vd. pure LIEBESCHUETZ,Administration and politics, p. 180, e il giusto riferimento ad episodi come quello nar-rato da Pietro Patrizio (in Costantino Porfirogenito, De caerimoniis I 93) relativo all’a-scesa al trono di Giustino I; cfr. anche WHITBY, The Violence, pp. 236-237.12 Come nota LIEBESCHUETZ, Administration and politics, p. 181, la rivolta è «the tip ofthe iceberg» dell’attività della fazione, che di solito emerge nella storiografia susci-tando il biasimo da parte degli storici classicheggianti. Sulla tendenza delle fazioni asemplificare i problemi individuando responsabilità o benemerenze di singole per-sonalità cfr. ID., The Decline and Fall, pp. 216-217. V’era una prassi generalmente
12_Roberto.qxp 26-10-2009 12:58 Pagina 217
Dunque, a partire dal V secolo il ruolo delle fazioni oltrepassail momento occasionale dei giochi e si estende ad altre circostan-ze nelle quali l’autorità viene a contatto con la massa dei sudditi13.Tra le ragioni che hanno indotto W. Liebeschuetz a correggere latesi troppo drastica di Al. Cameron, v’è l’importanza del ruolopolitico svolto dalle fazioni di Costantinopoli in occasione dell’e-levazione al trono di un nuovo imperatore. Nel corso del V seco-lo, l’importanza dell’esercito nella scelta degli imperatori dimi-nuisce sensibilmente. Dopo la morte di Aspar (471), senato epopolo di Costantinopoli assumono un rilievo sempre maggiorenella successione imperiale. Azzurri e Verdi non partecipanodirettamente alla scelta dell’Augusto. E tuttavia, secondo il ceri-moniale, questi gruppi acclamano festanti il nuovo Augusto, einducono le masse ad unirsi nell’espressione collettiva del gradi-mento. Senza questa generale acclamazione del �����, guidatadalle fazioni, l’imperatore non appare pienamente legittimato. Sitratta di indicazioni che appaiono confermate dalle fonti di VIsecolo, e che garantiscono alle fazioni un reale potere politico14.D’altra parte, la loro capacità politica si esprime pure nella possi-bilità di minare il consenso di un imperatore o di un suo rappre-sentante. Infatti, questi gruppi, ben organizzati con claques e capi-coro, erano in grado di dominare a piacimento l’opinione e lavoce della folla. Anche gli eventi che portarono alla rivolta Nikanel 532 possono essere spiegati alla luce dei rapporti tra Giusti-
UMBERTO ROBERTO218
rispettata nell’espressione delle acclamazioni popolari: cfr. ROUECHÉ, Acclamations,pp. 189-196. Per la produzione di acclamazioni particolarmente elaborate dal puntodi vista stilistico cfr. P. MAAS, Metrische Akklamationen der Byzantiner, BZ, 21 (1912), pp.28-51.13 Le riunioni nell’ippodromo tendono a sostituire in età tardoantica le assembleepopolari dei secoli passati. Sulla questione: LIEBESCHUETZ, The Decline and Fall, p. 208;WHITBY, The Violence, pp. 236-239, con particolare riferimento ad un passo di Malala(XIV 2 Thurn) sul favore di Teodosio II ai Verdi. Si tratta di un episodio di grandeimportanza che lo studioso data al 439-441, periodo della prefettura di Ciro aCostantinopoli.14 Si veda, ad es., il ruolo delle fazioni nella proclamazione di Giustino I, nel 518:Const. Porph., De caerim., I 93 Reiske. Sulla questione cfr. in particolare LIEBESCHUETZ,The Decline and Fall, pp. 211-213; in precedenza cfr. già Y. JANSSENS, Les Blues et les Vertssous Maurice, Phocas et Héraclius, «Byzantion», 11 (1936), pp. 499-539, in partic. pp.515-516, con riferimento a Teofilatto VIII 10; ROUECHÉ, Performers and Partisans, pp.143 e 155; e WHITBY, The Violence, pp. 236-237. CAMERON, Circus Factions, pp. 261-270,attenua sensibilmente il ruolo delle fazioni in questo contesto.
12_Roberto.qxp 26-10-2009 12:58 Pagina 218
niano e gli Azzurri. Per consolidare la sua posizione di erede diGiustino, Giustiniano aveva bisogno di consenso. A differenza dialtri pretendenti alla successione, come i nipoti di Anastasio,Giustiniano fu costretto a rimediare alla mancanza di sostegnopresso l’aristocrazia cercando il favore degli Azzurri. Ne seguì unperiodo di strapotere degli Azzurri, protetti dall’erede che agivacome loro patrono (almeno dal 521: cfr. Procopio, Anecdota 7).Divenuto imperatore, Giustiniano cercò di ridimensionare l’im-punità concessa alla fazione; ma gli Azzurri non gradirono questasvolta. Quando furono promulgati provvedimenti restrittivi con-tro le due fazioni, queste si unirono concordi nella protesta.Allorché, nel gennaio 532, l’imperatore decise di giustiziare alcu-ni esponenti delle fazioni, scoppiò la rivolta. Azzurri e Verdi pre-sero il controllo della capitale, nominarono nuovo imperatore unnipote di Anastasio e lo rivestirono della porpora nell’Ippo-dromo. Come noto, solo grazie alla lucidità di Teodora, Belisarioe Narsete, Giustiniano riuscì a conservare il trono. MentreNarsete trattava con gli Azzurri per rompere l’intesa, Belisarioentrò nell’Ippodromo massacrando gli insorti delle due parti.L’accordo tra Azzurri e Verdi contro il dispotismo di Giustinianoterminò dunque in una spaventosa carneficina15. Come dimostra-no gli esempi di Giustiniano nel 532, e di Maurizio e Foca nel 602-610, imperatori e uomini di potere in crisi di consenso cercavanospesso il favore di Azzurri e Verdi: l’attività delle fazioni potevaessere decisiva nel determinare il loro destino16.
IL RUOLO POLITICO DELLE FAZIONI DEL CIRCO A COSTANTINOPOLI 219
15 Per la rivolta Nika cfr. recentemente G. GREATREX, The Nika Riot: A Reappraisal, JHS,117 (1997), pp. 60-86; WHITBY, The Violence, pp. 242-243; con un’interpretazionediversa degli eventi, che lega lo scoppio della rivolta agli interessi politici diGiustiniano, cfr. M. MEIER, Die Inszenierung einer Katastrophe: Justinian und der Nika-Aufstand, ZPE, 142 (2003), pp. 273-300.16 Cfr. WHITBY, The Violence, pp. 244-245. Di grande rilievo al riguardo la versione diTheophyl. VIII 4, 9 - 11, 7 sulla caduta di Maurizio; in particolare VIII 7: ricevuta lanotizia della sollevazione dell’esercito nel 602, Maurizio si preoccupa di nasconderegli eventi al popolo della capitale. Organizza dunque dei giochi molto lunghi e ordi-na alle fazioni di trascurare le voci sulla folle ribellione dell’esercito. La loro rispostaè favorevole all’imperatore. In questa circostanza le fazioni operano per nasconderela realtà. Servono da mediatori, ma accettano e propagano la versione dei fatti secon-do la volontà imperiale. L’organizzazione dei giochi serve a Maurizio sia per radu-nare il popolo della città, sia per fornire di donativi e denaro le fazioni, che rispon-dono confermando il loro consenso. Il passo di Teofilatto si integra perfettamentecon quello di Teofane pp. 284-285 de Boor. Questi, infatti, ricorda anche il ruolo dei
12_Roberto.qxp 26-10-2009 12:58 Pagina 219
Merito di W. Liebeschuetz è stato pure di aver inserito il pro-blema del ruolo politico delle fazioni nel più generale contestodella trasformazione della città tardoantica. L’ascesa “politica”delle fazioni è direttamente collegabile alla crisi dei curiales tra IVe V secolo, e alla ridistribuzione dei munera causata dallo sman-tellamento delle funzioni amministrative nelle città. Mentre nellecapitali, da lungo tempo, gli imperatori avevano il monopolio suldivertimento dei cittadini, nelle poleis d’Oriente, ancora nel IVsecolo, questo onere era riservato ai curiali. Tradizionalmente, lasponsorizzazione degli spettacoli era strumento utile alle élitesurbane, e ai loro capi che ricoprivano il ruolo di agonoteti, perconsolidare il consenso delle masse cittadine e per garantire l’or-dine nella polis17. Poi, nel V secolo, il progressivo esaurimentofinanziario delle curie ebbe come effetto immediato che ad assu-mere compiti organizzativi divennero le fazioni dei “tifosi”, attra-verso il diretto sostegno imperiale. Nella generale crisi degli orga-ni di governo delle città, il regolare svolgimento dei giochi dove-va essere preservato e, a partire dall’età di Teodosio II, l’interosistema degli spettacoli venne riorganizzato, prendendo a model-lo quello delle capitali imperiali18. Secondo modalità e tempidiversi, in ogni grande centro dell’impero le fazioni accettaronol’onere di gestire le manifestazioni circensi; il finanziamentodegli spettacoli, e dell’attività delle fazioni, venne per la maggiorparte affidato all’intervento imperiale (attraverso l’opportunadestinazione di risorse fiscali); ma non solo: continuava infatti aresistere l’evergetismo dei notabili locali19. Sfruttando questa
UMBERTO ROBERTO220
Verdi, il partito favorito da Maurizio, e le loro richieste per un nuovo demarco. Cfr.in generale LIEBESCHUETZ, The Decline and Fall, pp. 211-213.17 Cfr. al riguardo: A.H.M. JONES, The Greek cities from Alexander to Justinian, Oxford1940, pp. 227-235.18 Per la centralità dell’età di Teodosio II come periodo di grandi trasformazioni nellastoria delle fazioni cfr. W. LIEBESCHUETZ, Review of A. Cameron, Circus Factions, JRS, 68(1978), pp. 198-199; e WHITBY, The Violence, pp. 237-238. Anche la semplificazione deidivertimenti è stata ricollegata alla necessità di risparmiare denaro, tanto da partedelle curiae, quanto da parte del fisco imperiale: cfr. in generale R. LIM, Consensus andDissensus on Public Spectacles in Early Byzantium, ByzF, 24 (1997), pp. 159-179.19 Cfr. per le numerose fonti relative a questa trasformazione: CAMERON, CircusFactions, pp. 214-229; ROUECHÉ, Performers and Partisans, in partic. pp. 143-156;LIEBESCHUETZ, Administration and politics, pp. 178-182. GASCOU, Les institutions, pp. 192-193, attribuisce la riforma non all’età di Teodosio II, ma a quella di Anastasio. La
12_Roberto.qxp 26-10-2009 12:58 Pagina 220
posizione all’interno della città, le fazioni si inserirono nel vuotodi potere e di rappresentanza creato dalla scomparsa dei curiales.Divennero, secondo le forme che abbiamo visto, mediatori tramasse urbane e autorità, anche dal punto di vista politico. E inquesta veste parteciparono al confronto tra potere imperiale,gruppi di corte ed élites urbane in età tardoantica. Il loro poteredi persuasione era enorme: sia attraverso l’espressione del con-senso, sia attraverso la protesta che poteva sfociare (ma nonnecessariamente) nella rivolta e nella violenza urbana. Attraversocomplesse dinamiche di solidarietà, le fazioni erano infatti ingrado di coinvolgere nelle loro manifestazioni grandi masse citta-dine. Probabilmente, le masse coinvolte non erano pienamenteconsapevoli di questi meccanismi; dal loro punto di vista, le sedi-zioni erano piuttosto occasione per sfogare il disagio sociale edeconomico. Ma nella contrapposizione tra potere centrale ed éli-tes l’appoggio o l’opposizione delle fazioni erano fattori determi-nanti, che venivano conseguentemente sfruttati; soprattutto se siconsidera che loro patroni erano spesso importanti esponentidella aristocrazia; e che lo stesso imperatore era pronto a dichia-rare il suo favore ad uno dei due “colori”20. Così, in molteplicioccasioni, gli imperatori si servirono delle fazioni per combattereed eliminare i loro avversari. E d’altra parte, queste erano spesso
IL RUOLO POLITICO DELLE FAZIONI DEL CIRCO A COSTANTINOPOLI 221
riforma fu graduale e diversificata: ad Antiochia l’organizzazione dei giochi rimasequella tradizionale almeno fino al 465; in Egitto la maggior parte delle menzioni diVerdi e Azzurri risale al VI secolo: cfr. GASCOU, Les institutions, p. 190. Procopio,Anecdota 26, 6 sembra intendere che in alcune città gli spettacoli erano ancora finan-ziati dalle curie all’epoca di Giustiniano. Per notabili che sponsorizzano giochi inprovincia cfr. LIEBESCHUETZ, The Decline and Fall, pp. 206-207. In generale per un’a-nalisi critica delle tesi di Liebeschuetz, cfr. WHITBY, The Violence, p. 233.20 Cfr. al riguardo ROUECHÉ, Performers and Partisans, pp. 150-154; LIEBESCHUETZ, TheCircus Factions, pp. 172-175. Tra i più importanti patroni delle fazioni nella capitale:il potente eunuco Crisafio, ministro di Teodosio II e patrono dei Verdi; il prefetto diCostantinopoli nel 498, Platone; l’illustris Teodosio Zticca. I patroni fornivano assi-stenza materiale alle fazioni, provvedendo a donazioni in denaro, ma anche in beni,come viveri, cavalli, artisti. Isidoro di Pelusio (350-435) considera i giochi dell’ippo-dromo come strumento di controllo della vita cittadina, e del malcontento del popo-lo, da parte degli imperatori, che sponsorizzavano le manifestazioni attraverso lefazioni: cfr. R. LIM, Isidore of Pelusium on Roman Public Spectacles, «Studia Patristica», 29(1997), pp. 66-74; ZUCKERMAN, Le cirque, pp. 87-88, segnala questa interpretazionedello sviluppo dei giochi in un passo di Giovanni Malala (VII 6 Thurn) che descrivela divisione del popolo in fazioni ai tempi di Romolo e Remo. Il passo venne poiripreso da Giovanni di Antiochia, fr. 38 Roberto.
12_Roberto.qxp 26-10-2009 12:58 Pagina 221
“manipolate” da ambiziosi esponenti della nobiltà o del notabila-to locale. Gli esempi da proporre sarebbero numerosi: daCostantinopoli, a Roma, alle città d’Asia Minore, all’Egitto di VIIsecolo. In tutte queste vicende appare costante il rapporto tra vio-lenza urbana e vincoli clientelari, tra reazione violenta al disagiosocio-economico e interessi politici di gruppi di potere in lotta21.
Nel presentare il ruolo politico delle fazioni nelle città tar-doantiche, Liebeschuetz non torna su posizioni giustamente cri-ticate dal Cameron. L’identità politica, culturale, religiosa dellefazioni non è netta, né omogenea nel tempo. Fonti importanticome la Doctrina Jacobi indicano che questa identità va sfumata inbase alle circostanze e alle condizioni di ogni comunità. Comeopportunamente ribadito da Liebeschuetz, il ruolo delle fazioninon è paragonabile a quello dei moderni partiti politici. Alla basedelle loro rivendicazioni non vi erano programmi sociali o strate-gie di riforma di ampio respiro. Piuttosto, secondo lo studioso, ilruolo delle fazioni richiama quello dei moderni media: esprimeree indirizzare proteste o gradimento. In un sistema tardoantico,ormai privo di spazi per il confronto politico, chiunque avesseinteresse a sollevare questioni urgenti davanti alle autorità, pote-va rivolgersi alle fazioni. E queste potenzialità erano perfetta-mente chiare agli imperatori e alle altre autorità tardoantiche22.
UMBERTO ROBERTO222
21 Teodosio II fu favorevole ai Verdi; Marciano agli Azzurri; Zenone ai Verdi; Anastasioai Rossi; Giustiniano agli Azzurri; Maurizio ai Verdi; Foca, dapprima ai Verdi, poi agliAzzurri; Eraclio ai Verdi. Cfr. al riguardo: ROUECHÉ, Performers and Partisans, pp. 143-156; WHITBY, The Violence, pp. 240-244. Di particolare importanza è la testimonianza sulruolo delle fazioni nell’Egitto della prima metà del VII secolo, nella trasformazionedel rapporto tra élites locali e potere centrale. Al riguardo, la cronaca del vescovoGiovanni di Nikiu è fonte di primo piano: cfr. A. CARILE, Giovanni di Nikius cronistabizantino-copto del VII secolo, in Byzance. Hommage à A.N. Stratos, Athènes 1986, pp. 353-398. In generale si vd. pure: E. WIPSZYCKA, Les factions du cirque et les biens ecclésiastiquesdans un papyrus égyptien, «Byzantion», 39 (1969); e per la documentazione papirologi-ca: GASCOU, Les institutions. Sull’esempio di Roma tardoantica cfr. CH. PIETRI, Le sénat,le peuple chrétien et les partis du cirque à Rome sous le pape Symmaque (484-514), MEFRM, 78(1966), pp. 123-139 (poi in ID., “Christiana Respublica”. Éléments d’une enquête sur leChristianisme antique, II, Roma 1997, pp. 771-787); e L. CRACCO RUGGINI, Clientele e vio-lenze urbane a Roma tra IV e VI secolo, in A. SORACI (a cura di), Corruzione, repressione e rivol-ta morale nella tarda Antichità, Catania 1999, pp. 7-52.22 LIEBESCHUETZ, Review of A. Cameron, Circus Factions, p. 199, fa corrispondere lo svi-luppo delle fazioni come strumento di propaganda e celebrazione imperiale al decli-no progressivo del culto imperiale nell’epoca della cristianizzazione. Anche in que-sto caso, il passaggio di competenze si compie, secondo lo studioso, durante il regnodi Teodosio II.
12_Roberto.qxp 26-10-2009 12:58 Pagina 222
Inoltre, le fazioni dello stesso colore erano in contatto tra loro sututto il territorio dell’impero: esse agivano secondo vincoli di soli-darietà, e la sintonia nella manifestazione di protesta o di con-senso – per lo più in posizione di netta contrapposizione tra Verdie Azzurri – è ben testimoniata dalla fonti23.
La capacità di rappresentanza delle fazioni rispetto alla popo-lazione è da collegare ad un altro filone di indagine, ripresorecentemente da C. Zuckerman (2000). Lo studioso ha riporta-to l’attenzione sul significato di ����� nella città tardoantica.����� e ������� indicano sempre il popolo delle città e i citta-dini che ne fanno parte. Coloro che appartengono alla cittadi-nanza, intesa come comunità politicamente riconosciuta dalleautorità, sono identificati attraverso il possesso di diverse prero-gative. A Costantinopoli, più della residenza o della nascita,garantisce l’appartenenza civica il possesso di privilegi sul siste-ma delle annone, e dunque della distribuzione gratuita di vive-ri. Ma uno tra gli elementi che segnano l’appartenenza del������� alla comunità urbana è anche la sua adesione a unadelle fazioni circensi. In questo senso, le fazioni contribuisconoa definire il concetto di ����� tra V e VII secolo; e l’origine stes-sa delle fazioni è da mettere in relazione con le divisioni interneal ����� urbano24.
D’altra parte, limitare il ruolo delle fazioni agli scontri armatie agli episodi di violenza sarebbe una semplificazione. Come èstato opportunamente notato, questa “distorsione” deriva dalfatto che generalmente le fonti si interessano alle fazioni solo
IL RUOLO POLITICO DELLE FAZIONI DEL CIRCO A COSTANTINOPOLI 223
23 LIEBESCHUETZ, Administration and politcs, pp. 179-182; ID., The Circus Factions, pp.163-164 e 170-173: la libertà di parola delle fazioni rispetto alle autorità era parago-nabile a quella dei vescovi e dei monaci; ma, di solito, questi si interessavano a que-stione ecclesiastiche. Cfr. al riguardo WHITBY, The Violence, pp. 238-240. Sulla solida-rietà tra le fazioni nelle diverse città dell’impero cfr. LIEBESCHUETZ, The Decline andFall, pp. 216-217; sulla sintonia tra le fazioni di Costantinopoli e quelle egiziane inoccasione del turbolento regno di Foca cfr., ad es., L. PARETI, Verdi e Azzurri ai tempi diFoca, SIFC, 19 (1910), pp. 305-310 (= ID., Studi minori di storia antica, IV, Roma 1969,pp. 85-94). D’altra parte, l’assimilazione tra le associazioni dello stesso colore nellecittà dell’impero è testimoniata anche attraverso i provvedimenti imperiali. QuandoTeodosio II ordinò ai Verdi di cambiare la loro disposizione nell’ippodromo diCostantinopoli, fece estendere questo provvedimento a tutte le città dell’impero, inmaniera tale che ovunque i Verdi sedessero in posizione privilegiata rispetto alleautorità presenti cfr. Malala XIV 2 Thurn. 24 Cfr. ZUCKERMAN, Le cirque, pp. 81-94.
12_Roberto.qxp 26-10-2009 12:58 Pagina 223
quando sono causa di rivolte urbane25. Esistono molti aspetti del-l’attività di queste associazioni, a Costantinopoli e in provincia,che rimandano ad un ruolo politico-amministrativo, da intenderecome partecipazione alla vita urbana e contributo al funziona-mento delle strutture civiche; e il fenomeno è tanto più significa-tivo, in un’epoca che vede la profonda trasformazione della cittàantica. Azzurri e Verdi partecipano alle cerimonie pubbliche inonore di imperatori o funzionari: le forme della loro partecipa-zione possono anche suscitare tensioni tra i due gruppi26. Ancheper quanto riguarda la conservazione di edifici pubblici delle città(come la cinta muraria), le fazioni svolgono un ruolo attivo.Possediamo, ad esempio, la testimonianza sulla riparazione dellemura di Costantinopoli dopo il catastrofico terromoto del 447;come pure la dedica di un edificio in un’iscrizione di epoca giu-stinianea da Bostra27. Inoltre, all’interno della città le fazioni rap-presentano anche una realtà economica. Essendo incaricati del-l’organizzazione dei giochi, Azzurri e Verdi dispongono senzadubbio di ingenti risorse. Si tratta di ricchezze che provengono inparte da trasferimenti imperiali, devoluti dal fisco; in parte dafonti interne alle stesse fazioni. Il denaro serve per attrarre nuoviaurighi o procurarsi cavalli migliori, come pure per erigeremonumenti in onore dei campioni. Allo stesso tempo, le associa-zioni gestiscono proprietà in città: hanno infatti edifici, magazzi-
UMBERTO ROBERTO224
25 La prima grande rivolta che coinvolse Verdi e Azzurri a Costantinopoli è testimo-niata per il 445: Marcellino Comes, s.a. 445; cfr. WHITBY, The Violence, p. 242: la rivol-ta coincide cronologicamente con la decisione di Teodosio II di dare sostegno uffi-ciale ai Verdi rispetto agli Azzurri.26 Cfr. Theophyl. Sym. VIII 10, 10 per le nozze di Leonzia, figlia di Foca nel 607 aCostantinopoli. In generale, cfr. ROUECHÉ, Performers and Partisans, pp. 144-147. Perle cerimonie di saluto che coinvolgono le fazioni ancora in piena età bizantina cfr.Costantino Porfirogenito, De caer., 500-501 e 506, 5 Reiske.27 Alla costruzione delle mura di Costantinopoli avrebbero partecipato 8000 �������:Patria II 58, T. PREGER, Scriptores Originum Constantinopolitanarum, II, Leipzig 1907, p.182, 10; il carattere generale della fonte farebbe pensare ad una evidente esagera-zione: G. DAGRON, Naissance d’une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451,Paris 1974, pp. 356-357; ID., Constantinople imaginaire. Études sur le recueil des «patria»,Paris 1984, pp. 183-184. Ma la questione è da ricollegare all’effettivo significato deltermine �������. In generale per la ricostruzione delle mura: G. ZECCHINI, Il terremo-to di Costantinopoli del 447 d.C. e la seconda guerra unna, in M. SORDI (a cura di),Fenomeni naturali e avvenimenti nell’antichità, Milano 1989, pp. 250-259. Per l’iscrizioneda Bostra (IGLS XIII 9129) cfr. ZUCKERMAN, Le cirque, pp. 67-73.
12_Roberto.qxp 26-10-2009 12:58 Pagina 224
ni, stalle dove tenere i cavalli. Inoltre, soprattutto nelle province,queste associazioni attirano l’evergetismo dei notabili locali, chericevono in cambio il loro appoggio28. Per il loro ruolo di media-zione tra autorità e popolazione, non sorprende neppure che ilpapiro London III 1028 da Hermopolis alluda alla possibilità chele fazioni avessero competenze a riscuotere alcune tasse tra gliabitanti della città29. Grande importanza ha pure l’impiego mili-tare delle fazioni nella difesa delle città tardoantiche. Un docu-mento della fine del VI secolo, lo Strategikon attribuito all’impera-tore Maurizio, ricorda come la popolazione civile (�����) debbaassistere le guardie nella sorveglianza delle mura di una città asse-diata, anche allo scopo di evitare le sommosse: �� � ����� !"���!� �# ��$��% ���� �&��'���� "���'��� !� ���� ��� ��'(��� ����)��*���� ���� "�����+����� ,�� ��*��� -� ��� ������������"�."�� ��$��/"��% &$$ ��0 ��������� 1�$��2� ��� ��$� ���"��*�"ϑ�� !��ϑ��/"� �� ���'"�� (10, 3)30. Diverse testimo-nianze confermano questa prassi per l’età di Maurizio. AnziTeofane offre un particolare di grande rilievo, in riferimento allevicende che portarono alla caduta di Maurizio nel 602: ��*����3��4� ������� 5 6�"�$�4� ��ϑ��$�"�� ��0 $�-��� 7�'���������."�� "4� ���� ���.�(��� 1�$.����� � ��'(� ��� ��$� ����"������� L’imperatore non sottopone le fazioni ad un coman-do militare specifico; al contrario, investe direttamente i �����)(�� di autorità militare, affidando loro il comando dei civili inarmi31. L’altra fonte sulla vicenda, Teofilatto, riferisce di un’im-
IL RUOLO POLITICO DELLE FAZIONI DEL CIRCO A COSTANTINOPOLI 225
28 Per la documentazione papiracea relativa alle risorse pubbliche e private dellefazioni in Egitto cfr. GASCOU, Les institutions, pp. 194-196. Per l’evergetismo dei nota-bili locali cfr. pure ROUECHÉ, Performers and Partisans, pp. 147-149 con la discussionedi un passo di Teodoro Balsamon (PG 137, 592) al riguardo; cfr. pure LIEBESCHUETZ,The Decline and Fall, p. 207. Sono attestati nelle fonti aurarii che gestiscono il denarodelle fazioni: cfr. ZUCKERMAN, Le cirque, pp. 77-78, che critica l’interpretazione restrit-tiva dell’attività delle fazioni nella ricostruzione di Cameron.29 Cfr. GASCOU, Les institutions, pp. 196-198; LIEBESCHUETZ, The Decline and Fall, p. 215.30 Mauricius, Strategikon, G.T. DENNIS and E. GAMILLSCHEG, Wien 1981: «se la popola-zione civile rimane in città, deve unirsi anch’essa ai soldati distribuiti lungo le mura.In questo modo sarà infatti meno predisposta ad aderire ad eventuali sommosse, masi sentirà responsabilizzata nella difesa della città, e più restia a disobbedire».Sull’impiego delle fazioni del circo nella difesa delle città cfr. già MANOJLOVIC, Le peu-ple, pp. 625-634; JANSSENS, Les Blues et les Verts, pp. 500-501. CAMERON, Circus Factions,pp. 105-125, attenua il ruolo militare delle fazioni.31 Cfr. Theoph. p. 279, 20. Sarebbe di grande interesse conoscere la fonte di Teofane
12_Roberto.qxp 26-10-2009 12:58 Pagina 225
portante riunione a palazzo durante la quale Maurizio convocò idemarchi delle due fazioni e chiese loro di indicare il numero dimembri effettivi. Questi consultarono il registro delle fazioni((.����) e comunicarono i rispettivi contingenti: 1500 i Verdi, 900gli Azzurri. Erano questi gli uomini che Maurizio pensava di impie-gare contro l’attacco di Foca32. L’episodio è emblematico pure peril rapporto che esiste tra l’imperatore e i capi delle fazioni. Tra idemarchi e l’imperatore non vi sono intermediari: vengono diret-tamente convocati a palazzo come rappresentanti della popolazio-ne urbana. Del resto, altre testimonianze indicano che, almeno aCostantinopoli, la scelta dei capi delle fazioni spetta all’imperato-re. Il riconoscimento politico dei demarchi di Costantinopoli deveintendersi come rappresentativo anche dei rapporti con le autori-tà nelle altre città dell’impero33. In conclusione.
1. Il ruolo politico delle fazioni è innegabile; anzi, decisivo inalcune circostanze come la rivolta Nika o l’eliminazione di Foca.In età imperiale, le autorità avevano efficacemente contrastatol’ascesa di associazioni capaci di turbare l’ordine pubblico; in etàtardoantica, le fazioni controllano minacciosamente l’umore
UMBERTO ROBERTO226
per queste vicende. Altre testimonianze sull’uso delle fazioni nella difesa diCostantinopoli: Theoph. p. 254, 7 e Theophyl. I 7 (contro gli Slavi nel 583-584).32 Cfr. Theophyl. VIII 7, 10-11: ���.��� � 8���� ��0 ��*� ���.�(��� 5 ������.� ���"��$�".����� ��9� � 6�"'$���% �:� ��������� �/� ��� � �; ϑ�� �9 �$�ϑ��&����$���% 3<������ � ��*���� =��-��� ��0 >�"�?�� !���ϑ.���� �/� ���������� �!�0 $����� �9� &��ϑ���� 5 �� �@� =��-��� !� (.���A �2� "*������ �/� !��"�/� ���($�.B����� !��(.���� (�+�����% �������"'��� ��9� ���� (�$'��� ��-(.������% 5 �>�"�?� ��4� ��� &���ϑ���� �C��"� � D������.��� !���� "������(��E ��� �*� -�(� �.� � !1�"��� � �/� FG ��' � �������� �� �$�ϑ�� 33 Tra le responsabilità dei demarchi v’è pure l’amministrazione del denaro pubblico(e privato) destinato agli spettacoli. Per una testimonianza relativa a Roma in etàostrogota cfr. Cassiodoro, Variae I 32-33 e R. ROCCA, Cassiodoro e la historia ludorum,«Romano barbarica», 5 (1980), pp. 225-237. Per un’età più tarda, le fonti attestanoanche l’esistenza di una struttura burocratica composta da notarii e cartularii dellefazioni. Nell’età di Foca sono documentati pure -�����"��' al servizio delle fazioni,incaricati di dipingere i ritratti imperiali da salutare nelle cerimonie ufficiali (cfr.Giovanni di Antiochia 319 Roberto; Theoph. p. 294, 11-25); compito di questi per-sonaggi al servizio delle fazioni era anche la conservazione delle acclamazioni ritua-li: cfr. ROUECHÉ, Performers and Partisans, pp. 150-151. Il coinvolgimento di Azzurri eVerdi nella difesa delle città è in continuità con una prassi già diffusa nell’età delprincipato per le associazioni giovanili: ROUECHÉ, Performers and Partisans, p. 152.Anche Giovanni di Nikiu, 108, 3 Charles, ricorda il coinvolgimento delle fazioni nelladifesa della città di Misr assediata dagli Arabi.
12_Roberto.qxp 26-10-2009 12:58 Pagina 226
delle masse cittadine e sono in grado di scatenare la rivolta. Lefonti contemporanee – in particolare gli autori di cronache tra Ve VII secolo – testimoniano soprattutto la capacità delle fazioni diguidare le espressioni di acclamazione o di protesta delle popola-zioni urbane. I luoghi e i tempi della loro azione, le strategie dipersuasione e i vincoli di solidarietà garantivano a Verdi e Azzurriun potere di influenza enorme, con conseguenze disastrose per-fino per la persona dell’imperatore34.
2. Alle fonti contemporanee non sfuggiva la rilevanza politicadelle fazioni. Se il loro peso è innegabile, occorre chiedersi comefosse giudicato negli ambienti aristocratici e intellettuali dellasocietà, in quei gruppi la cui voce è a noi giunta attraverso la sto-riografia, la panegiristica, il pensiero politico. Ripartiremo, dun-que, da un giudizio di A. Cameron nel capitolo Riots and Politicsdi Circus Factions per affrontare la questione delle fonti, e con-centrare poi l’attenzione sui frammenti della FH"���'� (������ diGiovanni di Antiochia.
Cameron sottolinea il giudizio complessivamente negativodella maggior parte degli storici sul ruolo delle fazioni nella vitapolitica dell’impero. Prima di iniziare la sua analisi, lo studiosonota che tali opinioni provengono da esponenti dei ceti medio-alti della società costantinopolitana e orientale. Presso questiintellettuali la considerazione della folla e del popolo era negati-va: la plebaglia veniva menzionata con disprezzo per la sua mal-vagia inclinazione alla rivolta e alla distruzione. Non v’è dubbioche la stessa formazione classicheggiante di molti tra loro contri-buisse ad alimentare i pregiudizi e l’insofferenza contro la massae le organizzazioni popolari, come appunto le fazioni. Da questoatteggiamento deriva la tendenza a sottovalutarne o a rendernemarginale il ruolo nella vita politica; o, d’altra parte, a farne men-
IL RUOLO POLITICO DELLE FAZIONI DEL CIRCO A COSTANTINOPOLI 227
34 Cfr� LIEBESCHUETZ, The Circus Factions, pp. 184-185. Cfr. pure WHITBY, The Violence,p. 245: il potere politico delle fazioni terminò nell’età di Eraclio con la crisi dell’im-pero. Soprattutto la fine del patronato e della protezione accordata dai potenti aVerdi e Azzurri determinarono, secondo lo studioso, la fine dell’influenza politicadelle fazioni. Allo sfaldamento dei vincoli di solidarietà tra gruppi di potere e fazio-ni si lega pure un generale declino del ruolo dell’ippodromo, con la fine dei giochipubblici nella maggior parte delle città dell’impero cfr. LIEBESCHUETZ, The Decline andFall, pp. 218-220. Cfr. pure CAMERON, Circus Factions, pp. 297-308.
12_Roberto.qxp 26-10-2009 12:58 Pagina 227
zione solo per gli episodi di violenza e di rivolta, tacendo dellaloro molteplice attività in ambito cittadino35.
In questa sede basti fare una veloce allusione ad uno dei testidi maggiore importanza e interesse scientifico per l’età diGiustiniano, il trattato di scienza politica I��0 ��$������!��"������ Si tratta di un testo attribuibile al patrizio e prefettodel pretorio (dal primo giugno 528 al 7 aprile 529) Menas, espo-nente della più alta burocrazia costantinopolitana; e non bisognadimenticare che una recente scoperta ha consentito di ricono-scere in Menas anche un importante esponente della cultura filo-sofica a Costantinopoli36. Nel dialogo De scientia politica si accennacon biasimo alla minacciosa instabilità della folla. Un lungopreambolo (V 97-100 Mazzucchi) dell’interlocutore di Menas, ilreferendario Tomaso, introduce al problema. Di fronte alle per-plessità di Menas, che non afferra immediatamente l’argomento,e pensa si stia parlando dell’esercito nella costruzione dello Statoperfetto, Tomaso risponde (103-107):
J� �9 ��� �/� ��$��' � – K L���� �� – "������������% &$$�9 �;��� ��0 M���ϑ�� !�1*$���% �� $�-������ ���% (����� ���ϑ�"�9� ���9� �� �2 &�(�� �*(�A ��0 ��-.$��E �N �2 ���1�"���� "1'"� ��� ��$������ ��*���% O�, �P� � �;� % ��$���� (���/�<������% Q"��� ���� 5�������� ϑ���� ��ϑ�������� �9 ��$��%
UMBERTO ROBERTO228
35 Cfr. CAMERON, Circus Factions, pp. 271-278. Si tratta di un disprezzo che si indirizza-va anche contro l’aspetto e l’abbigliamento dei membri delle fazioni. Così, ad es., nelpasso di Procopio, Anecd. VII 10, che menziona la loro moda di portare i capelli allamaniera “unna”. Al riguardo si vd. anche B. PHILIPPS, Circus Factions and barbariansDress in Sixth Century Constantinople, in F. DAIM (hrsg.), Awaren Forschungen, I, Wien1992, pp. 25-32.36 Per l’edizione del testo contenuto nel Cod. Vat. gr. 73 cfr. Menae patricii cum Thomareferendario De scientia politica dialogus. Iteratis curis quae extant in codice Vaticano palimp-sesto ed. CAROLUS MARIA MAZZUCCHI, Milano 2002. Per l’identificazione tra l’Anonimoe il prefetto Menas: C. MAZZUCCHI, Per una rilettura del palinsesto Vaticano contenente ildialogo «Sulla scienza politica» del tempo di Giustiniano, in G.G. ARCHI (a cura di),L’imperatore Giustiniano, storia e mito, Milano 1978, pp. 237-247; tesi poi ribadita eapprofondita in C.M. MAZZUCCHI - E. MATELLI, La dottrina dello stato nel dialogo ‘Sullascienza politica’ e il suo autore, in G.G. ARCHI (a cura di), Il mondo del diritto nell’epoca giu-stinianea. Caratteri e problematiche, Ravenna 1983, pp. 209-223, in partic. pp. 220-221.Per un nuovo documento sulla personalità di Menas cfr. M. RASHED, Menas, prefet dupretoire (528/529) et philosophe: une epigramme inconnue, «Elenchos», 21 (2000), pp. 89-98. Lo studioso concorda con Mazzucchi (che tuttavia non viene citato) nell’identi-ficare Menas con l’autore del dialogo De scientia politica.
12_Roberto.qxp 26-10-2009 12:58 Pagina 228
"����� ���% R� M�����% ��� �S�� �/�% !���� ��'� �� T ��� ��0��-.$�� �S��� ���"ϑ�� �.$�"�� ��0 T"�� ��� &�(���� (�$�)��- -'��% U� �� �2 �*(��% ��'B��� ��$$V �� ��$��� �; ϑ�� ��?���� W 5 M� ϑ��% R� !���ϑ�% !��-������ ��$����� W �� ��������' !"�� 5 ��� ���� ���9� ��ϑ, �X��� �� ��0 ��� Y$$�� ��$� ����A ������� �����% ������� Z�� � [� ��$����% \� � "��� <���."�� <������ ��"/� �� ]�� ��0 ��"(�������� ����$�'^ _����� – K L���� �� – �9 �/� &�ϑ�+� � -���� M$�-�� ��9 ���%��0 ��� � $�- $�- � �� �� ��*"���� (����� &�(�� �� ��(�����0 &- -�� �/� Y$$ � W ��� !$.������ W ��0 ��$$V ��'B����37�
Menas risponde a Tomaso confermando di aver pensato ancheall’urgente problema di una magistratura speciale per il control-lo delle fazioni (113-114):
8��� ������ �� ���/���� !� �`� ���$�$*ϑ����% R� a�ϑ��% 8���.�� &�(�% �� ��0 M���$�� W R� M$�-�� ����-���� ��-(.�������9� �� -� !6�*$��% R� M����% �9 ������� &�ϑ�+� � "*"����&�(# ���������� ���� �� ��ϑ, �X�9 " 1������% �.� �� ��$��� �2��$�"�"ϑ��E !-b ��% !��0 �2 ��1��� " 1������ ���/� ���1���0 �.$�"�� &�-'�A "�B/�% �� � ��0 "+1���� �� �9 �2��$�"�"ϑ��% R� �S���% &���"��% &$$ ��0 ���1�' � ��9� ��*** 38.
IL RUOLO POLITICO DELLE FAZIONI DEL CIRCO A COSTANTINOPOLI 229
37 Cfr. la traduzione di Mazzucchi: «Non di quello che milita contro i nemici, ma diquello pronto a combattere all’interno dello Stato; anche se non lo si dice, esso costi-tuisce un male peggiore nel caso non sia controllato da una salda autorità. A prete-sto di questa guerra civile, per così dire, un demone infausto, a quanto pare, scagliòfra loro, non so come, nomi di colori, come il mitologico pomo delle dee di Omero.E esso appunto ritengo abbia assolutamente bisogno delle redini di una salda, equanto salda!, autorità, dato che senza di essa è solito procurare alle città dannimolto maggiori, come si disse, alla guerra arrecata da nemici esterni. O non è qual-cosa di simile il popolo diviso in fazioni contro se stesso e il resto della città, una verae propria guerra domestica? Fazioni delle quali per disprezzo e vergogna insieme tra-lascerò di nominare i nomi venerandi. Questo genere di persone – o Menodoro – lodicevo prima, lo dico adesso, e non cesserò di dirlo, deve essere sottomesso a unaautorità e a una regolamentazione non inferiore o anche molto superiore alle altre».Su questo passo e sul seguente cfr. A.S. FOTIOU, Byzantine Circus Factions and their Riots,JÖByz, 27 (1978), pp. 1-10. Anche in Procopio, la violenza delle fazioni è duramen-te condannata come eversiva dell’ordinamento romano: cfr. Procop., Anecd. 7 e BP I24, 2-6.38 Traduzione di Mazzucchi: «Pure, nella nostra esposizione non abbiamo trascurato,come pensavi, tale magistratura, anche se essa è stata costituita in un modo opposto
12_Roberto.qxp 26-10-2009 12:58 Pagina 229
Purtroppo il testo del trattato è lacunoso proprio in questo punto.Ma è significativo che Menas presenti l’urgenza del problema,soprattutto nell’epoca a lui contemporanea, affermando la neces-sità di un controllo forte. Questo atteggiamento indica l’impor-tanza del ruolo politico delle fazioni: in un trattato dedicato allacostruzione di uno Stato ideale, il controllo di queste associazioniè una questione da affrontare con grande attenzione39.
3. Come notato da taluni dei suoi critici40, Cameron sembra con-dividere il giudizio negativo dei contemporanei di V e VI secolo;ma allo stesso tempo segnala come tra alcuni esponenti della cro-nachistica cristiana vi sia maggiore attenzione al ruolo delle fazio-ni. È interessante notare che queste testimonianze si concentranonel periodo a cavaliere tra VI e VII secolo. Così, ad esempio, nellaChronographia dell’antiocheno Giovanni Malala, fonte di estremaimportanza per Antiochia e per l’età di Giustiniano. E d’altraparte, grande rilievo offrono alle fazioni anche la cronaca delvescovo Giovanni di Nikiu, dei primi decenni del VII secolo, e l’o-pera di Strategio Monaco sulla cattura di Gerusalemme da partedei Persiani nel 61441.
UMBERTO ROBERTO230
a quello che tu dicevi. Tu infatti pretendevi, sembra, che questo gruppo di uomini,sottoposto a una magistratura, se ne stesse tranquillo, senza più danneggiare le città:io invece, poiché esso è per natura incapace di comportarsi in modo assennato, alle-vato malamente com’è e soprattutto vivendo sempre nell’ozio – se è d’altra partevero che un uomo assennato non si limiterà, penso, a non commettere devastazioni,ma anche la ricompensa per essere stato allevato…».39 La lacuna del testo impedisce di conoscere i modi di repressione delle fazioni indi-viduati da Menas. Cfr. WHITBY, The Violence, p. 245: l’intervento doveva colpire perlegge la possibilità che le fazioni potessero acquisire vincoli di patronato con impor-tanti personaggi, tra cui perfino l’imperatore, e dunque eliminare l’immunità e l’im-punità garantite da questi rapporti. Si può anche ipotizzare che l’intenzione diMenas fosse quella di colpire le fazioni dal punto di vista economico. Quindi, esoprattutto, riducendo le sovvenzioni imperiali (date attraverso le concessioni anno-narie) che in quell’età garantivano l’esistenza stessa di Verdi e Azzurri aCostantinopoli: cfr. sulla questione ZUCKERMAN, Le cirque, p. 88. WHITBY, The Violence,p. 235, nota opportunamente che l’interesse di Menas per le fazioni rispecchia l’in-teresse degli autori di cronache come Giovanni Malala, Giovanni di Antiochia eGiovanni di Nikiu.40 Si vd., ad es., GASCOU, Les institutions, p. 186; WHITBY, The Violence, p. 234 e 236.41 Per Malala fonte sulle fazioni cfr. le osservazioni di LIEBESCHUETZ, The CircusFactions, p. 166. Cfr. pure Strategius Monachus, La prise de Jérusalem par les Perses en614, éd. par G. GARITTE, (CSCO, 202, Scriptores Iberici, 11-12), Louvain 1960. In gene-
12_Roberto.qxp 26-10-2009 12:58 Pagina 230
Lo stesso atteggiamento è presente in Giovanni di Antiochia,autore di una FH"���'� (������, una storia universale in forma dicronaca da Adamo all’ascesa di Eraclio, pervenuta in modo fram-mentario42. La parte finale dell’opera, conservata negli ExcerptaConstantiniana, descrive gli eventi che portarono alla caduta diFoca e all’ascesa al trono di Eraclio nei primi giorni di ottobre del610. È interessante notare che Giovanni presta grande attenzioneal ruolo politico degli Azzurri e dei Verdi per questa vicenda. Siveda al riguardo il frammento 321:
>�0 c$ϑ�� Fd�.�$����% ��$ ϑ�0� ��� ��� I�'"��� ������'��%��� ef6���� ��0 ���.����� �9� ������ ,f6*��� M��ϑ�� ���,����� � ����*���� !� �# ��$��� !���1ϑ� � 5 &��$19� g �? 5�����(��� ��� �9 L���9� ���(��% ��0 ��ϑb� ��� ef6���� �S��� �9�Fd�.�$���� M1�-�� !� �# ��$��� 5 Fd�.�$���� �@� ��� ef6�����.���� ��4� !���'"���� !������% �:� !�+��"� g �?�� c$ϑ�� �@�Fd�.�$���� ��� Fd�.�$���� ��0 �h���� ��� �2� i-'�� j$����'��%��0 &�9 =�$�6�'�� ��"�$ϑ� �$V ��0 &��$ϑ�� ��� �2� ��"�� �2���$������� >�$+������ ��ϑb� �@� =��1���� 5 >�B������%$�6b� !� ��� k������� ,f��.��� "����� &��-�-�� ���9 �VFd���$�' A � !��$ϑ�� �@� g �?� !� l$�(������E M����� -�I�'"��� 5 -��6�9� ����� ��� �2� i-'�� "����% ���"����*�����&$-��� ��4� ������ 5 l�*� "�� �@� "���6��$�*��� &����������9� -��6�9� ������ ��ϑ����� �@� ����� I�."���� T�� c$ϑ�� 56�"�$�4� ��� �2� ��"�� �2� ���"������������ �# ��$��% &������2� -������ ��0 �2� ������ Fd���$�'�� g�6'�� ��0 &����-���Fd���$�' A �
,���$ϑ� � 5 g �?� ��0 &��$ϑ�� ��� l��'��� ��0 !ϑ�+��� �2����.����� �/� �$�' � �/� !$ϑ��� � ��� Fd���$�'�� &�9,f1������ c"�� � � �$��� m � ��� F�6������ ��0 R� !ϑ�+��� T��
IL RUOLO POLITICO DELLE FAZIONI DEL CIRCO A COSTANTINOPOLI 231
rale sull’interesse di questa parte della storiografia alle fazioni cfr. LIEBESCHUETZ, TheCircus Factions, pp. 181-182: si può ben condividere l’ipotesi per cui è il rapporto trafazioni e imperatore, in un’epoca di debolezza dell’istituzione imperiale dopoGiustiniano, ad attirare l’interesse di questi storici. Soprattutto per il fatto che la capaci-tà di protesta delle fazioni contro le decisioni imperiali è di altissimo impatto politico.42 Per il testo di Giovanni di Antiochia si vd. Ioannis Antiocheni Fragmenta ex Historiachronica. Introduzione, edizione critica e traduzione a cura di U. ROBERTO, (Texteund Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 154), Berlin-NewYork 2005; per la discussione su questa sezione finale dell’opera cfr. pp. XLII-XLIV.
12_Roberto.qxp 26-10-2009 12:58 Pagina 231
!--'B��"� �# ��$��% !�����*"�� 5 g �?� ��"�$ϑ�� !� �# ��$����0 !�������� 1�$.���"ϑ�� !� �/� I��"'� � �9� $����� �9�>��"��'�� ��0 �9� =�1'��% ��4� � l������� � !�0 FJ��'"���� 5� I�'"��� !��$ "� "���(ϑ���� ��4� !�"���6'����� ��� �l���n��� ��� �9� C��������� ��� �;��� ����� ]�� ���� "�����+)���� l����$$��'���� �S(� � Fd�.�$���� L�����/� �$�ϑ�� ��$*���0 ��"�$ϑ�� ��� ".���$�� >�$$���?� 5 o����$�'��� 5 8�'�(��%1��/� Y��� ��0 ��""'��% ��0 !��$ϑb� ��� �9 &���� $��% ��0!���� �2� ��""'��% p� !1����% ��0 -� ��"ϑ����� ����� ��ϑ4�M6�$�� �C I�."���� ��� � >��"��'�� ���E 5 � I�'"��� M���^�����9� ��9� � !�"���6������� ��� � l���+"�� &��$ϑ����� ���� >��"��'��% !��$ϑ�� ���V �C I�."����% ��0 1�6�ϑ�0� M1�-����� �'�� �/� "��$/� ��0 M$�6� �������'�� !���"�� �C �Y�ϑ� ��� ��� g �? &��(+��"��� FJ �@� g+����% 5 ��� g �? !��6��$��ϑ�0� ��� �2� -�����������% ��"�$ϑb� ��� �9 ��$.���� ��� "������% �����"�� ���9�&�9 ��� �+- ��� !��6�$�� ���9� ��� ��$��'��� !��*"����� �@����9� �2� 6�"�$��2� "��$2� ��0 !�6�$����� ���9� ��� &-��)���.(�� &��-�-�� ��9� Fd�.�$����� ��b� � ���9� 5 Fd�.�$����!�.-� �� ��������� $�-�� ���VE ‘�P� � ��q��"��% Yϑ$��% �2�6�"�$�'��;’ 5 � �S���E ‘"4 �.$$��� M(��� ������"��’� 5 �@�Fd�.�$���� ��ϑ������ ��� �9 "�$$�� ��� ��� ���V $����'��� ��0!�0 ��� ����� &����1.$�"�� �����% ��^����� �9� K��� �9�����9� ��0 �2� (���� ��0 �2� 1*"��% ��0 6�$����� ��� ����.���M"���� ���9� ��0 ������B'�$�� �9� &��$19� ����� ��0l�*� "�� ��0 r������� �9� "���$$.���� �����% ��0 M���"������4� ��� �9� l���st�
UMBERTO ROBERTO232
43 Traduzione di U. Roberto: «Eraclio, informato dal patricius Prisco, si recò ad Abido,ricevette il comes di Abido e venne a conoscenza da lui delle cose avvenute in città.Intanto il fratello di Foca detto ‘dalla corta mano’ venne inviato alle Lunghe Mura;quando seppe che Eraclio era ad Abido, fuggì di corsa a Costantinopoli. Frattanto,ad Abido Eraclio accolse tutti gli esuli, che Foca aveva esiliato. Quindi Eraclio si recòad Eraclea e rivolse preghiere a Santa Gliceria; poi salpò da Selubria e raggiunse l’i-sola chiamata Calonimo. Quando Stefano di Cizico lo venne a sapere, prese la coro-na della Madonna di Artace e la portò allo stesso Eraclio. Intanto Foca si recò aBlachernae. Prisco, suo genero, si trovava infatti presso la santa tomba e simulava diaver dolore ai piedi. Bunoso consigliava di ucciderlo. Quando alcuni tra i Verdi sep-pero che l’imperatore (scil. Eraclio) era giunto in quell’isola molto vicina aCostantinopoli, portarono via la moglie e la madre di Eraclio, Fabia, e le condussero
12_Roberto.qxp 26-10-2009 12:58 Pagina 232
Già Cameron nota che il solo Giovanni di Antiochia insiste sulladeterminante partecipazione di Verdi e Azzurri ai fatti, mentrealtri autori, come il contemporaneo Chronicon Paschale e, inparte, Teofane, ignorano questo aspetto. Non si tratta solo diassenza di particolari legati all’attività delle fazioni – ad esempiola liberazione delle donne della famiglia di Eraclio da parte deiVerdi –; tutta la ricostruzione degli eventi procede diversamente.Il Chronicon Paschale sostiene, ad esempio, che il comandanteBonoso (fedele a Foca), e non i Verdi, diede fuoco al porto diCesario. Soprattutto, Giovanni ascrive ai Verdi la decisione diabbandonare Foca e di aprire la città a Eraclio: si tratta di unanotizia assente nelle altre fonti. Cameron ritiene che il ChroniconPaschale (come in parte Teofane) dia un’informazione dotata diun «better sense of proportion», dunque di maggiore proporzio-ne nella valutazione dei fatti, rispetto a Giovanni di Antiochiache, sul modello di una delle sue fonti preferite, Malala, avrebbe
IL RUOLO POLITICO DELLE FAZIONI DEL CIRCO A COSTANTINOPOLI 233
a lui. Foca, intanto, uscì e si recò a Buridai; vide allora lo schieramento delle navivenute con Eraclio dall’Africa. C’erano navi fino all’Hebdomon. E come si accorseche si avvicinavano a Costantinopoli, montò a cavallo, rientrò in città e ordinò che ilporto di Cesario e quello di Sofia fossero sorvegliati dai Verdi, e che gli Azzurri con-trollassero il porto di Hormisdas. Prisco, da parte sua, ordinò che gli excubitores fos-sero radunati a Boradion, presso l’ippodromo di casa sua, insieme ai bucellarii.Eraclio disponeva pure di una forte schiera di cavalieri mauri. L’auriga Calliope,figlio di Trimolaimo, salì su una barca indossando un’armatura e un casco; giunsedunque all’estremità del molo e si tolse il casco che portava. Quando venne ricono-sciuto, subito i Verdi diedero fuoco ai quartieri di Cesario. Prisco quindi appiccò ilfuoco alla caserma degli excubitores. Bunoso intanto si recò ai quartieri di Cesario; iVerdi lo assalirono, e questi, spaventato, fuggì verso uno dei moli e lì ricevette uncolpo di lancia. Allora gli uomini di Foca si ritirarono. Fozio, contro il quale Focaaveva tramato a motivo della moglie, entrò nel palazzo con le truppe, catturò quelloe lo trascinò fuori dal palazzo per la barba. Lo spogliarono della veste imperiale, logettarono dentro una piccola imbarcazione e lo portarono da Eraclio. QuandoEraclio lo vide con le mani legate dietro la schiena gli disse: «Così hai governato l’im-pero, sciagurato?». E quello rispose: «Certo tu lo potrai governare meglio». Allora,rimanendo seduto sulla sella, Eraclio gli diede un calcio. Lo decapitarono in quelluogo. Tagliarono il braccio destro, la mano e i genitali. Misero le carni sulle lance etrascinarono per la città Foca, suo fratello Domenziolo, Bunoso e Leontio, suo sacel-larius. Infine li bruciarono nel foro boario». In generale sugli eventi legati alla mortedi Foca cfr. D.M. OLSTER, The Politics of Usurpation in the Seventh Century: Rhetoric andRevolution in Byzantium, Amsterdam 1993; in particolare per la versione di GiovanniAntiocheno cfr. U. ROBERTO, The Circus Factions and the Death of the Tyrant: John ofAntioch on the fate of the Emperor Phocas, in corso di stampa.
12_Roberto.qxp 26-10-2009 12:58 Pagina 233
esagerato il ruolo delle fazioni nella vicenda44. La questione è, amio giudizio, più complessa: evidentemente, la differente spie-gazione dei fatti si spiega per una diversa prospettiva politica estoriografica. Nei pochi frammenti di Giovanni di Antiochia anostra disposizione sugli eventi, la presenza delle fazioni ècostante. Pur provenendo da ambito antiocheno, Giovanni hascritto la sua opera a Costantinopoli, per un pubblico costanti-nopolitano. Ne sono evidente testimonianza la minuzia delladescrizione topografica non solo per i fatti dell’età di Maurizio eFoca, ma anche per le rivolte dei tempi di Zenone o di Anastasio:si tratta di dati che solo un pubblico della città poteva apprezza-re e comprendere.
L’attenta considerazione per le fazioni negli eventi del 610getta ulteriore luce sugli interessi di Giovanni e sulla natura delsuo pubblico. Dobbiamo in primo luogo partire da una premessagenerale: si tratta di frammenti “storiograficamente” fondamen-tali per l’articolazione dell’opera. Secondo la struttura tipica delgenere, dopo aver raccontato la storia dell’umanità dalle sue ori-gini, e aver rielaborato in maniera originale un numero di fontiaccuratamente trascelte, l’autore di cronache discute gli eventi alui più vicini. Si tratta di fatti per i quali lo storico diviene testi-mone oculare, e tali sono anche i suoi lettori. Ne deriva che lascelta narrativa di Giovanni Antiocheno è, in questa sezione, poli-ticamente e storiograficamente di grande significato. La descri-zione della rivolta con un netto interesse per il ruolo delle fazio-ni è indotta a mio giudizio dalla grande considerazione cheGiovanni ha per il ����� come elemento politico. Nella sua visio-ne non si tratta di un elemento neutro o insignificante (come nelcaso del Chronicon Paschale o di Teofane); e neppure di un grup-po sociale da disprezzare. Giovanni è portavoce di una sensibilitàoriginale nei confronti del �����, che attraverso le fazioni espri-me la sua posizione politica. In questo è vicino a Malala, ma la sin-tonia non si può ridurre alla comune appartenenza dei due stori-ci al genere della cronaca. La questione riguarda piuttosto le scel-te storiografiche. Tanto Malala, quanto soprattutto Giovanni diAntiochia, decidono di dare voce e spazio storico ad una compo-
UMBERTO ROBERTO234
44 Cfr. CAMERON, Circus Factions, pp. 284-285.
12_Roberto.qxp 26-10-2009 12:58 Pagina 234
nente fondamentale della vita urbana, appunto il �����, la popo-lazione urbana rappresentata dalle fazioni. Questi gruppi agisco-no a fini politici e contribuiscono attivamente a determinare l’e-sito di vicende come l’eliminazione del tiranno Foca e l’ascesa altrono di Eraclio. Si tratta di una sensibilità spiccata per i cetimedio-bassi, che si trovano spesso ai margini della storiografiaclassicheggiante e della cultura più elevata. A determinare la sin-tonia contribuisce forse il comune ambito sociale e professionaledei due storici. Malala proviene, infatti, dalla burocrazia al servi-zio del Comes d’Oriente e scrive per un pubblico antiocheno dipari estrazione. Anche Giovanni appartiene con ogni verosimi-glianza alla burocrazia imperiale. Ne sono evidente testimonian-za il suo interesse per le istituzioni, la sua esattezza nella descri-zione delle cariche istituzionali e politiche; la sua precisione per-fino nel descrivere gli spazi del palazzo imperiale (che evidente-mente frequentava spesso). È inoltre molto significativa la prove-nienza dei due storici dal milieu storiografico antiocheno (o piùlatamente siriaco). La tendenza a descrivere il ruolo delle fazioniè del resto più spiccata negli storici di ambito provinciale.
Ma l’interesse di Giovanni di Antiochia per le fazioni, in quan-to espressione del �����% è da interpretare considerando puredue aspetti originali dello storico. In primo luogo, nella FH"���'�(������ compare una spiccata tendenza alla riflessione politica.Gli eventi della storia universale sono analizzati secondo una pro-spettiva che rinvia alla storiografia classicheggiante: le cause chedeterminano gli eventi sono in primo luogo le scelte degli uomi-ni, che incidono sul destino di Stati, comunità e individui. Perquesta visione, l’Antiocheno appare profondamente sensibilealla carica eversiva dell’ordine costituito che caratterizza l’attivitàdelle fazioni. Nel fomentare la "�."��, le fazioni sono capaci dialterare il regolare corso degli eventi, di spezzare l’unità delleparti che garantisce la pace di una polis e di uno Stato. A talriguardo, e al pari di altri autori, la percezione del ruolo politicodelle fazioni da parte di Giovanni di Antiochia è indubitabile45.
IL RUOLO POLITICO DELLE FAZIONI DEL CIRCO A COSTANTINOPOLI 235
45 Sul ruolo delle fazioni come causa di "�."�� cfr. DAGRON, Le peuple de Constantinople,pp. 370-371. La sensibilità di Giovanni Antiocheno per le situazioni che spezzano l’or-dine delle compagini umane e ne turbano la pace e la prosperità – guerre, usurpa-zioni, rivolte, incursioni barbariche, congiure – caratterizza l’intera FH"���'� (�������
12_Roberto.qxp 26-10-2009 12:58 Pagina 235
Ma l’interesse non è solo in prospettiva negativa. Infatti, in stret-ta connessione con questo carattere generale è pure l’analisi deirapporti tra fazioni e potere imperiale. A Giovanni non sfugge ilruolo politico rivestito da Verdi e Azzurri in un periodo di gravedebolezza dell’istituzione imperiale, dalla morte di Giustiniano aEraclio. Nei pochi frammenti pervenuti, si coglie un dato fonda-mentale in questo rapporto: le fazioni erano in grado di espri-mere il loro dissenso verso l’imperatore, e il suo governo, in unamisura non tollerata per altri gruppi. Contava, certo, il fatto chefossero voce del popolo, e che si esprimessero nell’ippodromosecondo i codici rituali delle acclamazioni. Ma appunto le accla-mazioni mostrano la durezza degli attacchi, e la capacità di col-pire in profondità l’imperatore. In Giovanni di Antiochia, gliattacchi sono precisamente registrati. Questa inconsueta libertàdi parola è di estremo interesse per lo storico, che evidentemen-te attribuisce a questo fattore la forza e la valenza politica dellefazioni46.
Ma l’interesse di Giovanni è pure da interpretare secondo uncarattere generale dell’intera opera. Nella FH"���'� (������ il�����, nella sua identità di attore politico e costituzionale, svolgeun ruolo fondamentale. D’altra parte, considerando l’analisidella storia romana, non siamo in presenza di una cronaca uni-versale “tradizionale”. Abbiamo già indicato che si tratta di un’o-pera in cui la cornice cronologica è un contenitore per l’inter-pretazione politica della storia. In questa rappresentazione spiccal’insolito ma significativo interesse per la storia di Roma repub-blicana. In Malala, come pure nella maggior parte delle cronacheuniversali tardoantiche e bizantine, lo sviluppo della narrazionestorica segue forme consolidate: dall’antichità giudaico-orientalesi passa alla guerra di Troia; la fuga di Enea e il suo arrivo nel
UMBERTO ROBERTO236
46 Questo fattore può spiegare anche la sopravvivenza di un buon numero di fonti sulruolo delle fazioni tra la fine del VI secolo e il regno di Eraclio: cfr. LIEBESCHUETZ, TheCircus Factions, pp. 182-184 e ID., The Decline and Fall, p. 213, per la durezza degli attac-chi da parte delle fazioni: «In fact the factions enjoyed an independence which wasshared by no other institution, except the Church and the army». Nota inoltre lo stu-dioso che la prassi era quella di non punire le fazioni per i loro attacchi, anche seestremamente offensivi. Solo Foca ricorse a dure punizioni, ma pagò la sua intem-peranza allorché i Verdi aprirono la città ad Eraclio. Di grande interesse è rilevareche la maggior parte di queste fonti vengono da ambito provinciale: anche Giovannidi Antiochia scrive a Costantinopoli, ma è di origine antiochena.
12_Roberto.qxp 26-10-2009 12:58 Pagina 236
Lazio introducono nella narrazione Roma; Romolo e i sette resono anch’essi materia per i cronachisti, ma dopo la cacciata diTarquinio il Superbo, la ricostruzione salta drasticamente aCesare, fondatore dell’impero (�����('�). L’oblio della storia diRoma repubblicana non deve stupire: è una scelta storiograficapari a quella di ridurre la trattazione della storia greca a pochidati sulla basileia di Alessandro e dei suoi successori. È questo ilpunto. Agli autori di cronache interessa la basileia: quella ebraicae orientale, quella romana arcaica, e finalmente quella che par-tendo da Cesare e Augusto arriva fino all’età del cronachisticastesso47.
Per la sua epoca, Giovanni di Antiochia rappresenta una sin-golare eccezione a questo schema. Infatti, possediamo per interoun $�-�� �u �/� X�.� �% dedicato alla guerra tra Mario e Silla (indiciotto fogli manoscritti del Codex Athous 4932 = Iviron 812), e l’i-nizio del $�-�� �u, dedicato alle guerre tra Cesare e Pompeo.D’altra parte, un terzo quasi dei frammenti tratta di storia repub-blicana romana, che Giovanni chiama “età dei consoli”. A suo giu-dizio, questa fase della storia romana è fondamentale; ed anzi, dacontrapporre a quella successiva, in una visione della potenzaromana che si forma e si manifesta pienamente nell’età repubbli-cana. A tal proposito, è di grande rilevanza storiografica un passotratto dal fr. 150.1 Roberto. Nell’introdurre gli eventi della guer-ra civile tra Cesare e Pompeo, Giovanni afferma: ��� � �2� ���>�.""�� "��1��� 5 ��$����9� ��������� ��$����% !�.����� ����0 ��$$/� ����* � -�-��b� �;����% T�� �2 ��9� ���� Y$$������� ���, ���9� "��6�6���'��� "��1����� ��0 8 �*(� ��� �������� FG ��' � !� ��� 8-�������� ����"�� ��9� �9 X������48. Lafonte di Giovanni è sicuramente un passo di Eutropio VI 19, 1:Hinc iam bellum civile successit exsecrandum et lacrimabile, quo praetercalamitates, quae in proeliis acciderunt, etiam populi Romani fortunamutata est. Il metodo di lavoro e la tensione storiografica diGiovanni sono evidenti dalla rielaborazione di questo breve passo
IL RUOLO POLITICO DELLE FAZIONI DEL CIRCO A COSTANTINOPOLI 237
47 Sulla questione cfr. E.M. JEFFREYS, The Attitudes of Byzantine Chroniclers towards AncientHistory, «Byzantion», 49 (1979), pp. 199-238, con particolare riferimento allaChronographia di Giovanni Malala.48 «E dunque, dopo il disastro di Crasso, seguì la guerra civile, esecrabile e causa dimolte lacrime, perché, oltre alle altre sciagure che vi avvennero, perfino la sorte delpopolo romano passò dalla situazione di dominio alla condizione di sudditanza».
12_Roberto.qxp 26-10-2009 12:58 Pagina 237
eutropiano49. Mentre Eutropio accenna con neutralità al muta-mento della fortuna del populus romano, Giovanni è molto piùesplicito. La fortuna del populus romano cambia da una situazio-ne di dominio nello Stato ad una condizione di assoggettamentoe sudditanza sotto la monarchia dei Cesari. È questo il senso delladegenerazione indotta dalla conquista del potere da parte diCesare e poi di Augusto, uomini liberticidi, arroganti e brutalinella rappresentazione di Giovanni. Si tratta di un pensiero di sin-golare acutezza in un panorama politico e storiografico ormaiincline ad esaltare la basileia carismatica e a legittimarne la derivaautocratica50.
È evidente allora che l’attenzione dell’Antiocheno all’attivitàpolitica delle fazioni non si spiega con una superficiale sopravva-lutazione dei rapporti di forza nelle vicende dell’Oriente roma-no. Al contrario, il suo interesse muove da una scelta storiografi-ca: studiando le fazioni Giovanni descrive il ruolo politico del�����. In continuità con la ricostruzione della storia repubblica-na – sebbene per spazi ridotti e marginali –, il ����� organizzatoin fazioni nella nuova Roma è per l’Antiocheno l’erede del popu-lus repubblicano dell’antica Roma, e come tale continua ad esse-re presente e politicamente attivo. Secondo questa prospettivacambia anche il senso della descrizione dei fatti dell’ottobre 610.Non è un caso che la fine della tirannia del sanguinario Foca(�C�������% come un tempo Catilina, assetato di sangue, nel fr.149 Roberto) si realizzi attraverso la concorde azione di una partedel ����� di Costantinopoli, di esponenti del senato (sotto laguida del patricius e prefetto della città Prisco) e del liberatoreEraclio, rappresentante delle province e dell’esercito. Nella rico-struzione di Giovanni, infatti, una parte del popolo, i Verdi, deci-de di battersi contro il tiranno Foca. Con la sua scelta il �����consegna la città alle truppe di Eraclio, che punisce Foca.
UMBERTO ROBERTO238
49 Sui rapporti tra Giovanni di Antiochia e il Breviarium di Eutropio cfr. U. ROBERTO,Eutropio, Capitone Licio e Giovanni Antiocheno, «Medioevo Greco», 4 (2003), pp. 241-270.50 Cfr. sulla tradizione del logos quarto dei consoli ROBERTO, Ioannis AntiocheniFragmenta, pp. CXI-CXVII; e L. ZUSI, L’età mariano-sillana in Giovanni Antiocheno, Roma1989. In generale sull’interesse alla repubblica romana cfr. pure U. ROBERTO,L’immagine di Roma repubblicana nella Historia Chroniké di Giovanni Antiocheno, in I.MAZZINI (a cura di), La cultura dell’età romanobarbarica nella ricerca scientifica degli ultimi20 anni. Bilancio e Prospettive, «Romano barbarica», 18 (2003-2005), pp. 351-370.
12_Roberto.qxp 26-10-2009 12:58 Pagina 238
Intermediario tra le fazioni ed Eraclio è il patrizio Prisco: comegià sottolineava M. Whitby, è abbastanza significativo cheGiovanni insista sull’opera di questo personaggio che emergecome il reale artefice della fine di Foca. La sua versione è dunquepoliticamente orientata alla celebrazione del patrizio.
Ad ogni modo, come ai tempi della cacciata del tiranno etru-sco Tarquinio (fr. 69 Roberto), nell’ottobre 610 la libertà dallatirannide è riconquistata con il concorso di tutti i gruppi della cit-tadinanza, anche del �����% che agisce attraverso le fazioni. Lasperanza da tutti condivisa per la nuova basileia di Eraclio è soprat-tutto nella possibilità di una amministrazione equa e giusta delloStato, ben distante dal terrore e dagli abusi del dispotismo.Questo è un altro punto storiograficamente importante: è infattinoto che Eraclio giustificò la sua azione contro l’usurpatore assu-mendo, insieme al padre, l’antico titolo di console. Gli echi sto-riografici di questa scelta di propaganda da parte di Eraclio sonoevidentemente presenti nella ricostruzione dei fatti in Giovannidi Antiochia.
ABSTRACT
In the major cities of the late Roman Empire the Circus Factions, Bluesand Greens, were powerful organised groups, whose influence wasbased on their control of popular acclamations and mass demonstra-tions. The factions played a crucial role in the political struggle betweenthe municipal elites and the imperial authorities, in Constantinople aswell as in the provinces. The ancient sources were clearly aware of thispolitical importance. Among them, a special interest is showed by thechroniclers, as John Malalas and John of Antioch. In his Historia chronikéJohn of Antioch offers a vivid analysis of the political role of Blues andGreens in Constantinople. It is evident that John of Antioch attributesgreat importance to the factions in the events that, at the beginning ofOctober 610, led to the end of Phocas and the raising of Heraclius to thethrone. His point of view is very original when compared to the versioncommon to the other sources. In John’s perspective, Heraclius’ victorywould not have been possible without the support of the circus factions,i.e. the Greens, and of the Senate, i.e. the patricius Priscus and othermembers of the aristocracy who had sided against the usurper Phocas.Such a view clashes with the one that sees in Heraclius alone the mansent by Providence, the natural candidate for the imperial succession asthe sole author of rewon freedom.
IL RUOLO POLITICO DELLE FAZIONI DEL CIRCO A COSTANTINOPOLI 239
12_Roberto.qxp 26-10-2009 12:58 Pagina 239