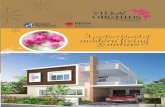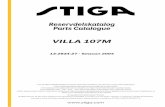La storia della Roccabruna a Villa Adriana
Transcript of La storia della Roccabruna a Villa Adriana
THEMENOS
θθ02
02
VILLA
ADRIANA.E
NVIRONMENTS
VILLA
ADRIANA
"Themènos" è una collana di approfondimento monografico incentrata sui temi dell'architettura degli interni ed in particolare delle sue accezionimuseografiche e allestitive.Thèmenos, fin dalle sue origini di senso, vuol dire "recinto sacro". Ha sempre designato un atto fondativo capace di istituire un'ordine di cose, una realtà fisica e mentale, una condizione di differenza, tra un dentro ed un fuori, tra ciò che appartiene e ciò che non appartiene ad uno spazio strutturato per definirsi come "interno". Il thèmenos articola unadimensione inclusiva ed esclusiva assieme. Inclusiva, in quanto tende a porre un limite allo spazio progettato. Esclusiva, in quanto stabilisce unascala di valori al cui centro s'impone la visione introspettiva ed endoscopica, una prospettiva dall'interno con diversi gradi di apertura sul mondoesterno. Ciò implica un'analisi sulla "condizione d'internità", sui suoi fondamenti, i suoi elementi e sulla sua fenomenologia. Lo spazio interno non è necessariamente né chiuso, né al caldo, né coperto. O non solamente. Lo spazio interno è un'esperienza complessa chesi istituisce come atto fondativo della forma in cui la compromissione con il mondo esterno è un prodotto del pensiero progettante, che è innanzi-tutto pensiero selettivo.
ENVIRONMENTS
Thèmenos
Collana di approfondimento monografico
di Architettura d'Interni, Museografia e Allestimento
Coordinamento scientifico e ideazione
Pier Federico Caliari
Coordinamento editoriale
Clarissa Ricci
Francesco Leoni
Gian Luca Vita
Progetto grafico ed impaginazione
Carola Gentilini
Maria Daniela Coi
Volume a cura di
Luca Basso Peressut e Pier Federico Caliari
In copertina:
Le Corbusier, schizzo del muro del pecile, Villa Adriana, 1911
In quarta di copertina:
Abstract dei progetti vincitori della prima edizione del Premio Piranesi
Environments
L’identità e il ruolo di Villa Adriana nel panorama
internazionale
di Anna Maria Reggiani
Museografia, archeologia, territorio
di Luca Basso Peressut
Villa Adriana. Costituzione d’interno e mappatura mentale
di Ernesto D’Alfonso
Passi su un suolo classico
di Gianni Accasto
Tracing the trace in the making of architecture
di Romolo Martemucci
Villa Adriana
di Allan Ceen
La casa di un romano
di Paolo Giardiello
Paesaggio preesistenza storica, progetto
di Giuseppe Milani
La misura antica per il progetto museografico di Roma
di Piero Meogrossi
Villa Adriana: progettazione, habitat museale e logiche
espositive adrianee
di Claudia Cecamore
La cosiddetta “Roccabruna” ed il dies imperiidi Alessandro Camiz
Perchè Villa Adriana?
di Nicola Pagliara
02
θcapitolo I:
19
27
49
109
35
99
Villa Adriana come paradigma
di Pier Federico Caliari
presentazione
9
79
63
73
85
121
131
Il Premio Piranesi
La nascita del Premio Piranesi dallo spirito del “Prix de
Rome”
di Pier Federico Caliari
La Musa e i Frammenti: Premio Piranesi primi vincitori
di Francesco Leoni
Categoria Archeologia e Paesaggio:
Punti e assi. Elementi sensibili e percori di visita
Categoria Archeologia e Architettura:
Ricostruzione del teatro nord di Villa Adriana
Categoria Archeologia Interni ed Allestimento:
Allestimento del Casino Fede come Museo Piranesiano
Workshop Report
5-14 settembre 2003
capitolo II:
141
155
167
159
187
180
Tales Polemon auctor refert fuisse oculos Hadriani impe- ratoris: caropous, humidos, acres, magnos, luminis plenos 1
La cosiddetta "Roccabruna" è costituita dalla parte basamentale
di una architettura originariamente composta da due piani
sovrapposti. Un'aula circolare con nicchie, coperta a cupola e tut-
tora esistente, sosteneva un tempietto circolare con cupola in
muratura. L'aula e la sua copertura sono intatte e conservano la
loro funzione primaria: si può quasi dire che si tratta di un edifi-cio vivo. La tholos del piano superiore è invece crollata in epoca
imprecisata: si possono infatti ancora vedere i frammenti mar-
morei del tempietto circolare e due grossi blocchi di muratura
appartenenti alla cupola di copertura. Il dado basamentale è
stato evidentemente spogliato di tutti i rivestimenti interni ed
esterni e si presenta dunque con il paramento murario in tufelli
listati da laterizi a vista. L'edificio è addossato alle sostruzioni
dell'Accademia, ed è stato realizzato successivamente ad esse
come si può notare dal giunto tra le due murature. Una rampa
sostenuto da volte impostate sui muri delle concamerazioni
esterne, raccorda i due livelli. Il Lugli ha trattato in maniera esau-
stiva l'edificio, illustrando con il rilievo di Renato Bonelli la fabbri-
ca e passando in rassegna gli autori precedenti per esaminare lediverse interpretazioni, concludendo con alcune ipotesi sui
modelli architettonici che possono aver ispirato il progetto. Si
rimanda dunque a tale autorevole trattazione per il rilievo e la
descrizione2. Elaboreremo piuttosto un tentativo di interpretazio-ne ed un progetto per l'attribuzione di senso al complesso, com-
patibilmente con il contesto archeologico. L'obiettivo di questa
trattazione è quello suggerire temi e metodi contemporanei per
riavvicinare e rendere compatibili il sito archeologico ed il turista
globalizzato. "Abbiamo da una parte la città contemporanea…e
dall'altra la città storica" 3, si tratta quindi di individuare un modo
per ricongiungere queste realtà separate a partire dall'intervento
sulle aree archeologiche. L'approfondimento del concetto di
tempo all'interno della città contemporanea e l'indagine sulle sue
"dinamiche modificative plurali e complesse"4, possono fornire
alcuni suggerimenti utili alla riconnessione semantica di città con-
temporanea e rovina archeologica.
122θ
Ale
ssa
nd
ro C
am
iz
pagina precedente:
fig. 62: Giambattista Piranesi, Avanzi di una Sala appartenente al Castro
Pretorio nella Villa Adriana in Tivoli
123θ
Funzione e modello: le diverse interpretazioni
Esistono diverse ipotesi sulla funzione originaria di questa archi-
tettura: gli autori hanno scritto della villa, ora con ispirazione let-
teraria, ora con il sostegno di consistenti metafore plastiche
architettoniche, comparando la "Roccabruna" con diverse archi-
tetture del passato5. Tralasciando il quadro tipologico che sareb-
be necessario per convalidare ciascuna ipotesi comparativa, si
ritiene intanto in prima analisi di considerarle tutte significative.
Dividendole in due categorie principali, architettura sacra e archi-
tettura legata all'osservazione del paesaggio, diventa chiaro
come le due funzioni coesistessero ai due livelli sovrapposti del-
l'edificio. Si trattava dunque di un'architettura dal duplice impian-
to e significato simbolico, dove ancora una volta è possibile sot-
tolineare la "priorità e coercività del significante6, rispetto alla
forma architettonica costruita. Si possono ragionevolmente ipo-
tizzare una funzione al piano terra ed una distinta al piano supe-
riore, entrambe descritte con coerenza dai tipi e dalle figure libe-
ramente adottate e sovrapposte (fig. 63). La coesistenza di due
funzioni autonome è confermata anche dalla rampa inclinata che,
essendo esterna alla fabbrica, costituisce l'unico elemento di col-
legamento verticale tra le due parti durante la fase adrianea di
utilizzo del monumento. Le scale che si trovano all'interno del
monumento appartengono al suo riutilizzo in epoca medievale e
barocca. Il progetto moderno può tenere conto di queste consi-
derazioni tipologiche e distributive e verificare i modi necessari
per attribuire un nuovo senso all'edificio affidandogli un ruolo
compatibile con il contesto archeologico specifico, attraverso la
conferma della sua duplice valenza di aula e osservatorio. La
presenza di aperture strombate che terminano in feritoie all'inter-
no della cupola suggerisce una funzione riferita a fenomeni
esterni, quali venti o fenomeni astronomici. Probabilmente si trat-
tava di un sistema naturale di condizionamento dell'aria ancora
essere efficace nonostante lo stato di abbandono. Una rete di
piccole canalizzazioni percorre l'edificio all'esterno ed all'interno,
sono ancora da indagare attraverso gli scavi il percorso dei plu-
viali del portico occidentale e la rete di scarico7. Infine è interes-
sante aggiungere alle numerose comparazioni suggerite dagli
autori precedenti, l'analogia con il cosiddetto Tempio della Tosse
(fig. 64): si tratta di un edificio, datato al IV secolo d.C., a pianta
ottagonale. La pianta interna però è molto simile e anche la tec-
nica costruttiva è analoga tanto da suggerire qualche riferimento
tra i due edifici8. Le due architetture presentano lo stesso impian-
to a pianta centrale ottagonale con 4 nicchie semicircolari; il dia-
metro della circonferenza della aula interna è 9,50 m. per la
Roccabruna9 e di circa 12,00 m circa per il Tempio della Tosse.
L'orientamento è di circa 256° per il Tempio diversamente dai
298°della Rocccabruna. A sostegno del quadro comparativo deli-
in basso:
fig. 63: Roccabruna,disegno dell'autore dal rilievo di Bonelli
fig. 64: Tempio della Tosse, pianta da Giuliani, Tibur
63
64
124θ
Ale
ssa
nd
ro C
am
iz neato, si consideri inoltre che l'attuale configurazione del Tempio
della Tosse presenta una cupola con estradosso gradonato ed
oculum centrale, molto simile alla ipotesi ricostruttiva che il Lugli
ha redatto basandosi sui blocchi murari che si possono ancora
osservare ai piedi della Roccabruna (fig.67). Il Cabral descrive
l'edificio con parole significative: "Poco sotto le polveriere per la
medesima strada romana, dalla parte sinistra dentro gli orti ispet-
tanti ai canonici della cattedrale di Tivoli, vedesi un antico tempio
di forma rotonda a somiglianza del Pantheon romano. Esso è di
vaga struttura, e molto ben conservato; ma presso gli storici
tiburtini non trovasi notizia alcuna a qual profano nume fosse
dedicato. Solo la costante voce del volgo lo ha sempre chiama-
to, e lo chiama tuttora, il tempio della tosse"10. Questa ipotesi
comparativa suggerisce la necessità di mettere in relazione la
villa ed i suoi modelli architettonici con la "la toponomastica, pro-
dotto di una stratificazione secolare di eventi"11. Questa compa-
razione è ancor più necessaria vista l'attuale assenza di riferi-
menti architettonici all'interno della villa. Tutte le architetture sono
state denominate in epoca moderna in funzione delle ben note
attribuzioni di senso desunte dagli Scriptores Historiae Augustae,
una tradizione letteraria che attende la conferma di studi storici
comparativi.
Orientamento e dies imperii
Il dado basamentale dell'edificio è simmetrico e presenta una
porta centrale sul fronte: l'asse principale di simmetria ha la dire-
zione di 298° (in base al rilievo di Bonelli): questa direzione coin-
cide con l'azimuth del sole al tramonto l'undici agosto del 117
d.C., il dies imperii, ovvero il giorno nel quale Adriano assunse il
potere. Secondo la tradizione degli Scriptores HistoriaeAugustae, l'undici agosto del 117 d.C. Adriano assunse formal-
mente il potere e tale giorno fu celebrato come una festa ufficia-
le12. Si tratta di una formidabile relazione di senso e di forma tra
architettura ed evento astronomico. E' verosimile ipotizzare che
nella Villa Adriana si sia messo in atto un rituale fondativo costi-
tuendo le relazioni fondamentali tra architettura ed imperium.
Non ci sono altre prove per dimostrare questa intrigante tesi, si
ritiene comunque di sottoporre alla attenzione della comunità
accademica questa singolare coincidenza.
-------------------------------------------------------------------
Altitude Azimuth Date Time
-------------------------------------------------------------------
+00° 01' 01" 298° 13' 32" 11 ago 117 19:47:30
-------------------------------------------------------------------
Tabella 1, effemeridi del sole al tramonto nel giorno 11 agosto del 117 d.C. 13
in basso:
fig. 65: Un blocco della muratura appartenente alla cupola della tholos del piano
superiore (foto dell'autore).
a lato:
fig. 66: L'orientamento del complesso, 298° in relazione al dies imperii, 11 ago-
sto 117 d.C. (disegno dell'autore).
65
125θ
La differenza tra il valore calcolato e quello riferito dal rilievo è di
circa 13': a meno di una verifica tramite misurazioni con stru-
mentazioni GPS e di calcoli astronomici più precisi, si può ragio-
nevolmente ipotizzare la coincidenza dei valori (fig.66). Questa
relazione astronomica rientra in un modo di costruire che pos-
siamo ritrovare in altri edifici concepiti dall'imperatore. Le relazio-
ni tra architettura e astronomia, molto in voga nella cultura
costruttiva egiziana alla quale Adriano si era ispirato, fanno rife-
rimento ad una concordanza celeste della quale l'architettura si
fa interprete ed imperitura testimone.
La conseguenza di questo allineamento comportava che nel gior-
no della celebrazione del dies imperii il sole al tramonto sarebbe
stato inquadrato dalla porta di ingresso, illuminando la nicchia
collocata sul lato opposto, dove è ragionevole supporre che
fosse collocata una statua o qualche oggetto particolarmente
significativo. Si può anche ipotizzare una lettura dell'impianto
topografico della intera villa in questo senso, dove dies natalis(tema natale) e dies imperii (tema imperiale) siano riferibili ad
eventi astronomici capaci di fornire gli orientamenti dei diversi
complessi e costituire quella pluriassialità che contraddistingue la
villa.
Allineamenti e paesaggio
Dalla ricostruzione effettuata dal Lugli si possono ragionevol-
mente ipotizzare 4 aperture nella cella ottagonale del piano supe-
riore, orientate verso altrettanti capisaldi del paesaggio circo-
stante nelle direzioni 298°, 118°, 208°, 28°. L'asse principale del
monumento è allineato con due significativi elementi del paesag-
gio: la direzione di 298° collima con il Monte Venere m. 838 col-
locato ad una distanza di km. 65,5°. L'altra direzione coincide con
il Monte Cavilli 1.116 m. collocato a 76 km di distanza. La dire-
zione ortogonale passante per il centro dell'aula ottagonale
28°(208°) collima con il tempio di Ercole Vincitore.
A meno di un'ulteriore verifica che includa la valutazione delle
aperture angolari delle vedute per ricostruire gli elementi inqua-
drati nelle aperture del piano terra e del piano superiore, si può
facilmente notare come l'edificio costituisca le sue relazioni disenso attraverso l'orientamento in relazione agli elementi più
significativi del paesaggio circostante: come se la architettura
avesse realizzato, ibridando abaco e groma, un modificazione
connessa dell'ambiente, in stretta relazione simbolica e funzio-
nale con il suo intorno.
Lo studio degli allineamenti dell'architettura in relazione agli ele-
menti del territorio è finalizzato al riconoscimento del carattere
sacro del paesaggio come strumento per il "radicamento della
comunità ai luoghi"14.
66
126θ
Ale
ssa
nd
ro C
am
iz
in alto:
fig. 67: La Roccabruna come si presentava nel XIX secolo. Da Luigi Canina,
L'architettura antica, descritta e dimostrata coi monumenti (1834-1844).
fig. 68: La Roccabruna come si presenta oggi, il confronto con la veduta del
Canina mette in evidenza la necessità della reintegrazione dell'immagine.
67
68
127θ
Frammenti di storia
Dalla caduta dell'impero ed il conseguente progressivo abbando-
no della Villa alla sua riscoperta rinascimentale è passato più di
un millennio di storia, denso di modificazioni continue che hanno
determinato l'assetto attuale del monumento. Il progetto contem-
poraneo non può e non deve cancellare questa storia millenaria.
Ad esempio, il muro sostruttivo della accademia lasciava spazio
per una apertura che si ricollegava al sistema dei percorsi sot-
terranei della villa, "una lunghissima galleria iniziata sotto il quin-
to arco della cordonata che saliva alle spalle di Roccabruna"15.
Questo tratto è oggi invisibile, "dal terreno emergono soltanto
quattro di questi cinque archi, il primo di essi venne completa-
mente distrutto"16 In passato l'interpretazione del complesso dei
collegamenti sotterranei ha lasciato spazio a speculazioni diver-
se, sostanziate però dal dato archeologico. "Credo bene che vi
fusse qualche appartamento per rappresentare i Campi Elisei,
come ancora, che vi fusse Roccadiferro, la quale Virgillio descris-
se esservi stata, e che venisse rappresentata in quel luogo,
ch'ancora hoggi si dice Roccabruna, et è comune che vi fusse
l'inferno, come dice Lampridio, et che di sopra habbiamo mostra-
to; ma che fusse rappresentato dal rumor di catene, et parlare, et
altro rumore de' schiavi somigliante la confusione infernale"17.
Nel XV secolo la Roccabruna è di proprietà della famiglia
Soliardi. Nel XVII secolo il complesso diventa di proprietà dei
Gesuiti, come testimoniato dal Kircher, un gesuita egli stesso,
che sembra aver frequentato il sito. "Versus occidentalem partemingens vallis occurrit, in cuius edito latere integre adhuc tholusspectantur, in loco, qui hodie Rocca bruna dicitur, et est subJurisdictione Tyrocinij Societatis Jesu ad Sanctum AndreamRomae, ubi quotannis summa sane commoditate tanquam inpropria villa costituto, dictae Adrianae villae rudera esplorareconcessum fuit"18. Più tardi anche il Cabral racconta l'edificio con
grande cura di dettagli: "Edifizio detto Rocca bruna, che conte-
neva due Tempj l'uno sopra l'altro. Quel di sotto esiste ancora
con le mura intiere ma spogliate de' marmi, ed altri antichi orna-
menti, ed appartiene al piano inferiore segnato ii. Quel di sopra
era circolare, e cinto di belle colonne, ed apparteneva al piano
superiore dell'accademia. Forse attorno a questo tempio supe-
riore girar doveano colle fiaccole quelli, che correvano nell'acca-
demia prima di far ritorno al tempio di Prometeo; ed era forse il
Tempio di Minerva, in grazia di cui facevansi dette feste. Oggidì
è affatto atterrato, e vi si erge in vece una casa, o torretta, che
serve di abitazione pe' contadini"19. Troviamo altri riferimenti al
territorio circostante dove "campi quasi piani, oggi vigne, ed oli-
veti di Roccabruna, dove tratto tratto si incontrano fondamenti di
muri incogniti. Attesa la vicinanza delle terme, buona parte que-
sta pianura contenere dovea boschi, e giardini; poiché come nota
il Bacci, De Thermis veterum cap. 5, ancora tali delizie soleansi
porre presso di quelle fabbriche"20. Infine il Bulgarini illustra la
zona circostante, "Il piano che incomincia sopra il canopo a
ponente principiando dal casale detto Roccabruna sorretto da
lunga costruzione, sino al corpo delle fabbriche dell'accademia,
si crede fossero i giardini della medesima. Il detto casale è posto
sopra un tempio al quale ne sovrastava altro porgente al piano
de'giardini, ornato di colonne; all'uno e all'altro danno varie ed
equivoche denominazioni"21.
Progetto di restauro e recupero funzionale
L'attuale definizione di "Roccabruna" fa riferimento ad una fase
di riutilizzo del complesso. E' necessario sottolineare che grazie
a questa fase il monumento è pervenuto fino ai giorni nostri inte-
gro nella sua parte inferiore. La fabbrica si presenta oggi così
come si doveva presentare agli occhi di Pirro Ligorio, a meno di
un importante particolare. (fig.67, 68). L'edificio è così descritto
nella seconda edizione di Contini: "Tempio per di fuori di figura
circolare, posto sopra l'altro descritto al numero 23 della lettera I.
e questo era ornato di fuori di 16 colonne di marmo bianco stria-
te d'ordine dorico, isolate di grossezza di palmi tre e mezzo di
diametro, sopra le quali era l'architettura, fregio e cornice di
marmo. La parte di dentro di questo tempio era di figura ottago-
na, con otto arconi nei lati larghi palmi 13 e mezzo; ed il diame-
tro del Tempio era di vano palmi 46 e mezzo. Il quale Tempio ora
è spianato affatto, ed in vece di esso vi è stata fabbricata una
Torre, che al presente si chiama ROCCABRUNA"22. Nonostante
la demolizione della torre avvenuta nel 1881 durante gli scavi del
Lanciani, il sito ha mantenuto il nome della parte che non esiste
più. Un paradosso logico, chiamare un'architettura con il nome
della parte demolita può comportare lo spaesamento del visitato-
re. Il progetto di sistemazione dovrebbe trovare le forme ed i
modi per consentire il riconoscimento della fase storica che è
stata vitale per l'edificio e rendere possibile "una più attenta let-
tura dell'architettura"23. Queste caratteristiche suggeriscono un
intervento diversificato rispetto ad altri edifici della villa, dove la
sola musealizzazione all'aperto viene indicata come strategia da
adottare. In questo caso il progetto ostensorio può e deve affian-
carsi ad una riflessione sul volume architettonico, dove la disci-
plina del restauro può affiancarsi alla museografia, alla composi-
zione architettonica ed al disegno degli interni e, sotto la sapien-
te guida della storia riconsegnare alla contemporaneità un edifi-
cio compiuto assegnandogli una funzione compatibile ed un
nuovo significato. La quantità dei frammenti marmorei apparte-
nenti alla tholos superiore24 è sufficiente per suggerire un'anasti-losi parziale che potrebbe prevedere il rialzamento di alcune
delle colonne e della corrispondente trabeazione (fig.69,70,71).
128θ
Ale
ssa
nd
ro C
am
iz La scelta della collocazione opportuna per il posizionamento
delle colonne dovrebbe tenere conto del contesto e della sua alti-
metria: in funzione del muro con concamerazioni esterne che
funge da sostruzione del piano della accademia, le colonne rivol-
te verso l'angolo esterno meglio consentirebbero la rilettura del
monumento. Si tratta di un progetto di musealizzazione all'aper-
to dei frammenti architettonici che, unitamente ad una sistema-
zione generale del percorso espositivo, dovrebbe consentire la
corretta lettura dell'architettura nel suo contesto. Inoltre tra i fram-
menti ritrovati nell'area circostante, uno sembra rimandare ad un
elemento colonnato lineare, il ritrovamento può fornire altri spun-
ti di riflessione progettuale. Inoltre un'opportuna illuminazione
notturna contribuirebbe a ridefinire l'immagine della parte man-
cante della tholos. La parziale reintegrazione dell'immaginerichiede che venga realizzata una struttura in elevazione, reale o
virtuale, per colmare il vuoto d'immagine del piano superiore,
vuoto che era stato colmato già nel XVI secolo con la realizza-
zione della torre. La demolizione del volume superiore attuata nel
1881 ha mutilato il monumento che richiede senz'altro un inter-
vento progettuale. "Un danno di immagine che chiede di essere
risolto con un restauro o con una reintegrazione di immagine"26.
Non a caso già il Nibby nella sua descrizione scriveva "una tor-
retta moderna è fabbricata su queste rovine e sembra conserva-
re la rimembranza della forma primitiva di questa parte"27.
Questa ipotesi sarebbe di grande utilità per il monumento e per
la villa. La visibilità-leggibilità del complesso è infatti limitata dagli
ulivi circostanti, la ricomposizione di alcune colonne e di un fram-
mento di trabeazione consentirebbe dunque di riconoscere il sito
dall'asse principale di percorrenza che va dalle Terme al Canopo
e di ricondurre l'attenzione dei visitatori all'area dell'Accademia.
Naturalmente l'operazione ipotizzata sarebbe la premessa per
una sistemazione degli interni della Roccabruna per il progetto
ostensorio degli oggetti rinvenuti duranti gli scavi. Oltre ad un
nuovo rilievo accurato è necessario realizzare un disegno rico-
struttivo dettagliato del genere architettonico28. Particolare cura
nel progetto dovrà essere prestata al pavimento interno ed alla
delimitazione dei suoli di pertinenza del monumento per ridefini-
re il temenos del tempio come "recinto sacro inteso come fisica
soglia dell'ostensione"29. La contemporanea considerazione di
restauro, storia, paesaggio, composizione ed allestimento
museografico contribuisce all'istituzione di una formidabile "rela-
zione tra più codici compresenti" 30. Un'ulteriore riflessione richie-
de a mio avviso il tema dell'accessibilità, tema estremamente
attuale e capace di fornire le prefigurazioni contemporanee degli
interventi sul patrimonio archeologico specialmente in un conte-
sto dove un forte dislivello suggerisce di inventare le forme per
"progettare nei luoghi antichi attraverso lo svolgimento del tema
dell'accessibilità"31.
69
70
71
129θ
Note
1. Anonimo latino, De physiognomonia liber, 34, Anonime latin, Traité de
Physiognomonie, André J, Les Belles Lettres, Paris 1981.
2. Lugli Giuseppe, La "Roccabruna" della Villa Adriana, in "Palladio", IV, n°6,
1940, pp. 257-274.
3. Terranova Antonino, Le città e i progetti. Dai centri storici ai paesaggi metro-politani, Gangemi editore, Roma 1993, p.51.
4. Terranova Antonino, op.cit., p.13.
5. per l'elenco delle ipotesi comparative vedi Lugli Giuseppe, op.cit., pp. 257-258.
6. Ottolini Gianni, Forma e significato in architettura, Laterza, Roma-Bari 1996,
p.165.
7. Righi Roberto, Torre di Roccabruna, in Archeologia e giubileo: gli interventi aRoma e nel Lazio nel piano per il grande giubileo del 2000, a cura di Fedora
Filippi, Electa, Napoli 2001, p.474.
8. cfr. Olivanti Paola, Via Tiburtina, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma
1997.
9. Lugli Giuseppe, op.cit., pp. 264.
10. Cabral Stefano, Del Re Fausto, Delle ville e de' più notabili monumenti anti-chi della città, e del territorio di Tivoli, nella stamperia del Puccinelli al Governo
Vecchio, Roma 1779, p.42.
11. Guidoni Enrico, Il paesaggio locale. Nota sulla dimensione storico-antropolo-gica dell'ambiente, in "Rassegna di Architettura e Urbanistica", XVI,
agosto/dicembre 1980, p.100.
12. "Quintum iduum august. Diem legatus Suriae litteras adoptionis accepit,quando et natalem adoptionis celebrari iussit. Tertium iduum earundem, quandoet natalem imperii statuit celebrandum, excessus ei Traiani nuntiatus est."Scriptores Historiae Augustae I,4,12, traduzione italiana in Soverini Paolo,
Scrittori della storia augusta, UTET, Torino1983, pp.141-143.
13. Elaborazione effemeridi storiche effettuata con Skymap Pro v9.0.9, Copyright1992-2002 C.A.Mariott.
14. Guidoni Enrico, op.cit., p.98.
15. Salza Prina Ricotti Eugenia, Villa adriana: il sogno di un imperatore. L'Erma
di Bretschneider, Roma 2001, p.113.
16. Salza Prina Ricotti, Eugenia, op.cit., p.113.
17. Del Re Antonio, Dell'antichità Tiburtine, appresso Giacomo Mascardi. Roma
1611, p.86.
18. Kircher Athanasius, Latium id est nova et parallela Latii tum veteris tum novadescriptio, Amstelodami 1627, p.150.
19. Cabral Stefano, DEL RE Fausto, op.cit., p.157.
20. Cabral Stefano, DEL RE Fausto, op.cit., p.158.
21. Bulgarini Francesco, Notizie storiche antiquarie statistiche ed agronomicheintorno all'antichissima città di Tivoli e suo territorio, Tipografia G.B. Zampi, Roma
1848, p.124.
22. Contini Francesco, Pianta della Villa Tiburtina di Adriano Cesare già da PirroLigorio… disegnata e descritta, dopoi da Francesco Contini riveduta e data allaluce…, stamperia di Apollo, Roma 1751, p.21.
23. Carbonara Giovanni, Avvicinamento al restauro. Teoria, storia, monumenti.
Liguori editore, Napoli 1997, p.452.
24. per l'elenco dettagliato dei frammenti rinvenuti vedi: LUGLI Giuseppe, op.cit.,pp. 267-270.
25. Rocco Giorgio, Su di un fregio dorico da Villa Adriana. La soluzione vitruvia-na del conflitto angolare, in "Palladio", n.14, luglio-dicembre 1994, pp.37-44.
26. Carbonara Giovanni, La reintegrazione dell'immagine, Bulzoni editore, Roma
1976, p.94.
27. Nibby Antonio, Descrizione della Villa Adriana, per i tipi di Angelo Ajani, Roma
1827, p.52.
28: per la ricostruzione del genere architettonico vedi: LUGLI Giuseppe, op.cit.,
fig. 15, p.269.
29: Caliari Pier Federico, La forma dell'effimero. Tra allestimento e architetturacompresenza di codici e sovrapposizione di tessiture, edizioni Lybra immagine,
Milano 2000. p.57.
30: Caliari Pier Federico, ibidem, p.40.
31: Camiz Alessandro, Colossi e tecnologie. Documenti per la valorizzazione el'accessibilità dei siti archeologici, in "Paesaggio urbano" gennaio-febbraio 2003,
p.21.
a lato:
fig. 69: Frammento della cornice dorica con protomi leonine(foto dell'autore)
fig. 70: Frammento di uno dei capitelli dorici (foto dell'autore)
fig. 71: Una delle basi delle 16 colonne doriche collocate al piano superiore.
(foto dell'autore)
in basso:
fig. 72: Finestra con strombatura collocata sul retro
e fuori asse rispetto all'edificio. (foto dell'autore)
72