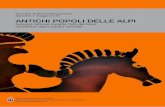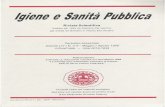La sovrapposizione semantica di Morriña e Saudade
Transcript of La sovrapposizione semantica di Morriña e Saudade
Dai pochi ai molti
Studi in onore di Roberto Antonelli
a cura di Paolo Canettieri e Arianna Punzi
tomo i
viella
Copyright © 2014 - Viella s.r.l.Tutti i diritti riservatiPrima edizione: febbraio 2014ISBN 9788867281367
viellalibreria editricevia delle Alpi, 32I-00198 ROMAtel. 06 84 17 758fax 06 85 35 39 60www.viella.it
Il volume è stato realizzato anche con il contributo della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Uni-versità di Roma La Sapienza
RedazioneAnatole Pierre Fuksas, Annalisa Landolfi, Gioia Paradisi, Roberto Rea, Eugenia Rigano, Gio-vanna Santini
Indice
tomo i
Paolo Canettieri, arianna Punzi
Premessa XIX
alberto abruzzese
Contro l’umanesimo e i suoi dispositivi 1
annamaria anniCChiariCo
La Biblis di Joan Roís de Corella (introduzione, edizione critica, traduzione) 15
rossend arqués
Dante y Octavio Paz: poética moderna y erotismo 37
Valentina atturo
Languor carnis. Echi di memoria salomonica nella fisiologia emozionale dei trovatori 49
anna maria babbi
«Je sui la pucele a la rose»: ancora sul Guillaume de Dole 79
sonia maura barillari
La «coppia d’Arimino» fra il Triumphus cupidinis e il Purgatorio di san Patrizio. (Una ballata per Viola Novella dal codice Magliabechiano VII, 1078) 89
maria Carla battelli
Il karma e la letteratura: insegnare in India 115
Fabrizio beggiato, antoni rossell
Ara que·m sui lonhatz d’est mestier brau 133
IndiceVI
Pietro g. beltrami
Il Manfredi di Jean de Meun (esercizio di traduzione dal Roman de la Rose) 135
ViCenç beltrán, isabella tomassetti
Refrains ed estribillos: dalla citazione all’imitazione 145
Valentina berardini
«Praedicatio est manifesta et publica instructio morum et fidei…». How did preachers act on the pulpit? 169
FranCesCa bernardini naPoletano
«Difficoltà di vita» e «ragioni dell’anima». Lettere di Alfonso Gatto a Enrico Falqui 179
Fabio bertolo
Minima filologica: quattro lettere inedite di Bruno Migliorini a Ettore Li Gotti 195
Valeria bertoluCCi Pizzorusso
«… non so che “Gentucca”»: analisi di Purgatorio XXIV, 37 199
simonetta bianChini
«Il mio tesoro» (Paradiso XVII, 121) 205
dominique billy
La Complainte de Geneviève de Brabant ou l’inconstance de la césure 215
Piero boitani
Identità europea e canoni letterari 231
Corrado bologna
Gli «eroi illustri» e il potere “illuminato” 241
massimo bonaFin
Rileggendo Les Vêpres de Tibert (branche 12 del Roman de Renart) 261
luCiana borghi Cedrini, Walter meliga
La sezione delle tenzoni del canzoniere di Bernart Amoros 273
merCedes brea
Esquemas rimáticos y cantigas de refrán 289
margaret brose
Leopardi and the gendering of the sublime. A meditation for Roberto Antonelli, in gratitude for his friendship 299
Indice VII
Furio brugnolo
Esercizi di commento al Dante lirico: Ballata, i’ vòi che tu ritrovi Amore (Vita nuova, XII [5]) e Tutti li miei penser’ parlan d’Amore (Vita nuova, XIII [6]) 307
giusePPina brunetti
Per un magnifico settenario 331
rosanna brusegan
Una crux della Passione di Ruggeri Apugliese: «bistartoti» 343
eugenio burgio
Achbaluch, «nella provincia del Cataio». (Ramusio, I Viaggi di Messer Marco Polo, II 28, 6-7) 359
rosalba CamPra
Costumbre de Primavera 375
Paolo Canettieri
Politica e gioco alle origini della lirica romanza: il conte di Poitiers, il principe di Blaia e altri cortesi 377
nadia Cannata, maddalena signorini
«Per trionfar o Cesare o poeta»: la corona d’alloro e le insegne del poeta moderno 439
mario CaPaldo
Eine altrussische sagenhafte Erzählung über Attilas Tod 475
maria grazia CaPusso
Forme di intrattenimento dialogato: la tenzone fittizia di Lanfranco Cigala (BdT 282, 4) 491
maria Careri
Una nuova traccia veneta di Folchetto di Marsiglia e Peire Vidal (Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 89) 513
attilio CastelluCCi
La sovrapposizione semantica di morriña e saudade 521
simone Celani
A empresa fornecedora de mitos. Un inedito di Fernando Pessoa tra ironia e mitopoiesi 535
maría luisa Cerrón Puga
¿Espía o traductor? El oficio de Alfonso de Ulloa en Venecia (1552-1570) 543
IndiceVIII
Paolo CherChi
Il rito della visita omaggio al maestro 563
Claudia Cieri Via
Qualche riflessione sull’ekphrasis nell’arte del tardo Quattrocento: da Leon Battista Alberti ad Alfred Gell 581
Fabrizio Cigni
Il lai tristaniano Folie n’est pas vasselage e i suoi contesti (con edizione del manoscritto braidense) 587
mariella Combi
Qualche riflessione antropologica: ri-mappare i sensi e le emozioni 597
anna maria ComPagna
Il sentimento tradotto: da Ausiàs March a Baltasar de Romaní 611
emma Condello
Gentil donsella, l’amourousou visou: un nuovo testo poetico in margine alla scuola poetica siciliana? 627
silVia Conte
Il principiare del canto. Per una nuova edizione di Marcabru, Al departir del brau tempier (BdT 293, 3) 637
Fabrizio Costantini
Su alcune rubriche del canzoniere Laurenziano: paratesto, struttura, metrica 667
marCo Cursi, maurizio Fiorilla
Un ignoto codice trecentesco della Commedia di Dante 687
alFonso d’agostino
Gli occhi di Lisabetta (Decameron IV 5) 703
FranCo d’intino
Raccontare lo Zibaldone 721
silVia de laude
«Is Cardinal Roncalli still alive?». Sull’edizione italiana di Mimesis di Erich Auerbach 733
gabriella de marCo
I luoghi del fare arte. L’atelier dell’artista tra valorizzazione museografica, pagine di critica d’arte e letteratura 759
Indice IX
tullio de mauro
Dieci neosemie e neologismi d’autore 771
silVia de santis
La similitudo dantesca nelle illustrazioni di William Blake 775
gioVannella desideri
La guerra ’15-’18 di Cacciaguida (ancora su Fortuna in Dante) 793
roCCo distilo
Sguardi sul vocabolario trobadorico: lessemi e rime (fra ansa, ensa e ilh, ilha) 809
Carlo donà
Marie de France, Alfredo e la scrittura dell’Esope 825
luCiano Formisano
«Dantis erat»: notula sul Fiore di Marin Sanudo 837
anatole Pierre Fuksas
La cobla tensonada e la “dama del torto” di Peire Rogier 843
massimiliano gaggero
L’épée brisée dans le Conte du Graal et ses Continuations 855
gaia gubbini
Amor de lonh: Jaufre Rudel, Agostino e la tradizione monastica 885
saVerio guida
Tremoleta.l Catalas (BdT 305, 16, v. 49) = Pons d’Ortafa? 893
tomo ii
marCo inFurna
Ideali cavallereschi in Valpadana: il Roman d’Hector et Hercule e l’Entrée d’Espagne 931
annalisa landolFi
La “finta innocenza” di Alberico. Qualche nota sul prologo del Frammento su Alessandro 945
lino leonardi
Postilla a una postilla inedita (di Gianfranco Contini) su Federico II 967
IndiceX
moniCa longobardi
Una traducson per Guiraut Riquier 979
lorenzo mainini
Rusticus, civis aut philosophus. Epistemi a confronto, modelli intellettuali e una “memoria dantesca” nel de Summo bono di Lorenzo de’ Medici 991
mario manCini
«Qu’il fet bon de tout essaier» (Roman de la rose, v. 21521) 1015
Paolo maninChedda
Amore e politica: una variante del dualismo europeo 1031
luigi marinelli
Tra canone e molteplicità: letteratura e minoranze 1041
sabina marinetti
L’altra interpretazione di «voce» e «vello» 1057
Paolo matthiae
Materia epica preomerica nell’Anatolia hittita. Il Canto della liberazione e la conquista di Ebla 1075
maria luisa meneghetti
Sordello, perché… Il nodo attanziale di Purgatorio VI (e VII-VIII) 1091
roberto merCuri
La morte del poeta 1103
Camilla miglio, domeniCo ingenito
Ḥāfez, Hammer e Goethe. La forma ghazal: Weltliteratur e contemporaneità 1109
luisa miglio
Ernesto Monaci, Vincenzo Federici, il Gabinetto di Paleografia e la Collezione manoscritta 1127
laura minerVini
Gli altri Siciliani: il poema sul Sacrificio di Isacco in caratteri ebraici 1139
mira moCan
Un cuore così illuminato. Etica e armonia del canto nella poesia dei trovatori (Bernart de Ventadorn, Marcabru, Raimbaut d’Aurenga) 1155
sonia netto salomão
Carlos Drummond de Andrade: a Máquina do Mundo em palimpsesto 1177
Indice XI
roberto niColai
Letteratura, generi letterari e canoni: alcune riflessioni 1197
teresa noCita
Loci critici della tradizione decameroniana 1205
sandro orlando
Un sonetto del Trecento su Bonifacio VIII 1211
mario Pagano
Un singolare testimone del Testament di Jean de Meun: ms. Paris, B.N., fr. 12483 1221
gioia Paradisi
Materiali per una ricerca su Petrarca e le emozioni («spes seu cupiditas», «gaudium», «metus» e «dolor») 1239
niColò Pasero
L’amor cortese: modello, metafora, progetto 1263
rienzo Pellegrini
Pasolini traduttore di Georg Trakl 1271
silVano Peloso
Letteratura, filologia e complessità: il caso del Brasile 1289
gianFeliCe Peron
Realtà zoologica e tradizione letteraria: il “gatto padule” 1299
Vanda Perretta
Nostalgia di buone maniere 1315
marCo PiCCat
La novella dei tre pappagalli 1325
antonio Pioletti
Cercando quale Europa. Appunti per un canone euromediterraneo 1335
mauro Ponzi
Goethe e gli “oggetti significativi” del cambiamento epocale 1347
norbert Von PrellWitz
Quando il canone dipende dai centimetri 1365
Carlo Pulsoni, antonio Ciaralli
Tra Italia e Spagna: il Petrarca postillato Esp. 38-8º della Biblioteca de Catalunya di Barcellona (primi appunti) 1371
IndiceXII
arianna Punzi
Quando il personaggio esce dal libro: il caso di Galeotto signore delle isole lontane 1395
gioVanni ragone
L’occhio e il simulatore 1423
roberto rea
«Di paura il cor compunto»: teologia della Paura nel prologo dell’Inferno 1433
eugenia rigano
Tra arte e scienza, la bellezza si fa meraviglia 1447
barbara ronChetti
Arte, scienza e tecnica fra immaginazione e realtà. Alcune riflessioni attraverso le pagine di Velimir Chlebnikov 1467
luCiano rossi
Les Contes de Bretaigne entre vanité (charmante) et eternité (précaire) 1491
gioVanna santini
«Or chanterai en plorant». Il pianto di Jehan de Neuville per la morte dell’amata (Linker 145, 6) 1521
maria serena saPegno
«L’Italia dee cercar se stessa». La Storia di De Sanctis tra essere e dover essere 1555
elisabetta sarmati
Metanovela, microficciones e racconti interpolati in El desorden de tu nombre di Juan José Millás 1563
anna maria sCaiola
La passione triste della vergine. Atala di Chateaubriand 1575
emma sColes
«que al que mil extremos tiene / lo extremado le conviene»: il codice cortese fra virtuosismo stilistico e rovesciamento parodico in un Juego de mandar cinquecentesco 1587
luigi seVeri
La resistenza della poesia: costanti petrarchesche e dantesche in Zanzotto 1597
Indice XIII
emanuela sgambati
L’Ars poetica di Feofan Prokopovič fra teoria e prassi 1619
margherita sPamPinato beretta
La violenza verbale nel tardo Medioevo italiano: analisi di corpora documentari 1629
giorgio stabile
Favourite Poet. Alma-Tadema e una promessa in codice per Roberto Antonelli 1647
Justin steinberg
Dante e le leggi dell’infamia 1651
Carla subrizi
«Cercando l’Europa» nel 1945: dolore e follia nei disegni di Antonin Artaud 1661
giusePPe taVani
Codici, testi, edizioni 1673
steFano tortorella
Archi di Costantino a Roma 1703
luisa Valmarin
Una possibile lettura di Năpasta 1721
gisèle Vanhese
Imaginaire du voyage baudelairien et mallarméen dans Asfinţit marin et Ulise de Lucian Blaga 1733
alberto VarVaro
Considerazioni sulla storia della Filologia Romanza in Italia 1747
sergio Vatteroni
«Il mistero del nome». Sull’essenza della poesia nel giovane Pasolini 1751
riCCardo Viel
La tenzone tra Re Riccardo e il Delfino d’Alvernia: liriche d’oc e d’oïl a contatto 1761
Claudia Villa
Un oracolo e una ragazza: Dante fra Moroello e la gozzuta alpigina 1787
IndiceXIV
maurizio Virdis
Un Medioevo trasposto: il Perceval di Eric Rohmer. Dalla scrittura letteraria alla rappresentazione cinematografica 1799
hayden White
History and Literature 1811
Claudio zambianChi
Marionette o dei: qualche riflessione su un saggio di Kleist 1817
Carmelo zilli
Su un “errore d’autore” nel Poemetto di Lelio Manfredi 1829
Bibliografia degli scritti di Roberto Antonelli 1835
attilio CastelluCCi
La sovrapposizione semantica di morriña e saudade
Questo breve saggio nasce da una riflessione; non una ricerca compiuta, pertan-to, ma al contrario un punto di partenza per futuri approfondimenti. Sappiamo tutti che il tratto forse più distintivo del popolo galego è la morriña; non si tratta sempli-cemente di un luogo comune, ma anzi di una caratterizzazione accettata dagli stessi galeghi. Però se è chiaro a tutti cos’è la morriña, allora che bisogno c’è di un’altra parola che esprima lo stesso concetto? Sto parlando naturalmente della saudade, lemma che convive a fianco a morriña, ricoprendo lo stesso ambito semasiologico. Perché se guardiamo i dizionari, anche i più antichi, il significato è lo stesso, direi quasi esattamente lo stesso, per i due lemmi. Una vera e propria sovrapposizione semantica, appunto. Anche se forse la domanda andrebbe invertita. Infatti è saudade la parola che troviamo attestata per prima come espressione dello stato d’animo, del modo di essere degli abitanti della Galizia.
Analizziamo anzitutto il campo semantico dei due lemmi. L’ho fatto utilizzando i dizionari d’uso più diffusi, semplicemente per verificare se ci fosse o meno qualche differenza, anche solo una sfumatura, nell’accezione e nel significato delle due parole.
Morriña Saudade
(Real Academia Galega, Dicionario da Lingua galega)
(1) s.f. Sentimento e estado de ánimo melan-cólico e depresivo, en particular o causado pola nostalxia da terra. Sentía moita morriña no estranxeiro. Nos días de chuvia éntrame a morriña. cf. soidade, señardade.
s.f. Lit. sin. soidade, señardade. cf. mor-riña, nostalxia
(Obradoiro-Santillana, Diccionario da lingua galega, Vigo 1995)
(1) s.f. Sentimento de tristeza que ten unha persoa ó lembrar algo que xa non existe ou está lonxe. Sin. Melancolía, nostalxia. Fam. Morriñento, Morriñoso.
s.f. Sensación de pena mesturada con melan-colía por alguén ou algo que xa non existe ou non está connosco: Lembra os anos mozos con saudade. Sin. Morriña, soidade, nostal-xia, señardade. Fam. Saudoso.
Attilio Castellucci522
(B. Ledo Cabido, Dicionario de galego, Vigo 2004)
(1) s.f. Sentimento nostálxico causado por algo ou alguén ausente.
s.f. Sentimento de tristeza provocado pola ausencia de algo ou alguén moi querido ou por estar lonxe da terra.
Credo sia sufficiente. A una prima occhiata, non mi sembra che ci siano grosse differenze; anzi, mi sembra non ce ne sia nessuna, sia pur sfumata. Il dizionario della Real Academia Galega addirittura rimanda a morriña per la definizione di saudade. Gli altri due hanno definizioni perfettamente intercambiabili, a mio avviso. Allora sono andato indietro e ho deciso di consultare i dizionari storici che avevo a disposi-zione. Vediamo rapidamente:
Morriña Saudade
(Pintos, 1865)
Morriña Tristeza que causa la memoria de un bien perdido, o ausente, ansiedad.
(Valladares, 1884)
Morrina, cierta epidemia en los ganados.Melancolía. Refrs: O que quèira comer mor-riña, coma carneiro en janeiro e en mayo ga-liña. O que n’a sua casa còme morriña, n’a allea, quère carneiro e galiña.
(Manca)
(Filgueira, 1926)
sf. Melancolía, nostalgia. Morriña. sf. Recuerdo, nostalgia, añoranza.
(Eladio, 1958-1961)
s. f. Melancolía, nostalgia, depresión del ánimo por estar ausente de la tierra nativa; SAUDADE.
Murria, especie de tristeza que produce cier-to abatimiento.
Enfermedad que impide a los gatos el desar-rollo, según creencia vulgar; RABUXA.
Comalia, especie de hidropesía del ganado lanar.
s. f. Recuerdo, nostalgia, añoranza.
Ansiedad moral que los gallegos llevamos dentro de nosotros mismos y que es herencia de raza.
Esperanza de un bien futuro que se anhela y se juzga irrealizable.
Deseo vehemente y atormentado de lo imposible e indefinido.
La sovrapposizione semantica di morriña e saudade 523
Empléase además, como adj. con la equi-valencia de miedoso, cobarde, acoquinado, falto de ánimo: eres un morriña.
La MORRIÑA es una enfermedad moral que sentimos los gallegos al vernos lejos de nuestra tierra nativa y del CURRUNCHO en que pasamos nuestros primeros años. Este sentimiento íntimo no puede apartarse del recuerdo; y así del gallego que lo sufre con más o menos intensidad suele decirse que entrou a morriña nél.
Añoranza, pena causada en el ánimo por la ausencia de la patria, de la tierra nativa y de la aldea en que uno nació; MORRIÑA.
La SAUDADE, en realidad, es un sentimiento inexplicable, que no se sabe de donde viene, ni se alcanza a donde va, ni se comprende lo que persigue. Es algo parecido al “Muero porque no muero” de Santa Teresa de Jesús. Ya dijo Rosalía Castro de la joven aldeana por alá garda non sei donde saudades de non sei cándo. Y así es. Las saudades vienen non sei cando; pero vienen también de non sei onde, y de non sei qué. Esta imprecisión es precisamente lo que caracteriza la SAUDADE.
(Carré, 1974)
s. f. Nostalgia. Tristeza. Melancolía. V. Sau-Melancolía. V. Sau-dade. Enfermedad leve. Murria.
Saudade s. f. Recuerdo melancólico de lo que pasó o de lo que se desea. Mal de ausencia. Añoranza. Nostalgia. V. Morriña.
(Constantino, 1985)
f. 1. (Cab. Fea. Cur. Com. Gro. Mra. Gud. Mez. Vil.), murriña (Goi.) nostalgia, tristeza;
f. (Com.) pena, nostalgia.
Anche qui, come si vede, fin dal 1865, le definizioni sono pressoché intercam-biabili. Insomma, non è affatto possibile delimitare il campo semantico in modo da stabilire dove finisca quello coperto da una definizione e dove cominci quello dell’altra.
In linea di principio, per le parole importanti, quelle che come in questo caso caratterizzano un popolo, di norma non dovrebbero esistere sinonimie. Tutto è pos-sibile, naturalmente, ma quando un lemma è così profondamente insito in una tradi-zione culturale, così ben definito e strutturato, non dovrebbe esisterne un altro che ne invada lo stesso campo semantico. Almeno ipoteticamente, perché i dati in questo caso sembrano dimostrare il contrario. Per questo ho sempre trovato così strano che in galego esistessero due parole che indicassero la peculiarità forse più marcata degli abitanti della Galizia.
Certo, si intende saudade come la forma colta, morriña quella popolare. Ma anche questo non convince. Perché se già esiste, fin da epoca remota, un determinato termine, è difficile che ne venga coniato, a livello popolare, un altro. Soprattutto tenendo conto che i testi che veicolano quel particolare termine, oltre che antichi, erano di conoscenza diffusa in tutta la popolazione, a qualunque livello culturale e sociale; stiamo ovviamente parlando delle cantigas. Io sono profondamente convin-to che la fruizione delle cantigas era estesa a tutti i livelli della popolazione, grazie al
Attilio Castellucci524
lavoro di diffusione di cantastorie e giullari in occasione delle feste e degli spettacoli di corte.
Allora ho deciso di fare un ulteriore passo indietro e di andare a cercare le prime attestazioni dei due termini. Naturalmente, se diamo per scontato che saudade sia la variante colta, non sorprende che sia anche la prima attestata per iscritto. Nelle sue varianti più antiche, è ovvio, ovvero soidade; ma anche suidade e soedade. Tuttavia il lemma va inteso non nel suo significato etimologico, ovvero “circunstancia de estar só ou o sentimento provocado por esa circunstancia”, ma in quello più evoluto, quello che ci interessa in questa mia riflessione, di sinonimo di morriña, saudade, nostálxia, ecc.
La prima attestazione di saudade nell’accezione che ci interessa è di norma con-siderata quella di Don Duarte che nel suo Leal Conselheiro afferma: «suidade pro-priamente he sentido que o coraçom filha por se achar partido da presença d’algùa pessoa ou pessoas que muito per afeiçom ama, ou espera cedo de seer [partido]». Normalmente la data ante quem per la composizione dell’opera del re portoghese è il 1438, che coincide con quella di morte del sovrano.
Ma esistono, in realtà, precedenti attestazioni che è importante vedere nel det-taglio. Non di tutte è possibile stabilire con esattezza la data di composizione, ma la loro analisi è comunque illuminante.1
Don Denis (B 578, V 181)Nom poss’ eu, meu amigo,com vossa soidade viver, bem vo-lo digo;e por esto morade,amigo, u mi possadesfalar, e me vejades.(RM 25, 52)
Origine: portoghese. Nipote di Alfonso X. Nato nel 1261. Attivo tra il 1279 e il 1325.
Don Denis (B 526a, V 119)Que soidade de mha senhor ei quando me nembra d’ ela qual a vi,e que me nembra que bem a oifalar; e por quanto bem d’ ela sei,rog’ eu a Deus que end’ a o poder,que mh a leixe, se lhi prouguer, veer(RM 25, 100)
Estevan da Guarda (B 619, V 220)Ora, senhor, tenho muyt’ aguysadode sofrer coita grand’ e gran deseio,
1. I testi delle cantigas profane sono tratti da: Lírica profana galego-portuguesa, a c. di M. Brea, Santiago de Compostela 1996. I testi delle cantigas de Santa María sono tratti da: Cantigas de Santa Maria, a c. di W. Mettmann, Coimbra 1959.
La sovrapposizione semantica di morriña e saudade 525
poys, du vos fordes, eu for alongadoe vos non vir, como vos ora veio;e, mha senhor, est’ é gran mal sobeiomeu et meu gran quebranto:seer eu de vos, por vos servir quantoposso, mui desamado.Deseg’ e coita e gran soidade conven senhor, de sofrer todavia,poys, du vos fordes, i a gran beldadevoss’ eu non vir, que vi en grave dia;e, mha senhor, en gran ben vos terriade me darde-la morteca de viver eu en coita tan forteet en tal estraidade.(RM 30, 23)
Origine: portoghese. Fedele di Don Denis, viveva alla sua corte come scrivano tra il 1299 e il 1325. Nato intorno al 1280. Morto tra il 1362-1364. Attivo tra il 1325 e il 1350.
Fernan Fernandez Cogominho (B 702, V 303)Non queredes viver migoe moiro con soidade, mais veeredes, amigo,pois que vos digu’ eu verdade,ca sodes mal conselhadode mi sair de mandado.(RM 40, 3)
Origine: portoghese. Attivo tra il 1250 e il 1275, abbiamo documenti da lui firmati. Muore tra il 1274 e il 1278.
Johan Zorro (B 1156, V 758)Met’ el-rey barcas no rio forte;quen amig’ á que Deus lh’ o amostre:alá vay, madr’, ond’ ey suidade!Met’ el-rey barcas na Estremadura;quen amig’ á que Deus lh’ o aduga:alá vay, madr’, ond’ ey suidade! (RM 83, 6)
Origine: probabilmente portoghese. Tuttavia compare nel Cancioneiro de Xograres Ga-legos, il che mette in dubbio l’origine. Attivo tra il 1279 e il 1325.
Lopo Liáns (B 1356, V 964)Á dona Maria soydade, Á dona Maria soydade,ca perdeu aquel jograr...dizendo d’ el ben; e el non achou
Attilio Castellucci526
que nen un preito d’ el fosse movernen ben nen mal, e triste se tornou.(RM 87, 3)
Origine: galega, probabilmente originario di Santa Eulalia de Liáns, Oleiros provincia di Coruña. Attivo tra il 1250 e il 1270, forse già nel 1240.
Nun´Eanes Cêrzeo (B 135)Pero das terras averei soidade de que m’ or’ ei a partir despagado;e sempr’ i tornará o meu cuidadopor quanto ben vi eu en elas ja;ca ja por al nunca me veeránulh’ ome ir triste nen desconortado.(RM 104, 1)
Origine: galega, nell’attuale Santiago de Cêrcio, concello di Lalín. Attivo tra il 1220 e il 1260. Morto intorno al 1265.
Pero da Ponte (B 1655, V 1189)Pero un cavaleiro sei eu, par caridade,que vos ajudari’ a tolher d’ el soidade; ¿mais queredes que vos diga ende ben verdade?:non est rei nen conde, mais é-x’ outra podestade,(RM 120, 27)
Origine: probabilmente galega. Attivo tra il 1235 e il 1275.
Pero Larouco (B 612, V 214)De vós, senhor, quer’ eu dizer verdade,e non ja sobr’ o amor que vos ei:senhor é ben a vossa torpidadede quantas outras eno mundo sei;assi de fea come de maldadenon vos vence oje senon filha dun rei.Eu non vos amo nen me perdereiu vos non vir, por vós, de soidade. (RM 130, 1)
Origine: probabilmente portoghese, più che altro per la sua collocazione nei manoscritti.Attivo tra il 1280 e il 1310.
Sancho Sanchez, clérigo (B 939, V 527)Ben vos dig’, amiga, en verdadeque jurei de nunca lhi fazer benant’ el, e non se leixou de s’ ir por en,mais, porque ei del gran soidade, se veess’ én, ja lh’ eu perdoaria(RM 150, 7)
La sovrapposizione semantica di morriña e saudade 527
Origine: probabilmente galega, per la sua produzione inserita nel Cancioneiro de poe-tas-clérigos. Attivo tra il 1280 e il 1315.
Cantigas de Santa MariaCSM 48
Esta é como Santa Maria tolleu a agua da fonte ao cavaleiro, en cuja erdade estava, e a deu aos frades de Monssarrad a que a el queria vender. (…)Pois ssa oraçon fezeron, a Sennor de piadade fez que sse canbiou a fonte ben dentro na sa erdade dos monges, que ant’ avian da agua gran soidade, e des alia adeante foron dela avondosos.
CSM 67Como Santa Maria fez connoçer ao ome bõo que tragia o demo consigo por serven-te; e quisera-o matar, senon pola oraçon que dizia. (…)Quand’ aquest’ oyu o bispo, preguntou-lle que om’ era. E ele lle contou todo, de com’ a ele vera e como lle lealmente sempre serviço fereza. Diss’ o bispo: «Venna logo, ca de veer-l’ ei soydade».
CSM 379[C]omo Santa Maria do Porto se vengou dos cos[s]arios do mar que roubavan os omees que viin[n]an pobrar en aquela sa vila.
Dest’ avo no gran Porto que el Rey pobrar mandava,que é de Santa Maria, en que el muito punnavade fazer y bõa vila; poren termino lle davagrande per mar e per terra, ca logar é dos melloresA que deffende do demo as almas dos pecadores...
Do mundo pera gran vila fazer ou mui gran çibdade.E el Rey de veer esto avia gran soidade;poren quanto lle pediam lles dava de voontade,en tal que pobrar vessen y mui ricos mercadores.A que deffende do demo as almas dos pecadores
Composte tra il 1250 e il 1280.
Dalla lettura di queste cantigas, il primo dato che si evince è che il termine doveva già essere ampiamente diffuso e soprattutto di uso comune: infatti appare in tutti i generi della lirica delle origini, ovvero nelle cantigas de amor, nelle cantigas de amigo, nelle cantigas de escarnio e maldizer e nelle cantigas de Santa María. Dunque nei generi sia profani, sia religiosi; in pratica in tutta la produzione.
Vediamo in quali cantigas il termine viene usato nell’accezione che ci interessa e in quali viene invece semplicemente usato con il significato etimologico di ‘estar só’.
Attilio Castellucci528
Non sempre è facile distinguere tra l’una e l’altra accezione, sia chiaro; discendono dallo stesso lemma latino seguendo un’unica linea evolutiva e il significato ha acqui-sito sfumature diverse solo in un momento successivo, dunque è normale che a volte le due accezioni siano, almeno in parte, sovrapponibili: sono solo in quanto mi manca qualcuno o qualcosa e identifico questa assenza o mancanza con la “nostalgia”.
In Don Denis (B 578, V 181) «Nom poss’ eu, meu amigo, / com vossa soidade / viver» il senso sembrerebbe essere ‘Amico mio, non posso vivere con la nostalgia di voi’, cioè corrisponderebbe al significato che ci interessa, anche se potrebbe essere pure inteso come ‘Amico mio, non posso vivere solo senza di voi’, nell’accezione di solitudine e in questo caso sarebbe fuori dal campo semantico in analisi. Stessa ambiguità nel secondo esempio di Don Denis (B 526a, V 119) «Que soidade de mha senhor ei / quando me nembra d’ ela qual a vi / e que me nembra que bem a oi / fa-lar», dove potremmo intendere ‘Quanta nostalgia ho della mia Signora quando mi ricordo di come l’ho vista e di come l’ho sentita parlare’, pur se anche qui al posto di nostalgia potremmo intendere il senso di solitudine del trovatore.
Ambiguo anche il caso di Estevan da Guarda (B 619, V 220) «Deseg’ e coita e gran soidade / conven senhor, de sofrer» dove qui mi sembra più probabile che il poeta si senta solo senza la dama, soffrendo ‘desiderio, pene e grande solitudine’; pur tuttavia anche qui potrebbe essere ‘desiderio, pene e grande nostalgia’.
Nel terzo trovatore Fernan Fernandez Cogominho (B 702, V 303) «Non quere-des viver migo / e moiro con soidade» mi sembra abbastanza chiaro il senso di ‘Non volete vivere con me e muoio in solitudine’, quindi lo escluderei.
Ambiguo anche il refran di Johan Zorro (B 1156, V 758), il cui «alá vay, madr’, ond’ ey suidade» potrebbe essere reso sia con ‘va lì, madre, dove ho solitudine’ sia con l’analogo ‘va lì, madre, dove ho malinconia’.
In Lopo Liáns (B 1356, V 964) «Á dona Maria soydade, / ca perdeu aquel jo-grar» il senso è il più difficile da interpretare. Pellegrini ipotizza che possa essere messo in relazione il significato di soydade con il perdeu del terzo verso: «a Donna Maria resta la soydade perché ha perso quel giullare»; in questo caso il senso di soydade sarebbe ancora una volta ambiguo, potendosi adattare ugualmente bene alla frase sia la ‘nostalgia, il senso di mancanza per qualcuno che si è perso’ che rimane a Donna Maria, sia la ‘solitudine’ di lei senza il giullare.
Molto chiaro il senso in Nun´Eanes Cêrzeo (B 135) «Pero das terras averei soi-dade / de que m’ or’ ei a partir despagado» che penso di poter affermare rientri senza ombra di dubbio nel campo semantico della morriña: ‘Ma avrò nostalgia delle terre da cui ora devo partire’.
Anche in Pero da Ponte (B 1655, V 1189) «Pero un cavaleiro sei eu, par carida-de, / que vos ajudari’ a tolher d’ el soidade» potrebbe leggersi un minimo di ambi-guità, anche se personalmente propendo decisamente per una resa ‘Ma io conosco un cavaliere che, per carità, vi aiuterebbe a togliervi la nostalgia di lui’.
Ancora ambiguità riscontriamo in Pero Larouco (B 612, V 214) «Eu non vos amo nen me perderei / u vos non vir, por vós, de soidade» dove interpreterei ugual-mente bene ‘Non vi amo e se non vi vedrò non mi perderò in solitudine per voi’ quanto ‘Non vi amo e se non vi vedrò non mi perderò in nostalgia per voi’.
La sovrapposizione semantica di morriña e saudade 529
Ancora un’interpretazione al limite delle due possibilità in Sancho Sanchez, clérigo (B 939, V 527) «mais, porque ei del gran soidade, / se veess’ én, ja lh’ eu perdoaria», dove tuttavia sarei assolutamente propenso a intendere ‘Ma poiché ho grande nostalgia di lui, se lo vedessi lo perdonerei’ piuttosto che ‘ma poiché per lui provo grande solitudine, se lo vedessi lo perdonerei’.
Indubbio invece il significato nelle tre Cantigas di Santa Maria. Nella pri-ma, CSM 48, «dos monges, que ant’ avian da agua gran soidade, / e des alia adeante foron dela avondosos» è direi evidente che i ‘monaci prima sentivano la mancanza dell’acqua, che da allora in poi ebbero invece in grande abbondanza’; dunque rientra appieno nel campo semantico della ‘nostalgia’, della morriña, il senso di mancanza per qualcosa che non si ha o non si ha più. Lo stesso direi per il secondo esempio, CSM 67, «Diss’ o bispo: “Venna logo, ca de veer-l’ ei soydade”» dove interpreterei ‘il vescovo disse: Venga dunque, che ho molta vo-glia, sento il desiderio di vederlo’ anche qui con il senso di sentire la mancanza, sentire il desiderio di qualcosa. Anche nel terzo esempio il discorso non cambia; infatti in CSM 379 «E el Rey de veer esto avia gran soidade» dove direi che pos-siamo senza dubbio leggere che ‘il Re aveva grande nostalgia di vederlo’. Per cui in tutti e tre i casi individuati in Alfonso X salta agli occhi il significato di ‘sentire la mancanza, avere nostalgia’ di qualcosa o di qualcuno.
Anzitutto va ribadito che il termine soidade doveva già essere diffuso nell’acce-zione di ‘nostalgia’, morriña, in contrapposizione a quella di ‘solitudine’, in quanto le occorrenze, se pur non numerosissime, sono comunque significative; ma soprat-tutto, come indicavo prima e come nota anche Yara Frateschi Vieira,2 appare in tutti i generi, sia profani (cantigas de amor, cantigas de amigo e cantigas de escarnio) sia religiosi (Cantigas de Santa Maria) a indicare che non si tratta dell’uso estempora-neo in un genere piuttosto che in un altro.
Mi rifarei, a questo punto, a quanto dice Tavani:(…) Sabido é que as ciencias, incluso as filolóxicas, coñeceron no século pasado unha evolución considerable das teorías e das prácticas metodolóxicas, (…); non obstante, é sabido tamén canto pode influír negativamente na recepción das novas ideas unha certa reticencia diante das innova-cións, alimentada polo que os físicos chaman “principio de inercia”, é dicir, a inclinación a deixar as cousas correr segundo a praxe consuetudinaria, rexeitando, consciente ou inconscientemente, ou simplemente ignorando, calquera hipótese de alteración desa praxe. A ese principio de inercia obedece tamén o uso da expresión “galego-portuguesa” (ou gallego-portuguesa, ou galaico-portu-guesa) para designar a produción lírica do oeste peninsular da Idade Media: (…) unha imprecisión terminolóxica que, en efecto, non ten sentido. Nos meus últimos traballos, xa emendei en parte esa expresión cando se aplicaba aos poetas: falar de trobadores e xograres galego-portugueses ten aínda menos sentido que falar de poesía galego-portuguesa, porque os poetas eran ou galegos ou portugueses, e incluso podían ser casteláns ou doutras rexións hispánicas, sen por iso deixar de ser trobadores ou xograres en galego ou en portugués. É verdade que a denominación de “poesía galego-portuguesa” pode, ou podería, xustificarse aducindo a existencia efectiva, como mínimo ata a metade do século XIII, dunha área cultural común ás dúas modalidades lingüísticas, ou polo menos dalgunhas analoxías entre dúas áreas afíns; mais é tamén verdade que entre os poetas oriúndos dun lado ou doutro do río Miño existían diferenzas notables, (…) desde o punto de vista
2. Y. Frateschi Vieira, A soidade/suidade na lírica galego-portuguesa, in Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero, reunidos e editados por José Luís Rodríguez, II, Literatura Miscelánea, Santiago de Compostela 2000, pp. 807-824.
Attilio Castellucci530
temático, expresivo, simbólico e ata lingüístico, integrados como estaban – uns e outros – en siste-mas sociopolíticos, e ata certo punto mesmo culturais, que non sempre coincidían (…)3
Concordo in pieno: non ha senso parlare di trovatori galego-portoghesi; i trova-tori sono galeghi o sono portoghesi. Ciascuno con un suo bagaglio culturale e lingui-stico ben definito e consolidato, già all’epoca di cui ci stiamo occupando.
In altre parole, siamo di fronte a trovatori che avevano una Weltanschauung, un retroterra culturale che non era lo stesso per tutti e che si rifletteva, oltre che nella loro espressione linguistica, anche in quella tematica e simbolica. E difficilmente riesco a pensare a qualcosa di più espressivo e simbolico, linguisticamente, che ri-specchi una visione del mondo di un popolo come fanno morriña o soidade.
Vediamo, pertanto, come si distribuisce il termine, nelle sue varianti, nel territo-rio, fra i trovatori galeghi e fra i trovatori portoghesi.
Prima, però, una precisazione metodologica. Quello che faccio è lavorare con i dati in mio possesso. Le nostre teorie, le nostre ricostruzioni testuali, sono sempre e solo ipotesi, basate sui dati che si posseggono al momento in cui le elaboriamo. Nel nostro caso specifico, si tratta di dati che hanno quasi mille anni, per cui certezze in proposito non ne esistono. A volte capita che nuovi dati emersi da nuovi studi, nuo-ve scoperte di vecchi testi possano mettere in discussione o addirittura ribaltare le nostre ipotesi. Per cui anche in questo caso le attribuzioni all’una o all’altra sponda del fiume Miño vengono fatte esclusivamente sulla base delle conoscenze di cui at-tualmente disponiamo e sugli studi fino ad oggi condotti.
Nun´Eanes Cêrzeo. In questo caso, possiamo affermare con una certa sicu-rezza che si tratti senza dubbio di un autore di origine galega, attivo nella prima metà del XIII secolo. Apparteneva infatti alla stirpe dei Cêrzeo, che prendono il nome dall’omonima località, oggi Santiago di Cêrcio, presso Lalin. La famiglia possedeva un notevole patrimonio che girava intorno ai monasteri di Oseira, Carboeiro e Vilar de Donas, nella regione oggi compresa dalle province di Ou-rense, Lugo e Pontevedra. Doveva essere fratello di Pedro Eanes e Urraca Eanes, citati in documenti rispettivamente del 1282 e del 1268-1275. I documenti rive-lano anche che aveva due figli, Afonso e Gonçalvo Nunez, che troviamo a Sivi-glia (1268) e Badajoz (1270), il che potrebbe far supporre che abbia partecipato alla Reconquista andalusa e che finì per stabilirsi in quelle terre. Alcuni studiosi hanno anche ipotizzato che un omonimo del nostro trovatore, individuato tra Siviglia e Jerez, sia in realtà proprio il nostro poeta. Per la vicinanza geografica, è possibile una sua relazione con la famiglia dei Taveiros, nel quadro concreto della corte dei Traba, ai tempi di Rodrigo Gomez de Trastamara. In alcuni docu-menti si parla anche di un «Johan Garcia que es cabeçaleyro de nuestro padre», che può essere identificato con il Johan Garcia nipote di Nun’Eanes dei canzo-nieri. Morì intorno al 1265.
3. G. Tavani, Unha provenza hispánica. A Galicia medieval, forxa da poesía lírica peninsular. Discurso lido o día 22 de maio de 2004, no acto da súa recepción como académico de honra, polo excelentísimo señor don Giuseppe Tavani e resposta do excelentísimo señor don Ramón Lorenzo, A Coruña 2004, p. XX.
La sovrapposizione semantica di morriña e saudade 531
Lopo Liáns. Si tratta di un trovatore molto probabilmente di origine galega. Era un cavaliere verosimilmente nativo della zona di Santa Eulalia de Liáns, Oleiros, in provincia di A Coruña. Corrobora la tesi della sua origine galega l’aver svolto la sua attività in ambienti signorili galeghi, tra la metà o forse la fine del XIII secolo. Johan Romeu, autore di Lugo, lo attacca inoltre in una delle sue cantigas.
Pero da Ponte. Molto probabilmente autore di origine galega. Giullare, forse scu-diero, era attivo tra il 1235, data in cui abbiamo un suo pranto per la regina Beatriz, e il 1257. Ha fatto parte delle corti reali di Fernando III e Afonso X, ma viaggiava spesso presso altre corti signorili. Era in stretta relazione con altri autori, tutti di origine galega, come Afons’ Eanes do Coton e Bernal de Bonaval. Inoltre fece parte del ciclo di attacchi a Maria Balteira e delle satire contro Sueiro Anes e Fernan Diaz.
Sancho Sanchez. Anch’egli probabilmente galego, anche se l’attribuzione nel suo caso è più debole. In realtà si basa sul fatto che le sue cantigas sono inserite nel canzoniere dei “poeti-chierici”. Il che ci porta anche a congetturare che la sua attività si svolga tra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo, ma non sappiamo dove questa si situi esattamente. Supponiamo che sia stato in relazione con i circoli castigliani.
Alfonso X. Di lui sappiamo invece praticamente tutto. Tralasciando il versante sto-rico, che tuttavia lo situa spesso in Galizia, anche la sua produzione, sia profana sia mariana, ci conferma che la sua formazione poetica era fortemente segnata dal sigillo galego. A ciò va aggiunto che la sua corte era il luogo d’incontro privilegiato di trovatori sia galeghi, sia portoghesi, sia provenzali. E non a caso, proprio sotto il suo regno la pro-duzione lirica in galego-portoghese raggiunge il punto di massimo splendore.
Don Denis. Trovatore portoghese, anche di lui conosciamo praticamente tutto, a parti-re dalla genealogia. Figlio di Afonso III del Portogallo e di Beatriz di Castiglia, dunque ni-pote di Afonso X, nacque nel 1261 e fu re del Portogallo fino al 1235, anno della sua morte. Anche la sua corte accoglieva volentieri i trovatori, diventando il centro di sopravvivenza della lirica galego-portoghese. Aveva un maestro francese che lo iniziò al francese e al pro-venzale. Con le sue 137 cantigas giunte fino a noi, è l’autore di cantigas più fecondo.
Estevan da Guarda. Essendo nato appunto a Guarda, in Portogallo, o discen-dendo da una famiglia che prendeva il nome dal toponimo, è assai probabile sia di origine portoghese. Inoltre, è sepolto a Lisbona e lo troviamo alla corte di Don Denis come scrivano reale. Dopo la morte del sovrano, si allontana dalla corte ed è possi-bile che abbia preso parte alla stesura del Livro das Cantigas del Conde de Barcelos. La maggior parte della sua produzione è databile a dopo il 1325.
Fernan Fernandez Cogominho. Figlio di Fernan Guedaz e Maria Fogaça, è anch’egli di origine portoghese. Fu consigliere alla corte di Afonso III ed è sepolto a Coimbra.
Johan Zorro. Sappiamo che era un giullare, ma le sue origini sono incerte. I documenti giunti fino a noi testimoniano che in Portogallo in quel periodo erano attestate ben tre persone dal cognome Zorro, il che ci farebbe propendere per una sua origine portoghese. Tuttavia la sua produzione è inserita nell’ipotetico Canzoniere dei giullari galeghi, cosa che sembrerebbe contraddire la sua origine portoghese. Va
Attilio Castellucci532
detto che nella sua produzione sono frequenti i riferimenti al re del Portogallo e a Lisbona e lo troviamo in Portogallo durante il regno di Don Denis.
Pero Larouco. La sua possibile origine portoghese verrebbe dalla sua posizione nei manoscritti, tra D. Pedro, Estevan Fernandiz d’ Elvas, Estevan da Guarda e Pero d’ Ornelas, oltre che da alcune allusioni nei suoi testi. Fu attivo tra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo.
Parità assoluta, non solo siamo cinque a cinque, per cui il termine sembra uniforme-mente distribuito in tutto il territorio, ma abbiamo anche un monarca per parte, così che ognuna delle due fazioni può essere capeggiata da un re, inserendo Alfonso X tra i trova-tori galeghi per via della lingua poetica utilizzata, naturalmente, e non delle sue origini.
Passiamo allora a una suddivisione ulteriore, probabilmente più interessante. Ordiniamo cronologicamente i trovatori:
Origine galega
Nun´Eanes Cêrzeo 1220-1260Pero da Ponte 1235-1275Lopo Liáns 1250-1270Alfonso X 1250-1280Sancho Sanchez 1280-1315
Origine portoghese
Fernan Fernandez Cogominho 1250-1275Don Denis 1279-1325Johan Zorro 1279-1325Pero Larouco 1280-1310Estevan da Guarda 1325-1350
E qui sì che ci troviamo di fronte a una bella sorpresa. Abbiamo ben due tro-vatori galeghi che usano il lemma soidade assai prima dei colleghi portoghesi, per cui le prime attestazioni del termine sono in trovatori di lingua galega. Non solo, anche il distacco è notevole: in un periodo che abbraccia poco più di 130 anni, dal 1220 al 1350 circa, il primo trovatore galego stacca il primo collega portoghese di ben 30 anni e il secondo di 15 anni. Stiamo parlando di un quarto dell’intero perio-do considerato, una distanza temporale notevole. Ma più in generale, guardando il quadro complessivo dei dieci trovatori presi in considerazione, gli autori di lingua galega usano soidade precocemente rispetto ai trovatori di lingua portoghese; se infatti escludiamo Fernan Fernandez Cogominho, in pratica l’uso in tutti i trovatori portoghesi è posteriore rispetto all’intero insieme degli autori galeghi.
Non solo, il primo trovatore a usare il termine, Nun´Eanes Cêrzeo, è proprio quello in cui il senso del lemma è inequivocabilmente quello moderno, quello che ci interessa prendere in considerazione, in quanto parla di avere soidade di quelle terre da cui si appresta a partire: niente potrebbe essere semanticamente più simile alla morriña che attanaglia i galeghi quando si trovano lontani dalla loro terra.
Le considerazioni appena esposte ci portano inevitabilmente a concludere che il concetto di soidade non nasce in Portogallo, ma in Galizia, fra i trovatori galeghi. So che si tratta di un’affermazione forte, ma mi sto limitando a analizzare i dati, almeno quelli che possediamo oggi. E, sulla scia di quanto affermato da Tavani, il mio invito è quello a non lasciarci trascinare dal «principio di inerzia», ma a voler prendere in considerazione tali dati, non ignorando che si tratta di un’alterazione della prassi.
La sovrapposizione semantica di morriña e saudade 533
Bibliografia minima
I. Alonso Estravís, Dicionário da língua galega, Santiago de Compostela 1995Cantigas de Santa Maria, a c. di W. Mettmann, Coimbra 1959Diccionario de diccionarios, a c. di A. Santamarina, A Coruña 2000Dom Duarte, Leal Conselheiro o qual fez, Lisboa 1942Y. Frateschi Vieira, A soidade/suidade na lírica galego-portuguesa, in Estudos dedicados a
Ricardo Carvalho Calero, reunidos e editados por José Luís Rodríguez, II, Literatura Miscelánea, Santiago de Compostela 2000, pp. 807-824
B. Ledo Cabido, Dicionario de galego, Vigo 2004Lírica profana galego-portuguesa, a c. di M. Brea, Santiago de Compostela 1996A.R. de Oliveira, A cultura trovadoresca no ocidente peninsular: trovadores e jograis gale-
gos, in «Biblos», LXIII (1987), pp. 1-22A.R. de Oliveira, A Galiza e a cultura trovadoresca peninsular, in «Revista de Historia das
Ideias», II (1989), pp. 7-36A.R. de Oliveira, Despois do espectáculo trovadoresco, Lisbona 1994M. Quintáns Suarez Diccionario conceptual galego, Laracha 1997Real Academia Galega, Dicionario da Lingua galega, versione online (http://www.realaca-
demiagalega.org/dicionario/#inicio.do) 30 novembre 2012G. Tavani, Unha provenza hispánica. A Galicia medieval, forxa da poesía lírica peninsular.
Discurso lido o día 22 de maio de 2004, no acto da súa recepción como académico de honra, polo excelentísimo señor don Giuseppe Tavani e resposta do excelentísimo señor don Ramón Lorenzo, A Coruña 2004
X. Xove Ferreiro, Diccionario da lingua galega,Vigo 1995
Manoscritti:
B: Lisboa, Biblioteca Nacional de Lisboa, cod. 10991 (antico Colocci-Brancuti)V: Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Vat. Lat. 4803