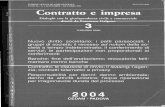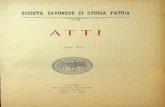La società dell'informazione: un'economia del simbolico
Transcript of La società dell'informazione: un'economia del simbolico
La società dell’informazione: un’economia del simbolico Pier Cesare Rivoltella – Università Cattolica di Milano [in: W.G Scott, M. Murtula, M. Stecco, Manuale di Management, Il Sole24ore, Milano 2002, pp. 139-170] 1. Introduzione
Già da qualche anno la ricerca nel campo delle scienze sociali e della comunicazione descrive la fase che stiamo vivendo come una fase di passaggio dall’età industriale all’età dell’informazione. Questa transizione viene di solito interpretata nel senso di una sostituzione delle tecnologie informatiche alla macchina e alle routines produttive, ma di fatto occorre andare più in profondità nell’analisi. Manuel Castells (1996) suggerisce opportunamente di spostare il discorso dal protagonismo della tecnologia alle modalità attraverso le quali nella società si produce conoscenza e si strutturano i rapporti tra gli individui e i sistemi. In questa prospettiva, l’età industriale cessa di essere identificata con la macchina per sgranare il cotone di Elias Withney, la locomotiva di Stephenson o la meccanizzazione del lavoro, ma designa piuttosto un certo tipo di organizzazione sociale – costruita sul taylorismo – che a partire dai settori-base dell’economia e dell’esercito finisce per permeare ogni sfera dell’attività umana, dalla scuola alla famiglia. Un discorso analogo si può fare per l’età dell’informazione che, se vale il ragionamento di Castells, non va tanto identificata con l’avvento della Information and Communication Technology (ICT), cioè materialmente con l’introduzione dei personal computers o delle reti telematiche, quanto piuttosto con la riorganizzazione sistemica che queste tecnologie inducono a livello sociale. Più che di Information Society il sociologo spagnolo preferisce parlare di Informational Society: nel primo caso l’informazione è un contenuto della società, nel secondo ne definisce la natura stessa. La società dell’informazione (continueremo a usare questo termine avendo ben presente che con esso indichiamo il fenomeno che Castells descrive e non semplicemente la realtà dell’informatizzazione) è un tipo di società in cui l’informazione è la realtà stessa di cui la società si costituisce, è una società “fatta di informazione”: si capirà in che senso nel prossimo paragrafo. Il processo di riorganizzazione che conduce a questa società può essere interpretato in relazione ad almeno tre variabili significative: 1) la velocità degli scambi, dei processi, di invecchiamento del sapere. Le transazioni, infatti, in virtù dell’implementazione delle reti, non fanno più viaggiare i beni ma le informazioni rendendo quasi istantaneo lo scambio; lo stesso vale per le procedure di qualsivoglia tipo, dall’emissione di biglietti di viaggio all’homebanking. La stessa velocità travolge la capacità della conoscenza individuale, capitalizzata nella formazione iniziale attraverso il sistema dell’istruzione, di rispondere adeguatamente sul medio-lungo periodo alle esigenze di una società in cui il ritmo dell’innovazione è come minimo doppio rispetto alla capacità di aggiornamento del sapere; 2) la virtualità, cioè lo sganciamento sempre più chiaro tra lo spazio e il tempo cui si possono ricondurre macro-fenomeni come la mondializzazione delle imprese e dei mercati e micro-pratiche come il telelavoro o il videoconferencing. Sganciamento di spazio e tempo significa emancipare chi trasmette e chi riceve informazioni dalla necessità di essere in uno stesso luogo nello stesso tempo. Il risultato è la possibilità di comunicare real time pur rimanendo in luoghi fisici molto lontani tra loro (come avviene nel videoconferencing) e insieme la flessibilizzazione dei luoghi e dei tempi di accesso all’informazione: basta una qualsiasi postazione Internet, in qualsiasi punto del pianeta, nel tempo che l’utente ritiene più opportuno in relazione alle proprie disponibilità; 3) il networking, cioè il trionfo della metafora della rete come paradigma di spiegazione di buona parte delle nostre pratiche sociali. Da questo punto di vista il nostro tempo registra, pur tra indubbie contraddizioni, un ritorno deciso della dimensione collettiva (o forse sarebbe meglio dire del bisogno della dimensione collettiva): l’intelligenza è collettiva, il lavoro è d’équipe, la cooperazione e la collaborazione sono scenari strategici nei settori più disparati, dall’economia alla didattica. L’elemento della connettività, insomma, si impone come macro-indicatore culturale, come valore
aggiunto, e la diffusione delle reti telematiche non è estranea a questa affermazione producendo un graduale spostamento del baricentro dei processi dalla dimensione locale a quella planetaria: oltre che nello sviluppo dell’economia e nei macrofenomeni politici e sociali (declino dello Stato-nazione, movimenti migratori, ibridazione delle culture) la globalizzazione consiste in buona parte proprio nella facilitazione della circolazione dei significati simbolici che dalla connettività su base telematica dipende. Un insieme di trasformazioni così decisive, nella prospettiva della sociologia della cultura, ha sortito l’effetto di portare in primo piano la conoscenza facendo della sua produzione, elaborazione e trasferimento la fonte principale della produttività e del potere. Una centralità che si articola secondo una catena di tre fenomeni consequenziali l’uno rispetto all’altro: il nuovo protagonismo delle merci simboliche (come dice Baudrillard 1976, la merce nelle società precedenti aveva un valore, oggi il valore è la stessa merce; basta pensare a “oggetti” commerciali come i format televisivi, i servizi internet, o ad attività come le intermediazioni finanziarie o l’advertising); l’ascesa alla ribalta di una nuova categoria di “lavoratori del simbolico” (Neveu, 1994) che attorno alla produzione-circolazione delle merci simboliche costruiscono le loro professionalità (sono lavoratori del simbolico i formatori, come i PR, le diverse figure di consulente, gli esperti di marketing, ecc.); la configurazione di un nuovo bisogno di formazione come risposta alla necessità di dotazione di questo know how. 2. La società dell’informazione, una costruzione sociale In uno dei suoi ultimi lavori, lo storico dei media Armand Mattelart fissa le coordinate per comprendere il significato reale di quanto oggi viene comunemente indicato come “società dell’informazione”. Dice Mattelart: Alla saga tecnologica della conquista dello spazio è subentrata un’altra grande epopea: la conquista della cyber-frontiera. La prima ha creato il cliché di «villaggio globale». La seconda ha appena elaborato la formula di «società globale dell’informazione». L’irresistibile ascesa delle nozioni di «società dell’informazione» e di «età dell’informazione» si è così identificata con la traiettoria folgorante della nomenclatura dell’«era globale». Tra battages promozionali, dichiarazioni ufficiali, manifesti aggiornati e studi più o meno scientifici, c’è tutta una logistica – e un’apologetica – che accompagna in vario modo l’affermazione di tali concetti e ambisce a presentarli come qualcosa di incontestabile (2001; p. 4). Il punto di vista di Mattelart è chiaro. Egli mette in relazione la conquista dello spazio con la diffusione di Internet cogliendo il tratto comune a tutti e due i fenomeni. Si tratta di “conquiste”, per utilizzare una categoria dei sociologi americani Dayan e Katz (1992), entrambe accompagnate (come sempre capita per le conquiste) da un racconto di emancipazione. Ciò che contraddistingue una conquista sono alcuni caratteri legati all’eccezionalità dell’evento che essa rappresenta e all’eroismo degli uomini impegnati a farlo accadere. Più precisamente, una conquista:
q fa riferimento a una situazione apparentemente insolubile e alla necessità di una grande azione per poterla superare;
q individua nel carisma (nel senso weberiano del termine) di alcuni uomini lo strumento per realizzare questo cambiamento;
q in virtù di questa transizione, definisce l’ingresso dell’umanità in un nuovo ordine simbolico.
Proprio quest’ultima caratteristica rende ragione del motivo per cui, di solito, le grandi conquiste sono accompagnate da un racconto di emancipazione. Esso funziona, dal punto di vista sociale,
come strumento di comprensione dell’evento che contribuisce anche a caricarlo di valore simbolico (fino al punto di poter dire che solo grazie a questo racconto diviene possibile cogliere il significato di conquista dell’evento); una funzione che nelle società tradizionali era svolta da aedi, bardi, cantori e che oggi è potentemente rilanciata attraverso i media, dalla carta stampata alla televisione. Si pensi all’allunaggio di Armstrong e Aldrin il 20 luglio del 1969 e al significato che esso viene ad assumere in quel preciso contesto storico: i media lo costruiscono come racconto di emancipazione in relazione alla guerra fredda e alla necessità di affrancare l’umanità dall’angoscia dell’autodistruzione e della penuria delle risorse. Un funzionamento analogo si può riscontrare in relazione ai temi della società dell’informazione. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una conquista ed è facile coglierne le caratteristiche strutturali:
q l’idea della società dell’informazione prende quota nel decennio scorso, cioè in un contesto segnato da grandi trasformazioni e grandi problemi: sul piano geopolitico, la caduta delle ideologie e il superamento della logica dei blocchi contrapposti ha prodotto come conseguenza la moltiplicazione dei conflitti regionali e la disseminazione del potenziale nucleare anche in paesi dotati di scarsa stabilità politica; a livello economico, la necessità di affermare un “capitalismo senza frizioni” diviene sempre più urgente per ridurre, nella distribuzione delle ricchezze, squilibri che facilmente si possono trasformare in altrettanti motivi di conflitto; a livello demografico, infine, il ritmo di crescita inverso tra mondo evoluto e terzo mondo e la conseguente grande mobilità migratoria da questo a quello ha evidenziato il problema di una convivenza adeguata delle differenze a livello sociale e culturale. Siamo, pare di poter dire, perfettamente dentro il caso di una situazione complessa e difficile che solo una grande azione può modificare;
q la società dell’informazione ha i suoi eroi. Vi sono i precursori, come Charles Babbage e Norbert Wiener, gli edificatori materiali, come Bill Gates, i guru che con il loro pensiero ne provvedono una legittimazione, come Nick Negroponte o Kevin Warwick. Attraverso il lavoro, di implementazione e di riflessione, di questi uomini passa la possibilità di trovare risposta ai problemi cui abbiamo appena accennato;
q infine, la società dell’informazione costituisce un nuovo ordine simbolico in grado di bilanciare la regionalizzazione dei conflitti con la predisposizione di un nuovo spazio di dialogo, di provvedere alla pacifica convivenza tra mercato e uguaglianza attraverso le promesse della new economy, di fissare le nuove regole del gioco democratico attraverso l’indicazione proprio nella rete quella nuova agorà in cui rendere possibile l’incontro e la riduzione dei conflitti sociali.
Risulta chiaro subito, da questo tipo di impostazione dell’analisi, come la società dell’informazione, più che come un dato di fatto, vada pensata come il risultato di un paziente lavoro di costruzione sociale. «La futurologia tecnologica – dice ancora Mattelart (2000; p. 68) – allestisce lo scenario che presiede alla costruzione delle idee incaricate di annunciare, se non di spiegare, che l’umanità è alle soglie di una nuova “età dell’informazione”». Di questo scenario fanno parte i tre principali discorsi di emancipazione che accompagnano la penetrazione sociale dell’idea di società dell’informazione. Il primo di questi discorsi è quello della scienza. Mattelart evidenzia molto bene come l’idea di una società dell’informazione sia presente già nella riflessione dei teorici a partire dai primi anni Sessanta, collegata con il tema della caduta delle ideologie. Quella che viene descritta è la nascita di un nuovo modello di società contraddistinta dalla organizzazione (management society) e dalla smaterializzazione del lavoro, dalla sostituzione della labor theory of value con la knowledge theory of value, dal superamento della centralità dell’impresa e dell’uomo di affari verso una nuova centralità delle università e dei centri di ricerca. Per definire questa società viene introdotto l’aggettivo “postindustriale”, poi sostituito, alla fine degli anni Settanta, dalla categoria di “società
dell’informazione”. Di questa società vengono individuati i “padri” nei teorici del pensiero organizzativo: l’utopia tecnocratica di Saint-Simon e il paradigma organizzativo di Taylor indicano nella società funzionale l’esito auspicato dello sviluppo e del progresso. Di tale sviluppo la metafora della rete viene presto indicata come l’indispensabile supporto, prestandosi bene alla rappresentazione di un modello organizzativo decentrato e complesso. L’idea della rete, di una società di (in) rete è al centro anche della seconda categoria di discorsi, quelli previsionali dei futurologi. Gli ultimi vent’anni hanno visto affermarsi la figura e il ruolo sociale dei think thanks, di specialisti cioè che fanno della loro capacità di prevedere gli scenari di sviluppo futuro una vera e propria competenza professionale (professional prognosticators). Tra i più famosi, oltre ad Herman Kahn, Alvin Toffler e al già citato Nicholas Negroponte, va annoverato anche Zbigniew Brzezinski, consigliere per gli affari internazionali sotto la presidenza Carter. A lui si deve la prima intuizione di una “diplomazia delle reti” che avrebbe dovuto gradualmente sostituire la tradizionale diplomazia della forza. Siamo con questo al cuore della terza tipologia di discorsi di accompagnamento della società dell’informazione, quelli che hanno a che fare con la situazione geopolitica del pianeta, segnata dalla lenta dissoluzione dello Stato-nazione, dalla moltiplicazione dei centri, dalla mondializzazione dei processi. Nel momento in cui Brzezinski immaginava un’architettura mondiale volta a dominare la ragione scientifica – vero e proprio freno all’innovazione tecnologica -, i nuovi protagonisti della geoeconomia minavano, in nome della ragione di mercato, le tradizionali fondamenta della geopolitica. E il discorso sul one world da parte delle multinazionali si fondava proprio sulla crescita delle industrie e delle reti d’informazione, capaci di liberare i manager della produzione, i consumatori e i prodotti dal vincolo delle frontiere e di farli interagire su un mercato unico autoregolato, decretando così l’insostenibilità dello Stato-nazione e, di conseguenza, la caducità delle politiche pubbliche (Mattelart, 2000, pp. 87-88). Il risultato delle analisi degli specialisti, delle previsioni del marketing, degli scenari politici internazionali socializzati dall’immaginario televisivo è la percezione che la società dell’informazione sia qualcosa di “incontestabile”, che con essa si sia entrati in una nuova fase dell’economia e della storia, che nulla possa più essere come prima. Se il NASDAQ sale, quanto dipende dalla forza reale delle imprese del comparto informatico e quanto dalla fiducia che rimbalza dalle riviste di settore e dai pareri degli opinion makers? Dipendere dagli umori del mercato è una vecchia legge della Borsa, ma nel caso della società dell’informazione e della new economy essa acquista un nuovo interessante significato: diviene l’immagine speculare di una società che proprio dell’informazione è costituita. Qui si misura quanto in apertura sottolineavamo Nel corso della nostra analisi questo aspetto sarà sottolineato attraverso il ricorso alla categoria del simbolico 3. Velocità, virtualità, networking Se pare innegabile, almeno dall’analisi che abbiamo fin qui condotto, che l’imporsi dell’idea di una società di rete sia in buona parte giocato su un dispositivo mitologico in cui è difficile distinguere ciò che è frutto di costruzione da quanto invece accade realmente, d’altra parte le trasformazioni del mercato e della produzione che le reti telematiche e il loro portato organizzativo hanno prodotto insieme alla comparsa di nuove professioni e di nuovi rapporti sociali non c’è dubbio che siano fatti reali: senza queste condizioni, di società dell’informazione non si potrebbe parlare nemmeno in presenza del lavoro di costruzione del mito di questa società prodotto dai media. Come anticipato in introduzione tre sono gli aspetti che a questo riguardo pare di dover evidenziare: la velocità, la virtualità e il networking nella sua capacità di produrre e sostenere la globalizzazione.
3.1. Velocità La velocità segna almeno in tre sensi, tra loro strettamente connessi, lo sviluppo delle reti telematiche e il loro impatto sull’organizzazione sociale. In primo luogo produce una compressione dei tempi e un annullamento delle distanze. In questa prospettiva le reti telematiche costituiscono ad un tempo un salto in avanti decisivo e un’inversione nella storia delle tecnologie di comunicazione. Infatti, fino ad ora, l’abbattimento delle distanze era stato realizzato attraverso il progressivo aumento della velocità: il cavallo è più veloce di un uomo che cammina, il motore a scoppio più del cavallo, l’aereo più dei veicoli che si muovono a terra. In sostanza abbattere le distanze significava, in tutti questi casi, aumentare la velocità del trasferimento, rendere più potente il mezzo di trasporto. Internet, in questa logica, si afferma subito come il mezzo più rapido, dal momento che la velocità del trasferimento è quasi prossima all’istante, ma questa incredibile velocità è ottenuta solo perché a viaggiare è l’informazione. In sostanza il massimo della velocità possibile consiste nel non muoversi e nel far sì che tutto parta da e tutto arrivi dove ci si trova. Lo si capisce bene se si pensa all’immagine del “giornalismo seduto” introdotta dalla sociologia dei media per fotografare il modo sempre più frequente di fare giornalismo oggi: si tratta di un giornalismo che «si allontana dai fatti nello stesso tempo in cui diviene tributario di un ristretto numero di fonti istituzionali. Un giornalista di un settimanale che ha cessato le sue pubblicazioni, osservava in una recente intervista come durante i quattro mesi della sua collaborazione al giornale non fosse uscito una sola volta dalla redazione» (Neveu, 2002, p. 23). I dispacci d’agenzia, che in tempo reale raggiungono la redazione, consentono al giornalista di “far arrivare” le notizie senza bisogno di spostarsi lui per andare a cercarle (anche se evidentemente questo comporta dei consistenti contraccolpi sul confezionamento della notizia, perché si accetta la mediazione delle agenzie senza andare a controllare i fatti, come invece succede nel classico giornalismo d’inchiesta). La velocità degli scambi informativi porta con sé alcune conseguenze. La più evidente, su cui torneremo nel paragrafo successivo, è la virtualizzazione della comunicazione, cioè il suo emanciparsi dalla condivisione dello spazio e del tempo: non è più necessario essere presenti nella stessa stanza per comunicare, con i vantaggi e gli svantaggi che questo comporta. Le altre due conseguenze, invece, si configurano come altrettanti modi di declinare la velocità nella società dell’informazione. Anzitutto la velocità, in un sistema sociale in cui l’informazione chiede di essere spostata in tempi strettissimi grazie ala tecnologia informatica, diviene anche un nuovo fondamentale fattore del profilo cognitivo degli individui. Infatti, da una parte l’elaborazione della conoscenza si alimenta non più soltanto della capacità di lettura dei fenomeni e di produzione concettuale, ma anche degli skill necessari alla loro esplicitazione. Quando si partecipa a un brainstorming in chat da cui dipende il varo di qualche progetto aziendale, non poter digitare sulla tastiera in maniera sufficientemente veloce o non conoscere adeguatamente l’ambiente di interazione che si sta usando (icone, pulsanti, procedure) produce lo stesso effetto che il non conoscere adeguatamente la lingua in un paese straniero: posso avere idee brillantissime ma non riuscirò ad imporle, perché la mia lentezza si tradurrà in una scarsa visibilità sullo schermo e questa scarsa visibilità verrà letta come mancanza di contributi significativi. Oltre a questo – l’abilità di interazione con le interfaccia – sarà richiesta al soggetto una grande rapidità di feed-back. Se l’informazione viaggia veloce, non occorre solo una grande velocità nel processarla, ma anche nel produrre le risposte che vengono richieste, perché abbassare la velocità della risposta significa abbassare la velocità generale del sistema e questo può tradursi in seri scompensi dal punto di vista organizzativo (se non rispondo subito a un’e-mail da cui dipende una decisione blocco il processo decisionale) e in una perdita dal punto di vista economico. Si tratta di una mutazione non da poco in chiave antropologica, poiché ai tempi distesi della analisi retrospettiva (Goodman, 1968) propri della civiltà della scrittura (prima di rispondere leggo
attentamente, rileggo, medito, scrivo una bozza, la correggo, la riscrivo e poi spedisco) subentrano i tempi sincopati della comunicazione elettronica che impongono di esaminare in tempo breve grandi quantità di informazioni reagendo ad esse in un tempo altrettanto breve. Il risultato è il sostituirsi di pratiche di lettura veloce alla lettura ponderata, il maturare di una comprensione sintetica e superficiale dei fenomeni rispetto a quella analitica e in profondità, il sentimento crescente di non riuscire a governare tutta l’informazione che ci verrebbe richiesto di elaborare (è questa, tra l’altro, una delle forme più concretamente sperimentabili di quella intotalizzabilità del sapere, tipica della società dell’informazione, di cui parla Levy, 1997). Virilio sostiene, a questo proposito, che ci si trovi di fronte a una vera e propria patologia, parente stretta del disagio che prende i viaggiatori tradizionali che soffrono l’auto o l’aereo: Il mal dei trasporti rapidi – chiamato cinetosi, che ci rende talora degli handicappati nel moto, dei voyeurs-viaggiatori – precedeva logicamente il mal delle trasmissioni istantanee, presto realizzato con i drogati delle reti multimediali, i net junkies, i webabolics e altri cyberpunk colpiti dalla malattia IAD (Internet Addiction Disorder), con la memoria che diventa un ciarpame, una discarica ingombra di un mucchio di immagini di ogni provenienza, di simboli usati, ammassati in qualche modo e in cattivo stato (Virilio, 1998, p. 37). Il terzo e ultimo significato della velocità (seconda conseguenza dell’incremento di rapidità nella circolazione delle informazioni) è quello che inerisce alla precoce obsolescenza delle conoscenze. Due sono le variabili che influenzano il fenomeno. Da una parte è la velocità del cambiamento tecnologico a imporre l’upgrading frequente delle conoscenze. Si tratta di una condizione ben conosciuta da coloro che operano nel mercato dell’e-Learning e tale per cui risulta difficile uscire dalla fase della sperimentazione perché, nel momento in cui si starebbe per abbandonarla in favore della messa a regime, l’innovazione tecnologica cambia completamente le cose e impone di aprire un’altra fase sperimentale, con il risultato che chi si sforza realmente di interpretare l’innovazione si condanna a non poter mai ragionare in termini di routines produttive e viceversa: essere aggiornati significa rischiare di uscire dal mercato (perché questo significa non poter mai ottenere quegli standard produttivi che solo consentono di rientrare degli investimenti e iniziare a realizzare profitto), starci dentro vuol dire quasi sicuramente dover rinunciare ad essere aggiornati (perché ragionare in termini di standard implica l’impossibilità di seguire l’innovazione). La rapida trasformazione degli scenari incide, infine, sull’aggiornamento delle conoscenze anche in ragione della velocità con cui l’informazione viene scambiata. Si passa così da un sapere “pesante”, quello dell’era pre-elettronica, la cui circolazione e appropriazione costituiva un compito affidato alla lunga durata, a un sapere “leggero” che si consuma in un lasso di tempo brevissimo. I “nuovi saperi” nascono e muoiono, sono figli di intersezioni spesso temporanee: la velocità li genera e li travolge. 3.2. Virtualità La letteratura abbondante prodotta sul termine ne consente ormai una comprensione critica sufficientemente lontana dagli entusiasmi futorologici (fantascientifici?) dei primi anni Ottanta. In essa si possono distinguere, riguardo al virtuale, almeno tre questioni, relative: al suo esatto significato (livello etimologico), al tipo di esperienza percettiva ad esso legata (livello tecnologico), alla portata dei suoi effetti (livello sociale). Per quanto riguarda la definizione del termine, è sicuramente Pierre Levy ad avere avuto il merito di mettere ordine nel campo di dibattito. A questo proposito il filosofo francese ha fatto vedere molto bene come il termine virtuale (se si guarda alla sua etimologia latina e all’uso che ne fa la filosofia scolastica medievale) non si contrapponga a “reale”, ma ad “attuale”.
La parola virtuale proviene dal latino medievale virtualis, derivato, a sua volta, da virtus, forza, potenza. Nella filosofia scolastica virtuale è ciò che esiste in potenza e non in atto. Il virtuale tende ad attualizzarsi, senza essere tuttavia passato a una concretizzazione effettiva o formale. L’albero è virtualmente presente nel seme. Volendosi attenere rigorosamente al ragionamento filosofico, il virtuale non si contrappone al reale ma all’attuale: virtualità e attualità sono solo due diversi modi di essere (Levy, 1995, p. 5). In questo modo viene subito superato il significato ordinario che abitualmente si attribuisce al virtuale pensandolo come qualcosa che non esiste, che è soltanto illusorio. La realtà virtuale non è un mondo “altro” rispetto a quello reale (per cui quest’ultimo esiste, il primo no), ma una modalità diversa del darsi della realtà. Quali sono, allora, le caratteristiche che costituiscono dall’interno il virtuale? Secondo Levy, semplificando di molto la sua analisi, esse sono sostanzialmente due:
q la problematicità, cioè il fatto di costituire un sistema di forze diversamente attualizzabile. Ad esempio, quando oggi si parla di impresa virtuale, la virtualità di questa impresa consiste nel fatto che la distribuzione della forza-lavoro e la localizzazione dei suoi diversi comparti non è qualcosa che sia risolto una volta per tutte, ma continuamente riproposto in modo che possa essere definito in relazione alle necessità che volta a volta si presentano (la direzione può essere spostata da Londra a New York, la fase produttiva da Taiwan al Brasile, ecc.);
q la deterritorializzazione, cioè il fatto che le variabili di localizzazione non abbiano più alcun rilievo al fine di determinare le situazioni. Sempre per restare all’esempio dell’impresa virtuale, questo significa che essa «non è più localizzabile con precisione. I suoi elementi sono nomadi, dispersi e la pertinenza della loro posizione geografica è notevolmente ridotta» (Levy, 1995, p. 9). Coglie molto bene il senso del fenomeno ancora una volta Virilio: «Più che a una “fine della Storia” assistiamo dunque a quella della geografia» (Virilio, 1998, p. 9).
Il chiarimento dei termini in gioco consente di ottenere guadagni significativi anche al secondo dei livelli di analisi che avevamo indicato, quello tecnologico. Per lungo tempo, infatti, il virtuale è stato identificato con un ben preciso tipo di tecnologia che facilitasse l’esperienza percettiva dell’immersione e della manipolazione in e di uno spazio sintetico. Anche dal punto di vista dell’immaginario sociale la realtà virtuale è stata tradizionalmente associata a tutti quei dispositivi – dal casco ai guanti – che sono stati progettati proprio per ottenere questi effetti percettivi, favorendo l’interazione dell’utente con uno spazio generato dall’elaboratore proprio come se si trattasse di uno spazio reale (e ricompare qui l’opposizione di reale e virtuale che, grazie a Levy, abbiamo già dimostrato superata dal punto di vista teorico). Il fatto che, per esempio, mettendoci una cuffia oculare (eye-phone), infilandoci un guanto intelligente (data-glove) e indossando una tuta intelligente (data-suit), siamo in grado di entrare in una realtà illusoria e viverla come se fosse reale (o quasi), è un passo evidente in questo senso. Ora siamo in condizione di perlustrare dall’interno una realtà che è la controfigura della nostra (Maldonado, 1992, pp. 51-52). Questo significato “forte” del virtuale ha subito una rapida caduta in disuso sia perché la tecnologia cui faceva ricorso era troppo ingombrante sia, soprattutto, perché l’utopia iniziale di mettere a disposizione di tutti, direttamente sul computer di casa, il consumo di realtà virtuale è clamorosamente naufragata. Di fatto i costi della tecnologia per ottenere effetti adeguati di immersione e navigazione sono talmente elevati da consentire l’acquisto di dispositivi RV solo ai laboratori di ricerca. Parallelamente alla crisi del senso “forte” del virtuale è andato sempre più imponendosi per le sue larghe implicazioni sociali un senso “debole” del termine che confluisce
all’interno di quella che oggi viene definita la “cultura della virtualità”. Questa cultura, che trova probabilmente la sua genesi nel movimento cyber (Gibson, 1984; Benedikt, 1991), si riconosce nelle comunità virtuali dei MUD o delle IRC e fa propria la convinzione secondo la quale le forme dell’esistenza in rete sarebbero da preferire a quelle reali: più libertà, maggiore possibilità di incontro, opportunità attraverso la simulazione di generare molti doppi di sé. Una prospettiva che non si può non riportare alle diverse esperienze di fuga dal corpo proposte dallo sciamanesimo (Zolla, 1992) o dalla tradizione platonica: L’idea, per esempio, di una realtà virtuale intesa come fuga dal reale verso il virtuale può essere interpretata come una fuga ascendente, liberatoria verso l’assoluto. Soprattutto se questo viene teorizzato come qualcosa che accade tramite una “decorporalizzata sensorialità umana” (disembodied human sensorial), ossia tramite una sensorialità che le tecnologie digitali avanzate hanno reso autonoma rispetto al corpo. Tutto questo ricorda troppo, inutile negarlo, l’estasi plotiniana, la fuga dal sensibile verso l’intelligibile (Maldonado, 1992, p. 56). Anche in questa accezione culturale del termine virtuale continua comunque a rimanere implicita la contrapposizione rispetto al reale: la vita virtuale è una “vita sullo schermo”, per citare il titolo del celebre saggio di Sherry Turkle (1995), che va letta in antitesi rispetto alla vita “vera”. Una prospettiva questa che, invece, sfuma se si riflette su cosa sia oggi la virtualità sul piano sociale. Essa ha a che fare con tutte quelle forme di interazione che surrogano la presenza fisica attraverso la mediazione dei dispositivi elettronici. Così, quando si parla di “aula virtuale” nell’e-Learning si fa riferimento alle attività di insegnamento/apprendimento così come esse sono rese possibili tra soggetti che non condividono lo stesso spazio fisico grazie alla mediazione di un ambiente telematico come è quello costituito dagli attuali Learning Management Systems. L’aggettivo virtuale, in questo caso, non indica più una dimensione diversa da quella reale in cui immergersi per fare esperienze percettive simulate, né un mondo di relazioni fittizie che favorisce il libero gioco del mascheramento: ciò che il termine designa è, piuttosto, una situazione in cui la presenza fisica viene risolta nella telepresenza. Il virtuale, dunque, più che come un luogo alternativo in cui è possibile entrare, va pensato come uno scenario di azione che è possibile prevedere accanto ad altri scenari di azione: per restare all’esempio dell’e-Learning, significherà prevedere che il soggetto, accanto a scenari di azione come la lettura personale di testi e materiali e la discussione face to face con i colleghi, ne possa anche aprire altri come la discussione in forum o il chatting con un docente che si trova a molti chilometri di distanza. Tutti e due i tipi di attività sono coerenti con l’obiettivo di apprendere, con la sola differenza che i primi richiedono la presenza fisica, gli altri la surrogano attraverso la telepresenza (Rivoltella, 2003). 3.3. Dal networking alla globalizzazione Una società che si pensa secondo le due metafore della velocità e della virtualità non può che essere una società di rete. La velocità, infatti, comporta una sempre maggiore facilità di circolazione di idee e conoscenze altrimenti confinate solo all’ambito locale, mentre la virtualità agevola la possibilità di fare esperienza mediata delle cose senza bisogno di spostamento. La conseguenza è che gradualmente si creano legami, nessi, tra un punto e l’altro del sistema-mondo, come spiega bene Mattelart (1996, p.9). Ampliando progressivamente le possibilità di circolazione sia delle persone, sia dei beni materiali e simbolici, i mezzi di comunicazione hanno accelerato l’incorporazione delle società particolari in gruppi più vasti, spostando continuamente le frontiere fisiche, intellettuali e mentali. L’osservazione è molto interessante e consente di capire alcune cose.
Anzitutto il fatto di essere in rete, l’esigenza di connessione, si dimostra essere non soltanto un dato di fatto o una scelta strategica delle imprese, ma un portato dello sviluppo tecnologico. Molto tempo prima dell’avvento di Internet, infatti, lo sviluppo del trasporto su rotaia piuttosto che la diffusione delle frequenze radiotelevisive hanno richiesto (imposto) l’adozione di scelte comuni – gli standard – che progressivamente hanno favorito il nascere di una rete internazionale tra le società e gli stati. Questo dato – il rapporto, cioè, tra sviluppo dei mezzi di comunicazione ed esigenza di connessione – ha costituito a partire dal Settecento illuminista anche un tema-guida di quelle correnti di pensiero che legano a doppia mandata la possibilità di costruire la convivenza dei popoli con la realizzazione fattiva di un network tra di essi. La configurazione di una società di rete, quindi, oltre che come un portato dello sviluppo tecnologico si può leggere come mito fondatore di un certo modo di pensare i rapporti tra gli individui e gli stati. Infine, società di rete, sviluppo tecnologico ed elaborazione ideologica sembrano incrociare un’altra categoria centrale del dibattito culturale attuale, quella di globalizzazione, consentendone una rilettura meno sbilanciata sui fattori economici (sicuramente importanti) e più attenta alle logiche culturali. Cerchiamo allora di raccogliere insieme queste indicazioni in un percorso unitario sforzandoci di chiarire in che senso il networking, in quanto dimensione strutturale della società dell’informazione, contribuisca a farne al tempo stesso una società della globalizzazione. L’ipotesi è che ciò che il termine globalizzazione evoca in negativo (eliminazione delle specificità culturali, aumento della povertà a livello planetario, espansione dei mercati a discapito dell’ambiente, incremento delle differenze sociali – Rossi, 2002, pp. 19 ss.) trovi la sua versione positiva nell’immagine “mitologica” della rete che abbiamo visto descrivere molto bene da Mattelart: networking e globalizzazione potrebbero dunque indicare in sostanza lo stesso fenomeno declinandone le implicazioni opposte a livello di mercato e di pratiche individuali e sociali. Due sono le definizioni del termine globalizzazione che paiono esemplificative del dibattito oggi in corso attorno al concetto:
q «la crescente interconnessione di regioni diverse del mondo, un processo che genera forme complesse di interazione e interdipendenza» (Thompson, 1995, p. 221);
q «il processo di unificazione del mondo economico e, per estensione, di tutto ciò che riguarda il pianeta» (Mattelart, 1996, p. 95).
Leggendo con attenzione “tra le righe” di queste definizioni si ricava, oltre alla comune matrice “connettiva” (l’”interconnessione” e l’”unificazione” implicano comunque un processo relazionale rinviando alla categoria della rete), che il fenomeno della globalizzazione occupa un’area semantica comune ad altri termini con cui spesso viene anche confuso:
q la transnazionalizzazione (preferito a multinazionalizzazione), intesa come il processo della riorganizzazione in senso policentrico dell’azienda;
q l’internazionalizzazione, cioè il processo di progressivo abbandono della logica dello stato nazionale tipica dell’età moderna (l’unificazione europea, ma anche il nuovo ruolo dell’ONU ne sono un sintomatico esempio);
q la mondializzazione, che è l’esito ultimo dell’internazionalizzazione, cioè l’apertura dello spazio di contrattazione simbolica tra individui e società all’intero pianeta (Morin, Kern, 1993, parlano a questo proposito di “epoca planetaria”);
q l’omogeneizzazione, intesa come standardizzazione planetaria dei gusti e della cultura (una standardizzazione che avverrebbe secondo i parametri propri della cultura occidentale in ossequio alla classica tesi dell’imperialismo culturale avanzata da Herbert Schiller nel suo Mass Communications and American Empire);
q l’interculturalità, versione “buonista” dell’omogeneizzazione, dove alla colonizzazione culturale si sostituisce la libera integrazione delle diverse culture in società come le nostre ormai sempre più multietniche.
Seguendo l’analisi di Thompson (1995) si può ben evidenziare come ciascuna di queste dimensioni costituisca parte integrante del fenomeno della globalizzazione senza, però, ridursi ad esso in via identificativa. Di fatto i singoli fenomeni che abbiamo rapidamente descritto si possono in misura diversa riportare alle tre caratteristiche strutturali della globalizzazione:
q l’iscrizione in una arena planetaria (l’internazionalizzazione, la mondializzazione); q l’organizzazione su scala globale (la transnazionalizzazione); q la reciprocità e interdipendenza (l’interculturalità).
Dimensioni, come ben si comprende, che sono tutte perfettamente riconoscibili nei processi che interessano la new economy: la configurazione planetaria dei mercati, la logica di partnership e la virtualità dei sistemi di produzione/distribuzione dei servizi, il carattere sistemico dei diversi tipi di relazione (il che implica la reversibilità di ogni nesso e la coimplicazione di ogni elemento del sistema nei processi di trasformazione che interessano tutti gli altri). Dove origina questo tipo di realtà socio-culturale? Dove occorre cercare le logiche che ne hanno prodotto l’avvento e l’affermazione? Seguendo l’analisi di Morin e Mattelart è possibile rintracciare, per la globalizzazione, (1) una genesi remota, (2) due matrici culturali prossime e (3) una evoluzione recente. La genesi remota va cercata nella scoperta dell’America che, nel 1492, spezza l’orientamento eurocentrico della storia e ne produce la prima vistosa accelerazione in senso globalistico. La coltura della patata o del pomodoro, sconosciute prima in Occidente (come la sifilide, prova incontrovertibile della avvenuta cristianizzazione delle Americhe), sono il sintomo dell’incipiente creolizzazione delle culture e dei comportamenti, proprio come il morbillo, sconosciuto nel Nuovo Mondo e che uccise più indios che i Conquistadores. Le matrici culturali prossime, nel ‘700, sono costituite dalle due teorie universaliste dell’illuminismo e del liberismo. Entrambe costruiscono la loro ideologia attorno al «potere creatore dello scambio», naturalmente declinandolo in due diverse direzioni. Gli illuministi ne sottolineano la capacità di far circolare le idee garantendo la democrazia: in questa prospettiva va inquadrata la politica rivoluzionaria di unificazione della lingua francese contro la sopravvivenza degli idiomi regionali come risposta alla logica dell’Ancienne Régime, volta invece a bloccare la circolazione delle idee e separare i popoli. Quanto al liberismo, il cui motto può essere cercato nella massima di J.S.Mill: «Produrre significa muovere», esso lavora a costruire una «repubblica mercantile universale», una grande comunità economica di consumatori in cui la libera iniziativa prenda il posto di istituzioni forti come quella dello Stato. Quanto, poi, all’evoluzione recente del fenomeno, essa coincide, si può dire, con lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione a partire dalla metà del XIX secolo e con il loro portato politico e culturale, come già si anticipava all’inizio di questo paragrafo. Sul piano della tecnologia si pensi alla nascita del telegrafo e alla sua funzione di contrazione delle distanze, resa evidente nel 1851 dalla posa del primo cavo telegrafico tra Calais e Dover e, nel 1902, dal completamento della prima linea transpacifica. Una tendenza poi accentuata, volta a volta, dal progressivo avvento della radio e della televisione fino ai temi attuali delle autostrade dell’informazione e del World Wide Web. Ma questa tendenza tecnologica innesca un processo analogo anche sul piano politico. Nel 1865 nasce l’Unione telegrafica internazionale, con lo scopo di fissare standard, tariffe e norme comuni a tutti i paesi, seguita nel 1874 dall’Unione generale delle poste e nel 1906 dall’Unione radiotelegrafica internazionale. Dunque, non solo la tecnologia “restringe” il pianeta, ma provoca il dialogo tra gli Stati, favorisce il coagulo delle relazioni sul piano internazionale.
Tutto questo produce inevitabilmente un riflesso anche a livello culturale. L’Europa, affondata nella crisi prodotta dalla Rivoluzione francese e impegnata a garantire con fatica un equilibrio politico tra gli Stati, trova proprio nella comunicazione quell’utopia di salvezza capace di prospettare al mondo un futuro di pace. L’universalismo, con Saint-Simon soprattutto, diviene allora una vera e propria «ideologia redentrice» che trova nell’industria e nel sapere positivo i suoi supporti e nelle grandi esposizioni universali un momento efficace di elaborazione mitologica. Come osserva Mattelart (1996, p.33): Esposizioni e invenzioni tecniche si sostengono reciprocamente per propagandare la retorica della pace e della comunione dei popoli: “Tutti gli uomini diventeranno fratelli”. Ogni generazione tecnologica è un’occasione per sostenere la commedia della concordia generale e della riconciliazione dei conflitti sociali sotto l’egida della civilizzazione occidentale. Momentaneamente tramontata a fine secolo con la caduta della Comune di Parigi e il crollo del sistema degli Stati dopo la guerra franco-prussiana, questa utopia rinascerà nel corso del ‘900 trovando nel programma cibernetico di Wiener il proprio momento di rifondazione: i temi attuali della società della comunicazione e del villaggio planetario, come Breton (1992) ha ben indicato, dipendono in larga parte da esso. Sulla base di questo scenario storico, quale immagine della globalizzazione è possibile fornire oggi rispetto soprattutto al fenomeno della comunicazione telematica? Adattando l’analisi di Thompson (1995) si possono individuare almeno quattro temi rilevanti in proposito:
q anzitutto la concentrazione dell’industria di settore nelle mani di pochi gruppi. Basta pensare a casi emblematici come quello di Microsoft o di AOL-Warner. Nel primo caso ci si trova di fronte a un produttore che impone un vero e proprio monopolio nell’ambito del software dettando le regole anche al mercato dell’hardware (l’obsolescenza delle macchine è, infatti, in larga parte decisa dalle caratteristiche tecniche richieste dal funzionamento delle nuove releases di Windows o di Office). Nel secondo, invece, si tratta della joint-venture tra il più grande provider del mondo e la più grande holding della comunicazione. A livello di mercato, tendenze come queste producono uno squilibrio nella distribuzione del potere economico e, soprattutto, simbolico di investire di significato una vasta arena collettiva. Se però si guadagna l’ottica del networking, allora più che di istanze monopolistiche si preferisce parlare di logiche di partnership la cui conseguenza non sarebbe l’omogeneizzazione illibertaria dei mercati, ma il coordinamento delle imprese produttive di settore con conseguenti vantaggi sia per chi produce che per chi acquista;
q un secondo aspetto rilevante della globalizzazione dei mercati telematici è dato dal loro impatto sulle pratiche di consumo. Infatti, le tecnologie di rete sfasano nettamente lo spazio nazionale rispetto a quello del mercato potenzialmente globale che consentono di raggiungere. Anche in questo caso l’ottica appare molto diversa secondo che si assuma il punto di vista della globalizzazione o del networking: nel primo caso vengono in primo piano i temi della omologazione e della perdita delle specificità culturali, nel secondo prevalgono invece quelli della libera circolazione dei significati e della costituzione di reti internazionali di collaborazione (la genesi dell’intelligenza collettiva e del lavoro cooperativo va cercata qui);
q un terzo tema particolarmente significativo è costituito dal problema dell’accesso alle tecnologie. L’apertura di contesti globali di distribuzione dei servizi e di circolazione delle merci, da una parte non sembra comportare un accesso equilibrato alla tecnologia, che si struttura invece secondo flussi preferenziali a livello planetario (dai principali paesi produttori al resto del mondo) o intraregionale (è quanto succede ad esempio in America Latina per il Messico e il Brasile in rapporto agli altri paesi del subcontinente), dall’altra
alimenta invece l’utopia che collega l’incremento costante delle connessioni con la diffusione di sempre maggiori possibilità di sviluppo;
q un’ultima questione è quella relativa agli effetti della globalizzazione sul piano socio-culturale, che consente di precisare meglio quanto già accennato in precedenza parlando dell’impatto della globalizzazione sulle pratiche di consumo. La tesi che a lungo (e forse ancor oggi) ha fatto da riferimento a questo proposito è quella dell’imperialismo culturale in base alla quale, dal piano Marshall in poi, si sarebbe assistito a una progressiva colonizzazione culturale del mondo da parte del modello americano, proprio perché erano gli Stati Uniti ad esercitare il controllo totale sull’industria dei media e della comunicazione. Secondo questa tesi, dunque, la globalizzazione andrebbe letta nei termini di una americanizzazione (più in generale, di una occidentalizzazione) delle altre culture. Senza entrare in una critica analitica di questa ipotesi si può tuttavia indicare la sua principale debolezza teorica che consiste nel fatto di contenere una spiegazione ingenua del processo di appropriazione attraverso cui un individuo interiorizza i modelli culturali proposti dai media. Tale processo non si può mai intendere nei termini di una assunzione meccanica (come vorrebbe la tesi dell’imperialismo culturale: imparo il consumismo fruendo di programmi consumistici), ma va pensato nella prospettiva di un modello ermeneutico secondo il quale «il significato che gli individui assegnano ai messaggi dei media e gli usi che essi fanno dei materiali simbolici mediati devono dipendere in modo cruciale dai contesti della ricezione e dalle risorse che essi impiegano nel processo di interpretazione» (Thompson, 1995, p.246).
Descrittori Esiti della globalizzazione Esiti del Networking Concentrazione Monopolio Coordinamento Pratiche di consumo Omologazione Circolazione dei significati Accesso alle tecnologie Digital divide Accesso per tutti Effetti socio-culturali Occidentalizzazione Appropriazione situata Tabella 1 – Aspetti della globalizzazione/networking (Fonte: elaborazione personale). 4. La società della conoscenza Le tre dimensioni su cui ci siamo soffermati interessano, ciascuna a suo modo, il processo di costruzione e di diffusione della conoscenza che, nella società dell’informazione, viene in primo piano costituendo un elemento caratterizzante dell’economia digitale. Si tratta di capire quale significato attribuire a questo processo, che tipo di effetto produca sui ruoli professionali e, infine, che tipo di procedure detti alle organizzazioni. 4.1. Il protagonismo delle merci simboliche Il dato macroscopico che segna la società dell’informazione è costituito dal protagonismo in essa giocato dalle merci simboliche. Si capisce cosa questo significhi se si pensa al fatto che in questo tipo di società si può vendere un database di nomi perché se ne possa ricavare un campione psicografico, si può entrare in una partnership offrendo null’altro che il proprio marchio, si possono investire somme ingenti in campagne pubblicitarie. In sostanza, all’età della merce intesa come materiale da produrre, immagazzinare e distribuire, subentra una nuova epoca in cui è il capitale simbolico a contare, cioè il patrimonio delle informazioni e il valore che esse possono costituire sul mercato. Con termini ormai consegnati all’uso corrente, questa transizione viene indicata nei termini di un passaggio dalla old alla new economy, come sinteticamente evidenzia Philip Kotler:
La combinazione di Internet, nuove tecnologie e globalizzazione ha dato origine a una nuova economia, la cosiddetta new economy, spesso contrapposta alla old economy: quest’ultima è edificata sui principi della gestione delle industrie manifatturiere, mentre la new economy poggia sulla logica della gestione dell’informazione e delle industrie dell’informazione. Nella logica della new economy, vince chi possiede i migliori sistemi informativi e sa ciò che gli altri concorrenti sul mercato non sanno: non sorprende, pertanto, che molte imprese si stiano affrettando a digitalizzare le proprie attività per conseguire risparmi sui costi e una più incisiva presenza e penetrazione di mercato (Kotler, Jain, Maesincee, 2002, p. XIII). Per rendere ragione del processo evolutivo attraverso il quale la tradizionale industria manifatturiera cede il passo alla merce simbolica e, dall’altra parte, si fa strada un modo completamente nuovo di concepire la conoscenza, si possono prendere in considerazione le analisi per molti versi esemplari di Jean Baudrillard (1976). Secondo il sociologo francese (ed è sbalorditivo che lo scrivesse ancora alla metà degli anni Settanta senza poter contare sulle conferme che lo sviluppo recente delle reti telematiche e dell’economia dei media forniscono alla sua ipotesi) il macrofenomeno che interessa la tarda modernità è una «rivoluzione strutturale della legge del valore» (Baudrillard, 1976, p. 18) per cui si passa da un tempo – quello dell’economia classica – in cui il valore rinvia comunque al prodotto nella sua materialità, a un tempo in cui, invece, l’immagine della merce si emancipa dalla merce stessa e non rinvia più a nulla se non a se stessa. Questo processo di perdita del referente è da tempo in corso, secondo Baudrillard, ai diversi livelli sul piano sociale. Questa mutazione storica e sociale è leggibile a tutti i livelli. L’era della simulazione è così ovunque aperta dalla commutabilità dei termini un tempo contraddittori o dialetticamente opposti. Ovunque la medesima “genesi dei simulacri”: commutabilità del bello e del brutto nella moda, della sinistra e della destra in politica, del vero e del falso in tutti i messaggi dei media, dell’utile e dell’inutile a livello degli oggetti, della natura e della cultura a tutti i livelli di significazione (Baudrillard, 1976, p. 20). Il simulacro è una particolare categoria di segno in cui, al rapporto obbligato con le cose subentra la libertà rispetto ad esse: in sostanza, alla naturalità del segno, per cui la cosa designante rinvia senza possibilità di equivoco alla cosa designata, si sostituisce l’impressione di naturalità del simulacro, in virtù della quale si è portati a credere che la cosa designante rinvii alla cosa designata. Il simulacro, dunque, reca con sé nella propria struttura la logica della simulazione: la storia del suo sviluppo è la storia dell’affermarsi progressivo di forme sempre più marcate di simulazione. La prima di queste forme simulacrali viene introdotta in età rinascimentale. Baudrillard la definisce contraffazione e la riconduce ad alcune espressioni culturali tipiche del Cinque-Seicento: gli artifici della moda (come il “davantino” della camicia o il falso gilet), le macchine teatrali barocche, i giochi illusionistici degli interni architettonici (come il trompe-l’oeil o gli ornati di stucco). Il programma che sta dietro a queste forme culturali è quello razionalistico di un ordinamento del mondo, di una riconduzione di tutte le cose a una logica razionale. L’artificio barocco, mentre simula altro, attraverso il sostituto simbolico delle cose reali disegna un mondo ordinato così come esso dovrebbe essere. La metafora del theatrum mundi è perfettamente omogenea a questo progetto politico: fingere (nel senso etimologico forte di plasmare, dare ordine) è esattamente la stessa azione con cui Dio modella tutto all’inizio dei tempi. L’arte della contraffazione e l’arte della creazione vivono della stessa logica strutturale. Questo ordine simbolico – funzionale, dal punto di vista politico, alla legittimazione dell’assolutismo - rimane funzionante fino all’avvento della Rivoluzione Industriale quando viene sostituito da una nuova forma di simulacralità: la produzione. Con la produzione meccanica e poi, più ancora, con la produzione seriale resa possibile dalla catena di montaggio, si entra in una
modalità completamente diversa della simulazione. Il prodotto seriale, infatti, a differenza dell’artificio barocco, non dissimula più la relazione con nessuno oggetto originale di cui esso sia contraffazione: più semplicemente non esiste più nessun oggetto originale. Nell’epoca della riproducibilità tecnica, come già notava Benjamin (1955), la distanza tra l’originale e la copia è eliminata perché ciò che esiste è solo una serie infinita di doppi «che non dovranno quindi essere contraffatti perché saranno fin dall’inizio prodotti su una scala gigantesca» (Baudrillard, 1976, p. 66). Qui si rintraccia la differenza che separa i simulacri del primo ordine (che si rifanno alla logica della contraffazione) da quelli del secondo ordine (iscritti, invece, nella logica della produzione): Il simulacro di primo ordine non abolisce mai la differenza: presuppone sempre la divergenza sempre sensibile del simulacro e del reale (gioco particolarmente sottile nella pittura en trompe-l’oeil). Il simulacro di secondo ordine, invece, semplifica il problema assorbendo le apparenze, o liquidando il reale, come si vorrà – erige in ogni caso una realtà senza immagine, senz’eco, senza specchio, senza apparenza: tale è appunto il lavoro, tale la macchina, tale l’intero sistema di produzione industriale in quanto si oppone radicalmente al principio dell’illusione teatrale (Baudrillard, 1976, pp. 65-66). Quando la logica della riproduzione meccanica viene spinta alle sue estreme conseguenze si opera il passaggio alla terza età del simulacro, quella in cui noi oggi viviamo, l’età della simulazione. La differenza rispetto all’età precedente è che all’idea della produzione in serie subentra quella di una generazione di oggetti a partire da modelli (non sarebbe fuori luogo adottare, per descrivere il fenomeno, la categoria della clonazione). Per spiegare cosa vuole intendere, Baudrillard porta l’esempio del DNA e dell’algoritmo informatico: in entrambi i casi ci troviamo di fronte a codici che portano iscritto in sé un modello a partire dal quale è possibile derivare determinati risultati. Il carattere numerico di questo codice lo rende processabile ed è questo che sta alla base tanto dell’ingegneria genetica che dell’industria del software o dei sistemi esperti. Il Web come gli organismi geneticamente modificati, le figure di sintesi che popolano un videogioco e la pecora Dolly, condividono la stessa sorte di essere simulacri la cui esistenza si deve soltanto alla generazione a partire da un modello. Così, dopo la contraffazione barocca che imitava la realtà e la produzione industriale che risolveva l’originale nella serie dei doppi, la simulazione tardomoderna produce una nuova realtà di sintesi a partire da un codice. Al limite d’uno sterminio sempre più spinto delle referenze e delle finalità, d’una perdita delle somiglianze e delle designazioni, si trova il segno digitale e programmatico, il cui “valore” è puramente tattico, all’intersezione di altri segnali (corpuscoli d’informazione/test), e la cui struttura è quella d’un codice macromolecolare di comando e di controllo (Baudrillard, 1976, p. 69). Non si fa fatica a ricondurre questo tipo di realtà modellata dal codice, cioè strutturalmente ordinata dall’informazione (il codice genetico come quello digitale altro non è che informazione), alla condizione attuale, persino dal punto di vista economico. Baudrillard, infatti, osserva come a ciascuna delle tre età del simulacro corrisponda un certo tipo di economia. Il simulacro di primo ordine vive ancora all’interno di un’economia di scambio in cui il valore della merce si basa sulla natura, è un valore d’uso: nello scambio di beni naturali ciò che determina il valore di questi beni è strutturalmente connesso alla loro stessa natura (il valore dell’acqua nel deserto è elevatissimo, non così in India durante la stagione delle piogge), per cui è in relazione alla loro stessa natura (cioè alla loro importanza materiale) che posso scambiare due beni. Con il passaggio all’età industriale e l’avvento della produzione il valore delle merci si determina sulla base del mercato: a costituirlo entrano fattori nuovi come il costo della materia prima, del lavoro necessario a produrle, non ultima la legge della domanda e dell’offerta. Pur perdendo il suo riferimento alla natura, il valore continua ad avere il suo significato perché rinvia comunque al denaro, al salario, al capitale. Questo aggancio
referenziale è proprio ciò che si perde con la transizione alla società del codice. Lo spiega bene ancora una volta Baudrillard (1976, pp. 34-35). Quest’ultima (fase n.d.r.) si lascia molto indietro gli obiettivi sociali tradizionali della produzione e del consumo. È un processo a sé stante, fine a se stesso. Non mira più né ai bisogni né al profitto. Non è un’accelerazione della produttività, ma strutturalmente un’inflazione dei segni della produzione, uno chassé-croisé e una fuga in avanti di tutti i segni, compreso il segno monetario, ben inteso. È lo stadio dei programmi spaziali, del Concorde, dei programmi militari in tutte le direzioni, dell’inflazione del parco industriale, delle attrezzature d’infrastruttura sociali o individuali, dei programmi di formazione e di riciclaggio, ecc. Bisogna produrre non importa che cosa, secondo una coazione a reinvestire a tutti i costi (e non in funzione del saggio del plusvalore). Questa produzione emancipata da qualsiasi fine (come poteva esserlo nell’età della produzione industriale l’accumulo del capitale) trova un’interessante applicazione proprio nel mercato dell’immagine costruito e gestito dal marketing, o nei nuovi mercati che, come quello dei beni turistici e culturali, vivono di consumi effimeri. Ma anche la Borsa e i mercati finanziari esemplificano adeguatamente un tipo di economia in cui la cosa più importante è la circolazione –delle informazioni, del denaro, dei titoli. In tutti questi casi le merci simboliche, l’immagine su tutte, vengono in primo piano e divengono il fulcro della nuova economia. Dalla loro leggerezza (nel senso della transitorietà, dell’esposizione ai flussi delle mode, dell’obbedienza alle leggi capricciose dei listini e delle campagne di comunicazione) dipende probabilmente lo scarto consistente e oggi sempre più avvertibile tra quanto nella new economy c’è di economia reale e quanto invece di virtuale. Ordine Tipo di logica Età storica Tipo di simulacro Tipo di valore Primo Contraffazione Rinascimento Artefatto Naturale Secondo Produzione Rivoluzione industriale Oggetto seriale Mercantile Terzo Simulazione Tarda modernità Derivato dal modello Strutturale Tabella 2 – I tre ordini del simulacro (Fonte: elaborazione personale) 4.2. I lavoratori del simbolico Questo nuovo protagonismo delle merci simboliche ha portato come conseguenza in questi ultimi anni la nascita e lo sviluppo di una nuova categoria di “lavoratori del simbolico”, secondo l’espressione di Erik Neveu (1994), cioè di figure professionali dedicate alla costruzione, valorizzazione e distribuzione di queste merci: si tratta di figure che non sono impegnate nella produzione materiale di qualcosa, quanto piuttosto nella costruzione e nella circolazione di significati. Appartengono a questa nuova casta professionale tutte le professioni della comunicazione (giornalisti, PR, operatori del settore radio-televisivo), quelle dell’organizzazione degli eventi culturali e della formazione e soprattutto gli operatori impegnati nel comparto dell’economia digitale, i cosiddetti net jober. Si tratta di profili professionali dai contorni non ben definiti, dal momento che buona parte delle loro prestazioni riguarda l’elaborazione conoscitiva e che il loro lavoro non è vincolabile in maniera rigida allo spazio-tempo: possono lavorare anche da casa, non necessariamente all’interno dell’orario lavorativo. Tutto questo produce serie difficoltà nelle organizzazioni che vedono stravolti i loro abituali parametri di gestione dei compensi economici. La ragione va cercata proprio nel fatto che questi lavoratori trattano informazioni.
Il fattore predominante di questa trasformazione è la sempre maggiore importanza che assume l’informazione digitalizzata, merce immateriale e illimitatamente organizzabile, rispetto ai più pesanti manufatti. In questa società dell’informazione numerica le principali fonti di creazione e circolazione diventano l’elaborazione, la produzione e la distribuzione di pacchetti di bit di conoscenza (Berra, 2000, pp. 24-25). Neppure le competenze di queste figure sono ancora ben delineate. Si tratta, infatti, di profili professionali ibridi, a forte tasso di integrazione delle competenze, per cui, a fronte di una buona competenza informatica, esse richiedono una formazione di base in marketing e comunicazione oltre che una specializzazione volta a volta sui temi della formazione, della progettazione delle interfaccia, ecc. Infine, a tutti questi lavoratori viene richiesta una grande flessibilità. Infatti si chiede che le loro prestazioni varino in relazione con le dimensioni dell’azienda e secondo le esigenze del committente adattandosi ai progetti sui cui sono coinvolti. La Texas University ha disegnato la mappa di queste nuove figure professionali distinguendole in quattro categorie relative rispettivamente a: hardware, software, e-Commerce e intermediazione. Le ultime due sono quelle direttamente coinvolte nell’area dell’economia digitale: a titolo esemplificativo proviamo a darne una sintetica presentazione. I professionisti dell’e-Commerce possono essere inquadrati in tre famiglie di profili professionali: figure di management, di amministrazione, di intermediazione commerciale. Il management nell’impresa digitale (come si può ricavare dai contributi raccolti nella parte quinta di questo volume) è un fenomeno molto complesso. Esso può richiedere, in primo luogo, compiti di progettazione e supervisione che si esplicitano attraverso l’organizzazione del lavoro e il coordinamento delle diverse competenze, dalla gestione del budget alla realizzazione del prodotto. Il Project Leader, che assume questi compiti, si avvale per gestirli di una serie di altre figure. La più importante di esse è quella del Project Manager, cui spetta il compito di seguire lo svolgimento del progetto scegliendo le risorse, verificando il budget e controllando l’avanzamento dei lavori in relazione con gli step previsti. Altre figure più tecniche sono quelle del Technical Analyst (la cui funzione è di vagliare idee e ipotesi in funzione di nuove opportunità di sviluppo del business), del Change Manager (valuta l’impatto delle nuove tecnologie sull’organizzazione individuando e realizzando azioni strategiche volte all’assorbimento del cambiamento), del controllore di gestione (che lavora sul progetto valutandone la fattibilità in relazione a costi e benefici). Non meno rilevanti sono le figure coinvolte nella amministrazione. La più diffusa è quella del Webmaster. Figura chiave nella produzione in quanto responsabile dell’architettura tecnologica, del back up dei dati e dell’amministrazione degli utenti, deve possedere competenze di comunicazione e di marketing oltre che, naturalmente, di tipo tecnologico. Nel suo lavoro coordina i Web Programmer e i Web Editor, cioè coloro che materialmente lavorano sulle architetture di rete e sulle pagine da mettere in linea. Con la diffusione delle reti Intranet a servizio della comunicazione interna delle aziende e in funzione del knowledge management, stanno assumendo una funzione sempre più strategica altre due figure di amministrazione, l’Intranet Administrator e il Net Director: il primo è impegnato nello sviluppo e nella gestione tecnica della rete, il secondo ne gestisce il controllo con funzioni di facilitazione, moderazione e organizzazione. Per quanto riguarda, invece, le figure professionali che nello studio della Texas University sono definite “di intermediazione”, esse identificano attività di servizio che riguardano la raccolta, la redazione e la pubblicazione delle informazioni in rete. La raccolta delle informazioni costituisce un fattore strategico per le imprese della new economy. Essa viene gestita a diversi livelli. Il primo e più semplice è quello della navigazione in rete effettuata da figure (i Surfer) specializzate nelle tecniche di ricerca in Internet; buona parte di queste figure trova occupazione nell’ambito dei web portal o dei motori di ricerca. A un livello superiore si trova il Database Manager, responsabile della organizzazione e della gestione delle informazioni all’interno di banche dati informatiche. Infine, si trovano figure come quella del Management
Consultant specializzate non tanto nella raccolta e nella gestione delle informazioni ma nella loro finalizzazione agli interessi dell’azienda; tra le loro competenze, pertanto, vanno incluse la capacità di svolgere ricerche di mercato, di valutare le opportunità di finanziamento, di razionalizzare la spesa e ottimizzare i costi. Per quanto riguarda la redazione delle informazioni, la figura probabilmente più importante è quella dell’Information Broker. Si tratta di una figura molto simile a quella dell’Account nelle agenzie pubblicitarie. I suoi compiti sono quelli tipici della intermediazione con il cliente per il quale si impegna a raccogliere il maggior numero di informazioni nel minor tempo possibile secondo formati (grafici, tabelle, report, traduzioni) funzionali alle sue esigenze. Infine, sul versante della pubblicazione delle informazioni in rete si trovano figure come quella del Publisher Owner, cui spetta di decidere modalità e tempi della distribuzione e del mantenimento delle informazioni sul web, e del Packager, un free lance cui viene affidato il compito di allestire il progetto editoriale da posizionare sul mercato. A proposito di tutte queste figure si impongono alcune considerazioni che ci riportano al tema del mercato delle merci simboliche e, in parte, anche alle considerazioni iniziali sulla natura “mitologica” della società dell’informazione. Anzitutto occorre notare come esse abbiano un profilo per così dire ad assetto variabile, perfettamente in linea con i contorni fluidi delle loro competenze. Nella old economy vige una corrispondenza abbastanza stretta tra specializzazione professionale e compiti lavorativi richiesti all’interno dell’organizzazione. Non altrettanto avviene nelle imprese della new economy in cui gli assetti sono definiti contestualmente volta per volta. Questo significa, per restare a qualcuno degli esempi sopra forniti: che posso servirmi di un Information Broker oppure no; che le attribuzioni del Project Manager possono variare tra il caricarlo di responsabilità da Project Leader fino ad assorbire in sé anche quella funzione e il ritenerlo un semplice gestore di processo; che l’amministratore della mia rete aziendale può anche svolgere funzioni da Net Director. Anche in virtù di questa variabilità di profilo (e quindi per far fronte a una domanda molto mobile) tutte queste figure professionali si trovano di fatto nella condizione di imporre esse stesse la propria necessità intraorganizzativa. In sostanza non si visualizza l’utilità del Project Manager fino a quando qualcuno all’interno dell’organizzazione non evidenzia la necessità di affiancare il Project Leader con una figura che si occupi della gestione e del coordinamento del progetto seguendolo nelle sue diverse fasi realizzative, una funzione che non necessariamente può essere svolta da chi, come il Project Leader, ha invece competenze di progettazione alta e di visione sistemica dei processi. Si tratta di una logica perfettamente simulacrale, nel senso di Baudrillard, poiché il lavoratore del simbolico costruisce e fa legittimare un modello di figura professionale che prima non esisteva generando se stesso in quanto figura professionale a partire da questo modello. In tal senso, l’organizzazione di impresa della new economy, più che viziata da una forma di taylorismo di ritorno come qualcuno ha fatto notare (la proliferazione delle figure professionali, in essa risponderebbe, in questo senso, a una logica di razionalizzazione distributiva dei compiti in funzione di una ottimizzazione dei processi), pare caratterizzata piuttosto da una forma di autopoiesi (Maturana, Varela, 1984), cioè dalla capacità di autorganizzarsi dal proprio interno in relazione alle variabili di contesto e alle necessità della produzione. Questa spinta autopoietica attraverso la quale i lavoratori del simbolico legittimano se stessi e si ritagliano spazio dall’interno nelle organizzazioni va di fatto in loop con l’idea della società dell’informazione consentendo una volta di più di comprenderne il significato di impalcatura sociale. In buona sostanza si tratta di chiedersi se sia la società dell’informazione, di fatto presente, a spingere la diffusione delle professioni del simbolico, oppure non siano piuttosto le professioni del simbolico a conferire alla società dell’informazione il carattere della ben nota profezia che si autoavvera. 4.3. Sapere e impresa
Le trasformazioni che abbiamo descritto consentono, in ultima istanza, di articolare una riflessione sul nuovo significato che la conoscenza viene ad assumere all’interno di un mercato in cui l’informazione costituisce il principale elemento di valore. Sinteticamente si può indicare questa trasformazione parlando di uno spostamento da modelli “trasmissivi”, in cui il sapere è detenuto e trasferito da qualcuno a qualcun altro, a modelli “distributivi”, in cui invece esso è co-costruito e reso disponibile per altri che ne possano usufruire. Questa transizione consentirà di verificare come la conoscenza così intesa sia destinata a modificare in profondità le dinamiche interne all’impresa contribuendo a configurarla come una vera e propria knowledge company, cioè un’organizzazione in grado di adottare un atteggiamento strategico e operativo nei confronti della conoscenza intesa come l’insieme delle risorse costituenti il capitale intellettuale dell’azienda stessa. Infine, sulla base di questa nuova centralità della conoscenza nell’impresa, risulterà chiaro il compito decisivo che in questo tipo di economia sta sempre più rivestendo la formazione, soprattutto nelle forme dell’on line education: la new economy è in larga parte una learning economy. 4.3.1. Verso una nuova immagine della conoscenza David Weinberger (2002) suggerisce che l’evoluzione dell’idea di conoscenza si possa scandire in quattro grandi fasi che egli identifica con la filosofia, la scienza, il computer e il web. Percorrerle rapidamente consente di comprendere quale sia la specificità di ciascuna e, soprattutto, quali siano le caratteristiche della conoscenza oggi che ci troviamo nell’età in cui le reti telematiche incidono a tal punto sul sistema sociale da contribuire in maniera significativa alla sua definizione. Il problema della filosofia riguardo la conoscenza è sempre stato quello della certezza e si è tradotto nella ricerca delle modalità attraverso le quali fissare i criteri di validità del sapere. Queste modalità, dalla grecità al pensiero moderno, sono state indicate volta a volta in maniera diversa, ma sempre concordi, tranne poche voci di dissenso, nel riconoscere al momento razionale una superiorità rispetto a quello sensibile: lo si coglie chiaramente nella tradizione platonica, per cui lo sguardo teoretico di cui solo la ragione è capace è l’unico in grado di intuire l’idea, la forma che è anche paradigma ontologico della realtà; lo conferma l’aristotelismo, anche nelle sue riprese medievali, per il quale vero sapere è solo il sapere che risale alle cause, quindi l’argomentazione, cioè il lavoro della ragione; lo fissa con decisione Cartesio (e la sua posizione sarà fatta proprio dalla filosofia moderna fino a Kant e anche oltre) quando individua nell’orizzonte del pensiero l’unico elemento che si possa sottrarre agli effetti corrosivi del dubbio. La conseguenza di questo modo di impostare il problema è stata la graduale contrapposizione del pensiero con la realtà fino al limite ultimo della loro separazione. I termini della questione sono già chiari con Parmenide. Quando la dea che gli detta i versi del suo poema Sulla natura gli appare, distingue nettamente quello che la “via della verità” indica rispetto a quanto invece indica la “via dell’errore”: la prima è la via della riflessione razionale, la seconda quella dei sensi. La via dell’errore è quella percorsa da Eraclito che, stando all’esperienza delle cose, suggerisce che tutto muta nel mondo: le stagioni si alternano, la notte e il giorno si succedono, l’uomo invecchia e poi muore. Queste esperienze, passate al vaglio della ragione, appaiono contraddittorie: se, infatti, una cosa è, non può contemporaneamente non essere, come implicherebbe la posizione di chi, fidandosi dei sensi, nota che tutto si trasforma incessantemente. Quindi il divenire è un falso movimento, un’illusione dei sensi: la ragione mostra chiaramente che o c’è l’essere o c’è il nulla, senza transiti (come provocatoriamente Emanuele Severino continua anche oggi a sostenere). «Uno degli effetti di questa esagerata preoccupazione per la certezza è stato un generale distacco della filosofia dalla vita concreta, visto che una buona parte di ciò che interessa agli uomini non è generalmente in grado di superare il rigoroso esame gnoseologico della disciplina» (Weinberger, 2002, p. 164). La scienza, proprio negli stessi anni in cui Cartesio fissa le coordinate del cogito, sposta i termini della questione. La fondazione razionale di matrice filosofica cede il campo al metodo sperimentale
che, da Francesco Bacone a Galileo e Newton, fa sostanzialmente due vittime: il pregiudizio, cioè tutto ciò che di soggettivo può entrare ad alterare la conoscenza dei fatti così come sono, e il non verificato, cioè tutto ciò che non è sottoposto al vaglio dell’esperimento (Newton emblematicamente lo sintetizza nelle sue regole del metodo con il celebre “hypoteses non fingo”). In teoria, la scienza funziona in modo semplice: gli scienziati raccolgono i fatti, spesso con l’ausilio di esperimenti in grado di isolare le cause degli eventi; poi formulano delle ipotesi sulle possibili spiegazioni di tali fatti e le mettono alla prova. Le ipotesi vengono quindi aggregate in forma di teorie che sono considerate solide e certificate poiché i loro componenti essenziali – i fatti – sono adeguatamente provati. Così, la scienza descrive un mondo basato sulle prove e immune da punti di vista personali («libero da valori») (Weinberger, 2002, p. 164). Popper e l’epistemologia da lui influenzata (Kuhn, Lakatos, Feyerabend) interverranno su questo modello facendo notare che il fatto in sé non esiste e che, nel lavoro scientifico, esso acquisisce senso solo all’interno di un disegno che dipende dalla teoria. Ma questo non sposta il problema di dover comunque, nella conoscenza scientifica, aver a che fare con la capacità delle teorie di interpretare i fatti (tanto è vero che nel dibattito recente si registra una netta ripresa delle posizioni del realismo). La rivoluzione informatica e l’avvento del computer introducono, accanto a questi due modi “classici” di pensare la conoscenza, una terza prospettiva. Si tratta di una concezione “meccanica” e computazionale della conoscenza ben espressa dal noto principio degli informatici: “Garbage in, garbage out”, spazzatura dentro, spazzatura fuori. Questo significa che la bontà delle operazioni che il computer può compiere sulle informazioni che vengono in esso inserite dipende proprio da quelle informazioni, dalla correttezza della loro codifica. Una concezione della conoscenza, questa, che ha trovato nel cosiddetto modello matematico dell’informazione di Shannon e Weaver la propria legittimazione teorica e ha fornito per anni agli studiosi di intelligenza artificiale il modello in base al quale pensare l’analogia tra la mente umana e la mente artificiale: la capacità di calcolo, l’elaborazione meccanica dell’informazione. Con l’avvento di Internet ci troviamo di fronte a un modo di pensare la conoscenza completamente differente. Conoscere non vuol dire più raggiungere la certezza razionale su un problema (come per la filosofia), sottoporre una teoria al controllo dei fatti (come per la scienza), o processare informazioni pertinenti (come per l’informatica), ma condividere il nostro punto di vista. Come ben precisa ancora una volta Weinberger (2002, p. 176): «La conoscenza non è un corpo di verità autenticate con il sigillo della legittimazione: sul web diventa piuttosto attività sociale, un processo che si attiva e dispiega quando qualcuno dice qualcosa che gli interessa, qualcun altro risponde e ne segue una conversazione». La dimensione sociale di questo tipo di conoscenza, oltre a confermare le tesi delle recenti teorie sociali e dell’organizzazione, comporta alcune interessanti conseguenze. Cambia, anzitutto, il concetto di autorità. Nel web non sono i criteri ufficiali a sancire l’autorità in materia (titolo accademico, posizionamento nel mercato editoriale), ma la visibilità e il riconoscimento all’interno di una comunità professionale. Da questo punto di vista costituiscono una fonte di conoscenza straordinariamente più efficace le liste di discussione che non i miliardi di pagine di testo archiviate sui server del pianeta. Queste ultime, infatti, altro non sono che la versione on line di materiali cartacei quasi sempre già disponibili (anche se non facilmente reperibili, di qui l’utilità del web); nel caso delle liste di discussione, invece, stiamo parlando di esperti consultabili real time la cui capacità di elaborazione concettuale è continuamente in progress in relazione con i problemi che attraverso la lista di discussione vengono loro sottoposti. Da questa prima sottolineatura si ricava una seconda importantissima indicazione. Se la conoscenza accessibile in Internet dipende strettamente dalle interazioni sociali che nella rete si intrattengono, questo significa che più persone sono in rete e più possibilità si hanno a disposizione per realizzare conoscenza. Su questo fatto ha riflettuto in particolare Bob Metcalfe, il fondatore di 3Com, una delle più importanti aziende per la produzione di hardware di rete. Secondo Metcalfe il valore Vr di
una rete cresce con il quadrato del numero di persone che sono collegate in quella rete. Questa relazione matematica è nota come legge di Metcalfe e si esprime nella formula: Vr = n (n – 1), dove n è il numero degli utenti connessi in rete e (n – 1) indica il fatto che quando mi connetto con me stesso ottengo il segnale di linea occupata. Quindi il vero valore conoscitivo di Internet non risiede tanto nei documenti, quanto nei contatti. David Reed, professore al MIT di Boston e poi direttore del laboratorio di ricerca della Lotus, è tornato sulla legge di Metcalfe correggendola (o forse, meglio, integrandola). Infatti, su base empirica, la legge risulta attaccabile se solo si nota che la crescita esponenziale delle persone connesse non necessariamente implica la crescita esponenziale dei contatti: in altre parole, non è detto che se il numero degli utenti cresce cresca proporzionalmente anche il numero dei miei contatti (banalmente, il fatto che sempre nuovi utenti ottengano un allacciamento telefonico non implica che il mio uso del telefono aumenti esponenzialmente). Reed, ragionando su questa difficoltà che apparentemente parrebbe mettere in discussione la legge di Metcalfe, ne ha tratto spunto per riformularla. Il vero valore di Internet non è dato dal numero dei contatti singoli, ma dal fatto che questi singoli entrano a far parte contemporaneamente di una molteplicità di gruppi. La legge di Reed traduce in formula questa constatazione: 2n – (n -1). Al di là dei termini numerici della questione, la legge di Reed fornisce una giustificazione teorica al fatto che la conoscenza in Internet è conoscenza condivisa. Il knowledege management e l’idea secondo cui in esso consiste il capitale di un’impresa poggia su questa fondamentale constatazione. 4.3.2. L’intelligenza, capitale dell’impresa Quando si afferma che l’intelligenza è il vero capitale dell’impresa si pensa ad essa come alla capacità di utilizzare il sapere in maniera appropriata secondo i diversi contesti. Questo implica, anzitutto, la registrazione della differenza esistente tra i termini “intelligenza” e “sapere” ed altri che di solito vengono utilizzati come loro sinonimi quando si fa riferimento al problema della conoscenza in contesto aziendale: “informazione”, “dati”. Tecnicamente si può dire che un dato è una stringa di valori numerici, cioè un insieme di segni. Quando due o più di questi dati vengono combinati insieme si ottiene un’informazione. Nella misura in cui questa informazione viene interpretata, cioè inquadrata in un contesto e messa in relazione con un sistema di conoscenze preesistenti si genera sapere. L’intelligenza implica la riflessione su questo sapere, la sua comparazione con altri saperi, la valutazione operativa e strategica di ciò che a partire da esso è possibile ritenere o progettare (Fig. 1). Quindi, nel caso dell’organizzazione, non sono tanto i dati bruti o le informazioni in sé a costituire valore, quanto piuttosto la possibilità di sviluppare da essi dei saperi e, in ultima istanza, promuoverne un uso intelligente. La soddisfacibilità di questa esigenza dipende dal controllo di due ordini di variabili:
q anzitutto dalla possibilità di rendere visibile il sapere esplicito (cioè le procedure, le pratiche codificate, l’informazione) e di favorire la socializzazione del sapere implicito (cioè il saper-fare che appartiene agli esperti e che quindi difficilmente può essere codificato in informazione trasferibile);
q in secondo luogo dalla capacità di «lottare contro la “corporate amnesia” (e cioè la dimenticanza di quanto l’organizzazione ha in passato appreso), l’autismo collettivo (la tendenza dell’organizzazione a ritenersi autoreferenziale impermeabilizzandosi rispetto al cambiamento) e la resistenza dei gruppi all’innovazione (“groupthink effects”)» (Eppler, 2002, p. 3; l’impostazione dell’intero paragrafo si rifà a questo contributo).
Entrambe le condizioni trovano nell’ITC un’opportunità di sviluppo e resa applicativa.
Per quanto riguarda il sapere esplicito, un sistema finalizzato alla sua gestione in azienda – di solito si tratta di una rete Intranet - deve prevedere quattro funzioni (Eppler, 2002, p. 5):
q collaborazione. Questa funzione è garantita da tecnologie per il CSCW (Computer Supported Collaborative Work), attraverso le quali è possibile, ad esempio, a membri diversi della stessa organizzazione coeditare un documento, e per il CSCL (Computer Supported Collaborative Learning), cioè la maggior parte dei corsi on line attraverso i quali in azienda si provvede alla formazione in servizio del personale. Queste funzioni possono essere integrate in piattaforme più complesse (groupware) grazie alle quali il lavoro collaborativo viene sostenuto con strumenti di comunicazione asincrona (come i forum) e sincrona (i diversi sistemi di aula virtuale);
q gestione dei contenuti. Questa funzione viene di solito garantita attraverso l’agenda personale e di gruppo del singolo utente e l’accesso a cartelle condivise di materiali. L’importanza di questo tipo di servizio sta nella possibilità di dirimere eventuali questioni relative a versioni diverse dello stesso documento e di attingere a un patrimonio di materiali di comune utilità ai diversi livelli (individuale, di piccolo gruppo, di reparto, dell’intera organizzazione);
q visualizzazione e aggregazione. Si tratta di una funzione garantita dai cosiddetti knowledge visualizer, cioè da veri e propri portali interni all’organizzazione di solito strutturati in modo da fornire un accesso organizzato alle risorse (attraverso tassonomie per processi, progetti, ecc.) e un lessico concettuale condivisibile (di solito attraverso lo sviluppo di un glossario interno all’organizzazione);
q ricerca ed estrazione intelligente. Attraverso questa funzione è possibile ottenere che il singolo utente venga facilitato nell’accesso alle informazioni che verosimilmente potrebbero essere di suo interesse, risultato che si ottiene di solito attraverso la definizione di profili personali di utenza in base ai quali favorire lo smistamento delle informazioni automaticamente in posta elettronica (push) o attraverso una ricerca condotta appunto per profilo (pull).
intelligenza riflessione
sapere applicazione
informazione combinazione
dati aggregazione
segni Figura 1 – I livelli della conoscenza nel contesto dell’impresa (Fonte: Eppler, 2002).
Anche la socializzazione del sapere implicito può trovare un valido supporto nella tecnologia Intranet. In particolare sono ancora una volta quattro le operazioni possibili:
q sviluppo del sapere. È specifico soprattutto delle comunità di pratica, cioè di quei gruppi di utenti appartenenti alla stessa organizzazione che si occupano degli stessi problemi. All’interno di queste comunità, di solito supportate da servizi di forum e di chat, lo sviluppo del sapere può essere perseguito attraverso modalità differenti: workshop finalizzati alla soluzione di problemi e a spingere l’innovazione (Team Syntegrity – Beer, 1993), spazi di lavoro che attraverso la simulazione disegnano gli scenari futuri (Future Labs), spazi di confronto e di riflessione dedicati allo sviluppo di nuove idee e concetti (Think Thanks);
q trasferimento del sapere. Si può ottenere in modi diversi, tra cui sono particolarmente impiegati i “mercatini telematici” in cui i differenti gruppi di progetto possono presentare a tutti gli altri gruppi dell’organizzazione i temi di cui si stanno occupando e interagire con essi al riguardo, e le diverse forme di tutoring grazie alle quali i nuovi assunti possono essere accompagnati da esperti senior nella fase di apprendimento del loro lavoro;
q applicazione del sapere. Anche in questo caso si fa ampio ricorso a sistemi di simulazione sia per socializzare le azioni e gli step che di solito sono necessari per la realizzazione di un progetto (Project Labs), sia per la formazione delle equipe (Team Training);
q valutazione. Nel corso della realizzazione di un progetto le persone in esso coinvolte portano in gioco le proprie conoscenze implicite per far fronte ai problemi che volta a volta si presentano. Il ricorso alla valutazione, nella forma dello studio di caso, può servire a esplicitare queste conoscenze convogliandole verso una zona della Intranet in cui tutti i membri dell’organizzazione possono trovare sintetizzati, per ogni singolo progetto, i “più” e i “meno”.
Evidentemente in tutti e due i casi esaminati (sapere esplicito e implicito) l’apporto della infrastruttura tecnologica è fondamentale, ma non servirebbe a nulla se non fosse in grado di facilitare delle relazioni reali. Questo sposta decisamente l’attenzione dalla tecnologia alle risorse umane. 4.3.3. La learning economy Le considerazioni appena svolte a proposito della gestione dell’intelligenza in azienda consentono di capire che un’impresa, per poter essere riconosciuta una knowledge company, non necessariamente deve appartenere al comparto informatico o della new economy: la variabile decisiva, a questo riguardo, è il livello di formalizzazione secondo cui quest’impresa considera la componente intellettuale come parte integrante del patrimonio aziendale, riconosce la centralità del sistema informativo e delle tecnologie della conoscenza, fa di tutto questo un nodo della cultura e della prassi manageriale. Ma, in particolare, questo tipo di organizzazione si dimostra profondamente legata alla capacità di apprendere, in termini assoluti e dal proprio stesso operare. Il concetto di learning economy nasce qui ed indica, nel termine stesso, il fatto che il mercato della formazione e dell’apprendimento costituiscono nella società dell’informazione uno dei principali capitoli di spesa delle aziende. Evidentemente tempi e metodi della formazione hanno dovuto accogliere le esigenze dell’azienda stessa riprogettandosi secondo modelli “leggeri”, compatibili con il tempo e i compiti lavorativi, flessibili in modo da adeguarsi ai percorsi personali di apprendimento dei singoli lavoratori. Così il boom della formazione è consistito, negli ultimi anni, quasi per via identificativa, con il boom della formazione on line. La previsione per il 2004 è di un incremento del mercato dell’e-Learning pari all’83% contro una crescita dell’11% degli altri segmenti del mercato della formazione, con il mercato europeo in grado di sfiorare i 4 miliardi di
dollari, di cui 150 milioni circa fatturati dal solo mercato italiano (McGovern, 2001): la learning economy è di fatto una e-Learning economy. Occorre subito rilevare che si tratta di un’economia anomala poiché la conoscenza è un bene particolare, come del resto il mercato su cui viene scambiata. Una prima ragione di questa anomalia dipende dal fatto che i benefici di un “acquisto” di formazione sono difficilmente misurabili e comunque, anche quando lo sono, passa generalmente molto tempo dal momento in cui si segue il corso on line e quello in cui si può misurare la sua spendibilità a livello di capacità produttiva e di reddito. Due esempi possono aiutare a capire la questione. L’acquisto di un corso on line che consentirebbe a un imprenditore di aprire una nuova linea di produzione ad alto profilo di innovazione potrebbe risultare una spesa inutile qualora quell’imprenditore si rendesse poi conto che quel tipo di scelta gli comporterebbe una maggiorazione di spesa insostenibile. Allo stesso modo, un professionista che intendesse migliorare la propria conoscenza della lingua inglese potrebbe iscriversi a una community per l’apprendimento collaborativo della lingua straniera, ma poi potrebbe passare molto tempo tra la conclusione del suo corso e il momento in cui si troverà a sperimentare le competenze acquisite con il rischio che al momento dell’impiego potrebbe già aver perso il vantaggio costituito dal fatto di aver frequentato il corso. Un secondo motivo di anomalia è che nel caso dell’e-Learning la cessione delle conoscenze non impoverisce chi le offre: l’expertise resta tale anche se viene condivisa. Il problema, piuttosto, è un altro e cioè il fatto che più le conoscenze divengono condivise più si riduce il loro valore. Ecco perché nel mercato dell’e-Learning uno dei problemi cruciali è costituito, per chi eroga servizi di formazione, dalla possibilità di vendere formazione senza condividere l’expertise che gli consente di venderla. Questo spiega la grande cautela che le corporations mettono nella difesa del proprio know how e la rilevanza a livello di dibattito cui sta assurgendo la problematica del diritto d’autore e del copyright relativo a procedure e good practices. Questo nuovo mercato, con le sue anomalie, è insieme un prodotto e un segmento rilevante della new economy. Ne è un prodotto, perché nella new economy il bisogno di formazione, anche dei lavoratori più anziani, è notevolmente più alto che negli altri segmenti produttivi, e per soddisfare questo bisogno di formazione il new training (basato sulla rete Internet) pare un passaggio obbligato. Non solo. L’e-Learning garantisce ai lavoratori della new economy quelle condizioni – motivazione, prestazioni, collaborazione, innovazione – che sono parte integrante della loro professione. Il risultato è che proprio la new economy costituisce uno dei fattori di spinta e di sviluppo dell’e-Learning, tanto da farne uno dei suoi sottosegmenti più promettenti, molto più promettenti, già oggi, rispetto sia all’e-Commerce che all’e-Business. Proprio questa reciprocità tra economia digitale e mercato della formazione on line ci consente di ritornare confermandole su alcune delle tesi a cui abbiamo agganciato la nostra analisi. Anzitutto l’e-Learning verifica il carattere mitologico della società dell’informazione e dei suoi elementi portanti. Il mito, nella prospettiva antropologica e funzionale da cui l’abbiamo assunto in questo contributo, costituisce una demarcazione dei limiti del reale, cioè un orizzonte in cui l’uomo colloca le cose per poterle conoscere. Questa logica ordinatrice delle cose si esprime poi sempre attraverso un racconto di accompagnamento (mithologoumenon) che ha la funzione di articolarlo radicandolo sul piano individuale e sociale. Letto in quest’ottica, l’e-Learning funziona mitologicamente perché cor-risponde all’idea di una società “fatta” di informazione e tecnologia dimostrando di interpretare al meglio le sue caratteristiche: infatti, l’e-Learning è un modello di formazione che accetta la sfida della velocità (sia nel senso della velocità della trasmissione che in quello della rapidità di aggiornamento delle conoscenze), è per sua struttura virtuale (emancipando l’insegnamento/apprendimento dalla dipendenza dallo spazio-tempo), fa della struttura di rete e dell’apertura al globale le sue dimensioni naturali. Oltre a questo, l’e-Learning provvede anche al mito della società dell’informazione un racconto di accompagnamento. Si tratta del racconto delle competenze che
invecchiano in fretta, delle informazioni che vanno rese disponibili “everywhere, anytime for everyone”, della dimensione collaborativa che solo in rete telematica è possibile applicare in termini effettivamente funzionali. Se si torna sulla mutua implicazione di new economy ed e-Learning (la new economy “spinge” l’e-Learning che, nella misura in cui viene spinto da essa, la alimenta “spingendola” a sua volta) si comprendono anche le ragioni economiche e sociali del mito e del suo racconto di accompagnamento: il mito alimenta l’economia, attraverso il tema della necessità dell’aggiornamento costante crea un mercato – quello della Longlife Education – destinato a prolungarsi indefinitamente, favorisce l’inserimento di figure professionali nuove. Proprio nella misura in cui fa della conoscenza un bene da scambiare, l’e-Learning conferma anche l’altra tesi che, attraverso le analisi di Baudrillard, abbiamo messo a fuoco e cioè il fatto che la società dell’informazione sia caratterizzata dal primato delle merci simboliche. La formazione on line, da questo punto di vista, incarna alla perfezione un’attività simulacrale del terzo ordine: fa leva su bisogni secondari che essa stessa contribuisce ad alimentare; non produce merce ma apprendimento, cioè qualcosa di estremamente difficile da misurare e soprattutto tale per cui il suo mancato ottenimento non è mai imputabile esclusivamente ai limiti dell’intervento formativo; vende all’utente competenze, cioè qualcosa di assolutamente immateriale e soggettivo che può essere incarnato solo da figure di esperto iperspecializzate. Dunque, la learning economy come dispositivo mitologico che crea mercato attorno alla merce simbolica della conoscenza e legittima socialmente figure professionali sempre più competenti in cose sempre meno importanti, come direbbe Panikkar (1990): occorre capire se si tratta di un nuovo inizio, di una fase transitoria o solo del compimento di un destino. Nuovo umanesimo o disperazione della finitezza?
BAUDRILLARD, J., 1976, L’echange symbolyque et la mort, Gallimard, Paris ; tr.it., Lo scambio simbolico e la morte, Feltrinelli, 1979. BEER, S., 1993, Origins of Team Syntegrity, In Internet, URL: http://www.staffordbeer.com/papers/Origins%20Team%20Syntegrity.pdf. BENEDIKT, M., (ED.) 1991, Cyberspace: First Steps, The MIT Press, Cambridge (Mass.). BENJAMIN, W., 1955, Das Kunstwerk in Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit in Schriften, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main; tr. it., L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 1976. BERRA, S., 2000, Dossier nuove professioni, «Net Business», 7-8, luglio-agosto. BRETON, P., 1993, L’utopie de la communication, La Découverte, Paris; tr. it., L’utopia della comunicazione, UTET, Torino 1995. CASTELLS, M., 1996, The Rise of the Network Society, Blackwell, Malden, Massachussets. Parziale traduzione italiana: La nascita della società in rete, Università Bocconi, Milano 2002. DAYAN, D., KATZ, E., 1992, The live broadcasting of history, Harvard University Press, Cambridge; tr.it., Le grandi cerimonie dei media, La storia in diretta, Baskerville, Bologna 1993. EPPLER, M.J., 2002, Le savoir dans le contexte de l’entreprise. Individus, systémes et socialisation, «Quaderni dell’Istituto Comunicazione e Formazione», 5. GIBSON, W., 1984, Neuromancer, Ace Books, New York. GOODMAN, N., 1968, Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols, Bobbs-Merrill, Indianapolis; tr. it., I linguaggi dell'arte, Il Saggiatore, Milano1976. KOTLER, P., JAIN, D.C., MAESINCEE, S., 2000, Marketing Moves. A New Approach to Profits, Growth and Renewal, Harvard Business School Press, Boston; tr. it., Il marketing che cambia. Un nuovo approccio al profitto, alla crescita e al rinnovamento, Il Sole 24 ore, Milano 2002. LEVY, P., 1995, Qu’est-ce que le virtuel?, La Découverte, Paris; tr. it., Il virtuale, RaffaelloCortina, Milano 1997. –, 1995, Cyberculture. Raport au Conseil de l’Europe, Odile Jacob, Paris; tr. it., Cybercultura. Gli usi sociali delle nuove tecnologie, Feltrinelli, Milano 1999. MALDONADO, T., 1992, Reale e virtuale, Feltrinelli, Milano. MATTELART, A., 1996, La mondialisation de la communication, PUF, Paris; tr. it., La comunicazione globale, Editori Riuniti, Roma 1998. –, 2001, Histoire de la société de l’information, La Découverte, Paris; tr.it., Storia della società dell’informazione, Einaudi, Torino 2002. MATURANA, H., VARELA, F., 1984, El arbol del conocimiento, ; tr. it., L’albero della conoscenza, Garzanti, Milano 1992. MCGOVERN, S., 2001, L’avanzata dell’e-Learning, «Il Sole 24 Ore.com», 23.5. In Internet, URL: http://neteconomy24.ilsole.com/art.jhtml?codid=22.0.199342663. MORIN, E., KERN, A.B., 1993, Terre-Patrie, Editions de Seuil, Parsi; tr. it., Terra-Patria, Raffaello Cortina, Milano 1994. NEVEU, E., 1994, Une société de la communication?, Montchrestien, Paris. –, 2002, Profession : journaliste, «Sciences Humaines», 129, luglio 2002, pp. 22-25. PANIKKAR, R., La Torre di Babele, ECP, Firenze 1990. RIVOLTELLA, P.C., Condividere significati. Comunicazione, socialità e didattica in Internet, Erickson, Trento 2003. ROSSI, A., 2002, Il mito del mercato, Città aperta, Troina. THOMPSON, J.B., 1995,The Media and the Modernity. A Social Theory of the Media, Polity Press, Cambridge; tr.it., Mezzi di comunicazione e modernità. Una teoria sociale dei media, Il Mulino, Bologna 1998. TURKLE, S., 1995, Life on the screen. Identity in the age of Internet, Simon & Schuster, New York; tr. it., La vita sullo schermo. Nuove identità e relazioni sociali nell’epoca di Internet, Apogeo, Milano 1997.