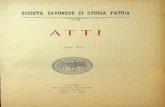A. BARTOLACELLI, Profili del recesso ad nutum nella società per azioni
Transcript of A. BARTOLACELLI, Profili del recesso ad nutum nella società per azioni
ALESSIO BARTOLACELLI
Profili del recesso ad nutum nella società per azioni
Sommario: 1. Cenni sul recesso ad nutum in generale e sul concetto di società costituita atempo indeterminato. – 2. Il recesso ad nutum da società contratte a tempo indetermi-nato: profili generali. – 3. Legittimazione. – 4. Modalità di esercizio: coordinamento tragli artt. 2328 e 2437 c.c. – 5. Segue: il preavviso e la dichiarazione. – 6. Segue: status so-cii e ius variandi. – 7. Valutazione e liquidazione. – 8. Inderogabilità e rinuncia. – 9. Re-cesso ad nutum da società a tempo determinato? – 10. Considerazioni conclusive.
1. – Come è noto, l’istituto del recesso ad nutum, ovvero quel partico-lare caso in cui lo scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale è de-mandato alla volontà discrezionale in tale senso di uno dei contraenti, co-stituisce nel nostro ordinamento giuridico un’eccezione. Solamente inpochi casi, infatti, il legislatore ne ha fatto uso (1), e proprio per tale ragio-ne l’ipotesi che qui si considera assume una notevole importanza, pure daun punto di vista sistematico; in particolare la portata dell’innovazioneemerge in tutta evidenza qualora si consenta la sua applicabilità in via sta-tutaria pure alle società contratte a tempo determinato.
L’innovazione di cui si discute, peraltro, è tale solamente qualora si as-suma come terreno di riferimento il solo campo delle società di capitali (2).
(1) Si rammentano, a titolo di esemplificazione e senza alcuna pretesa di completezza,i seguenti casi, previsti ora dalla normativa codicistica, ora dalla legislazione complementa-re: art. 1373 c.c., in tema di recesso unilaterale dal contratto; art. 1671 c.c., sua specificazio-ne in materia di contratto d’appalto; art. 1985 c.c. per il recesso dal contratto di cessione deibeni ai creditori; art. 2227 c.c. (contratto d’opera); art. 2237 c.c. (prestazione d’opera intel-lettuale); artt. 4 ss., d. lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, per il caso di recesso da contratto nego-ziato al di fuori dei locali commerciali; art. 5, d. lgs. 9 novembre 1998, n. 427 in materia direcesso da contratti mediante i quali si costituiscano diritti reali in regime di multiproprietàsu beni immobili. Necessariamente non si può non citare pure la normativa in tema di di-ritto del lavoro, che trova, quanto al recesso ad nutum, la sua collocazione codicistica negliartt. 2118 e 2244 c.c., peraltro da integrare con una sovrabbondante normativa complemen-tare ancora in fase di stabilizzazione. Si sarà naturalmente notata l’assenza, da questa fintroppo lunga lista, di norme quali l’art. 2285 c.c., dettato per le società di persone; di questae di altre disposizioni aventi ad oggetto casi di recesso da contratti a tempo indeterminatosi darà conto infra nel testo.
(2) È interessante vedere come, nelle varie tipologie sociali che si sono susseguite nel-l’esperienza statunitense, sia quasi sempre stata a disposizione del socio che desiderasse
Come è noto, il nostro ordinamento in materia societaria prevedeva già pri-ma della riforma, con norma che dal 1942 ad oggi non ha subito alcuna mo-difica, un caso di recesso non sottoposto ad alcuna condizione, circoscritto,però, al solo novero delle società di persone. L’art. 2285 assurge, alla lucedelle modifiche apportate dalla riforma Vietti all’impianto codicistico detta-to in tema di società di capitali, ad importante pietra di paragone che con-sente di misurare la cifra dell’(eventuale) avvicinamento delle società di ca-pitali alle società di persone (3). Ci sembra che non si possa prescindere dallegame tra la vecchia disposizione dettata per le società di persone e la nuo-va formulazione dell’art. 2437, comma 3°, c.c.; ben si può affermare, anzi,che la prima costituisce una sorta di « sorella maggiore» della seconda,quantomeno per l’individuazione della categoria di società ai cui parteci-panti è imprescindibilmente concessa la facoltà di recedere anche in assen-za di una «giusta causa» (4) o di una qualsiasi altra ricorrenza di ipotesi di
1126 CONTRATTO E IMPRESA
uscire dalla compagine una via di exit: cfr. Blair, Reforming Corporate Governance: WhatHistory can Teach Us, reperibile on-line http://papers.ssrn.com/abstract=485663, spec. pp.13, 42, 56 del dattiloscritto.
(3) Avvicinamento che tutta la dottrina non ha mancato di notare, specie per quanto ri-guarda la nuova s.r.l., che di volta in volta può passare, a seconda delle esigenze dei con-traenti, da « piccola s.p.a. » a « grande s.n.c. »; per un interessante ed assai completa analisidi tale concetto, si veda, per tutti, Zanarone, Introduzione alla nuova società a responsabi-lità limitata, in Riv. soc., 2003, p. 58 ss. Per quanto riguarda più specificamente il diritto direcesso, Cagnasso, Commento all’art. 2473, in Il nuovo diritto societario, diretto da Cottino(e altri), vol. 2, Bologna, 2004, p. 1841.
(4) Interessante, per l’ipotesi del recesso per giusta causa da una società di capitali, Trib.Milano, 9 settembre 1991, con nota adesiva di Niccolini, Recesso per giusta causa da societàdi capitali?, in Riv. dir. comm., 1992, p. 71 ss.; l’a., sia pure nella vigenza della precedente di-sciplina, si esprimeva in termini fortemente critici quanto alla possibilità di configurazionedi un’ipotesi di recesso per giusta causa da società di capitali, motivando la propria posizio-ne non tanto in ragione dell’allora maggioritario orientamento che non riteneva possibile laprevisione di casi statutari di recesso, quanto: a) in relazione al fatto che « il recesso ‘pergiusta causa’ (. . .) quale espressione tipica del carattere personale della partecipazione so-ciale non può non rimanere in principio estraneo, per sua intrinseca incompatibilità conl’ordinamento di questi, ai modelli societari che attribuiscono rilievo reale alla partecipa-zione sociale » (ivi, p. 80 s.); b) in ragione del fatto che, se il recesso in tale forma fosse sta-to da considerare ammissibile, « inevitabilmente risulterebbe svincolato, per connotato dipresupposto obiettivo, dal contenuto delle deliberazioni assembleari (. . .) tradendo la pro-pria origine storica e venendo meno alla propria caratteristica funzione, di meccanismo (. . .)temperativo del rigore della regola maggioritaria » (ivi, p. 81).
L’ultima obiezione dell’a., come si è appena visto, è stata superata dalla lettera stessadella legge (e si potrebbe quindi dire, con le parole di Niccolini, che il recesso ha tradito lapropria origine ed è venuto meno alle proprie funzioni. . .); per quanto riguarda, invece, la
recesso legale o statutaria: l’essere la società contratta a tempo indetermi-nato. Sembra debba rinvenirsi in questo il massimo comune denominato-re, quantomeno espresso, tra le due norme: il concetto di « giusta causa» direcesso non ha trovato albergo nell’impianto (legale) riformato delle societàdi capitali; ed anche in materia di recesso ad nutum si segnalano almenodue aspetti di non completa aderenza: da un lato il differente termine dipreavviso (5), dall’altro l’inciso, previsto nell’art. 2285, ma non ripreso dallanormativa relativa alle s.p.a., che equipara le società contratte per la duratadell’intera vita di uno dei soci a quelle a tempo indeterminato.
Quanto al primo punto, non pare difficile sostenere che il differentetermine è ancora una volta diretta conseguenza delle diverse caratteristi-che dei due tipi di società, e, in certo senso, della stessa tipologia dei soci:mentre nelle società di persone sarà più agevole rinvenire una composi-zione sociale basata su conferimenti di norma non particolarmente ingen-ti operati in prevalenza da persone fisiche (6), non così nelle società di ca-
SAGGI 1127
perplessità a consentire l’ipotesi del recesso per giusta causa in ragione della diversa naturadelle società per azioni rispetto alle società di persone, sembra che tale posizione non solodebba essere condivisa tout court, ma che abbia pure resistito all’erosione del tempo ed al-l’avvento delle nuove regole, trovando conferma persino nella Relazione Ministeriale allaRiforma, par. 9, ove si rimarca il ruolo centrale dell’azione nella partecipazione in s.p.a.; di-versamente, invece, avviene per le s.r.l., in cui, in seguito alla riforma, ha assunto maggioreimportanza la figura del socio fisicamente intesa. Il risultato di una tale impostazione èquello di ritenere ammissibile una clausola statutaria che legittimi il recesso per giusta cau-sa solamente nelle società a responsabilità limitata, essendo essa incompatibile, invece, conun sistema de-personalizzato come quello delle s.p.a.
(5) Che, si ricorda, è di almeno tre mesi per le s.n.c., mentre per le s.p.a. passa ad al-meno centottanta giorni non estendibili a più di un anno.
(6) Che socio di società di persone potesse essere pure una società di capitali era fontedi controversie nella previgente disciplina. Il problema risulta oggi superato in ragione del-la previsione ex art. 2361, comma 2°, che statuisce che qualora la società assuma in altre im-prese partecipazioni comportanti l’assunzione della responsabilità illimitata per le obbliga-zioni delle medesime (e tale è il caso, ad es., di una s.p.a. che acquisti partecipazioni in unas.n.c.), la deliberazione relativa dovrà essere presa dall’assemblea. A questo punto interes-sante potrebbe essere, ma esula dall’oggetto del presente lavoro, vedere in quale modo sidebba affrontare il problema della durata della società di persone qualora essa sia contrattaper l’intera vita del socio persona giuridica. Qualora, infatti, quest’ultima sia costituita atempo indeterminato, o a tempo solo formalmente determinato in base a quanto si dirà in-fra, il problema non si porrebbe ed il recesso dovrebbe comunque essere riconosciuto qua-le diritto di tutti i soci. Questione più interessante, invece, è quella riguardo a come com-portarsi per il caso della società di persone costituita per tutta la vita di un socio-personagiuridica che però sia fornita di termine finale. Ci pare che, nonostante la società sia con-tratta per la durata di tutta l’esistenza di un socio, in questo caso il recesso ex art. 2285 non
pitali, ove l’investimento di forti somme da parte di soci persone giuridi-che giustifica e legittima un lasso di tempo maggiore al fine del reperi-mento, da parte della società, dei fondi per liquidare il socio recedente.
Più complesso, invece, pare il secondo punto. Come già si è accenna-to, l’essere il contratto a tempo indeterminato è uno dei presupposti piùricorrenti nelle varie ipotesi di recesso ad nutum, e non solo in campo so-cietario (7); in questo senso si potrebbe dire che il recesso incondizionatorappresenta, per la società, il « prezzo » cui essa deve (potenzialmente) es-sere soggetta per il fatto di tenere i propri soci avvinti a sé per un temponon definito (8). È a questo punto imprescindibile premettere alla tratta-zione dell’istituto l’analisi del concetto stesso di tempo indeterminato perquanto riguarda le società. In altre parole, se è ovvio affermare che è for-malmente a tempo indeterminato quella società che nell’atto costitutivonon riporti il proprio termine finale, non è certo inutile tentare di capirequando essa sia da considerarsi sostanzialmente contratta sine die, pur es-sendo stabilito in via formale un termine (9). Ciò può accadere, fonda-mentalmente, in due casi (10): da una parte vi è la società contratta a tem-
1128 CONTRATTO E IMPRESA
sia da attribuire, essendo da considerarsi la società stessa implicitamente costituita a tempodeterminato, salvo, naturalmente, delibera di proroga della durata del socio persona giuri-dica.
(7) Es. in tale senso, volutamente tralasciati dall’elenco della nota 4, sono rappresenta-ti, oltre che dall’art. 2285 di cui si sta trattando, dagli artt. 1750 (recesso da contratto di agen-zia a tempo indeterminato), 1833 (recesso da contratto di conto corrente), 1845 (recesso dacontratto di apertura di credito bancario) c.c.
(8) Si può forse vedere in questo un paradosso: la società contratta a tempo indetermi-nato può essere considerata da un lato come un ente tendenzialmente eterno, e dall’altrocome un organismo perennemente condizionato nel suo stesso essere da una volontà in ta-le senso dei suoi soci.
(9) Il caso è segnalato, in termini sostanzialmente problematici, da Cagnasso, Recesso edesclusione del socio: interessi in gioco e « costi » degli strumenti di tutela, in AGE, 2003, 2, p. 365.Sono favorevoli ad ammettere la durata indeterminata anche per il caso di termine sproposi-tato Paciello, Commento all’art. 2437, in Le società di capitali, a cura di Niccolini-Stagnod’Alcontres, Napoli, 2004, p. 1115; D’Andrea, Recesso del socio nelle società per azioni. Lanuova disciplina e qualche riflessione, in La riforma del diritto societario. Profili civili e panali,a cura di Lanzi-Franceschelli, Milano, 2004, p. 51. Decisamente contrario a tale ipotesi è Cap-piello, Commento all’art. 2437, in Aa.Vv., Codice commentato delle nuove società, Milano,2004, p. 847, che argomenta a partire dalla eccezionalità della ipotesi di recesso in esame.
(10) Il terzo, quello della società inizialmente contratta a tempo determinato che ha poisubito una proroga a tempo indeterminato pare possa agevolmente fatto ricadere nel casogenerale della società contratta ab origine a tempo indeterminato, con l’ovvia avvertenza diattribuire il diritto di recesso ad nutum ai soci solamente dal momento della delibera di pro-roga.
po determinato, ma avente un termine finale tanto lontano da potere es-sere considerata, de facto, a tempo indeterminato; dall’altra il caso analo-go di una proroga di durata spropositata che si presenti però solo al mo-mento della proroga della società, inizialmente contratta a tempo deter-minato formale e sostanziale (11). Il problema più serio è quello dell’indi-viduazione del punto di discrimine superato il quale una società che abbiauna durata formalmente determinata possa essere considerata di fattosprovvista di un termine finale. Come è stato segnalato, mentre la norma-tiva in tema di recesso da società di persone risolve il problema equipa-rando la società contratta per l’intera vita del socio (persona fisica, e a for-tiori, persona giuridica) ad una società contratta a tempo indeterminato,nulla si dice riguardo a tale problema nell’ambito delle società di capitali (12).È stata proposta (13), riguardo a tale problema, una soluzione, pare condi-
SAGGI 1129
(11) Per quanto, invece, riguarda il caso della proroga di fatto della società, la necessitàpare essere quella di capire se sia sufficiente la continuazione dell’attività sociale a fare con-siderare la società come contratta a tempo indeterminato, oppure occorra l’apposizione,nell’atto costitutivo, di ulteriori informazioni. Sull’argomento, sia pure da un diverso pun-to di approccio, si v. anche la nota successiva.
(12) Si anticipa fin d’ora come non soccorra, in tal senso, neppure la formulazione del-l’art. 2328, comma 2°, n. 13. In base a tale disposizione, infatti, l’atto costitutivo deve con-tenere « la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il pe-riodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere»;ai fini che in questo momento interessano, quindi, si potrebbe affermare che non sarebbesufficiente, perché la società possa dirsi contratta sine die, il fatto che nel suo atto costituti-vo non si faccia menzione della durata, essendo indispensabile anche l’indicazione delladurata del « periodo finestra » durante il quale non è dato al socio di recedere. Si vedrà me-glio nel prosieguo della trattazione come tale conclusione possa non essere condivisa qua-lora non si ravvisi nella seconda parte del periodo di cui al n. 13 dell’art. in esame un inuti-le « doppione » dell’art. 2437, comma 3°, che prevede un preavviso compreso tra i sei mesi el’anno per l’efficacia del recesso.
(13) Morano, Analisi delle clausole statutarie in tema di recesso alla luce della riformadella disciplina delle società di capitali, in Riv. not., 2003, p. 303 ss. (spec. p. 311 ss.). L’a., pe-raltro, distingue a seconda che la partecipazione faccia capo ad una persona fisica piuttostoche giuridica. Fermo restando che ci si troverebbe certamente dinanzi a società contratta atempo indeterminato qualora la sua durata fosse superiore alla lunghezza della vita mediadi una persona fisica, egli manifesta perplessità nel caso in cui l’azionista sia una personagiuridica, rispetto al quale certo non si può individuare un criterio di « vita media ». Il risul-tato di un tale distinguo è costituito dal consentire il recesso ai soci persone fisiche, negan-dolo agli azionisti persone giuridiche in ragione proprio della impossibilità di identificareun « parametro atto a stabilire il limite oltre il quale un termine di lunga durata possa equi-pararsi ad una durata senza determinazione di termine » (ivi, p. 313). Ci pare che su talepunto le conclusioni non siano da condividere, specie a causa della contrarietà al principiodi uguaglianza dei soci; sia la persona fisica che la persona giuridica sono parimenti soci
visibile, che opera mediante applicazione analogica della disposizione det-tata per il recesso da s.s., e dunque considerando a tempo indeterminatoquelle società la cui durata sia manifestamente superiore alla durata dellavita media umana (14). Aderendo a tale impostazione, quindi, saranno daconsiderare contratte a tempo indeterminato ai fini del caso di recesso quipreso in considerazione tutte quelle società che abbiano tale caratteristica,formalmente o sostanzialmente. Per queste ultime, se mai, il problemache si può porre è l’individuazione, nel silenzio dell’atto costitutivo, delperiodo decorso il quale sarà possibile ai soci il recesso (15); a tale questio-ne si tenterà di dare risposta infra in sede di analisi della relazione tra ledisposizioni di cui agli artt. 2328, comma 2°, n. 13 e 2437, comma 3° .
Svolte queste preliminari considerazioni volte a definire i limina delconcetto di società costituita a tempo indeterminato, passiamo ora all’a-nalisi della specifica disciplina dettata per questo caso di recesso ad nutume delle problematiche che da essa potranno derivare
1130 CONTRATTO E IMPRESA
della società, e non è ragionevole (né supportato dal diritto positivo, parrebbe) ipotizzareuna diversità di trattamento e di attribuzione di diritti sociali tra i due. Piuttosto si ritieneche la pietra di paragone debba essere comunque costituita dalle vite delle persone fisiche aloro volta socie della persona giuridica socia della prima società, e questo anche a costo direalizzare un complesso sistema, pericolosamente simile ad una matrjoska, ma foriero dimaggiori garanzie per il duplice aspetto della certezza del diritto e della uniformità di trat-tamento tra i soci che avrebbe il suo risultato ultimo nel consentire il recesso ad nutum aqualsiasi socio, sia esso persona fisica o giuridica, da una società contratta a tempo formal-mente determinato, ma sostanzialmente indeterminato. Sulla stessa posizione pare Nota-ri, Costituzione e conferimenti nella s.p.a., in Aa.Vv., Il nuovo ordinamento delle società. Le-zioni sulla riforma e modelli statutari, Milano, 2003, p. 6 ss.
(14) Per una completa analisi di questa soluzione, elaborata in via giurisprudenzialeavendo riferimento alle società di persone, si veda per tutti Ianniello, Recesso del socio dasocietà con durata superiore alla vita media umana, in Società, 1997, p. 1032 ss. Contrario, siapure in termini problematici, all’applicazione di questa tesi alle società per azioni pare Sal-vatore, Il « nuovo » diritto di recesso nelle società di capitali, in questa rivista, 2003, p. 629 ss.(spec. p. 635). Si nota, comunque, che quanto esposto alla nota precedente non discendedall’applicazione analogica dell’art. 2285 c.c. nella parte in cui consente il recesso da societàcontratta per tutta la vita di uno dei soci (analogia, peraltro, di per sé non applicabile in ra-gione della differente rilevanza della figura del socio all’interno della compagine socialenelle società personali rispetto a quelle di capitali), bensì dalla ratio stessa sottesa all’idea di« tempo indeterminato », e che dunque si estrinseca in una durata che potremmo definireper tutta la vita non più di uno dei soci, bensì di tutti, venendo così a sostituirsi un criteriooggettivo al criterio soggettivo presente nella disciplina del recesso da s.s.
(15) Si tratta di una questione che può porsi pure nel caso in cui la società, formalmen-te contratta a tempo indeterminato, non si sia preoccupata dell’inserimento nell’atto costi-tutivo dell’indicazione del periodo in questione, ovvero del caso, già accennato, della pro-roga di fatto della società.
2. – Qualora la società sia stata contratta a tempo indeterminato, o siacomunque da considerarsi tale, la riforma ha voluto delimitare l’ambito dioperatività dell’ipotesi di recesso in esame al solo caso in cui le azioni del-la società non siano « quotate in un mercato regolamentato » (16). Molto siè discusso, in sede di lavori preparatori, sull’opportunità o meno che que-sto particolare caso di recesso dovesse essere limitato a quelle società chenon fossero provviste di quotazione in borsa. Testimone di ciò è il fattostesso che il primo testo provvisorio licenziato dalla commissione, eviden-temente al fine di conoscere i pareri del mondo accademico sulle effettivesoluzioni proposte dalla riforma, di fatto non prevedeva la limitazione delrecesso ad nutum ai soci di quelle società che non fossero quotate (17), ma
SAGGI 1131
(16) Non è purtroppo questa la sede per un’analisi approfondita del significato che deb-ba essere dato a tale espressione; è tuttavia molto interessante quanto prospettato da Ma-rano, Mercati di capitali e strumenti finanziari nel nuovo diritto societario, in Riv. dir. priv.,2003, p. 755 ss., che giustamente distingue tra le due ipotesi del fatto che la società sia quo-tata in borsa piuttosto che le sue azioni siano negoziate su di un mercato regolamentato.Se, infatti, si considera che la borsa (luogo riservato alle quotazioni ufficiali) non è che unodei mercati regolamentati teoricamente disponibili, bene si intuisce come l’espressione« quotate in mercati regolamentati » sia un ibrido di difficile coordinamento e di scarsa in-telligibilità. Per un’utile collocazione del caso di specie si dovrà allora fare riferimento pre-minente al fattore « quotazione » (escludendo in tal modo ogni altro mercato regolamenta-to che non sia la borsa), oppure alla pluralità dei mercati regolamentati? O ancora, con lo-gica alquanto discutibile, ritenere che il legislatore si riferisse solamente alle quotazioni del-le borse, anche estere, ma non agli altri mercati regolamentati eventualmente presenti oltrefrontiera? Dovendosi aderire, riteniamo, alla prima teoria, in ragione della specialità dellaquotazione rispetto al genus dei mercati regolamentati, resta comunque la perplessità adammettere il recesso ad nutum anche per quelle società a tempo indeterminato non quota-te, ma comunque ad azionariato diffuso ex art. 2 bis reg. Consob n. 11971 del 1998.
(17) Suscitando, in tal modo, le perplessità di un coro di autorevoli esponenti del mon-do universitario e non solo, evidentemente poi condivise dallo stesso legislatore, avendoprovveduto, nella versione definitiva, ad inserire la limitazione di cui nel testo. Su tale ar-gomento si vedano gli autorevoli pareri espressi da Portale, Osservazioni sullo schema didecreto delegato (approvato dal governo in data 29-30 settembre 2002) in tema di riforma dellesocietà di capitali, in Riv. dir. priv., 2002, p. 701 ss. (spec. p. 710); Campobasso, La costituzio-ne della società per azioni, relazione al Convegno di Alba del 23 novembre 2002, La riformadelle società: corporate governance, principi imperativi ed autonomia statutaria, ora in So-cietà, 2003, p. 283 ss. (spec. p. 287); Bianchi, Ghezzi, Marchetti, Notari (a cura di), Os-servazioni dell’Istituto di diritto Angelo Sraffa della Università Bocconi di Milano, in Riv. soc.,2002, p. 1527 ss. (spec. p. 1534 s.); Montalenti, Osservazioni alla bozza di decreto legislativosulla riforma delle società di capitali, ivi, p. 1542 ss. (spec. p. 1544 s.); Aa.Vv., Osservazioni diBorsa Italiana s.p.a., ivi, p. 1564 ss. (spec. p. 1578 s.) e, da ultimo, il Parere approvato dalleCommissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) ella Camera dei deputati, in data 12 dicem-bre 2002, ivi, p. 1649 ss. (spec. p. 1651). Si segnala, infine, la curiosa, ma isolata interpreta-
lasciava tale possibilità ad ogni azionista di s.p.a., indipendentemente dallaquotazione o meno (18).
L’ipotesi di recesso prevista dal terzo comma dell’art. 2437, dunque, èfruibile dai soci di società per azioni costituite a tempo indeterminato eche non abbiano azioni quotate in mercati regolamentati; le modalità diesercizio di tale diritto non sono difformi dalle regole generali dettate inmateria di recesso, se non per un punto cui già abbiamo avuto modo diaccennare in precedenza: l’obbligo di preavviso almeno semestrale (manon più che annuale) con cui il socio deve manifestare alla società la pro-pria intenzione di recedere. Già da questa brevissima definizione emergo-no molte questioni che possono essere connesse a questo particolare casodi recesso.
3. – Quanto al profilo della legittimazione a recedere, già si è detto co-me questo tipo di recesso non sia in alcun modo connesso all’adozione diuna delibera, e tantomeno al verificarsi di un evento. Una tale circostanzafa venire meno una classificazione, forse la principale, che da sempre haaccompagnato e caratterizzato l’istituto del recesso: l’essere non soloespressione, ma addirittura baluardo dei cosiddetti Minderheitsrechte. Conl’introduzione di questa nuova ipotesi, infatti, si nota fin dal primo ap-proccio che non vi è alcuna controindicazione ad ammettere la possibilitàche a recedere sia l’azionista di maggioranza, con quanto ciò potrà signifi-care per la stessa sopravvivenza della società.
1132 CONTRATTO E IMPRESA
zione dell’ipotesi di recesso qui considerata che dà ABI, ivi, p. 1599 ss.: « laddove (. .) si va-da a leggere l’art. 2437 che disciplina il recesso, sembra intendersi che i motivi (ovvero: lecause di recesso, n.d.r.) ivi indicati debbano essere rispettati anche nel caso ora indicato(recesso con preavviso almeno semestrale dalla società per azioni costituita a tempo inde-terminato, n.d.r.) » (p. 1606); in questo senso pare si intenda l’ipotesi in esame non quale re-cesso ad nutum, bensì come apposizione di un apposizione di un termine che, per il solo ca-so delle società contratte a tempo indeterminato, stabilisce l’efficacia differita a 180 giorni diogni dichiarazione di recesso, qualunque ne sia il presupposto.
(18) La ratio della nuova limitazione è da ravvisarsi nel fatto che comunque, se la so-cietà è quotata, in ragione della maggiore negoziabilità potenziale dei titoli, non sussiste-ranno i problemi per il socio di società contratta a tempo indeterminato ad esercitare util-mente e proficuamente il diritto di exit che il legislatore ha espressamente garantito al suoomologo di società non quotata attraverso la previsione dell’ipotesi di recesso in esame; sipuò anzi affermare che, in quanto l’alienazione dei titoli sul mercato azionario non è lega-ta ad un preavviso almeno semestrale, come abbiamo accennato essere per l’esercizio delrecesso ad nutum, il socio di società a tempo indeterminato quotata potrebbe addirittura es-sere favorito rispetto al suo omologo di società sì contratta a tempo indeterminato, ma nonquotata.
Inoltre, l’essere del tutto slegato da logiche di dialettica tra maggioran-za e minoranza nei casi di adozione di delibere fa venire meno anche lanecessità di indagare cosa significhi, nelle intenzioni del legislatore, l’e-spressione « soci che non abbiano concorso alla deliberazione » (19).
Il venire meno del profilo del dissenso, poi, rende del tutto ammissi-bile il recesso dell’azionista che, ex lege od in conformità all’atto costituti-vo, non abbia la possibilità di esprimere il proprio voto in assemblea, oquantomeno possa farlo solo in determinate circostanze. Alle figure del-l’azionista di risparmio o di godimento, per cui già nel vigore della prece-dente normativa la migliore dottrina riteneva dovesse essere concessa lafacoltà di recedere (20), si affiancano oggi le varie ipotesi che scaturirannodalla previsione dell’art. 2348, comma 2°; e a ben poco vale l’invocare lapossibilità che la diversità nei diritti attribuiti menzionata dalla norma inparola si possa concretizzare in una eliminazione della possibilità di rece-dere, se, come si vedrà infra, la tendenza sarà di ritenere questa fattispeciedi recesso come inderogabile (21).
Altra questione, più classica, si pone nei confronti del socio che abbiacostituito un pegno od un usufrutto sulle proprie azioni, ovvero le cuiazioni siano sottoposte a sequestro. La trattazione di tali argomenti, cheper loro natura appartengono alla disciplina generale in tema di recesso,
SAGGI 1133
(19) Espressione che ha dato un contributo essenziale alla legittimazione della teoria,già maggioritaria nel previgente sistema, che al socio astenuto rispetto ad una delle delibe-re la cui approvazione comportasse il potere di recedere in capo ai soci assenti e dissen-zienti, spettasse il diritto di recesso.
(20) Angelici, Le azioni, in Il codice civile – Commentario, diretto da Schlesinger, Mila-no, 1992, p. 246; Bione, Le azioni, in Tratt. delle società per azioni, diretto da Colombo ePortale, vol. 2, Torino 1991, p. 97, nota 177; coloro che tendevano, nella previgente discipli-na, a negare la possibilità del recesso al socio di godimento, argomentavano tale posizionepartendo dalla presunta indifferenza del socio di godimento stesso rispetto a qualsiasi deli-bera adottata dall’assemblea che fornisse l’occasione per recedere (in questo senso si v. Ca-vallo Borgia, Azioni e obbligazioni di società, Padova 1988, p. 268); è evidente, come emer-ge dalla nuova funzione del recesso, ormai slegato, almeno in questo caso, alla dialetticamaggioranza/minoranza, come tale obiezione risulti del tutto superata, non frapponendosiormai più nulla al pacifico riconoscimento della facoltà di recedere in capo al socio titolaredi tali partecipazioni.
(21) Al contrario, tuttavia, ci pare si debba ammettere la possibilità di creare un deter-minato tipo di azioni in cui il diritto diverso sia costituito da un termine di preavviso diffe-rente da quello stabilito dallo stesso statuto per le azioni ordinarie, sia pure sempre nel ri-spetto dei limiti legali. Il fatto di ammettere, invece, tipi azionari cui sia attribuito il poteredi recedere ad nutum, pure in assenza del presupposto della costituzione della società atempo indeterminato si deve misurare con quanto si dirà infra, par. 9.
in questa sede è dettata, ancora una volta, dalla novità dell’ipotesi di re-cesso in esame, che prescinde dalla titolarità (e dal conseguente esercizio)del diritto di voto. Non rientrando il recesso tra i diritti espressamente re-golati da parte dell’art. 2352 c.c., è legittimo chiedersi a chi spetti l’eserci-zio di tale diritto tra il titolare delle azioni e, rispettivamente, il creditorepignoratizio, l’usufruttuario ed il custode. Inoltre, per disposizione dellastessa norma ora citata, l’esercizio di ogni altro diritto amministrativo al difuori di quelli espressamente regolati, tra cui non figura il recesso, spetta,nei casi di pegno ed usufrutto, « sia al socio che al creditore pignoratizio oall’usufruttuario », restando invece sempre in capo al custode per il casodel sequestro.
Prodromica ad ogni altra questione potrebbe dunque essere quella ri-guardante l’identificazione del recesso quale diritto amministrativo o meno,pur essendo la dottrina più recente propensa alla seconda soluzione (22).Senza addentrarci in tale questione sistematica, tuttavia, ci pare si possagiungere ad ammettere che sia legittimato a recedere anche il creditore pi-gnoratizio mediante l’applicazione del diritto comune, sia pure solamentein determinate circostanze (23).
1134 CONTRATTO E IMPRESA
(22) Decisamente contrari all’identificazione del recesso come diritto di natura ammini-strativa sono, tra gli altri, Galletti, Il recesso nelle società di capitali, Milano, 2000, p. 174 s.,nota 60 ove ampi riferimenti bibliografici; Poli, Il pegno di azioni, Milano, 2000, p. 462, no-ta 335. Si nota qui solo incidentalmente come l’inserimento del recesso nel novero dei di-ritti amministrativi potrebbe condurre a soluzioni di tendenza del tutto opposta rispetto aquanto considerato durante la vigenza della precedente normativa. Pare infatti che la con-secutiva « sia al socio sia al creditore pignoratizio o all’usufruttuario » dovrebbe essere inte-sa in senso disgiuntivo, legittimando dunque il recesso del soggetto che, tra i due, per pri-mo lo avrà esercitato (perplesso, ma non contrario in assoluto rispetto a tale impostazione,sia pure in prospettiva de iure tunc condito, pare Galletti, op. cit., p. 179). L’elemento, for-se non discriminante, ma certamente utile che sembra possa essere utilizzato per negare latitolarità concorrente di creditore pignoratizio e debitore alla dichiarazione del recesso è diordine logico; se infatti ad entrambi viene attribuita la possibilità di recedere validamente,ad entrambi sarà pure data la facoltà, a meno di limitazioni in tal senso incomprensibili inrelazione alla lettera della legge, di revocare utilmente la dichiarazione di recesso ex art.2437 bis, comma 3° .
(23) Se, infatti, fino all’avvento della riforma era dominante la posizione che ritenevache il recedere fosse prerogativa solamente del socio, specie in ragione della dissociazionetra le persone del titolare dell’azione e del votante in assemblea (cfr. Salandra, Manuale didiritto commerciale, Bologna, 1949, p. 360; Presti, Questioni in tema di recesso nelle societàdi capitali, in Giur. comm., 1982, I, p. 105; Spatazza, Pegno, usufrutto, sequestri, pignoramen-to e riporto delle azioni, in Riv. soc., 1971, p. 672; Angelici, Le azioni, in Il Codice Civile –Commentario, diretto da Schlesinger, Milano, 1992, p. 210; Poli, op. cit., p. 462; Nigro, Il vo-to del creditore pignoratizio e il diritto di recesso, in Not., 2003, 4, p. 375 ss.; Vidiri, Pegno di
Differente dal pegno, nonostante la tradizionale trattazione unitaria
SAGGI 1135
azioni, diritti del creditore pignoratizio e recesso ex art. 2437 c.c., in Giust. civ., 2003, p. 388 ss.;Lisanti, Carenza di legittimazione del creditore pignoratizio di azioni all’esercizio del diritto direcesso ex art. 2437 c.c., in Società, 2003, p. 1237 ss.; contra Galletti, op. cit., p. 178 s.), orapare siano molteplici gli elementi che consentono una decisa inversione di tendenza. Il pri-mo è costituito dalla considerazione che, nell’ipotesi di recesso qui in esame, non è più ne-cessario, al fine di recedere, il non aver concorso all’approvazione di una qualsiasi deliberaassembleare, venendo così meno ogni problema legato alla dissociazione personale tra ilsoggetto votante ed il recedente. In secondo luogo pare utile applicare, per quanto nonesplicitamente disposto dall’art. 2352 c.c., le regole di diritto comune in tema di pegno, inparticolare gli artt. 2795 ss., disciplinanti i casi di vendita del bene dato in pegno da parte delcreditore pignoratizio, specie in considerazione delle nuove regole dettate dall’art. 2437quater in tema di liquidazione del socio e che si estrinsecano, quantomeno nelle prime fa-si, in una vera e propria vendita delle azioni agli altri soci, a terzi od alla società. Nel caso exart. 2797 c.c., infatti, qualora si consenta al creditore, essendo scaduta l’obbligazione, lavendita del bene, previa l’esperimento di un avviso al debitore, non si vede perché egli do-vrebbe essere privato di tale possibilità qualora il bene in questione sia costituito da titoliazionari. Lo stesso si può affermare per quanto riguarda l’art. 2795, che detta le regole inmateria di vendita anticipata qualora si assista ad un deterioramento del bene dato in pegnotale da pregiudicare la sicurezza della garanzia del creditore. In questo caso l’unica diffi-coltà sarà data dalla necessità di individuare quali siano i casi in cui, in materia di titoli azio-nari, si assista ad un simile deterioramento della garanzia. Sembra che l’unico criterio vera-mente valido debba essere rappresentato da una tale diminuzione di valore del pacchettoazionario che questo non consenta più di avere la certezza della sua idoneità alla soddisfa-zione del creditore; in questo senso, naturalmente, tale decisione sarà di assoluta compe-tenza del giudice che dovrà autorizzare la vendita (e che certo potrebbe rifiutare l’autoriz-zazione qualora ravvisi la concreta possibilità, ad es., di una pronta rivalutazione del titolo),secondo il disposto dello stesso art. 2795 c.c. (il tutto, naturalmente, accettando un signifi-cato del termine « deteriorarsi » che abbia al suo centro, come pare debba essere per questanorma, il valore del bene, più che il suo aspetto; solo in questo senso una svalutazione po-trà essere letta come un deterioramento del titolo azionario). Ora, in entrambi questi casi cipare si possa ritenere che il recesso ad nutum può rappresentare un’alternativa valida all’a-lienazione della quota. Si riconosce tuttavia che l’ipotesi sub art. 2795 c.c. è quasi di scuola,dal momento che la stessa norma ha un carattere in certo qual modo di « emergenzialità »che mal si concilia con un istituto che necessita, per la sua perfezione, di un termine dipreavviso almeno semestrale. Maggiori le implicazioni pratiche nel caso della vendita in ba-se all’art. 2797 c.c.; in questo caso, scaduta l’obbligazione sottostante al pegno ed avvertitoil debitore, il creditore potrà utilmente recedere dalla società, anziché vendere normalmen-te i titoli. Una tale soluzione potrebbe portare a due ordini di risultati apprezzabili: da unlato potrebbe essere vista come una ulteriore dilazione del pegno nei confronti del debito-re, che avrà a disposizione ancora gli almeno centottanta giorni di preavviso più i novantaprevisti dall’art. 2437 bis, comma 3°, c.c. per potere soddisfare il debitore, riprendere il pie-no possesso delle azioni e revocare il recesso (ovvero non perfezionarlo non effettuando laseconda dichiarazione o non depositando i titoli presso la sede sociale; su questo tema v.infra); d’altronde il creditore avrà la certezza della liquidazione della quota (non, però,
del caso inerente i titoli azionari, pare essere la disciplina dell’usufrutto.In tale istituto, infatti, diversamente da quanto previsto per il pegno, nonè data all’usufruttuario la possibilità di alienare il bene dato in usufrutto,integrando anzi un simile comportamento la fattispecie di abuso dell’usu-fruttuario che determina lo scioglimento dell’usufrutto stesso (24). Qualo-ra, dunque, si proceda nel non considerare il recesso quale diritto di natu-ra amministrativa, mancando ogni appiglio anche nelle norme di dirittocomune cui aggrapparsi in via analogica per consentire il recesso all’usu-fruttuario, ci pare ragionevole concludere per l’impossibilità per l’usufrut-tuario stesso di dichiarare utilmente il recesso.
1136 CONTRATTO E IMPRESA
della effettiva rispondenza del quantum debeatur all’ammontare del suo credito, a causadella valutazione delle azioni presumibilmente differente nel momento del preavviso ed inquello della determinazione della liquidazione), cosa che non avviene qualora egli tentiuna vendita all’asta o sul (fittizio, sicché si tratta di azioni non quotate) mercato (si badi co-me questa risulti essere l’unica nota positiva che potrebbe fare propendere il creditore, nel-l’ipotesi dell’art. 2795, per un recesso anziché per la vendita). La conseguenza di tale co-struzione, dunque, è che pare vi sia comunque la possibilità di giungere alla conclusionedella legittimazione a recedere del creditore pignoratizio attraverso i principi di diritto co-mune, anche senza la necessità di considerare il recesso quale diritto amministrativo.
(24) Art. 1015 c.c.; si ricorda anche la stringente obiezione di Partesotti, Le operazionisulle azioni, in Tratt. delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, vol. 2, Torino,1991, p. 325, secondo il quale l’attribuzione della possibilità di recedere in capo all’usufrut-tuario sarebbe « in insanabile contraddizione col rispetto della destinazione economica del-l’oggetto dell’usufrutto (art. 981, comma 1°, c.c.) ». Ci pare, invece, superabile l’argomentomediante cui Galletti, op. cit., p. 178, ammette la possibilità di recedere sia per il credito-re pignoratizio che per l’usufruttuario. Sostiene l’a. che « il creditore stesso (ma alla sua si-tuazione è paragonabile, nel ragionamento di Galletti, anche quella dell’usufruttuario,n.d.r.) potrebbe produrre un effetto del tutto analogo (a quello del recesso, n.d.r.) votandoa favore, magari con efficacia decisiva, della proposta di scioglimento volontario della so-cietà, con conseguente liquidazione, non individuale ma collettiva ». La soluzione non pa-re condivisibile per tre ragioni. Innanzitutto la mutata disciplina legale fa dell’ipotesi di re-cesso qui in esame una sorta di ibrido che, come già più volte si è detto, esula da ogni con-siderazione in ordine all’espressione del voto in assemblea; in secondo luogo, assai diffe-rente è l’ipotesi di uno scioglimento unilaterale dal vincolo sociale da quella dello sciogli-mento della società stessa se non altro perché, mentre da un lato è sufficiente la decisivavolontà di uno, dall’altro è necessaria una maggioranza assembleare. In certo qual modo sipotrebbe dire che mentre nel recesso ciascun socio basta a se stesso, l’abbandono della so-cietà come conseguenza dello scioglimento della stessa necessita di un più ampio ventagliodi consensi, la cui manifestazione in sede assembleare non è assolutamente certa, né tan-tomeno frutto, nella maggioranza dei casi, dell’attivarsi del potenziale recedente in tal sen-so. Infine è differente il regime liquidatorio di riferimento, sia in termini monetari, sia, conle ultime modifiche apportate alla riforma dal d. correttivo del febbraio 2004, in relazione alnon trascurabile particolare del termine ad quem le pretese liquidatorie del recedente deb-bano essere soddisfatte.
Diversa, oltre che meno studiata, pare invece la situazione del custodeper i casi di sequestro di azioni. La prima questione da affrontare è, infat-ti, quella relativa alla ratio degli istituti comportanti il sequestro: il desue-to sequestro convenzionale, ex artt. 1798 ss. c.c., il sequestro giudiziario exart. 670 c.p.c., il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. In tali casi, pare discorgere una identità di fondo nella stessa esigenza che ha dato luogo alsequestro: la necessità che il bene sottoposto a tale misura non si trovinelle mani di chi lo deteneva in precedenza, al fine di salvaguardarne, evi-dentemente, la stessa integrità. Al sequestratario è infatti demandata lacustodia ed eventualmente l’amministrazione del bene sequestrato, es-sendogliene consentita l’alienazione solamente nel caso di grave pericolodi perdita o deterioramento; identica pare essere la disciplina dettata per ilcustode, nel momento in cui il legislatore si esprime nei termini di « con-servazione » ed « amministrazione » (art. 65 c.p.c.). Certo, il legislatore delcodice di rito non si preoccupa di individuare i casi di possibile alienazio-ne da parte del custode, ma non pare comunque peregrino, specie in ra-gione della particolarissima natura dei titoli azionari (25), consentire taleipotesi nel caso in cui le mutate condizioni di mercato portino ad una no-tevole svalutazione della partecipazione azionaria (26).
SAGGI 1137
(25) Ipotesi condivisa da Galletti, op. cit., p. 177 s., che parla dei titoli azionari come di« beni di secondo grado » la cui particolare natura « consente di adottare criteri e parametridi giudizio più elastici, consentendo di vendere e comprare, dietro lo schermo delle facoltàsociali, in modo più ampio ».
(26) Si noterà come una tale impostazione sia prima facie condivisibile per il caso del se-questro conservativo, in cui più che il bene in sé a rilevare è la sua possibilità di essere ve-locemente monetizzato per consentire la soddisfazione del (supposto) creditore. Per le re-stanti ipotesi, invece, sembra che l’elemento realmente rilevante sia lo stesso bene sottopo-sto, legalmente o in via pattizia, al sequestro. È pur sempre da rilevare che la possibilità diuna pronta monetizzazione è una delle caratteristiche fondamentali dei titoli azionari. Nelmomento in cui si consideri tale aspetto come il maggiormente rilevante non vi sarannocontroindicazioni per ritenere che al custode possa essere consentito il diritto di recederead nutum. Non si deve tuttavia correre il rischio di non ritenere altrettanto importanti altriaspetti del titolo azionario non surrogabili dalla sua trasformazione in denaro contante, pri-mo fra tutti, ad esempio, il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione, specie se de-rivante da un aumento gratuito del capitale sociale, che naturalmente verrebbe meno nelmomento in cui si consenta il recesso, o l’alienazione dei titoli da parte del custode. O an-cora l’espletamento di interessi personali del socio che trovino il loro habitat nella stessasua partecipazione alla società.
Per quanto riguarda, poi, la contingenza della valutazione della quota per cui si recede,non si cada nell’erronea attribuzione di una eccessiva responsabilità in capo al custode. Èinfatti esplicito l’art. 67, comma 2°, c.p.c. nel momento in cui sancisce che la responsabilitàdel custode per gli atti di amministrazione da lui compiuti debba essere valutata alla stregua
Problematica, in ragione della presenza del termine di preavviso, po-trebbe essere pure la situazione della vendita a termine di azioni (27), senon che tale contratto ha il proprio habitat naturale nei mercati borsistici,ragione per cui una simile disquisizione in tema di recesso ad nutum, persua natura escluso nelle società quotate, avrebbe una funzione solamenteteorica.
4. – Come già si ha avuto modo di ricordare, tra le particolarità del re-cesso ad nutum vi è certamente il fatto di prevedere un periodo di preav-viso particolarmente lungo e (in certa misura) determinabile statutaria-mente. La presenza di un tale periodo, tuttavia, costituisce un problemarispetto alla determinazione dei diritti che spettano al socio. Il primo pro-blema che è opportuno affrontare riguarda il coordinamento dell’art. 2437,comma 3° con l’art. 2328, comma 2°, n. 13. Vi è stato chi, infatti, ha pro-peso per considerare le due norme come una sorta di fotocopia, il cui sco-po fosse, sostanzialmente, il rimarcare la necessità di un periodo di preav-viso per perfezionare l’esercizio del diritto di recesso (28).
La soluzione non convince: perché il legislatore avrebbe dovuto ripe-tersi, e per giunta in termini disomogenei (29)? Molto meglio pare una let-tura differenziata delle norme, secondo il modello che segue.
1138 CONTRATTO E IMPRESA
della diligenza del bonus paterfamilias, e dunque non con le capacità da riconoscersi ad unoperatore professionale. Anche qualora si faccia ricadere l’alienazione, od il recesso, nel ca-so di atto di amministrazione straordinaria, quindi, il giudice potrà agevolmente autorizza-re, o ratificare, l’operato del custode qualora rilevi che è stata prestata una tale diligenza.Contrario alla possibilità di legittimazione a recedere del custode era, sia pure nella vigen-za della precedente normativa, Partesotti, op. cit., p. 364, ove altri riferimenti bibliografici.
Altra questione che merita spazio è quella relativa alla possibilità di recedere in capo alsequestrato. Pare corretto, stante la ratio che è sottesa ai vari istituti che vanno sotto il no-me di sequestro, negare che al socio (od al soggetto supposto tale) spetti la facoltà di eser-citare alcun diritto sociale; qualora si conceda al custode di bene sequestrato in via cautela-tiva la legittimazione a recedere in forza di quanto detto supra, il riconoscere lo stesso di-ritto in maniera concorrente pure al socio potrebbe portare agli esiti nefasti già ipotizzatiper l’analogo caso in tema di pegno. Pare comunque soluzione più razionale attribuire la le-gittimazione a recedere al custode in virtù della sua supposta imparzialità, i cui effetti si ri-verbererebbero su entrambe le parti in causa. Sul tema, con soluzione affermativa rispettoalla legittimazione a recedere al socio sequestrato in caso di sequestro conservativo, si v.Partesotti, ibidem.
(27) A tale ipotesi va equiparata quella del riporto di azioni, la cui disciplina legale ri-manda espressamente a quella dettata in materia di vendita a termine.
(28) Su tale posizione pare assestarsi Rordorf, Il recesso del socio da società di capitali:prime osservazioni dopo la riforma, in Società, 2003, p. 927
(29) L’art. 2328, infatti, parla di « atto costitutivo », senza menzionare la limitazione del-
La previsione dell’art. 2328, comma 2°, n. 13, si riferisce, come daqualche autore è stato fatto notare, ad un adempimento della società in« fase genetica » (30), mentre l’art. 2437 ha il proprio ambito applicativo inun momento organizzativo della vita della società; in questo senso i duetermini presenti negli articoli citati devono essere letti separatamente. Ladisposizione di cui al n. 13 del comma 2° dell’art. 2328 si riferisce, certa-mente, ad un determinato lasso di tempo che deve trascorrere prima cheil socio possa utilmente recedere (31), ma il legislatore non si è preoccupa-to di stabilire da quale momento debba decorrere il termine a quo, men-tre l’articolo in materia di recesso non fa mistero della decorrenza del ter-mine dal preavviso.
Per una utile analisi del problema è necessario in primo luogo stabili-re quale sia la ratio delle due norme. Ci pare di potere affermare che il ter-mine ex art. 2437, comma 3°, è stabilito in ragione di un duplice interessesocietario: in primo luogo consente alla società di avere un periodo ditempo medio/lungo a disposizione per trovare le risorse mediante cui li-quidare il recedente, ed inserire un tale avvenimento, potenzialmente as-sai gravoso per la società, all’interno di un quadro di strategie aziendali; insecundis fornisce una zavorra contro recessi troppo interessati ad abban-donare la società in cattive acque, e, di conseguenza, sarebbe un deter-rente per una categoria di azionisti ispirati da mentalità hit and run (32). Laconsiderazione che, invece, pare sottostare alla norma dettata in tema dicontenuto dell’atto costitutivo può avere due differenti motivazioni, a se-conda che si interpreti il termine a quo come decorrente dalla costituzio-ne della società (termine oggettivo), ovvero dalla assunzione della qualitàdi socio (termine soggettivo o ad personam): nel primo caso il « divieto direcesso » per una durata massima di un anno avrebbe la funzione di pre-
SAGGI 1139
la previsione alle società non quotate, né un termine minimo; l’art. 2437, invece, non solosi rifà allo statuto, ma, come noto, limita la portata dell’applicazione alle società non quo-tate e statuisce anche un termine minimo di preavviso in centottanta giorni.
(30) Cfr. Sparano e Adducci, S.p.a. a tempo indeterminato: disciplina e problematicheconnesse, in Dir. e prat. società, 2004, 7, p. 35.
(31) Si noti come, in questo caso, per « potere recedere » si possa tranquillamente in-tendere il momento di efficacia del recesso, e dunque la seconda dichiarazione, da presen-tare contestualmente al deposito delle azioni, piuttosto che la prima, con meri fini di preav-viso. Per un’analisi più puntuale, v. infra.
(32) E, in questo senso, viene meno l’utilità della visione del recesso quale « opzione divendita », dovendo essere preferita una funzione semplicemente determinativa della duratadella società in relazione ad ogni singolo socio: cfr. De Nova, Il diritto di recesso del socio disocietà per azioni come opzione di vendita, in Riv. dir. priv., 2004, p. 332.
servare la neonata società da exit generalizzati e diffusi in un momento incui le necessità dell’organizzazione imporrebbero la maggiore integritàpossibile del capitale sociale (33); nella seconda ipotesi, invece, alla funzio-ne appena menzionata si affianca (34) utilmente una sorta di garanzia (fa-coltativa) alla serietà dell’investimento da parte dell’azionista (35). Di ga-ranzia « facoltativa » perché, nel momento in cui la legge stabilisce che iltermine massimo per il divieto in esame è di un anno senza preoccuparsidi fornire una durata minima, pare si possa affermare che alla sua even-tuale assenza, unita all’assenza pure di un generale termine di durata del-la società, non si potrà che dare il significato di una implicita rinuncia allagaranzia di serietà predisposta, in termini derogabili dall’autonomia statu-taria, dal legislatore (36); e questo, quindi, senza pregiudicare in alcun mo-do la qualificazione della società come a tempo indeterminato (37).
Dati i risultati della breve analisi appena svolta, sembra preferibile ac-cogliere la soluzione del termine soggettivo; una diversa lettura, infatti,oltre a costituire una diminuzione di garanzia in una disciplina che già diper sé ne è globalmente carente (38), pare sarebbe eccessivamente gravosaper i soci fondatori, che in fin dei conti sarebbero gli unici, o quasi, a ve-dersi iniquamente preclusa la via di fuga (39).
1140 CONTRATTO E IMPRESA
(33) Questa la soluzione adottata da Granelli, Il recesso del socio nelle società di capi-tali alla luce della riforma societaria, intervento svolto il 2 luglio 2003 nell’ambito dei Semi-nari sul nuovo diritto societario tenutisi in Roma su iniziativa della Cassa Nazionale di Pre-videnza ed Assistenza Forense e dell’Università degli Studi di Roma, ora in Società, 2004, p.143 ss., spec. 146.
(34) Se infatti il termine è riferito all’acquisizione dello status socii da parte del singoloazionista, ciò varrà anche per i fondatori della società, e dunque il termine nei loro con-fronti decorrerà implicitamente dalla costituzione sociale.
(35) E della funzione di « garantire la serietà dell’impegno », tra l’altro, dice la stessa re-lazione ministeriale, al par. 1.3.
(36) In questi termini si esprime pure Notari, op. cit., p. 7, sia pure aderendo all’ipotesiche vede decorrere il periodo di cui all’art. 2328, comma 2°, n. 13, solamente dalla costitu-zione della società.
(37) V. supra, nota 11 e testo corrispondente.(38) E proprio per questo oggetto di aspre critiche in dottrina; si veda per tutti Morano,
op. cit., p. 310, ove cita, tra gli altri, Vella, Audizione dinanzi alle Commissioni riunite Giu-stizia e Finanze sullo schema di decreto recante « Riforma organica della disciplina delle societàdi capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366 », Camera deiDeputati, 26 novembre 2002: per l’a., tale caso potrebbe « trasformarsi in una continua e in-controllabile minaccia per l’integrità del patrimonio aziendale rafforzando le preoccupazio-ni . . . di un sostanziale indebolimento delle imprese costrette ad un forzoso accantonamen-to di risorse nella prospettiva di subire onerosi esborsi per far fronte al recesso del socio ».
(39) Anche la soluzione accolta, tuttavia, non è esente da problemi; in particolare si ac-
Stante quanto precede, è ora necessario provvedere al coordinamentodella disposizione appena esaminata con quanto previsto dal terzo com-ma dell’art. 2437. Il problema maggiore sarà, in questo caso, valutare se idue periodi di tempo, quello ex art. 2328 e quello ex 2437, si debbanocomputare successivamente o contemporaneamente. Due sono le ragioniche sembra portino a preferire la seconda soluzione, e dunque un decor-so contemporaneo dei due termini. Innanzitutto, come si è visto, la par-ziale identità di ratio ci pare spinga per un non aggravio eccessivo dellaposizione del socio, essendo la serietà del suo apporto alla società garanti-to ampiamente attraverso entrambe le disposizioni. Ciò che, tuttavia, pa-re dirimente è il tenore letterale di entrambe le norme: nell’art 2328 siparla di « periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso ilquale il socio potrà recedere», ove, abbiamo visto, per recedere si intendeuscire dalla società, non inviare il preavviso (40); ugualmente, l’art. 2437stabilisce che è dovuto, al fine dell’efficacia del recesso, un preavviso dicentottanta giorni, fermo restando che « lo statuto può prevedere un ter-mine maggiore, non superiore ad un anno ». Come si vede, entrambe lenorme, sia pure animate da intenti di tutela della società, forniscono unaprotezione pure al socio, prevedendo che la durata massima del periododi “sospensione” della sua facoltà di recesso è di un anno. Ora, qualora siaatto costitutivo che statuto prevedessero di adottare il termine massimoannuale rispettivamente per l’adempimento ex art. 2328 e per quello pre-visto dal 2437, ecco che al socio appena entrato nella compagine socialesarebbe impedito di recedere, anche qualora volesse esercitare il propriodiritto il giorno stesso del suo ingresso in società, per i successivi due an-ni, e ciò in spregio, evidentemente, di entrambe la disposizioni appena ci-tate (41). Secondo questa costruzione, quindi, i due termini di cui si di-
SAGGI 1141
cenna all’ipotesi in cui venga fissato, a norma dell’art. 2328, il termine prima della cui sca-denza sia precluso al socio il recesso in una società sì contratta a tempo indeterminato, maquotata in borsa (e dunque in cui non opera la previsione del recesso ad nutum). Non si rie-sce a scorgere, in questo caso, altra soluzione che inibire al socio il recesso per qualsiasicausa fino allo scadere del detto termine, conclusione che cozza violentemente, specie con-tro l’ultimo comma dell’art. 2437, e non trova peraltro giustificazione in esigenze particola-ri della società.
(40) Non a caso l’art. 2437 dice proprio che il « il socio può recedere con il preavviso dialmeno centottanta giorni », assumendo così il preavviso non quale caratteristica ulterioredel recesso, bensì solamente come sua modalità di esercizio.
(41) Che, avendo posto espressamente un limite massimo alla compressione del dirittodel singolo socio, evidentemente visto come parte debole del rapporto, non sono da rite-nersi assolutamente passibili di deroghe in peius della posizione del singolo azionista.
scorre potranno trascorrere anche contemporaneamente, con l’evidenteconseguenza che il tempo massimo di sospensione del diritto nei con-fronti del socio sarà di un anno (42).
5. – Esaurito il tema del coordinamento tra le due norme che si sonoviste, veniamo alle effettive modalità di esercizio del caso di recesso inesame.
Secondo quanto stabilito dall’art. 2437, comma 3°, il socio potrà rece-dere da società contratta a tempo indeterminato fornendo un preavviso dicentottanta giorni. Mentre, però, l’art. 2437 bis fornisce indicazioni in me-rito alla forma che deve avere la dichiarazione di recesso, nulla è dettoquanto all’eventuale forma del preavviso. Da ciò si può desumere che sitratti di una informazione che il socio ha l’onere di fornire alla società, mache non necessariamente dovrà rivestire la forma della raccomandata conavviso di ricevimento (43). Molteplici sono i problemi che potrà suscitare
1142 CONTRATTO E IMPRESA
(42) L’unico problema che pare porsi è nel caso in cui il termine ex art. 2328 sia più lun-go di quello stabilito dall’art. 2437 ed il socio appena entrato in società decida immediata-mente di uscire attraverso il rimedio del recesso ad nutum. Si può ipotizzare, a fini chiarifi-catori, il seguente esempio: il periodo stabilito dall’atto costitutivo è di un anno, quello dal-lo statuto di sei mesi. Quid iuris se il socio entrato in società il 1° gennaio 2005 decida ilgiorno successivo di recedere inviando il prescritto preavviso? Tralasciando per ora il pro-blema, che verrà esaminato tra breve, se il computo dei sei mesi debba essere fatto dal mo-mento dell’invio da parte del socio ovvero da quello della ricezione dalla società del preav-viso, presumibilmente il periodo di preavviso scadrà nella prima decina di luglio, mentre alsocio sarà impedito di recedere, ai sensi di quanto previsto dall’atto costitutivo, fino al 1°gennaio 2006. In che modo valutare la situazione del socio (o ex socio) nei mesi intercor-renti tra luglio ed il gennaio successivo? Non è certo questa la sede per una trattazione pun-tuale sul controverso ed affascinante tema della cessazione dello status socii in seguito al-l’esercizio del diritto di recesso. Qui si rileva solamente come una soluzione valida potreb-be essere quella di prolungare, solamente nel caso specifico in esame e solo per il socio cheversi in tale situazione, il termine ex art. 2437 ipso iure fino alla scadenza del periodo fissa-to dall’atto costitutivo, con i problemi derivanti dalla possibile diversa valutazione dellapartecipazione in sede di liquidazione. Per questo aspetto si veda infra nella sezione dedi-cata all’obbligo degli amministratori di approntare la determinazione del valore della liqui-dazione ai sensi dell’art. 2437 ter, comma 5° .
(43) Già durante la vigenza delle precedenti norme, dottrina e giurisprudenza si eranointerrogate sulla possibilità per il socio di dichiarare il proprio recesso mediante altro mez-zo che non la raccomandata (contra, tra le altre, una risalente sentenza della Cassazione, ri-portata in Foro it., 1951, I, c. 891 ss., con nota adesiva di Andrioli), ma ugualmente, se nonmaggiormente, certo (si è fatto l’esempio della comunicazione a mezzo ufficiale giudizia-rio). La eventuale soluzione positiva si deve confrontare con il problema della derogabilitàdella disposizione dell’articolo in parola. Di fatto vi è chi, giustamente, ritiene che le dispo-
questa disposizione in materia di preavviso nel caso di recesso qui in esa-me. Detto quanto precede sulla forma in cui si esprime il preavviso, ci sipuò domandare da quale momento vada a decorrere il termine almenosemestrale che precede l’efficacia del recesso. Come è noto, una dellemaggiori innovazioni apportate dalle riforma riguarda il fatto che il com-puto dei giorni entro cui inviare la dichiarazione del recesso non sottostàpiù ai giugulatori termini (tre ovvero quindici giorni dalla delibera assem-bleare che ha fornito il presupposto per il recesso, a seconda che il sociofosse stato presente o meno all’assise) previsti dalla vecchia formulazionedell’art. 2437, e che a detta di dottrina e giurisprudenza maggioritarie an-davano interpretati come riferiti al momento della ricezione della dichia-razione da parte della società (44). Al fine di un’analisi completa del pro-blema, tuttavia, è necessario premettervi una considerazione riguardanteil significato della disposizione di cui al terzo comma dell’art. 2437 in ma-teria di dichiarazione del recesso. L’articolo in questione dispone che del-la volontà di recedere debba essere dato un preavviso quantomeno seme-strale. Ciò apre la via ad almeno due possibili interpretazioni: 1) è neces-sario un atto separato con funzione di preavviso, ma che non sottostia ne-cessariamente alle regole dettate in materia di dichiarazione di recesso; 2)
SAGGI 1143
sizioni in tema di esercizio del diritto di recesso, inclusi i termini, possano essere derogatidallo statuto, ma solo in melius per il socio. A tale soluzione, negativa delle ipotesi peggio-rative, si perviene non tanto attraverso la clausola di garanzia dell’art. 2437, ult. cpv., quan-to con la lettura dell’art. 2437 bis nella parte in cui prevede che la lettera deve essere spedi-ta entro i termini prescritti. Non essendovi ragioni di ordine pubblico a presidio di tale do-vere, è da intendere che la doverosità dell’azione nei termini sia posta a tutela del socio, eche, dunque, siano ammissibili termini più ampi. Ragionando nello stesso modo, pare chelo statuto possa prevedere, oltre alla raccomandata, altre modalità di trasmissione della pro-pria volontà alla sede sociale, quali, ad esempio, posta elettronica, fax, o documento tele-matico munito di firma digitale (ora equiparato alla scrittura privata); in questo senso v.Carmignani, Commento all’art. 2437 bis, in La riforma delle società, a cura di Sandulli eSantoro, Torino, 2003, p. 886; Rordorf, op. loc. citt.; Maltoni, Prime riflessioni in ordine al-la nuova disciplina del recesso nelle S.p.A., reperito in rete all’url http://www.notarlex.it/news/recesso_maltoni.pdf, p. 3.
(44) Anche una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 12 del 1998) si era espres-sa nel senso di ritenere il termine come riferito alla ricezione della raccomandata da partedella società, facendosi così portatrice dell’opinione della maggioritaria dottrina: tra gli altriPresti, op. cit, p. 106; contrari a tale interpretazione, e dunque fautori di quella poi consa-crata dal legislatore del 2003, Leo, Privilegiata l’interpretazione più rigorosa per evitare una si-tuazione di stallo dell’ente, in Guida al dir., 1998, 6, p. 56 ss.; Galletti, Sulle forme e sullemodalità della dichiarazione di recesso nelle società di capitali, in Giur. comm., 1999, II, p. 247ss.
è sufficiente la dichiarazione di recesso, fatta nelle forme previste dall’art.2437 bis, che avrà tuttavia efficacia differita al momento della scadenza delperiodo di preavviso. Nel silenzio della legge, pare che entrambe le solu-zioni siano praticabili, anche se la seconda sembra foriera di minori diffi-coltà. Nella prima ipotesi, infatti, è auspicabile che l’atto separato dipreavviso di cui alla prima ipotesi sia portato a conoscenza della societàcon mezzi idonei a garantire la ricezione del preavviso da parte dell’orga-nizzazione e ad avere certezza della data in cui tale conoscenza si sia ef-fettivamente perfezionata (45). In questo senso, pure se non prevista espli-citamente, la raccomandata rientra nel novero dei mezzi validamente uti-lizzabili; ma al suo fianco può trovare spazio la notifica per mezzo di uffi-ciale giudiziario, il documento elettronico se provvisto di firma telemati-ca, o persino la consegna a mano, se munita di apposita ricevuta. Non co-sì, come già si è detto, per la vera e propria dichiarazione di recesso, percui la legge esplicitamente prevede forma e contenuto. Quanto a quest’ul-timo si nota solo incidentalmente come la riforma abbia ritenuto possibi-le il cosiddetto recesso parziale, ovvero la possibilità che il socio si svinco-lasse dalla società solo per parte delle azioni in suo possesso (46), e comenon vi sono elementi per ritenere che una tale facoltà non debba valereper il caso di recesso qui in esame (47). Ci si può chiedere se, nel caso dipreavviso dato con atto separato, costituisca onere del recedente specifi-care già nell’atto di preavviso il numero di azioni per cui intende esercita-re il proprio diritto. Se è vero quanto si è affermato supra in merito alla ra-tio del preavviso, che deve essere dato anche per consentire alla società direperire i fondi per soddisfare il socio recedente, pare che la soluzionenon possa che essere positiva; in assenza di ogni indicazione normativa,tuttavia, non si intende quale possa essere la conseguenza per il socioqualora ometta tale indicazione (48).
1144 CONTRATTO E IMPRESA
(45) Innanzitutto per il socio, in capo al quale incombe il rischio della mancata cono-scenza della sua volontà di recedere da parte della società.
(46) E questo certamente in ossequio al principio della centralità del titolo azionarionella s.p.a. ribadito anche nella relazione ministeriale al par. 9, e che ha come indispensabi-le corollario il principio di autonomia dell’azione.
(47) Di fatto il socio potrebbe, data la trasformazione della società in organizzazione atempo indeterminato, desiderare non tanto di abbandonare la compagine sociale, ma sem-plicemente di ridurre il proprio apporto in funzione di un minore rischio da dovere soppor-tare.
(48) Si potrebbe ipotizzare, ad esempio, il caso di silenzio del socio sul numero delleazioni per cui intende recedere nell’atto di preavviso, salvo specificarlo nella dichiarazioneallo scadere del periodo previsto. O ancora il caso di potenziale conflitto tra le due dichia-
Tornando al problema da cui si è partiti, è necessario notare come an-che qualora il preavviso sia dichiarato attraverso un atto separato, il socio,al fine non solo della validità, ma della stessa sussistenza della dichiara-zione di recesso dovrà avere cura di inviare una tale dichiarazione conte-nente le indicazioni prescritte dall’art. 2437 bis a mezzo raccomandata conavviso di ricevimento al termine del periodo statutariamente fissato qualepreavviso, nonché di depositare le azioni in suo possesso per cui abbiamanifestato la volontà di recedere presso la sede sociale. Giunti a questopunto, tuttavia, è necessario precisare da quale momento decorra il perio-do di preavviso, semestrale o più lungo, ma non eccedente l’anno. Comesi è appena ricordato, il legislatore del 2003 ha voluto mutare radicalmen-te le disposizioni in tema di dichiarazione del recesso, non soltanto me-diante un dilatamento dei tempi, ma anche, ed è ciò che maggiormente anoi importa in questa sede, prevedendo che tali periodi abbiano un termi-ne a quo computare a ritroso il tempo costituito non più dalla ricezionedella dichiarazione da parte della società, ma dall’invio della stessa adopera del socio. Riteniamo tuttavia che questa innovazione non debbaoperare in materia di recesso ad nutum, fondamentalmente per due ragio-ni. La prima è costituita dalla diversa natura del termine, ora estintivo del-la possibilità di dichiarare utilmente la propria volontà di recedere, ora ini-ziale, per cui da quel momento dovrà essere computata la decorrenza delperiodo di preavviso. In secondo luogo, e questo pare il punto non supe-rabile, la ragione per cui il legislatore ha ritenuto di modificare la decor-renza dei termini per la dichiarazione di recesso in favore del momentodell’invio, anziché di quello della ricezione, sono da ricercarsi nel fattoche il recesso, nelle sue varie forme e modalità, è stato generalmenteidentificato come strumento di reazione (49) ad una delibera assemblearemodificativa di una caratteristica essenziale della società, da cui il socioabbia dissentito (ipotesi tradizionale ed originale del recesso), ovvero daun evento, il cui verificarsi magari neppure è dipeso effettivamente dallasocietà, ma che per volontà della società stessa ha costituito una valida ra-gione per l’abbandono della compagine sociale (ipotesi nuova, applicabilesolamente alle società che non facciano ricorso al mercato del capitale dirischio). In entrambe tali ipotesi è più che ragionevole riconoscere che il
SAGGI 1145
razioni. In questi casi, forse, si dovrebbe tutelare l’interesse della società che « subisce » ilrecesso, più che quello del socio dalle intenzioni malferme. Il recesso sarebbe dunque daconsiderarsi esercitato per il numero di azioni minore, tra i due dichiarati dal socio, in virtùdel minore pregiudizio che tale soluzione importa (potenzialmente) per le casse sociali.
(49) In questi termini cfr. per tutti Galletti, Il recesso, cit., p. 258.
periodo per cui la società resta esposta all’alea del recesso del socio siadella minore durata possibile, contemperando tale esigenza con la possi-bilità che il socio giunga ad una decisione matura e consapevole (il termi-ne di quindici ovvero trenta giorni), nonché ad una dichiarazione che siaprima facie evidentemente foriera dell’effetto desiderato (l’apposizionedel termine ad quem al momento dell’invio della dichiarazione, che con-ferisce maggiore certezza al socio stesso in merito all’ammissibilità dellapropria dichiarazione), salvo poi passare ulteriormente la palla alla societàche potrà revocare la delibera a fondamento del recesso ovvero deliberarelo scioglimento della società.
Di questa sorta di valzer tra società e socio, è bene rammentarlo anco-ra una volta, non vi è traccia, se non per l’ultima parte, di cui si dirà trabreve, nella disciplina dell’ipotesi di recesso qui esaminata. Il recesso adnutum, per sua natura, è slegato da ogni logica di reazione. Si tratta di unatto liberamente ponibile in essere dal socio in qualsiasi momento, salvoquanto detto supra in relazione al delicato rapporto con l’art. 2328, com-ma 2°, n. 13, c.c.; proprio in virtù di questo non ha senso estendere ulte-riormente, inutilmente e al di fuori di ogni dato testuale in aiuto (50), invia analogica una norma che già riveste carattere di assoluta eccezionalitàin quel panorama degli atti a natura recettizia in cui tradizionalmente sisuole fare rientrare la dichiarazione di recesso (51). La conclusione di taleragionamento è che, per quanto riguarda il caso di recesso in esame, con-tinua a valere il principio generale degli atti recettizi, per cui la dichiara-zione acquista efficacia dal momento in cui essa perviene alla conoscenza(legale) da parte della società. Sarà da quel momento, dunque, che andràcomputato il decorso del periodo di preavviso necessario perché, dopo ladichiarazione, anche la stessa volontà di recedere del socio acquisisca effi-cacia (52). Ma, come già si è avuto modo di accennare, la dichiarazione di
1146 CONTRATTO E IMPRESA
(50) L’art. 2437 bis si esprime infatti solamente riguardo i casi in cui il recesso sia conse-guenza di una delibera ovvero di un fatto « diverso da una deliberazione ». Il caso del re-cesso incondizionato, però, è carente pure di un fatto legittimante « diverso da una delibe-razione », ma comunque consacrato a causa scatenante del fenomeno recessuale per vo-lontà dello statuto, ragion per cui non è possibile applicare il regime dei trenta giorni. Sal-va, naturalmente, qualora inopinatamente si dovesse propendere per tale situazione, la ne-cessità di provare quale sia il momento della conoscenza da parte del socio della (propria!)determinazione a recedere.
(51) E non a caso Galgano, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2004, p. 388 parlaesplicitamente di « deroga (. . .) al generale principio della cognizione ».
(52) Forse a questo punto si inserisce la perplessità maggiore che porta a ritenere prefe-ribile il sistema della sola dichiarazione di recesso ad efficacia differita piuttosto che la com-
recesso ha assunto, nei disegni del legislatore del 2003, una configurazio-ne di atto complesso, che, per quanto riguarda l’ipotesi esaminata, assumequasi la connotazione di un « procedimento di recesso ». Alla dichiarazio-ne « cartacea », di cui ci siamo finora interessati, deve infatti seguire pureil deposito delle azioni presso la sede sociale. Ora, in un’epoca di progres-siva dematerializzazione dei titoli azionari, consacrata pure dal codice ci-vile all’art. 2346, è bene non enfatizzare eccessivamente la portata di unatale disposizione. Tuttavia, qualora siano stati emessi i titoli, ovvero siastata utilizzata una diversa tecnica di legittimazione, è bene chiedersi qua-le sia il momento in cui è previsto l’obbligo del deposito presso la sede so-ciale. A ben vedere, pare che la soluzione debba essere data nel senso diprevedere che il deposito debba essere effettuato presso la sede socialeentro il giorno della scadenza del periodo di preavviso, e ciò in ragione diuna molteplicità di fattori.
Innanzitutto, infatti, l’art. 2437 bis prevede l’obbligo del deposito del-le azioni in funzione, ci pare, della garanzia che il socio si astenga dall’a-lienazione dei titoli. Il deposito deve essere effettuato, secondo quanto sipuò arguire dalla lettera della legge, contestualmente alla dichiarazionedella volontà di recedere, si direbbe proprio al fine di evitare l’alienazione
SAGGI 1147
binazione « atto separato + dichiarazione ». Se infatti al termine esatto del periodo previstoquale preavviso è necessario, per completare il procedimento di dichiarazione di recesso, ildeposito delle azioni presso la sede sociale, dato su cui senz’altro ci si occuperà nel testo,un tale adempimento è senza dubbio più semplice avendo quale riferimento a quo la datadi arrivo a destinatario della dichiarazione stessa: da essa sarà sufficiente computare i seimesi (o il termine maggiore eventualmente previsto dallo statuto, sempre all’interno dellacornice annuale) per avere senza esitazioni la data certa in cui effettuare il deposito. Noncosì per il sistema combinato di cui sopra. Si avrà naturalmente, in base a quanto supraesposto, la certezza della data di arrivo della dichiarazione di preavviso (in cui andrà effet-tuato il deposito delle azioni), da cui andrà fatto decorrere il termine semestrale (o comun-que maggiore, se stabilito dallo statuto); ciò che mancherà, invece, sarà la certezza a prioridella data di arrivo della raccomandata contenente la dichiarazione ufficiale di recesso; sal-vo ammettere che per tale dichiarazione: a) tornasse (inesplicabilmente) ad essere applica-bile il sistema che prevede l’efficacia decorrente dal momento dell’invio, ovvero b) fosseopportuno ed ammissibile che potesse essere fatta anche non alla cadenza esatta del preav-viso, con l’indicazione della data che, a seconda di quanto riportato nell’avviso di ricevi-mento dell’atto separato, sarà da considerare scadenza del preavviso. Ma qualora si accolgaquesta seconda soluzione, si nota come essa rispecchi, in definitiva, il sistema della sola di-chiarazione, senza apprezzabili benefici né per il socio (che trova ad avere due adempimen-ti anziché uno solamente), né per la società (che non sarà interessata a sapere da che gior-no sarà efficace il recesso, avendo conoscenza della data di arrivo presso di lei della dichia-razione, ovvero della lettera di preavviso).
del titolo azionario. In questo senso pare si possa leggere la disposizionedel secondo comma dell’art. 2437 bis come una endiadi, volta a decretareil deposito proprio quale modalità esecutiva del divieto di vendita delleazioni per cui si recede, non intuendosi altra possibile funzione (53). Se,tuttavia, si aderisce alla impostazione finora seguita, che fa della dichiara-zione di recesso un atto complesso formato dalla dichiarazione scritta edal deposito delle azioni, senza il compimento del quale il recesso non siada ritenersi efficace, ci si pone, per l’appunto, il problema relativo al tem-pus di tale onere. Come si è finora detto, l’invio della dichiarazione qualemodalità di preavviso va a configurare la stessa come un recesso ad effica-cia differita; differita, appunto, al momento della scadenza del periodo dipreavviso stesso, ragion per cui il decorso di tale termine (condizione diefficacia specificamente prevista per il caso di recesso ad nutum) va affian-cato, al fine dell’acquisizione di efficacia della dichiarazione, all’adempi-mento del deposito dei titoli presso la sede sociale (condizione di efficaciageneralmente prevista per ogni ipotesi di recesso). Il fatto, poi che il de-posito debba essere effettuato soltanto entro il giorno di scadenza delpreavviso risponde ad esigenze di un duplice ordine. Da un lato, infatti, illegislatore nulla ha detto riguardo il deposito in questa particolare ipotesi,e pare che quindi sia da ritenere che tale adempimento debba essere com-piuto non tanto nella contestualità della dichiarazione cartacea, come èstato ipotizzato per gli altri casi di recesso, bensì almeno entro l’avverarsidell’altra condizione di efficacia prevista per questa particolare causa di re-cesso. In secondo luogo, non sembra sia ammissibile un deposito che siverifichi successivamente alla scadenza del preavviso. Se così non fosse,infatti, la società resterebbe paradossalmente in balia degli umori del so-cio, e ciò per un tempo non determinabile (54), con palesi interferenze sul-
1148 CONTRATTO E IMPRESA
(53) Per la verità una ragione potrebbe essere rinvenuta nella verifica della serie conti-nua di girate da cui desumere l’effettività della qualifica di socio, se non che tale adempi-mento è necessario pure per l’iscrizione del libro dei soci; tale funzione sarebbe comunquepossibile solamente in presenza di titoli nominativi.
È significativo notare, a suffragio della tesi esposta sulla ratio del deposito delle azioni,come anche in altri casi, nel testo della riforma, tale onere sia accompagnato dalla necessitàdi non alienare i titoli, esplicitamente (ad es. art. 2343, comma 3°) o implicitamente (art.2370, comma 2°; si riconosce che in questa circostanza la impossibilità di alienare è solo uneffetto secondario del deposito, essendo il principale la stessa certificazione dello status so-cii).
(54) Infatti il socio potrebbe tranquillamente inviare la dichiarazione di recesso con sco-pi, per così dire, meramente precauzionali, ed omettere il deposito delle azioni così da po-tere recedere immediatamente, in virtù della scadenza ormai avvenuta del periodo di
la libertà di gestione della società e sull’approntamento di eventuali pianistrategici e finanziari (55) (56).
6. – Da quanto finora emerso, si sollevano almeno due questioni. Laprima è relativa alla posizione del socio nella pendenza del periodo dipreavviso, e se e come su questo influisca l’avvenuto deposito o meno deltitolo azionario; la seconda, invece, riguarda le conseguenze di un tardivoo mancato adempimento (57) rispetto ad uno o più tra gli obblighi previstidal legislatore per l’efficacia del recesso.
Iniziando, per comodità e per semplicità, dal secondo problema, sipuò ipotizzare che il mancato adempimento di uno qualunque degli ob-blighi previsti al fine della attribuzione di efficacia al recesso dichiarato dalsocio dovrebbe portare alla caducazione implicita della dichiarazione stes-sa. In questo senso si potrebbe affermare che il mancato deposito delleazioni entro il termine di scadenza del preavviso comporti una revoca defacto della dichiarazione di recesso (58).
SAGGI 1149
preavviso, qualora decidesse in tal senso. In questo modo si priverebbe di qualsiasi effica-cia la previsione legale del preavviso stesso.
(55) Il tutto in ragione del fatto che non si saprebbe se il socio intenda veramente rece-dere e, in caso positivo, se realmente le sue azioni passerebbero in mano ad un altro sog-getto, ovvero la liquidazione debba essere effettuata attingendo al capitale sociale.
(56) Se la società dovesse decidere per la mancata emissione dei titoli azionari, un even-tuale trasferimento della partecipazione avrebbe effetto nei confronti della società, secondoil disposto del comma 1° dell’art. 2355, dal momento dell’iscrizione dell’acquirente nel li-bro soci. In questa ipotesi la condizione di efficacia non potrà certo essere il deposito del-l’azione presso la sede sociale, in virtù del lapalissiano assunto che non si può depositareciò che non esiste, quanto l’assenza del comportamento per prevenire il quale è posto a ca-rico del socio l’obbligo di depositare le azioni, ossia, come è appena stato detto, il non tra-sferire la partecipazione sociale. In caso contrario, ovvero qualora il socio alienasse la par-tecipazione durante la pendenza del termine, un tale comportamento sarebbe da conside-rarsi, ai fini che qui interessano, una revoca implicita della dichiarazione di recesso.
(57) Il novero di casi qui ricompresi è più ampio di quanto non si possa intravedere adun primo sguardo; oltre al caso, lampante, del mancato o tardivo deposito delle azioni, sipuò configurare, ad esempio, anche il tardivo invio della raccomandata contenente la di-chiarazione di recesso, qualora il preavviso sia stato atto con atto separato, e la prima giun-ga oltre la scadenza del preavviso; o ancora l’alienazione dei titoli, espressamente vietatadalla legge, ma non provvista di sanzione.
(58) Con conseguenze sia in capo al socio, che lasciando decorrere inutilmente il termi-ne suddetto si priva della possibilità di recedere per un tempo almeno pari alla durata di unulteriore preavviso previsto dallo statuto; sia in capo alla società, che, ancorché si sia attiva-ta nella ricerca di risorse mediante le quali fare fronte alla pretesa liquidatoria del socio exrecedente, dovrebbe comunque vedere con maggiore favore il mantenimento dell’integrità
È proprio attraverso questa visione che si giunge al primo dei proble-mi supra sollevati. Per quanto riguarda, infatti, il contenuto del c.d. statussocii durante il periodo di preavviso, ci pare non vi siano elementi per ri-tenere che il socio debba essere privato di alcuno dei suoi diritti. Se infat-ti vale quanto finora affermato, il recesso, per quanto validamente espres-so, è ancora inefficace nella pendenza del periodo di preavviso, ed il legi-slatore non ha voluto stabilire esplicitamente compressioni di diritti neiconfronti del socio uscente; ragion per cui saranno da riconoscersi in capoal socio tutti i diritti amministrativi e patrimoniali generalmente di suapertinenza, compreso quello di revocare, come si è appena visto, la di-chiarazione di recesso già espressa, sia in via esplicita, che implicita.
Il campo in cui, piuttosto, sorgeranno questioni è quello relativo al-l’applicazione a questo modello recessuale dell’art. 2437 bis, comma 3°,dettato in tema di efficacia del recesso. Come noto, infatti, la disposizionein parola statuisce che « il recesso non può essere esercitato, o, se già eser-citato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la de-libera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della so-cietà ».
Certo non sfugge l’anomalia della norma: ancora una volta non è in-dicato il dies a quo fare decorrere i novanta giorni. È pur vero che è stataproposta una soluzione doverosamente differenziata a seconda che ci sitrovi innanzi ad un recesso che trova la sua legittimazione in una deliberaassembleare piuttosto che nell’accadimento di un evento (59); tuttavia, co-me più volte nel corso di questa pagine si è detto, il recesso qui in esame
1150 CONTRATTO E IMPRESA
del patrimonio sociale, piuttosto che l’effettivo utilizzo delle risorse oggetto della sua ricer-ca durante il periodo di preavviso. Ci pare comunque si possa profilare una sorta di respon-sabilità del socio nei confronti della società qualora l’utilizzo sistematico del recesso sia in-dice di un reiterato atteggiamento dell’azionista volto ad intralciare l’operato del gruppo di-rigente, sfruttando a proprio favore il dovere di quest’ultimo di approntare i fondi even-tualmente necessari alla buonuscita dell’azionista (qualora l’espletamento delle prime for-me di liquidazione previste dall’art. 2437 quater sia stato vano), distogliendo attenzioni edenaro da altre operazioni strategiche. Pare che in questo senso possano essere invocati gliestremi dell’abuso di diritto di recesso; sul punto cfr. Paciello, op. cit., p. 1114 s.; e, da unpunto di vista più generale, Galgano, Abuso del diritto: l’arbitrario recesso ad nutum dellabanca, in questa rivista, 1998, p. 18 ss; Martines, Abuso di diritto: la chicane del socio di mi-noranza, ivi, p. 27 ss.
(59) Maltoni, op. cit., p. 5 che sostiene che i novanta giorni debbano essere computatidall’assunzione della delibera, qualora il recesso sia conseguenza di essa, ovvero dal ricevi-mento, da parte della società, della dichiarazione di recesso del socio qualora la causa de-terminante il recesso sia l’accadimento di un fatto.
è indipendente da entrambe tali variabili, e questa sua caratteristica non ècerto di aiuto nel ricostruire la volontà del legislatore. Vi sono, difatti, duepossibili conclusioni tra esse configgenti che si possono trarre, entrambe anostro avviso sufficientemente fondate. Da un lato si può ritenere che lapossibilità di rendere inefficace il recesso ad nutum sia data alla societàqualora, entro novanta giorni dalla ricezione da parte della società delladichiarazione con funzione di preavviso (60), deliberi il proprio sciogli-mento; dall’altro si può ipotizzare che i novanta giorni decorrano, invece,solamente a partire dal momento del deposito delle azioni.
A favore della prima ipotesi milita l’interesse del socio a che il proce-dimento di liquidazione della partecipazione abbia il suo inizio esatta-mente al termine del periodo di preavviso, senza dovere attendere, quin-di, ulteriori novanta giorni in cui il suo recesso, pur efficace, si trova ad es-sere in certo qual modo sub iudicio societatis, con conseguente surrettizioampliamento del termine di preavviso (61). Si deve tuttavia osservare che,in questo caso, al socio sarebbe fornito un termine ben più lungo di quel-lo in mano alla società per porre nel nulla il recesso. Egli, infatti, essendodurante il periodo di preavviso in possesso di ogni suo diritto sociale, po-trà revocare in qualsiasi momento il proprio recesso, mentre alla societàsarebbe data tale facoltà solamente per i primi novanta giorni successivialla ricezione del preavviso.
Le ragioni che, invece, spingerebbero a propendere per la seconda so-luzione sono di ordine sia letterale che di equità. Il criterio basato sullalettera della legge si fonda sull’espressione: « è privo di efficacia » (art.2437 bis, comma 3°). Come si è appena visto, infatti, la dichiarazione di re-cesso acquista efficacia solamente dal momento del deposito delle azionie non pare si possa avere un’anticipazione di tale efficacia al momento
SAGGI 1151
(60) Sia essa stata fornita con le formalità ex art. 2437 bis ovvero con atto separato.(61) É forte, però, una perplessità riguardo ad una tale ricostruzione: se la società vera-
mente può privare di efficacia il recesso solamente sino a novanta giorni dalla prima dichia-razione del socio, perché il socio può revocare il recesso, secondo il modello appena pre-sentato, fino alla data di scadenza del preavviso? Si potrebbe sostenere che una simile di-sparità di trattamento tra socio e società è del tutto ingiustificata, e che non ha senso con-cedere un tale favore a chi ha già dalla sua parte il considerevole vantaggio di potersene an-dare in qualsiasi momento. A fini equitativi, dunque, si potrebbe ipotizzare che anche lapossibilità di revoca da parte del socio può essere ammessa solamente fino al novantesimogiorno dalla ricezione della dichiarazione da parte della società. Ma anche questo escamo-tage non convince: se così fosse, quali conseguenze si potrebbero attribuire al fatto delmancato deposito delle azioni, che supra abbiamo considerato quale tacita volontà di revo-care la dichiarazione di recesso?
della ricezione del preavviso solamente al fine di limitare il potere da par-te della società di porre nel nulla il recesso già esercitato dal socio ai priminovanta giorni seguenti la ricezione del preavviso. È pur vero che vi potràessere chi ritenga eccessiva una tale soluzione, motivando la propria posi-zione con il presunto difetto di esercizio del recesso in mancanza dell’e-spletamento dell’obbligo di deposito dei titoli azionari e la conseguenteapplicabilità della prima parte del periodo del comma in esame per cui « ilrecesso non può essere esercitato ». Una simile obiezione non parrebbecondivisibile, ancora una volta in ragione del riferimento alla lettera dellalegge: recita infatti l’art. 2437 bis: « il diritto di recesso è esercitato me-diante lettera raccomandata . . . »; in altre parole, altro è l’esercizio del re-cesso, che in base a questa ricostruzione avviene mediante la ricezione daparte della società del preavviso, altro la sua efficacia, che si raggiunge so-lamente con il deposito dei titoli, o, in caso di mancata emissione dei tito-li azionari, con il decorso del termine di preavviso. Se la ricezione dellaraccomandata costituisce la modalità di esercizio del diritto di recesso,una volta che essa sia stata recapitata, sia pure anche a fini di preavviso,già non si può più ritenere che non sia stato esercitato il recesso, ragionper cui l’unico parametro su cui fare affidamento resta quello della effica-cia (62), che verrà acquisita solamente al momento del deposito. La conse-guenza di tale ragionamento sarebbe di negare la possibilità, per la so-cietà, di porre nel nulla il « procedimento di recesso » (iniziato dal sociocon la sua dichiarazione) attraverso la delibera di scioglimento durante ilperiodo che va dalla ricezione da parte della società della dichiarazione direcesso (esercizio del recesso) al deposito dei titoli azionari presso la sedesociale (efficacia del recesso). Anche se venisse deliberato lo scioglimentoin tale lasso di tempo, infatti, esso non avrebbe l’effetto di rendere ineffi-cace il recesso dichiarato dal socio, e ciò in virtù del fatto che tale recessoè già ex se inefficace fino al momento del deposito dei titoli; la conse-guenza di tale conclusione si riverbererebbe, quindi, sulla quota di liqui-dazione del socio, da valutare alla stregua dei criteri dell’art. 2437 ter, e
1152 CONTRATTO E IMPRESA
(62) E non si può non ritenere che la ricezione della dichiarazione non costituisca eser-cizio del recesso anche perché, altrimenti, stante il fatto che « il recesso non può essereesercitato » qualora la società deliberi il proprio scioglimento, realmente non si ha alcunapezza d’appoggio al fine di stabilire da quando debbano decorrere i novanta giorni entro iquali il deliberato scioglimento non consente l’esercizio del recesso, essendo gli unici duefatti oggettivi passibili di costituire un termine a quo, come supra si è affermato, i momen-ti da un lato della ricezione del preavviso e dall’altro del deposito delle azioni presso la se-de sociale.
non di quelli generali per la liquidazione della società (63). Il socio diver-rebbe, in questo senso, creditore della società allo scadere del termine dipreavviso. Nulla, tuttavia, è disposto riguardo alla disciplina della deliberadello scioglimento della società in un tale periodo di limbo. A fronte diquesto grave inconveniente, vi sarebbe il vantaggio di avere finalmenteuna situazione equiparata tra il socio e la società. Consentendo a que-st’ultima di rendere inefficace il recesso del socio fino al novantesimogiorno successivo al deposito delle sue azioni, infatti, sarà possibile rite-nere che anche la possibilità di revoca del recesso dichiarato da parte delsocio potrà essere esercitata, in via analogica, fino a tale termine.
La scelta tra le due opzioni non è semplice, anche se pare sia preferi-bile la prima. È vero che il socio potrà porre nel nulla il proprio recessoben più a lungo del tempo a disposizione della società per renderlo (defi-nitivamente) inefficace (64), ma è necessario considerare se una tale que-stione sia sufficiente per comprimere il suo diritto ad una pronta uscitadalla società, al punto di tenere in sospeso il recesso fino a, potenzialmen-te, un anno e tre mesi dal momento in cui è stato il procedimento sia sta-to iniziato. Inoltre è necessario valutare se è effettivamente un lato nega-tivo il fatto che al socio sia dato un tempo alquanto più dilatato di quantonon sia quello concesso alla società. Certamente una simile situazione èpositiva per l’interesse del socio, che ha a disposizione un lasso di temposufficientemente lungo per valutare l’effettiva convenienza dell’abbando-no della società. Ciò che può lasciare perplessi, piuttosto, è l’eventualecompressione degli interessi della società; si deve però valutare con atten-zione il fatto che è plausibile che il potere di reazione conferito alla so-cietà attraverso la possibilità di deliberare lo scioglimento con effetti pre-clusivi dell’efficacia del recesso sarà presumibilmente esercitato dalla stes-sa nel minor lasso di tempo possibile, se la sua ragion d’essere è realmen-
SAGGI 1153
(63) E non varrebbe, a tale proposito, sostenere che l’espressione « è privo di efficacia »debba essere letta nel senso non tanto della perdita di un’efficacia che evidentemente inprecedenza il recesso possedeva, quanto nell’intenzione di renderlo definitivamente inca-pace di essere in un futuro efficace. Se pure così fosse, non bisognerebbe dimenticare cheil termine qui preso in considerazione come dies a quo fare decorrere i novanta giorni sa-rebbe comunque successivo, essendo il deposito dei titoli l’ultimo adempimento che il so-cio dovrà sostenere alla conclusione del periodo di preavviso. In effetti è comunque da talelettura della privazione di efficacia che si prendono le mosse per sostenere la tesi preferitanel testo.
(64) Ci pare, per equità di trattamento, anche nel caso di mancata emissione dei titoliazionari, essendo possibile una dichiarazione di revoca del recesso che pervenga alla societàentro la scadenza del periodo di preavviso.
te il recesso del socio. Il ritenere che tale effetto sia protraibile fino ai tremesi successivi al deposito delle azioni significa, in pratica, che lo sciogli-mento potrebbe essere deliberato per ragioni che nulla hanno a che vede-re con il recesso, restando il socio soltanto a farne le spese ed essendo ilsuo abortito recesso nulla più che un elemento meramente accidentale,travolto dalle dinamiche societarie. In questo modo, difatti, verrebbe me-no anche quell’ultima traccia dell’originale dialettica societaria tra mag-gioranza e minoranza che per decenni ha costituito il terreno d’elezionedel recesso e che, in questa ricostruzione del recesso ad nutum, non ha al-tro appiglio che nel basilare schema azione/reazione.
Altra questione riguardo questo tema attiene alle conseguenza sul re-cesso già dichiarato, non tanto della delibera di scioglimento della società,che abbiamo visto comportarne l’inefficacia, quanto di una sua eventualerevoca. In questo caso si assiste ad un fenomeno di reviviscenza del re-cesso precedentemente dichiarato? O piuttosto si deve ritenere che sia ne-cessaria una nuova dichiarazione di recesso, con conseguente obbligo dilasciare decorrere interamente un nuovo periodo di preavviso? Il proble-ma deve però essere affrontato secondo un differente punto di vista, fo-riero di maggiore soddisfazione per l’interesse del socio. Difatti, tra le cau-se di recesso « ordinarie » ed inderogabili previste dal primo comma del-l’art. 2437 vi è pure la revoca dello stato di liquidazione. Una simile previ-sione costituisce una sorta di clausola di garanzia per il socio che subisca,a meri fini dilatori, la decisione dell’assemblea riguardo il prima delibera-re e poi revocare la messa in liquidazione della società; al socio sarà appe-na sufficiente « non concorrere » alla deliberazione riguardante la revocadello stato di liquidazione per avere la possibilità di recedere, e questa vol-ta senza neppure la necessità del decorso del termine di preavviso (65).
1154 CONTRATTO E IMPRESA
(65) Si può discutere, ma sembra doversi dare risposta affermativa, se anche il recesso,da dichiarare entro i termini previsti dall’art. 2437 bis debba essere inteso come inefficacenei successivi sessanta giorni ai sensi del secondo comma dell’art. 2487 ter, in attesa di unaeventuale opposizione dei creditori sociali alla revoca dello stato di liquidazione. A rigoredi logica, se la messa in liquidazione della società e la revoca stessa dovessero rispondere alogiche di mero intralcio alla volontà nel senso del recesso del socio, non dovrebbero esse-re molti i creditori interessati a presentare opposizione; qualora, al contrario, il recesso delsocio, anziché la ragione scatenante, fosse nulla più che un elemento accidentale all’inter-no della contingente situazione societaria, in quel caso sono ipotizzabili ben più opposizio-ni dei creditori, e con maggiori chance di essere accolte. In questo modo, il recesso del so-cio sarebbe comunque privo di efficacia, ma non sarebbe tuttavia censurabile il comporta-mento della società.
7. – Esaurite le questioni in tema di esercizio del diritto di recesso adnutum, che certamente rappresentano l’aspetto più problematico del coor-dinamento tra norme pensate per l’utilizzo nel caso del recesso tradizio-nalmente inteso quale diritto della minoranza e questo nuovo caso, è be-ne dare un rapido sguardo alle disposizioni in tema di valutazione dellaquota e liquidazione al socio recedente.
Quanto al primo punto, gli aspetti che si presentano ictu oculi proble-matici sono essenzialmente due: da un lato la scelta del momento storicoin base al quale determinare il valore della partecipazione, dall’altro l’ob-bligo o meno da parte degli amministratori di determinare in anticipo ilquantum della liquidazione al fine di consentire al socio una migliore va-lutazione su quale strategia possa essere la migliore in relazione alla suasituazione concreta.
La scelta del momento in cui effettuare le valutazioni previste dalcomma 2° dell’art. 2437 ter, o dall’autonomia statutaria nel caso in cui, inbase al quarto comma dell’articolo in esame, si sia stabilito di derogare aicriteri legali, è questione che ha notevoli implicazioni ben oltre la sempli-ce valutazione della quota da riconoscere e liquidare al socio che abbiadeciso di recedere, riverberandosi in maniera decisa anche sulla questionedei diritti da riconoscere al socio nella pendenza del periodo di preavviso.È necessario, infatti stabilire in primis quali siano i momenti in cui effet-tuare tale valutazione, per poi scegliere quale risulti preferibile. Sembrache essi siano rinvenibili o nella ricezione della dichiarazione di preavvisoda parte della società, o alla scadenza del periodo stesso.
Molteplici ragioni fanno propendere per questa seconda ipotesi. In-nanzitutto, infatti, se si ritiene, come supra è stato fatto, che il socio, du-rante il periodo di preavviso, resta a tutti gli effetti socio della società (66),non si intende per quale ragione egli dovrebbe essere privato, nel bene enel male, degli eventuali risultati figli della gestione (anche sua, se non al-tro per avere concorso al raggiungimento dei quorum assembleari) dellares sociale (67). Un secondo indice di preferenza per questa soluzione è da-
SAGGI 1155
(66) Ipotesi che, come si è visto, troverebbe una certa conferma nella implicita possibi-lità di revocare la propria volontà di recedere sino al giorno della scadenza del preavviso.
(67) Ovviamente un tale aspetto assumerà importanza via via crescente a seconda delpeso del socio all’interno della compagine azionaria; essendo possibile, come più volte ri-cordato, anche il recesso del socio di maggioranza, un simile criterio porta a conclusioni as-sai maggiormente accettabili di una soluzione opposta, in cui il socio, ormai certo di avereuna quota di liquidazione valutata sulla base della situazione sociale del momento dell’ini-zio del periodo di preavviso, potrebbe benissimo disinteressarsi della gestione della società,non ricavando da tale attività alcun utile, né alcuna perdita.
to dal maggior grado di veridicità della quantificazione del valore dellapartecipazione. Come è noto, infatti, una delle innovazioni epocali in ma-teria di recesso presenti nel testo della riforma è data proprio dai mutaticriteri volti a determinare il quantum debeatur al socio recedente, che, nel-la vigenza della previgente disciplina, erano considerati attendibile indicedel palpabile sfavore del legislatore nei confronti dell’istituto del recesso(68). La ragione della innovazione è da rinvenire proprio nel desiderio, an-che a detta della Relazione ministeriale, di conciliare le due prospettive, laliquidazione del socio e la continuazione dell’attività sociale, in insanabi-le contrasto, mutando i criteri previgenti, « fortemente penalizzanti » (69).Il fatto di liquidare al socio il valore attribuito, potenzialmente fino ad unanno prima, alla sua partecipazione sociale, non solo non è conciliabilecon l’intento del legislatore a fornire, almeno di default, una valutazioneveritiera del valore della partecipazione, ma sarebbe indice proprio perquesto di una nuova volontà punitiva del socio recedente, ovvero propriodal sistema da cui si rifugge (70).
1156 CONTRATTO E IMPRESA
(68) Riguardo alla presunta iniquità dei criteri di liquidazione previsti dal previgente si-stema concordava la dottrina quasi unanime fin dalla più risalente; si v., tra gli altri, Sraf-fa, Una nuova questione sul recesso dei soci dalle società anonime, in Riv. dir. comm., 1905, II,p. 253; Di Sabato, Istituzioni di diritto commerciale, Milano, 2001, p. 153; Galgano, Dirittocommerciale. Le società, Bologna, 2001, p. 338; Campobasso, Diritto commerciale, II, Torino,2002, p. 486; Grippo, Il recesso del socio, in Tratt. delle società per azioni, diretto da Colom-bo e Portale, vol. 6, Torino, 1993, p. 192; Santoro, Recesso del socio e criteri di ricalcolo delrimborso delle azioni, in Società, 2001, 3, p. 313. Contra tale impostazione l’autorevole vocedi Galletti, Il recesso, cit., passim, che non riteneva iniqui i criteri di valutazione, e tanto-meno che non fossero spia dello sfavore del legislatore nei confronti dell’istituto in esame,sostenendo invece che le garanzie di inderogabilità in peius dell’istituto previste dal vecchioart. 2437 c.c. per tutte le ipotesi di recesso testimoniassero un ottica di favore per questoistituto da parte dell’ordinamento.
(69) Così la Relazione Ministeriale, par. 9.(70) È pur vero che vi sarà chi, animato dalle considerazioni « antirecessuali » retaggio
dell’abrogato sistema, ritenga che il lasciare in capo al socio recedente la valutazione, ma-gari vecchia di un anno, della sua partecipazione risponde ad esigenze in certo qual modoperequative degli svantaggi arrecati dal recesso stesso all’organizzazione societaria: unasorta di « occhio per occhio, dente per dente », in cui la vetustà della valutazione funge da« sanzione » al socio per avere col suo recesso indebolito la società. Una tale impostazioneè da rifuggire decisamente, soprattutto perché, anche muovendosi su di un terreno tantoaspro, non si riesce a capire dove stia la sanzione qualora, in seguito ad esempio ad una pe-sante svalutazione, il valore della partecipazione al momento dell’inizio del periodo dipreavviso sia maggiore rispetto a quello calcolato al termine del periodo stesso. Per un ap-proccio molto interessante, anche se non suffragato da elementi di diritto positivo, in temadi liquidazione della quota sociale, si v. Angiola, Il diritto di recesso del socio di società di
Un terzo elemento che spinge a preferire la soluzione qui perorata ècostituito da quello che qui abbiamo ipotizzato essere il secondo proble-ma in tema di valutazione della quota: l’obbligo di preventivo calcolo delvalore delle quote alla stregua dei criteri ex art. 2437 ter. È vero che l’art.2437 ter, comma 5°, si esprime, riguardo la possibilità di preventiva cono-scenza del valore della liquidazione, in termini inequivocabilmente legatialle previsioni di recesso quale reazione ad avverse delibere assembleari.Premesso ciò, tuttavia, non si può prescindere, a nostro avviso, dal consi-derare quale sia la ratio che ispira una simile disposizione. Ci pare, dun-que, che essa risieda inequivocabilmente nel dare la possibilità al socio divalutare, ponendole sui piatti della bilancia, quale delle due opzioni siamaggiormente preferibile, tra la sopportazione dei risultati derivanti dalladelibera a lui sgradita e la liquidazione della propria partecipazione secon-do il valore determinato dagli amministratori. Si può dunque affermareverosimilmente che tale norma sia stata inserita nel corpus della riforma alfine di favorire il socio recedente. È pur vero, però, che se questa è la si-tuazione nelle ipotesi di recesso « tradizionale », in cui si possono riscon-trare due elementi da porre, come si è appena detto, sul piatto della bilan-cia dell’interesse individuale, nel caso di recesso da società contratta atempo indeterminato una disposizione di questo tipo potrebbe avere, pa-radossalmente, una funzione « filosocietaria ». Se, infatti, si desse al sociola possibilità di conoscere in anticipo l’entità della sua eventuale liquida-zione, la società non solo non avrebbe nulla da perdere (71), ma sarebbe incondizione di ottenere il massimo guadagno potenziale possibile: il man-cato recesso da parte del socio. Si consideri, infatti, il caso in cui il rece-dente fornisca il preavviso di cui finora si è detto, ma al termine dello stes-so il valore della partecipazione calcolato alla stregua dei criteri ex art.2437 ter, comma 2°, sia notevolmente inferiore alle sue attese; il fatto diavere la possibilità di conoscere in anticipo il quantum gli verrà liquidatopotrebbe essere, in un caso simile, un buon deterrente per il socio dal suo
SAGGI 1157
capitali. Riflessioni economico-aziendali alla luce dell’innovata disciplina civilistica, in Lariforma delle società di capitali. Aziendalisti e giuristi a confronto, a cura di Abriani e Onesti,Milano, 2004, p. 312 ss.
(71) Non è infatti credibile che, mancando la preventiva determinazione del quantum daparte degli amministratori venga meno pure la procedura di contestazione prevista dal se-sto comma dell’articolo in parola. Piuttosto si dovrà, qualora non si ritenga di accettare l’i-potesi infra presentata nel testo, consentire che il socio possa proporre la contestazione almomento della sua prima conoscenza del valore della liquidazione, momento che potreb-be, in caso di particolare inerzia, coincidere con lo stesso momento della liquidazione.
iniziale proposito di abbandono della società, e rappresenterebbe per essala possibilità, in un momento che potrebbe essere difficile, dato il deprez-zamento del titolo, di non subire il trauma ulteriore della defezione di unazionista.
Coordinando le soluzioni date ai due problemi qui esaminati, dun-que, si perviene ad un disegno complessivo che vede la società in doveredi approntare, per mezzo degli amministratori, la determinazione del va-lore della liquidazione dei titoli per cui è esercitato il recesso, in prossi-mità della scadenza del termine di preavviso; mancando qualsiasi riferi-mento rispetto a quando tale adempimento debba essere portato a termi-ne, si potrebbe ipotizzare, in via analogica, che l’obbligo per gli ammini-stratori (72) scatti entro i quindici giorni che precedono la scadenza del pe-riodo di preavviso (73).
Altra questione assai importante riguardo la valutazione della parteci-pazione, specie qualora lo statuto nulla disponga e si resti, dunque, nel re-gime di default, è legata al passaggio della società alla quotazione nellapendenza del periodo di preavviso. Stanti le differenti modalità di quanti-ficazione del valore della partecipazione, ci si può chiedere in primo luo-go che ne sia del recesso e, qualora si propenda per una sua persistenza,quale debba essere il regime di valutazione della partecipazione che deb-ba essere usato.
Per un approccio esauriente alla questione dell’an, sembra imprescin-dibile, ancora una volta, il ricorso alla ratio ispiratrice del recesso da so-cietà contratta a tempo indeterminato. Come supra è stato evidenziato, inseguito alle critiche venute da autorevoli esponenti del mondo accademi-co e finanziario, la commissione incaricata di predisporre il testo della
1158 CONTRATTO E IMPRESA
(72) Oggetto di particolare attenzione è il contenuto dell’obbligo per gli amministratori.Stando alla lettera della legge, ad essi compete solamente l’approntare la determinazionedel valore nei termini e secondo i criteri stabiliti, non già il comunicare tale valore al rece-dente. Pur essendo, infatti, tale obbligo previsto nell’interesse del socio, il legislatore pareaver inteso condizionare tale interesse all’attivazione del socio per conoscere la determina-zione. In questo senso, infatti, sembra si debba leggere l’assunto per cui « i soci hanno di-ritto di conoscere . . . »: il diritto è quello dei soci alla conoscenza, ed agli amministratorispetta semplicemente il rendere azionabile tale diritto in linea teorica; non certo, dunque,il comunicare ai soci quanto determinato, bensì, semplicemente, operare affinché tale co-noscenza possa essere acquisita da parte del socio che si sia voluto attivare. In questo sen-so v. Maltoni, op. cit., p. 4 s.
(73) Interpretazione analogica che, peraltro, potrebbe essere adottata in ogni caso di re-cesso non direttamente derivante da deliberazione, ma in cui sia possibile l’individuazionedi un dies a quo computare i quindici giorni.
riforma ha mutato il suo precedente avviso ed ha ritenuto che il recessoad nutum dovesse essere concesso solamente ai soci delle società le cuiazioni non fossero quotate su un mercato regolamentato. La ragione ditale limitazione risiede proprio nella maggiore apertura delle società quo-tate, condizione che consente una più facile e rapida monetizzazione del-la partecipazione al socio che voglia abbandonare. Vi sarebbero, dunque,due ordini di ragioni che spingerebbero a ritenere che il recesso del sociovenga ad essere implicitamente caducato dalla quotazione della societànella pendenza del periodo di preavviso: da un lato la maggiore facilitànell’alienazione della partecipazione nel sistema delle società quotate;dall’altro la rapidità del fenomeno traslativo dei titoli, ovvero la non ne-cessarietà di attendere un periodo almeno semestrale per uscire dalla so-cietà.
Il sistema prospettato pare reggere bene, se non che sarebbe ipotizza-bile una sua applicazione pure nel caso in cui il procedimento di recessopersista (74), peraltro con l’ulteriore garanzia che la partecipazione verràcomunque liquidata anche qualora non vi siano compratori sul mercatoregolamentato (75). Una simile affermazione, tuttavia, parrebbe scontrarsiinsanabilmente con il dettato dell’art. 2437, comma 3°, quando affermache «. . . se le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il so-cio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni », qualoranon si dia al termine recedere il significato di uscire. Se infatti si conside-rasse il significato di recedere come l’inviare la dichiarazione al fine diesercitare il recesso, allora al problema da cui si è partiti si dovrebbe darerisposta indubbiamente negativa: in questo caso, infatti, il recesso sareb-be esercitato quando già la società è quotata in un mercato regolamenta-to, e la dichiarazione di recesso conseguente è da ritenersi inammissibile.Qualora, al contrario, si segua la linea interpretativa che qui si è cercato diillustrare, ovvero il considerare anche il preavviso come parte del procedi-mento che porta all’uscita, nonché modalità dell’esercizio del recesso, al-lora al recedere si dovrà dare il significato di « esito del procedimento direcesso », ritenendosi, a questo punto, che il procedimento del recesso infieri sopravviva all’avvenuta quotazione della società.
SAGGI 1159
(74) Seguendo, infatti, quanto si è detto supra, il socio che intenda vendere la sua parte-cipazione tra il momento del fornito preavviso a quello della scadenza di tale periodo potràcomunque farlo, comportando tale gesto una implicita revoca alla dichiarazione di recesso.
(75) Per la stessa natura del mercato, l’ipotesi è del tutto residuale, ma costituirebbe inpotentia una ulteriore garanzia per il socio di cui, se si seguisse una simile impostazione,non si capirebbe perché dovrebbe essere privato.
Qualora si aderisca alla soluzione appena prospettata, tuttavia, sarànecessario, come si anticipava all’inizio di questo paragrafo, desumerequale debba essere il criterio di valutazione per la partecipazione del sociorecedente, stante la differente disciplina di default prevista a seconda chele società siano quotate o meno. Prescindendo in questa sede dalla pun-tuale analisi delle due discipline, e pure dal problema della derogabilitàstatutaria della disposizione in materia di valutazione della liquidazionenelle società quotate, si ricorda solamente come il valore di liquidazionedella azioni del socio di società che faccia ricorso al mercato del capitale dirischio sia da calcolare in base al prezzo medio di chiusura dei sei mesiprecedenti l’avviso di convocazione dell’assemblea la cui delibere abbianodeterminato il recesso. Ora, come si è visto in tema di prederminazionedel valore ad opera degli amministratori, il fatto che la disposizione siaesplicita solamente in relazione ai casi di recesso tradizionalmente intesinon costituisce un problema insormontabile. Certo, però, in questo casopotrebbe rappresentare un indizio che, letto congiuntamente ad altri chestiamo per vedere, faccia propendere per il criterio di valutazione fissatoper le non quotate, o quantomeno per un valore misto. Ciò che, probabil-mente, è più indicativo al fine di escludere la possibilità che il criterio diriferimento sia tout court quello dettato per le quotate, è la valutazione se-condo un valore medio semestrale. La ratio di tale disposizione pare deb-ba essere ricercata nel garantire al socio se non il reale valore della parte-cipazione, almeno uno che ad esso si avvicini il più possibile, depuratoquindi da eventuali picchi positivi o negativi della quotazione. Natural-mente quanto maggiore sia il periodo preso in considerazione per il cal-colo della media, tanto più fedele sarà tale opera di « depurazione ». Il fat-to che, nell’ipotesi qui in esame, il lasso di tempo compreso tra la quota-zione della società in borsa e la scadenza del periodo di preavviso possatranquillamente essere inferiore ai sei mesi richiesti dalla norma in temadi valutazione della quota, pare un ostacolo difficilmente superabile, an-che guardando alla ratio della disposizione (76). In funzione di ciò, dun-
1160 CONTRATTO E IMPRESA
(76) Specie in relazione al fatto che la norma, dettata come si è detto per i recessi deter-minati da delibere non gradite al socio, si preoccupa di non fare sentire all’azionista rece-dente il peso, in termini di valutazione della quota, della delibera cui egli non abbia con-corso, essendo tale valore da determinare al momento della pubblicazione degli avvisi diconvocazione dell’assemblea. Non così il caso qui esaminato: il fatto che si tratti propriodei primi mesi successivi alla quotazione fa propendere in maniera decisa per una instabi-lità di massima della società, che ancora deve trovare un suo equilibrio nel mercato, conconseguenti oscillazioni anche sensibili della quotazione, cui pure la media aritmetica diffi-cilmente potrebbe porre rimedio.
que, restano due alternative: o si adotta il criterio stabilito per le societànon quotate, o si crea ad hoc un parametro « misto », che si riferisca, cioè,ai criteri dettati per le non quotate fino a che la società sia in tale condi-zione, passando poi ai parametri dettati per le quotate, dal momento del-l’ingresso nel mercato in poi. Pare che la prima ipotesi sia probabilmenteda preferire, nonostante una teorica applicabilità anche del sistema misto.Ciò che maggiormente fa propendere per i parametri ex art. 2437 ter, com-ma 2°, è, ancora una volta, il dato letterale. Quando, infatti, si stabilisceche per determinare il valore della partecipazione per cui si recede gli am-ministratori debbono tenere conto anche « dell’eventuale valore di merca-to delle azioni », non si capisce quale altro significato si possa attribuire atale inciso, dal momento che ci si riferisce alle società che non hannoazioni quotate in mercati regolamentati, e dunque essenzialmente « chiu-se ».
Quanto, poi alla liquidazione della partecipazione, pare di potere af-fermare che, almeno quanto a questo aspetto, non dovrebbero sussistereproblemi legati alla particolare natura del caso di recesso qui in esame,trovando applicazione la normativa generale dettata dall’art. 2437 quater.
8. – Le ultime due questioni che paiono prospettabili rispetto alla di-sciplina del recesso ad nutum sono relative alla possibilità o meno di eli-minare questo caso di recesso da parte della società, ovvero di rinunziarvia priori da parte del singolo socio.
Per quanto riguarda la derogabilità o meno dell’ipotesi di recesso inesame, da un punto di vista letterale-sistematico pare ci possano essereelementi a favore dell’una come dell’altra tesi. La clausola di garanzia del-l’art. 2437, comma 6°, copre solamente i casi previsti dal primo comma,ovvero quelli appartenenti alla categoria espressamente definita come in-derogabile. Da questo novero resta escluso naturalmente il caso che qui sista esaminando, e potrebbe da ciò argomentarsi la possibilità della stessaeliminazione, ad opera dello statuto, della possibilità di recedere ad nu-tum. Tale ipotesi, per quanto giustificabile in base alla lettera della norma,tuttavia non convince. A favore della tesi contraria, infatti, si può citare laformulazione del terzo comma quando, con perentoria sentenziosità, sta-bilisce che in caso di società contratta a tempo indeterminato e che nonsia quotata, « il socio può recedere con il preavviso di almeno centottantagiorni ». A tale regola generale, poi, è data una deroga, prevista dal perio-do successivo ove si ammette che « lo statuto può prevedere un terminemaggiore, non superiore ad un anno ». Se si svolge il ragionamento a con-trario, ammettendo la possibilità per lo statuto di eliminare detto caso di
SAGGI 1161
recesso, si assisterebbe alla paradossale ipotesi in cui sarebbe possibile,per usare la stessa terminologia dell’art. 2437, rendere più gravoso l’eserci-zio del recesso solamente fino ad un certo punto (il termine massimo dipreavviso fissato dalla legge in un anno); ma che, parimenti, la stessa fat-tispecie potrebbe essere lecitamente eliminata da una espressa previsionestatutaria in tal senso.
Dalla ricostruzione appena fatta, quindi, emerge che, pur non copertodall’applicazione della clausola di garanzia, il recesso ad nutum in caso disocietà a tempo indeterminato è da considerarsi non eliminabile dallo sta-tuto (77).
Non sembra crei particolari problemi, invece, ammettere la possibilitàdi rinuncia al diritto da parte del socio. Il problema è stato per decennicontroverso ed ha costituito, anche sotto l’impero del codice di commer-cio, oggetto di aspro dibattito (78). Le difficoltà, fondamentalmente, nasce-vano dal pensare che il socio cui ancora difettassero i presupposti per l’e-sercizio del diritto (delibera assembleare e suo dissenso) non potesse vali-damente disporre di un diritto che, di fatto, ancora non era venuto alla lu-ce. Tale questione certamente non si pone nel caso di recesso in esame;qui, essendo il recesso un diritto che è entrato nello stesso patrimonio didiritti del socio nel momento in cui ha aderito ad una società contratta atempo indeterminato, non esiste ragione per ritenere che il socio non nepossa disporre.
9. – L’ultimo problema che si pone riguardo l’ipotesi di recesso ad nu-tum è, probabilmente, il più affascinante. Ci si chiede, infatti, se vi sianoimpedimenti di ordine legislativo all’ipotesi che venga inserita negli statu-ti delle società che non facciano ricorso al mercato del capitale di rischiouna clausola concedente il recesso ad nutum anche nelle società contrattea tempo determinato.
Come si vedrà, il problema pare destinato ad essere più teorico chepratico; tuttavia la sua trattazione fornisce un interessante spunto perquanto concerne il limite ultimo oltre cui la volontà dei soci non si può
1162 CONTRATTO E IMPRESA
(77) Su tale linea interpretativa si inseriscono Morano, op. cit., p. 310; Santosuosso, Ilnuovo diritto societario, Milano, 2003, p. 84; Rosapepe, Modificazioni statutarie e recesso, inAa.Vv., Diritto delle società di capitali. Manuale breve, Milano, 2003, p. 303; Paciello, op.cit., p. 1114; D’Andrea, op. loc. citt.; e, sia pure in termini dubitativi, Rordorf, op. cit., p. 9.Decisamente contrario, invece, è Cappiello, op. cit., p. 846 s.
(78) Per tutti si v. Donadio, Il recesso del socio per modifiche statutarie, Milano, 1940, p.25 ss.
spingere nelle società azionarie. In base alla linea tendenziale della rifor-ma verso una sempre maggiore autonomia statutaria l’ammissibilità dellaclausola non sarebbe da escludere tout court (79). Acutamente, un autoreha ritenuto opportuno segnalare che la effettiva possibilità di una similecausa deve discendere, innanzi tutto, dall’analisi approfondita del caso direcesso legale previsto per le società a tempo indeterminato (80). Pare tut-tavia eccessivo basarsi, al fine di escludere la possibilità di prevedere unrecesso ad nutum statutario, sull’argomento che il recesso disciplinato dalterzo comma (caso di società costituita a tempo indeterminato) sia a talpunto eccezionale da non consentire la sua estensione anche a quelle so-cietà che, non avendo azioni quotate, siano state contratte a tempo deter-minato. Ed invero qui non si tratta di pensare in termini di interpretazio-
SAGGI 1163
(79) Per la verità i commentatori sono divisi sul punto. Danno soluzione sostanzial-mente favorevole: Carmignani, op. cit., p. 882; Maltoni, op. cit., p. 3; Crosti, Vitali, Il re-cesso, in La nuova disciplina del diritto societario, a cura di Bellezza e Gubitosi, Piacenza,2003, p. 241; Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società, Bologna, 2003, p.209; Rordorf, op. cit., p. 927. Propendono per l’opposto avviso: Cappiello, op. loc. citt.;Galletti, Commento all’art. 2437 c.c., nel Commentario al nuovo diritto societario a cura diMaffei Alberti, in corso di pubblicazione su Nuove leggi civ. comm., consultato grazie allacortesia dell’a. In posizione scettica, ma alquanto dubbiosa, si annoverano De Nova, op.cit., p. 333; Callegari, Commento all’art. 2437, in Il nuovo diritto societario, diretto da Cot-tino (ed altri), Bologna, 2004, p. 1407. Qualora si estenda il campo visivo all’àmbito dellesocietà a responsabilità limitata, il panorama non pare mutare in maniera sostanziale. Op-pongono un netto rifiuto alla liceità di clausole di recesso ad nutum in società a tempo de-terminato Toschi Vespasiani-Ginotti, La costituzione, i conferimenti ed il recesso nellanuova società a responsabilità limitata, in Studium Iuris, 2004, p. 447; oltre che, ancora, Gal-letti, Commento all’art. 2473, contenuto nel Commentario sopra menzionato; e ancora, ve-latamente, Lanzio, Il recesso di socio di s.r.l., in Società, 2004, p. 154, che lamenta scarsa ef-ficienza garantistico-operativa nel sistema che consente l’opposizione dei creditori in casodi liquidazione del recedente mediante intaccamento del capitale sociale. Fautore della so-luzione permissivistica è invece, oltre al già citato Rordorf, Maltoni, Il recesso e l’esclusio-ne nella nuova società a responsabilità limitata, in Not., 2003, p. 310. Una soluzione interme-dia, basata sulla costante analisi del caso di specie è, invece, proposta da M. Rescigno, Lanuova società a responsabilità limitata, in Il nuovo diritto delle società di capitali e delle so-cietà cooperative, a cura di M. Rescigno e Sciarrone Alibrandi, Milano, 2004, p. 282. Perma-ne dubbiosa la posizione di Nigro, La società a responsabilità limitata nel nuovo diritto so-cietario: profili generali, reperito online http://www.unisi.it/eventi/riforma-srl/atti.html, p. 14del dattiloscritto.
(80) Scrive Maltoni, Prime riflessioni, cit., p. 3: « circa l’ammissibilità di una clausola direcesso ad nutum, si può ritenere che ogni valutazione debba passare attraverso le forchecaudine della valorizzazione sistematica della disposizione del terzo comma, che fissa qua-le causa di recesso inderogabile in ordine all’an l’assenza di un termine finale della so-cietà ».
ne estensiva od analogica, bensì di chiara volontà dei soci che non trovaalcun limite esplicito nel testo della legge (81). Detto ciò, la lettura più coe-rente con il disegno complessivo sarebbe quella che vede la possibilità direcedere da società contratte sine die tutelata dalla inderogabilità statuta-ria, in ragione del vincolo perpetuo altrimenti opprimente il socio; mentreper le società a tempo determinato come una semplice possibilità che è la-sciato alla discrezione della volontà sociale se sfruttare o meno.
Si deve tuttavia considerare che l’ammissione di una clausola che con-senta il recesso incondizionatamente anche nelle società contratte a tem-po determinato potrebbe rivelarsi estremamente pericolosa (82). Non soloperché l’attribuzione di tale diritto, e la conseguente imprevedibilità concui potrebbe essere esercitato, costituisce una sorta di cappio al collo del-l’ente sociale, che potrebbe trovarsi nell’impossibilità di un’adeguata pia-nificazione finanziaria a causa di una miriade di mini-recessi che, nel me-dio periodo, potrebbero non essere sempre assorbiti (83) dai soci supersti-ti; ma soprattutto, da un punto di vista sostanziale, perché l’attribuire lafacoltà di un recesso ad nutum ad ogni socio significa privare di valore vin-colante il termine finale della società apposto nell’atto costitutivo (84), for-nendo una sorta di data di scadenza definitiva erga omnes, ma lasciando lo
1164 CONTRATTO E IMPRESA
(81) Per la verità, vi è stato chi (Galletti, Commento all’art. 2437 c.c., cit.; Cappiello,op. loc. citt.) ha ritenuto di vedere nell’espressione « ulteriori cause di recesso », presentenel quarto comma dell’art. 2437, un implicito divieto all’apposizione di clausole di recessoad nutum, rimarcando il fatto che la discrezionalità dell’azionista non integra la fattispeciedella « causa ». Ci si permetta di dissentire: qualora l’accento venga posto, anziché sul ter-mine « causa » sul concetto di « ulteriori », pare necessario domandarsi rispetto a cosa deb-ba essere intesa tale « ulteriorità». Certamente, si risponderà, alle fattispecie previste dalcomma 1° (inderogabili) e dal comma 2° (derogabili) dell’art. in parola; ma perché, allora,non anche da quella ex comma 3°, che peraltro fornisce l’antecedente logico-sistematico piùprossimo alla norma in tema di cause statutarie di recesso?
(82) Il pericolo per la società ed il suo capitale sociale è costante di tutti gli aa. che siesprimono contro la possibilità di apposizione di clausole di recesso ad nutum in società atempo determinato, si rimanda perciò alla nota 79. Per una critica radicale al recesso ad nu-tum, anche nel mondo giuridico anglosassone, si veda la classica posizione di Manning,The Shareholder’s Appraisal Remedy: An Essay for Frank Coker, in The Yale Law Journal,1962, vol. 72, p. 239 s.
(83) Sia quanto alla liquidazione dei recedenti, che alla pazienza dei restanti, che po-trebbero vedere minato il proprio investimento dalla instabilità di una simile situazione, ri-solvendosi essi stessi per l’abbandono della società in cerca di maggiori profitti altrove, edeterminando, così, la fine della società.
(84) Ed in questo senso, ci pare, la definizione del recesso in esame quale « determina-tivo », operata da De Nova, op. cit., p. 332.
spazio ad una serie di termini ad personam, a detrimento, in ultima ratio,dei creditori sociali (85). E, non essendo l’ipotesi in alcun modo previstadalla legge, non pare si debba necessariamente ritenere applicabile in viaanalogica la norma sulla società a tempo indeterminato, restando così lapossibilità, eventualmente, anche di non prevedere alcun termine dipreavviso (86). Crediamo che il punto focale del ragionamento debba esse-re imperniato sull’importanza ed il fondamento dell’accordo tra i soci, chedeve essere letto come una sorta di « vincolo di sistema » per la salvaguar-dia, in ultima ratione, sia della società che del mercato in cui essa opera.Altre strade dubitiamo possano essere battute: non la pista letterale (87);né tantomeno la supposta eccezionalità dell’istituto del recesso, che hatrovato nella riforma nuova vigorosa linfa vitale. Forse è praticabile lastrada dell’eccezionalità del solo recesso ad nutum, ma ancora una voltaessa conduce ad una questione di fondo, ovvero se l’autonomia statutariapossa avere, nelle società azionarie, un peso tale da consentire la derogaal vincolo sociale, in un problema che investe totalmente anche l’assettoorganizzativo della società. Invero, l’autonomia statutaria è stata certoampliata in relazione al profilo organizzativo, ma si risolve comunque nel-la scelta di uno dei tre modelli di governance, senza possibilità di estrositàstatutarie in materia, e non pare guardare con estrema simpatia a vie diexit particolarmente semplici che non siano dettate da ragioni di promo-zione dell’investimento economico. Se, infatti, ci si sofferma sulle ragioniche hanno condotto all’affermazione della possibilità di apporre negli sta-tuti ipotesi di recesso che non fossero quelle legali, si scorge, indubbia-mente, il non celato desiderio di fornire al piccolo azionista risparmiatoreun « paracadute » approntato dalla società stessa al fine di rendere più ap-petibile l’investimento nei propri titoli. Un tale disegno emerge con chia-rezza lampante anche da altre disposizioni riformate, quali, ad esempio,l’aumento del tetto massimo alle emissioni obbligazionarie o la previsio-ne di strumenti finanziari partecipativi di tertium genus. Ci si trova dinanziad una società che ha necessità di finanziamenti, sia in termine di capitali
SAGGI 1165
(85) Che tuttavia avrebbero una propria tutela attraverso la consultazione preventiva delregistro delle imprese. Per ulteriori spunti in questo senso si veda, sempre a proposito del-la possibilità di inclusione di ipotesi extralegali di recesso negli statuti, ma nella vigenzadelle precedenti norme Niccolini, op. cit., p. 77 s.
(86) Contra Galletti, op. ult. cit.(87) Quantomeno in via principale; potrebbe tuttavia rivelarsi, come peraltro è nelle
trattazioni degli aa. cit. supra, nota 81, un sussidio ad una dimostrazione di più ampio re-spiro.
di rischio, che di capitale di debito, e per questa ragione tenta di convo-gliare verso di sé i potenziali investitori, promettendo loro un facile egres-so dalla società. In questo senso una clausola di recesso ad nutum costi-tuirebbe lo strumento ideale nelle mani della società. Se non che, per unavolta, è necessario trovare un principio superiore al favor societatis, chepotremmo definire favor mercaturae. In questo senso, più che la singolaimpresa, importa il mondo del mercato, inteso come interrelazione traimprese, consumatori, finanziatori. La situazione che si verrebbe a creareattraverso l’apposizione di clausole di recesso ad nutum sarebbe estrema-mente pericolosa proprio perché istituzionalizzerebbe un giogo sul collodelle società che le avessero adottate, ma non solo per il pericolo che inquesto senso correrebbe la società, quanto per il pregiudizio che un suoeventuale dissesto potrebbe causare alla platea dei fornitori, dei creditori,degli investitori, dei consumatori. In breve, per le notevoli esternalità ne-gative che da tale dissesto andrebbero determinandosi (88). Considerato ilfatto che il recesso ad nutum costituisce, inoltre, il punto più alto di mi-naccia credibile da parte del socio nei confronti della società, non sembradel tutto peregrino ipotizzare una situazione in cui la società sia, di fatto,prigioniera del suo socio, in proporzione tanto maggiore quanto è il pesodi questi all’interno della struttura societaria (89). Ad ulteriore suffragio diquesto argomento, si deve rilevare che i capitali in movimento saranno ra-gionevolmente più consistenti nelle s.p.a. rispetto ad ogni altro tipo socia-le, per cui maggiore sarà l’interesse pubblico alla conservazione della so-cietà, in quanto inserita in un contesto socio-produttivo.
Per quanto, dunque, l’autonomia statutaria sia complessivamenteuscita rinvigorita dall’impianto riformato, pare si debba comunque dareimportanza maggiore ad una fase esterna della società, ossia al visum concui essa si presenta al pubblico degli investitori e, soprattutto, dei credito-ri. In questo senso pare sussista una sorta di interesse pubblico ad evitareche la società possa prevedere forme di recesso ad nutum anche qualora visia un contratto a tempo determinato.
1166 CONTRATTO E IMPRESA
(88) A tale proposito è chiarissimo Galletti, op. ult. cit., ripreso da Id., Commento al-l’art. 2532, nel Commentario cit. Molto interessante pure Manning, op. cit., pp. 240-241.
(89) La credibilità della minaccia, poi, è ulteriormente acuita dal fatto che, in caso discioglimento della società dovuto all’impossibilità di riduzione del capitale sociale, a causadell’opposizione dei creditori, al socio receduto potrebbe verosimilmente toccare in sorteuna quota di liquidazione più alta rispetto a quella dei restanti consoci, e questo potrebbeessere un ulteriore stimolo a « tradire » la società, qualora essa dovesse versare in cattive ac-que. Per ulteriori spunti, si v. Martines, op. loc. citt.
10. – Si è visto come il diritto di recesso ad nutum costituisca una im-portante innovazione apportata dalla riforma delle società di capitali. Ilnucleo fondante di tale novità è probabilmente costituito dalla naturacompletamente autonoma ed indipendente dell’ipotesi in esame. In altritermini, dall’essere il recesso ad nutum assolutamente slegato dalla pro-spettiva di dialettica maggioranza-minoranza che era propria di questoistituto fino alla riforma Vietti. Il fatto stesso che si tratti di una ipotesi direcesso « senza dissenso » (90), e quindi azionabile pure da chi sia socio dimaggioranza, rende il recesso ad nutum una incognita per il prosieguodella società, che si potrebbe trovare, ex abrupto, privata di sostanziose ri-sorse finanziarie.
Ma un altro aspetto deve essere preso in considerazione; se è vero, co-me si è appena detto, che il terzo comma dell’art. 2437 configura una ipo-tesi di recesso « anomala » rispetto allo schema « azione-reazione » comenoto nel previgente sistema, non è tuttavia detto che non possa fornire lospunto per un diverso approccio al tema della dialettica endosocietaria. Inragione, infatti, delle considerazioni in tema di minaccia credibile espostenel precedente paragrafo, non pare assurdo ipotizzare il recesso ad nutumcome una sorta di minaccia, attraverso la quale il socio con una partecipa-zione rilevante possa tenere sotto scacco l’intera compagine sociale; sipensi solo al caso in cui egli possa determinare una situazione di deadlocknel caso in cui si prospetti l’adozione di una delibera a lui sgradita. A que-sto si aggiunga l’ulteriore questione delle esternalità negative che semprenel precedente paragrafo sono state prese in considerazione.
Non vi è dubbio, poi, che nelle società a tempo indeterminato il re-cesso ad nutum dispieghi al meglio le proprie funzioni, ma il quid, a que-sto punto, deve salire ulteriormente di un gradino: è utile la società con-tratta a tempo indeterminato? A chi serve? Prevalgono i pro o i contra? Inquesta sede si è tentato di dare una organica trattazione al diritto di reces-so, e le questioni relative all’opportunità o meno di contrarre una societàa tempo indeterminato richiederebbero spazio maggiore; non sembra tut-tavia difficile ipotizzare una scarsa applicazione di tale modello, in ragio-ne degli alti costi di transazione a fronte di pochi vantaggi evidenti.
SAGGI 1167
(90) Così Lanzio, op. loc. citt.