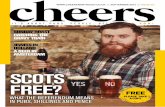La partecipazione invisibile. L'impegno di una generazione esclusa
Società civile e partecipazione democratica nell'UE del dopo referendum irlandese
Transcript of Società civile e partecipazione democratica nell'UE del dopo referendum irlandese
Le scommesse dell’Europa
Diritti. Istituzioni. Politiche
a cura diGiuseppe Bronzini, Fausta Guarriello,
Valeria Piccone
La presente pubblicazioneè stata realizzata con il contributodella Compagnia AssicuratriceUNIPOL S.p.a.
© Ediesse, 2009Casa editrice Ediesse s.r.l.Via dei Frentani 4/A - 00185 Roma06/44870283-325 Fax 06/44870335http:// [email protected]
Progetto grafico: Antonella LupiImmagine di copertina: Carla Bernardi
Introduzionedi Giuseppe Bronzini, Fausta Guarriello, Valeria Piccone 11
PARTE PRIMAI diritti
L’«internazionalizzazione» dei diritti umanidi Valeria Piccone 19
Il ruolo della Corte di Giustizia UE in una fase di crisidel modello sovranazionaledi Antonio Tizzano 51
L’adesione dell’Unione Europea alla Convenzione europeadei diritti dell’uomo. Domande e rispostedi Françoise Tulkens 55
La Corte di Giustizia e i diritti fondamentalidi Giuseppe Tesauro 63
Il rapporto fra Trattato di Lisbonae Carta dei diritti fondamentali dell’UEdi Lucia Serena Rossi 73
La tutela dei diritti nell’ordinamento comunitario:alcune osservazioni critichedi Roberto Mastroianni 89
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dopol’allargamento del Consiglio d’Europa ad est:forse (più di) qualcosa è cambiatodi Oreste Pollicino 101
Indice
Brevi notazioni sulle trasformazioni del dirittocostituzionale e sulle sorti del diritto del lavoroin Europadi Gaetano Azzariti 139
Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazionenell’ambito dell’impresa: un diritto fondamentaledi matrice europeadi Giuseppe Bronzini 147
La Carta dei diritti fondamentali dell’UE:effettività versus efficaciadi Giovanna Pistorio 163
Efficacia e ambito di applicazione dei principidi non discriminazione. La sentenza Bartschdi Silvia Borelli 177
L’Europa… vista dal Sud del mondodi Franco Ippolito 197
Diritti fondamentali, trattato di Lisbonae l’esperienza del Mercosurdi Virginia Zambrano 209
Art. 47 della Carta, Corte di Giustiziae Tribunale di Primo gradodi Marco Borraccetti 233
Il trattato di Lisbona e l’accesso alla giustiziadi Laura Nissolino 249
PARTE SECONDALe istituzioni e le politiche
Principio democratico e principio parlamentarenell’Unione Europea: il difficile camminodella «democrazia federalistica»di Paolo Ridola 261
Dopo il Trattato di Lisbona: verso un nuovo modellodi esecutivo federaledi Lucio Levi 273
L’Agenzia dell’Unione Europeaper i diritti fondamentalidi Elena Paciotti 283
Is Flexicurity a European Policy?by Silvana Sciarra 293
«I diritti collettivi e i beni comuni. Verso un riconoscimentoeuropeo?»di Piervirgilio Dastoli 311
Diritti sociali dalla prospettiva del Parlamento europeo:alcune sfaccettature della mobilitàdi Donata Gottardi 321
Cittadinanza e mercato nell’Europa socialedi Stefano Giubboni 345
Politica e giurisdizione nella costruzione europeadi Ignazio Juan Patrone 361
Società civile e partecipazione democratica nell’UEdel dopo referendum irlandesedi Giuseppe Allegri 369
Le politiche ambientali dell’Unione Europeadi Barbara Pozzo 385
Una politica europea per l’immigrazionedi Rita Sanlorenzo 409
Lotta al terrorismo, sicurezza del trasporto aereoe protezione dei dati personali nel recentecontenzioso USA/UEdi Paola Puoti 421
L’Unione Europea e le politiche di contrastodel terrorismo internazionaledi Armando Spataro 459
Tutela europea della privacy e dei dati personalidi Elena Falletti 475
Le strategie di semplificazione normativa in Europadi Chiara Meoli 485
Le autrici e gli autori 525
369
Premessa
Il no referendario irlandese al Trattato di Lisbona del 12 giugno2008, oltre ad aver sospeso l’adozione di questo Trattato, ha ripro-posto l’eterna querelle sulla mancanza di legittimazione popolare di-retta del processo di integrazione continentale.
Già nella tarda primavera del 2005 i no referendari francese edolandese al Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa avevanobloccato il pluriennale processo di costituzionalizzazione continentale,avviato con la Convenzione per il futuro dell’Europa1.
Le recenti trasformazioni dell’unificazione europea sembranoquindi essere vittime della ricerca di una legittimità democraticaperduta e, in realtà, mai ottenuta fino in fondo. In queste brevi no-te si vorrebbe riflettere sullo stallo del processo di integrazionecontinentale – a causa di una legittimità introvabile perché ormaidifficilmente rintracciabile anche nel livello nazionale delle societàtardo-mediatiche – come occasione per pensare altrimenti i mecca-nismi di controllo sulle istituzioni, partecipazione democratica eprevisione di forme di self-government, nella dimensione continen-tale.
1 In generale per una ricostruzione di quegli eventi si veda il recente volume di G.Amato, J. Ziller, 2007. Sia anche consentito rinviare a una nostra ricostruzione: G.Allegri, 2005.
Società civile e partecipazione democraticanell’UE del dopo referendum irlandese
di Giuseppe Allegri
«Je regrette l’Europe aux anciens parapets!»Arthur Rimbaud, Le Bateau ivre, 1871
370
1. Gli 862 mila no irlandesi
Per l’adozione del Trattato di Lisbona solo l’Irlanda ha dovutoconvocare una consultazione popolare diretta: procedura seguita sindall’adesione irlandese all’ordinamento comunitario, con il referen-dum del 1972 (primo emendamento costituzionale). Nel 2001 ilcorpo elettorale irlandese aveva già rifiutato l’adozione del Trattatodi Nizza, bloccando solo momentaneamente la sua adozione, che fuottenuta con un nuovo referendum, convocato nell’anno successivo.Nell’ordinamento irlandese la ratifica dei trattati comunitari avvie-ne tramite emendamento costituzionale ed in base all’art. 46 dellaCostituzione irlandese del 1937 la procedura di revisione di quellaCostituzione prevede la convocazione di un referendum popolare,conseguente all’approvazione parlamentare della legge di revisionecostituzionale.
Nel giugno del 2008 862.415 irlandesi hanno bloccato il ventot-tesimo emendamento alla Costituzione irlandese, rifiutando l’ado-zione del Trattato «semplificato» adottato a Lisbona nel dicembre2007, in sostituzione di quel «Trattato costituzionale europeo» nau-fragato nei succitati no referendari di Francia e Paesi Bassi. La par-tecipazione a questo referendum è stata di poco superiore alla metàdegli aventi diritto, il 53,4% dei quali ha votato no, con uno scarto dicirca 110 mila voti2. Così meno di un milione di no (in rappresen-tanza di quasi l’1% dei circa 490 milioni di cittadini dell’Unione Eu-ropea: i circa 4 milioni della popolazione irlandese) ha di fatto arre-stato l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Come nella prima-vera 2005 si è bloccato il processo di costituzionalizzazione dell’U-nione Europea, inaugurando una fase di immobilismo nella tra-sformazione istituzionale continentale, senza che i vincitori del noavessero nessuna proposta alternativa, così ora si piomba nuova-mente in una impasse che coinvolge le élite comunitarie e nazionali,ma anche l’apatica e scettica opinione pubblica, rappresentata daquei no irlandesi.
2 Riferimenti in rete sulla procedura seguita per il ventottesimo emendamento co-stituzionale al sito istituzionale: http://www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?DocID=8981.Per i risultati del referendum irlandese del 12 giugno 2008 e le relative percentuali sirinvia alle informazioni on line rintracciabili in http://www.rte.ie/news/features/lisbontreaty/index.html.
371
2. In cerca di quale legittimità
La storia dell’unificazione europea è costantemente accompagna-ta da critiche riguardanti il deficit democratico delle istituzioni comu-nitarie: in particolare dinanzi all’oramai più che decennale processodi trasformazione dell’Unione Europea e ai recenti allargamenti, fi-no agli attuali 27 Stati membri3. L’evolversi dei meccanismi conti-nentali di integrazione economico-finanziaria non è stato accompa-gnato dalla previsione di adeguati strumenti di controllo politico epartecipazione democratica. Il «vincolo economico» posto alle ori-gini delle Comunità europee, per avvicinare nazioni che si eranocombattute nelle due tragiche guerre mondiali del Novecento, è ri-masto monco del circuito di legittimazione diretta da parte delle di-verse cittadinanze. La supremazia del circuito intergovernativo delConsiglio dell’Unione Europea, insieme con la centralità dellaCommissione europea in quello comunitario sono argini all’amplia-mento di strumenti democratici continentali, visti nella sola ottica dipotenziamento del Parlamento europeo. È questo il leitmotiv che ac-comuna i critici, gli scettici ed i nemici dell’Unione Europea. Ementre i primi partono da un ragionevole timore per le sorti della«democrazia continentale», gli altri si cullano nello spregiudicatoabbandonarsi alle forze del mercato globale, salvo poi ritrarsi, di-nanzi alle crisi economiche, verso i sicuri lidi del «sovranismo» iden-titario delle «piccole patrie»: liberismo economico sfrenato, che allaluce dei suoi fallimenti globali si trasforma in arroccamento sicurita-rio e protezionista.
Nell’affermarsi dell’euroscetticismo è spesso sottovalutato il ruolocentrale di alcuni partiti, soprattutto della destra, in particolarequelli tradizionalisti-autoritari-nazionalisti, nel veicolare una radi-cale opposizione, spesso populistica e intollerante, all’integrazioneeuropea nei singoli dibattiti pubblici nazionali4. Sotto questo profilo
3 Questo pluriennale dibattito ha conosciuto un’attualizzazione con il saggio di A.Follesdal e S. Hix, 2005, nel loro dialogo con le ricostruzioni di Giandomenico Majo-ne e Andrew Moravcsik.
4 Si veda il recente saggio di P. Statham, 2008, che prende in esame il comporta-mento di alcuni partiti politici in sette paesi europei: Gran Bretagna, Francia, Ger-mania, Paesi Bassi, Italia, Spagna e la Svizzera, anche se paese non comunitario. Daquesta analisi si evince una significativa capacità di mobilitazione «euroscettica» daparte di diversi partiti di destra (per il caso italiano la coalizione del Polo della Liber-
372
c’è piuttosto un allarme da prendere in considerazione, troppospesso omesso nell’analisi sociale e istituzionale: «i movimenti razzi-sti e populisti hanno già acquistato un ruolo e una rispettabilitànuovi nella politica dell’Europa occidentale contemporanea», conuna pericolosa capacità di gestire il malcontento attraverso scorcia-toie intolleranti e razziste5. Dinanzi al persistere di forti disegua-glianze economiche, all’inadeguatezza dei sistemi di tutela sociale eal verificarsi di crisi finanziarie locali e globali, l’incapacità di prati-care uno spazio politico continentale all’altezza del contesto spingeverso soluzioni che potrebbero mettere in discussione i plurisecolariprocessi di civilizzazione democratica del vecchio continente.
Non è questa la sede per entrare nella singolar tenzone tra euroscet-tici, eurooppositori ed euroentusiasti; né in quella tra spregiudicati teo-rici dei funzionalismi comunitari, infaticabili difensori della monoli-tica sovranità della democrazia statuale e neo-populisti delle piccolepatrie. Tanto meno qui si vogliono azzardare nuove teorie o, peggioancora, prassi di ricerca della legittimità continentale, soprattuttodinanzi ai fallimenti dell’Unione Europea dal punto di vista dellaricerca di legittimità delle proprie trasformazioni istituzionali6. Sivorrebbero solo abbozzare alcune ipotesi di ripensamento dei rap-porti tra partecipazione democratica, attivismo della società civileed esperienza istituzionale continentale. Assumendo i pronuncia-menti referendari negativi al di là della banale interpretazione euro-scettica, piuttosto come una sorta di rifiuto dello statu quo europeo.In questi no si può intravedere una critica alle incapacità dell’Eu-ropa di presentarsi come uno spazio politico all’altezza delle crisipolitiche ed economiche, locali e globali, dinanzi alle incertezze deilegami sociali nelle società tardo-moderne e alla radicale trasforma-zione dei meccanismi di governo e delle tradizionali forme di parte-cipazione democratica.
tà), che sfocia in una opposizione anti-europeista, con punte di intolleranza e xenofo-bia, dei partiti cosiddetti tradizionalisti/autoritari/nazionalisti (TAN, traditionalist-au-thoritarian-nationalist).
5 Queste le preoccupazioni enunciate, tra gli altri studiosi, da C. Crouch, 2003, p.133, dal quale si è ripresa la citazione e l’analisi.
6 Sul «fallimento della Costituzione europea» ci invitava a riflettere Claudio DeFiores, già a partire dall’adozione del Trattato di Lisbona, senza ancora immaginarela bocciatura irlandese (C. De Fiores, 2008); si veda nella stessa Rivista anche l’inter-vento di S. Dellavalle, 2008.
373
3. Le innovazioni nello spazio politico continentaletra post-democrazia e nuova questione sociale
La posta in gioco sembra essere quella di ripensare la sfida de-mocratica post-nazionale, nell’epoca in cui il paradigma della de-mocrazia rappresentativa è in permanente crisi anche all’internodelle strutture istituzionali statuali. Dinanzi alle involuzioni speri-mentate dalla democrazia rappresentativa negli ultimi trenta annidi vita degli Stati nazione della vecchia Europa, alla scomparsa deitradizionali partiti politici di massa, alla trasformazione delle cam-pagne elettorali in sondocrazie e plebisciti mediatici permanenti, allaimpermeabilità dei circuiti di governo da parte di strumenti di con-trollo in mano alle cittadinanze, al soverchiante potere economico-finanziario nel condizionare quello politico, non c’è nessuna etàdell’oro da rimpiangere e da riproporre al livello continentale, co-me panacea di una integrazione comunitaria in affanno. Ci trovia-mo «sulla parabola discendente della democrazia»: scivolando inun’epoca che segue sperimentazioni anche radicali di forme demo-cratiche si piomba in un’era di «post-democrazia», come qualcunol’ha definita7. È quel complesso processo, sfaccettato e multiforme,che ha visto «la nascita della società in rete», per dirla con l’analisiormai classica di Manuel Castells, che con la «rivoluzione della tec-nologia dell’informazione» ha contribuito a realizzare e successiva-mente investito i meccanismi di globalizzazione, trasformando tantoi soggetti sociali, politici ed economici, quanto le forme del vivere insocietà, interrogando la «politica informazionale» dinanzi alla «crisidella democrazia»8. Sono gli interrogativi ancora aperti che CarloFormenti si pone nel ripensare i nessi tra «spazio pubblico, media epostdemocrazia», tra «declino dell’uomo pubblico» (Sennett, 2006) epostdemocrazia intesa come «catastrofe», ovvero come «speranza
7 C. Crouch, 2003, spec. p. 26, da dove si è presa la citazione. La letteratura in te-ma è oramai sconfinata; tra gli altri si vedano i saggi raccolti in D. De Kerckhove e A.Tursi, 2006.
8 Questo è uno dei profili rintracciabili nel percorso che Manuel Castells proponedell’Età dell’informazione, nella sua monumentale opera The Information Age: Economy,Society and Culture, trilogia che comprende La nascita della società in rete (1996), Il poteredelle identità (1997, 2004), Volgere di millennio (2000), pubblicate in Italia per i tipi diUniversità Bocconi Editore, anche in un unico cofanetto, M. Castells, 2004.
374
utopica», nella possibilità di immaginare una «cyberdemocrazia de-territorializzata, trasparente e partecipativa» (Formenti, 2008)9.
Anche a questo proposito Saskia Sassen parla di «assemblaggi diun’era digitale», dove sperimentare «nuove configurazioni spazio-temporali per l’attività sociale largamente intesa» (Sassen, 2008).Sono scommesse analitiche e pratiche che provano ad immaginareinediti sentieri di ripensamento e superamento delle crisi politiche,sociali, economiche, culturali che si attraversano in questo scorcio dimillennio, soprattutto in un processo di integrazione comunitariache ha perso il suo slancio progettuale, tra nuovi populismi e inca-pacità di soluzione delle questione sociali10. Dinanzi a questo cam-biamento epocale non sarà più sufficiente volgere lo sguardo al pas-sato, rammendando i vestiti lacerati della democrazia rappresenta-tiva e le logore garanzie del sistema sociale fordista, ormai inadegua-te rispetto alle attuali forme del lavoro e ai bisogni delle nuove ge-nerazioni. Il nostro punto di vista evita quindi di ancorarsi solamen-te al potenziamento del ruolo del Parlamento europeo nel meccani-smo istituzionale comunitario, tanto quanto alla riproposizione deisistemi di welfare ormai escludenti, rispetto alle nuove composizionisociali.
Accanto ad una necessaria riflessione sullo Stato della democraziarappresentativa11 sarà utile anche domandarsi (con Claus Offe e Ul-rich K. Preuss, 2006), se la democratizzazione sia la risposta al pro-blema della legittimazione del sistema comunitario, che secondo idue autori sembra sempre più incamminato verso l’ossimoro di un«Impero repubblicano». In assenza di un demos omogeneo, che untempo legittimava le democrazie statuali, il livello continentale è
9 L’ultima espressione virgolettata è una ricostruzione del pensiero di Pierre Lévyriportata da C. Formenti, 2008.
10 Proprio M. Castells, in Volgere di millennio, cit., p. 373 e ss., nel capitolo specifi-camente dedicato all’«unificazione europea: stato a rete, identità e globalizzazione»riflette sulla necessità di lottare per una «identità progettuale» continentale, «per im-porre modelli alternativi di sviluppo economico, di socialità e di governo»; questo in-vito risulta tuttora attuale, dinanzi al vuoto di progettualità politica, sia delle élites co-munitarie, che delle cittadinanze impaurite e «intimamente» ripiegate su se stesse.
11 Per parafrasare il titolo del volume a cura di C. De Fiores, 2003 (numero12/2002 della rivista Democrazia e Diritto), in cui si provava una prima analisi polifoni-ca sulle trasformazioni della democrazia tra crisi dei paradigmi statualisti e ruolodell’Europa, ma anche tra nuove forme di partecipazione e mutamenti nei modi dirappresentanza politica e sindacale.
375
piuttosto lo spazio di una coesistenza rispettosa della reciproca alte-rità delle cittadinanze d’Europa, fondata su vincoli solidaristici e dipolitiche redistributive, in un «mondo dove le popolazioni divengo-no vicine, ma rimangono straniere le une alle altre». Per dirla conparole simili: «un’idea di solidarietà che si realizza autenticamente‘tra estranei’ su di un piano transnazionale» (Giubboni, 2008).
Sembra la visione di un’Europa sociale, immaginata come sfidaaperta per ricombinare il modello sociale europeo, alla fine del pat-to statale fordista e con l’affermarsi delle rivendicazioni delle nuovegenerazioni precarie, per prevedere «uno zoccolo minimo di presta-zioni di «cittadinanza», disciplinate e in parte finanziate a livellocomunitario»12. Re-immaginare forme attive e partecipate di unnuovo welfare, legandolo alle dimensioni locali e continentali, perrendere più virtuosi e inclusivi i legami della sicurezza sociale conl’esigenza di autonomia, libertà e autodeterminazione di esistenzedignitose. Una cittadinanza sociale multilivello imperniata sull’affer-mazione di nuovi diritti, previsione di un reddito di base (basic inco-me), garantito oltre le tradizionali forme dell’impiego, accesso aiservizi e alle nuove tecnologie, libertà di movimento, possibilità diaccedere a percorsi formativi lungo tutto l’arco di vita.
Questo orizzonte di riflessione attraversa parzialmente anche ildibattito pubblico continentale sulla c.d. flexicurity (flessicurezza),nel tentativo di bilanciare flessibilità e sicurezza nelle politiche socialie del lavoro. Negli ultimi anni il confronto sulla flexicurity ha cono-sciuto un coinvolgimento della porzione più attenta di opinionepubblica europea, soprattutto all’indomani dell’adozione della Co-municazione della Commissione europea «Verso principi comuni diflessicurezza. Posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla fles-sibilità e alla sicurezza» [COM(2007) 359 def.]13.
12 S. Giubboni, 2008, spec. p. 63; poco dopo lo stesso Giubboni parla di redditominimo europeo e di «stipendio civico» (mutuando questo da R. Zoll, La solidarietà.Eguaglianza e differenza, Il Mulino, Bologna, 2003), proposte che interloquiscono conla previsione di un reddito di cittadinanza e di una continuità di reddito tra le diverseesperienze esistenziali e lavorative, come punto di confronto sia rispetto ai princìpi diflexicurity discussi a livello comunitario, che nelle ipotesi di ripensamento di nuovimodelli di welfare. Su queste tematiche cfr. G. Bronzini, 2008. Sul dibattito riguardan-te le forme di reddito universale si veda il classico Y. Vanderborght e P. Van Parijs,2005.
13 Cfr. Commissione europea, Verso principi comuni di flessicurezza: Posti di lavoro piùnumerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza, COM(2007) 359 def., Bruxelles,
376
4. Oltre l’Europa dei diritti,per la «costruzione di una società europea»
Accettare quindi che lo spazio politico ed istituzionale europeosia anche un luogo di sperimentazione di inedite, e a tratti ancoraimpensate, forme di possibili vite in comune negli anni zero del nuo-vo millennio. In questo senso si è andata consolidando nell’ultimodecennio una definizione normativa e soprattutto giurisprudenzialedei diritti fondamentali, quasi che, evitando le incapacità delle classidirigenti europee, possano essere solo i «giudici a fare l’Europa deidiritti». Dall’adozione della Carta dei Diritti fondamentali dell’UnioneEuropea nel 2000 a Nizza c’è la scommessa di investire nella forza divolontà giuridica per sconfiggere la forza dell’abitudine politica, checondanna al fallimento il processo di integrazione comunitaria.Quella Carta dei diritti fondamentali che da molti era stata immedia-tamente intesa come «atto politico e documento giuridico»14: figliadella prima Convenzione e della sua immediata applicazione pervia giurisprudenziale.
È il volontarismo ragionevole e creativo delle «sfere di giustizia»che prova a sconfiggere la pigra depressione permanentemente sta-tica delle «torri d’avorio» politiche: l’apertura verso il riconoscimen-to dei diritti di una «giurisprudenza multilivello», contro la sordachiusura delle burocrazie nazionali ed europea rispetto alle trasfor-mazioni sociali15. Del resto è nel codice genetico dell’ordinamento
27 giugno 2007. Per una interessante ricostruzione del dibattito sulla flessicurezza esulle occasioni di partecipazione ed intervento che ancora lascia aperte si rinvia al re-cente lavoro di B. Caruso, C. Massimiani, Prove di democrazia in Europa: la Flessicurezzanel lessico ufficiale e nella opinione pubblica europea, in WP int. CSDLE Massimo D’Antona,n. 59/2008, http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/int/caruso_massimiani_n59-2008int.pdf. Per una prima riflessione sulla flexicurity, anche in senso critico e nellospecifico riguardo alla modernizzazione del diritto del lavoro europeo, si rinvia ancheagli interventi di Giuseppe Allegri, Giovanni Arrigo, Giuseppe Bronzini, Salvo Leo-nardi, Benedetto Vecchi, contenuti nella rubrica FlexEuropa, http://www.centroriformastato.it/crs/rubriche/flexeuropa.
14 Per riprendere il titolo del saggio di Stefano Rodotà, La carta come atto politico edocumento giuridico, in A. Manzella, P. Melograni, E. Paciotti, S. Rodotà, 2001, volumecollettivo ad opera dei quattro rappresentanti italiani alla Convenzione sui diritti fonda-mentali dell’Unione Europea, che redasse il testo della Carta.
15 La letteratura in tale ambito è sconfinata; basti qui ricordare due recenti lavoripresenti nel dibattito italiano: M. Cartabia (a cura di), 2007, e G. Bronzini, V. Piccone(a cura di), 2007.
377
comunitario il procedere per conflitti tra giustizia ordinaria, costitu-zionale ed europea, dialogo tra le Corti, attivismo giurisprudenzialee «integrazione attraverso i diritti».
Dal dialogo/conflitto tra i diversi livelli di giustizia, fino al prota-gonismo della Corte di Giustizia delle Comunità europee è possibileintravedere la «costruzione di una società europea attraverso la giu-risdizione»16. La ricostruzione sociologica che Münch propone, apartire dalla concezione della «divisione del lavoro nella società»mutuata dall’omonimo classico di Emile Durkheim, è l’affermazionedi un sistema giuridico comunitario, una comunità giuridica euro-pea, che realizza una giustizia progressiva come eguaglianza di op-portunità all’interno e tra le diverse nazioni, fino alla creazione diuna «nuova società transnazionale europea, composta da individuidotati di poteri e da una pluralità di associazioni auto-organizzate edi singoli individui autonomi».
5. Le possibilità al di là del nuovo Trattato:ripensare i diritti e la partecipazione democratica
Per certi versi il Trattato «semplificato» adottato nel dicembre2007 a Lisbona andava in questo senso, da una parte riconoscendovalore giuridico alla Carta dei diritti fondamentali all’interno delTrattato; dall’altra ribadendo le aperture in favore di forme di de-mocrazia oltre quella rappresentativa.
Il nuovo articolo 6 del TUE (anche in versione consolidata), se-condo gli emendamenti introdotti dal Trattato di Lisbona prevedeesplicitamente che «l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principisanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che halo stesso valore giuridico dei Trattati»17. Con ciò si vorrebbe dareseguito alle previsioni del precedente Trattato che adotta una Costitu-zione per l’Europa, del quale la Carta dei diritti fondamentali costituiva
16 Così argomenta in un recente saggio R. Münch, 2008.17 Si veda il Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione Europea e il
trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007,2007/C 306, art. 1, 8, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, 17 dicembre2007, 2007/C 306/01; e la versione consolidata del Trattato sull’Unione Europea 2008/C115, pubblicato in GUCE del 9 maggio 2008.
378
la seconda parte18. Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona laCarta dei diritti fondamentali diverrebbe diritto primario di una Unio-ne Europea non più fondata sui tre pilastri tradizionali, ma soprat-tutto sulla tutela dei diritti fondamentali, intesa come il nucleo durodi una integrazione che fa leva sull’estensione delle garanzie e il ri-conoscimento di nuove generazioni dei diritti.
D’altro canto al titolo II («Disposizioni relative ai principi demo-cratici») gli articoli 8A, 8B e 8C del TUE, secondo gli emendamentiintrodotti dal Trattato di Lisbona (articoli 10, 11 e 12 del TUE in ver-sione consolidata)19, affermano rispettivamente la supremazia delprincipio della democrazia rappresentativa sul quale «si fonda»l’Unione Europea; l’apertura a cittadini e associazioni rappresentati-ve del circuito istituzionale dell’UE; la valorizzazione dei parlamentinazionali.
Come è stato notato dai primi commentatori del Trattato «sem-plificato» il nuovo articolo 11 del TUE in versione consolidata (art.8B, secondo gli emendamenti introdotti dal Trattato di Lisbona alTUE)20, rispetto alle previsioni del Trattato costituzionale europeomantiene «principi e procedure della «democrazia partecipativa»,che però perde questa denominazione»21. Infatti all’articolo I-47 delTrattato che adotta una Costituzione per l’Europa, si affermava il «prin-cipio della democrazia partecipativa» (nel titolo di quell’articolo)22;mentre nella versione del Trattato di Lisbona si perde il riferimentoterminologico alla democrazia partecipativa, che non è più esplici-tamente citata, ma rimane identico il contenuto del nuovo articolo11 rispetto al precedente art. I-47.
Come nella redazione del Trattato costituzionale europeo al primo
18 Si veda Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, 2004/C 310, pubblicatonella GUCE del 16 dicembre 2004.
19 Cfr. Trattato di Lisbona, 2007/C 306, cit., art. 1, 19 e nella versione consolidata delTUE, Trattato sull’Unione Europea 2008/C 115, cit., art. 11.
20 Ivi.21 Sergio Dellavalle, Una legge fondamentale post-costituzionale? Il diritto pubblico euro-
peo alla luce del Trattato di Lisbona, cit.22 Per un commento al principio di democrazia partecipativa previsto dal Trattato che
adotta una Costituzione per l’Europa sia consentito rinviare a Giuseppe Allegri, 2006. Unaricostruzione delle nuove frontiere della democrazia in Europa è contenuta nel recentevolume Z.T. Pállinger, B. Kaufmann, W. Marxer, T. Schiller (eds.), 2007, in cui il saggiodi Victor Cuesta si occupa specificamente della democrazia partecipativa: Prospects forPartecipatory Democracy in the Supranational Constitutionalism of the European Union.
379
paragrafo del nuovo art. 11 TUE in versione consolidata si ricono-sce un generale diritto di pubblicità delle opinioni dei cittadini edelle associazioni rappresentative, «in tutti i settori di azione dell’U-nione». Al secondo paragrafo si rende vincolante per tutte le istitu-zioni dell’Unione il «dialogo aperto, trasparente e regolare con leassociazioni rappresentative e la società civile». Al terzo si affermache la Commissione «procede ad ampie consultazioni delle parti in-teressate» per «assicurare coerenza e trasparenza delle azioni dell’U-nione». Al quarto paragrafo si prevede in capo ad «almeno un mi-lione di cittadini dell’Unione, che abbiano la cittadinanza di unnumero significativo di Stati membri», il diritto di «iniziativa di invi-tare la Commissione, nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentareuna proposta appropriata su materie in merito alle quali tali citta-dini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai finidell’attuazione dei Trattati». Si rinvia quindi a quanto previsto dal-l’attuale art. 24, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell’U-nione Europea in versione consolidata23, per l’adozione di regolamenticomunitari che disciplinino «le procedure e le condizioni necessa-rie» per tale iniziativa.
Per certi versi è questo l’ennesimo tentativo di dare una cornicegiuridica formale, tramite l’esplicitazione in un Trattato, alle diverseforme di partecipazione messe in atto dalla parte organizzata edistituzionalizzata della società civile europea e di quelle nazionali nelpolicymaking comunitario, tra hard e soft law. Si è detto in precedenzache già il Trattato costituzionale europeo provava una costituzionalizza-zione delle pluriennali, e a volte oscure o poco conosciute, pratichedi apertura, audizione, consultazione che avvengono nel circuito traCommissione, Parlamento, Consiglio dell’UE e le porzioni più or-ganizzate della società civile (Allegri, 2006). È un tentativo di par-ziale emergenza e regolazione attraverso trattati delle cangiantiforme di governance: c’è una letteratura sconfinata che ha indagato einterrogato l’evoluzione di questi meccanismi di governance comuni-taria, fino a giungere alla ricostruzione di new modes of governance (apartire dall’open method of coordination) e, da ultimo, alla presa in
23 Si cfr. l’ultimo comma del nuovo art. 11 TUE in versione consolidata, cit., che rin-via all’attuale nuovo articolo 24, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell’U-nione Europea in versione consolidata, pubblicato nella GUCE del 9 maggio 2008, 2008/C115/47, da p. 47 in poi.
380
esame della partecipazione delle organizzazioni non governative «inthe EU law-making Process»24.
Il nuovo Trattato di Lisbona ribadisce la necessità di riconoscimen-to di queste pratiche e sembra puntare ad una loro valorizzazione,ribadendo il diritto di iniziativa di un milione di cittadine/i europei,nel ripensamento delle azioni pubbliche con pretesa di influenzaistituzionale immediata, optando per un potenziamento sia di navi-gate, che di inedite forme di partecipazione democratica, oltrequella rappresentativa.
6. Conclusioni provvisorie: un cortocircuito post-rappresentativo,oltre il Trattato di Lisbona
Oltre ad accettare le innovazioni dell’articolo 11 del TUE in ver-sione consolidata – che di fatto riconosce alle associazioni (a partiredalle NGOs) e ai cittadini europei un diritto ad essere ascoltati an-che dall’istituzione intergovernativa per eccellenza: il Consiglio dellaUE (Butler, 2008) – si dovrebbe trasformare l’immobilismo euro-peo, delle classi dirigenti, come di un’opinione pubblica incapace diarticolare qualcosa oltre il no, in una sfida per ripensare strumenti,procedure e pratiche di partecipazione.
Proprio dinanzi alla sordità della politica tradizionale, al plebisci-tarismo tardo-populista e iper-mediatico in cui declina la rappre-sentanza, alla sterile usura degli strumenti logori della democrazia ecompletamente immersi sia nel vuoto delle trasformazioni istituzio-nali europee, che nella passività egoistica e chiusa di larga fetta del-l’opinione pubblica nazionale ed europea, è auspicabile il salto diparadigma che permetterebbe di prendere sul serio i diritti e le nuoveforme della partecipazione in Europa. Se da una parte è incontesta-bile l’attivismo giurisdizionale che mette in comunicazione la riven-dicazione dal basso di nuovi diritti, il conflitto ed il dialogo tra leCorti e i diversi livelli di giustizia, dall’altro è possibile leggere l’an-damento carsico dell’attivismo della società civile e dei nuovi movi-
24 Tra i molti si rinvia da una parte ad A. Héritier, 2001; S. Smisman, 2006 e M.Barbera (a cura di), 2006; dall’altra al recente saggio di I.J. Butler, 2008 (dal quale siè presa la citazione), dove si indagano i meccanismi informali di inclusione delleNGOs e della società civile nel circuito comunitario.
381
menti sociali, come il contraltare escluso, eppure presente, dai mec-canismi di governance comunitaria.
Sono sentieri questi che vengono indagati da ormai quasi una de-cina di anni da un’attenta e spesso disarticolata rete di attivisti, ri-cercatori sociali, studiosi, intellettuali, associazioni, movimenti, neltentativo di decodificare i segnali delle forme di protagonismo epartecipazione che verranno, nell’epoca della fine dei partiti politiciideologici tradizionali, della crisi dei vincoli sociali della modernitàe delle trasformazioni dello spazio politico europeo, tra sua costitu-zionalizzazione e cristallizzazione25.
Quale produttivo cortocircuito post-rappresentativo è possibilenel ripensare i contraddittori rapporti tra «governance, civil societyand social movements»?26 Proprio dinanzi alla legittimità introvabileper l’integrazione europea e alla incapacità di ricevere tradizionaleconsenso da parte delle «nuove» istituzioni europee, dovrebbero es-sere presi sul serio, indagati e radicalmente trasformati quei processistratificati (seppure a volte oscuri) di parziale inclusione di una fettadella società civile, che le istituzioni comunitarie portano avantiormai da molti anni.
Mettere sotto controllo pubblico e trasformare la new governancecome punto di partenza per ripensare i processi di riconoscimento elegittimazione di un ordinamento sovranazionale sui generis come
25 In questa ottica, tra diverse pubblicazioni, si ricordano, per il dibattito italiano eriguardo al confronto tra nuovi movimenti sociali e spazio politico europeo: G. Bron-zini, H. Friese, A. Negri, P. Wagner (a cura di), 2003 (specificamente G. Allegri, 2003,rintracciabile in paper anche in rete: http://www.iue.it/LAW/Events/Allegri.pdf); D.Della Porta e M. Caiani, 2006; N. Montagna (a cura di), 2007; per una riflessione checoinvolge ricerche portate avanti sui nuovi movimenti sociali in diversi paesi europei sivedano i saggi recentemente pubblicati in A.L. Farro, P. Rebughini (a cura di), 2008.Chi scrive queste note aveva cominciato ad indagare l’attivismo dei nuovi movimentisociali dinanzi alle trasformazioni istituzionali comunitarie in G. Allegri, 2002.
26 È questo il titolo di un incontro di studi multidisciplinari tenutosi nel giugno del2007 presso l’Istituto Universitario Europeo di Fiesole, http://www.iue.it/LAW/ Events/CJWorkshop30June2007.shtml; le relazioni di tale convegno sono attualmente pubblica-te in M. Blecher, G. Bronzini, J. Hendry, C. Jeorges (eds.), 2008 (vi si trovano gli inter-venti di G. Allegri, M. Blecher, R. Brown, G. Bronzini, R. Ciccarelli, J. Dine, D. DellaPorta, G. Frankenberg, J. Hendry, C. Joerges, A. Negri, G. Teubner, L. Zagato). Il nostrointervento in quella sede, insieme in particolare a quello di Donatella Della Porta e Giu-seppe Bronzini, si situa sul crinale di indagine tra attivismo dei nuovi movimenti socialieuropei, trasformazione dei meccanismi di governance comunitaria e politiche comunita-rie, anche dinanzi all’affermazione di principi di flexicurity nel diritto del lavoro.
382
quello dell’Unione Europea. Aprire il flusso di audizione/partecipa-zione/protagonismo nel policymaking comunitario alle porzioni me-no istituzionalizzate dell’attivismo sociale, andando al di là del tradi-zionale partenariato sociale e dei gruppi di pressione istituzionalizzati.Assumere che le istanze di una legittimità continuativa e diffusa nonpassano più per il pronunciamento elettorale o referendario, manecessitano di meccanismi aperti di inclusione, partecipazione, ri-conoscimento di libertà e autonomia, accettazione della differenzacome valore fondante, re-immaginazione di vincoli solidaristici e digiustizia sociale «tra estranei», esplorando le possibilità tra redistri-buzione delle ricchezze, affermazione di nuovi diritti e riappropria-zione dei tempi di vita. Indagare come i mutamenti sociali possanoinvestire in modo progressivo le trasformazioni del welfare, dellepolitiche sociali e del lavoro nella transizione a modelli sociali post-fordisti, soprattutto dinanzi al processo di adozione dei princìpi diflexicurity.
Questi potrebbero essere alcuni dei punti all’ordine del giorno diuna possibile agenda europea che non ci costringa a dimorare nelsilenzio della nostra «società intimista»27, ovvero a tornare indietro,alle irrecuperabili insufficienze di un ordine politico statuale at-tualmente privo di qualsiasi risposta.
Bibliografia di riferimento
Allegri Giuseppe (2002), I nuovi movimenti sociali nello spazio comune euro-peo. Primi spunti per una riflessione su alcuni nodi politico-istituzionali dell’in-tegrazione europea, in De Fiores Claudio (2003).
Allegri Giuseppe (2003), Oltre l’Europa convenzionale: i mille piani dei movi-menti sociali nell’Europa politica, in Bronzini Giuseppe, Friese Heidrun,Negri Antonio, Wagner Peter (a cura di) (2003).
Allegri Giuseppe (2005), Dopo il no francese al Trattato costituzionale, in CriticaMarxista, n. 4, pp. 23-29, http://www.criticamarxista.net/articoli/4_2005allegri.pdf.
Allegri Giuseppe (2006), Le autonomie territoriali e la democrazia partecipativa,in Petrangeli Federico (2006).
27 Per riprendere l’analisi che R. Sennett (2006) fa della fine della cultura pubblicanel corso del corso della modernità, in particolare nella parte quarta del suo volume(pp. 319 e ss.).
383
Amato Giuliano, Ziller Jacques (2007), The European Constitution. Cases andMaterials in EU and Member States’ Law, Edward Elgar.
Barbera Marzia (2006), Nuove Forme di Regolazione: Il metodo aperto di coordi-namento delle politiche sociali, Giuffrè, Milano.
Blecher Michael, Bronzini Giuseppe, Hendry Jennifer, Jeorges Christian(eds.) (2008), Governance, Civil Society and Social Movements, in EuropeanJournal of Legal Studies, vol. 1, issue 3, July, http://www.ejls.eu/index.php?id=3.
Bronzini Giuseppe (2008), L’Europa e il suo modello sociale: l’innovazione istituzio-nale alla prova, in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, n. 1, pp. 97-121.
Bronzini Giuseppe, Friese Heidrun, Negri Antonio, Wagner Peter (a curadi) (2003), Europa, Costituzione e movimenti sociali, manifestolibri, Roma.
Bronzini Giuseppe e Piccone Valeria (a cura di) (2007), La Carta e le Corti. Idiritti fondamentali nella giurisprudenza europea multilivello, Chimienti, Ta-ranto.
Butler Israel de Jesús (2008), Non-governmental Organisation Participation inthe EU Law-making Process: The Example of Social Non-governmental Organi-sations at the Commission, Parliament and Council, in European Law Journal,vol. 14, n. 5, September, pp. 558-582.
Castells Manuel (2004), L’età dell’informazione. Economia, società, cultura, Uni-versità Bocconi Editore, Milano, trad. it. Lara Turchet (il primo volume)e Gianni Pannofino (gli altri due volumi).
Cartabia Marta (a cura di) (2007), I diritti in azione. Universalità e pluralismodei diritti fondamentali nelle Corti europee, Il Mulino, Bologna.
Crouch Colin (2003), Postdemocrazia, Laterza, Roma-Bari, trad. it. di Cristia-na Paternò.
De Kerckhove Derrick e Tursi Antonio (a cura di) (2006), Dopo la democrazia.Il potere e la sfera pubblica nell’epoca delle reti, Apogeo, Milano.
De Fiores Claudio (a cura di) (2003), Lo Stato della democrazia, in Democrazia eDiritto, nuova serie, n. 12, Franco Angeli, Milano.
De Fiores Claudio (2008), Il fallimento della Costituzione europea. Note a margi-ne del Trattato di Lisbona, in www.costituzionalismo.it, fasc. 1, aprile, http://www.costituzionalismo.it/articolo.asp?id=272.
Della Porta Donatella e Caiani Manuela (2006), Quale Europa? Europeizza-zione, identità e conflitti, Il Mulino, Bologna.
Dellavalle Sergio (2008), Una legge fondamentale post-costituzionale? Il dirittopubblico europeo alla luce del Trattato di Lisbona, in www.costituzionalismo.it, fasc. 1, aprile, http://www.costituzionalismo.it/articolo.asp?id=269.
Farro Antimo L., Rebughini Paola (a cura di) (2008), Europa alterglobal.Componenti e culture del «movimento dei movimenti» in Europa, Franco An-geli, Milano.
Follesdal Andreas, Hix Simon (2005), Why There is a Democratic Deficit inEU: A Response to Majone and Moravcsik, in European Governance Papers
384
(EUROGOV): http://www.connex-network.org/eurogov/pdf/egp-connex-C-05-02.pdf.
Formenti Carlo (2008), Cybersoviet. Utopie postdemocratiche e nuovi media,Raffaello Cortina, Milano.
Giubboni Stefano (2008), Un certo grado di solidarietà. Libera circolazione dellepersone e accesso al welfare nella giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, inRivista del Diritto della Sicurezza Sociale, n. 1, pp. 19-64.
Héritier Adrienne (2002), New Modes of Governance in Europe: Policy MakingWithout Legislating?, in Political Science Series, n. 81, http://www.ihs.ac.at/publications/pol/pw_81.pdf.
Manzella Andrea, Melograni Piero, Paciotti Elena, Rodotà Stefano (2001),Riscrivere i diritti in Europa, Il Mulino, Bologna.
Montagna Nicola (a cura di) (2007), I movimenti sociali e le mobilitazioni globa-li. Temi, processi e strutture organizzative, Franco Angeli, Milano.
Münch Richard (2008), Constructing European Society by Jurisdiction, in Euro-pean Law Journal, vol. 14, n. 5, September, pp. 519-541.
Offe Claus, Preuss Ulrich K. (2006), The Problem of Legitimacy in the EuropeanPolity. Is Democratization the Answer?, http://www.bath.ac.uk/esml/conWEB/Conweb%20papers-filestore/conweb6-2006.pdf, ConWEb, Constitutional-ism Webpapers, n. 6.
Pállinger Zoltán Tibor, Kaufmann Bruno, Marxer Wilfried, SchillerTheo (eds.) (2007), Direct Democracy in Europe. Developments and Prospects,VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Petrangeli Federico (a cura di) (2004), Una Costituzione per l’Europa? Poten-zialità e limiti del nuovo ordinamento dell’Unione, Ediesse, Roma.
Rodotà Stefano (1997), Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie dellacomunicazione, Laterza, Roma-Bari.
Sassen Saskia (2008) [2006], Territori, autorità, diritti. Assemblaggi dal Medioevoall’età globale, Bruno Mondadori, trad. it. di Nuccia Malinverni e Giu-seppe Barile.
Sennett Richard (2006) [1974], Il declino dell’uomo pubblico, Bruno Mondado-ri, Milano, trad. it. di Federica Gusmeroli.
Smisman Stijn (2006), New Modes of Governance and the Partecipatory Myth, inEuropean Governance Papers, n. 06-01, http://www.connex-network.org/eurogov/pdf/egp-newgov-N-06-01.pdf.
Statham Paul (2008), Political Party Contestation over Europe in Public Dis-courses: Emergent Euroscepticism?, in Arena Working Papers Series, n. 8,http://www.arena.uio.no/publications/working-papers2008/papers/wp08_08.pdf.
Vanderborght Yannick, Van Parijs Philippe (2005), L’allocation universelle, LaDécouverte, Paris [trad. it. Il reddito minimo universale, di Giovanni Talla-rico, Università Bocconi Editore, 2006].