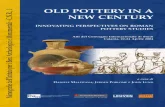GUINEA-BISSAU E ISOLE DI CAPO VERDE: PARTECIPAZIONE FEMMINILE ALLA LOTTA POLITICA
Transcript of GUINEA-BISSAU E ISOLE DI CAPO VERDE: PARTECIPAZIONE FEMMINILE ALLA LOTTA POLITICA
GUINEA-BISSAU E ISOLE DI CAPO VERDE:PARTECIPAZIONE FEMMINILE
ALLA LOTTA POLITICA
Patricia Gomes
La sfida al potere dello stato è il passo più importante perfavorire i diritti delle donne e per la lotta femminile allapovertà, all’oppressione e alla discriminazione del generefemminile. Fatou sow, 2003
Introduzione
La mobilitazione delle donne nella politica (1) rappresentauna sfida importante per il mondo contemporaneo. Nel perio-do intercorso tra la colonizzazione e la costruzione di societàpost coloniali, la condizione femminile nell’africa subsaharia-na ha conosciuto dei cambiamenti straordinari, seppur conritmi differenti da un paese all’altro del continente. in questomondo, dove spesso si incontrano e si mescolano modi di vitatradizionali e moderni, il ruolo della donna presenta delle sfu-mature estremamente diverse (2).
Nella fase successiva all’indipendenza dei paesi africani, leautorità politiche hanno in genere accordato alle donne pocospazio nella gestione dello stato, mentre la loro posizione èstata cruciale nelle lotte per la liberazione intraprese in alcunipaesi africani. in questo senso, la Guinea-Bissau (3) e le isoledi capo Verde (4), due ex colonie portoghesi, con un passatostorico comune e politicamente unite fino al 1980 rappresenta-no uno dei più rilevanti esempi di quanto la presenza delladonna abbia contribuito allo sviluppo del nazionalismo. Perciò,sia in Guinea-Bissau che nelle isole di capo Verde il percorsodella donna verso lo sviluppo culturale e la sua integrazione
192
nelle strutture governative dei rispettivi stati è avvenuta nelcorso di un processo complesso e peculiare, in cui è stato cru-ciale il ruolo nella lotta di liberazione che ha condotto entram-bi i paesi all’indipendenza nazionale.
Per parlare della partecipazione politica della donna guinea-na e capoverdiana nella società odierna non si può ignorare ilsuo ruolo in tutto il processo della lotta per l’indipendenza, inquanto l’emancipazione femminile e la presa di coscienza delleproprie capacità e dei propri diritti ebbe inizio in questo perio-do. Durante la dominazione coloniale portoghese, la donna nonusufruiva di nessun tipo di diritto politico e ancor meno pote-va occuparsi degli affari che riguardavano lo stato. La princi-pale legge coloniale che regolava la vita politica, amministra-tiva e sociale degli africani indigeni delle cosiddette “provinced’oltremare” varata nel 1954, non faceva alcun riferimento allapartecipazione della donna nelle istituzioni pubbliche né aqualsiasi forma di diritto (5). La donna era, quindi, doppia-mente sottomessa, sia dal colonizzatore sia dalla sua stessa cul-tura; da un lato essa non godeva dei diritti politici che spetta-vano ai cittadini portoghesi e dall’altro viveva in una societàtradizionale dove la sua condizione era di totale disuguaglian-za rispetto all’uomo (6). Del resto, nel Portogallo degli annicinquanta, circa il 40% della popolazione era analfabeta e lamaggior parte di questa era formata soprattutto da donne (7).Da qui si può quindi intuire quanto la realtà delle colonie fosseancora più drammatica sotto questo profilo.
La lotta per la conquista dei diritti politici fu resa possibilesoltanto dopo il 1956, con la creazione del P.a.i.G.c. (8), par-tito che fin dall’inizio s’impegnò nella lotta contro la discrimi-nazione del genere femminile. Nel suo programma d’azioneche nel 1973 diventò la costituzione della Guinea-Bissau,infatti, esso stabilì “l’uguaglianza dei cittadini di fronte allalegge, senza distinzione di nazionalità o gruppo etnico, disesso, di origine sociale o di livello culturale (…)”, aggiun-gendo ancora che “gli uomini e le donne godono degli stessi
193
diritti in famiglia, nel lavoro e nelle attività pubbliche”(9). inun contesto politico e sociale caratterizzato soprattutto da unsistema coloniale rigido e conservatore, il programma d’azio-ne del P.a.i.G.c. apparve rivoluzionario e all’avanguardia.Una delle parole d’ordine del partito fu “difendere i diritti delladonna, rispettare e far rispettare le donne (bambine, giovani eadulte) convincendole del fatto che la loro liberazione devedipendere da loro stesse, dal loro lavoro e dalla dedizione alpartito, dalla loro personalità di fronte a tutto ciò che sia con-trario alla propria dignità”(10). in un situazione politica esociale che impediva alla donna di usufruire dei più elementa-ri diritti della persona umana, il P.a.i.G.c. ha avuto un ruolodecisivo per quanto concerne la modernizzazione culturaleriguardo alla condizione femminile.
L’obiettivo di quest’analisi è di ricostruire il complesso per-corso storico compiuto dalle donne dei due paesi verso la loromodernizzazione, stabilire in che modo questo processo èavvenuto in uno e nell’altro paese e quali sono state le conse-guenze nella vita politica e sociale della donna guineana ecapoverdiana. a tale fine, si terranno in considerazione quat-tro momenti storici rilevanti: la lotta di liberazione durata dal1963 al 1973, la divisione dei due stati nel 1980, il delicatoprocesso d’integrazione politica e sociale degli anni ottanta eNovanta (tuttora in corso) ed infine la creazione nel 2000 dellaconferenza delle donne della comunità dei paesi di lingua por-toghese.
La partecipazione nella lotta armata
Durante il periodo della lotta contro il colonialismo porto-ghese, la donna (sia guineana che capoverdiana) ebbe un ruolofondamentale. Nella fase dell’attività politica clandestina delP.a.i.G.c., dal 1956 al 1962, le donne organizzavano le riunio-ni dei dirigenti del partito, preparavano e distribuivano il mate-
194
riale propagandistico, nascondevano nelle loro case gli uominipolitici perseguitati dalla P.i.D.e. (11) e, soprattutto, servivanocome elemento di collegamento tra le diverse cellule del parti-to sparse nel territorio, partecipando in modo diretto all’attivi-tà politica clandestina (12).
Quando nel 1963 il processo di liberazione passò alla fasearmata, erano le donne coloro che informavano le unità diguerriglie del P.a.i.G.c. sui movimenti delle truppe portoghe-si. e furono sempre loro ad affiancare gli uomini nelle opera-zioni armate quando gli scontri si intensificarono, a partire del1965. Nel 1966, infatti, per far fronte alla mancanza di uominiin grado di occuparsi di questioni di ordine pubblico, furonocreate le milizie popolari, formate soprattutto da gruppi didonne armate il cui compito principale era proteggere le popo-lazioni dei villaggi dagli attacchi dell’esercito portoghese eallo stesso tempo provvedere al mantenimento dell’ordine(13). in un discorso di amilcar cabral (14), pronunciato nel1972 ai responsabili del partito a proposito dell’impegno delladonna nella lotta armata, si legge: “Vogliamo sottolineare inparticolar modo il fatto che la donna nel nostro paese sta con-quistando l’indipendenza per la quale molti hanno lottato senzaaverla raggiunta. si è potuto verificare che i responsabili, siadei comitati di villaggio sia dei comitati regionali, sia ancoradei comitati inter-regionali, sono spesso donne responsabili,coscienti dei loro valori e del loro ruolo in seno al nostro par-tito, e si può dire che nel partito, a tutti i livelli, la donna è pre-sente” (15). ovvero, l’interazione tra l’uomo e la donna, la par-tecipazione femminile a livello degli organi e delle struttureemergenti del partito erano diventati un dato di fatto e non piùsoltanto un aspetto teorico del programma.
tuttavia, l’integrazione della donna nella vita politica ed isti-tuzionale del paese fu un processo lento e difficile che dovetteaffrontare diversi ostacoli lungo il suo percorso. all’epocadella guerriglia, infatti, vi furono molte resistenze a propositodella partecipazione della donna nelle strutture del partito.
195
esse, in quanto in maggioranza analfabete, erano considerateincapaci di dirigere organi di elevata responsabilità e compe-tenza politica (16). a proposito della partecipazione politicadella donna nella lotta armata, teodora inácia Gomes, militan-te del P.a.i.G.c., cita i problemi di discriminazione sociale chele donne dovettero fronteggiare affermando: “ho visto come ledonne vivevano nella miseria, lottando per la sopravvivenza.Dovevano affrontare i loro mariti che sollevavano diversi pro-blemi. ma cosa potevamo fare allora? ciò che l’uomo volevaera che la propria moglie restasse a casa. avevano il controllodel denaro, quindi se volevano dare soldi alle mogli lo faceva-no, altrimenti non ne davano. Noi donne non potevamo fareniente perché eravamo oppresse” (17). Nonostante la volontàpolitica del partito di contribuire sempre di più all’affermazio-ne della donna, in sostanza c’era ancora una lunga strada dapercorrere; l’aspetto forse più delicato del problema che biso-gnava combattere era la sottomissione culturale della donna.Nel corso della lotta per l’indipendenza, durata ben dieci anni,vi sono state delle figure femminili nelle più elevate carichepolitiche della gerarchia del P.a.i.G.c. Le donne guineane chepiù attivamente parteciparono alla lotta di liberazione acquisi-rono larga notorietà e popolarità nell’ambiente politico e mili-tare. Questo il caso di carmen Pereira (18), uscita dalla piùnota scuola del partito, la Escola Piloto, primo commissariopolitico dell’intera regione sud del paese nonché responsabileper la mobilitazione politica delle popolazioni di quell’area.carmen Pereira è stata l’unica donna presente nel comitato ese-cutivo (19) del partito, il più importante organo di direzione. inseguito alla dichiarazione unilaterale dell’indipendenza dellaGuinea-Bissau, nel settembre del 1973, è stata eletta deputatadella repubblica per la regione di Bissau e, nello stesso anno,incaricata vicepresidente del nuovo parlamento eletto nellezone liberate della Guinea-Bissau. ancora Francisca Pereira,commissario politico e rappresentante del P.a.i.G.c. nell’orga-nizzazione panafricana per le donne nei primi anni settanta,
196
con sede ad algeri, ed ernestina silá, prima donna guineanamilitare con un livello d’istruzione superiore (20). Nel 1970, ilpartito statuì che, nei comitati di villaggio (21), “almeno duedei cinque membri dell’organo devono essere donne” (22). Neiprimi anni della lotta armata, data la resistenza sociale con laquale queste donne dovevano fare i conti, gli incarichi loroaffidati erano piuttosto semplici. Generalmente esse si occupa-vano delle provviste di riso e di altri prodotti alimentari desti-nati ai soldati. come riferisce Urdang, “era una estensione delloro lavoro quotidiano e accettato da entrambi le parti” (23). apartire del 1972, le donne incominciarono a prendere parte aipiù importanti organi di decisioni del partito a livello distret-tuale e regionale. alcune volte si verificò che il presidente e ilvice-presidente di tali organi fossero “degnamente rappresen-tati da donne” (24). Nei tribunali popolari vi erano figure fem-minili tra i membri della giuria (25); a livello dell’informazio-ne e della comunicazione, importante strumento nella lottacontro il colonialismo, le donne erano alla guida della radio edel quotidiano del partito. infine, quando fu riorganizzato l’e-sercito del P.a.i.G.c., nel 1966, l’inserimento della donna nellestrutture militari costituì un altro aspetto innovativo nella poli-tica del partito (26). in questo contesto di partecipazione allalotta armata, le donne capoverdiane presenti in Guinea-Bissau(27) hanno avuto un ruolo di rilievo, soprattutto per quantoriguarda l’istruzione. È stato il caso di Dulce almada Duarte,insegnante di lingua portoghese e di educazione civica nellapiù prestigiosa scuola del P.a.i.G.c. a proposito della situazio-ne della donna durante la lotta armata, essa afferma che “il par-tito ha fatto di tutto per la donna, soprattutto per la donna gui-neana. in genere, le donne capoverdiane che hanno partecipa-to alla lotta di liberazione avevano un certo livello di forma-zione. Per la donna guineana, invece, la politica del partito fudi grande importanza perché in Guinea era in una condizionedi totale analfabetismo. Durante la lotta, la donna ha presocoscienza del suo vero valore ed ha esercitato le funzioni attri-
197
buitele con grande dignità, orgoglio e determinazione. il fattodi liberarsi, di imparare sempre di più, è stato qualcosa dimolto importante per lei” (28). Una delle conseguenze dell’e-mancipazione della donna guineana, nell’opinione di Duarte, èstato l’inizio dei matrimoni misti fra donne di una certa etnia euomini di un’altra. Questo fatto ha rivoluzionato l’intero siste-ma sociale tradizionale dove i matrimoni, oltre ad essere com-binati tra le famiglie, avvenivano rigorosamente tra membridella stessa etnia (29). Un’altra conseguenza dell’emancipa-zione femminile è stata la scolarizzazione di un numero sem-pre più elevato di giovani. Questo lavoro di formazione si èdimostrato molto faticoso e delicato. il suo obiettivo era ren-dere effettuabile una formazione accelerata e molto intensiva,permettendo in questo modo ai giovani che arrivavano aconakry di poter partire all’estero per proseguire i loro studi(soprattutto corsi tecnici e professionali). Per i giovani era dif-ficile riuscire a conseguire una laurea, perché non avevano lebasi necessarie. alcuni di loro, nell’opinione di ana mariacabral, vedova di amilcar cabral, “hanno poi continuato glistudi dopo l’indipendenza. essendo la Escola Piloto l’unicache dava una formazione secondaria, non era quindi possibileimpartire una formazione solida a tutti gli alunni che arrivava-no. Noi dovevamo fare dei corsi abbastanza intensivi perchécabral aveva urgenza di formare dei quadri tecnici e dei fun-zionari” (30).
il compito del partito, in termini immediati, era la liberazio-ne del territorio dalla presenza coloniale. Nelle zone liberate(31) e sotto il controllo delle forze del P.a.i.G.c., la donnaacquisì un ruolo politico la cui conseguenza più diretta è statala conquista del rispetto da parte della società e, soprattutto,dell’uomo e la conferma di essere in grado di svolgere gli stes-si ruoli affidati fino a quel momento a individui di generemaschile. inoltre, la sua partecipazione attiva alle decisionisulla vita amministrativa dei villaggi, dirigendo addiritturaorgani amministrativi di gestione locale, si è resa possibile sol-
198
tanto perché c’è stato uno sviluppo culturale permanente econtinuo. tale sviluppo ha permesso loro di affiancare gliuomini nell’avviare le nuove istituzioni verso la modernizza-zione e allo stesso tempo ha contribuito all’apertura mentale esociale di questi ultimi nell’ accettare l’avvio di tale processo.
La donna e l’istruzione
L’istruzione costituì uno dei pilastri fondamentali della poli-tica del P.a.i.G.c. Nel capitolo Vii del suo programma d’azio-ne si legge per quanto riguarda gli obiettivi relativi all’istru-zione e alla cultura: “1. riforma del sistema d’istruzione; svi-luppo dell’istruzione secondaria e della scuola tecnica; crea-zione dell’università e di istituti scientifici e tecnici; 2. Lottaall’analfabetismo; istruzione primaria obbligatoria e gratuita;formazione e perfezionamento urgente dei quadri tecnici e pro-fessionali; 3. Lotta contro tutti i pregiudizi ereditati dal colo-nialismo” (32). sconfiggere l’analfabetismo era una delle prio-rità del programma politico del partito.
il sistema d’istruzione messo in atto nelle zone liberate sirivelò originale. Le metodologie d’insegnamento applicate (ilcaso dell’uso dell’idioma creolo come mezzo intermediarionell’apprendimento della lingua portoghese) ottennero deirisultati positivi. tale sistema si proponeva di raggiungere treobiettivi principali: l’istruzione obbligatoria dei bambini e deigiovani, la formazione dei soldati, la formazione di insegnanti.Per quanto riguarda l’istruzione elementare, esistevano trelivelli di formazione scolastica. il primo livello aveva comeobiettivo l’alfabetizzazione dei bambini nelle zone rurali. ilsecondo era composto in genere da centri scolastici che acco-glievano coloro che riuscivano a superare il primo anno e chefunzionavano come scuola-collegio. il terzo livello, invece,corrispondeva all’insegnamento secondario e le uniche duescuole esistenti si trovavano nella repubblica della Guinea e nel
199
senegal. La più importante di queste era a conakry, nellarepubblica della Guinea. La Escola Piloto creata nel 1965,aveva lo scopo di formare “un uomo nuovo, libero da tutti gliaspetti negativi delle credenze e delle tradizioni animiste epronto ad assimilare, con spirito critico, le conquiste dell’uma-nità” (33). L’insegnamento mirava soprattutto alla preparazio-ne dei giovani per affrontare i problemi della vita quotidiana,oltre alla formazione puramente accademica (34). in questafase, la donna assunse un ruolo di rilievo anche nelle istituzio-ni scolastiche, come dimostra la sua presenza nel più impor-tante organo di gestione amministrativa della scuola, il comita-to di gestione responsabile per tutte le decisioni amministrati-ve che riguardavano il funzionamento della stessa. il comitatoera costituito da sei rappresentanti degli studenti (tre uomini etre donne) e controllato da un rappresentante dei professori eda un membro del P.a.i.G.c. (35). allo stesso modo, il gruppodi controllo, organo le cui funzioni consistevano nel coordina-mento e nel controllo di tutte le attività scolastiche era forma-to da quattro membri, due uomini e due donne ed era l’organoche organizzava le riunioni periodiche in cui si discutevano leproblematiche che gli studenti e i professori affrontavano (36).come appare, la presenza della donna nelle istituzioni scolasti-che con posti di decisione era una realtà. esisteva un equilibrionumerico fra uomini e donne in ogni organo, fatto di estremaimportanza in una società nella quale, tradizionalmente, ladonna doveva limitarsi ai ruoli di riproduttrice e di educatricedei figli e ai lavori domestici.
Nel periodo tra il 1963 e il 1973, la percentuale di donne conun livello di formazione media ha subito un aumento esponen-ziale; da sei donne che occupavano i posti d’infermiere specia-lizzate nel 1964 si è passato a 132 nel 1972 (37). La sua pre-senza nell’area della sanità è stata di tale importanza da diven-tare indispensabile nei servizi sanitari. Le donne erano inseritenei cosiddetti “posti fissi”, fatto legato alla sua condizione dimadre.
200
tuttavia, l’inserimento della donna nel mondo del lavoro,che fino a quel momento apparteneva soltanto alla classemaschile, non è stato facile. il suo ruolo all’interno della socie-tà tradizionale andava contro questo nuovo concetto di lavoroal femminile. in questo senso, uno degli aspetti pratici dellalotta di liberazione è stato quello di aver promosso l’evoluzio-ne della situazione femminile della donna dall’ambiente ruralea quello moderno senza causare grandi traumi. Dai villaggi, ibambini dei due sessi erano inviati a conakry per studiare nellascuola del P.a.i.G.c. (38).
L’istruzione dei soldati fu un altro aspetto importante di que-sto programma perché soltanto istruendoli sarebbe stato possi-bile l’utilizzo di alcune tecniche che richiedevano una forma-zione militare di base nonché un’istruzione elementare. L’altrogrande obiettivo della politica del P.a.i.G.c. era la formazionedei quadri docenti. anche in questo caso, le donne sono stateprotagoniste nella preparazione didattica dei giovani che poivenivano scelti per garantire l’istruzione primaria e mediadelle popolazioni. in tutte le zone liberate furono create, a par-tire del 1965, dei centri di formazione per insegnanti di scuoleelementari e medie che dovevano assicurare un’istruzione, seb-bene elementare, ai giovani guineani (39).
il sistema d’istruzione, adoperato in Guinea-Bissau durante ilperiodo della lotta armata, cercò di enfatizzare alcuni aspettidella società tradizionale considerati positivi come, per esem-pio, l’informalità, la spontaneità e l’esperienza degli anziani. sicercò di sviluppare negli studenti una nuova mentalità senzapregiudizi e senza gli aspetti più retrogradi della società tradi-zionale.
i risultati ottenuti nell’ambito della scolarizzazione dellapopolazione furono importanti: gran parte dei bambini a parti-re dai dieci anni ricevettero un’istruzione (40). secondoPereira (41), nell’anno accademico 1971/1972 il P.a.i.G.c.aveva nelle zone liberate della Guinea, un totale di 164 scuole,dove insegnavano 258 professori. Questo fatto dimostra che,
201
nel periodo della lotta armata, vi è stato uno sforzo considere-vole di cambiamento sociale a favore dell’istruzione, della for-mazione e dell’integrazione politica della donna.
L’istruzione dei giovani in Guinea-Bissau, durante la lotta diliberazione, costituì una delle più importanti sfide che il parti-to di amilcar cabral dovette affrontare. in particolar modo, lascolarizzazione delle donne ebbe grande successo e facilitò laloro, anche se parziale, integrazione nella vita politica, econo-mica e culturale del paese (42). È stato un processo certamen-te difficile, considerato che, all’inizio della lotta armata, piùdella metà della popolazione analfabeta era costituita da donne.
Significato politico del 14 novembre 1980
il P.a.i.G.c. si proponeva di formare in breve tempo l’unitàbi-nazionale, già una realtà a livello delle strutture del partito edelle forze armate. essa avrebbe dovuto continuare con unaprogressiva unificazione delle strutture fra gli stati dellaGuinea-Bissau e del capo Verde. invece, il golpe militare del14 novembre 1980 in Guinea-Bissau, rompendo il progetto diunità tra i due paesi, ha creato le condizioni per il risveglio diciò che sembrava superato: il contrasto tra le varie etnie.L’insorgere di un clima d’opposizione verso i capoverdiani el’ascesa al potere di un esponente guineano delle forze armate,il comandante Nino Vieira (divenuto presidente della repubbli-ca della Guinea-Bissau dopo la separazione dei due stati),secondo le aspettative diffuse, avrebbe potuto rinforzare lacoscienza nazionale, contribuendo così all’unificazione delpopolo della Guinea-Bissau. certe etnie, soprattutto quelle difede animista, avendo finalmente un presidente “dei loro”,consegnarono a Vieira dei simboli d’accettazione del suo pote-re (una spada, una statuetta, ecc). Questo gesto aveva un signi-ficato ambivalente: erano simboli della coscienza d’unitànazionale ma anche di identificazione etnica.
202
Fino al 1980, la Guinea-Bissau e le isole di capo Verdehanno avuto lo stesso ordinamento giuridico. La costituzionedel 1980 stabiliva, come si è detta, l’uguaglianza tra i cittadini,“senza distinzione di gruppo etnico, di sesso, di origine socia-le, di livello culturale, di professione, di condizione di fortuna,di credo religioso o di convinzione filosofica” (43), e garanti-va che “l’uomo e la donna hanno gli stessi diritti nella famiglia,nel lavoro e nelle attività pubbliche” (44). Questo strumento,servito anche di base all’elaborazione dei nuovi testi costitu-zionali dopo la scissione, era allora considerato all’avanguar-dia per quanto riguarda la tutela dei diritti delle donne.
il golpe del 14 novembre 1980, detto anche MovimentoReajustador, fu il risultato del deteriorarsi delle condizioni divita dei guineani; del confronto con un P.a.i.G.c. le cui strut-ture si erano cristallizzate nella concezione di un contro pote-re, base della nascita di uno stato nuovo; dell’assenza di undibattito politico aperto all’interno delle strutture del partito eil conseguente allontanamento dalle basi; infine dell’insosteni-bile progetto dell’unità Guinea / capo Verde a due velocità(45). Nel caso specifico della lotta tra classi, ci si riferisce allalotta tra la borghesia intellettuale capoverdiana, responsabiledella linea ideologica e programmatica del P.a.i.G.c., e lagrande massa contadina guineana, utilizzata soprattutto comeforza militare. con l’aumento delle contraddizioni e delle posi-zioni estreme, i guineani che integravano le strutture del parti-to videro le loro responsabilità ridotte mentre l’ala capoverdia-na rafforzava la propria posizione. con la scissione del 1980,molti di quest’ultimi che, ormai da tempo, si erano stabiliti inGuinea-Bissau, iniziarono ad essere isolati dal nuovo poterepolitico. anche per quanto riguarda la donna accadde lo stes-so; donne capoverdiane che occupavano posti di prestigio nellagerarchia dello stato furono allontanate per motivi puramentepolitici. a questo proposito, Paula Fortes (46) afferma che “ilmalessere presente da qualche tempo, soprattutto la sfiducia trai compagni di lotta e l’ambizione del potere portarono ad una
203
reazione troppo affrettata da parte di alcune persone (…). so diqualche donna capoverdiana che aveva responsabilità inGuinea e che dopo l’accaduto è stata sostituita ed è tornata acapo Verde. in quel contesto storico, era normale che ciò acca-desse”. Per i capoverdiani, continua Fortes, “è come se ci fossestato un secondo assassinio di amilcar cabral. tutta la sua teo-ria pacifista e democratica è stata messa in causa. si sarebbepotuto dialogare, discutere dei problemi e arrivare ad un accor-do, così come egli ci aveva abituati” (47). invece, nell’opinio-ne di Henriqueta Godinho Gomes (48), l’ostilità che c’è statasubito dopo il golpe del 1980 non era specificamente rivoltaalla donna capoverdiana ma ai meticci guineani in generale(49). Questo tipo di comportamento ostile era manifestatosoprattutto dalle persone mediocri e professionalmente incom-petenti che cercavano in questo modo di emergere senza dover-si confrontare. il vero problema, come afferma GodinhoGomes, “era la questione del “burmedjo” (50), cioè i precon-cetti verso la persona di pelle più chiara. se da un lato è veroche il meticcio è spesso associato al cittadino capoverdiano perle ragioni storiche alle quali si è fatto riferimento in preceden-za, è altrettanto vero che l’attuale generazione di meticci gui-neani niente ha in comune con la cultura capoverdiana e con ilsuo popolo. Pertanto, l’opportunismo di quelli che, sin dalmomento dell’indipendenza, si sono ritrovati all’ombra delpotere per incompetenza sembra, in questo caso, la spiegazio-ne più obiettiva del problema. tuttavia, bisogna sottolineareche, in seguito alla scissione della Guinea-Bissau e di capoVerde, vi è stata una grossa campagna di sensibilizzazione suiveri obiettivi del golpe del 1980. Le condizioni di vita delpopolo guineano si erano deteriorate in maniera indiscriminatamentre l’attuazione del programma maggiore del P.a.i.G.c.,che prevedeva un piano di sviluppo economico, giuridico eculturale, compito principale del nuovo governo guineo-capo-verdiano, era stata in sostanza dimenticata. il 1980 dovevaassumersi come l’anno simbolo del cambiamento politico e
204
sociale oramai inevitabile, non ha purtroppo rappresentato lafine del sistema monopolista del potere in vigore nel paese sindal 1974. L’inizio del processo dello smantellamento effettivodi tale sistema si sarebbe verificato soltanto quattordici annidopo, nel 1994 (51).
Verso l’integrazione politica: dagli anni Ottanta agli anni Novanta
La proclamazione dell’indipendenza di capo Verde, nelluglio del 1975, è stato uno dei più importanti momenti dellastoria di questo paese. tuttavia, l’affermazione dello statonazionale non coincise con l’instaurazione di un regime demo-cratico pluralista. Nei primi anni, il nuovo stato capoverdianoha firmato convenzioni e dichiarazioni relativi ai diritti umanie alle questioni femminili, tra i quali la convenzione sull’eli-minazione di tutte le forme di discriminazioni contro le donne,la carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, la cartainternazionale dei diritti umani e la dichiarazione universaledei diritti umani (52).
L’approvazione del codice di famiglia, nel 1981, stabilì ilprincipio dell’uguaglianza tra la madre e il padre, in particola-re della patria potestà fino ad allora esclusivamente riservata alpadre (53). infatti, venne stabilito dal codice civile capover-diano che essa consiste “nell’autorità conferita ad entrambi igenitori responsabili della promozione e difesa della crescitaintegrale e armoniosa dei figli minori” (54). La garanzia delsostentamento e della salute dei propri figli, una loro adeguataformazione intellettuale e culturale e provvedere alla loro for-mazione morale e al loro domicilio sono solo alcune delle com-petenze che, dal 1981, appartengono anche alla madre (55). Unaltro aspetto positivo introdotto da questa legge è stato il rico-noscimento del nuovo tipo di struttura famigliare, caratterizza-ta da una popolazione contraria all’idea del matrimonio e dal-
205
l’unione “di fatto” sempre più frequente, dove il ruolo princi-pale è riservato alla donna capo famiglia. in questo caso, ilcirca 41% dei capi famiglia sono costituiti da donne, dei qualiil 60% nelle zone rurali, il 30% nelle zone urbane e l’8% nellezone semi urbane (56). Nelle principali città, quali Praia (lacapitale) e são-Vicente (la seconda città), il 40% delle donneassume la responsabilità della famiglia in tutti i sensi, dall’e-ducazione dei figli al loro nutrimento e alla loro formazionemorale e intellettuale. sembra, quindi, esistere una relazionediretta tra questo nuovo tipo di famiglia, con a capo la donna,e la responsabilità che la stessa assume nei confronti dei proprifigli. in fondo, in un contesto di società patriarcale e nonostan-te la decisione finale appartenga all’uomo, è la donna che pos-siede di fatto il potere (57). inoltre, il fenomeno delle famigliecon solo un genitore (in questo caso la madre) è sempre più dif-fuso. Dal punto di vista dell’emancipazione femminile, comeafferma Paula Fortes, “Gli anni ottanta hanno avuto grandeimportanza per la donna capoverdiana, soprattutto per quantoriguarda la sua partecipazione al parlamento. si è passato da ununico deputato donna a tredici (…). in questo senso, è statadecisiva la partecipazione della donna alla discussione e divul-gazione dei principali strumenti della politica, quali: la costitu-zione della repubblica, il codice di famiglia, il codice dei mino-ri, i piani nazionali per lo sviluppo, la legge per l’interruzionevolontaria della gravidanza, la legge base della salute, ecc”(58). Questi cambiamenti possono essere, quindi, consideratifrutto della sua emancipazione e soprattutto dell’autonomiaeconomica dovuta ad una sempre più grande integrazione delladonna nel mondo del lavoro.
Nel preambolo della costituzione della repubblica di capoVerde (59), approvata nel 1990, sono espresse le motivazioniche portarono ad un profondo cambiamento della legge costi-tuzionale, ovverosia le “nuove idee del mondo che hanno fattocadere le strutture e le concezioni che sembravano solidamen-te impiantate, avendo cambiato il corso degli avvenimenti poli-
206
tici internazionali” (60). inoltre, la nascita della democrazia,dopo una lunga parentesi caratterizzata dall’esercizio del pote-re nell’ambito del modello di partito unico, ha portato allanecessità di introdurre delle riforme importanti nella vita poli-tica e sociale del paese. L’apertura politica in capo Verde haavuto inizio nel 1990, “portando alla creazione delle condizio-ni istituzionali necessarie alla realizzazione delle prime elezio-ni legislative e presidenziali in un contesto di concorrenza poli-tica” (61). infatti, nel settembre del 1990 il parlamento (62) havarato la legge costituzionale n.2/iii/90 che ha istituito il prin-cipio del pluralismo politico. Nel gennaio del 1991 si sono rea-lizzate le prime elezioni per la costituzione del nuovo esecuti-vo capoverdiano e a febbraio si sono tenute le elezioni presi-denziali.
La nuova costituzione del capo Verde ha, quindi, consacratolo stato di diritto democratico e ha concesso al cittadino tutti idiritti e le libertà ma, soprattutto, ha considerato la dignitàumana come valore assoluto dello stato (63). Dal punto di vistaistituzionale, i diritti della donna sono stabiliti dalla costituzio-ne, ovvero “tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge,godono degli stessi diritti e hanno gli stessi doveri, senzadistinzione di sesso, livello sociale, intellettuale o culturale,confessione religiosa o convinzione filosofica” (64); vieneconsacrato, dall’articolo 23, il principio di una partecipazioneparitaria della donna e dell’uomo alla vita sociale e politica:“l’uomo e la donna sono uguali di fronte alla legge in tutti ipiani della vita politica, economica, sociale e culturale” (65).sul piano istituzionale, le disposizioni legali e costituzionaliriconoscono e garantiscono gli stessi diritti e doveri civici epolitici ad entrambi i membri della coppia. Per quanto riguar-da il diritto di famiglia, il codice civile rimane il più importan-te strumento giuridico a disposizione e, a tutt’oggi, costituiscela base d’orientamento delle principali organizzazioni e asso-ciazioni che si occupano di problematiche legate alla donna.
La fase dell’apertura politica nelle isole di capo Verde è stata
207
segnata da una serie di cambiamenti istituzionali e giurisdizio-nali. È stato proprio in questo clima di grandi trasformazioniche, nel 1994, è stato creato l’istituto della condizione femmi-nile, noto icF. Nato come organo del governo, l’icF dipendedirettamente dal primo ministro e funziona come strutturaintermediaria di coordinamento tra lo stato e le diverse orga-nizzazioni non governative sulle donne presenti nel paese. apartire del 1996, grazie all’intensa attività di quest’istituto ealla diffusione d’informazione sulla condizione della donna, siè incominciato finalmente a parlare del concetto di genere,nozione fino al momento sconosciuta dalla maggior parte dellapopolazione locale, soprattutto del sesso femminile. Negli annisuccessivi, l’icF ha messo in pratica alcuni progetti di ottimiz-zazione delle risorse umane, con speciale riguardo alla donna.in particolare, è stato avviato un programma di sensibilizza-zione sull’azione delle leggi esistenti, i cui risultati sono statipiuttosto soddisfacenti. secondo Paula Fortes, è stato soltantograzie alla democrazia instaurata negli anni novanta che ladonna capoverdiana ha potuto liberamente partecipare alla vitapolitica del suo paese, allo stesso tempo che ha visto aumenta-re la sua capacità d’associazione. tutto questo è stato reso pos-sibile soltanto perché si tratta di diritti garantiti dalla costitu-zione e da altre leggi dello stato (66). il lavoro svolto da que-sto organo si presenta, quindi, abbastanza complesso. Un lavo-ro trasversale che attraverso l’attuazione di piani settoriali, incollaborazione con i diversi ministeri, cerca di rendere più faci-le la giusta integrazione della donna nelle istituzioni dello statoe in quelle private.
L’avvio del processo di democratizzazione ha portato allafine del secolo scorso, all’esigenza di procedere a delle riformeimportanti dell’icF, come, per esempio, la revisione degli sta-tuti, che prima consideravano quest’organo parte del Partidoafricano da independencia de cabo-Verde (ala capoverdianadel P.a.i.G.c. nata dopo la scissione del 1980); la sua comple-ta ristrutturazione e il miglioramento delle sue capacità (mezzi
208
umani, materiali e finanziari) al fine di permettergli una gestio-ne autonoma e un funzionamento adeguato alla nuova realtàpolitica. La riforma di questo istituto ha permesso inoltre l’a-dozione di un importante documento di base, il piano naziona-le per l’uguaglianza ed equità di genere (67).
Un’altra importante organizzazione che lotta per i diritti delledonne è l’organizzazione delle donne di capo Verde (68), laprima e più nota tra le associazioni di carattere femminile.creata nel 1981 dal partito allora al potere, il P.a.i.c.V., que-st’organizzazione ha come obiettivo principale quello diaumentare il livello della qualità di vita delle donne capover-diane, fascia della popolazione più colpita dalla povertà.attraverso la concessione di micro finanziamenti per intra-prendere attività economiche che, in genere, le banche com-merciali difficilmente concedono, l’o.m.c.V. cerca di sostene-re le donne a mettere in piedi delle piccole aziende e a coin-volgere soprattutto quelle del mondo rurale in progetti soste-nuti da micro crediti (69). Per questa ragione, l’organizzazioneha aperto, nell’anno 2000, degli “uffici di concessione di cre-dito” in cinque distretti del paese. il compito di tali uffici èricevere i fondi destinati a finanziare le iniziative imprendito-riali delle donne e distribuirli, dopo aver valutato attentamenteogni progetto presentato. inoltre, l’o.m.c.V. ha sviluppato, sindagli anni ottanta, politiche di attribuzione di prestiti e dimutui con l’obiettivo di garantire una maggiore stabilità eco-nomica e finanziaria alle donne. a tale fine è stato istituito uncomitato di valutazione e monitoraggio che si occupa diretta-mente dei finanziamenti. tuttavia, le attività che quest’orga-nizzazione porta avanti, fin dalla sua creazione, non si limitanoal campo imprenditoriale. oggi, i crediti concessi possono esse-re impiegati anche in progetti che riguardano l’istruzione, lapromozione della salute familiare, la prevenzione dell’a.i.D.s.
Dopo l’avvento della democrazia in questo paese, le diverseriforme avviate hanno riguardato anche l’o.m.c.V. Da orga-nizzazione politica appartenente a un partito è stata trasforma-
209
ta in una organizzazione non governativa aperta a tutte ledonne a prescindere dall’appartenenza politica.
ciò nonostante, dal punto di vista della partecipazione fem-minile alla politica e all’amministrazione, la situazione noncorrisponde alle aspettative del governo, anche se si è verifica-to un aumento significativo per quanto riguarda l’istruzione ela formazione. Le istituzioni che si occupano della difesa e pro-mozione della donna sostengono che la partecipazione nellepiù elevate cariche dello stato a livello centrale e locale rima-ne ancora un’aspirazione (70). Nel parlamento capoverdiano,nel 1995, su un totale di settantadue deputati, il numero delledonne era appena di dieci. Nell’ambito del potere locale, nelmedesimo anno, vi erano poche donne che avevano funzionidirettive nei comuni e nell’amministrazione pubblica. il gene-re femminile rappresentava circa il 48,5% dei funzionari. ma,soltanto il 27% esercitava funzioni dirigenziali (71). Le donnecapoverdiane rappresentano il 45% delle risorse umane delpaese, fatto importante che dimostra la loro capacità e impor-tanza per lo sviluppo. capo Verde è una nazione in via di svi-luppo; il livello di analfabetismo tra le donne è tuttora elevato:il 32,8% degli illetterati sono costituiti da donne e appena il15% sono uomini; nelle aree rurali, soltanto il 56,6% delledonne sa leggere e scrivere (72).
La lotta per le pari opportunità assume quindi una grandeimportanza nella società odierna capoverdiana. Una particola-re attenzione è stata dedicata al problema in occasione dellagiornata mondiale della donna, manifestazione tenutasi l’8marzo del 2002 a Praia, sul tema della leadership femminile acapo Verde. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di metterein rilievo l’importanza della donna nel mondo del lavoro e lamancanza di politiche specifiche, soprattutto, nei confrontidella donna rurale, meno istruita e con meno possibilità econo-miche di quella che vive nei centri urbani. Nel discorso di aper-tura del convegno, proferito dal sottosegretario alle politichegiovanili (73), è evidente la consapevolezza del fatto che la
210
donna non può essere dimenticata in una prospettiva di svilup-po futuro ma deve essere parte dello stesso. riferendosi allacausa, afferma che si tratta non “di una lotta tra la donna e l’uo-mo, ma indubbiamente di una lotta titanica della società capo-verdiana stessa, che deve mettere assieme tutti gli uomini etutte le donne di questo paese in quanto cittadini e costrutto-ri/beneficiari di un processo di sviluppo, possibile soltanto inun contesto di realizzazione e massimizzazione delle potenzia-lità di ciascun di loro. È in causa la costruzione di una societàdove tutti possono avere, in uguale modo, il diritto ad esercita-re la propria capacità e di utilizzarla per il benessere comune”(74). Dalle sue parole emerge il fatto che sono sempre piùnumerosi i punti d’incontro tra l’uomo e la donna, soprattuttola convinzione che, nonostante le conquiste significative otte-nute sin dal momento dell’indipendenza, in materia di promo-zione dell’uguaglianza e equità tra i sessi, di protezione deidiritti umani e dell’affermazione nell’ambito politico, econo-mico e sociale, un lungo e faticoso cammino resta ancora dapercorrere. Quindi, i diritti della donna capoverdiana, anche sescritti nella costituzione e formalmente una realtà, nella prati-ca non corrispondono ancora agli obiettivi delineati dal gover-no (75).
Nel suo discorso, infatti, il sottosegretario alle politiche gio-vanili riferisce che il programma del governo e le grandi opzio-ni dei piani “evidenziano una chiara scelta del governo per unmaggiore equilibrio nei rapporti uomo / donna. tale equilibrioè permanentemente cercato tramite l’implementazione dimisure di politica multi settoriali che mirano alla promozionedelle pari opportunità in tutte le sfere della vita pubblica” (76).in questo senso, gli obiettivi proposti puntano a una totale ecompleta integrazione della donna nella società, attraversol’aumento della capacità delle istituzioni e organizzazioni chelavorano in quest’area, il coordinamento interdipartimentale,l’accesso all’istruzione e alla cultura a tutti i livelli, all’attivitàeconomica e alla salute (77). Finché la partecipazione della
211
donna, specie a livello del potere politico, non sarà una datoeffettivo, difficilmente verranno prese decisioni a suo favore.rafforzare la leadership femminile e ridurre la discrepanza trauomini e donne nella vita politica, assicurandone una rappre-sentanza quantitativa e qualitativa nei luoghi di decisione,costituisce la sfida del futuro. in questo processo dovrannoavere ruolo decisivo e fondamentale lo stato in quanto istitu-zione, la società civile e i comuni cittadini.
ciò nondimeno, sul piano della partecipazione politica, capoVerde è attualmente all’avanguardia rispetto ad alcune ex colo-nie africane lusofone per quanto riguarda la presenza femmini-le in parlamento (78). Dal 1975 ai nostri giorni, sono state inca-ricate per due legislature consecutive ben due donne comevicepresidente del parlamento nazionale. Le donne rappresen-tano oggi il 18% dei sindaci eletti rispetto al 9% del 1995 men-tre nelle assemblee municipali, le donne rappresentano ben41% rispetto al 27% del 1995 (79). i maggiori sforzi per con-sentire l’integrazione politica delle donne sono stati compiutinegli ultimi trent’anni. Gli anni ottanta sono stati di fonda-mentale importanza per l’ascesa politica della donna; da un’u-nica deputata si è passati a tredici deputate in parlamento (80).Gli anni Novanta, invece, sono stati cruciali in quanto ladonna, finalmente, si è vista protagonista nella discussione edivulgazione dei principali strumenti della politica, quali lacostituzione, il codice di famiglia, il codice dei minori, la leggebase della salute, la legge per l’interruzione volontaria dellagravidanza, ecc. L’inizio del processo democratico nel 1991 hafavorito da una parte la nascita di diverse associazioni tra ledonne e, dall’altra, l’iniziativa nel settore imprenditoriale, seb-bene la presenza di donne in luoghi di decisione resti debole.
in Guinea-Bissau, la lotta di liberazione ha contribuito inmodo decisivo alla formazione culturale e politica delle donneguineane. Fu nell’ambito di tale processo che per la primavolta, la donna ha potuto assumere delle responsabilità a livel-
212
lo politico (come quello di commissario politico delle regioni),occupando il posto che in passato apparteneva soltanto all’uo-mo. La donna arrivata dalle zone liberate della Guinea avevaconquistato la sua emancipazione politica e aveva lottato afianco all’uomo non solo per la libertà e per la giustizia maanche convinta di riuscire ad ottenere la sua libertà in quantocittadina e, per questo, titolare di inderogabili diritti. allo stes-so tempo, però, vi era una parte importante di donne che si tro-vava in una situazione di disagio in tutti i sensi. Vi erano donneche non erano mai entrate in contatto con la modernità, con gliideali del P.a.i.G.c., donne che avevano vissuto fino al momen-to della liberazione del paese nella totale oscurità e ignoranzadel colonialismo e nella sottomissione della società tradiziona-le africana. Nella nuova dinamica spettava, quindi, alle donnepiù istruite e culturalmente più evolute sostenere e indirizzarequelle che non avevano avuto le stesse opportunità.
Nei primi anni ottanta, la partecipazione della donna gui-neana nella politica è stata importante. La mancanza di risor-se umane, nell’area della pubblica amministrazione, ha spintoil nuovo stato a ricorrere ai giovani che avevano ottenuto unaformazione accademica all’estero. tale strategia non ha certa-mente voluto discriminare la donna e tanto meno mettere indiscussione le sue capacità, anche perché si era già visto quan-to utile fosse stato il suo contributo alla creazione delle nuoveistituzioni.
È stato il caso di Henriqueta Godinho Gomes, donna gui-neana che interpreta la partecipazione femminile nel suo paesesostenendo che “il P.a.i.G.c. aveva bisogno di tutte le risorseumane per aiutare alla ricostruzione nazionale (…). mi sonosentita utile, perché negli anni settanta quando sono arrivata,vi erano poche persone con esperienza nell’area della pubbli-ca amministrazione, la mia area di formazione” (81).
Durante gli anni in cui è stata dirigente dell’U.D.e.m.U.(82), unica organizzazione delle donne allora esistente creatanell’ambito della lotta armata, Henriqueta Godinho Gomes
213
afferma di ritenere di “aver fatto qualcosa di positivo” e soprat-tutto di aver “contribuito direttamente in azioni che miravanoall’integrazione e l’emancipazione della donna nel processo disviluppo” (83). Dal 1984 al 1990, anni in cui è stata ministrodella pubblica amministrazione e del lavoro, ha portato a ter-mine alcune riforme a favore della donna lavoratrice: ricono-scimento e consacrazione dei diritti della donna lavoratricenella legge generale sul lavoro che, per la prima volta, ha avutoil diritto alla maternità senza perdere il proprio posto di lavo-ro; applicazione nell’ordinamento giuridico interno di conven-zioni internazionali sul lavoro femminile e infantile; creazionedell’ispettorato generale del lavoro (organo responsabile delcontrollo delle norme sul lavoro). Questa partecipazione diret-ta ad un centro di decisione politica ha dato alla donna guinea-na non soltanto un nuovo impulso in ambito lavorativo e note-vole prestigio nell’apparato statale, ma le ha permesso di met-tersi in competizione e di confrontarsi con l’uomo, in partico-lar modo nella sfera politica. Uno dei risultati di questa politi-ca è stato l’istituzione, nel 1990, di alcune azioni per la prote-zione della salute della donna e del bambino, fatto che ha por-tato all’aumento significativo dello standard medio della salu-te pubblica nell’intero paese (84).
Nel maggio del 1991, il regime di Vieira ha deciso di riesa-minare la costituzione approvata nel 1984 che ha formalizzatola separazione degli stati della Guinea-Bissau e di capo Verde.tra le modifiche degli articoli vi è stata anche quella dell’arti-colo iV che consacrava il P.a.i.G.c. come l’unica forza politi-ca in grado di condurre la società e lo stato. La riforma costi-tuzionale ha consentito finalmente l’esistenza di partiti politicie la libertà di stampa, e la Guinea-Bissau è stata classificatacome uno dei paesi in via di democratizzazione (85). tra ildicembre del 1991 (data della legalizzazione del primo partitopolitico) e il dicembre del 2002, sono stati legalizzati ben ventipartiti politici. tre anni dopo l’introduzione delle prime modi-fiche della costituzione, sono state realizzate le prime elezioni
214
legislative e presidenziali in tutta la storia di questo paese. Perla prima volta il P.a.i.G.c., partito vincitore, ha costituito ungoverno basandosi sul voto legittimo conquistato attraverso leurne. cinque anni dopo le prime elezioni libere nonostante gliavvenimenti del giugno 1998, sono state realizzate le elezioniche hanno portato alla sostituzione del presidente Vieira, algoverno ormai dal 1974.
Nonostante gli importanti passi compiuti negli anni ottanta eprimi anni Novanta, il rapporto tra la donna e il potere inGuinea-Bissau è oggi strettamente collegato alla mentalitàdelle popolazioni locali e alle imposizioni culturali della stessasocietà (86). La maggior parte della società guineana odierna èfortemente maschilista e l’elevato indice di analfabetismo nonfa che peggiorare la posizione della donna (87). La mancanzadi formazione e di informazione porta la maggior parte di loroad assumere un atteggiamento di sottomissione rispetto all’uo-mo e alla società. tale posizione rende difficile il processo d’e-mancipazione e la sua partecipazione ai luoghi di decisione.
È abbastanza nota la discrepanza che esiste tra il lavoro delladonna nella società in generale e il grado di partecipazionepolitica nella stessa (88). sia nell’ambito rurale sia in quellourbano, la donna guineana contribuisce in modo attivo alla vitaquotidiana e svolge dignitosamente le responsabilità attribuita-le nel sistema sociale del gruppo etnico al quale appartiene.Nella società tradizionale, la donna ha essenzialmente un ruolodi educatrice e di madre. Nell’ambiente rurale partecipa attiva-mente alla vita produttiva ed economica, ma non ha nessunpotere di decisione. La popolazione femminile all’interno rap-presenta circa 52% del totale, 54% della popolazione econo-micamente attiva e 67% della manodopera disponibile (89).Quindi, nonostante siano escluse dall’organizzazione politicaed economica, sono le donne che si occupano della gran partedei lavori agricoli. Nelle città, invece, sono loro le principaliresponsabili della crescita del settore informale del commercio.mediante la vendita di manufatti, in piccoli negozi o come
215
ambulanti, le donne garantiscono la sussistenza della maggiorparte delle famiglie cittadine, in particolare quando i maritisono dipendenti statali ed hanno, quindi, salari piuttosto mise-rabili (90).
Nel 1990 è stato istituito il ministero degli affari sociali edella Promozione femminile, la cui strategia si è basata teori-camente sulla formulazione, il coordinamento e l’istituzione dipolitiche dirette ad una maggiore valorizzazione del ruolo delledonne nello sviluppo nazionale. Questo ministero aveva ancheil compito di stabilire dei programmi in grado di rendere piùfacile l’inserimento della donna nel processo di decisione.L’obiettivo è stato raggiunto soltanto in parte, con l’attuazionedel programma di formazione / istruzione delle donne in alcu-ne zone rurali. L’assenza di capacità finanziaria e politica daparte di questo organismo, dovuta in gran parte grande allacrisi economica degli anni Novanta, alla quale poi si è aggiun-ta nel 1998 la guerra civile, che ha lasciato in ginocchio l’inte-ro paese, hanno reso impraticabili i piani d’azione e di strate-gie d’integrazione delle donne nelle istituzioni politiche stabi-liti negli anni precedenti (91). La decade degli anni novanta hasegnato l’inizio di una nuova fase storica e politica dellaGuinea-Bissau. il regime di partito unico ha finalmente lascia-to lo spazio ad un regime pluripartitico. La democrazia, perquanto prematura possa essere, ha aperto alle donne guineanenuovi orizzonti sul piano politico, dando loro la possibilità diintervenire e di accedere al potere, integrando e talvolta diri-gendo organizzazioni politiche. anche nell’ambito della socie-tà civile il ruolo della donna è cambiato; sono sempre piùnumerose le organizzazioni non governative che si battono peri diritti delle donne e per le pari opportunità tra l’uomo e ladonna (92). tuttavia, l’opinione di ausenda cardoso a riguar-do è piuttosto controversa: essa sostiene che all’epoca del regi-me di partito unico, vi erano paradossalmente più donne in par-lamento rispetto agli anni novanta. Nelle precedenti legislatu-re, la scelta dei deputati della nazione era fatta attraverso i con-
216
sigli regionali eletti nelle assemblee popolari, il che favoriva inun certo senso la presenza di donne perché si cercava in ognimodo di dare spazio alla presenza femminile. con l’introdu-zione del regime pluripartitico, è cambiata la strategia e ilmetodo di scelta dei deputati. in questa nuova ottica di compe-tizione, dove per vincere le elezioni è necessario convincerel’elettore, presentandogli delle figure carismatiche e conosciu-te dal popolo, le donne sono state penalizzate, sia perché ilnumero di candidate è ancora poco espressivo sia perché lamentalità maschilista della società in generale pregiudica ognitipo di candidatura da parte delle donne. Basta vedere che nel1999, l’unico partito guidato da una donna ha avuto nel parla-mento soltanto una rappresentante (93). Vi sono alcuni fattoriche spiegano questo tipo di comportamento. innanzittutto, l’e-sistenza di un sentimento culturale retrogrado che concedequasi esclusivamente all’uomo la possibilità di dedicarsi allapolitica e agli affari dello stato, mentre alla donna è affidato ilcompito di moglie e di madre. inoltre, data la sua natura con-ciliante, spesso preferisce pensare alla famiglia piuttosto cheavere qualsiasi tipo di ambizione politica.
alla fine degli anni novanta, la rappresentanza femminile alparlamento guineano era molto debole, appena il 2% (94).considerando i tre poteri sovrani, legislativo, esecutivo e giu-diziario, soltanto il 5,4% dei rispettivi posti di decisione sonoattualmente occupati da donne. ciò significa che spetta all’uo-mo pensare, scrivere e approvare le leggi, nonché prendere ledecisioni politiche e amministrative più opportune senza nem-meno pensare ai diritti della donna. a livello locale la situazio-ne è simile, se non peggiore. La maggior parte dei presidentidelle regioni sono uomini scelti dal governo, fatto anomalo inuna realtà dove all’interno del paese la presenza della donna èpiuttosto elevata.
a proposito dell’accesso della donna ai più importanti orga-ni del potere, il presidente dell’istituto della donna e del bam-bino della Guinea-Bissau, edneusa Lopes da cruz Figueiredo
217
è dell’opinione che soltanto attraverso la sensibilizzazione deipartiti politici sui problemi del genere femminile si possonocreare alternative in grado di permettere alla donna una parte-cipazione adeguata, attiva e diretta nelle prossime elezionilegislative del marzo del 2004 in qualità di candidate (95).significa questo che soltanto il coinvolgimento delle forzepolitiche del paese potrà riuscire a presentare delle soluzionipositive poiché il problema del genere deve essere dibattutoall’interno dei partiti politici. ed è per questa ragione che que-sti ultimi devono essere i primi a capire e a compiere il primopasso, i primi a mettere in risalto il fatto che l’uguaglianza trai sessi è la condizione indispensabile per uno sviluppo socialeequilibrato e per la convivenza tra l’uomo e la donna.
L’organizzazione delle donne del P.a.i.G.c., U.D.e.m.U.,creata nel 1965 nel contesto della lotta armata era finalizzata adorganizzare e mobilitare le donne contro il colonialismo.costituì indubbiamente il primo gran passo verso le pariopportunità tra uomini e donne nella sfera decisionale.tuttavia, nei primi anni ottanta, nel difficile contesto politicoed economico che caratterizzò l’epoca post indipendenza,l’U.D.e.m.U., per mancanza di risorse, non riuscì a dare dellerisposte concrete ai problemi e alle richieste delle donne, comeinvece era successo a capo Verde con l’o.m.c.V. Non riuscìinoltre ad essere all’altezza delle necessità di coloro che all’or-ganizzazione avevano concesso tutta la loro fiducia perché iloro diritti potessero essere gradualmente riconosciuti.Quest’organizzazione, creata in una logica di partito unico ilcui proposito era soprattutto rappresentare e inquadrare ledonne dovrebbe essere adesso in grado di affrontare una pro-fonda riforma strutturale così come era previsto per gli altriorgani del P.a.i.G.c. (96). L’U.D.e.m.U. non doveva più esse-re considerata come un’organizzazione del P.a.i.G.c. ed averequindi uno scopo soltanto politico, ma doveva essere in gradodi unire tutte le donne intorno alle grandi sfide politiche, socia-li ed economiche del paese.
218
in questa nuova logica politica ed economica, l’organizza-zione avrebbe dovuto avere il merito di poter intervenire atti-vamente nell’ambito civile, aiutando le cause sociali. Dovevaessere allora il veicolo giusto per permettere la realizzazione didiversi interventi nell’ambito sociale, l’inquadramento delledonne nella società e soprattutto aperta a tutte le tendenze poli-tiche. Quindi, l’U.D.e.m.U. avrebbe dovuto assumere uncarattere di organizzazione apartitica che dovrebbe funzionarecome meccanismo d’azione civica e d’inquadramento socialedelle donne. ma tutto ciò non è ancora accaduto. insomma,questa riforma avrebbe potuto favorire l’ascesa politica delladonna guineana, e l’U.D.e.m.U., come federazione delle asso-ciazioni delle donne della Guinea-Bissau doveva, in seguitoalla riforma, accogliere tutte le donne e presentarsi come orga-nizzazione non governativa.
secondo un documento pubblicato dal governo guineanonell’anno 2000 a proposito di strategie di riduzione dellapovertà a livello nazionale (97), il fenomeno è particolarmentediffuso in alcuni segmenti della società locale, soprattutto tra ledonne, che in questo paese rappresentano ben 55% della forzalavoro. il documento riferisce che le donne (insieme ai bambi-ni, l’altra fascia debole della popolazione) costituiscono laparte più numerosa della popolazione e sono marginali allaglobalità della società. Nei normali meccanismi del sistemaeconomico formale hanno in genere una posizione abbastanzadebole, fatto che quasi sempre li porta ad optare per il sistemaeconomico informale, settore a rischio dove il lavoro è gene-ralmente mal pagato. Quindi, questa nota discriminazione eco-nomica favorisce inevitabilmente la loro esclusione sociale contutte le conseguenze che possono da li derivare come per esem-pio la diffusione della prostituzione soprattutto tra le giovanedonne. spesso quelle che lavorano nel settore informale sonoconsiderate capo famiglia, e nei centri urbani è sempre più fre-quente il fenomeno delle famiglie con un solo genitore, lamadre. Questo nuovo tipo di nucleo famigliare è strettamente
219
collegato alla povertà perché la donna, essendo un soggettofortemente vulnerabile e integrata in modo inadeguato nell’e-conomia formale, non riesce a far fronte alle necessità econo-miche della famiglia perché mal retribuita e senza capacità dirisparmio.
La conferenza delle donne della comunità dei paesi di lingua portoghese
Dal 30 gennaio al 1 febbraio del 2000 si è tenuta a salvador(Brasile) per la prima volta nella storia della comunità dei paesidi lingua portoghese, la conferenza delle donne della c.P.L.P.sul tema “genere e cultura”. Gli argomenti maggiormente ana-lizzati sono stati: accesso al potere, partecipazione politica esviluppo. La conferenza, promossa dai ministeri della cultura edegli affari esteri brasiliani, in stretta collaborazione con ilsegretariato esecutivo dell’organizzazione, ha avuto la presen-za delle delegazioni di tutti i paesi membri, quali Brasile,Portogallo, angola, capo Verde, Guinea-Bissau, mozambico esão-tomé e Príncipe.
trattandosi del primo incontro al quale partecipavano donnedi tutti i paesi membri, la conferenza ha avuto l’obiettivo di“favorire lo scambio d’informazione sulla situazione delledonne e sulle politiche nei paesi della c.P.L.P., così come l’a-dozione, negli stessi paesi, del programma d’azione diPechino”. inoltre, ha avuto la finalità di “identificare le propo-ste comuni relative alla lotta alla povertà, alla promozionedello sviluppo umano e dell’inclusione sociale, all’accesso allasanità, all’istruzione e al lavoro, al sostegno delle donne nellapolitica e nelle attività economiche, in specie l’accesso al pote-re” (98). in questa conferenza, le donne degli stati membrihanno riconosciuto l’importanza di stabilire un dialogo tra diloro e del servirsi degli strumenti messi a disposizione dallestrutture dell’organizzazione in vista dell’attuazione dei pro-
220
grammi nazionali di promozione delle pari opportunità e deidiritti delle donne. Diverse sono state le tematiche dibattute daigruppi di lavoro, quali la partecipazione delle donne nelle atti-vità economiche, le condizioni d’accesso alla salute e all’istru-zione, la cultura e l’identità, le pari opportunità, la partecipa-zione politica e l’accesso al potere, tra gli altri. Per quantoriguarda la partecipazione politica e l’accesso al potere, ildocumento finale così conclude: “nella maggior parte dei paesiè ancora negato alla donna il pieno sviluppo e l’accesso ai postidi potere. tale fatto si manifesta nella loro rappresentanza alivello legislativo, dove esiste una ridotta presenza femminile:angola 15,5% (34 donne su 220 deputati), Brasile 6,06% (36donne su 594 parlamentari), capo Verde 6,9% (5 donne su 72deputati), Guinea-Bissau 7,8% (8 donne su 102 deputati),mozambico 28% (70 donne su 250 deputati), são tomé ePríncipe 9,1% (5 donne su 55 deputati) e Portogallo 18,7% (43donne su 230 deputati)” (99).
tra le decisioni finali quella che appare più importante è l’i-stituzione della conferenza delle donne della c.P.L.P., la primaorganizzazione femminile di carattere internazionale delmondo lusofono. si è altresì decisa la creazione di una rete conl’obiettivo di sostenere le donne dei paesi lusofoni colpiti dallaguerra civile (il caso della Guinea-Bissau e dell’angola).Un’altra importante decisione di questa conferenza è stata lacreazione di un forum delle donne della c.P.L.P all’interno deiparlamenti nazionali.
Nel luglio del 2001 è stato costituito, come stabilito dallaprima conferenza del 2000 tenutasi in Brasile, il forum delledonne della c.P.L.P. in centri di decisione. in questa prima riu-nione realizzata a maputo (mozambico), con l’obbiettivogenerale di creare le basi per lo scambio d’informazione eesperienza sulle politiche di pari opportunità e sulle strategiecomuni, erano presenti donne in rappresentanza dell’angola,mozambico e capo Verde, assenti la Guinea-Bissau e le isoledi são tomé e Príncipe.
221
il tema centrale del dibattito è stato la posizione giuridicadella donna in ogni paese e la sua partecipazione ai processidecisionali (100) Un anno più tardi si realizzava il secondoforum nella capitale angolana, Luanda. L’incontro si poneva incontinuità con il primo. il suo obiettivo era soprattutto coglie-re le esperienze dei vari paesi e dare particolare enfasi al pro-blema della scolarizzazione, cercando le diverse forme di pro-mozione dell’istruzione per le donne giovani e adulte. tra lerelazioni presentate dai paesi membri, la rappresentante capo-verdiana madalena tavares, presidente dell’istituto della con-dizione femminile, parlò della donna nel contesto del sistemad’istruzione del capo Verde. Nei diversi interventi venne sot-tolineata la volontà del forum di “dare voce” alle donne neicentri decisionali, per essere in grado di influenzare e concre-tizzare politiche favorevoli all’equilibrio tra i sessi.L’istruzione ancora una volta è stata riferita come “fattore pre-ponderante per lo sviluppo, essendo quindi prioritario incenti-vare in modo sistematico e pianificato le azioni volte a risulta-ti pratici”. L’istruzione delle donne e il cambiamento dellementalità (che presuppone anche un cambiamento dei pro-grammi nelle scuole e dell’informazione diffusa dai mezzi dicomunicazioni) è stato uno dei punti che ha suscitato più inte-resse da parte dei gruppi di lavoro.
coinvolgere innanzitutto le famiglie e la società in generaleper quanto riguarda la qualità dell’istruzione nei paesi rappre-sentati nel forum è stato forse l’obiettivo finale più importantedell’incontro di Luanda. La diffusione dell’informazione rela-tiva alla donna (ai suoi diritti e ai problemi che affronta),migliorando le conoscenze a riguardo e sensibilizzando l’opi-nione pubblica e i mezzi d’informazione; influenzare le inizia-tive legislative attraverso l’istituzione di un ufficio di donneparlamentari di ogni paese e la promozione di incontri periodi-ci; coinvolgere il governo nella definizione di politiche, pro-grammi e risorse finanziarie, eliminando le discriminazioniesistenti, sono i principali impegni presi in questa riunione
222
internazionale che ha interessato soltanto tre dei sette statilusofoni appartenenti alla c.P.L.P.
L’intervento deve essere fatto quindi a partire dei nucleifamigliari, delle comunità locali e regionali e delle organizza-zioni non governative, che devono avere un ruolo più attivo edeciso. a livello legislativo, bisognerà passare dalla teoria allapratica. L’istituzionalizzazione delle varie forme di pressione edei meccanismi di responsabilizzazione, dovranno essere allabase di un’azione comune ed efficace. La Guinea-Bissau nonha partecipato ai forum, nonostante faccia parte della confe-renza. ciò indurrebbe a ritenere che non vi sia la necessariasensibilità verso la promozione dei diritti della donna e relati-vi problemi. tuttavia, l’esistenza oggi di una organizzazioneinternazionale che aggrega le donne dei paesi lusofoni è unfatto di fondamentale importanza e dimostra che il problemadelle pari opportunità e della presenza attiva e costante delladonna nella politica, nell’economia e nella società civile, invista della conquista di un suo proprio spazio è un denomina-tore comune alla maggior parte delle donne del mondo lusofo-no e di tutti i quadranti della società odierna di questi stati.
Conclusioni
Questa analisi vuole porre in risalto le differenze che esisto-no in tema di partecipazione della donna nella sfera politica eistituzionale in Guinea-Bissau e a capo Verde, due stati uniti inepoca coloniale, che hanno separato i loro destini nel 1980.alla fine di questa analisi si possono cogliere alcuni aspettimeritevoli di particolare attenzione. innanzitutto, è evidenteche il processo di liberazione in Guinea-Bissau ha contato mol-tissimo sulla forza delle donne. sia la donna guineana chequella capoverdiana sono state oggetto e soggetto nel progettonazionalista che ha avuto come principale protagonista il lea-
223
der politico amilcar cabral. egli aveva basato il programmad’azione del suo partito soprattutto sull’istruzione e sulla for-mazione del popolo, a suo avviso garanzia di progresso e disviluppo sostenibile. Per la prima volta nella storia delle colo-nie portoghesi fu accordata alla donna la possibilità di interve-nire in modo diretto nelle decisioni degli organi del partito edelle nuove istituzioni delle zone liberate. Questa politica hafavorito la donna in termini culturali e a livello della sua inte-grazione nelle istituzioni politiche. La condizione socio cultu-rale della donna guineana era sicuramente più svantaggiatarispetto alla donna capoverdiana, fatto che trova spiegazionenella politica coloniale attuata dai portoghesi in questi duepaesi, dove il capoverdiano, meticcio, è servito fondamental-mente come veicolo di acculturazione del popolo guineano,quindi più istruito. in questo contesto, la donna capoverdiana siè trovata in una posizione culturalmente più elevata rispetto alladonna guineana, fatto che nel tempo ha avuto i suoi riflessi.
il 1980 ha segnato un cambiamento politico radicale nellastoria di questi due stati. il progetto ideato e messo in atto dacabral, di “uno stato due nazioni” era arrivato alla fine.L’incomprensione tra gli esponenti politici, la sfiducia in unprogetto politico e sociale comune e la paura da parte guinea-na di un controllo politico capoverdiano hanno vanificato ognipossibilità di portare a termine il sogno di amilcar cabral. Lascissione della Guinea-Bissau e di capo Verde ha comportatouna rottura completa anche dei rapporti istituzionali. Perprimo, il P.a.i.G.c. l’unica forza politica esistente nei duepaesi, si è diviso in due parti, l’ala capoverdiana e l’ala gui-neana. Dopo pochi mesi, l’ala capoverdiana cambiò il nomedel partito in Partido Africano da Independencia de CaboVerde. La costituzione che era stata il simbolo dell’indipenden-za e della sovranità dei due stati fu adattata alla nuova realtàpolitica e subì alcuni cambiamenti; i rapporti conflittuali cheintanto si erano creati all’inizio degli anni ottanta fra i guinea-ni e capoverdiani ebbero riflessi negativi nel processo di eman-
224
cipazione femminile. La presenza di donne capoverdiane nelleistituzioni pubbliche guineane è stato un ulteriore motivo didivergenze fra le due parti.
Nella Guinea-Bissau, cinque anni dopo l’effettuazione delleprime elezioni libere e democratiche, il paese è scivolato versoun terribile conflitto etnico che ha distrutto le già poche strut-ture esistenti ed ha inevitabilmente rimandato il progetto disviluppo socio culturale che il paese aveva scelto e che lo statoaveva appena avviato all’inizio degli anni novanta. se da unlato tutto sembrava procedere regolarmente, dall’altro è dove-roso constatare le non poche contraddizioni e cedimenti al pas-sato. La più significativa analisi di queste vicissitudini è diFafali Koudawo. egli analizza le transizioni politiche a capoVerde e nella Guinea-Bissau nel corso dell’ultimo ventennioriconoscendo che, mentre capo Verde è passato dall’autoritari-smo alla democrazia liberale, la Guinea-Bissau è passata dal-l’autoritarismo alla democrazia parziale (1991-1998). a giudi-zio dell’autore, dal giugno del 1998, data dell’inizio della guer-ra civile, si è scivolato di nuovo verso l’autoritarismo. il casodella Guinea-Bissau si può, quindi, considerare un caso di“transizioni sovrapposte e incompiute” (101).
malgrado i segni di regressione verificatisi nell’ultimodecennio in materia di partecipazione del genere femminilenelle istituzioni statali, la democrazia, come sostieneHenriqueta Godinho Gomes, ha aperto alle donne guineanenuovi orizzonti sul piano politico, offrendo loro la possibilitàdi intervenire e di accedere al potere politico, integrandolo etalvolta dirigendolo, giungendo in qualche caso anche alladirezione di partiti politici (102). Nella società civile, il ruolodella donna ha assunto un’importanza ancora più grande. Ladonna, infatti, partecipa sempre di più alla vita del paese. sulpiano governativo, c’è stata un’evoluzione positiva dopo il1998, essendoci addirittura negli ultimi quattro anni una donnaalla guida dei ministeri della Difesa e degli esteri. ciò nono-stante, la partecipazione delle guineane a livello politico e nei
225
centri di decisioni resta minima, anche esse se rappresentano il52% della popolazione attiva del paese. Diventa quindi impor-tante agire con coscienza, cercare di cambiare gradualmente lementalità della società attuale perché la donna possa non esse-re esclusa dalla vita politica e istituzionale e prendere parte alprocesso di decisione.
come si è visto, capo Verde fino al 1980 ha avuto un per-corso storico identico a quello della Guinea-Bissau. Una lottadi liberazione comune, lo stesso partito nazionalista e il sognodi costruire una nazione guineo-capoverdiana che fosse una eindivisibile. il colpo di stato del 14 novembre 1980 ha vanifi-cato ogni possibilità di concretizzare questo sogno ed ha rap-presentato per le isole di capo Verde non soltanto la fine diun’unione culturale e istituzionale che legava i due popoliormai da secoli. Ha significato anche una seconda morte delleader politico amilcar cabral, in quanto le sue idee e i suoipresupposti di costruzione dello stato nazionale sono statimessi in causa. Per la Guinea-Bissau e per i guineani, invece,ha consentito di riprendere il potere che fin dall’indipendenzaera gestito dai capoverdiani. capo Verde aveva, al momentodella scissione, un vantaggio rispetto alla Guinea: un più altolivello di istruzione ed era culturalmente più avanzato, in gradodi intraprendere la ricostruzione del nuovo stato. il passaggiodal regime di partito unico alla democrazia parlamentare nel1991 è stato graduale e senza traumi, mentre nella Guinea-Bissau si è avuta una violenta interruzione del processo demo-cratico iniziatosi nel 1994. Nelle isole di capo Verde, gli anniottanta sono stati un periodo di grandi cambiamenti per ladonna a livello politico e istituzionale. si può addirittura parla-re di una vera rivoluzione in ambito parlamentare, poiché da undeputato, nel 1980, si è passati a tredici deputati nel 1984.anche se la partecipazione delle donne a livello politico è con-siderata oggi ancora poco significativa, alcuni passi importan-ti sono stati compiuti: la presenza di quattro donne al governo,alla guida di importanti ministeri quali gli affari esteri,
226
l’ambiente, l’agricoltura e Pesca e la Giustizia (103) dimostraquanto la situazione stia cambiando. Gli anni Novanta portaro-no dei cambiamenti fondamentali in entrambi i paesi.
Nella struttura e nel funzionamento dello stato, si può direche sia in Guinea-Bissau che a capo Verde, anche se in que-st’ultimo in misura minore, la natura patriarcale delle leggicrea e consolida le disuguaglianze tra i due sessi. Le istituzio-ni dello stato sono ancora ampiamente dirette e controllatedagli uomini. Le loro politiche riflettono la dominazionemaschile sulla vita delle donne. e anche la società, nonostantele pretese democratiche, è critica riguardo alle iniziative chemirano all’applicazione concreta dei diritti del genere femmi-nile.
tra la Guinea-Bissau e le isole di capo Verde esiste una note-vole discrepanza a livello di sviluppo umano. Lo conferma ilrapporto del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo(UNDP) riferente all’anno 2000 (104), che ha classificatocapo Verde al 105° posto (tra i paesi con un sviluppo umanomedio) e la Guinea-Bissau al 169° posto (tra i paesi con unbasso sviluppo umano); la percentuale di alfabetizzazione acapo Verde era, nel 1998, tra gli adulti del 72,9%, mentre nellaGuinea-Bissau corrispondeva a solo 36,7%; infine nelle isoledi capo Verde, nel 1997, 99,9% dei bambini frequentavanoregolarmente le scuole elementari, mentre in Guinea-Bissau,soltanto al 52,3% dei bambini accadeva lo stesso. Questi datiriflettono chiaramente la situazione socio culturale in cui si tro-vano attualmente i due paesi. ma riflettono soprattutto le scel-te politiche che entrambi i paesi hanno fatto fin dal momentodella loro separazione nel 1980.
infine il ruolo che il forum delle donne della c.P.L.P. potràsvolgere all’interno dei centri di decisione sarà di unione tra ledonne guineane e capoverdiane. Un’occasione di dibattitodove poter discutere e scambiare idee sulla situazione delledonne, dove poter proporre delle soluzioni nonché esercitareuna determinata pressione verso i governi locali nel senso di
227
promuovere delle politiche che riguardino i diritti della donna.Questa sarà sicuramente la via migliore per muoversi, il modopiù adatto per ottenere dei risultati concreti, non dimenticandoche attraverso l’unione delle donne lusofone e tramite un lavo-ro di gruppo, l’emancipazione e lo sviluppo culturale delladonna in questi paesi potrà finalmente essere una realtà e nonuna norma meramente astratta contenuta nelle leggi costituzio-nali.
Note
1) il periodo storico considerato abbraccia gli anni a cavallo tra il collasso delregime coloniale e l’inizio di un sistema politico democratico. Gli anni dellalotta armata di liberazione significarono per la donna guineana e capoverdia-na l’inizio della presa di coscienza politica e della partecipazione diretta nelleistituzioni che nascevano nelle zone liberate della Guinea. Gli anni Novantahanno avuto, invece, per questi due paesi un significato politico profondo.Furono gli anni dell’apertura politica e del multipartitismo; gli anni in cui ilsistema di partito unico messo in atto fin dall’indipendenza, ha dato spazioad un sistema di democrazia parlamentare (almeno teoricamente). Nelle isoledi capo Verde, le prime elezioni generali libere e democratiche sono stateeffettuate nel 1991, mentre nella Guinea-Bissau lo stesso è accaduto nel1994. (si vedano “Guinea-Bissau” in Africa South of the Sahara 2002,London, europa Publications, 2002, pp.473-489; “cape-Verde”, in AfricaSouth of the Sahara 2002, London, europa Publications, 2002, pp.164-174;amNistia iNterNacioNaL, Guiné-Bissau: direitos humanos em tem-pos de guerra e de paz, Julho 1999, index a1: aFr 30/07/99).2) sul ruolo della donna nella società dell’africa subsahariana (tradizionalee moderna) e sul suo rapporto con il commercio, la politica e la cultura siveda c. coQUerY-ViDroVitcHh, Les africaines. Histoire des femmesd’Afrique noire du XIX au XX siècle, Paris, editions Desjonquères, 1994.3) La Guinea-Bissau, nota come Guinea Portoghese durante il periodo dellacolonizzazione portoghese, fu scoperta dai portoghesi alla fine del quindice-simo secolo (verso 1490). Nell’opinione di antónio carreira, la parolaGuinea definiva una larga area senza limiti comprensibili, sembrando, quin-di, più appropriato l’uso del termine Fiumi della Guinea, che comprendeval’area tra il fiume senegal e il fiume casses nel nord della sierra Leone. Finoal 1879, la Guinea Portoghese dipendeva dal punto di vista amministrativodalle isole di capo Verde ed era considerata addirittura colonia di una colo-nia. Quindi, la storia dell’espansione portoghese nell’occidente africano èquella della penetrazione del capoverdiano nel continente, poiché senza tal
228
elemento difficilmente sarebbe stato possibile influenzare in modo significa-tivo la vita sociale degli africani di quella area geografica. (a. carreira,Documentos para a história das Ilhas de Cabo-Verde e Rios de Guiné (sécu-los XVII-XVIII), Lisboa, 1983; a. carreira, “aspectos da influencia dacultura portuguesa na área compreendida entre o rio senegal e o norte daserra Leoa (subsidios para o seu estudo)”, Boletim Cultural da GuinéPortuguesa, 1964, n. 76, pp.374-376; a. carreira, “a Guiné e as ilhas decabo-Verde. a sua unidade historica e populacional”, Ultramar, 1968, pp.70e ss.; J. Barreto, História da Guiné, 1419-1918, Lisboa, edição do autor,1938, pp.244/ 248 e ss.; L. matos, “a delimitação das fronteiras da Guiné”,in Curso de Extensão Universitária, Lisboa, instituto superior de ciênciassociais e Políticas, 1968; r. PeLissier, Historia da Guiné. Portugueses eafricanos na Senegambia, 1841-1936, Lisboa, editorial estampa, 1989,vol.i, pp.156-162; m.e .maDeira saNtos, “Lançados na costa da Guiné:aventureiros e comerciantes”, in c. Lopes (a cura di), Mansas, Escravos,Grumetes e Gentios. Cacheu na encruzilhada das civilizações, , institutoNacional de estudos e Pesquisa, Bissau, 1993, pp.67-78.4) secondo le parole di antónio carreira, il popolamento delle isole di capoVerde fu fatto soprattutto con “bianchi della metropoli e delle isole adiacen-ti e con i neri deportati dalla Guinea”, dando origine, “attraverso la più curio-sa mescolanza il capoverdiano, l’elemento più caratteristico della fusione delsangue portoghese nei tropici”. conclude, carreira, dicendo che “la storiadell’espansione portoghese nell’occidente africano é anche la storia dellapresenza del capoverdiano nel continente”, perché senza quell’elementoumano, molto difficilmente sarebbe stato possibile influenzare in modosignificativo la vita economica e sociale dei popoli che vi abitavano. [a.carreira, “aspectos da…”, cit., pp.373-374; a. carreira, , “aGuiné…”, cit., p.70]. Lo stabilimento di un regime amministrativo “noncoloniale” a capo Verde (la cui popolazione dopo la revisione della CartaOrgânica do Império Colonial Português, fu esclusa dall’influenza dellaprincipale legge che regolava la vita degli africani, cioè dallo Estatuto dosIndigenas Portugueses das Provincias de Angola, Moçambique e Guiné del1954) equivalse ai regimi autonomi in vigore nelle isole portoghesi dellamadeira e delle azzorre. tuttavia, il passaggio dallo statuto di colonia a quel-lo di “isola adiacente” non fu reso concreto, e nel 1963 l’esame della LeiOrgânica do Ultramar confermò l’unità politica della “nazione portoghese”,consolidando in questo modo la vittoria delle correnti antifederaliste eantiautonomiste [a. .moreira, Partido Português, Lisboa, Bertrand,senza data (s/d), pp.140-141]. 5) tale statuto si riferiva agli africani che, dal punto di vista legale, eranoconsiderati indigeni, ovvero coloro che non avevano diritto di cittadinanza e,perciò esclusi da ogni vantaggio che tale diritto comportava (voto, istruzio-ne, lavoro nelle istituzioni dello stato e così via. (si veda Estatuto dosIndígenas Portugueses das Províncias da Guiné, Angola e Moçambique,Lisboa, agência Geral do Ultramar, 1954). sulla situazione sociale degli afri-
229
cani negli anni cinquanta si veda a. caBraL, “a dominação colonial por-tuguesa” in m. de andrade (a cura di), A arma da teoria. Unidade e luta,Lisboa, seara Nova, 1976, vol.i, pp.57-116.6) si veda intervista a Henriqueta Godinho Gomes, realizzata dall’autore,15/11/2003 (a partire da questo momento saranno citati soltanto il nome e ladata).7) si veda a. caBraL, “a dominação colonial portuguesa” in m. deandrade (a cura di), A arma da teoria. Unidade e luta, Lisboa, seara Nova,1976, vol.i, pp.79-80.8) Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo-Verde.9) PartiDo aFricaNo Da iNDePeNDeNcia Da GUiNe e caBo-VerDe, Programa do P.A.I.G.C.-Programa Maior, 1965, p.2, Fundaçãoamilcar cabral, Praia (cabo-Verde), non classificato (a partire da questomomento n.c.).10) a. caBraL, , Para a melhoria do nosso trabalho politico (seminariodestinado aos quadros do Partido), conacry, 19-11-1969, , Fundação máriosoares, Lisboa, pasta n.4357.009.11) La Polícia internacional da Defesa do estado, nota P.i.D.e., fu creata nel1954 con l’obiettivo fondamentale di combattere ogni tipo d’attività politicae propagandistica nelle colonie africane del Portogallo e nella madrepatria.(sull’ attività della P.i.D.e. in Guinea-Bissau e nel capo Verde si vedanosoprattutto i documenti riguardanti la lotta clandestina del P.a.i.G.c. e diamilcar cabral presenti nel Arquivo Nacional da Torre do Tombo: “Boletimn. 147289” (1 fl.); “Processo sr-1915/50”: pasta 1 (94 fls., pasta 2 (397 fls.),pasta 3 (332 fls.), pasta 4 (264 fls.), pasta 5 (288 fls.), pasta 6 (294 fls.), pasta7 (208 fls.), pasta 8 (315 fls.), pasta 9 (167 fls.), pasta 10 (306 fls.), pasta 11(316 fls.), pasta 12 (248 fls.), pasta 13 (1179 fls.), pasta 14 (328 fls.).12) in questo caso i messaggi segreti fondamentali per la comunicazione trai diversi responsabili militari e una efficace interazione erano consegnatedalle donne. [si veda PartiDo aFricaNo Da iNDePeNDeNcia DaGUiNe e caBo-VerDe, Sobre o papel político, económico e social damulher na Guiné e em Cabo-Verde, conacry, P.a.i.G.c., 1972, pp.2-3,Fundação amilcar cbaral, Praia (cabo-Verde), n.c.].13) a. caBraL, , Forças Armadas Revolucionárias do Povo (F.A.R.P.).Bases e componentes (vamos reorganizar e melhorar a acção das ForçasArmadas Nacionais, vamos mobilizar todas as capacidades para criar edesenvolver as Forças Armadas Locais, vamos dar golpes cada vez maisduros ao inimigo para expulsá-lo de vez para sempre da Guiné e Cabo-Verde), conacry, P.a.i.G.c. (conselho de Guerra), 1966, p.2, Fundaçãoamilcar cabral, Praia (cabo-Verde), n.c.14) amilcar cabral nacque a Bafata (regione orientale della Guinea-Bissau),il 12 settembre 1924, da genitori capoverdiani (Juvenal cabral e iva Pinhelevora). Frequentò il liceo a capo Verde, nell’isola di sao Vicente, dove con-cluse la maturità brillantemente con una media di 17/18 punti. Nel 1945vinse una borsa di studio dal governo portoghese per compiere gli studi uni-
230
versitari a Lisbona, dove nel 1950 si laureò in ingegneria agronomica. Nel1952, cabral tornò a Bissau, con un contratto di lavoro come responsabiledei servizi agricoli e forestali della Guinea Portoghese. in realtà questoimpiego gli ha permesso di iniziare un lungo e difficile lavoro di conscien-zializzazione delle masse rurali della Guinea. con il sostegno di cinque gio-vani che con lui condividevano gli stessi ideali e la stessa volontà di liberareil paese dal colonialismo, cabral fondò, il 19 settembre del 1956, il Partidoafricano da independencia da Guiné e cabo-Verde (P.a.i.G.c.), inizialmen-te un movimento di liberazione e già negli anni settanta partito che ha con-dotto sia la Guinea-Bissau sia le isole di capo Verde all’indipendenza nazio-nale. (Per una lettura più completa sulla biografia di amilcar cabral si vedaPartiDo aFricaNo Da iNDePeNDeNcia Da GUiNe e caBo-VerDe,Amilcar Cabral, vida e obra, Lisboa, centro de informaçao e Documentaçaoamilcar cabral (ciDac), 1977, GB-ac-ii-2).15) a. caBraL, , Textos politicos, 1972, p.14, Lisboa, centro deinformação e Documentação amilcar cabral (c.i.D.a.c.), GB-a.c. ii-4.16) Nonostante le opposizioni interne, amilcar cabral difese fin dai primianni di lotta armata la situazione della donna all’interno del partito. La deci-sione di creare la escola Piloto a conakry (la più importante scuola delP.a.i.G.c. durante questo periodo) e l’invio successivo di gruppi di giovaneragazze per studiare in alcuni paesi del est europeo, fa capire quanto fosseimportante per cabral l’istruzione delle donne. (su questo argomento sivedano soprattutto PartiDo aFricaNo Da iNDePeNDeNcia Da GUiNee caBo-VerDe, Rapport sur le rôle politique-social et économique de lafamme en Guinée et aux îles du Cap-Vert, conacry, P.a.i.G.c., 1972,Fundação amilcar cabral, Praia (cabo-Verde), n.c.; m. De aNDraDe, Lalutte de libération en Afrique. Le rôle de la femme, posteriore a 1967,Fundação mário soares, pasta n. 4310.003, imagem 43.17) s. UrDaNG, , “Women in national liberation movements”, in Africanwomen south of the Sahara, Usa, Longman House, 1984, cit., p.160.18) Nel 1975 carmen Pereira è stata nominata dirigente dell’organizzazionedelle donne del P.a.i.G.c., l’U.D.e.m.U. (União Democrática dasmulheres), incarico che ha svolto fino al 1981. Dal 1984 al 1992 è stata ilpresidente del parlamento guineano (assembleia Nacional Popular).attualmente resiede in Guinea-Bissau e continua a partecipare alla vita poli-tica del paese. (si veda http://people.africadatabase.org/peolple/data/per-son3339.html.19) in portoghese Comité Executivo da Luta.20) si veda c. coQUerY-ViDroVitcH, Les africaines..., p.308.21) il comitato di villaggio era l’organo responsabile per l’amministrazionedel villaggio. Vigilava sulla circolazione degli individui tra villaggi, su que-stioni civili, sul trasporto di articoli di prima necessità e di materiali vari, esulla speculazione dei prezzi. era costituito da cinque membri, quali un pre-sidente (primo responsabile del villaggio e della rispettiva popolazione), unvicepresidente, un addetto agli affari sociali e di stato civile, e due addetti al
231
commercio e rifornimento. [si veda Decisão de 30 de Agosto de 1970,conacry, P.a.i.G.c., 1970, Fundação amilcar cabral, Praia (cabo-Verde),n.c.].22) Decisão de 30 de Agosto de 1970, conacry, P.a.i.G.c., 1970, p.5,Fundação amilcar cabral, Praia (cabo-Verde), n.c.23) s. UrDaNG, cit., p.162.24) s. UrDaNG, cit., p.162. sullo stesso argomento si veda PartiDo aFri-caNo Da iNDePeNDeNcia Da GUiNe e caBo-VerDe, Sobre o papelpolítico, económico e social da mulher na Guiné e Cabo-Verde, conacry,P.a.i.G.c., 1972, p.3, Fundação amilcar cabral, Praia (cabo-Verde), n.c.(25) il primo tribunale Popolare “di primo livello”, cioè di villaggio, fu elet-to nel 1969. aveva la funzione di giudicare i problemi d’interesse comunita-rio e del quotidiano delle popolazioni (come per esempio divorzi, conflitti diterra, circolazione di persone da zone liberate a zone non liberate). Questotribunale era costituito da tre membri, quali un giudice e due assessori, scel-ti dall’assemblea del popolo, per un periodo di tre anni. tra questi membri,almeno uno doveva essere donna in tutti gli altri livelli amministrativi (set-tori e regioni), i tribunali dovevano essere rappresentati anche da donne. [a.caBraL, Para a melhoria do nosso trabalho politico (Seminário destina-do aos quadros do Partido), conacry, P.a.i.G.c., 19-11-1969, Fundaçãomário soares, Lisboa, Pasta n.4357.009; PartiDo aFricaNo Da iNDe-PeNDeNcia Da GUiNe e caBo-VerDe, Decisão de 1 de Janeiro de1970- sobre alguns problemas actuais da nossa vida nas regiões libertadas,conacry, P.a.i.G.c., 1972, Fundação amilcar cabral, Praia (cabo-Verde),n.c.].26) Dopo la ristrutturazione delle forze armate del P.a.i.G.c., le donne furo-no chiamate a far parte del corpo dell’esercito regolare. Le Forze armateLocali (F.a.L) contavano con la presenza di diverse donne. avevano all’in-terno dei gruppi armati rigorosamente costituiti da donne (gruppi da 18 per-sone) che formavano le “unità femminili” e che addirittura compivano mis-sioni di guerra. [si veda a. caBraL, Forças Armadas Revolucionarias doPovo (F.A.R.P.). Bases e componentes (vamos reorganizar e melhorar aacção das Forças Armadas Nacionais, vamos mobilizar todas as capacida-des para criar e desenvolver as Forças Armadas Locais, vamos dar golpescada vez mais duros ao inimigo, para expulsá-lo de vez para sempre daGuiné e Cabo-Verde), conacry, P.a.i.G.c. (conselho de Guerra), 1966, p.2,Fundação amilcar cabral, Praia (cabo-Verde), n.c.].27) Durante la lotta armata il numero di donne di origine capoverdiana eranaturalmente inferiore a quelle di origine guineana. La maggior parte di loroerano moglie di militari capoverdiani che compivano missioni di guerra.28) si veda intervista a Dulce almada Duarte realizzata dall’autore, Praia(capo Verde), 5/02/2001, in P. Gomes, A nova ordem social criada peloPartido Africano da Independência da Guiné e Cabo-Verde (P.A.I.G.C.) naszonas libertadas da Guiné-Bissau (1963-1973), tesi di Dottorato in storia eistituzioni dell’asia e dell’africa moderna e contemporanea, Xiii ciclo
232
(1998-2001), cagliari, 2003.29) Ibidem.30) si veda intervista a ana maria cabral realizzata dall’autore, Praia (cabo-Verde), 1/02/2001, in P. Gomes, A nova ordem social criada pelo PartidoAfricano da Independência da Guiné e Cabo-Verde (P.A.I.G.C.) nas zonaslibertadas da Guiné-Bissau (1963-1973), tesi di Dottorato in storia eistituzioni dell’asia e dell’africa moderna e contemporanea, Xiii ciclo(1998-2001), cagliari, 2003.31) La presenza di zone liberate nel territorio della ancora Guinea Portoghesecorrispondeva “a più di due terzi del territorio nazionale sotto il nostro con-trollo nel 1971, intendiamo per controllo la presenza effettiva del nostro par-tito organizzato, dai villaggi alle regioni e lo sviluppo di una amministrazio-ne locale e di diversi altri servizi dello stato che stiamo creando nelle zoneliberate”. (L. De aGUiar, Livro Negro da Descolonização, Lisboa-Braga,editorial intervenção, s/d, cit., p.447).32) PartiDo aFricaNo Da iNDePeNDeNcia Da GUiNe e caBo-VerDe, Programa do P.A.I.G.C.-Programa Maior, 1965, p.8, Fundaçãoamilcar cabral, Praia (cabo-Verde), n.c.33) P. Gomes, cit., p.84.34) La formazione dei giovani prevedeva non soltanto l’insegnamento nel-l’ambito strettamente scolastico, bensì nozioni di educazione sanitaria e dieducazione civica. [si vedano P. Gomes, p.83; “o sistema educativo naszonas libertadas”, O Militante, Bissau, P.a.i.G.c., 1965, pp.157-158; L.ocUNi ca, A educação durante a colonização portuguesa na Guiné-Bissau(1471-1973), www.bibli.fae.unicamp.br/revbfe/v2n1out2000/artigo10.pdf].(35) PartiDo aFricaNo Da iNDePeNDeNcia Da GUiNe e caBo-VerDe, Regulamento Interno dos Internatos das Regiões Libertadas,conacry, P.a.i.G.c., 1971, Fundação amilcar cabral, Praia (cabo-Verde),n.c.36) Ibidem.37) si veda m. BoaL, A organização da assistência médico-sanitária donosso partido, Bissau, P.a.i.G.c., 1970. 38) si veda P. Gomes, pp.97-98.39) si veda P. Gomes, p.85.40) L ocUNi ca, A educação durante a colonização portuguesa na Guiné-Bissau (1471-1973), www.bibli.fae.unicamp.br/revbfe/v2n1out2000/arti-go10.pdf. secondo l’autore, le condizioni d’instabilità creata dalla guerraportavano ad un netto ritardo nell’inizio della scuola. Perciò i bambini ini-ziavano a frequentare la prima elementare soltanto a partire dai dieci anni.41) si veda a. Pereira, Balanço de vinte anos de luta (1956-1976), sãoVicente, edição da Direcção regional de são Vicente, 1977, p.101.42) si veda soprattutto PartiDo aFricaNo Da iNDePeNDeNcia DaGUiNe e caBo-VerDe, Rapport sur le role politico-sociale et economiquede la femme en Guinée et aux iles du Cap-Vert, conacry, Giugno 1972,Fundação amilcar cabral, Praia (cabo-Verde), n.c.
233
43) Constituição da Guiné-Bissau e de Cabo-Verde de 1980, art.13,http://www.dhnet.org.br/direitos/lexdh/cplp/guineb/const.htm.44) Constituição da Guiné-Bissau e de Cabo-Verde de 1980, art.16,http://www.dhnet.org.br/direitos/lexdh/cplp/guineb/const.htm.45) si veda c. LoPes, Etnia, stato e rapporti di potere in Guinea-Bissau,Bologna, GVc, 1984, pp.13-18.46) Paula Fortes è nata a são Vicente (capo Verde) nel 1945. È stata infer-miera del P.a.i.G.c. durante la lotta armata di liberazione condotta inGuinea-Bissau, dal 1968 fino al 1973. Ha assunto alcune cariche politiche dirilievo nel suo paese (deputata della repubblica dal 1980 al 1990, vice-presi-dente del consiglio Nazionale del P.a.i.c.V., dirigente dell’organizzazionedelle donne di capo Verde tra il 1990 e il 1993).47) intervista a Paula Fortes realizzata dall’autore, 12/12/2003 (da questomomento saranno citati il nome e la data).48) Henriqueta Godinho Gomes è nata il 9 aprile del 1943 a empada (suddella Guinea-Bissau). Ha compiuto gli studi primari e secondari a Bissau.Nel 1963 vinse una borsa di studio per frequentare l’università di Lisbona,dove ottenne la laurea in amministrazione pubblica, nel 1967. Dal 1974Henriqueta Godinho Gomes ha occupato diversi posti nell’amministrazionepubblica della Guinea-Bissau: direttore dei servizi del lavoro presso il mini-stero dell’amministrazione interna, Funzione pubblica e Lavoro dellaGuinea-Bissau (1974), sottosegretario alla presidenza per gli affari pubblicie lavoro (1982/84). Nel 1984 è stata nominata ministro della funzione pub-blica, lavoro e previdenza sociale, ministero che ha diretto fino al 1990. Nel1990 è stata nominata ministro della sanità pubblica, incarico che ha svoltofino al 1994.49) si veda intervista a Henriqueta Godinho Gomes realizzata dall’autore,15/11/03 (da questo momento saranno citati il nome e la data).50) Ibidem. il termine “burmedjo” significa nell’ideoma creolo persona dipelle chiara, ovvero, meticcia.(51) sulla transizione politica della Guinea-Bissau si veda c. carDoso,Da apertura 1 a aperture 2: os desafios da transição política na Guiné-Bissau, www.iscte.pt/cardoso.htm52) si veda www.undp.org/cabo-verde.com.53) c. saNtos, Integração da mulher, condição de desenvolvimento emCabo-Verde, www.panapress.com.54) Código Civil da Repubblica de Cabo-Verde-Direito da família (Título V-Filiação), art.1817, www.bnv-gz.de/~lschmid/cvrecht.htm.55) Código Civil da Repubblica de Cabo-Verde-Direito da família (Título V-Filiação), art.1818, www.bnv-gz.de/~lschmid/cvrecht.htm56) Dati del progetto National Long Term Prospective Studies Cap-Vert2000, ministério da coordenação económica, Praia, maio 1996,www.governo.cv.57) Colloque international-Genre, population et dévelopment en Afrique. Laquestion du genre dans le secteur informel au Cap-Vert : étude sur les “rabi-
234
dantes”au marché de Sucupira dans l’île de Santiago, abidjan, 16-21/7/2001.58) intervista a Paula Fortes, 12/12/2003.59) si veda: Constituição da Republica de Cabo-Verde-Preâmbulo,www.isecmar.cv/Legislação/constit_preambulo.htm.60) Ibidem.61) Ibidem.62) Nella repubblica del capo Verde, così come nelle altre ex-colonie porto-ghesi, il parlamento assume il nome di assembleia Nacional Popular.63) si veda Constituição da Republica de Cabo-Verde-Preâmbulo,www.isecmar.cv/Legislação/constit_preambulo.htm.64) Constituição da Republica de Cabo-Verde (Título II), art.22,www.dhnet.org.br/direitos/cplp/caboverd/const.htm.65) Constituição da Repubblica de Cabo-Verde (Título II), art.23,www.dhnet.org.br/direitos/cplp/caboverd/const.htm.66) si veda intervista a Paula Fortes, 12/12/2003.67) si veda Presença da mulher nos centros de decisão em Cabo-Verde,www.panapress.com.(68) in portoghese Organização das Mulheres de Cabo-Verde (notao.m.c.V.). Paula Fortes è stata dirigente dell’omcV dal 1990 al 1993 eafferma che “in questa fase era molto difficile far fronte al partito che avevavinto le elezioni e che di tutto faceva pur di distruggere l’immagine delP.a.i.c.V. Questo periodo è stato molto importante per l’organizzazione, per-ché siamo riuscite a consolidare alcune conquiste e a mantenerla in piedi cosìcome oggi la vediamo”. (intervista a Paula Fortes, 12/12/2003).69) Report of the African Development Foundation’s (ADF) performanceduring fiscal year 2001, www.adf.gov/aDF_Pr_FY_2001.pdf.70) c. saNtos, Integração da mulher, condição de desenvolvimento emCabo-Verde, www.panapress.com.71) Ibidem.72) si veda Presença da mulher nos centros de decisão em Cabo-Verde,www.panapress.com.73) si veda Discurso proferido por Sua Excelência a Secretaria de Estadoda Juventude, na cerimónia de abertura do ciclo de palestras em saudaçãoao Dia da Mulher Africana, instituto da condição Feminina, Praia,08.08.2002, www.governo.cv/Discursos.74) Discurso proferido por Sua Excelência a Secretaria de Estado daJuventude, na cerimónia de abertura do ciclo de palestras em saudação aoDia da Mulher Africana, instituto da condição Feminina, Praia, 08.08.2002,www.governo.cv/Discursos.75) Nell’opinione di Paula Fortes, gli anni novanta non hanno portato molteconquiste politiche a livello della partecipazione nelle istituzioni politiche.L’apertura politica ha spinto le donne a difendere gli interessi dei propri par-titi in parlamento, piuttosto che la causa femminile, come succedeva neglianni ottanta, dove non vi erano contrasti politici e quindi l’attenzione erarivolta soprattutto alla condizione della donna. (si veda intervista a Paula
235
Fortes, 12/12/2003).76) Discurso proferido por Sua Excelência a Secretaria de Estado daJuventude, na cerimónia de abertura do ciclo de palestras em saudação aoDia da Mulher Africana, instituto da condição Feminina, Praia, 08.08.2002,www.governo.cv/Discursos ed anche Instituto da Condição Femminina,www.cabonet.cv/noticias.77). si veda Discurso proferido por Sua Excelência a Secretaria de Estadoda Juventude, na cerimónia de abertura do ciclo de palestras em saudaçãoao Dia da Mulher Africana, instituto da condição Feminina, Praia,08.08.2002, www.governo.cv/Discursos ed anche Instituto da CondiçãoFemminina, www.cabonet.cv/noticias.78) si veda Termos de referência para a organização de uma uma reuniãode consulta com os parceiros de desenvolvimento de Cabo-Verde (Praia,Abril 2003), www.cv.undp.org/tableronde.pdf.79) Ibidem.80). si veda intervista a Paula fortes, 12/12/2003.81) intervista a Henriqueta Godinho Gomes, 15/11/03.82) União Democrática das Mulheres.83) intervista a Henriqueta Godinho Gomes, 15/11/03.84) si vedano intervista a Henriqueta Godinho Gomes, 15/11/03, RelatórioAnual do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento-2000,www.undp.org/guine-bissau.85) c. carDoso, Da abertura 1 a aperture 2: os desafios da transiçãopolítica na Guiné-Bissau, www.iscte.pt/cardoso.htm; Constituiçao daRepubblica da Guiné-Bissau (titulo II), www.dhnet.org.br/direitos/cplpgui-neb/const.htm.86) a. carDoso, A mulher e o poder de decisão na Guiné-Bissau, http://homepage.esoterica.pt/cidac/mulher-gb.html87) La percentuale di donne alfabetizzate in Guinea-Bissau alla fine deglianni Novanta era di circa 32%, mentre la stessa percentuale per gli uominiera di 58%. Questi dati spiegano quanto la donna sia culturalmente più arre-trata rispetto all’uomo. (www.prime.org.br/primenet/mundoemissão/dado-sdiscrim.htm).88) si veda United Nations Development Program, Relatório Anual doPrograma das Nações Unidas para o Desenvolvimento - 2000, sito:www.undp.org/guine-bissau89) Ibidem. si veda anche a. carDoso, A mulher e o poder de decisão naGuiné-Bissau, http: //homepage.esoterica.pt/cidac/mulher-gb.html.90) Le donne guineane che gestiscono delle attività commerciali lavorano,nella maggior parte dei casi, nel settore informale del commercio. Per unapprofondimento si veda a. carDoso, A mulher e o poder de decisão naGuiné-Bissau, http: //homepage.esoterica.pt/cidac/mulher-gb.html.91) sulla guerra civile in Guinea-Bissau si veda G. GaiLLarD, “Guinée-Bissau: un pas doloreux vers la démocratie”, Afrique Contemporanie, 1999,n.191, pp.43-57; J. amPaGatUBo, As causas do conflito de 7 de Junho de
236
1998 na Guiné-Bissau, http: //africadebate.iscte.pt/Guinebissau.htm92) attualmente esistono in Guinea-Bissau diverse organizzazioni nongovernative (oNG) che si occupano del genere femminile. tra le più impor-tanti la ProsaFam (protezione della salute familiare con particolare atten-zione al problema dell’aids nella donna e nel bambino),la amae (associa-zione delle donne di attività economica la cui attività si concentra nell’areadella formazione delle donne negli ambienti rurali), aGss (associazioneguineana per la solidarietà sociale), sinin mira Nassiquê (lotta contro lamutilazione femminile), aD (azione per lo sviluppo che appoggia soprattut-to le iniziative in campo economico e culturale), raoa (rete di appoggioalle organizzazioni di auto promozione).93) si veda a. carDoso, A mulher e o poder de decisão na Guiné-Bissau,centro de Documentação e informação amilcar cabral (ciDac),http://homepage.esoterica.pt/cidac/mulher-gb.html.94) Ibidem.95) si veda Istituto da Mulher e da Criança quer mais mulheres na lista decandidatos a deputado, www.guine-bissau.com/guine-bissaunews; LigaGuineense incentiva mulheres a agir positivamente na sociedade guineense,www.guine-bissau.com/guine-bissaunews.96) L’avvento della democrazia in Guinea-Bissau ha messo il P.a.i.G.c. difronte ad una realtà inevitabile: l’urgente necessità di procedere a delle rifor-me strutturali del partito e di adattarsi alle nuove sfide. il problema dei com-battenti della patria (prima riforma e la più urgente), gli organi e i militanti(seconda riforma), i giovani del partito (JAAC-Juventude Africana AmilcarCabral) (terza riforma) e l’organizzazione delle donne U.D.e.m.U. (quartariforma). Per quanto riguarda la riforma dell’organizzazione delle donne delpartito, essa non è stata tuttora avviata. Per una lettura più completa sull’ar-gomento si veda r. GoDiNHo Gomes, O P.A.I.G.C. e o futuro: um olhartransversal, Lisboa, afro expressão-Publicacões, 2001, pp.79-92.97) National Poverty Reduction Strategy Paper (Interim), Bissau, september2000, www.inf.org/external/NP/prsp/2000/gnb/01/093000.pdf.98) i Conferência de mulheres da CPLP sobre género, cultura, acesso aopoder, participação política e desenvolvimento-documento final, www.cplp.org/eventos/doc_evento.99) Ibidem.100) si veda II Fórum Lusófono de Mulheres em Postos de Decisão, Luanda,17-18 de Julho de 2002, www.cplp.org/eventos.101) Fafali Koudawo citato in c. carDoso, Da abertura 1 a aperture 2:os desafios da transição política na Guiné-Bissau, www.iscte.pt/cardoso.htm102) intervista a Henriqueta Godinho Gomes, 15/11/03. antonieta rosaGomes è il leader politico del Fórum Cívico Guineense Social Democracia(F.C.G.S.D.), l’unico partito guineano attualmente guidato da una donna. Èstata eletta nel dicembre 2003 presidente della comissione di elezioni dellacorte suprema di giustizia della Guinea-Bissau. Le elezioni si terrano il 26gennaio 2004, e afferma che “saranno sicuramente trasparenti” (si veda
237
www.guine-bissau.com).103) Vi sono quattro ministeri nel capo Verde guidati da donne: il ministerodegli affari esteri, della cooperazione e delle comunità (ministro maria deFátima Lima Veiga), il ministero della Giustizia (ministro maria cristinaLopes almeida Fontes Lima), il ministero dell’ambiente, agricoltura ePesca (ministro maria madalena Brito Neves), sottosegretario alle politichegiovanili (maria de Jesus Veiga mirando mascarenhas)(www.governo.cv/elenco/elenco_governamental.htm.104) O Relatorio do PNUD e a Guiné-Bissau,www.dhnet.org.br/direitos/cplp/guineb/pnud.htm.
iNterViste
Henriqueta Antónia da Silva Godinho GomesAutore: Patricia GomesData: 15/11/2003
Dati BioGraFiciHenriqueta antónia da silva Godinho Gomes è nata il 9 aprile del 1943, aempada (sud della Guinea-Bissau). Ha fatto gli studi primari e secondari aBissau, avendo concluso la maturità nel 1962. Nel 1963 è risultata vincitricedi una borsa di studio per proseguire gli studi all’università di Lisbona, pres-so l’istituto superiore di scienze politiche e sociali (iscsPU), dove ottennela laurea in amministrazione pubblica nel 1967. tra il 1968 e il 1974,Henriqueta Godinho Gomes ha svolto le funzioni di tecnico del lavoro pres-so l’istituto del lavoro e della previdenza sociale dell’angola. Dal 1974 al1976 è stata nominata direttore dei servizi del lavoro presso il ministerodell’amministrazione interna, Funzione pubblica e Lavoro della Guinea-Bissau. Dal 1976 al 1980 è stata capo d’ufficio del primo ministro e segreta-ria del consiglio dei ministri. Dal 1980 al 1982 Henriqueta Godinho Gomesha avuto l’incarico di segretario generale della presidenza del consiglio ddel-la rivoluzione. Dal 1982 al 1984 è stata nominata sottosegretario alla presi-denza per gli affari pubblici e lavoro. Nel 1984 è stata nominata ministrodella Funzione pubblica, Lavoro e Previdenza sociale, dicastero che ha diret-to fino al 1990. Nel 1990 è stata nominata ministro della salute pubblica,incarico che ha svolto fino al 1994. attualmente è presidente onorario di unaorganizzazione non governativa, la ProsaFam (Protecção da SaudeFamiliar), che si batte per migliorare le condizioni della salute in ambitofamiliare, soprattutto l’aids nelle donne e nei bambini.
D.: signora Henriqueta Godinho Gomes, quando lei era all’Università diLisbona, vi erano altre ragazze del suo paese che studiavano?H.G.G.: Purtroppo vi erano pochissime ragazze con la mia stessa fortuna. Già
238
a liceo, il numero di ragazze che frequentavano era abbastanza ridotto, equando riuscivano a terminare gli studi secondari, il loro destino era il matri-monio, imparare a cucire e forse fare il corso di infermiere o essere una pic-cola funzionaria (questo era possibile soltanto alle ragazze appartenenti afamiglie di persone istruite). io ero l’unica guineana all’università di Lisbonanel 1963.D.: era un’eccezione, la presenza di una ragazza all’università in quell’epo-ca?H.G.G.: sì, lo era. Per lo spirito dell’epoca, si può dire che era un caso d’ec-cezione per una giovane donna riuscire a scavalcare tutte le barriere (che nonerano poche!), concludere il liceo e proseguire gli studi universitari. eraquasi impossibile che ciò accadesse. a liceo io ero vista come un fenomenosia dai miei colleghi maschi sia dai genitori. mi chiamavano “pautera” chenella nostra lingua significa visionaria. tutto questo perché ero riuscita nonsoltanto a concludere il liceo, ma a essere tra i primi migliori alunni, fattoinconsueto per una ragazza in quel periodo. sono stata molto fortunata per-ché mia madre, nonostante avesse soltanto la quarta elementare, era una per-sona evoluta per la sua epoca e con grande apertura mentale. e stato grazie alei che riuscì a sfuggire alla regola e rompere le barriere culturali e del siste-ma coloniale.D.: Dopo aver concluso l’università, è tornata nel suo paese?H.G.G.: Finì gli studi universitari nel 1967 e nello stesso anno sarei dovutatornare in Guinea, il ché è stato impossibile data la situazione politica.soltanto nel 1974 tornai a Bissau. io e mio marito eravamo militanti delP.a.i.G.c. nella clandestinità, partito che conduceva una lotta vittoriosa con-tro il colonialismo portoghese e che nel 1967 aveva già liberato ben due terzidel territorio nazionale. ritornare in Guinea in un momento in cui la lottaarmata era nella sua fase più importante e il colonialismo compiva le piùgravi atrocità contro le popolazioni civili era un suicidio per un giovane cheaveva appena finito gli studi all’estero. Per questa ragione abbiamo deciso diandare a lavorare a Luanda (angola), dove non potevamo essere perseguita-ti anche se in questo paese avevamo la possibilità di collaborare con le strut-ture clandestine dell’m.P.L.a. (movimento Popular de Libertação deangola). e stata all’epoca un’opzione molto sofferta che tuttavia non ci haallontanato dai nostri ideali. in angola ho lavorato dal 1968 al 1974 e i mieitre figli sono nati tutti lì. e stata un’esperienza molto interessante e di gran-de utilità, e che mi è servita quando sono tornata nel mio paese.D.: Quando arrivò a Bissau, quale era la situazione della donna guineana intermini di partecipazione politica e negli organi amministrativi?H.G.G.: si può dire che vi erano due situazioni distinte: una relativa alladonna che arrivava dalla lotta di liberazione, che aveva già conquistato la suaemancipazione politica, che aveva lottato a fianco all’uomo non soltanto perla libertà e la giustizia, ma soprattutto per la sua stessa liberazione dalla tra-dizione e della sua cultura. tutto questo ha reso più facile l’inizio della suaintegrazione negli organi e nelle strutture politiche e amministrative del
239
paese sovrano.L’altra situazione si riferisce alla donna che viveva nelle zone controllate dalregime coloniale: una donna schiavizzata dalla propria cultura e dalle tradi-zioni, una donna senza diritti politici che viveva in una situazione di disu-guaglianza e di ingiustizia rispetto all’uomo. Una donna doppiamente sotto-messa, dalla propria cultura e dal sistema coloniale. È stato questo il conte-sto nel quale ho trovato la donna guineana. in seguito, vi è stato un grandesforzo dal P.a.i.G.c. nell’ integrare le donne, mobilitandole intorno ad unideale comune: uguaglianza e giustizia. si imponeva, perciò, un lavoro nelsenso della promozione della donna, della sua istruzione, del rispetto per sestesse. tutto questo lavoro è stato iniziato dall’organizzazione delle donnedel P.a.i.G.c., l’unica organizzazione femminile che esisteva all’epoca, lacommissione femminile del P.a.i.G.c., più tarde U.D.e.mU. (UniãoDemocrática das mulheres).D.: a suo parere, vi è stata qualche ostilità nei confronti delle donne capo-verdiane che dopo il colpo di stato del 1980 si trovavano in Guinea?H.G.G.: Dobbiamo dire intanto che vi è stata una certa ostilità nei confrontidei “burmedjo”, termine che in lingua locale significa meticcio. È vero chein Guinea il “burmedjo” viene sempre associato al capoverdiano, ma il com-portamento ostile non era diretto soltanto verso la donna capoverdiana, maverso tutti i meticci in generale. si deve dire anche che questo comporta-mento ostile era manifestato soprattutto dagli ignoranti, dai mediocri e dagliopportunisti . e stato un aspetto molto combattuto dai principali esponentidel colpo di stato del 14 novembre 1980. a questo riguardo, vi è stata unagrossa campagna di sensibilizzazione sugli obiettivi del 14 novembre, cheniente avevano a che fare con quelle tendenze. Questi atteggiamenti cheemergono ogniqualvolta scoppi una crisi, sono stati duramente combattuti daNino Vieira, autore del golpe. Penso che un giorno, prima o poi, questo argo-mento dovrà essere sottoposto a dibattito pubblico, perché si possano analiz-zare a fondo in totale libertà le vere cause e trovare soluzioni equilibrate egiuste.D.: Quando e perché tornò in Guinea-Bissau?H.G.G.: tutto è iniziato nel dicembre del 1974. mi trovavo a Luanda, angola,con mio marito e i miei figli, il 25 aprile giorno della rivoluzione deiGarofani in Portogallo, allorché fu riconosciuta de jure la repubblica dellaGuinea-Bissau. il P.a.i.G.c. ebbe la necessità di disporre di tutte le risorseumane per il nuovo stato, in vista della ricostruzione nazionale. così, miomarito venne chiamato nel novembre del 1974 e subito dopo inviato inalgeria per uno stage presso la banca centrale algerina. io sono arrivata quinel dicembre del 1974 e sono andata a lavorare al ministero della pubblicaamministrazione e del lavoro. in seguito, sono entrata a far parte del segreta-riato del consiglio dei ministri, con funzioni di capo ufficio del primo mini-stro. Più tardi, ho occupato diversi posti: segretaria generale della presiden-za della repubblica, sottosegretario alla presidenza, ministro della Pubblicaamministrazione e del Lavoro e ministro della sanità. in questa ultima fase
240
della mia permanenza al governo, ho svolto anche l’incarico di segretaria perl’informazione e propaganda dell’organizzazione delle donne e membro delcomitato centrale del P.a.i.G.c.D.: Pensa che la sua presenza al governo all’epoca possa aver portato deivantaggi al paese e alle donne?H.G.G.: si. Per me è stata una esperienza molto importante e gratificante. Hofatto del mio meglio, con i mezzi di cui disponevo. mi sono sentita utile, per-ché negli anni settanta quando sono arrivata, vi erano poche persone conesperienza nell’area dell’amministrazione, la mia area di formazione. Pensodi aver dato un buon contributo, nonostante oggi senta un certo sentimentodi frustrazione quando vedo distruggere tutto ciò che ho aiutato a costruirecon tanto sacrificio e dedizione e tanto amore alla mia terra.Per quanto riguarda le donne, credo di aver fatto qualcosa di positivo. Neglianni in cui ero dirigente dell’U.D.e.mU. (União Democrática das mulheres),ho contribuito direttamente ad iniziative mirate all’integrazione e all’eman-cipazione della donna nel processo di sviluppo. Negli anni in cui sono statamembro del governo, dal 1982 al 1994, penso di aver fatto qualcosa di utilea favore della donna guineana: riconoscimento e consacrazione dei dirittidella donna lavoratrice nella legge generale del lavoro, ratifica di conven-zioni internazionali sul lavoro femminile e infantile e sua applicazione all’or-dinamento giuridico interno, organizzazione dell’ispettorato generale dellavoro, organo creato per stabilire un controllo più efficace sulle norme dellavoro, elaborazione di iniziative per la protezione della salute della donna edel bambino, aumento del livello della salute pubblica in tutta la Guinea-Bissau. tutto questo è stato purtroppo interrotto dalle successive crisi politi-che e socio economiche che il paese ha attraversato negli ultimi anni, soprat-tutto a partire del 1998.D.: Quali sono le differenze che coglie nella condizione delle donne guinea-ne tra gli anni ottanta e Novanta?H.G.G.: La differenza fondamentale è stata conseguente all’avvento dellademocrazia multipartitica, riflesso della caduta del muro di Berlino nel 1989e della scomparsa del blocco sovietico. La democrazia ha aperto alle donneguineane nuovi orizzonti; sul piano politico, esse hanno avuto la possibilitàdi intervenire e di accedere al potere politico, integrandolo e talvolta diri-gendolo, in qualche caso anche assumendo la direzione di strutture di partitipolitici. Nell’ambito della società civile, il ruolo della donna ha assuntoun’importanza maggiore, perché partecipa sempre di più a livello delleoNG’s. sul piano governativo, l’evoluzione è stata ugualmente positiva,essendoci addirittura una donna come ministro della Difesa.
Paula Maria Fortes
241
Autore: Patricia GomesData: 12/12/2003
Dati BioGraFiciPaula maria Fortes è nata il 26 gennaio del 1945, a são Vicente (capoVerde). Nel 1968 è stata chiamata dal P.a.i.G.c per lavorare nelle zone libe-rate della Guinea come infermiera. È stata in Guinea fino al 1973 quando siè dichiarata unilateralmente l’indipendenza nazionale del paese. Paula Fortesè stata nominata deputata della repubblica del partito unico Partido africanoda independência de cabo-Verde (P.a.i.c.V.) per dieci anni, dal 1980 al1990, nella ii e iii legislatura. attualmente è dirigente di una organizzazionenon governativa che agisce nell’ambito della famiglia, la VerDeFam(cabo-Verde Familia).
D.: signora Paula Fortes, pensa che il colpo di stato del 14 novembre sia statoil risultato del malessere sociale che da qualche tempo si viveva in Guinea?P.F.: Penso di si. il malessere presente da qualche tempo, soprattutto la sfi-ducia tra i compagni di lotta e l’ambizione del potere portarono ad una rea-zione improvvisa da parte di alcune persone.D.: Per i capoverdiani, che significato ha avuto?P.F.: Per i capoverdiani è come se ci fosse stato un secondo assassinio dicabral. Vi è stata una interruzione di una strategia di sviluppo che riguarda-va le due nazioni, l’unità Guinea / capo Verde, ideata da amilcar cabral.tutta la sua teoria pacifista e democratica è stata messa in causa. si sarebbepotuto dialogare, discutere dei problemi e arrivare ad un accordo, così comeegli ci aveva abituati.D.: Le donne capoverdiane che allora vivevano in Guinea, sono state in qual-che modo contrapposte alle donne guineane dopo il colpo di stato?P.F.: Non ho molta informazione al riguardo, perché allora vivevo già a capoVerde. comunque, so di qualche donna capoverdiana che aveva responsabi-lità in Guinea e che dopo l’accaduto è stata sostituita ed è tornata a capo-verde. in quel contesto storico, era normale che ciò accadesse.D.: La decade degli anni ottanta ha avuto importanza per la donna capover-diana a livello di partecipazione politica?P.F.: Gli anni 80, nella mia opinione, hanno avuto grande importanza per ladonna capoverdiana, soprattutto per quanto riguarda la sua partecipazionenel parlamento. si è passato da un’unica deputata a tredici. tuttavia, questonumero non era soddisfacente a nostro avviso, anche se ha portato ad uncerto cambiamento politico. in questo senso, è stata decisiva la partecipazio-ne della donna capoverdiana alla discussione e divulgazione dei principalistrumenti della politica, quali la costituzione della repubblica, il codice dellafamiglia, il codice dei minori, i piani nazionali per lo sviluppo, la legge perl’interruzione volontaria della gravidanza, la legge base della salute, ecc.D.: Lei è stata una donna di potere. Potrebbe parlarmi della sua esperienza?P.F.: sono stata deputata della nazione per ben dieci anni, nella seconda e
242
terza legislature. e stata un’esperienza abbastanza importante per me, e miha dato tanto. Ho imparato tanto, ho consolidato ciò che negli anni precedentiavevo imparato da amilcar cabral e dalla vita. il mio intervento nel parla-mento è stato apprezzato non soltanto dai colleghi deputati ma anche dallepersone comuni. Lavoravo nell’ospedale di Praia in contatto diretto con lapopolazione e quindi sentivo tutti i commenti. Nonostante sia stata deputataal tempo del partito unico, non mi sono mai sentita costretta. infatti, in unasessione parlamentare della seconda legislatura, ho addirittura votato controun decreto-legge del governo perché ispirato a principi ingiusti e per il fattodi essere superato. Durante i miei mandati, sono stata anche vicepresidentedelle commissioni specializzate per la salute e per l’istruzione. Un’altra espe-rienza abbastanza interessante è stata quella di delegato del governo nell’i-sola di sal, l’isola dell’aeroporto internazionale e del turismo, la terza piùimportante del capo Verde. Lì, ho avuto l’opportunità di lavorare con unapopolazione abbastanza partecipe e imprenditrice e di avere dei rapporti coninvestitori di diverse origini. L’esperienza che ho avuto con la popolazionedell’isola di sal è stata delle più gratificanti e pedagogiche che ho vissuto.Durante cinque anni sono stata anche vicepresidente del consiglio nazionaledel P.a.i.c.V., allora all’opposizione, esperienza che ha contribuito moltoalla mia formazione, insegnandomi soprattutto ad ascoltare gli altri e ad ana-lizzare il potere come spettatore.Parlo ancora degli anni che ho passato alla direzione dell’organizzazionedelle donne di capo Verde, dal 1990 al 1993, all’inizio della fase dei cam-biamenti politici. in questa fase era molto difficile far fronte al partito cheaveva vinto le elezioni e che di tutto faceva pur di distruggere l’immagine delP.a.i.c.V. Questo periodo è stato molto importante per l’organizzazione per-ché siamo riuscite a consolidare alcune conquiste e a mantenerla in piedi cosicome oggi le vediamo.D.: capo Verde degli anni ottanta e capo Verde degli anni Novanta, qualidifferenze per quanto riguarda la situazione della donna?P.F.: Gli anni Novanta hanno beneficiato delle conquiste e di ciò che neglianni ottanta è stato fatto, e vi sono stati dei progressi considerevoli. La donnache già partecipava all’elaborazione degli strumenti di democratizzazione delpaese ha continuato ad occupare incarichi politici nel governo, come ministrie sottosegretari, cosa che prima non succedeva. Vi è stato il ritorno di donneche avevano studiato all’estero e che poi hanno occupato posti di decisionenella pubblica amministrazione e nelle imprese. con il pluralismo, moltealtre organizzazioni femminili sono state create e la donna oggi si sente piùtutelata e più sicura. i mecanismi che consacrano le pari opportunità si stan-no perfezionando sempre di più.D.: Pensa che, dopo l’avvento della democrazia nel 1991, la donna capover-diana ha conquistato qualcosa di più a livello politico?P.F.: oltre a quello che ho già detto, la donna capoverdiana non ha smesso diconquistare con la democrazia, perché la libertà di partecipare a tutte le forzepolitiche è garantita dalla costituzione. È aumentata la sua partecipazione a
243
livello associativo. a mio avviso, soltanto a livello della partecipazione nelparlamento la donna non ha conquistato di più. Prima non vi erano interven-ti per difendere gli interessi dei singoli partiti, le donne deputati dedicavanoi loro intervento a favore degli interessi della popolazione femminile. oggi,gli interessi dei partiti vengono prima degli interessi della collettività e lioffuscano. recentemente è stata creata una rete di donne parlamentari, ini-ziativa di concertazione che vuole mettere insieme tutte le donne presentinella politica e intervenire in modo più decisivo a favore degli interessicomuni e soprattutto delle fasce deboli, quali donne e bambini.
244